Libri di Diego Fusaro
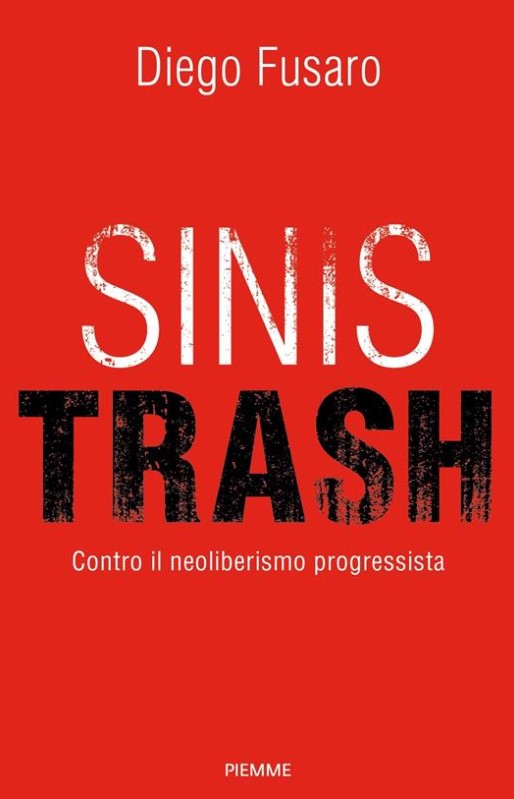
Qui trovate segnalati i principali libri di Diego Fusaro.
Come sempre, i vostri pareri e i vostri giudizi sono graditissimi. Grazie. Buona lettura!

“L’orizzonte in movimento. Modernità e futuro in Reinhart Koselleck”, Il Mulino, 2012
In forza della sua costitutiva pluridisciplinarità, la riflessione di Reinhart Koselleck (1923-2006) costituisce oggi un importante punto di riferimento per studiosi che, provenienti da esperienze culturali molto eterogenee, trovano nella pratica della “storia dei concetti” (“Begriffsgeschichte”) un fecondo metodo d’indagine e di confronto. Il presente lavoro costituisce la prima monografia – nel panorama sia italiano, sia internazionale – specificamente dedicata alla ricostruzione e all’analisi di pensiero di Koselleck, alla sua genesi e ai rapporti intrattenuti con l’ermeneutica gadameriana, la “teoria del politico” schmittiana, l’ontologia heideggeriana, il “teorema della secolarizzazione” löwithiano e la “Verfassungsgeschichte”. A giusta distanza dalla tradizionale “history of ideas”, l’opera koselleckiana tematizza la concettualità nella sua funzione politico-sociale, facendo convergere il fuoco prospettico della sua analisi sulla “zona di scambio” tra i processi sociali alimentati e tenuti in tensione dal vocabolario moderno e il modo in cui quest’ultimo va modellandosi sul terreno concreto dei conflitti, dei compromessi e degli equilibri dinamici dell’azione e del pensiero politico. Koselleck adombra come in quella “soglia epocale” (“Sattelzeit”) racchiusa tra i due estremi del 1750 e del 1850 la costellazione dei concetti fondamentali della storia e della politica sia andata incontro a una profonda risemantizzazione.

Filosofia e speranza. Ernst Bloch e Karl Löwith interpreti di Marx
Uno dei maggiori problemi irrisolti che Karl Marx ha lasciato in eredità ai suoi interpreti riguarda la legittimità della speranza in sede pratica e teoretica, tanto nella cornice del suo pensiero quanto nel più ampio orizzonte della filosofia. L’intera opera marxiana sembra enigmaticamente in bilico tra le opposte dimensioni della scienza e della speranza. La linea interpretativa adottata da Ernst Bloch e da Karl Löwith scorge in Marx il filosofo della speranza più che della scienza, riconoscendo nella sua riflessione un’ineludibile tensione utopica rispetto alla quale la scienza sarebbe un fenomeno secondario e funzionale.

L’Europe et le capitalisme. Pour rouvrir le futur
L’Union Européenne telle que nous la connaissons aujourd’hui est trop souvent présentée comme la réalisation parfaite de l’idée d’une Europe des peuples et de la liberté. Cet essai renverse cette perspective. Triomphe d’un capitalisme désormais absolu, la création de l’Union Européenne a pu révoquer l’hégémonie du politique. C’est ainsi que pour rouvrir le futur, défendre les peuples et le travail, il faut partir d’une critique radicale de l’Europe de l’euro et de la finance.
La critique de Diego Fusaro, jeune et brillant philosophe italien, auteur déjà d’une dizaine d’essais qui ont contribué à alimenter le débat en Italie pendant ces dernières années de crise financière, franchit enfin la frontière européenne. Ce nouveau livre de Fusaro sortira en même temps en français, italien et Anglais.

Fichte e l’anarchia del commercio. Genesi e sviluppo di «Stato commerciale chiuso»
Il presente studio monografico affronta il problema della genesi e dello sviluppo del concetto di “Stato chiuso dal punto di vista commerciale” nella riflessione di Johann Gottlieb Fichte. Prendendo in esame la non esigua bibliografia sul tema e le più recenti acquisizioni della Fichte-Forschung, il saggio cerca di mostrare come sia possibile rintracciare, nel percorso teorico fichtiano, una correlazione essenziale tra il fondamento della dottrina della scienza come “sistema della libertà” e la teoria dello Stato chiuso commercialmente così come viene sviluppata da Fichte a partire dal 1800. La “chiusura commerciale” appare a Fichte, nella specifica congiuntura storica in cui si trova a operare, la sola via per reagire all'”anarchia commerciale” e, dunque, per rendere praticabile la dottrina della scienza come inesausto sforzo di razionalizzazione dell’esistente.

Idealismo e prassi. Fichte, Marx e Gentile
Il presente studio affronta il rapporto tra idealismo e prassi nelle riflessioni di Fichte, Marx e Gentile, nella convinzione che tra i sistemi di pensiero dei tre autori si dia un nesso di forte continuità. Per un verso, l’ontologia della prassi su cui si regge la dottrina della scienza fichtiana costituisce la base delle marxiane undici Tesi su Feuerbach. Per un altro verso, l’attualismo di Gentile opera una riforma della dialettica hegeliana in cui risuona il timbro del prassismo fichtiano e marxiano. L’ideale marxiano della prassi trasformatrice non soltanto è presente in Fichte come in Gentile: è la chiave stessa dell’idealismo e del suo rigetto di ogni dogmatica resa alle logiche dell’esistente. In un rovesciamento integrale delle letture più consolidate, si adombra per questa via il carattere intrinsecamente idealistico della prassi e, in maniera convergente, l’essenza antiadattiva dell’idealismo.

Personale e soggettivo per sua natura, virtù virile che trova nel campo di battaglia la propria “scena originaria”, il coraggio è il luogo in cui rifulge la libertà di chi sceglie di agire malgrado tutte le avversità e i rischi che indurrebbero a scelte differenti o, semplicemente, a optare per quell’inerzia che, alleata della viltà, rappresenta uno degli opposti della fortezza. Il “coraggio della verità”, come lo chiamava Foucault, è anche l’essenza dell’impresa filosofica e dell’audacia del “dire-di-no” della critica: essere contro significa, infatti, avere il coraggio dell’indocilità ragionata, in primo luogo della propria dissonanza rispetto all’esistente, ma poi anche della volontà di delineare diversamente la morfologia del reale in opposizione alle logiche conservative del potere e al “senso comune” che accetta il mondo non perché sia buono o giusto in sé, ma perché, per inerzia, ritiene che non possa essere altro da quello che è.

Marx e l’atomismo greco. Alle radici del materialismo storico
Questo lavoro cerca di mettere in luce come accanto a quelle che sono state tradizionalmente individuate come le «tre fonti» del pensiero di Marx (l’economia politica inglese, il socialismo francese e la filosofia tedesca) ve ne sia una quarta, solitamente trascurata: il materialismo atomistico di Epicuro. L’interesse marxiano per il pensiero epicureo non è episodico né casuale, come molti interpreti hanno sostenuto: non solo Marx si laurea con una tesi su Epicuro, ma continua a vedere in lui, nelle successive evoluzioni del suo pensiero, un imprescindibile punto di riferimento, rintracciando nel filosofo greco il fondatore di quella tradizione saldamente materialistica e atea – alternativa all’idealismo platonico e poi hegeliano – a cui egli stesso intende riallacciarsi col suo «materialismo storico». Oltre che per comprendere la genesi della «concezione materialistica della storia», Epicuro è anche importante, se non per risolvere, almeno per riflettere su alcuni grandi nodi problematici della riflessione marxiana, come il valore da attribuire alla scienza, il peso da riconoscere alla libertà dell’agire umano, alla critica della religione e al «farsi mondo» della filosofia.

Filosofia e speranza. Ernst Bloch e Karl Löwith interpreti di Marx
In opposizione all’immagine gratificante che l’epoca moderna diffonde di sé come «regno della libertà» pienamente dispiegata, Marx scopre come anche nel mondo moderno sopravviva una particolare forma di schiavitù, dai contorni difficilmente percepibili: la «schiavitù salariata» di una classe sociale che, in una condizione di privazione totale, è costretta ad alienare la propria forza-lavoro e a vendersi quotidianamente.
La libertà formale di cui godono i lavoratori salariati nasconde un asservimento economico dissimulato dalla «finzione giuridica» del contratto di lavoro e, per molti versi, analogo a quello dell’antico schiavo: in un coerente intreccio di filosofia della storia e di indagine economica, Marx scopre che, nonostante la diversa condizione formale, l’operaio e l’antico schiavo vengono a coincidere nell’estorsione di «pluslavoro» a cui sono soggetti. In questo modo, tra passato e presente sussiste una forte continuità: l’antico schiavo, il servo della gleba e il moderno salariato si configurano inaspettatamente come tre proiezioni storiche della stessa figura del lavoratore asservito, come tre diverse forme della stessa sostanza schiavistica che ha accompagnato la storia in ogni sua fase; ma con una differenza decisiva: gli «schiavi del salario» costituiscono una classe potenzialmente rivoluzionaria, in grado di spezzare l’incantesimo di alienazione e sfruttamento in cui è sospeso il mondo moderno.

Essere senza tempo. Accelerazione della storia e della vita
Viviamo nell’epoca della fretta, un “tempo senza tempo” in cui tutto corre scompostamente, impedendoci non soltanto di vivere pienamente gli istanti presenti, ma anche di riflettere serenamente su quanto accade intorno a noi. L’endiadi di essere e tempo a cui Martin Heidegger aveva consacrato il suo capolavoro del ’27 sembra oggi riconfigurarsi nell’inquietante forma di un perenne essere senza tempo. Figlio legittimo dell’accelerazione della storia inaugurala dalla Rivoluzione industriale e da quella francese, il fenomeno della fretta fu promosso dalla passione illuministica per il futuro come luogo di realizzazione di progetti di emancipazione e di perfezionamento, la nostra epoca “postmoderna”, che pure ha smesso di credere nell’avvenire, non ha per questo cessato di affrettarsi, dando vita a una versione del tutto autoreferenziale della fretta: una versione nichilistica, perché svuotata dai progetti di emancipazione universale e dalle promesse di colonizzazione del futuro. Nella cornice dell’eternizzazione dell’oggi resa possibile dalla glaciale desertificazione dell’avvenire determinata dal capitalismo globale, il motto dell’uomo contemporaneo – mi affretto, dunque sono – sembra accompagnarsi a una assoluta mancanza di consapevolezza dei fini e delle destinazioni verso cui accelerare il processo di trascendimento del presente. (Prefazione di Andrea Tagliapietra)

Minima mercatalia. Filosofia e capitalismo
La modernità è anche la storia del nesso di tensione, adattamento e contrasto tra la filosofia e l’assolutizzazione del mercato in cui si condensa lo spirito del capitalismo. Sulle orme di Hegel e di Marx, il libro delinea una fenomenologia dello spirito del capitalismo condotta sui due piani della storia della modernità e delle principali figure del pensiero che l’hanno animata. Massima alienazione dell’uomo rispetto alle proprie potenzialità ontologiche, l’odierno monoteismo del mercato è la prima società in cui regna sovrano il principio metafisico dell’illimitatezza, il “cattivo infinito” della norma dell’accumulazione smisurata del profitto a scapito della vita umana e del pianeta. In questo scenario, la filosofia resta il luogo del rischio assoluto: infatti, essa è il luogo della possibile resistenza al nichilismo della forma merce e, insieme, della sua eventuale legittimazione in stile postmoderno. Saggio introduttivo di Andrea Tagliapietra.

“Europa e Capitalismo” Mimesis 2019
L’odierna Unione Europea è troppo spesso presentata come la realizzazione perfetta dell’idea di un’Europa dei popoli e della libertà. Il presente saggio rovescia questo comune modo di intendere la realtà. A un’analisi attenta e ideologicamente non condizionata, infatti, l’Europa corrisponde a una “rivoluzione passiva” (Gramsci) con cui i dominanti, dopo il 1989, hanno stabilizzato il nesso di forza capitalistico e l’hanno fatto rimuovendo la forza che ancora in parte lo contrastava, lo Stato nazionale sovrano, con il primato del politico sull’economico e con diritti sociali garantiti. Trionfo di un capitalismo ormai assoluto, la creazione dell’Unione Europea ha provveduto a esautorare l’egemonia del politico: ha aperto la strada all’irresistibile ciclo delle privatizzazioni e dei tagli alla spesa pubblica, della precarizzazione forzata del lavoro e della riduzione sempre più netta dei diritti sociali, imponendo la violenza economica ai danni dei subalterni e dei popoli economicamente più deboli. Per questo, la sola via per riaprire il futuro, per difendere i popoli e il lavoro e per continuare nella lotta che fu di Marx e di Gramsci, deve oggi muovere da una critica radicale dell’Europa dell’euro e della finanza.

Antonio Gramsci. La passione di essere nel mondo
Antonio Gramsci è, più di ogni altro, autore fecondamente “inattuale”, dissonante rispetto allo spirito del nostro presente. A caratterizzare il rapporto che l’odierno tempo del fanatismo dell’economia intrattiene con Gramsci è, infatti, la volontà di rimuoverne la passione rivoluzionaria, l’ideale della creazione di una “città futura” sottratta all’incubo del capitalismo e della sua mercificazione universale. Risiede soprattutto “nell’attuale inattualità” della sua figura la difficoltà di ogni prospettiva che aspiri oggi a ereditare Gramsci e ad assimilare il suo messaggio: ossia ad assumere come orientamento del pensiero e dell’azione la sua indocilità ragionata, fondata sulla filosofia della praxis dei “Quaderni”. Essa trova la sua espressione più magnifica nella condotta di vita gramsciana, nel suo impegno e nella sua coerenza – pagata con la vita – nella “lotta per una nuova cultura, cioè per un nuovo umanesimo”. Critica glaciale delle contraddizioni che innervano il presente e ricerca appassionata di un’ulteriorità nobilitante costituiscono la cifra del messaggio dell’intellettuale sardo: l’ha condensato lui stesso nel noto binomio del “pessimismo dell’intelligenza” e dell'”ottimismo della volontà”. Ereditare Gramsci significa, di conseguenza, metabolizzare la sua coscienza infelice e non conciliata, la passione durevole della ricerca di una felicità più grande di quella disponibile.

Bentornato Marx! Rinascita di un pensiero rivoluzionario
Marx è morto. È questa l’ossessiva litania che siamo ormai abituati a sentire. Dietro tale canto funebre si cela però, forse, l’auspicio che tale trapasso abbia luogo davvero, perché il “morto” in questione è ancora in forze e non cessa di seminare il panico tra i vivi. Chi si ostina a ripetere, in nome di Dio o del Mercato, che “Marx è morto” lo fa, allora, perché assillato dal suo spettro.- esso continua infatti a denunciare le contraddizioni di un mondo capovolto. Anche oggi che il “socialismo reale” è naufragato e che la storia ha mandato in frantumi il sogno di Marx, il fallimento delle sue profezie non intacca l’esattezza della denunce da lui formulate, e la sua critica radicale del capitalismo rappresenta ancora lo strumentario concettuale più “forte”per criticare la società esistente e le contraddizioni che la permeano. Il progetto marxista continua a essere la più seducente promessa di felicità di cui la filosofia moderna sia stata capace.

Il futuro è nostro. Filosofia dell’azione
Il sistema economico in cui viviamo, a differenza dei regimi del passato, non pretende di essere perfetto: semplicemente nega l’esistenza di alternative. Per la prima volta il potere non manifesta le proprie qualità, ma fa vanto del proprio carattere inevitabile. Il nuovo saggio di Diego Fusaro è un colpo di frusta alla retorica della realtà come situazione immutabile, all’abitudine di prenderne atto anziché costruirne una migliore. Si impone così il principale comandamento del monoteismo del mercato: “non avrai altra società all’infuori di questa!”. Il primo compito di una filosofia resistente è quindi ripensare il mondo come storia e come possibilità, creare le condizioni per cui gli uomini si riscoprano appassionati ribelli in cerca di un futuro diverso e migliore. A partire da questo pensiero in rivolta, si può combattere il fanatismo dell’economia: e, di qui, tornare a lottare in vista di una più giusta “città futura”, un luogo comune di umanità in cui ciascuno sia ugualmente libero rispetto a tutti gli altri.

Da sempre, sia pure in forme diverse, gli uomini si ribellano. Difficilmente le rivolte si lasciano ricondurre a un paradigma unitario, ma presentano come orizzonte comune la rivendicata antitesi rispetto a un ordine costituito o a un «comune sentire» che si pretende giusto. La cellula genetica del dissenso corrisponde a un sentire altrimenti che è, già virtualmente, un sentire contro: e che, per ciò stesso, può trapassare nelle figure concrete in cui il dissentire si cristallizza facendosi operativo. Il pensiero ribelle deve costituire oggi il gesto primario contro l’uniformazione globale delle coscienze che si sta registrando nell’orizzonte del nuovo pensiero unico e del falso pluralismo della civiltà occidentale. Diego Fusaro si propone qui di analizzare le figure del pensare altrimenti, le declinazioni storiche del dissenso e la sua fenomenologia.

La farmacia di Epicuro. La filosofia come terapia dell’anima
Fin dall’antichità, il pensiero di Epicuro fu paragonato a un potente farmaco finalizzato a debellare i mali dell’anima che da sempre tormentano l’uomo impedendogli di vivere serenamente: ma sappiamo che il termine greco pharmakon racchiude in sé i due opposti significati di “medicina” e di “veleno “; e, a ben vedere, la stessa duplicità anima la filosofia di Epicuro, che, nella misura in cui si pone come medicina per l’anima umana, assume il carattere di veleno che distrugge dall’interno la filosofia tradizionalmente intesa come disinteressata contemplazione della verità.

Marx, again! The Spectre Returns
In this radical new book, Dr Diego Fusaro examines the current neo-liberal world through the lens of Marx. The present age has declared itself to be post-ideological, and yet it is the most ideological age of all. Only one ideology has survived, linked to capitalism, the very concrete abstraction which dominates as a real economic fanaticism.
“I share Diego Fusaro’s analysis: whereas Marx by himself is not enough today, it is also not possible to understand, criticise and finally overcome the contradictions of triumphant capitalism without Marx. … From Fusaro’s text emerges a Marx who is freed from dogmatism, scientism and the myth of guaranteed progress, but not from the ability to criticise injustice and to propose a real emancipation of humankind. A non-Marxist Marx…” (Gianni Vattimo)

Europa y capitalismo. Para reabrir el futuro.
Se suele presentar a la Unión Europea como la realización perfecta de la idea de una Europa de los pueblos y la libertad. Europa y capitalismo desmonta este modo de entender la realidad. Un análisis cuidadoso y sin condicionamientos ideológicos que revela que, en Europa, se ha producido una «revolución pasiva» (Gramsci) con la que las élites han estabilizado la relación de fuerza capitalista eliminando la potencia que todavía, en parte, se les oponía: el estado nacional soberano, con su preponderancia de la política sobre la economía y sus derechos sociales garantizados. La creación de la Unión Europea, triunfo de un capitalismo ya absoluto, se encargó de desautorizar la hegemonía de la política, dando paso al irresistible ciclo de privatizaciones y recortes del gasto público, de precarización forzosa del trabajo y reducción cada vez más tajante de los derechos sociales, imponiendo la violencia económica en perjuicio de los subalternos y los pueblos de economía más débil. Ejemplos como Grecia ponen de manifiesto esta estrategia. Por eso, hay que recuperar el futuro, en palabras de Fusaro, ya que el único camino pasa ahora por una crítica radical de la Europa del euro y las finanzas.

Europe and capitalism. Regaining the future
The current European Union is too often presented as the Europe of peoples and freedom. This essay overturns this common way of understanding our political reality. In fact, upon closer and unbiased analysis, Europe appears to be the result of a “passive revolution” (Gramsci) through which the dominant class, after 1989, has managed to stabilise capitalist relations of power. This happened at the expense of the force which had partly resisted it: the sovereign nation state, which gave primacy to the political over the economic and guaranteed social rights. Marking the absolute triumph of capitalism, the creation of the European Union has managed to deprive politics of any hegemony: it has paved the way to the unstoppable cycle of privatisations and cuts to public spending, to the enforced precarisation of work and to the ever sharper reduction of social rights, imposing economic violence to the detriment of the subaltern and the economically weakest peoples. For this reason, the only way to open up the future once again, to defend peoples and labour, and to carry on that struggle once fought by Marx and Gramsci, is a radical critique of the euro and contemporary finance.

Ευρώπη και καπιταλισμός
Η σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζεται πολύ συχνά ως η τέλεια πραγματοποίηση της ιδέας μιας Ευρώπης λαών και ελευθερίας. Το παρόν δοκίμιο αντιστρέφει αυτόν τον κοινό τρόπο αντίληψης της πραγματικότητας. Με μια προσεκτική και ιδεολογικά ανεπηρέαστη ανάλυση, η Ευρώπη πράγματι μοιάζει με μια παθητική επανάσταση (Gramsci) όπου οι εξουσιάζοντες μετά το 1989 καθιέρωσαν τον σύνδεσμο της καπιταλιστικής δύναμης: αυτό επετεύχθη απομακρύνοντας τη δύναμη που κατά μέρος μπορούσε ακόμη να τον εξουδετερώσει, αυτή δηλαδή του υπέρτατου εθνικού Κράτους, όπου τον πρωτεύοντα ρόλο είχε η πολιτική πάνω στην οικονομία καθώς επίσης και τα εγγυημένα εθνικά δικαιώματα. Θριαμβεύει λοιπόν ο καπιταλισμός που είναι πλέον απόλυτος, η δε δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέβλεψε να αποδυναμώσει την πολιτική ηγεμονία: άνοιξε τον δρόμο στον ακαταμάχητο κύκλο των ιδιωτικοποιήσεων και της μείωσης της δημόσιας δαπάνης, στην προσωρινότητα της εργασίας και στην ολοένα βεβαιότερη μείωση των κοινωνικών δικαιωμάτων, επιβάλλοντας την οικονομική βία στους εξαρτώμενους και οικονομικά πιο αδύναμους λαούς. Γι’ αυτό τον λόγο η μόνη οδός για να ανοιχτεί εκ νέου το μέλλον, για να υπερασπίζονται οι λαοί και η εργασία και για να συνεχίσουμε τη μάχη του Marx και του Γκράμσι είναι να ξεκινήσουμε από μια κριτική ριζική της Ευρώπης, του ευρώ και των οικονομικών.

Todavía Marx, el último libro de Diego Fusaro, es un libro de filosofía en el que el pensador italiano enlaza el pensamiento de Marx con Hegel y Fichte, y reivindica la pervivencia de un Marx no marxista útil para pensar la coyuntura actual.
Gianni Vattimo, importante filósofo italiano y uno de los principales autores del postmodernismo (discípulo de Hans-Georg Gadamer) afirma en su prólogo para Todavía Marx: “La lucha de clases existe, Marx tenía razón, y la están ganando los dominadores, sin encontrar resistencia por parte de los condenados del planeta, reducidos a ser el sujeto pasivo que padece en silencio. Mientras existan el capitalismo, la lucha de clases, la enajenación y la explotación, Marx estará vivo: es más, será un punto de referencia imprescindible para las luchas cuyo fin sea la liberación.” Y añade: “únicamente Marx […] es insuficiente; pero sin él no se pueden comprender, criticar y, eventualmente, superar las contradicciones del capitalismo actualmente triunfante.”

Fichte e la compiuta peccaminosità. Filosofia della storia e critica del presente nei «Grundzüge»
Scopo del presente studio monografico è un’analisi storicofilosofica dei principali nuclei teorici della filososofia della storia sviluppata da Johann Gottlieb Fichte nelle sue lezioni tenute a Berlino dal 4 novembre 1804 al 17 marzo 1805 e pubblicate nel 1806 con il titolo di Tratti fondamentali dell’epoca presente (Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters). In un costante richiamo delle pregresse acquisizioni teoriche fichtiane, delle filosofie della storia anteriori e successive (kant, Schelling, Hegel) e delle più autorevoli voci della Fichte-Forschung, il saggio esamina in particolare le seguenti categorie concettuali: la divisione dei compiti tra storici e filosofi, il nesso tra filosofia della storia e dottrina della scienza, la relazione tra la libertà degli enti finiti e il “piano del mondo” (Weltplan), la concreta periodizzazione della storia universale e la serrata critica del presente, connotato da Fichte come “epoca della compiuta peccaminosità”.

The Place of Possibility: Toward a New Philosophy of Praxis, Pertinent Press, London 2017
One difference between the economic system in which we live and the systems of the past is that the former does not claim to be perfect. It merely denies the existence of alternatives. For the first time, power does not manifest its qualities, but simply claims that its nature is inevitable. Diego Fusaro’s new essay is a strong rejection, like a whiplash, of the rhetorical claim that reality is an immutable situation and of the habit of accepting it lying down instead of building a better one. This rhetoric gives rise to the principal commandment of Market Monotheism: “thou shalt have no other society before this!” The first task of a philosophy of resistance is to rethink the world as history and possibility, to create the conditions according to which men rediscover themselves as passionate rebels in search of a different and better future. Starting from this revolutionary thought, one can struggle against economic fanaticism and for a fair “city of the future”, a place common to all humanity in which each and every one is equally free compared to all the others.

“Philosophy and Hope: Bloch and Löwith interpreters of Marx”, Mimesis, 2017
“It will then be clear that the world has long possessed the dream of a thing of which it only needs to possess the consciousness in order really to possess it” (Karl Marx). One of the greatest unsolved issues that Karl Marx bequeathed to his interpreters concerns the legitimacy of practical and theoretical hope, both in the frame of his thought and in the wider horizon of philosophy. The entire Marxian work seems to be enigmatically suspended between the opposite dimensions of science and hope. The interpretative lines chosen by Ernst Bloch and Karl Löwith see in Marx a philosopher of hope more than a philosopher of science; and these reflections recognize the inevitable utopian tension in relation to which science is a secondary and functional phenomenon. They both claim that hope is at the heart of Marx’s thought; however, given the antithetic views about this feeling held in their philosophical reflections, they end up with an opposite evaluation of hope. One of the greatest unsolved issues that Karl Marx bequeathed to his interpreters concerns the legitimacy of practical and theoretical hope, both in the frame of his thought and in the wider horizon of philosophy.

Ντιέγκο Φουζάρο, Και πάλι ο Μαρξ
Ένα βιβλίο-ενταγμένο στη σειρά βιβλίων για τα 200 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου στοχαστή, που συμπληρώνονται το 2018-για την επικαιρότητα των σκέψεων του Μαρξ
Ξανά ο Μαρξ. Το φάντασμά του συνεχίζει να πλανάται στην Ευρώπη και στον κόσμο, παρότι υπάρχει η επιθυμία να εξορκιστεί. O νεκρός για τον οποίο μιλάμε, είναι ακόμα ακμαίος και δεν έχει σταματήσει να διασπείρει τον πανικό μεταξύ των ζώντων, καταγγέλλοντας τις αντιφάσεις ενός κόσμου στον οποίο το πραγματικό απέχει μακράν από το νοούμενο ως λογικό.
Η επανεκκίνηση από τον Μαρξ είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε για να βγούμε στο δρόμο ενός διαλεκτικού αντικαπιταλισμού, που οδηγεί τη σκέψη και τη δράση του ανθρώπινου είδους στην τελική απελευθέρωση από τη δικτατορία του κεφαλαίου, με στόχο μία δημοκρατική κοινωνία ελεύθερων, ίσων και αλληλέγγυων ατόμων. Ο Μαρξ συνεχίζει να είναι ο «πυρανιχνευτής» ενός άλυτου προβλήματος που δεν έχει σταματήσει να μας καταδιώκει. Η σκέψη του δεν παύει να μας δείχνει ότι στον κόσμο του υποτιθέμενου «τέλους της ιστορίας» λείπει ακόμα κάτι. Η απλότητα, που είναι τόσο δύσκολο να επιτευχθεί…

Idealismo o barbarie. Por una filosofía de la acción (Trotta, Madrid 2018)
La metáfora de la caverna de Platón es la imagen por antonomasia de la emancipación del género humano. En ella verdad y libertad, contemplación y acción van indisolublemente unidas, pues la conversión al cielo de las ideas implica la exigencia política de que el filósofo baje otra vez a la caverna para liberar a sus conciudadanos. La actitud filosófica es así la propuesta de una alteridad dignificadora que denuncia la injusticia del estado de cosas existente con miras a su transformación. Frente a esta, otra metáfora, la jaula de hierro de Max Weber, se alza como paradigma de la imposibilidad de trascender todo horizonte presente; contra el encantamiento utópico de la fuerza transformadora, el desencanto nihilista que culmina en la figura, hoy hegemónica, de soportar el mundo con cínica resignación.
Este libro invita a construir una razón utópica capaz de vencer a la ideología que entroniza lo existente, esto es, el mercado global transfigurado en jaula de hierro. Bebiendo en las fuentes del idealismo alemán, sobre todo en Fichte, donde halla la inspiración para una filosofía de la acción, y ahondando esta idea de la mano de Marx, Gramsci, Bloch o Gentile, Diego Fusaro plantea una alternativa acuciante: idealismo o barbarie. Ante la apología del fatalismo imperante, el programa de una nueva filosofía de la praxis —que atribuye la primacía ontológica al sujeto que se objetiva en la temporalidad histórica— exhorta a despertar del sueño dogmático de la apraxiacontemporánea y de la pesadilla posmoderna del final de la historia.

Con il 1989 è tramontato il vecchio capitalismo disciplinato dalla potenza degli stati nazionali e dal sistema welfaristico conquistato dalle lotte di classe. Al suo posto si è affermato il capitalismo liquido e finanziario della new economy. La classe borghese e quella proletaria, una volta in conflitto tra loro, sono precipitate nell’abisso e costituiscono la struttura fondamentale della nuova classe dominata: il precariato, composto da una moltitudine di atomi sradicati e senza identità, migranti, senza coscienza di classe e costretti all’erranza nell’open space del mercato mondiale deregolamentato. Un precariato lavorativo ed esistenziale: il nuovo paradigma non tollera alcuna forma di stabilità e di etica comunitaria. La nuova classe dominante, un’aristocrazia finanziaria apolide, sta annientando uno dopo l’altro tutti i vecchi fondamenti del mondo proletario e borghese: dalla famiglia al lavoro garantito, dai diritti sociali alla cittadinanza. E’ questo il teatro del nuovo conflitto di classe nel quadro della mondializzazione: uno scenario ”tremendo, ma non irrimediabile.”

“Antonio Gramsci. La pasión de estar en el mundo” (Akal, Madrid 2018)
En el presente que vivimos, donde el capitalismo voraz engulle cualquier esperanza de los de abajo por cambiar el mundo, se hace más urgente que nunca partir de Gramsci para tomar impulso, heredar su espíritu y actualizar su filosofía.
Tomar impulso desde Gramsci supone adoptar una postura crítica frente a las contradicciones que impregnan el tiempo presente y liberarse de la pereza e indiferencia de quienes viven pasivamente los acontecimientos como si fueran el producto de una necesidad histórica inescrutable. Heredar su espíritu significa metabolizar su conciencia infeliz y no reconciliada, ejercitar la pasión duradera por un futuro más justo, perseguir una felicidad superior y enarbolar el valor de la política. Actualizar su filosofía es recuperar un humanismo radical que, haciendo del ser humano el libre creador de su mundo, tenga como objetivo redimir el dolor de los humillados y ofendidos. Partir de Gramsci entraña, en suma, combatir en nombre de una humanidad más justa y por una sociedad menos indecente.
En Antonio Gramsci. La pasión de estar en el mundo, Diego Fusaro presenta un marco general impresionista de la figura del intelectual sardo y nos invita a heredar y actualizar su pensamiento.

Diego Fusaro’s monograph on Epicurus’ influence on Marx’s philosophy is multi-layered. Not only does it explain Epicureanism and its impact on a young Marx, but it also manages to do unto Marx what Marx did unto Epicurus, as Marx employed Epicurus’ critical stance toward Plato and Aristotle to drop not-so-subtle hints about the philosophy and politics of contemporary Germany.
Fusaro, described by the influential paper La Repubblica (July 2013) as “possibly the brightest star in the Italian philosophical firmament of our times”, employs Marx’s critique of nineteenth century Germany to propose a critique of the present – a critique of economic libertarianism and moral libertinism. Fusaro’s underlying argument is that we live in times that are nothing but Epicurean, where the pensée unique is dogmatic and hedonistic liberalism.
This book combines the exoteric and the esoteric. Exoterically, it analyses of Karl Marx’s long-ignored University dissertation and the influences of Greek Atomism on Marx’s thought system. Esoterically, or by implication, it analyses our contemporary world.
Fascinatingly and breathtakingly written in a flowing and fast-paced style, Anna Carnesecchi’s translation succeeds in conveying the original’s urgency and clarity in beautiful prose which satisfies scholar and layman alike.

Diego Fusaro, “Filosofía y esperanza. Ernst Bloch y Karl Löwith” (El Viejo Topo, Barcelona 2018)
En este Filosofía y esperanza. Ernst Bloch y Karl Löwith, intérpretes de Marx, el filósofo italiano Diego Fusaro retoma el famoso principio de esperanza de Bloch y lo confronta con el pensamiento de Löwith, para proyectar ambos sobre la obra de Karl Marx. Y es que uno de los principales problemas no resueltos que Marx le ha dejado en herencia a sus intérpretes concierne a la legitimidad de la esperanza en la práctica y en la teoría, tanto en el marco de su pensamiento como en el horizonte más amplio de la filosofía.
Así, toda la obra marxiana está suspendida enigmáticamente entre dos dimensiones opuestas: la ciencia y la esperanza. La línea interpretativa adoptada por Ernst Bloch y Karl Löwith ve en Marx al filósofo de la esperanza más que el de la ciencia, reconociendo en su reflexión una tensión utópica ineludible frente a la cual la ciencia sería un fenómeno secundario y funcional. Ambos reconocen la centralidad del momento de la esperanza en Marx, pero en virtud de las concepciones antitéticas de este sentimiento que hacen valer en su propia reflexión filosófica, terminan por evaluarlo de manera opuesta.
Ahora este texto breve pero sustancioso describe a Karl Marx como un filósofo de la esperanza.

Benedikt Kaiser, Alain de Benoist, Diego Fusaro, “Marx von rechts” (Jungeuropa Verlag, 2018)
Karl Marx ist zurück! Und er überrascht viele seiner heutigen Leser. Denn noch immer sind viele der von ihm aufgeworfenen Fragen aktuell, noch immer finden sich in seinen Schriften Problemstellungen, die im 21. Jahrhundert besonders relevant werden.
Obwohl anläßlich des 200. Geburtstag des Philosophen im Jahr 2018 kein Mangel an neuer Marx-Literatur herrscht, wird doch deutlich: Die Linke kommt ihrem Auftrag als Verwalter des großen Werkes nicht mehr nach. Sie verliert sich in Detailstudien und ideologischen Sackgassen.
Alain de Benoist, Benedikt Kaiser und Diego Fusaro machen sich deshalb auf, unkonventionelle Fragen zu stellen und nonkonforme Antworten zu geben: Marx von rechts – das heißt Abschied vom Marxismus, ohne dem Neoliberalismus auf den Leim zu gehen.
Der Marxismus ist tot, es lebe Marx?

“Encore Marx! Le spectre qui revient” (Ovadia, Nice 2018)
L’aspiration au communisme, aujourd’hui, dans le monde post-1989, ne semble pouvoir exister qu’en tant que réminiscence d’un monde alternatif auquel on est resté sentimentalement attaché : comme s’il s’agissait d’une utopie prématurément abandonnée ; une utopie vers laquelle, en ces moments de crise, l’on pense se tourner. Toutefois, évoquer le «spectre» qui, à l’époque de Marx, rôdait déjà autour de l’Europe et qui aujourd’hui est devenu encore plus fantasmatique ne signife pas seulement prendre acte de la faillite – évidente sur toute la ligne – des prétendues vertus salvatrices du capitalisme et de l’économie du «libre marché », système que l’idéologie contemporaine a érigé en paradigme unique de notre société.
«Marx avait raison: la lutte des classes existe, mais ce sont les dominants qui sont en train de la gagner, sans rencontrer de résistance de la part des offensés de la planète, réduits à subir en silence, dans une condition de passivité. Tant que le capitalisme, la lutte des classes, l’aliénation et l’exploitation seront là, Marx aussi sera vivant et il sera même le point de repère incontournable de toutes les luttes de libération. Sur ce point, je partage la lecture de Diego Fusaro: Marx à lui tout seul est aujourd’hui insufsant, mais, sans Marx, il est impossible de comprendre, de critiquer et, le cas échéant, de dépasser les contradictions du capitalisme actuellement triomphant» (Gianni Vattimo).

Diego Fusaro, “Epicurus’s Pharmacy. Philosophy as Therapy for the Soul” (Mimesis, London 2018)
Since antiquity, Epicurus’ thought has been compared to a powerful drug able to cure the pains of the soul that have always tormented man preventing him from living a peaceful existence: but we know that the Greek term pharmakon can be interpreted in its two opposite meanings of medicine and poison; and indeed, the same duplicity animates Epicurus’ philosophy which, by acting as a medicine for the human soul, also has the effect of a poison, destroying from within, philosophy traditionally conceived as a disinterested contemplation of truth. The philosophical revolution undertaken by Epicurus as a fracture with respect to all the previous tradition, from Thales to Aristotle, coincides with an inversion of the traditional relation between man and cosmos, between theory and practice: the classic question “what is reality made of?” is replaced by the Epicurean question that is at the basis of his philosophical anthropocentrism: “how must reality be made and how should one understand it in order to be happy?”. Each specific articulation of Epicurean philosophy is subordinate to the task of achieving a happy existence that is in no way inferior to any of the divine realities.

Diego Fusaro, “Il nuovo ordine erotico. Elogio dell’amore e della famiglia” (Rizzoli, Milano 2018).
C’è stato un tempo in cui il diktat del capitale conosceva dei limiti. Si arrestava ai cancelli della fabbrica: oltre, la vita scorreva in forme che non si lasciavano imbrigliare nell’orizzonte limitato della logica di produzione e dello scambio di merci. Quel tempo è ormai lontano. Oggi, alla società basata sull’economia di mercato si è sostituita una società di mercato e basta. Viviamo in un mondo «a capitalismo integrale e mercificazione sconfinata». Il che, è chiaro, coinvolge anche la sfera dell’affettività e dell’erotismo. Il globalitarismo al potere – nuovo totalitarismo glamour onniavvolgente – ci vuole precari e omologati, neutri anche in amore. Novelli Don Giovanni, figura emblematica dell’instabilità amorosa e dell’isolazionismo sentimentale. Le relazioni solide, basate su progetti di vita condivisi e una visione dell’amore come forza eterna, cedono il passo a forme consumistiche di rapporto: incontri fugaci e privi di conseguenze, legami occasionali facili tanto da instaurare quanto da spezzare, sesso virtualizzato e rapporti online. Dalla precarizzazione erotica e sentimentale alla femminizzazione del maschio, dal nuovo femminismo postmoderno alla crisi della famiglia, dalla gendercrazia al trionfo del neutro indifferenziato unisex, Diego Fusaro accompagna il lettore attraverso i temi principali di una riflessione che ci coinvolge tutti, in quanto esseri eminentemente amorosi. E se a cadere sono addirittura i fondamenti più intimi del rapporto interpersonale, cosa può esserne della struttura sociale che ci accoglie, della nostra «famiglia allargata»?

“Marx y el atomismo griego”, del filósofo italiano Diego Fusaro, rastrea el influjo de Epicuro. Y no solo en el conocido trabajo universitario, sino en el conjunto de su obra. Y llega a la conclusión de que es de Epicuro de quien Marx toma la idea de un “materialismo de la libertad”.
Tradicionalmente se ha dicho que las “tres fuentes” de Karl Marx fueron la filosofía clásica alemana, el socialismo francés y la economía política inglesa. Que se inspiró en estas tres grandes corrientes está fuera de toda duda. Pero, ¿son solo estas tres corrientes de pensamiento las que gravitaron sobre el fundador de la concepción materialista de la historia?
De esas tres fuentes Marx habría derivado el democratismo igualitario y la idea de una asociación fundada en la participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones (Rousseau), el método dialéctico y la importancia decisiva de la historia (Hegel), y la idea según la cual el fundamento de la propiedad es el trabajo (Adam Smith y después David Ricardo). Pero en sus teorías aparece una cuarta fuente, a la que no se le ha prestado la debida atención: Epicuro, de quien tomó la idea de un “materialismo de la libertad”. Un materialismo que hace hincapié en la importancia de la praxis y que se metaforiza en la teoría del ‘clinamen’.

“Marx idealista. Per una lettura eretica del materialismo storico” (Mimesis, Milano 2018)
Il pensiero di Marx può essere interpretato come il compimento della filosofia dell’idealismo tedesco? In questi saggi Diego Fusaro analizza l’ontologia marxiana al di là delle apparenze e dei luoghi comuni proposti dal marxismo classico, per rintracciare i punti di consonanza non immediatamente evidenti tra il pensiero del filosofo tedesco e le modalità avanzate dall’idealismo classico. Ciò che emerge è un conflitto a tratti paradossale: da una parte, la volontà manifesta di abbandonare l’idealismo hegeliano, dall’altra, l’effettivo permanere di Marx su questo terreno.

“La farmacia di Epicuro. La filosofia come terapia dell’anima” (ed. serba, 2018)
Унија синдиката просветних радника Србије ће ове године по други пут самостално учествовати на 49. Сајму образовања и наставних средстава који се одвија у склопу 63. Београдског међународног сајма књига, у периоду од 24. до 28. октобра 2018. године. Представљамо вам књигу Диега Фузара “Лечење Епикуром”.

“Globalización infeliz Once tesis filosóficas sobre el devenir mundo del mercado” (Tirant lo Blanch, Barcellona 2019)
Entre las tareas principales de la filosofía, entendida como arte crítico en busca de la verdad, también está la deconstrucción de las ideologías: es decir, de
aquellas narraciones que se hacen pasar por verdades universales, cuando en realidad son solo la máscara que oculta y reconoce el interés de una parte. La
globalización es, entre todas, la mayor ideología del nuevo milenio. Con su encantadora retórica celebra el espacio abierto de un mundo sin fronteras donde
domina la libre circulación de toda realidad. Pero, en verdad, es el nuevo campo de lucha del capitalismo que se ha hecho planetario. Este, gracias a la unificación del globo bajo el signo de la forma mercancía y de sus patologías, puede explotar ilimitadamente el planeta, crear competitividad a la baja entre los trabajadores de todo el mundo y exacerbar las desigualdades. Con la ayuda de Hegel y Marx, de Gramsci y Heidegger, el libro intenta reconstruir a contracorriente, en
clave filosófica, la verdadera esencia de la globalización como triunfo del capitalismo planetarizado.

Diego Fusaro, “Marx idéaliste.
Essais hérétiques sur son matérialisme” (Mimesis France, Paris 2019)
Peut-on interpréter la pensée de Marx comme l’accomplissement ultime de l’idéalisme allemand ?
Dans cet essai, Diego Fusaro analyse l’ontologie marxienne au-delà des apparences et des lieux communs avancés par le marxisme classique, pour souligner les points de ressemblance – qui ne seraient pas immédiatement évidents – entre la pensée du philosophe allemand et la démarche classique de l’idéalisme.
Ce qui en ressort, c’est le paradoxe d’un conflit : d’un coté, la volonté manifeste de Marx d’abandonner l’idéalisme hégélien, de l’autre, son évidente persistance à se situer sur ce terrain.

Diego Fusaro e Silvio Bolognini, “Il nichilismo dell’Unione Europea” (Armando, Roma 2019)
Nel 1940, Martin Heidegger tenne un celebre ciclo di lezioni che, destinate a sfociare nel monumentale studio su Nietzsche, vennero pubblicate con l’evocativo titolo di “Der europäische Nihilismus”, “Il nichilismo europeo”. Sulla scorta di un Nietzsche riletto in chiave ontologica come Vollendung, come “compimento” tecnocapitalistico della metafisica e del suo “oblio dell’essere” (Seinsvergessenheit), Heidegger individuava nel nichilismo l’ombra segreta dell’avventura storica dell’Europa. Approfondendo i fattori di scenario e strumentali che attivano in ambito europeo le condizioni per la costruzione e istituzionalizzazione del paradigma (quali le politiche di coesione, la governance multi livellare, la catena del valore prescrittivo, il partenariato pubblico e privato, i criteri di valutazione delle progettualità, il sistema degli indicatori e delle buone prassi) è possibile individuare nel sub paradigma espresso dalla locuzione smart city una declinazione elettiva, una sorta di distillato della visione in oggetto. È conseguentemente doveroso segnalare i rischi di una adesione acritica alla retorica di tale visione che tende ad essere sempre più autoreferenziale, prefigurando la violazione di alcuni fondamentali diritti negli scenari inquietanti della città iper-tecnologizzata del prossimo futuro e producendo implicazioni negative sulla partecipazione dei cittadini alla vita politica.

“Caro Epicuro. Lettere sui grandi temi della vita e della filosofia” (Piemme, Milano 2020)
«Caro Epicuro, è di felicità che oggi vorrei parlarti…». Esordisce così Diego Fusaro nella prima di quasi 90 lettere a Epicuro, l’interlocutore immaginario al quale si rivolge per affrontare altrettanti temi che riguardano il nostro stare al mondo: Amicizia, Amore, Felicità, Anima, Dono, Comunità, Tempo, Lavoro, Dialogo, Ideologia, Volontà… Perché proprio Epicuro?, si chiederà chi legge. Perché rappresenta la filosofia nella piena aderenza alla vita reale e ai suoi problemi. Non c’è un’età ideale per fare filosofia. Tutti possiamo avere a un certo punto la curiosità – o la necessità – di interrogarci sulla nostra esistenza, sui sentimenti che ci animano e il mondo che ci circonda. Ecco dunque la vera sfida che l’autore ha raccolto scrivendo questo libro: avvicinare alla filosofia i lettori di qualsiasi età in modo chiaro, accessibile, non dottrinale, amichevole. Perché, scrive, «tutti noi disponiamo – talvolta, senza neppure saperlo – di una nostra “filosofia primitiva”, un quadro complessivo di senso mediante il quale interpretiamo l’accadere e la nostra esistenza, il rapporto con gli altri e con il reale».

“Difendere chi siamo. Le ragioni dell’identità italiana” (Rizzoli, Milano 2020)
Già Pasolini, in tempi non sospetti, aveva inquadrato il nuovo potere globalista come «il più violento e totalitario che ci sia mai stato: esso cambia la natura della gente, entra nel più profondo delle coscienze». E non è un caso se si era spinto a parlare, con lucida lungimiranza, di «genocidio culturale».Mascherandosi dietro un multiculturalismo di facciata, che è solo la riproposizione infinita dello stesso modello politically correct, la civiltà globale in cui viviamo non accetta infatti differenze. Esiste un unico profilo consentito: quello del consumatore sradicato, indistinguibile dagli altri, senza identità né spessore culturale. Per usare le parole di Fusaro, il globalismo si fonda su un’inclusione neutralizzante: «in nome del mercato unificato, opera affinché ogni ente si muti in merce liberamente circolante, senza frontiere politiche e geopolitiche, morali ed etiche, religiose e giuridiche». In quest’ottica distorta, ogni tradizione è sacrificata sull’altare del finto progresso turbocapitalista, che vuole «non popoli radicati nella loro storia e nella loro terra, né soggettività dall’identità forte e capaci di opporre resistenza, bensì consumatori dall’io minimo e narcisista, con identità liquide, gadgetizzate ed effimere». Acquirenti indistinti cui vendere ovunque la stessa illusione.Come possiamo opporci a quest’imperante «eterofobia»? Recuperando e difendendo il valore della nostra identità, che si definisce solo nel dialogo con le differenze dell’altro. In questo saggio acuto e provocatorio, la voce critica di Diego Fusaro ci invita dunque a riappropriarci delle nostre radici; a rieducarci – e rieducare soprattutto i più giovani, condannati a un futuro precarizzato che rischiano di accettare supinamente – al «sogno di una cosa», come diceva Marx. All’immagine di un futuro meno indecente di quello che ci vede solo come merce tra le merci.
«Una tale uguaglianza in cui scompaiono le differenze favorisce nascostamente la disuguaglianza.» T.W. Adorno, Dialettica negativa

Diego Fusaro,
“Marx idealista. Para una lectura herética del materialismo histórico”, El Viejo Topo, Barcelona 202
¿Puede interpretarse el pensamiento de Marx como el corolario de la filosofía idealista alemana? Para el joven filósofo italiano, Marx no consiguió zafarse por completo del idealismo, y para ello rastrea y analiza la obra marxiana (singularmente las Tesis sobre Feuerbach, pero no solo) y la relaciona con aspectos de los escritos de Hegel, Fichte, Sterner o Preve.
En este ensayo Fusaro analiza la ontología marxiana más allá de la apariencia y los lugares comunes propuestos por el marxismo clásico. Y lo hace para entretejer aspectos no inmediatamente evidentes entre el pensamiento del filósofo alemán y las formas avanzadas del idealismo clásico.
Lo que emerge es un conflicto con rasgos paradójicos: de una parte, la voluntad manifiesta de abandonar el idealismo hegeliano; de otra, la permanencia efectiva de Marx en ese terreno. Marx idealista es una obra intensamente polémica que rompe los esquemas habituales al respecto.
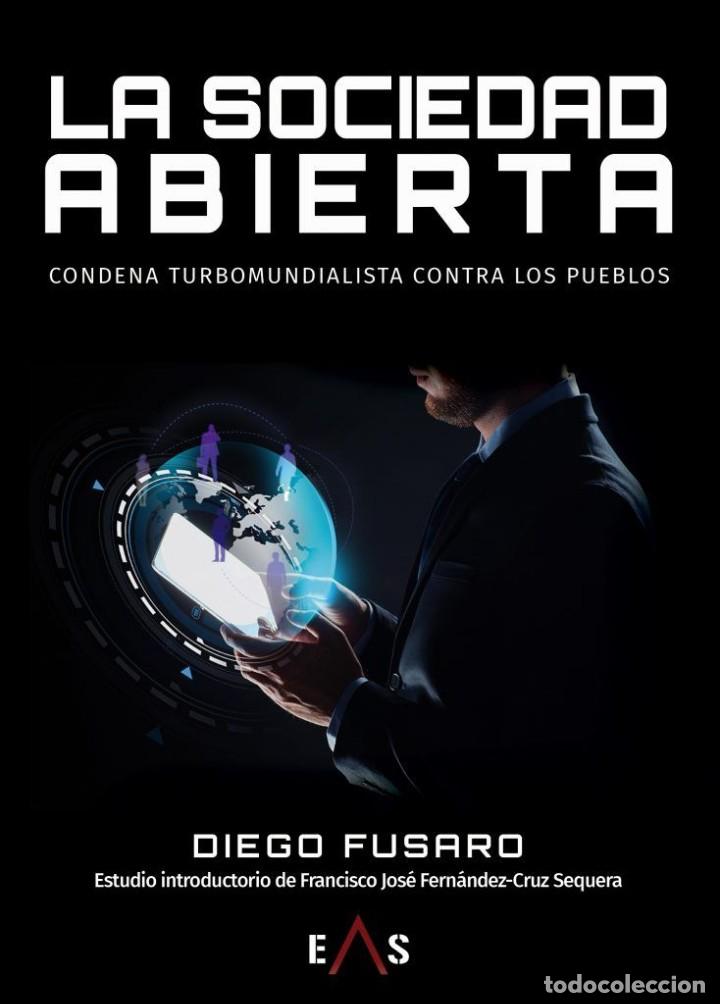
Diego Fusaro, “La sociedad abierta: Condena turbomundialista contra los pueblos” (Eas, Madrid 2020)
El grado de libertad de la actual sociedad y por ende, de cada uno de los individuos que la componen, va directamente relacionado con el poder adquisitivo de los mismos, ya que la sociedad es valorada como mercancía, esta “mercancía” a su vez será libre en función de la libertad de mercado.
La sociedad abierta postmoderna y globalizada coincide así con el espacio global e ilimitado del mercado desregulado, donde todo –mercancías y personas mercantilizadas– circula sin trabas y según la lógica de la valoración: este espacio abierto sin fronteras se presenta según el orden ideológico como universalmente bueno y justo, cuando es un espacio solo para los señores del turbocapital, que encuentran en él el terreno ideal para el triunfo de su clase y, por tanto, para la masacre unívocamente realizada contra los perdedores de la globalización.
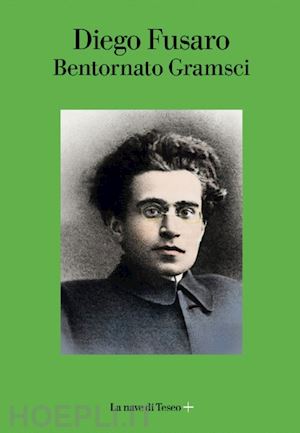
“Bentornato Gramsci. Undici tesi di filosofia della prassi” (La Nave di Teseo, Milano 2021)
Egemonia e intellettuali, nazionale-popolare e cultura rivoluzionaria: questi alcuni dei concetti fondamentali della costellazione teorica elaborato da Antonio Gramsci nella sua lunga reclusione carceraria. Può essa, e in che misura, aiutare a fare luce sul caotico e contraddittorio presente di cui siamo abitatori? Che cos’ha ancora da dirci Gramsci nel tempo della globalizzazione mercatista e della vittoria del capitalismo finanziario? Questo libro prova a ripensare radicalmente Gramsci. E lo fa individuando nella sua ” filosofia della prassi” la chiave indispensabile per comprendere teoricamente e per risolvere praticamente le contraddizioni che infettano la nostra epoca; quella che, con la rassicurante etichetta di ” fine della storia”, ha provato, dal 1989 a oggi, a mettere in congedo ogni possibile idea di futuro che non fosse la ripetizione tautologica del presente a forma di merce. Un saggio avvincente che supera tanto l’idealismo quanto il materialismo e getta nuova luce sull’opera e sul pensiero di una tra le figure intellettuali e politiche più importanti del Novecento.

“Historia y conciencia del precariado” (Alianza, Madrid 2021)
En 1989 comenzó el declive del viejo capitalismo disciplinado de los estados nacionales y del sistema de bienestar conquistado con las luchas de clase. En su lugar se afirma el capitalismo líquido y financiero de la ‘new economy’. La clase burguesa y la proletaria constituyen la estructura fundamental de la nueva clase dominada: el precariado, compuesto por una multitud de átomos desarraigados y sin identidad, migrantes, sin conciencia de clase en el ‘open space’ del mercado mundial desregulado. Un precariado laboral y existencial: el nuevo paradigma no tolera forma alguna de estabilidad ni de ética comunitaria. La nueva clase dominante, una aristocracia financiera, está destruyendo los antiguos fundamentos del mundo proletario y burgués: de la familia al trabajo asegurado, de los derechos sociales a la ciudadanía.

“Pensar diferente. Filosofía del disenso” (Trotta, Madrid 2022, traducción de Michela Ferrante)
Desde siempre los seres humanos se rebelan. Lo hacen de múltiples y variadas maneras que no se dejan encasillar fácilmente en un paradigma único y que, sin embargo, tienen como horizonte común la oposición, la protesta, la antítesis reclamada frente a un orden establecido o, más simplemente, frente a un «sentir común», a un consenso que pretende ser el único legítimo. La revolución y la rebelión, la defección y la protesta, la revuelta y el motín, el antagonismo y el desacuerdo, la insubordinación y la sedición, la huelga y la desobediencia, la resistencia y el sabotaje, la contestación y la sublevación, la guerrilla y la insurrección, la agitación y el boicot son todas figuras proteicas del disenso, expresiones plurales que encuentran su fundamento en la única matriz del «sentir diferente» ante el orden, el poder, el discurso dominante. El pensamiento rebelde debe constituir hoy el gesto primario contra la uniformización global de las conciencias que se registra en el espacio del nuevo pensamiento único y del falso pluralismo de la civilización occidental. Este libro analiza las figuras del pensar diferente, las declinaciones históricas del disenso y su fenomenología.

“Golpe globale. Capitalismo terapeutico e grande reset” (Piemme, Milano 2021)”
La gestione della pandemia di Covid-19 lascerà un’impronta minacciosa e duratura sul futuro dell’umanità, al di là degli aspetti sanitari. In questo libro Diego Fusaro, filosofo del “pensare altrimenti” e celebre voce fuori dal coro nel dibattito italiano, mostra come l’emergenza sia diventata un vero e proprio metodo di governo. Il potere sfrutta la paura del contagio per ristrutturare in senso oligarchico e autoritario tanto la società quanto l’economia e la politica. Mentre diritti e libertà fondamentali vengono sospesi. Le classi dominanti hanno approfittato dell’emergenza epidemiologica per accelerare tutti i processi già avviati nella globalizzazione capitalistica: il superamento delle già fragili democrazie parlamentari, la neutralizzazione del dissenso, la riorganizzazione autoritaria dei rapporti di forza, la distruzione programmatica delle classi lavoratrici e dei ceti medi all’ombra dei signori della finanza e dei colossi dell’e-commerce e del web. Per questo Fusaro arriva a parlare di un golpe globale: l’ideologia medico-scientifica (da distinguere dalla scienza vera e propria) ha imposto una gestione del virus all’insegna dello stato di eccezione permanente. La svolta autoritaria di tipo post-nazionale che ne è seguita – e che qualcuno ha definito “Grande Reset” – sembra voler instaurare una nuova normalità, contro cui il filosofo invita a resistere.

La Erste Einleitung del 1797 è un testo di primaria importanza nel percorso formativo di Fichte e nell’evoluzione della “dottrina della scienza”. Per un verso, Fichte mette a tema una serie di acquisizioni teoretiche fondamentali, che segnano un “superamento” delle prime versioni della dottrina della scienza e un perfezionamento del suo “sistema della libertà”. Per un altro verso, egli formula in modo accessibile e più “popolare” i guadagni teorici della sua impresa filosofica: a tal punto che il testo sembra, a tratti, assumere la forma di un incendiario pamphlet di appassionata difesa dell’idealismo contro il dogmatismo. Due soltanto sono i sistemi filosofici, spiega Fichte: da un lato, il dogmatismo realista che sacrifica l’Io sull’altare della realtà data; dall’altro, l’idealismo trascendentale, che tutto riconduce all’attività dell’Io. Benché soltanto il secondo sistema possa rendere conto del reale nella sua complessità, nessuno dei due sistemi può “sconfiggere” teoricamente l’altro. Sicché la scelta per il dogmatismo o per l’idealismo deve essere di ordine pratico: essa rinvia, in ultima istanza, a un diverso rapporto pratico con il mondo. Sceglierà il dogmatismo l’animo pigro, che – “come un pezzo di lava sulla luna” – accetta passivamente ciò che c’è come pura presenza data. Opterà, invece, per l’idealismo il soggetto responsabile, che ritiene che nulla sia immodificabile e che tutto possa e debba essere trasformato in vista del suo perfezionamento. La Erste Einleitung può, così, oggi anche essere letta in certa misura come un “manifesto” della filosofia dell’azione per il tempo presente, paralizzato nell’incubo dell’end of history e nel dogmatismo generale che la accompagna.

“Odio la resilienza. Contro la mistica della sopportazione” (Rizzoli, Milano 2022)
Si fa un gran parlare di resilienza. Viene descritta come la virtù dell’uomo che ha capito come va il mondo. Nulla può spezzare il resiliente, perché è capace di assorbire qualsiasi colpo e resistervi, come il metallo regge l’urto e riprende la forma originaria. Tutti i media ne parlano in questi termini, ricorre nei discorsi dei governanti, abbonda nelle narrazioni sulla collettivi-tà. Ma la resilienza è una favola, ci dice Diego Fusaro. Una fiaba della buonanotte cantilenata al fine di stordirci e farci assopire. È un incubo che minaccia il nostro futuro.L’uomo resiliente è il suddito ideale. Si accontenta di ciò che c’è perché pensa che sia tutto ciò che può esserci. Non conosce nulla di grande per cui lottare e in cui credere. Ha abbandonato gli ideali e vivacchia convincendosi che il suo compito, la sua missione, sia di accettare un destino ineluttabile. Anzi, viene portato a pensare che proprio nella passività possa dare il meglio di sé.È storia vecchia. Da sempre chi ha il potere ci chiede di subire in silenzio, di sopportare con stoica resilienza per poter agire indisturbato. Ma in questi anni ce lo chiede ancora di più: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di Mario Draghi ne è un esempio lampante, ma già nel 2013 il «dinamismo resiliente» era la parola d’ordine del World Economic Forum. Perché, certo, la resilienza è un profilo psicologico, ma anche un atteggiamento politico. I cittadini sono chiamati a fare propria la virtù dell’adattarsi senza reagire alle storture invocando il cambiamento. Non è forse il sogno inconfessabile di ogni padrone quello di governare schiavi docili e mansueti? Eppure “vivere vuol dire adoperarsi per cambiare il mondo con i propri pensieri e con le proprie azioni” scrive l’autore: una vera e propria chiamata alle armi. “Riprendiamoci le nostre passioni annichilite da questa docilità. Frangar, non flectar.”

La desacralizzazione e la scristianizzazione accompagnano il destino dell’uomo occidentale. La civiltà del capitalismo assoluto, che basa il suo dominio sul nichilismo relativista e sulla volontà di potenza tecnoscientifica, non solo non ha più bisogno di affidarsi, come un tempo, alla religione quale strumento di potere: deve necessariamente promuoverne l’estinzione. Con il suo richiamo al sacro e alla trascendenza, alla dignità dell’uomo come immagine di Dio e all’idea di una verità non utilitaristica, la religione cristiana resta infatti una “potenza frenante” rispetto al nulla della civiltà merciforme e del fanatismo economico. Per Diego Fusaro questo pernicioso processo di desacralizzazione si manifesta al livello più preoccupante nel pontificato di Francesco, e nel suo tentativo di scendere a patti con la civiltà dei consumi, assimilandone il lessico e la visione del mondo – anche se in salsa progressista. Come la perestrojka proposta da Gorbacëv per “ammodernare” il comunismo produsse il suo scioglimento nel capitalismo, così la modernizzazione combattuta da Ratzinger e difesa da Bergoglio non porta il cristianesimo alla sopravvivenza, ma alla dissoluzione. La fine del cristianesimo è un atto d’accusa filosofico contro la fede “liquida” e low cost, e insieme un invito a riscoprire il messaggio di Pasolini, secondo cui «l’opposizione al nuovo potere non può che essere un’opposizione anche di carattere religioso». Per Fusaro, contro lo spirito del tempo presente è irrinunciabile un’alleanza tra la Chiesa resistente al modernismo nichilista e le forze laiche anticapitalistiche che non intendono soggiacere al consumismo imperante.

Al governo dei Paesi occidentali si alternano partiti di destra e di sinistra, eppure nulla sembra cambiare davvero per il popolo e le sue istanze. È ciò che Diego Fusaro chiama alternanza senza alternativa, con le fazioni della vecchia politica «egualmente sussunte sotto l’ordine neoliberale». Quelli che un tempo erano schieramenti in lotta per due opposte visioni del mondo e dell’agire politico sono ormai le fac-ce intercambiabili della stessa medaglia: l’agenda turbocapitalista. La sinistra ha abdicato al suo ruolo di strumento di emancipazione globale; e, nei fatti, la destra cosiddetta sovranista non si cura minimamente del popolo sovrano. Siamo così passati dalla democrazia – il governo del popolo, nella dialettica delle sue articolazioni – alla demofobia: la paura del popolo da parte di chi gestisce monoliticamente il potere. Oggi la «destra bluette» del denaro e la «sinistra fucsia» del costume non sono altro che le due ali dell’aquila neoliberale, parti organiche al medesimo sistema, che «si riproduce economicamente a destra, politicamente al centro e culturalmente a sinistra». Così il partito unico del capitale e della sua omogeneità bipolare egemonizza lo spazio politico, e «dall’alto vola rapacemente verso il basso, aggredendo ceti medi e classi lavoratrici, popoli e nazioni». Ci troviamo insomma dinanzi a una «rivoluzione spaziale» della filosofia politica, che impone la teorizzazione di una nuova geografia e di una rinnovata topografia, in cui l’asse interpretativo più utile e appropriato è appunto quello dell’opposizione alto-basso: tra le élite finanziarie globaliste e il popolo. Comprendere la natura profonda di tale scenario è il primo passo per riportare al centro dell’agire sociale e politico il benessere dei popoli-nazioni, la loro sovranità e identità.

“El nuevo orden erótico. Elogio del amor y de la familia” (El Viejo Topo, Barcelona 2022)
Hubo un tiempo en que la tenaza del capital conocía límites. Se detenía en las puertas de la fábrica: más allá, la vida discurría en formas que no se dejaban enjaular en el horizonte limitado de la lógica de la producción y el intercambio de mercancías. Pero ese tiempo ya no existe. Hoy, la sociedad basada en la economía de mercado ha sido reemplazada por la sociedad de mercado a secas. El nuevo orden del sistema del libre mercado absoluto requiere la liberalización no solo del consumo, sino también de las costumbres; requiere precariedad incluso en el amor. Las relaciones sólidas, basadas en proyectos de vida compartidos y una visión del amor como fuerza eterna, han dado paso gradualmente a formas consumistas de relación: encuentros fugaces y sin incidentes, vínculos ocasionales tan fáciles de establecer como de romper, sexo virtualizado y relaciones on line. Hemos pasado de la precarización erótica y sentimental a la feminización del varón, del nuevo feminismo posmoderno a la crisis de la familia, de la gendercracia al triunfo del indiferenciado unisex, del “para toda la vida” a la inestabilidad amorosa y el aislacionismo sentimental. Aquí, Diego Fusaro acompaña al lector por los ejes temáticos de una reflexión que nos involucra a todos, como seres eminentemente amorosos que somos. Y nos invita a reflexionar sobre el nuevo orden amoroso globalizado y desregulado, descubriéndonos que el laissez-faire del liberalismo económico y del liberalismo sentimental son –paradójicamente– dos caras de la misma moneda.

La dittatura del sapore (Rizzoli, Milano 2024)
Hamburger di carne sintetica, panini con i grilli, patatine di farina di mosca: in nome del rispetto dell’ambiente e della salute, il nuovo menù del mondo globalizzato mette al bando ciò che per secoli ha plasmato la nostra identità alimentare, dal vino all’olio d’oliva, dalle carni al pane, annientando ogni diritto alla pluralità, alla differenza e al locale. Anche a tavola, nel modo in cui pensiamo, produciamo, prepariamo, gustiamo il cibo, si sta assistendo all’imposizione di un unico modello ammesso e autorizzato: il nuovo codice gastronomicamente corretto, applicato allo stesso modo in ogni angolo del pianeta, non è altro che la variante alimentare del politicamente corretto, proprio come il piatto unico è l’equivalente del pensiero unico. Diego Fusaro punta il dito sulla deriva in corso, ne smaschera la grigia ideologia omologante, ne denuncia gli effetti disastrosi – perdita della convivialità, della valenza simbolica e culturale del cibo, aumento delle disuguaglianze e dell’asimmetria tra i primi e gli ultimi – e insieme propone una nuova filosofia del mangiare bene in cui il cibo torni ad alimentare le teste oltre che le pance.

Odio la resiliencia (Viejo Topo, 2024)
Resiliencia: una palabra de uso corriente en los discursos de la política desde que en 2013 Obama la lanzara en el Foro de Davos. Los principales líderes políticos de Occidente la adoptaron inmediatamente y la han promovido con insistencia. Pero, ¿qué es la resiliencia? Para los legos, su significado es equivalente al de “resistencia”. Pero no es así. Podemos leer en un diccionario que “resiliente” es aquel que manifiesta la “capacidad de re- surgir de experiencias difíciles, adversidades, traumas, tragedias, amenazas, manteniendo una actitud positiva al afrontar la existencia”. En la práctica, es el que sufre y supera la desgracia y que, frente a la injusticia, en lugar de rebelarse prosigue su camino adaptándose e ignorando la existencia de las cadenas que lo tienen sometido. Es decir, El homo resiliens ha aceptado ser sumiso en lugar de revolucionario, adaptable en lugar de contestatario. Ha optado por hablar el idioma de su enemigo de clase, creyendo en el progreso y sobre todo asumiendo mansamente el comportamiento que los amos siempre han soñado de los esclavos. ¿No es acaso el sueño inconfesable de todo amo gobernar esclavos dóciles y sumisos, en una palabra, resilientes?

Il cervello della passione. Marx e la critica del capitale (Mimesis, Milano 2019)
Dopo “Marx idealista”, Fusaro con questo volume prosegue la sua opera di rilettura critica del pensiero di Karl Marx. L’analisi del “Manifesto del partito comunista”, secondo l’autore, può regalare ancora preziose intuizioni sulle traiettorie determinate dallo scenario economico dei nostri giorni e dal neoliberismo sfrenato da cui è contraddistinto. Dopo quasi un secolo di peripezie, il comunismo e, con lui, il suo teorico più autorevole sono tornati all’originario statuto di “spettri”, anche se in un senso del tutto differente da quello originario: dalla caduta del muro di Berlino, infatti, il comunismo è spettro non perché, come nel 1848, deve ancora compiersi, ma perché non esiste più, nella misura in cui esso ha cessato di essere come realtà politica e come struttura sociale. Per questo motivo, riscoprire il messaggio filosofico di Marx attraverso alcune delle sue opere più importanti permette di ripensare e immaginare nuove alternative al “progetto incompiuto di modernità” del quale oggi siamo parte.
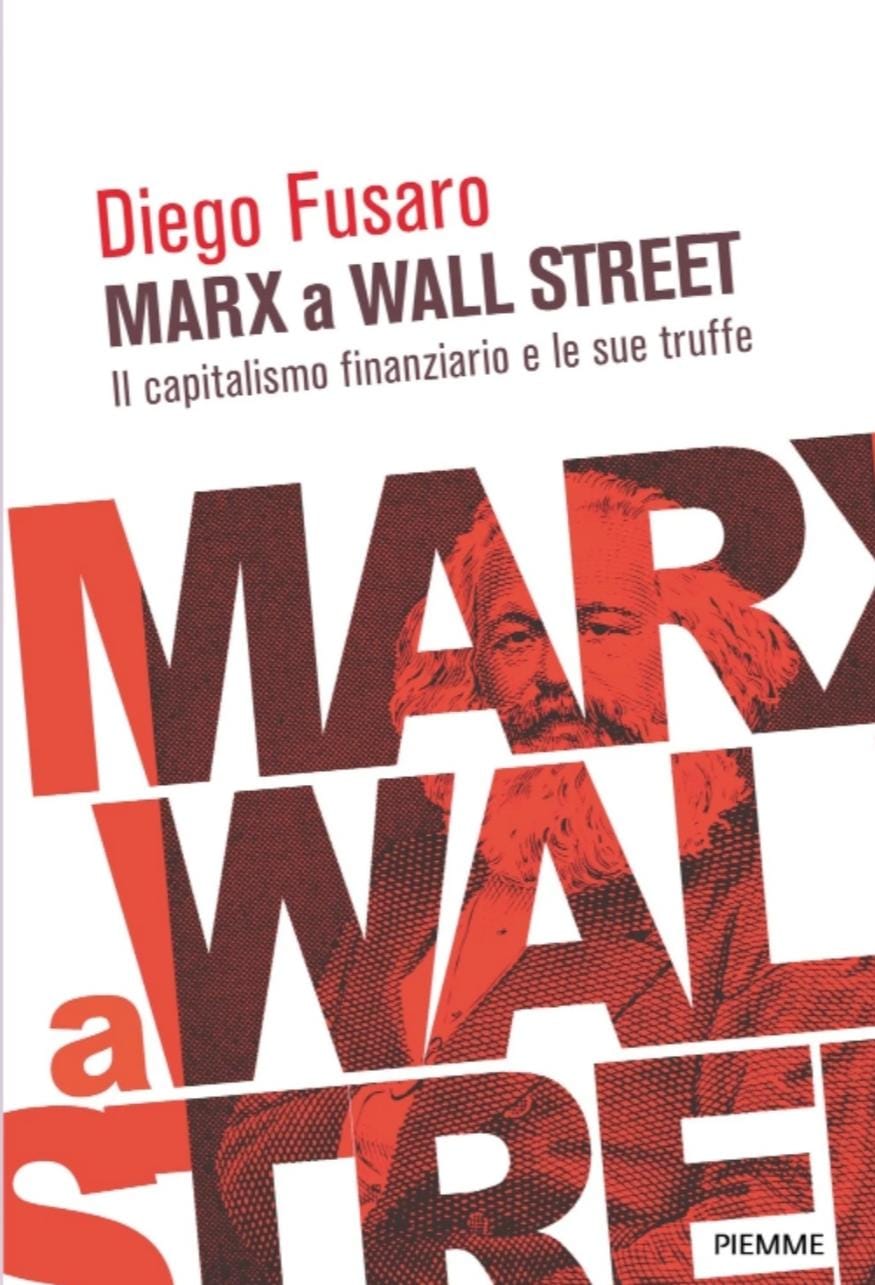
In un’epoca di forti polarizzazioni, nuovi ordini mondiali, tensioni internazionali e sconfitte politiche altisonanti, questo libro induce il lettore a una riflessione profonda sul mondo in cui viviamo. Diego Fusaro, infatti, torna sul tema che più di tutti lo rende riconoscibile come studioso in Italia e nel mondo: Karl Marx e il capitalismo di oggi. Lo “spettro di Marx” seguita ad aggirarsi minaccioso tra le rovine del desolato paesaggio post-1989, e resta la guida imprescindibile e il sismografo irrinunciabile per cartografare le contraddizioni che costellano il nostro presente. Marx a Wall Street indaga criticamente il nuovo capitalismo finanziario che si è venuto contraddittoriamente delineando a partire dagli anni Ottanta del “secolo breve” e che si è rafforzato con la marcia trionfale della globalizzazione liberal-finanziaria, fino a questi ultimi anni (e a maggior ragione oggi che, con la vittoria di Trump, entra in una nuova e sofisticata fase). Un libro ricco di analisi, teorie e suggestioni interpretative che danno forma e concetto ai tentativi di resistenza che la politica prova o dovrebbe provare a costruire, perché «l’utopia non è la coscienza astratta e individuale dell'”anima bella” che anela alla sua “fetta di cielo”, ma è, al contrario, la stoffa di cui è intessuta la realtà stessa come storia e come possibilità. Il programma di ricerca e il progetto di emancipazione di Marx continuano a essere una stella polare nel deserto del nostro presente».

Ya Pier Paolo Pasolini había calificado el nuevo poder globalista como «el más violento y totalitario de la historia, pues cambia la naturaleza de la gente, entra en lo más hondo de las conciencias». Y no es ninguna casualidad que llegara a hablar, con lúcida clarividencia, de «genocidio cultural». Enmascarada tras una fachada de multiculturalismo, que no es más que la repetición sin fin del mismo modelo políticamente correcto, la civilización global en la que vivimos no acepta, de hecho, las diferencias. Admite solo un perfil: el del consumidor desarraigado, indistinguible de los demás, sin identidad ni espesor cultural. En palabras de Diego Fusaro, el globalismo se basa en la inclusividad neutralizante: «en nombre del mercado unificado obra para que cada entidad se transforme en una mercancía que circula libremente, sin fronteras políticas o geopolíticas, morales o éticas, religiosas o jurídicas». En esta visión distorsionada, toda tradición se sacrifica en el altar del falso progreso, que no necesita contar con «pueblos arraigados en su historia y en su tierra, ni subjetividades con identidades fuertes y capaces de oponer resistencia, sino consumidores con un yo mínimo y narcisista, con identidades líquidas, gadgetizadas y efímeras». Compradores indistinguibles a los que se les puede vender la misma ilusión en todas partes. ¿Cómo podemos oponer resistencia a esta «heterofobia» imperante? Recuperando y defendiendo el valor de nuestra identidad, que se define solo dialogando con las diferencias del otro. En este ensayo agudo y provocativo, la voz crítica de Diego Fusaro nos invita a reivindicar nuestras raíces; a reeducarnos –y a reeducar sobre todo a los más jóvenes, condenados a un futuro precarizado que corren el riesgo de aceptar inadvertidamente–, a exigir un futuro menos indecente que aquel que solo nos ve como una mercancía entre las mercancías.

¿Es éste el triunfo del turbocapitalismo, acabar con el trabajo? ¿La generalización del trabajo-basura es la abolición de la clase proletaria? Asistimos al tele-trabajo, a la extensión del precariado, a la sustitución y amordazamiento del campesino y del obrero nacionales por otras masas apátridas ajenas a la producción, subvencionadas y “movilizadas” por el Gran Capital con el fin de desarraigar a los pueblos y desunirlos, y así volverlos más débiles. La estrategia triunfante del Señor es crear nuevos estratos de siervos ajenos unos a otros, en medio de un “mundo-mercado-basurero”.

Il rosso e il nero, Karl Marx e Martin Heidegger: due filosofi fondamentali per la storia del pensiero d’Occidente, accusati però entrambi di essere, in qualche modo, parte in causa nelle tragedie peggiori del Novecento, di aver contribuito ideologicamente alle colpe del nazismo e del comunismo. È inevitabile, dunque, che siano pensatori destinati a essere costantemente interpretati, reinterpretati o male interpretati. A seconda del punto di vista, infatti, la critica delle loro opere ha portato a schierarsi con l’uno e contro l’altro, o – peggio – ad assimilarne le riflessioni alle categorie del “precorrimento” o della “filiazione”: Marx precursore di Heidegger, Heidegger interprete di Marx. In entrambi i casi, il rischio è di incorrere in un’intollerabile reductio ad unum, in cui si perde la specificità dei rispettivi approcci, e il profilo dell’uno viene sacrificato in favore di quello dell’altro, letto alla sua luce e attraverso categorie che non gli appartengono. Invece, se ci liberiamo da giudizi precostituiti, questi due grandi intellettuali possono dirci ancora tanto, e il loro contributo si rivela imprescindibile per leggere la realtà in cui siamo immersi. «Per mezzo della critica heideggeriana di Marx e della critica marxiana di Heidegger, è possibile non solo comprendere meglio il codice teorico di entrambi i filosofi, ma anche tentare di prendere posizione rispetto allo spirito del nostro tempo, l’epoca della tecnica planetaria e del capitalismo mondializzato.» Ecco perché Diego Fusaro, studioso e critico severo di questo presente tecnocapitalistico, ha deciso di ripartire dai loro testi, guidando il lettore all’interpretazione diretta del pensiero di Marx e Heidegger. Solo superando l’intricata selva degli approcci critici precedenti, infatti, si può ripensare il lascito di questi due fecondi sistemi di pensiero per far emergere, tramite il loro confronto, l’impensato e il non-detto di ciascuno, e per capire fino in fondo le radici della letale inversione tra Soggetto e Oggetto cui siamo di fronte: quando cala La notte del mondo, possiamo sempre interrompere la catena in cui ci ritroviamo «signoreggiati dai prodotti della nostra mano, dalle merci e dagli apparati tecnici» e ritrovare finalmente la nostra vera dimensione di uomini.

En este libro de Diego Fusaro se cruzan dos hebras. Cada una surge y se hilvana por medio de una nación, es decir, una procedencia. La palabra nación viene de nacer, y todo pensamiento, al igual que toda persona, procede de un vientre y de una madre. La primera fuente ventral es Alemania. De la lengua, la nación y la filosofía alemanas proceden Marx y Heidegger. Hay otro manantial, vientre de pensamientos, que es Italia. Con sumo gusto podemos leer en español este par de hebras tan entrecruzadas, surgidas de dos naciones europeas, basilares, ambas muy recias en materia filosófica. La densidad germana y la ágil lucidez latina maridan bien. El idealismo alemán –tanto como el italiano– fueron capaces de construir teorías de la realidad en la cual ésta no es un monolito, una losa fatal que aplasta al hombre, sino la humanidad misma viviente, desplegada, que con esfuerzo supera obstáculo y reconfigura el ser.

En contra del vento
Pensar filosóficamente es pensar en contra del viento, navegar en aguas procelosas, surcar piélagos sin ayuda de las corrientes, siempre bajo el rayo de la ira conservadora y frente a ataques filibusteros. La historia de la filosofía tal y como la interpreta Diego Fusaro es la historia de ese pensar peligrosamente. Se trata de una reconstrucción racional de los mitos historiográficos que han diseminado las cátedras perezosas y las inercias intelectuales. En su lugar: un Marx Idealista, un Fichte que ontologiza la Revolución, un Spinoza comunitarista y en absoluto materialista… Este libro es Fusaro en estado puro.