APPUNTI UNIVERSITARI
“Putavi mihi suscipiendum laborem utilem studiosis, mihi quidem ipsi non necessarium” (M. Tullius Cicero, De Optimo Genere Oratorum, V)

Qui trovate alcuni miei appunti universitari, risalenti agli anni in cui ero studente all’Università di Torino (2002-2007). |
TEORETICA
INTRODUZIONE ALL’ERMENEUTICA
Tra opera d’arte ed ermeneutica intercorre un rapporto forte, e lo si può già presagire dal fatto che l’ermeneutica si costituisca come posizione filosofica che intende sottrarsi alla determinazione scientifica: e in effetti, soprattutto negli ultimi anni e in Italia, più che disciplina a sé stante è stata concepita come corrente filosofica (un po’ come era accaduto per la semiologia negli anni ’70 del Novecento). L’ermeneutica così come la concepiamo oggi nasce a partire da una svolta avvenuta negli anni ’30 del Novecento come conseguenza dell’esistenzialismo tipico di quegli anni; per dare una definizione generale, potremmo dire che essa è la “scienza” che si occupa dell’interpretazione: prima della svolta poc’anzi menzionata, l’ermeneutica era una disciplina importantissima in ambito giuridico (per l’interpretazione della legge), teologico (per l’interpretazione dei testi sacri) e filologico. Si tratta dunque di una disciplina ausiliaria utilissima per interpretare i testi e per integrare quelli corrotti. Ma l’ermeneutica non si limita ad interpretare i testi, bensì fissa essa stessa le regole di interpretazione: la parola deriva dal greco ermhneia e gli antichi greci se ne servivano in modo piuttosto differente e oscillante rispetto a noi. Per esempio, Aristotele nella sezione dell’Organon intitolata Peri ermhneiaV (in latino “De interpretatione”) parla della struttura della lingua, dei segni fonetici, cosicchè l’ermeneutica rientra, nella prospettiva aristotelica, a pieno titolo nella logica. L’uso che del termine fa Platone è meno preciso rispetto a quello aristotelico: il filosofo delle idee impiega la parola “ermeneutica” per designare la “traduzione”, in riferimento non solamente alla trasposizione in un’altra lingua rispetto alla nostra, ma, paradossalmente, riferendosi alla traduzione nell’ambito della nostra stessa lingua: è infatti evidente che tutti, chi più e chi meno, abbiamo la tendenza a riportare i termini che sentiamo ad un linguaggio che ci è proprio. Secondo la prospettiva di Franco Bianco (“Introduzione all’ermeneutica”), è nell’Ottocento che si riscontra la prima grande trasformazione del significato dell’ermeneutica: essa viene impiegata per interpretare i testi e si sgancia definitivamente dalla scienza; ma oltre che interpretare i testi, essa li spiega anche. Il positivismo sviluppatosi in quegli anni, tende a leggere la realtà come susseguirsi di fatti (cosicchè, per addurre un esempio, la malattia deriva dai batteri). Però esistono anche altre scienze oltre a quelle della natura (tra le quali rientra appunto il positivismo): esistono cioè anche le scienze dello spirito, che non hanno la pretesa di “spiegare” (il tedesco usa il verbo “Erklaren”), come invece avviene per quelle della natura, ma si propongono invece di comprendere lo spirito attraverso l’interpretazione. Nei paragrafi 31-34 di “Essere e Tempo”, Heidegger legge l’interpretazione come determinazione ontologica, cosicchè l’uomo stesso è comprensione, il suo essere è definito dal comprendere. Ancor prima di Heidegger, il teologo Schleiermacher ha redatto una “Ermeneutica generale”, prospettando l’idea innovativa che l’ermeneutica, in fin dei conti, non sia legata ad una disciplina particolare e che quindi essa sia autonoma; naturalmente, pur essendo di fondamentale rilievo le novità introdotte da Schleiermacher, la grande svolta dell’ermeneutica avverrà nel Novecento grazie a Heidegger e a Gadamer. Abbiamo accennato alla distinzione tra il comprendere e l’interpretare: in realtà gli antichi greci non facevano alcuna distinzione tra i due termini; è invece in Tommaso che troviamo una netta separazione tra i due aspetti: il latino, del resto, presenta il termine “comprehendo”, che letteralmente significa “prendere insieme” ed è sinonimo di “intelligere”. Tommaso, tuttavia, usa in due diverse sfumature questi due verbi: a suo avviso, posso “comprehendere” le cose riguardanti la fede (ad esempio Dio), ovvero quelle cose che non si identificano mai con un oggetto esterno. Dio infatti non lo posso “vedere”, ma, ciononostante, lo posso trovare nel testo della Scrittura: se non parlo di Dio non posso capirlo (basta anche un colloquio intimo con se stessi). Invece, le cose esterne (gli alberi, gli animali, ecc) che non sono espresse linguisticamente possono essere spiegate: non più “comprehendo”, ma “intelligo”. Queste problematiche, del resto, erano già in qualche misura sentite da Platone: la seconda parte del “Fedro” è dedicata al rapporto tra retorica e dialettica, dove quest’ultima è intesa come dimensione che c’è nella misura in cui riconosco l’esistenza di strutture del pensiero: come dire che si tratta di cose che ci sono perché le penso (Dio, la giustizia, la bellezza o, per toccare la tematica portante nel Fedro, l’amore). Aristotele, dal canto suo, riserva la dialettica esclusivamente alle cose etiche, come se per lui le cose potessero sempre e comunque essere mostrate in senso concreto. Più vicino, sotto questo profilo, alla posizione platonica è il pensiero di Gadamer: la terza parte di “Verità e metodo” è infatti un’ontologia del linguaggio, tesi esprimibile secondo la formula “ci sono cose che sono perché sono nel linguaggio”: in altri termini, secondo Gadamer, l’essere che può essere compreso è nel linguaggio. Questa posizione che tende ad accentuare il comprendere si contrappone nettamente agli atteggiamenti metodici: il titolo dell’opera gadameriana, “Verità e metodo”, allude proprio a questo: per accedere alla verità devo rinunciare al metodo, sicchè il titolo dell’opera di Gadamer può in realtà essere letto come “Verità o metodo”: se scelgo la verità rinuncio al metodo e viceversa. Il metodo a cui allude Gadamer è soprattutto quello impiegato dagli esponenti del neokantismo, ultimo bagliore dell’idealismo. Come è noto, era stato in buona parte l’esistenzialismo (Kierkegaard soprattutto, ma perfino Schelling, quando parlava di “fondamento”) ad opporsi aspramente all’idealismo, contrapponendo allo Spirito e alla sua astrattezza l’esistenza concreta: ora, il pensiero ermeneutico si contrappone al metodo kantiano ed idealistico e dunque trova nell’esistenzialismo un suo naturale alleato. Nel 1927 compare “Essere e Tempo”, nel quale viene ribadita l’esistenza contro l’Idea: e, con l’emergere dell’esistenza, affiora anche l’importanza del comprendere, poiché la mia singola esistenza posso solo comprenderla (non “intelligere”) dall’interno, è un qualcosa che sono senza ragioni. E l’esistenziale è sempre opposto al metodico, dato che implica l’essere sempre situato emotivamente, al di là di ogni rigido metodo: ad esempio, una cosa mi piace o non mi piace. La posizione esistenziale, dunque, è per molti versi “realista”, dove per “realista” dobbiamo intendere quell’attenzione per la realtà a cui ci hanno invitati Aristotele e Tommaso: devo prestare attenzione alla realtà, alle cose che mi circondano, e non al mio procedere mentale, ovvero al metodo, come invece volevano i Neokantiani. E non è un caso che il neokantismo tenda a respingere Aristotele: si può a tal proposito ricordare il titolo di un’opera di un celebre neokantiano, Natorp (Gadamer si è laureato con lui), comparsa nel 1903 e intitolata “La dottrina platonica delle idee”; in quest’opera, l’autore si schiera al fianco di Platone e sostiene che le idee sono le leggi di natura. Viene così espunto il tratto esistenziale: che i corpi cadano o che il sole sorga ogni mattina è vero anche senza che io soggetto esistente lo constati. In definitiva, Hegel stesso aveva una concezione simile: ma contro di lui e in opposizione al suo Sistema, Kierkegaard portava il singolo uomo esistente e sosteneva che Hegel aveva capito tutto fuorchè se stesso. E tuttavia la riproposizione della tematica esistenziale contro il metodo è parsa piuttosto pericolosa sia ad Heidegger sia a Jaspers: proprio quest’ultimo scrive, nel 1935, un’opera dal significativo titolo “Esistenza e ragione”; in essa egli sostiene che l’esistenza ha il diritto di portare avanti le sue ragioni, ma esse non devono andare contro la ragione. Era infatti chiaro a Jaspers che le posizioni irrazionalistiche fiorite in quegli anni non promettevano nulla di buono e il nazismo, in effetti, ne fu la conferma. Similmente, Heidegger, quando nel 1923 tiene il corso sull’”Ermeneutica dell’effettività”, dice che per parlare dell’esistenza non è affatto necessario respingere Aristotele (l’errore imperdonabile del neokantismo viene appunto scorto nell’adesione alle tesi kantiane e nel rifiuto pressochè totale di quelle aristoteliche). La filosofia dell’esistenza, dopo la parentesi kierkegaardiana nell’Ottocento, rinasce dopo la tragica esperienza della prima guerra mondiale, sull’onda del fallimento dell’ “idealismo” che l’aveva alimentata (le guerre, a partire dal primo conflitto mondiale, sono diventate “guerre di materiali”, ha asserito Jünger): prevale la tendenza ad andare verso il concreto o, come si propone la fenomenologia di Husserl, “alle cose stesse”, non al metodo o all’idea. E le cose in questione non sono solamente quelle materiali che ci circondano, ma pure quelle di cui parliamo: in una prospettiva di questo tipo, l’a-priori kantiano non può apparire a Husserl altro che mitologico, poiché è ineccepibile ammettere che la logica preceda il mondo; viceversa, la logica è una cosa come le altre, né più né meno. Ed è per molti versi questo richiamo fenomenologico alla concretezza ad aprire la strada all’esistenzialismo, che a sua volta segnerà una svolta per l’ermeneutica. Perché l’ermeneutica si occupa del rapporto con l’arte? Nel saggio “Sull’origine dell’opera d’arte”, Heidegger dice espressamente che si tratta di pensare la cosa stessa, l’elemento “cosale”. Per capire meglio questa prospettiva, prendiamo come esempio la musica e la pittura: la musica non intende dirmi cose che potrebbe dirmi anche la filosofia; al contrario, è arte perché mi dà il suono in quanto tale, così come la pittura è arte perché mi dà il colore in quanto tale. A tal proposito, Heidegger conduce una lunga e attenta analisi del quadro di Van Gogh in cui sono raffigurate due scarpe: oltre al fatto che sono tutte e due sinistre, si può notare come esse nel quadro non camminino, ma viceversa vengano colte come oggetti, non nel loro funzionamento. Sia Heidegger sia Gadamer polemizzano fortemente contro l’estetica di marca kantiana, che si propone di tradurre l’arte in termini concettuali (Van Gogh nel suo quadro voleva dire…): soprattutto Gadamer (se Heidegger non parla quasi mai della bellezza, Gadamer invece scrive un saggio “Sul bello”, in cui ne parla ma non come dimensione estetica), si schiera apertamente contro la teoria del genio, contro la concezione kantiana, contro l’idealismo, contro l’illuminismo. Egli mira a far notare come esistano diritti dell’arte e come invece l’illuminismo (e con esso Kant) l’abbiano relegata ad un ambito particolare, con la conseguenza che essa è semplicemente una questione di gusto, viene privata del valore conoscitivo riconosciutole invece da pensatori come Tommaso. Per ritornare al rapporto esistenzialismo/fenomenologia, si può notare come il paragrafo 7 dell’introduzione di “Essere e Tempo” sia dedicato alla chiarificazione del termine “fenomenologia”: il problema in questione è quello del fenomeno; il pensiero stesso è, se letto in trasparenza, fenomeno, ovvero da descriversi. Se per Kant sono dotato del pensiero e grazie ad esso interpreto il mondo, viceversa per la fenomenologia parto da zero. L’ermeneutica non nega che ci siano fatti: nel paragrafo 1 della “Critica della ragion pura”, Kant distingue la forma dal contenuto; a tutto questo, invece, deve sostituirsi il fenomeno. La fenomenologia, del resto, poggia sul presupposto che il fenomeno non appare: Heidegger stesso definisce la fenomenologia come “metodo”, in modo beffardo nei riguardi del neokantismo; e poi aggiunge che il fenomeno è ciò che si mostra da sé, sia come cosa sensibile, sia come cosa pensata, respingendo in questo modo la distinzione operata da Kant tra intuizione e pensiero. Si tratta, dunque, di descrivere la datità originaria, togliendo il nascondimento, concetto presente in Heidegger (la nozione di alhqeia ). Contro questo atteggiamento si è schierato apertamente Emilio Betti, il quale, attento conoscitore della filosofia del diritto, ha scritto un’ermeneutica in cui difende l’ideale di un’oggettività, come se ci fosse una dimensione del pensiero in cui le cose hanno una loro validità. Heidegger tenta di sostituire l’ Io penso kantiano col tempo (e in ciò Gadamer lo segue): tutte le mie rappresentazioni devono essere accompagnate non tanto dall’Io penso quanto dal tempo; Heidegger cerca dunque di stabilire una connessione tra Io penso e tempo, cosa che può sembrare, in una prima analisi, piuttosto bizzarra, poiché tutti noi siamo portati a pensare che l’Io penso sia una categoria posta al di fuori del tempo: al contrario Heidegger vuole precipitarlo nel tempo, descrivendo l’esistenza nella sua “cosalità”. La parola “ermeneutica” deriva dal greco e furono proprio i Greci a dare il via alla storia di questa disciplina: infatti, troviamo il verbo ermhneuw (“parlare”, “interpretare”) già in Platone e in Aristotele, seppure con significati diversi tra loro. Per Platone si tratta, in definitiva, di una mantica, ovvero della comprensione di qualcosa che non compare immediatamente ma che, per essere compreso, richiede sforzo; in un passo del “Teeteto”, Platone collega l’ ermhneuein con il logoV : Socrate, infatti, dice che se si vuole capire Teeteto bisogna ” ermhneuein ” (“comprendere”, “interpretare”) ciò che è effettivamente suo, cioè come lui usa il linguaggio. Anche in un’altra opera, le “Leggi”, ricompare il verbo ermhneuein , in riferimento all’interpretazione delle leggi che regolano la città giusta e viene messo l’accento sul fatto che capire non è una disposizione puramente meccanica. Aristotele, dal canto suo, impiega tale verbo in riferimento al collegamento dei suoni delle parole con i significati. La storia dell’ermeneutica trova poi una tappa fondamentale in età ellenistica, quando le due scuole di Alessandria e di Pergamo assurgono a vere e proprie capitali della cultura dopo la caduta di Alessandro Magno: esse segnano, tra l’altro, la nascita della cultura così come la intendiamo noi oggi; è infatti in quest’epoca che si sviluppano i musei e le biblioteche, luoghi di tesaurizzazione del sapere. Di per sé, già l’affermarsi del museo e della biblioteca sembrano favorire lo sviluppo della disciplina ermeneutica, poiché segnalano, in modo netto, la distanza temporale, mettendo in risalto che il tempo passa. Si tratta di un’idea pressochè sconosciuta ad Aristotele, Platone e ai loro contemporanei, che vivevano in un clima culturale in cui il libro non aveva il significato che noi oggi gli attribuiamo. Oltre al raccoglimento dei libri, comincia in età ellenistica, ad Alessandria e a Pergamo, a svilupparsi il lavoro filologico, testimoniato dalla comparsa della prima edizione critica dei testi omerici; nascono anche le grammatiche, sconosciute nel passato; certo, il Cratilo platonico e il Peri ermhneiaV aristotelico avevano qualche parentela con quelle che oggi definiamo grammatiche, ma restavano ancora troppo legati al passato. In questa nuova era culturale ci si comincia inoltre a convincere, sulla scia degli insegnamenti stoici, che il linguaggio sia una struttura convenzionale, con la conseguenza che tutto ciò che è oscuro (ad esempio nella poesia) può e deve essere espulso. Come si ricorderà, nel Cratilo Platone ci metteva di fronte ad una duplice possibile interpretazione del linguaggio: da un lato Ermogene sosteneva che esso avesse un’origine assolutamente convenzionale, dall’altro Cratilo propendeva per la tesi secondo la quale, al contrario, il linguaggio ha un’origine naturale; ora, in età ellenistica, prevale nettamente la tesi avanzata da Ermogene, con la conseguenza inevitabile che l’attenzione si sofferma sempre più sul significato letterale del testo, perché esso è l’unico significato possibile (la filologia nasce anche su queste basi); questa tendenza ad interpretare letteralmente i testi prevale soprattutto ad Alessandria; a Pergamo, invece, fiorisce una scuola dagli esiti diversi: anch’essa nata dalla dissoluzione dell’impero di Alessandro Magno, trova il suo grande teorico in Cratete di Mallo, che propone, in antitesi con le usanze invalse ad Alessandria, una lettura allegorica del testo. Quest’interpretazione si differenzia da quella “grammaticale”, secondo cui il testo lo si capisce solo attraverso la lingua (senza servirsi di elementi storici e caratteriali), perché propone una lettura aperta ai significati mitici, storici e, in definitiva, a qualsiasi elemento utile alla lettura stessa. Questa diatriba tra scuola di Alessandria e scuola di Pergamo tende a riprodursi continuamente: in epoca cristiana, ad esempio, si ripropone, sebbene coi ruoli invertiti, dal momento che ad Alessandria vige la tendenza allegorica e ad Antiochia (che ha, per così dire, preso il posto di Pergamo) quella letterale. La storia dell’ermeneutica passa anche per Roma: qui, come è risaputo, prevale l’interesse giuridico e, dunque, l’ermeneutica viene impiegata soprattutto per interpretare la legge, poiché quest’ultima non è mai totalmente oggettiva e priva di problemi. Ci può infatti essere un’interpretazione che si basa soprattutto sul testo scritto o, al contrario, una che fa riferimento specialmente a come la legge è stata applicata. Nell’interpretazione giuridica, tuttavia, vale la stessa mentalità valente per la letteratura: centrale è, a tal proposito, la nozione di “applicatio” (che sarà nodale in Gadamer), poichè il discorso giuridico tende ad essere sostituito dall’impianto dogmatico. Con l’ epoca cristiana, invece, si passa dalla problematica dell’interpretazione dei testi giuridici si passa a quella dell’interpretazione dei Testi Sacri: la domanda centrale in questa nuova età è come si debbano leggere il Nuovo e l’Antico Testamento; i due principali pensatori di questa nuova stagione dell’ermeneutica sono Filone di Alessandria, coetaneo di Gesù vissuto tra il 30 a.C. e il 40 d.C., e Origene. Filone non aderisce alla religione cristiana ma a quella ebraica e applica i metodi filologici della scuola di Alessandria per interpretare la Scrittura, leggendo i Testi Sacri con un’incredibile precisione filologica; in sintonia con la nuova linea interpretativa invalsa ad Alessandria, egli privilegia di gran lunga la lettura spirituale, lussurreggiante di allegorie, e sarà seguito in questa modalità interpretativa da Origene. La letteratura spirituale, in età cristiana, tende a sostituire quella spirituale: in verità, già nei testi dell’antica scuola di Pergamo aleggiava l’idea che certi passi possano essere letti solamente in modo spirituale, anche se con ciò non si voleva dire che il testo non dovesse essere appurato nella sua concreta costituzione. Origene, ad esempio, è precisissimo sul piano filologico, ma è convinto che il vero significato della Scrittura sia quello nascosto e desume da San Paolo tale concezione: lo spirito è la dimensione della perfezione, il momento più lontano dalla corporeità del Testo; sono invece i neofiti a fermarsi al corpo del testo, cioè alla lettera; un ulteriore passo è dato dall’anima, ed è costituito dal momento etico in cui si impara come comportarsi. Il mondo viene così platonicamente inteso in senso dualistico: tanto più capiamo la Scrittura quanto più ci allontaniamo dalla lettera e tanto più siamo veri cristiani quanto più ci distanziamo dal corpo. La scuola di Antiochia, tuttavia, sviluppatasi tra il III e il IV secolo d.C., si orienta in senso decisamente diverso, ma non per questo propone una lettura esclusivamente letterale: piuttosto, suggerisce di evitare un’eccessiva allegoria, giacchè si corre il rischio, altrimenti, di moltiplicare all’infinito i significati insiti nel testo; se, infatti, dico che il vero significato non è quello letterale, ma va ricercato al di là, allora ognuno può trovare nel testo un significato diverso da quello trovato dagli altri. I principali esponenti della scuola di Antiochia, Teodoro e Diodoro, propongono quindi di affiancare all’allegoria la “teoria”, poiché riconoscendo valore illimitato e indipendente all’allegoria si finisce per sganciarsi totalmente dalla lettera; ecco perché occorre, a loro avviso, una teoria, un’ossatura teorica che deve essere trovata nella Scrittura e alla quale non si possa sfuggire. Spetta a Gerolamo il merito di aver tradotto i Testi Sacri in latino dall’ebraico, già tradotti in greco dai “Settanta”: l’atteggiamento di Gerolamo è piuttosto oscillante tra allegoria e scrittura, e lui stesso dice di voler seguire il verso e non parola per parola (e Lutero lo condannerà aspramente per questo). Anche Agostino ha dato notevoli contributi all’ermeneutica: l’apice è costituito da uno dei suoi ultimi scritti, intitolato “Sulla dottrina cristiana”, e articolato in quattro libri; di essi, i primi tre trattano del problema della ricerca e il quarto ed ultimo costituisce, in un certo senso, il punto d’arrivo dell’itinerario conoscitivo: affiora il problema dei due tipi di lettura, spirituale e letterale, e di quale debba essere privilegiato. In questo suo scritto, Agostino riprende le riflessioni elaborate da Ticonio e da Origene; in particolare, da Ticonio ripesca le “regole” e, in tale prospettiva, il rapporto tra Cristo e il suo corpo viene letto come rapporto tra Cristo e la Chiesa. Ma non solo: viene dato anche spazio al rapporto tra res e signa , cioè tra cose indicate e parole che le indicano. Anche in virtù di queste riflessioni di grande importanza ermeneutica, Agostino sarà di grande rilievo nella riflessione di Heidegger: non a caso, uno dei suoi primi corsi universitari verterà su “Agostino e il neoplatonismo” e la nozione di “cura”, nodale nel pensiero heideggeriano, è di ascendenza agostiniana, come pure lo scavo nell’essere . Ciononostante, Heidegger considerava in modo negativo Agostino, perché in lui vedeva la deformazione greca del cristianesimo: Agostino è, agli occhi di Heidegger, il pensiero greco (che però parla in latino, visto che Agostino aveva scarsa confidenza con la lingua greca) che filtra nel mondo latino e, con esso, nel cristianesimo. In età medioevale, è di fondamentale importanza, per la storia dell’ermeneutica, quella che è passata alla storia con il nome di teoria dei “quattro significati della Scrittura”: sebbene tale teoria sia presente nel pensiero di Dante, di Bonaventura e di Tommaso, non si sa di preciso a chi debba essere fatta risalire, ma ciò non diminuisce la sua importanza, poiché in essa è racchiuso tutto ciò che il mondo antico ha detto sulla Scrittura. Secondo questa teoria, la Scrittura può essere letta secondo quattro significati: la prima possibile lettura è quella secondo il significato letterale; la lettura di tipo spirituale, invece, è distinta in tre momenti distinti: allegorico, morale, anagogico. E questi tre momenti altro non sono se non le tre virtù teologali: alla lettura allegorica corrisponde la virtù teologale della fede (ciò in cui si crede: non ci si deve fermare alla lettera, ma bisogna scavare più in profondità con un atto di fede); a quella morale (ciò che si deve fare) corrisponde invece la virtù teologale della carità; e, infine, a quella anagogico corrisponde la speranza. Ciò non toglie però che la lettera non va tolta, come osserva Tommaso: l’importante è non fermarsi ad essa. Dal canto suo, Bonaventura si domanda perché il significato profondo non sia dato nella lettera e perché non basti il libro della natura ma ci voglia un libro apposito. La risposta da lui data è, in sostanza, che tutto si spiega se teniamo conto della malvagità del genere umano, malvagità in virtù della quale non riesce a vedere il messaggio divino nella natura e nemmeno nel testo della Scrittura, ma deve scavare a fondo. In quest’ottica, l’ermeneutica viene a coincidere con la spiritualità stessa del cristianesimo. La successiva tappa nell’ambito della storia dell’ermeneutica è costituita dall’età umanistica: fondamentali sono le figure di Petrarca, di Leonardo Bruni e di Lorenzo Valla. Leonardo Bruni, grande studioso di etica (tradusse in latino l’ “Etica Nicomachea” di Asristotele) critica aspramente le traduzioni scolastiche perché mediate dall’arabo e propone, pertanto, di ritornare ad una traduzione diretta dal greco. Egli compone un opuscolo dal titolo “De recta interpretatione”, dove discute di alcuni significativi dubbi che gli sono sorti mentre traduceva. Lorenzo Valla, invece, riesce abilmente a dimostrare, su basi filologiche, che il testo della donazione di Costantino è un falso clamoroso scritto da un monaco pressochè ignorante; con ciò viene quindi messa in luce la falsità del potere temporale della Chiesa. In quegli anni anche Cusano giungeva filologicamente alle stesse conclusioni: non è un caso che siamo ormai alle porte della Riforma. Il secolo XVI e il secolo XVII costituiscono per molti versi una preparazione alla grande svolta ermeneutica operata da Schleiermacher nell’Ottocento; nel XVI secolo ha luogo quella riforma protestante che, secondo il parere di Dilthey, costituisce il passo fondamentale per l’ermeneutica moderna: l’ermeneutica così come oggi noi la concepiamo, infatti, nasce propriamente solo con la riforma protestante e non è un caso che Schleiermacher fosse un pastore protestante e che spesso sia stato insignito del titolo di “secondo Lutero”. Proprio Lutero diceva che la Scrittura dovesse essere letta a partire da se stessa (“la Sacra Scrittura è interprete di se stessa”), con la conseguenza che la tradizione apostolica, su cui poggiava la Chiesa romana, non ha alcun potere, non può intervenire nella lettura dei Testi Sacri: questi ultimi, dunque, hanno secondo Lutero una loro autonomia da cui non si può prescindere. I passi oscuri della Scrittura vanno affrontati, né più né meno, come quelli di ogni altra opera, ovvero con l’ausilio dei soli mezzi filologici. Ci si deve quindi basare sulla sola scrittura, come recita il celebre motto luterano “sola scriptura”. Il testo della Bibbia, nella prospettiva luterana, è un testo come tutti gli altri, Dio non soccorre il lettore con una particolare ispirazione, viceversa è il lettore che, leggendo il testo, trova l’ispirazione divina. Se la Chiesa romana si sente autorizzata a diffondere il Testo con una lettura ispirata dallo Spirito Santo, al contrario nel protestantesimo tutti sono autorizzati a leggere il Testo Sacro e a trovare in esso la fede: infatti, secondo Lutero, non si legge il Testo perché si ha la fede, ma, viceversa, si ha la fede perché si legge il Testo. Ed è in questa prospettiva che Lutero traduce in lingua tedesca l’Antico Testamento: la Chiesa romana, invece, lo mantiene in una lingua radicalmente diversa da quella parlata dal popolo, quasi come se avesse una sua lingua. Secondo Lutero, però, non ci dev’essere alcuna mediazione da parte della Chiesa, poiché è l’insieme stesso dei fedeli a costituire la Chiesa attraverso al Testo. Viene dunque dato grande peso all’interpretazione, anche se, ad onor del vero, Lutero dà maggior importanza alla lettera che non all’allegoria. Molto rilevante, nell’ambito della riforma proptestante e della sua influenza sull’ermeneutica, è la figura di Melantone, grande erudito conoscitore di lingue antiche, il quale dà molto peso a quella retorica che, soprattutto nel Novecento, sarà centrale nella riflessione ermeneutica (Gadamer, Parelman): la retorica vuole semplicemente indicare quale è lo stato d’animo dell’autore nel momento in cui ha scritto il testo, il quale ha, nella prospettiva luterana, una sua dimensione affettiva che deve essere colta nella lettura: ne consegue che cogliere le parole non basta, bisogna anche cogliere la dimensione retorica. Questa teoria degli “affetti” si è sviluppata soprattutto nel XVII secolo presso i pietisti, soprattutto Francke (1663-1727): egli ha l’idea di una “patologia sacra”; a suo avviso, dal Testo si deve capire l’amore e il fatto di accedere ad un significato mistico della Scrittura rappresentato dalla figura stessa del Cristo. Il pietismo, del resto, si presenta come reazione alla piega dogmatica assunta dal protestantesimo così come è esposto nella “Clavis aurea” di Mattia Flacio Illirico (1520-1575): dopo la condanna del protestantesimo avvenuta al Concilio di trento, Illirico dà una sistemazione teorica al protestantesimo. Se Melantone individuava il senso della retorica, Illirico, dal canto suo, introduce il tema del “circolo” ermeneutico, secondo il quale non posso leggere i singoli libri della Scrittura se non a partire dall’insieme della Scrittura e viceversa: c’è una continua mediazione, quasi una dialettica, tra il tutto e le parti; il fatto stesso che ancor prima di leggere un libro si guardi l’indice per avere un’idea generale che illumini la lettura delle singole parti è, sotto questo profilo, significativo. Nel secolo successivo a quello del Concilio di Trento, Rambach proclamerà possibile la “analoghia fidei”, secondo la quale ogni libro che compone la Scrittura deve essere letto per conto proprio, però in qualche modo il fatto che l’insieme di questi scritti contiene la Rivelazione suggerisce che vadano presi nella loro unità complessiva. Rambach cercava di conciliare il pietismo di Francke con gli insegnamenti di Lutero e introduce il concetto di “applicatio”: egli infatti divide l’ermeneutica in “investigatio” (ricerca del senso), “explicatio” (trasmissione del senso agli altri) e “applicatio”, ovvero uso che faccio del senso trovato. Sul versante della Controriforma meritano di essere ricordati Roberto Bellarmino e Richard Simon: quest’ultimo, grande esegeta del Testo biblico, fu autore di “Storia critica del Vecchio Testamento” e “Storia critica del Nuovo Testamento”; sia lui sia Bellarmino cercano di dimostrare che il Testo, di per sé, non è sufficiente e richiede una mediazione; in particolare, Simon tiene in considerazione alcune riflessioni di Flacio Illarico, ma gli rimprovera di voler, da un lato, leggere il Testo così com’esso si presenta ma, dall’altro lato, di far riferimento costante all’autorità di Lutero (come se Flacio avesse sostituito l’autorità della Chiesa con quella di Lutero). Il secolo XVII è il secolo del razionalismo imperante: e in ambito ermeneutico Spinoza scrive, nel 1670, il celebre “Trattato teologico-politico”, in cui prospetta un modo di leggere la Scrittura a partire dal “lumen naturale” (ossia la ragione): secondo la prospettiva del pensatore olandese, non è necessario affiancare al “lumen naturale” un “lumen” soprannaturale; viceversa, il Testo Sacro va letto secondo gli stessi princìpi che impieghiamo per capire la natura: la ragione è l’unico mezzo per leggere il testo. La ragione, oltre a spiegare le leggi di natura, è in grado di comprendere la fede e gli altri ambiti (perfino i miracoli). Spinoza ci chiede di entrare nella lingua in cui il Testo è stato scritto e di creare una specie di elenco in cui mettere insieme tutti i passi che parlano di cose simili, cercando di ricostruire ciò che è andato perduto o è incomprensibile. Ed è in quest’ottica che Spinoza chiedeva la libertà nell’interpretazione dei Testi e nella fede religiosa. Il terzo punto su cui egli si concentra è la storia: si deve, a suo avviso, ricondurre, quanto più è possibile, l’opera al momento storico in cui è stata scritta . L’atteggiamento di fondo del “Trattato teologico-politico” è che non si deve cercare tanto ciò che è specifico (i primi due libri dell’opera sono dedicati ai profeti e alla profezia) nei profeti, quanto piuttosto, se si vuole comprendere l’insieme delle Scritture, ciò che è comune a tutti i profeti; proprio come in fisica per definire la natura in modo generale si può dire “quiete e movimento”, similmente devo agire per quel che riguarda la Scrittura, cercando di attenermi il più possibile all’universale. L’atteggiamento spinoziano, fortemente razionalistico, segna profondamente la cultura dell’epoca e anche quella successiva: ancora Kant, un secolo dopo, quando scrive “La religione entro i limiti della sola ragione”, si muove in parte sotto gli influssi spinoziani; egli definisce, in quest’opera, il cristianesimo come una volgarizzazione della religione morale e dichiara Gesù Cristo come il santo etico. Sempre nell’età dell’Illuminismo, Ernesti, autore della “Institutio interpretationis Novi Testamenti” e molto citato da Schleiermacher, propone, in sintonia con il clima illuminista, una lettura dei Testi in chiave grammaticale e storica: il linguaggio è, a suo avviso, una mera convenzione e, pertanto, una lettura logica dei testi va assolutamente respinta; razionale è soltanto la lettura storica (così come ancor oggi accade), senza tuttavia fermarsi alla lettera, perché, secondo le parole di Agostino, “la lettera uccide”. Negli anni ‘60-70 del Novecento, Perelman e lo strutturalismo propongono l’autonomia del testo e della sua letteralità; anche il decostruzionismo di Derrida, del resto, nasce da presupposti analoghi, anche se, in realtà, è bene ricordarlo, Platone nel Fedro aveva asserito che la scrittura ammazza l’autore. Queste posizioni novecentesche trovano, in parte, una prima formulazione, seppur in parte diversa, in Ernesti e in Rambach, i quali tentano una teoria dei segni, una semiotica. Già Platone sembrava aprire spiragli in direzione del “circolo” ermeneutico quando, nel Fedro, diceva che posso leggere i testi solo facendo costante riferimento alla verità. Quando leggo un libro, quindi, devo (e di fatto lo faccio) partire da un pregiudizio, come ha acutamente sottolineato Gadamer, sostenitore di un’ermeneutica fortemente anti-illuministica. Ancora nel XVII secolo, Dannhauer inaugura un’ermeneutica generale, anticipando di due secoli Schliermacher: il suo intento è di fornire uno schema dell’interpretazione che valga per tutte le discipline, poiché, se tutto è oggetto di scienza (come si crede nel Seicento), allora anche l’interpretazione delle scienze (cioè l’ermeneutica) deve diventare una scienza. Dal canto suo Keil, seguace di Leibniz, pone il problema da un originale punto di vista: l’interpretazione, a suo avviso, parte sempre dal punto di vista, da quella che Leibniz definiva “monade”; essa contiene in se stessa tutte le rappresentazioni, ma “non ha finestre”, ovvero non comunica con l’esterno. Anche quando Schleiermacher pone l’accento sulla “congenialità” tra il lettore e il libro sembra muoversi, in parte, in una prospettiva di matrice leibniziana. L’Ottocento è particolarmente importante, dal punto di vista ermeneutico, soprattutto per due nomi: quello di Schleiermacher e quello di Dilthey, vissuti uno all’inizio e l’altro alla fine del secolo. Il movimento inaugurato da Heidegger e da Gadamer interrompe, in qualche modo, la storia dell’ermeneutica, quasi come se arrivata a Dilthey subisse un’interferenza (cioè la determinazione ontologica) per poi tentare di riprendere il suo corso. Certo, anche con Heidegger e Gadamer è rimasto centrale il tema del comprendere, ma se per Schleiermacher e Dilthey l’ermeneutica è, kantianamente, una facoltà umana, per Heidegger e Gadamer, invece, è una determinazione ontologica, cosicchè essa viene interrotta perché fatta coincidere con l’ontologia, proprio in quel particolare momento storico in cui l’ontologia tendeva a scomparire. Si tratta ora di capire in che cosa consista il movimento che avviene con Schleiermacher e con Dilthey nell’ambito della dialettica. In realtà, ancor prima di questi due pensatori, un ruolo decisivo era stato giocato da Ast (1778-1841) e da Wolf (1759-1824), entrambi citati da Schleiermacher stesso nella sua “Memoria” del 1829, testo che riassume le sue posizioni filosofiche. Viene talvolta citato anche Ernesti, il teologo settecentesco, insieme ad un altro teologo, Morus. In particolare, il tentativo di Wolf è di rivolgersi all’antichità come ad una totalità da cui trarre modelli per il presente, il che è significativo perché all’epoca (siamo sul finire del Settecento) si assiste ad un ritorno generale ai Greci, tant’è che si è parlato di greco-mania (pensiamo a filosofi come Schiller o i fratelli Schlegel). Il mondo classico per tutti questi pensatori è un modello che deve produrre qualcosa per il mondo moderno: in questa accurata attenzione per il passato greco, Wolf, padre della cosiddetta “questione omerica” (e autore di un’opera intitolata “Scienza dell’antichità”), arriva a sostenere che Omero non sia un solo autore, ma una serie di autori. Cogliere il mondo classico nella sua unitaria interezza è il compito del filosofo classico, armato della lingua, della grammatica, del movimento storico e filosofico (del resto l’ermeneutica del Settecento era totalmente volta alla storia). L’attenzione al movimento storico costituisce a fine Settecento un modo per penetrare nel mondo antico, alla ricerca di una esemplarità, quasi come se il mondo classico potesse dare ancora qualcosa: Hölderlin definisce l’uomo moderno come un essere costituito da parti non ugualmente sviluppate in contrapposizione all’uomo classico, dotato di parti ugualmente sviluppate. Ast, invece, fu allievo di Schelling a Jena e, in virtù di ciò, introdusse nella filologia molte istanze schellinghiane; egli propone il circolo ermeneutico: a suo avviso, la lingua è una totalità, ma viene usata in modo individuale da ognuno. La cosa più rilevante dell’ atteggiamento di Ast è il rapporto con la comprensione: essa altro non è se non il risalire al momento della creazione, si deve cioè compiere uno slancio creativo uguale a chi ha creato l’opera. L’ermeneutica ci soccorre quando dobbiamo capire ciò che ci sfugge, tanto nello scritto quanto nel parlato: essa interviene risalendo all’interpretazione, al come e al quando quel qualcosa che dobbiamo interpretare è stato scritto o detto. Avremo pertanto un’interpretazione grammaticale (basata sulle parole), una storica (basata sul contesto storico), e una filosofica; le prime due riguardano la forma del pensiero, la terza il contenuto. In questa prospettiva, l’antichità è una totalità e ogni cosa va capita facendo costante riferimento ad essa. Schleiermacher propriamente non ha scritto un’ermeneutica: sotto il suo nome circola un’ “Ermeneutica”, ma è una raccolta di frammenti non destinati alla pubblicazione. L’unico suo testo relativamente completo sono le due conferenze tenute nel 1829. La divisione centrale che egli opera è tra interpretazione grammaticale e interpretazione psicologica: si tratta, come in Ast, di separare ciò che è prodotto attraverso la lingua da ciò che invece è prodotto dall’autore stesso; siamo dunque di fronte ad un’ermeneutica dell’individualità: l’oggetto da comprendere, infatti, è l’individualità. Di fronte a un testo devo capire l’individualità cui esso appartiene e lo devo fare o servendomi della lingua (interpretazione grammaticale) o del pensiero e, in generale, dello stile (interpretazione psicologica, che presuppone la totalità dei pensieri dell’autore). Schleiermacher parla spesso di “decisione germinale”, con l’idea che ogni testo nasca da una decisione dell’autore di scriverlo affinchè io capisca e, per capire, devo capire la sua persona, capendo anche se magari lui vuole ingannarmi . Lo scopo, in generale, è cogliere le determinazioni tra un individuo e l’altro, e non a caso Dilthey parlerà di “psicologia descrittiva”. Schleiermacher, dal canto suo, parla invece di “congenialità tra il lettore e il testo”, con l’idea che il tratto comune tra i due sia la lingua, anche se ciascuno la usa in modo diverso. Mi atteggio di fronte alla lingua come se fosse una totalità e poi procedo parola per parola: in ciò risiede il circolo ermeneutico. E in quest’ottica significatio e sensus sono due cose diverse (come già aveva detto Wolf, e come diranno più avanti Frege e Wittgenstein): il significato di “capra” è, ad esempio, l’avere la barba, mentre il senso è l’essere immersa nelle pagine, nell’opera dell’autore, nell’epoca storica, cosicchè esso è la vita della parola. Non mi è possibile partire dalle singole parole, ma sempre dalla totalità: capisco i singoli discorsi e le singole proposizioni perché capisco il tutto ma, al contempo, capisco il tutto perché capisco le singole proposizioni; le lingue sono dunque mondi in cui bisogna imparare a muoversi. Fortissimo è il rapporto che lega il pensiero di Schleiermacher a quello di Fichte, il cui sforzo stava nel dedurre il mondo a partire dall’Io, anche nel senso della produzione. Questo per l’ermeneutica è importante perché la mette in una particolare condizione: se tutto è determinazione dell’Io, allora viene messa tra parentesi la prospettiva meccanica del Settecento, secondo cui le parole erano mere convenzioni. Anzi, per tale via, l’ermeneutica diventa necessaria proprio perché non sussiste una meccanica dello spirito e, non a caso, Schleiermacher ripete spesso che l’ermeneutica è una “dottrina dell’arte” e, in quanto tale, sfugge ai dettami della meccanica. L’ermeneutica grammaticale (cui Schleiermacher riserva di gran lunga maggior spazio, anche se è di pari peso rispetto a quella psicologica: infatti, devono portare entrambe alla stesse cose, ma per vie diverse) si articola in due canoni: 1) per comprendere un testo, devo mettermi dal punto di vista del lettore originario, anche se questo è difficilissimo a farsi, poiché il tempo passa: il primo canone è come se ci chiedesse di superare la distanza temporale che ci separa da quando è stato scritto il testo, per poterlo leggere così come il lettore “originario” (come quel lettore cioè che lo leggeva all’epoca); la pretesa è quindi quella di capire l’autore meglio di quanto l’autore abbia capito se stesso. Tutto ciò è l’esatto contrario dell’ermeneutica gadameriana: per Gadamer non si deve superare la distanza temporale, ma, al contrario, leggere il testo con tutto il tempo che ci separa dall’arte e perciò non lo si può leggere come lo leggeva il lettore originario. Di sfuggita, si può notare come l’ermeneutica, in generale, si distingua dalla critica: quest’ultima è integrazione del testo, l’ermeneutica è anche quello, ma, in più, è un’arte, divisa in momento divinatorio (abbinato da Schleiermacher al femminile) e momento comparativo (abbinato al maschile); col primo momento porto le cose in una specie di vuoto per poi illuminarle; col secondo, invece, metto a confronto le situazioni note con quelle ignote. Non è un caso che tutti gli ermeneutici si siano, in qualche misura, interessati a Platone: Ast è autore di un “Lexicon Platonicum”, Schleiermacher ha tradotto l’intero corpus dei dialoghi, in modo ermeneutico: si possono capire Platone e i suoi dialoghi solo se li si riconduce ad un’unità e si può capre tale unità solo se si capiscono i singoli dialoghi. Dietro all’interpretazione linguistica c’è l’interpretazione della lingua, dietro a quella psicologica c’è l’interpretazione della persona: e l’interpretazione riesce quando non ci sono dissidi tra le due cose, ossia quando la persona mi è interamente data nella lingua. Il grande principio di Dilthey è “individuum est ineffabile”, con il quale egli sottolinea come non si possa mai capire l’individuo fino in fondo. Dilthey resta scosso dalle “Ricerche logiche” di Husserl, che lo inducono a trasformare la sua posizione, spostando l’attenzione dall’individuo all’espressione: cogliere la vita dentro di sé e coglierla con i mezzi della vita stessa. Ogni pagina scritta mi rimanda a chi l’ha scritta: questo a Dilthey è poi sembrato un po’ riduttivo. Già Droysen aveva messo in luce la differenza tra comprendere e spiegare e l’aveva fatto per conferire specificità alle scienze dello spirito: anche Dilthey mantiene tale distinzione, ma con seri problemi; distingue tra psicologia descrittiva (che non spiega con il nesso causa/effetto, giacchè esso non può sussistere nella sfera psicologica) e psicologia esplicativa, che è un’illusione. Se il primo canone dell’ermeneutica grammaticale vuole che si debba capire l’autore secondo la lingua del suo pubblico (se ad esempio leggo il Vangelo di Matteo devo capire cosa pensasse e a chi si rivolgesse), il secondo canone dice che nessuna parola è isolata, ma è sempre all’interno di un preciso contesto (la proposizione, l’opera, ecc). Dilthey riprende questa distinzione operata da Schleiermacher (non a caso scrive un’opera intitolata “La vita di Schleiermacher”, un lavoro molto approfondito di ricerca storica) e fonda l’ermeneutica sull’individualità: la comprensione è, secondo lui, un’arte che sfugge ad ogni meccanismo rigorosamente determinato e determinabile; scrivere un testo è un’arte, ma interpretarlo è azione altrettanto speciale, poiché è richiesta un’altrettanto marcata genialità, visto che si deve ripetere tutto ciò che è successo nell’’utore (ecco perché Dilthey poteva affermare: “individuum est ineffabile”). L’ermeneutica diltheyana è, come quella di Schleiermacher, un’ermeneutica dell’individualità, che pretende di comprendere l’autore meglio di quanto l’autore avesse compreso se stesso; mentre infatti l’autore è, a tutti gli effetti, se stesso e produce le sue opere per un impulso interno, l’interprete deve costruire artificialmente con arte ciò che l’autore ha fatto senza passare per un percorso costruito. Dunque, per Schleiermacher e per Dilthey si tratta di capire l’autore meglio di quanto egli si fosse capito; per Gadamer, invece, si tratterà di capirlo diversamente. Quella di Dilthey, poi, è un’ermeneutica dell’Erlebnis, del rivivere con paqoV , del sentire le cose così come le ha sentite l’autore stesso. E, a questo punto, si aprono due possibilità: o l’atteggiamento epistemologico (che verrà seguito da Dilthey e da Emilio Betti) o l’atteggiamento ontologico (che sarà seguito da Heidegger e da Gadamer); quest’ultimo atteggiamento consiste nel non voler conoscere l’intimità dell’autore in questione, ma voler comprendere l’evento stesso dell’essere: l’essere di ciò che è nel testo è ciò che si deve comprendere, e il comprendere è l’essere (comprendere dunque non l’autore, ma ciò che è nel testo), tenendo conto (a differenza di quanto faceva Schleiermacher) della distanza temporale che ci separa dal testo. Per la storia dell’ermeneutica è importantissimo anche Max Weber, poiché oltre al testo pensa che debba far parte dell’ermeneutica anche l’azione: in una prospettiva piuttosto simile, Ricoeur ha scritto “Dal testo all’azione”, in cui coglie il passaggio dall’ermeneutica ottocentesca a quella “moderna” del Novecento nel fatto che quest’ultima si è resa conto (e il lavoro di Weber è centrale in tal senso) che il comprendere non riguarda solo i testi, ma anche le azioni (tant’è che si parla spesso di “significato dell’azione”), cosicchè si può gadamerianamente parlare di universalizzazione dell’ermeneutica. Weber (cui tra l’altro spetta il merito di aver introdotto una spiegazione causale anche nel comprendere) era profondamente insoddisfatto di fronte alla distinzione (di remota ascendenza medioevale) operata nell’Ottocento da Droysen (e ribadita energicamente da Dilthey) tra capire e comprendere: per Dilthey l’ermeneutica è l’ organon delle scienze dello spirito, basato sull’intuizione. Con questa distinzione sullo sfondo, Frege ha scritto un saggio “Senso e denotazione”, dove “denotazione” sta per “significato”, riprendendo le considerazioni di Wolf sul senso e sul significato. Schmitt propone l’idea che a stabilire le leggi sia chi detiene il potere, sottolineando in tal modo l’arbitrarietà delle leggi stesse (come già notava Hobbes, le leggi sono valide per tutti fuorchè per il sovrano): crolla la fiducia nell’esistenza di una tavola delle leggi immobile e questo è importante per l’ermeneutica perché apporta una variazione al pensiero antico (Antigone, ad esempio, si appellava alle leggi non scritte). Nel capitolo 5 della seconda sezione di “Essere e Tempo”, Heidegger confessa di voler proseguire il lavoro avviato da Dilthey, assumendo però un atteggiamento assai lontano: introducendo il senso dell’essere, finisce infatti per introdurre una dimensione diversa dall’estrema libertà dell’individuo; certo Dilthey e Heidegger sono accomunati dalla decisa opposizione alla tradizione illuministica e al suo culto ossessivo della ragione, ma ad Heidegger l’atteggiamento ermeneutico alla Dilthey sembra piuttosto limitativo: nello spirito non ci sono leggi e ciò significa che bisogna procedere in altro modo; lo sforzo di Weber e di Heidegger (anche se Heidegger non cita mai Weber) è di ridare peso a questi ambiti troppo sottovalutati; e perciò Lowith e Marcuse accuseranno il maestro di riportare il pensiero all’antichità, visto che per Heidegger il compito del pensiero è pensare l’essere ma questo è venuto meno nell’età moderna (pensiamo all’accusa di nichilismo che Heidegger muove alla società a lui contemporanea). E’ come se Heidegger, quando parla dell’essere, si riferisse ad una dimensione esclusivamente orale (ed era appunto sull’oralità che Platone aveva puntato nella sua famosa “Lettera VII”): Heidegger non pubblica la sua terza sezione di “Essere e Tempo” (forse l’aveva pubblicata, ma l’ha poi distrutta) e prosegue il lavoro avviato da Dilthey perché, diversamente da Weber, tiene conto dell’ineffabilità dell’individuo (ed è appunto l’unica cosa che mutua da lui) e la trasferisce all’essere (cosa, questa, impensabile per Dilthey, anche se già lui diceva che i grandi sistemi metafisici non hanno ormai più senso). “Verità e metodo” di Gadamer assume un atteggiamento affine a quello heideggeriano, arrivando a sostenere che è nel linguaggio che si coglie l’essere e a diagnosticare l’universalizzazione dell’ermeneutica (nozione sulla quale Habermas aveva i suoi seri dubbi: il sottosviluppo e mille altri fattori testimoniano che l’universalità dell’ermeneutica non esiste).
HEIDEGGER: L’ORIGINE DELL’OPERA D’ARTE
Lo scritto di Heidegger “L’origine dell’opera d’arte” risale agli anni ’30, anche se fu pubblicato solo negli anni ’50, all’interno dell’opera “Sentieri interrotti”; fu però nel 1989, centenario della nascita di Heidegger, che lo scritto ebbe una pubblicazione ufficiale, all’interno di un periodico dedicato al pensiero heideggeriano. In realtà, già il 13 novembre 1935 Heidegger aveva tenuto una prima conferenza sul tema dell’opera d’arte e aveva donato una copia di questa conferenza a Elisabeth Blochmann, una studiosa di pedagogia di origine ebraica. Proprio a questa sua amica Heidegger scrive, il 20 dicembre 1935, parlandole di quella conferenza tenutasi a Friburgo e definendo il manoscritto inviatole una “seconda versione”, alludendo ad una prima versione del 1931-32, un periodo che lui non esita a definire “felice” per il suo operato filosofico. L’anno seguente, nel novembre del 1936, tiene altre conferenze sul tema dell’opera d’arte a Francoforte: proprio da esse trarrà origine la versione pubblicata nel ’50 nella raccolta “Sentieri interrotti”. Si tratta di una raccolta dal titolo emblematico: i “sentieri” a cui fa riferimento Heidegger sono quelli “del bosco”, che cioè non portano da nessuna parte e non servono a nulla di preciso se non a muoversi all’interno del bosco stesso; sotto questo profilo, la traduzione francese del titolo rende bene l’idea: essa suona “Sentieri che non portano da nessuna parte”. I sentieri sono dunque le singole ricerche contenute nel libro che si inoltrano nel bosco dell’essere per signoreggiarlo, ma che in realtà finiscono per perdersi in esso. Come scrive Heidegger ancor prima di iniziare il libro: ” Holz è un’antica parola per dire bosco. Nel bosco ci sono sentieri che, sovente ricoperti di erbe, si interrompono improvvisamente nel fitto. Si chiamano Holzwege. Ognuno di essi procede per suo conto, ma nel medesimo bosco. L’uno sembra sovente l’altro: ma sembra soltanto. Legnaioli e guardaboschi li conoscono bene. Essi sanno che cosa significa trovarsi su un sentiero che, interrompendosi, svia “. Uno di questi “sentieri interrotti” è quello riguardante l’opera d’arte (“L’origine dell’opera d’arte”). E’ molto significativo che il primo abbozzo delle conferenza risalga al 1931-32, perché in quel periodo Heidegger stava producendo il suo secondo grande capolavoro (dopo “Essere e Tempo”), “Contributi alla filosofia. Addicimento”: un libro consistente, portato a termine ma mai pubblicato perché pressochè incomprensibile nella disposizione e nella terminologia; c’è chi in tal libro, a ragion veduta, ha scorto un vero e proprio tentativo di Heidegger di creare un sistema in cui dare una sistemazione a tutte le altre opere (Heidegger stesso, in una lettera del dicembre del ’35 apre spiragli in questo senso). Per comprendere a fondo “L’origine dell’opera d’arte” è bene far riferimento, seppur di sfuggita, a quest’opera, visto che, come tutte le cose scritte dal “secondo Heidegger”, anche “L’origine dell’opera d’arte” è stata composta in funzione di questo sistema che però è taciuto dall’autore: “Contributi alla filosofia” è costituita da sette parti o, come le chiama Heidegger stesso, “cose ordinate le une rispetto alle altre”, aventi titoli che, di per sé, dicono poco: dopo lo “sguardo preliminare” che apre lo scritto, troviamo, ad esempio, una sezione intitolata “il risuonare”, in cui si parla del fatto che l’essere è stato abbandonato da noi che lo trascuriamo e, al contempo, ci ha lui stesso abbandonati di sua iniziativa; ne consegue un “risuonare” del fatto che l’essere si è ritirato e che ormai il pensiero greco (che reggeva “Essere e Tempo”) ha perso la sua validità. Il problema dell’essere, infatti, fu per la prima volta avvertito dai Greci, ma essi subito se ne distaccarono, poiché ponevano in modo errato il problema, in termini di “sostanza” e di “essenza”. Dopo il grande inizio greco (chiusosi ben presto con il ritirarsi dell’essere), quindi, “risuona” in lontananza un nuovo grande inizio, quello richiesto dal fatto che, appunto, l’inizio greco è svanito: l’essere così come si era dato nel pensiero greco declina e cede il passo ad un’altra e nuova determinazione che deve avvenire. In questa prospettiva, la parola tedesca impiegata da Heidegger per designare l’ “inizio” è Anfang, termine che indica le ragioni profonde della storia, mai racchiudibili entro un solo fatto; tale termine è da Heidegger contrapposto a Beginn, che designa invece l’inizio effettivo e, in termini militari, le scaramucce che precedono la battaglia vera e propria. La seconda sezione dell’’opera porta un titolo altrettanto originale: “rimessa in gioco” (o anche “acclaramento”), con riferimenti al linguaggio calcistico; con questo titolo, Heidegger vuol proporre una rimessa in gioco, quasi come se la “partita” fosse stata momentaneamente interrotta. La terza sezione, invece, è intitolata “l’esordio” o “il salto”, termine quest’ultimo particolarmente caro a Heidegger: con tale espressione, egli sostiene che si dovrebbe, paradossalmente, saltare dove si è già; come a dire che il fatto di essere qui non è immediato, ma richiede, appunto, un salto, perché non è tutto necessariamente chiaro sul nostro essere qui. Viceversa, perché si colga quel che è talmente ovvio da passare sotto silenzio, è opportuno accorgersi (con un “salto”) di essere, cosa che tendiamo a dare troppo per scontato; un tema, questo, già toccato in “Essere e Tempo”, quando, proprio in apertura dell’opera, Heidegger sosteneva che il vanto della nostra epoca è di tornare alla metafisica ma dimenticando il vero problema di quest’ultima, ovvero il ripiegarsi dell’essere su se stesso. La quarta sezione di cui è costituita l’opera “Contributi alla filosofia” è intitolata “la fondazione”: in essa troviamo un riferimento all’opera d’arte, che sarà poi al centro dello scritto “L’origine dell’opera d’arte”. Nella quinta e nella sesta sezione dell’opera, Heidegger tratta esplicitamente dell’ “altro inizio” di cui abbiamo poc’anzi parlato: esse, non a caso, sono intitolate “i futuri”. La settima ed ultima sezione, infine, si chiama “l’ultimo Dio”: il tema portante sta nella presa di coscienza, da parte dell’autore, del fatto che tutti gli dèi si sono raccolti in un’essenza che ormai si ritira (evidente l’allusione heideggeriana alla “fuga degli dèi” di cui parla Hölderlin), con la conseguenza che, ora, è troppo tardi per gli dèi, ma ancora troppo presto per l’essere. Il V capitolo di “Essere e Tempo” è dedicato alla nozione di destino (parola che, nella lingua tedesca, è affine a “storia”), già presente, peraltro, in Agostino (quando diceva che Dio è un peso che, solo una volta accettatolo, ci permette di capire la sua importanza) : ora, il destino è l’argomento portante dei “Contributi alla filosofia”, in cui avviene una svolta dall’ontologia all’atteggiamento con cui non determino concettualmente l’essere, ma capisco che il destino stesso produce una sua concettualità, con un’evidente critica di fondo alla logica matematica e alle sue strutture mentali astratte. Nella prospettiva heideggeriana, è la realtà stessa a produrre la propria comprensione, e, per questa concezione, il pensiero di Heidegger appare, in qualche modo, vicino a quello di Kant: in realtà, tuttavia, sussiste tra i due pensatori una diversità colossale; per Kant vi è una disposizione logica a priori, che incontra il mondo e determina il costituirsi delle varie scienze stabilendo la regolarità della natura (l’intelletto, in tal modo, è indipendente dall’esperienza sensibile). Per Heidegger, invece, non si deve pensare l’indipendenza dell’intelletto dalla realtà, ma, al contrario, bisogna pensare che solo la congiunzione di queste due cose può produrre la comprensione. Questo rifiuto, da parte di Heidegger, dell’a priori kantiano è presente anche in Husserl, il quale ha etichettato come “mitico” (e dunque lontano dalla realtà) l’idea kantiana di un intelletto sganciato dalla realtà sensibile. Su queste tematiche, Heidegger tiene, nel 1937, il corso “Domande fondamentali della filosofia: selezioni di problemi della logica”: in esso, viene posto in maniera chiara il problema dell’ “altro inizio” (di cui abbiamo già detto) in relazione al tema della logica. Il nocciolo del corso sta nella proposta heideggeriana di una “logica filosofante”, contrapposta ad una logica scarna ma universalmente valida; la logica, sostiene Heidegger, non è un insieme di regole, giacchè il pensiero, propriamente, non è asservito a nessun tipo di regola. Il pensatore tedesco vuole mettere in luce come una dimensione logica esista già nella lingua e come questo non abbia nulla a che fare con la logica di tipo metafisico: il linguaggio, egli dice, ha una sua struttura coerente, che deve essere ricercata nelle etimologie ed è in virtù di questa considerazione che Heidegger, sulle orme di Hölderlin, punta tutto sulle singole parole e non sulle frasi. Dobbiamo tradurci nel pensiero greco e provare a pensare non come se il pensiero fosse un’origine, come siamo stati abituati erroneamente da Aristotele in poi a concepire Dio come puro pensiero; la scienza stessa è erede di questo pensiero, poiché essa poggia sul presupposto che tutto sia traducibile in pensiero. Heidegger, quindi, suggerisce di cominciare a pensare dalla “affettività”, purchè il sentimento non finisca nelle mani della psicologia, perché anch’essa è una scienza (abbiam finito, constata Heidegger con amarezza, per fare perfino della nostra psiche un oggetto di scienza). Significativo è, da questo punto di vista, l’ultimo corso tenuto da Heidegger a Friburgo, nel 1951, “Che cosa significa pensare?”: in esso, largo spazio viene dato al verbo “significare”, che in tedesco vuol anche dire “spingere”; quindi, la domanda “che cosa significa pensare?” può anche essere tradotta con “che cosa ci spinge a pensare?”. In altri termini, si chiede Heidegger, è vero che traduciamo ogni cosa nelle formule di pensiero, così come ci ha insegnato il pensiero antico, ma che cosa ci spinge a farlo? Perché tradurre tutto nel pensiero? Platone e, soprattutto, Aristotele avevano risposto a questo interrogativo sostenendo che il pensiero nasce dal qaumazein , ovvero dalla meraviglia; in quest’ottica, dunque, vi è prima una dimensione “affettiva” (la meraviglia) e poi, ad essa, fa seguito il pensiero. Lo stesso linguaggio impiegato in “L’origine dell’opera d’arte” non vuol cedere nulla alla logica: per investigare sull’arte, la logica va tenuta distante; posso dire che un’opera d’arte è una cosa, ma questa definizione, evidentemente, non basta; l’opera d’arte, infatti, è anche qualcos’altro. Il quadro che ci sta dinanzi non è una pura e semplice cosa appesa al muro come potrebbe esserlo un fucile da caccia; certo, nessuno può negarlo, il quadro è anche una cosa e, come tutte le cose, può essere materialmente spostato da una città all’altra: ma, limitandoci a intenderlo come cosa, non si spiegherebbe perché si fanno le mostre proprio con tale quadro e non con una qualsiasi altra cosa. Nella “cosa” quadro, accade qualcosa di artistico, che non toglie però che il quadro resti, in ultima analisi, una cosa: se non ci fossero cose, infatti, non potrebbero nemmeno esserci opere d’arte; cose sono dunque le pietre, i martelli, le scarpe ma, accanto a ciò, esiste anche una dimensione affettiva, che ci fa vedere quanto sia riduttivo vedere l’opera d’arte come una semplice cosa qualsiasi. Essa è, viceversa, un insieme di cose che vengono a sussistere lì nella cosa e che la rendono opera e non solo cosa; e, sotto questo profilo, ciò che costituisce il mondo e l’opera d’arte è del tutto inconsistente in termini logici. Lo sforzo di Heidegger è di capire la verità dell’opera d’arte, la quale non è riposta nella sua consistenza di oggetto, ma in un qualcosa che non posso definire se non in termini di storia dell’arte, con considerazioni anche tecniche che fanno sì che quella cosa sia un’opera d’arte. Un quadro, dunque, è sì una cosa, ma quando lo considero come opera d’arte, diventa una cosa in cui è successo qualcosa: per capire tutto ciò però, è necessario rinunciare ad una visione esclusivamente logico/scientifica. In “Che cosa significa pensare?” Heidegger stabilisce, con grande acutezza, connessioni tra pensare, ringraziare e poetare, sviluppando una posizione polemica contro il positivismo e l’idealismo; se Husserl continua ad illudersi della possibilità di un pensiero puro e, conseguentemente, di una filosofia come scienza rigorosa, Heidegger, invece, muove dalla convinzione che il pensiero nasca dai fatti; a suo avviso, pensiamo così perché le cose sono andate così (e qui riaffiora la nozione di destino). Proprio nel proseguire ripudiando la pretesa di una logica universalmente valida risiede l’ “altro inizio” di cui parla Heidegger; non si tratta, tuttavia, di un pensare da capo (come si proponeva invece Cartesio nel “Discorso sul metodo”), ma, semplicemente, da un altro inizio, prendendo atto della connessione situazione/pensiero: la filosofia, si potrà allora giustamente osservare, non serve assolutamente a nulla se raffrontata con il lavoro di un ingegnere; eppure il lavoro della filosofia è a lungo termine ed è riscontrabile in quelle grandi trasformazioni che avvengono saltuariamente e che vanno ricondotte, appunto, all’operato della filosofia che ha capito l’essere. Il problema dell’essere sta proprio, secondo Heidegger, nel vedere la storia da una distanza tale che ci permetta di vedere la figura del destino e, per fare ciò, si deve necessariamente rinunciare alla posizione logica e trascendentale (l’idea, cioè, che si possa isolare una dimensione del pensiero, poiché, in verità, tutto scaturisce dall’affettività): si devono respingere l’io trascendentale di Kant e lo spirito di Hegel per basarsi sul tratto esistentivo, perché quello attuale, dice Heidegger, è un “tempo di povertà”; similmente, Hölderlin si domandava “perché ci sono i poeti nel tempo della povertà?”: perché, risponde Heidegger, si riconosce l’insufficienza delle dimensioni trascendentali e quindi solo i poeti, ovvero coloro che provano, sentono e sono semi-dèi (preparano cioè l’incontro tra uomini e dèi) possono ricostruire l’arte. L’atmosfera che aleggia ne “L’origine dell’opera d’arte” è del resto tipicamente quella degli anni ’30 e non a caso lo scritto è strettamente legato ai “Contributi alla filosofia”: rilevante è anche il sottotitolo di questo libro, “appropriamento” o, meglio ancora, “addicimento”, in riferimento al momento in cui le cose si “addicono”, ossia si fanno proprie. In altri termini, per addurre un esempio, è solo nella musica che colgo effettivamente che ci sono suoni nel mondo, quasi come se essi si raccogliessero e si “facessero propri”, venendo colti esclusivamente come suoni. Sotto questo profilo, dunque, l’arte è un’artificiale sospensione dello stato normale delle cose ed è grazie ad essa che riesco a cogliere lo stato proprio (in questo risiede l’ “appropriamento” del sottotitolo) delle cose; ed è curioso che Heidegger spieghi l’opera d’arte senza far riferimento alla bellezza: nel momento in cui assisto ad un’opera d’arte, le cose cessano di funzionare e appaiono, dice Heidegger, nella loro “cosalità”, ovvero nel loro essere cose. La cosa, quindi, è cosa solamente nell’opera d’arte e non perché questa coglie la bellezza, bensì perché mostra la cosa nel suo essere cosa. In quest’ottica, Heidegger conduce un’approfondita analisi del dipinto di Van Gogh in cui vengono raffigurate due scarpe: esse non vengono colte nel loro funzionamento, ma sono sospese da ogni funzione e, proprio in virtù di ciò, mi accorgo che sono cose. Ed è importantissimo capire che sono cose e non, propriamente, scarpe: e, nota Heidegger, non è un caso che Van Gogh abbia rappresentato due scarpe sinistre. Abbiamo accennato al fatto che l’analisi heideggeriana sfugge alla categoria di bellezza: sarà invece Gadamer a riportare il pensiero di Heidegger ai canoni tipici dell’estetica, cosicchè la filosofia gadameriana potrà essere definita, secondo le parole di Habermas, come un’urbanizzazione della filosofia di Heidegger. Dalla facoltà dell’arte di mettere in luce la cosalità delle cose emerge un altro tratto essenziale: il rapporto tra mondo e terra. La terra è il chiuso rispetto all’aperto del mondo; il mondo, invece, è un luogo aperto, in cui le cose hanno la loro funzione, armonica con tutto il resto (nel mondo tutte le cose “servono per”, sono cioè strumenti, e il mondo stesso è la determinazione strumentale delle cose): non è un caso che, in generale, si tendano a definire le cose in base alla loro funzione (ad esempio: alla domanda “cosa è la sedia?” si risponderà “è quella cosa che serve per sedersi”). L’arte, dal canto suo, sospende questa strumentalità propria del mondo e rimanda alla terra, al chiuso, al non funzionale: la terra è dunque lo sfondo sul quale si edifica un mondo. Heidegger desume la parola “terra” da Hölderlin (celebre è una sua poesia “Alla madre-terra”), che era solito contrapporla nettamente al cielo. Ora Heidegger, influenzato dalla poesia hölderliniana, tende a leggere il mondo come incontro di quattro elementi fondamentali: cielo, terra, divino, mortale; e non è un caso che egli elabori una posizione di questo tipo negli anni ’30, proprio quando si era distaccato dal cristianesimo e, con esso, dalla cultura europea, rifacendosi ad una visione elementare ed immediata della realtà, con espliciti richiami irrazionalisti alla terra. L’intento di Heidegger, come egli stesso afferma in “La poesia di Hölderlin”, è di risalire ai Greci saltando la tradizione latina e cristiana: è opportuno evitare la religione perché essa è semplicemente una questione dei latini, ci vuole un rapporto con la terra che, in quanto chiusa, si apre continuamente nel mondo. E’, curiosamente, come se “L’origine dell’opera d’arte” prendesse in esame non tanto l’opera d’arte, quanto piuttosto la cosa: l’opera d’arte è, infatti, l’essere cosa della cosa. L’arte in questione, su cui si sofferma Heidegger, è, in buona parte, quella delle avanguardie, quella cioè considerata “degenere” dal regime nazista: il nazismo, infatti, cercò di sostituire l’arte con quella che Benjamin definiva “estetizzazione della politica”, ovvero viene tolta dal suo posto e generalizzata; questo atteggiamento, peraltro, prosegue anche dopo il crollo dei regimi totalitari, come se fosse il mondo stesso a diventare estetico. Heidegger indaga anche sulla tecnica e prova a metterne in luce l’altro lato rispetto a quello più noto: egli fa notare che per gli antichi greci la parola tecnh comprendeva sia l’arte sia la tecnica, e le colonne del tempio greco erano, al contempo, opera d’arte e di tecnica, in quanto appoggio fantastico di terra e cielo. Heidegger mette dunque in evidenza il tremendo destino delle parole: il termine tecnh designa l’arte ma anche la tecnica distruttiva, che fa sì, ad esempio, che l’uomo venga integrato alla macchina; ma l’origine dell’arte e della tecnica, così diverse tra loro, è la medesima: si tratta dunque, nel far emergere l’essenza dell’arte, di tenerla distinta da quella pericolosa dimensione che è la tecnica. Sembra, fino a questo punto, che il linguaggio di Heidegger sia estremamente complesso, quasi volutamente complesso: e in realtà lo è solo nella traduzione italiana, perché nell’edizione in lingua originale il filosofo tedesco si serve quasi della parlata quotidiana; egli opera una netta distinzione tra cosa, strumento, opera. Fin dalle prime righe dello scritto “L’origine dell’opera d’arte” il problema dell’opera d’arte si moltiplica: dal momento che l’opera d’arte è, in primo luogo, una cosa, chiedersi quale sia l’origine dell’opera d’arte equivale a chiedersi quale sia l’origine della cosa in questione e la risposta più immediata che si possa dare è che l’opera d’arte ha origine dall’artista. Tuttavia, fatto questo chiarimento, è bene provare a rispondere ad una nuova domanda: quale è l’origine dell’artista? Paradossalmente, ci si trova costretti a rispondere che la sua origine è l’opera d’arte. Ne consegue che se l’opera d’arte è prodotta dall’artista, allo stesso modo l’artista è prodotto dall’opera d’arte: ci troviamo di fronte ad un’evidente circolo vizioso, da cui si può uscire in un solo modo: trovando un terzo elemento, cioè l’arte stessa. Possiamo dunque sfuggire al circolo vizioso soffermando la nostra attenzione non sull’opera d’arte o sull’artista, ma sull’arte stessa, a cui sono ugualmente legati sia l’artista sia l’opera d’arte: l’arte, in prima analisi, è definibile come attività umana, ma si tratta di una definizione non soddisfacente. All’incirca a metà del saggio, Heidegger afferma che l’arte è “il porre in opera la verità”, quasi come se fosse la verità stessa a farsi opera, ovvero strumento o, meglio ancora, un qualcosa che ha una sua precisa determinazione. La verità dell’arte, però, (ed è proprio la ricerca di una verità dell’arte che accomuna la ricerca heideggeriana a quella gadameriana), nota Heidegger, non è nemmeno tanto la bellezza: si può notare (e in parte l’abbiamo già fatto) come cogliere un attrezzo come tale o coglierlo invece in funzione di qualcos’altro (“serve per”) non sia la stessa cosa; il quadro di Van Gogh, ad esempio, quello che Heidegger chiama le “scarpe contadine”, è poverissimo di elementi all’infuori delle scarpe stesse, tanto che nemmeno si scorge bene il suolo: ed è proprio in quest’ottica che il paio di scarpe sinistre viene colto come cosa. Certo, le scarpe servono alla contadina per camminare con passi sicuri per i campi, ma esse, se colte come cose e non nella loro funzione (“servono per camminare”) evocano un mondo, quello della campagna contadina e delle sue fatiche. Proprio in questo evocare quel mondo, esse vengono trascurate nella loro funzione fondamentale: viceversa, quando la contadina le calza ogni giorno per recarsi al lavoro, le vede come puri e semplici strumenti per camminare e non come cose; ma quando, nel giorno di festa, ne indossa un altro paio, al rivedere quelle scarpe con cui ha camminato per i campi nel corso della settimana, esse rievocano in lei il mondo contadino, proprio perché in quel momento non servono. Parimenti, anche nell’osservatore del quadro, come nella contadina la domenica, le scarpe rievocano un mondo. Siamo dunque di fronte alla messa in opera della verità: la cosa, nella tradizione occidentale, è o una cosa su cui poggiano significati o da cui muovono percezioni o una cosa in cui si nota la distinzione tra forma e contenuto; le percezioni sensoriali, infatti, nota Heidegger, rimandano alla sostanza, cosicchè posso cogliere la cosa attraverso le percezioni (particolarmente significativo è l’esempioche adduce Heidegger: dalla mia stanza sento sulla strada un forte rumore e, a partire da questa percezione, mi viene in mente una macchina o una moto). Naturalmente sullo sfondo c’è un problema di vecchia data: è il pensiero che forma le cose (come credeva Kant) o sono le cose che formano il pensiero (come credeva Aristotele)? La pretesa di Heidegger è di uscire da questo vicolo cieco e una possibile soluzione è quella del “lasciare che”, così come, per tornare all’esempio del quadro, il mondo contadino si affida alle cose, senza porsi il problema se abbia ragione Kant o Aristotele. Proprio in ciò risiede quella che Heidegger chiama “affidatezza”, ovvero il fidarsi del mondo, indifferentemente dal prendere una posizione kantiana o aristotelica, ma prendendo una posizione che sta prima della metafisica. Ecco dunque che non si va incontro ad una filosofia dell’arte, ma si coglie la verità nella sua affidatezza, senza strane operazioni mentali volte a raggiungere la verità, dal momento che “siamo sempre nella verità” (“Essere e Tempo”, paragrafo 34); si può anzi dire che “c’è verità finchè c’è l’esserci”. La stessa esistenza è, dunque, immersa nella verità: esistere significa porre il problema della verità, essere nella verità, proprio come la contadina che è a suo agio con le scarpe per i campi; tutto quel mondo che per i filosofi non è tanto ovvio, per lei lo è, senza neanche la necessità di rifletterci (facendo dunque affidamento sul mondo). E il mondo è per lei aperto non perché le scarpe sono un attrezzo, ma perché esse, colte nella loro cosalità, rappresentano l’apertura di quel mondo. Da tutto ciò consegue che l’arte non è mera imitazione: Van Gogh non si è limitato ad imitare banalmente un paio di scarpe di una contadina; e, similmente, Hölderlin, nella composizione dell’ “inno al Reno” non si è limitato ad imitare il fiume. E del resto, se l’arte fosse imitazione, il tempio greco di cosa sarebbe imitazione? Dunque, si può a ragione affermare che il paio di scarpe di Van Gogh non è un’opera d’arte perché imita perfettamente le scarpe, ma perché raffigura un attrezzo colto in un non-funzionamento capace di aprire un mondo. Di fondamentale importanza, in questa prospettiva, è il tema della festa (che Gadamer riprenderà): essa è una manifestazione in cui tutto è sospeso, non si lavora e si coglie il mondo come è nella sua normalità; infatti, quando nel corso della settimana sono impegnato dal lavoro, non mi è dato di vedere il mondo perché sono tutto assorbito in esso. Quando invece sopraggiunge la festa, gli attrezzi non vengono visti nella misura in cui “servono per”, ma sono colti nel loro essere cose e diventano quindi punti d’accesso di un mondo che altrimenti non riuscirei a conoscere, diventano espressioni del sentimento della vita. Tuttavia, nota Heidegger, la tecnica, imperante nell’attuale mondo, è di notevole disturbo, giacchè con essa tutto “serve per” e non può dunque essere colto nel suo essere “cosa”. L’opera d’arte, invece, ha il grande merito di lasciare che la cosa sia nella verità, in uno stato d’animo che sfugge ai problemi scientifici, ovvero con il concreto stupore di fronte all’essere che si manifesta nel mondo; l’arte fa vedere la verità là dove la verità è la totale ovvietà (il mondo della contadina); è evidente come la posizione di Heidegger, finora delineata, si contrapponga nettamente alla teoria del genio. Si tratta, nella prospettiva heideggeriana, di portare il problema dell’ente non a una dimensione estetica (come avveniva in Kant) ma alla verità, a come la verità accade nell’opera d’arte, poiché quest’ultima è quella che è aperta alla verità. E’ dunque assolutamente sbagliato credere che l’opera d’arte sia astrazione, poiché ciò implicherebbe una concettualizzazione: ma la verità della vita è essa stessa vita e l’estetica sbaglia perché finisce per essere solo filosofia e non arte. Bisogna però notare che il fatto che la verità sia apertura non implica una contrapposizione tra vero e falso: già Aristotele, nel “De interpretatione”, diceva che solo una parte del logoV nasce dalla contrapposizione tra vero e falso, e non tutto; se infatti dico “apri la finestra”, tale affermazione non è suscettibile di falsità, c’è un vero non contrapposto al falso. Esaminiamo ora un po’ più nel concreto l’opera: Löwith diceva che Heidegger è per metà uno scienziato e per metà un tribuno della plebe; e in effetti è piuttosto difficile inquadrare Heidegger e i suoi scritti. Da “L’origine dell’opera d’arte” emerge chiaramente come tutto sia affettività, paqoV (nell’opera sono davvero pochi gli argomenti filosofici) e come il miglior modo di esprimere queste ultime sia dato dalle suggestioni evocative: fin troppo chiaro è il confronto con l’estetica tradizionale, che viene da Heidegger risolutamente respinta (insieme alla metafisica) per essere sostituita da una visione patetica e suggestiva dell’arte, scevra di argomentazioni logico-filosofiche. Il primo dei tre paragrafi che costituiscono l’opera è intitolato “La res e l’opera” ed è, in realtà, preceduto da una breve descrizione di come l’estetica tradizionale abbia sempre inteso l’arte: come allegoria (ovvero come un “dire qualcosa attraverso altro” , giacchè in greco allo agoreuw significa letteralmente “dire altro”; così la statua veniva intesa come dire un qualcosa nella pietra) e come simbolo (dal greco sumballein , “mettere insieme” una dimensione concreta, cioè la materia, con una rappresentativa). L’arte è infatti, tradizionalmente, intesa come un qualcosa che non è solo la materia che costituisce l’opera: bensì, è letta come l’unione di materia e forma, con un evidente riferimento alla teologia, dal momento che l’opera d’arte viene sempre concepita come un prodotto di qualcuno alla pari di come il mondo è inteso come prodotto di Dio. Il problema dell’estetica tradizionale risiede proprio nel considerare tutto in questo modo, mettendo insieme la dimensione pensata (formale) con quella materiale, priva di forma. Ora, Heidegger dice che si deve invece cogliere la cosa nella sua semplicità ed affiora un tratto che viene sviluppato soprattutto nel secondo paragrafo, intitolato “La verità e l’opera”, in cui si tratta del rapporto tra terra e mondo. Nel tentativo di cogliere la cosa nella sua semplicità, ci si accorge che essa, quanto più si cerca di afferrarla, tanto più si allontana da noi, come quando stringiamo una pietra ed essa si sbriciola: il lavoro che svolgiamo nei confronti delle cose, dunque, non fa altro che consumarle; il merito dell’arte, quindi, sta nel trattare le cose senza consumarle e proprio in questo risiede la differenza tra il lavoro dell’artigiano e quello dell’artista: l’artigiano consuma il colore nel verniciare le pareti, l’artista, invece, gli conferisce valore e lo fa essere ciò che esso è per davvero. Nell’opera heideggeriana incontriamo una notazione di rilievo sul rapporto tra opera e cosa: tutto il primo paragrafo è dedicato alla comprensione della cosa, come se fosse necessario comprenderla per poter, di conseguenza, comprendere l’opera d’arte; si tratta, ovviamente, di una suggestione inargomentabile con armi logiche, poggiante su basi puramente “retoriche” (cioè, in un certo senso, affettive). La scoperta cui porta il primo paragrafo è che, paradossalmente, non è la comprensione della cosa a spiegare l’opera d’arte, ma, al contrario, è la comprensione dell’opera d’arte a farmi capire il significato della cosa. L’esempio addotto da Heidegger è, come abbiamo già visto, quello del quadro delle scarpe di Van Gogh. Nell’opera d’arte, nota Heidegger, è rappresentato un attrezzo (le scarpe “servono per” camminare) ma in realtà, se letta in trasparenza, non è rappresentato in quanto attrezzo o in quanto cosa, viceversa l’opera d’arte coglie l’ “attrezzalità” nel momento in cui l’attrezzo non funziona come attrezzo; vedo che nel quadro qualcosa si sottrae e l’opera d’arte mi fa vedere che è un attrezzo (e non viceversa, come vogliono invece l’estetica e la metafisica). E’ dunque attraverso l’opera d’arte che colgo la cosalità delle cose, e non già perché colgo la materia (certo, è innegabile, le opere d’arte sono in materia e sono cose, anche se non tutte le cose sono opere d’arte): attraverso questo coglimento scorge il particolare sottrarsi di quel qualcosa che Heidegger chiama “terra”; non bisogna pensare che l’opera d’arte sia imitazione della realtà: e per convincerci Heidegger adduce due esempi, quello della poesia “La fontana” e quello del tempio greco; sembrano pure e semplici descrizioni di una cosa (di una fontana, di un edificio), ma in realtà viene colta l’essenza, rispettivamente, della fontana e del paesaggio (nel caso del tempio), come se l’opera d’arte istituisse un mondo. Il tempio greco è immerso nel paesaggio e tutto ciò che è, è in riferimento al tempio, giacchè esso è una essenza o, se preferiamo, uno “stanziarsi” (perfino il temporale è in riferimento al tempio). L’essenza qui in questione non è il tratto comune che fa sì, come in Platone, che tutte le case partecipino dell’unica idea di casa, ma, al contrario, è il tratto fondativo: non dobbiamo pensarlo, cioè, come il tratto comune che le cose hanno, ma come il tratto che fonda un mondo. Ed è proprio questo che viene sottratto al mondo moderno, che non ha più gli déi, non ha più tratti fondativi, è invaso dalla tecnica, non coglie più il tempio greco come essenza e tiene nei musei le opere d’arte come se fossero banali oggetti tecnici. La stessa arte è, nel mondo moderno, incapace di esporre il mondo, il che significa che quest’ultimo non è più costruito a partire dall’opera d’arte, ma dalle determinazione tecnica: l’essenza diventa allora qualcosa di calcolabile e di strettamente razionale, o, se vogliamo, la ragione diventa calcolo (vedi il paragrafo due). La suggestione cui fa costante riferimento Heidegger si è ritirata dal mondo moderno e, nel secondo paragrafo dell’opera, il filosofo si distacca dall’idea che l’opera parli della bellezza: essa parla, invece, della verità e a parlarne non è la logica; tuttavia il mondo moderno è un mondo che non ha più bisogno di opere d’arte. In una conferenza tenuta a Brema sul “Pericolo” Heidegger dice che l’arte può tranquillamente sparire dal mondo e tramutarsi in tecnica, però c’è il pericolo di far sopravvivere un mondo che non appartiene più alla sua essenza propria, cosicchè si finisce per credere di vivere in un mondo assolutamente tecnico, ma in realtà si continua a vivere in quel mondo che un tempo era costruito intorno all’opera d’arte (viene in qualche modo ripreso il tema del “salto”). La tecnica spezza il rapporto con la terra, la quale si ritira: se il tempio dei Greci guardava in tutto e per tutto fuori di sé, la Chiesa cristiana, viceversa, guarda interamente al proprio interno (le funzioni, gli ori, la vita). Si tratta dunque, per superare questa situazione moderna, di fare un “salto” o anche “un passo indietro”, poiché il mondo moderno non riesce a vedersi nel suo insieme, sa solo quantificare le singole cose: per fare ciò occorre guardare non alle opere come cose (come fa l’estetica), ma alle cose come opere, sospendendo l’ “attrezzalità” dello strumento. L’opera d’arte, quindi, attraverso la sua cosalità fonda e apre l’intero mondo, in quanto questo poggia su una terra che si sottrae: quest’ultima non è rappresentata nel quadro di Van Gogh, ma ciononostante è possibile cogliere che il mondo della contadina poggia sulla terra. Nel paragrafo due Heidegger dice che il mondo “si fa mondo” e che proprio in ciò risiede l’essenza del mondo: esso non è quindi una determinazione stabile, ma è un divenire continuo, un “mondeggiare”, giacchè il mondo è un farsi mondo e ha bisogno di un atto fondativo, che (nel caso del quadro) può essere individuato nelle scarpe che durante il giorno di festa non vengono calzate e usate. In quest’ottica, bisogna ricostruire la filosofia a partire dall’affettività (la retorica aristotelica), con un “salto”, o, come avrebbe detto Bergson, con “un supplemento di anima”. Le cose sono senza mondo, gli animali ne sono poveri: solo l’uomo ha mondo, perché egli ha l’arte; certo, gli animali dispongono della tecnica (sanno costruire strumenti a loro utili), ma solo l’uomo possiede la mano e se il mondo della tecnica è retto dal pensiero (come anche quello dei Greci), al contrario il mondo proposto da Heidegger è il mondo della mano, in cui anche il pensiero è opera della mano (e non viceversa). Sotto questo profilo, l’America rappresenta l’apice della tecnica, e ciò è ravvisabile, ad esempio, nel fatto che le opere d’arte vengano valutate, alla pari di ogni altra cosa, nel prezzo (la quantificazione tipica dell’era della tecnica), cosicchè si può scegliere se comprarsi una casa, una vacanza o, magari, un’opera d’arte. Nel secondo paragrafo, “La verità e l’opera”, il problema dell’opera d’arte viene ricondotto al problema della verità ed è questo il punto centrale del pensiero di Heidegger: come va intesa la verità perché l’opera d’arte possa essere concepita come sua rappresentante? Tradizionalmente, la verità è stata letta come corrispondenza tra la cosa e l’intelletto, con la conseguenza che tutta la tradizione greco-scolastica ha finito per contrapporre il pensiero alla materia, e la stessa concezione di Dio soggiaceva a questo schema (Dio crea a partire da un atto intellettivo). Ora, Heidegger vuol superare questo antico modo di pensare per poter così intendere la verità in un altro modo e per fare ciò non adotta argomentazioni propriamente filosofiche, proprio perché vuole superare il momento intellettuale. Come è noto, per i Greci la tecnh era un sapere, un far venire alla luce l’ente ed è qui che, allora, la verità non può essere una mera corrispondenza, altrimenti essa non sarebbe che la trasformazione delle cose della realtà in pensiero (ed è così che opera l’Occidente, pensiamo a Cartesio). Dobbiamo provare a pensare la verità non a partire dalla divisione cosa/pensiero, e a tal proposito Heidegger parla di “non-verità”, ossia di una verità che non ha contrapposizioni, che non è cioè contrapposta alla falsità, ma che è la verità di un conflitto. Sempre nel secondo paragrafo, si accenna, in questa prospettiva, al conflitto intercorrente tra terra e mondo: il mondo è un qualcosa che si fa a partire dalla terra, ciò su cui il mondo poggia ma che si ritira (della terra non posso fare un mondo, giacchè essa non si lascia civilizzare); la verità è esattamente il restare nel conflitto, essa non è una determinazione logica: è, anzi, una “non-verità”, una dimensione in cui emerge il conflitto. Ma se l’arte non è né una copia né un’imitazione di qualcosa, ma è verità, allora cosa si vede nell’opera d’arte (il quadro, il tempio, ecc)? si vede l’origine, risponde Heidegger nel terzo paragrafo (intitolato “Verità e arte”): l’opera d’arte viene letta come origine; propriamente, però, non c’è un’origine dell’opera d’arte, come non c’è un’origine della verità, ed è per questo che l’opera non può essere semplice imitazione della realtà. Ora, in questo terzo e conclusivo paragrafo, si afferma esplicitamente che l’opera d’arte è origine e, in virtù di ciò, verità. L’intero paragrafo orbita intorno a due questioni di fondo: 1) la differenza tra “creare” e “approntare”; 2) quale è l’essenza dell’opera d’arte, perché io possa dire che l’opera è creare? Analizziamo in primis il primo problema: noi traduciamo con “creare” la parola tedesca “shaften”, che, in realtà, è meno impegnativa del nostro “creare”; essa significa semplicemente “fare (senza seguire un modello)”, cosicchè il “creare” è sempre un creare guardando all’inusitato, con un “urto” contro l’essere che inaugura un mondo. Si dona senso inaugurando il mondo con l’opera d’arte, cosicchè quest’ultima è l’origine del mondo: le dimensioni fondative sono, secondo Heidegger, quattro: a) l’opera d’arte; b) lo Stato; c) la domanda del pensatore; d) il sacrificio essenziale (la morale fondata sul proprio sacrificio). Tale dimensione fondativa consiste nel dar luogo a qualcosa che prima non c’era e che ora viene ad esserci, con un inizio che è confine tra terra e mondo. L’opera d’arte è creazione perché coglie il momento del conflitto, e non è imitazione: nel quadro di Van Gogh, non vengono imitate le scarpe reali, ma è colto (attraverso la rappresentazione delle scarpe) il conflitto tra terra e mondo. L’opera è, dunque, quel punto di sutura tra la terra e il mondo, in cui il ritirarsi della terra consente quella donazione di senso che è il mondo. Un ruolo particolare è affidato al “dettare”: l’arte della parola ha un significato preminente perché la parola è ciò che più di ogni altra cosa ha funzione fondativa, sa dare origine (oltrechè ornare). “Dettare” è per Heidegger diverso rispetto a “poetare”: “dettare” è l’arte che dà origine, “poetare” è l’arte che dà ornamento. La creazione è la capacità di far uscire dall’oscurità della terra ciò che per sua natura tende alla luce: e l’artista fa esattamente questo. Tutto il secondo paragrafo è, come abbiamo detto, dedicato alla cosa e all’opera, e viene messo in luce come la cosa non è un qualcosa che viene fatto, mentre l’opera sì, è appunto “messa in opera”, e la sua essenza risiede nel far affiorare l’ente; l’opera non può essere dunque ridotta a pura cosa, perché ci si accorge della realtà della cosa grazie all’opera d’arte e non viceversa. L’essenza dell’opera non sta nell’essere conservata al museo o in biblioteca, ma la sua origine è che è essa stessa origine, e il mondo in cui viviamo è riflesso di Omero, di Sofocle e di Hölderlin. Ci sono quelli che “creano”, ma anche quelli che “salvaguardano”: infatti, una volta creata, l’opera d’arte può essere colta da chi la osserva e costui, in tal caso, ne diventa il custode e prolunga l’atto creativo di essa (e questo non perché è custodita nel museo). “Ciò che resta è fondato dai poeti”, diceva Hölderlin nella chiusa di un suo famoso inno: per Heidegger ciò significa sia che quanto si conserva (“resta”) è dell’arte, sia che quanto ci sarà, sarà solo più dell’arte. Non a caso la sesta parte dei “Contributi alla filosofia” si intitola “I futuri”, con l’idea di fondo che afferrare il senso dell’opera d’arte equivalga ad essere aperti ai “futuri”. Ma quella dell’opera d’arte è una “non-verità”, poiché non è un qualcosa di fisso una volta per tutte; ugualmente non c’è un pensiero fisso in grado di capire a fondo l’intero mondo, ed è per questo che Heidegger polemizza contro la filosofia tradizionale , la quale cristallizza tutto in schemi predeterminati; piuttosto che agire in tal modo, nota Heidegger, è meglio credere che la verità venga fuori dal nulla, sia creata e, nel momento in cui è creata, fornisca un criterio di sè. Tutte le opere d’arte sono casuali e inventate ma, tuttavia, proprio perché ci sono, portano con sé la comprensione di determinati ambiti del mondo. Quale parola può fissare tutto questo? La parola tedesca “Gestahlt”, che significa “forma” (“forma” però intesa senza riferimenti materiali, altrimenti sarebbe “sagoma”): l’opera d’arte si propone in una sua forma; nel saggio compare, in merito, il tema del “ciò che è posto”, con l’idea, ad esempio, dell’essere esposte delle opere d’arte nelle mostre. L’opera deve essere prodotta (nei suoni per quel che riguarda la musica, nella pietra per la scultura, nei colori per la pittura, ecc) e per far ciò è necessaria la materia, ma Heidegger respinge nettamente la tradizionale distinzione materia/forma (giacchè rifiuta che l’arte nasca come messa in atto del pensiero): tutto ciò va, per, a favore della materia. Infatti, è vero che la pietra non è pura e semplice “materia” e che la statua non è pura e semplice “forma”, ma la statua è per Heidegger la pietra stessa che emerge, come la poesia è la parola stessa che emerge. Certo, l’opera d’arte rende possibile la comunicabilità e Heidegger nota come sia necessaria una nuova parola che sostituisca quella che significa “materia”, poiché quest’ultima (restando all’esempio della scultura) designa solo la pietra e non la statua. Heidegger propone allora la parola “Gestell”, che, letteralmente, significa “piedistallo”, “ripiano” e, in generale, tutto ciò su cui si può appoggiare qualcosa; tale termine viene da Heidegger impiegato in connessione a “Gestahlt” (“forma”) e può essere tradotto, meglio che con “piedistallo”, con “supporto”, “formatura”, come se questa parola fosse adoperata per indicare qualcosa di diverso da ciò che solitamente indica: è avvenuto qualcosa, è stato posto qualcosa nel marmo e per questo il marmo si è rivelato come marmo. Ciò ha richiesto l’opera di una mano: e l’opera d’arte è proprio questo, un qualcosa che non c’era e che è stato posto e non a partire dal pensiero; è infatti grazie alla mano che la pietra si è mostrata nel suo essere pietra, senza alcun contenuto “culturale”; il mostrarsi della pietra, dunque, rivela l’opera della mano. E il conflitto tra terra e mondo è conflitto tra nascondimento e illuminarsi, il quale è ottenuto con uno scontro contro la terra: esattamente questo è la verità, ossia l’illuminarsi in contrasto con l’oscurità della terra; e Heidegger parla espressamente di “montagna dell’essere”, in riferimento all’emergere da una terra che non può essa stessa mostrarsi. La ricerca che avviene nell’arte è proprio la ricerca dell’apertura, senza contrapposizioni col falso, poiché non è questione di logica, ma di mano: proprio a partire da questi presupposti, Derrida ha scritto un saggio su “La mano di Heidegger”, con riferimento all’esistere come dimensione operativa ed esistentiva; del resto, il paragrafo 38 di “Essere e Tempo” recita che “l’esserci esiste di fatto”. Certo, il pensiero rientra nel fare, ma non lo precede. Il termine centrale in questa ricerca che avviene nell’arte è “Riss”, il “tratto scissibile”, la “crepa”, ovvero il cogliere il distacco del mondo dalla terra, cogliendo il mondo e, nel contempo, il suo inverso (la terra appunto). Il mondo, proprio in virtù di questa scissione, è labile e l’arte non fa che fissare momentaneamente il mondo. Già nella riflessione di Dilthey era centrale la parola Erlebnis (“esperienza vissuta”), derivante dal verbo Erleben (“vivere”): se in Dilthey tale parola era fortemente positiva perché coglieva la vita (e Dilthey si proponeva appunto di costruire una filosofia della vita), per Heidegger è l’esatto opposto, è una parola negativa, poiché probabilmente nell’Erleben l’arte non vive, ma muore. A questo proposito, Heidegger cita esplicitamente Hegel e la sua “Estetica”: l’arte ha cessato di essere il modo primario in cui accedere alla verità e dunque appartiene al passato; tuttavia, se per Hegel è giusto che sia così, perché il movimento dello Spirito prevede un superamento dell’arte in favore della filosofia, al contrario, per Heidegger, è una cosa pericolosissima, anche se per noi è piuttosto difficile capire a fondo che cosa egli voglia effettivamente dire. Certamente, non pensa ad un ritorno magico a quando la verità si mostrava nell’arte, perché ciò sarebbe un inutile rimpianto per il passato; in particolare, nella postfazione a “L’origine dell’opera d’arte”, egli dice che il problema non è quello di risolvere l’enigma dell’arte ma, piuttosto, di vederlo, di accorgersi cioè che esso sussiste. La posizione hegeliana, che pensa la morte dell’arte, in fondo continua a credere che l’enigma dell’arte sia risolto sotto forma di trapassamento della verità dall’arte alla filosofia, ma questo è proprio ciò che Heidegger si rifiuta di accettare: è inammissibile, egli sostiene, che vi sia una carica spirituale che possa manifestarsi prima nell’arte e poi nel pensiero. La storia stessa, egli prosegue, non è un puro e semplice passaggio da certe maniere di manifestarsi della verità ad altre: tanto più che, per quel che riguarda l’arte, essa non può affatto essere risolta come contrapposizione di spiritualità a materialità, come faceva Hegel, ad avviso del quale l’artista fissa i concetti attraverso forme materiali (il marmo per la scultura, la tela per la pittura, ecc). Sarebbe del resto assurdo accettare tale contrapposizione, visto che nell’arte si manifesta la verità come messa in opera e questa messa in opera della verità vale sia nel senso che la verità viene messa in opera sia nel senso che lei stessa si mette in opera. Il momento sensibile non può (né deve) essere superato, checchè pensi Hegel: né è vero che oramai l’arte debba continuare ad esistere come un qualcosa confinato ad una certa limitata regione. Viceversa, secondo Heidegger, la verità si mette in opera nell’arte e il sensibile non è affatto un limite: in quest’ottica, Heidegger propone di eliminare la classica distinzione tra il sensibile e lo spirituale, tra la materia e la forma; per restare all’analogia con Hegel, non è sbagliato dire che per Heidegger la verità sia sempre già data nella tesi, immediatamente, senza dover attendere la sintesi per coglierla: l’essere stesso è una frattura, è sempre situato, ma bisogna fare attenzione a non confondere la posizione heideggeriana con quella materialistica: ogni cosa è appropriazione di se stessa, non la si può immaginare come proveniente da altrove; al massimo, è lecito affermare che la verità provenga dal nulla, a patto che non si parli del nulla dell’ente. Ogni cosa è grazie ai suoi confini, in antitesi con quanto diceva la tradizione, la quale collocava le cose come se il confine fosse una condanna, mentre invece una cosa è grazie ad esso (la perfezione delle cose sta sempre nel finito, dice Heidegger). L’arte è quindi un evento ed è del tutto casuale che l’opera si trovi appesa ad un muro, conservata in un museo o esposta in una mostra: certo, se Van Gogh non avesse dipinto quelle scarpe, il mondo della contadina ci sarebbe stato ugualmente (seppur limitato all’esperienza della contadina), ma sarebbe a noi rimasto sconosciuto. Si può stabilire una differenza tra Erleben e Bewahren: il primo implica una sfumatura psicologica (il ricostruire mentalmente il mondo della contadina), il secondo non richiede alcuna capacità (è semplicemente la presenza della verità di quel mondo). Il quadro è inverato da chi lo guarda perché c’è la verità, l’essere, il quale traspare nell’opera d’arte ed è “dettato”. E poi non ci può essere un superamento dell’arte anche perché le cose non possono non essere espresse nel sensibile: con questo vivace attaccamento all’arte, quasi un po’ conservatore, Heidegger sembra legato ad un mondo primordiale, a quello che, ironicamente, Cassirer ha definito il mondo “come era il primo giorno”. L’opera d’arte non può né deve essere superata e quella di Hegel è solo un’illusione, poiché i limiti della materia sono i limiti dell’essere. Dobbiamo poi tener presente che c’è un potere della tecnica che tende a sfuggirci: tutto ciò che l’arte raccoglie entro confini determinati, ritorna tale e quale nella tecnica. Heidegger propone un sapere che non necessariamente sia conoscenza, cioè conforme a regole universali: e infatti difende l’opera d’arte come particolare punto di vista limitato contro l’universalità del sapere. E i confini non sono ciò che ci vieta di andare oltre, ma ciò che ci spinge ad andare oltre e ci determina. Il comunismo stesso è inteso come trionfo universale della razionalità e come negazione di quell’appropriamento dell’essere che è la proprietà; la scienza si mette al servizio della tecnica per creare strumenti tecnici; anche Spengler vede il “tramonto dell’Occidente” come frutto del trionfo della tecnica e gli stessi campi di sterminio impiegati dai nazisti sono, in fin dei conti, una soluzione tecnica. In questa prospettiva, Heidegger dice che lo stupore della filosofia non va spento (come pretende di fare la scienza), e la verità non è una determinazione universale, ma il particolare evento per cui la verità si fa opera e si apre come mondo. Con “L’origine dell’opera d’arte” la verità viene tenuta distante dall’universale e, proprio perché messa in opera della verità, l’opera d’arte può dirsi bella.
GADAMER: VERITA’ E METODO
“Verità e medoto. Lineamenti di un’ermeneutica filosofica“, comparso nel 1960, ha per oggetto il problema della verità nell’arte, secondo quanto Heidegger aveva insegnato nel suo scritto “L’origine dell’opera d’arte”. Gadamer, nel condurre la sua indagine, si distacca radicalmente dalla tradizione occidentale per ribadire fermamente la tesi heideggeriana della verità nell’arte e lo fa ricostruendo, nelle sue linee generali, il cammino nel quale l’arte ha smarrito la verità. Responsabile di questa tragica perdita è, secondo Gadamer, la figura di Kant, il quale ha presentato (nella sua “Critica del Giudizio”) l’arte come un qualcosa privo di verità: nella prospettiva kantiana, infatti, nell’arte non si scopre nulla di vero, bensì viene solamente prodotto un sentimento. In quest’ottica, erano per Kant centrali il genio e il gusto: il genio è colui che è capace di produrre in modo eccezionale, di far sì che nel suo lettore nasca un sentimento universale determinato da un “a priori” non di tipo gnoseologico, ma riguardante il gioco delle varie determinazioni dell’intelletto. Ed è proprio in questo che può essere compendiata la critica che Gadamer muove all’estetica moderna, che trova in Kant il suo massimo eroe.
L’arte non ha davvero nulla a che fare con la conoscenza? Non c’è nell’esperienza dell’arte una rivendicazione di verità, diversa certo da quella della scienza, ma altrettanto certamente non subordinabile ad essa? E il compito dell’estetica non è proprio quello di fondare teoricamente il fatto che l’esperienza dell’arte è un modo di conoscenza ‘sui generis’, diversa beninteso da quella conoscenza sensibile che fornisce alla scienza i dati sulla cui base essa costruisce la conoscenza della natura, diversa altresì da ogni conoscenza morale della ragione e in generale da ogni conoscenza concettuale, ma tuttavia pur sempre conoscenza, cioè partecipazione di verità? Ciò è difficile da riconoscere se si continua a seguire Kant nel misurare la verità della conoscenza in base al concetto di conoscenza e di realtà proprio delle scienze della natura. E’ necessario pensare il concetto di esperienza in maniera più ampia di quanto abbia fatto Kant, in maniera che anche l’esperienza dell’opera d’arte possa venir intesa come esperienza. Per tale operazione possiamo rifarci alle ammirevoli lezioni di estetica di Hegel. In esse il contenuto di verità che si trova in ogni esperienza d’arte viene magistralmente riconosciuto e messo in rapporto con la coscienza storica. L’estetica diventa così una storia delle Weltanschauungen, cioè una storia della verità come essa si rivela nello specchio dell’arte. In tale modo viene riconosciuto in maniera radicale il compito che abbiamo indicato, cioè quello di giustificare teoricamente l’esperienza della verità anche nell’arte. (Verità e metodo, parte I, Il trascendimento della dimensione estetica)
E’ opportuno chiedersi come Gadamer arrivi a vedere le cose in questo modo: il punto di partenza del suo discorso può essere rintracciato nella distinzione tra scienze della natura e scienze dello spirito; tale distinzione, secondo Gadamer, non fa altro che riproporre la stessa metodica delle scienze della natura nella lettura dell’attività spirituale. Del resto, Dilthey stesso, che si era molto soffermato su questa distinzione, aveva esplicitamente confessato di non volersi sganciare dal positivismo e si era anzi proposto di studiare lo spirito in modo positivistico, secondo l’induzione; certo, egli non si era spinto a tal punto da ricercare nelle attività spirituali delle regolarità delle leggi, ma, ciononostante, è convinto che si possano ricercare delle regolarità del fenomeno. In netta rottura con questa posizione, Gadamer sostiene apertamente che l’ambito dello spirito esula dalla scienza (ed è questo che non è chiaro a Dilthey) e che pertanto non si deve estendere il metodo scientifico allo spirito e, di conseguenza, all’arte, bensì occorre considerare lo spirito, e con esso l’arte, come portatore di una sua verità inconciliabile con quella delle scienze: ecco perché, secondo Gadamer, la stessa definizione “scienze dello spirito”, così vicina alla scienza positivistica, è assolutamente inadeguata. Si tratta dunque di indagare sulla verità presente nell’arte e per far questo bisogna rinunciare al metodo con cui procedono le scienze: il titolo dell’opera, “Verità e metodo”, può allora anche essere letto (così suggerisce Ricoeur) come “Verità o metodo”, nel senso che o si sceglie di raggiungere la verità o si sceglie di utilizzare il metodo scientifico e, in tal caso, si rinuncia alla verità dell’arte. Gadamer è infatti, heideggerianamente, convinto che ci sia un ambito della verità (cioè l’arte) cui si acceda senza quel metodo tipico delle scienze; il che è particolarmente significativo perché mette in luce come esista un tratto dell’umanità che non è affatto legato al progresso scientifico: Heidegger stesso, nel suo saggio “L’origine dell’opera d’arte”, aveva mostrato come l’ambito che si manifesta nell’opera d’arte è esso stesso origine e, perciò, sfugge alla scienza. Nell’opera di Gadamer affiorano, in posizione centralissima, i termini “Bildung” (cultura, formazione) e “sensus communis” (senso comune), con l’idea che quel particolare ambito che si sottrae alla metodologia scientifica (e che Gadamer si propone di indagare nella sua opera) incontri la Bildung, il sensus communis e il gusto (qui inteso come sede della moralità). E Gadamer spende parecchie pagine come, in origine, il “gusto” riguardasse, propriamente, la sfera morale e non quella estetica, tant’è che le belle maniere sono ancor oggi, retaggio di quel passato, concepite come un abbellimento della persona. Il pensatore tedesco muove anche dall’amara constatazione che, al giorno d’oggi, l’arte è completamente inutile, è un semplice sovrappiù rispetto alla scienza: e, in tale prospettiva, la verità compete ormai soltanto a quest’ultima; questo era già vero in Kant e trova la sua conferma nel fatto che, oggi, nessuno va a vedere una mostra per trovare la verità. In fin dei conti, già Platone, Aristotele e Epicuro dicevano che i poeti erano dei bugiardi mistificatori, ma, in tempi remotissimi, ciò non era affatto vero, tant’è che pensatori come Parmenide e Empedocle affidavano la verità di cui erano portavoce ai versi, ossia all’arte. Piuttosto curioso è che Gadamer citi Hegel, dicendo che la Bildung è la razionalità che si fa universale, con un’evidente rinuncia al aprticolare in favore dell’universale: ogni cosa particolare, infatti, viene recuperata ad un innalzato livello universale e proprio qui sta la Bildung. Molta attenzione viene da Gadamer prestata a Vico, a Shaftesbury, a Reid, a Hutcheson e, in generale, a tutta quella filosofia morale contro cui argomenta Kant: per tutti questi pensatori il problema etico è indissolubilmente legato ad un sentimento, e non alla ragione (come pretendeva il Kant della “Critica della ragion pratica”). Vico, dal canto suo, proponeva la “scienza nuova”, basandola sul “sensus communis”, poiché si tratta di una scienza che riscopre l’antico e lo ripropone come modello sottratto alla scienza meccanica di marca cartesiana all’epoca dilagante. A Vico spetta dunque il merito di aver evidenziato come, accanto a quella scienza meccanica di cui si occupava Cartesio, esistesse un altro ambito altrettanto degno di scienza ma funzionante in maniera diversa dalla scienza cartesiana; in altri termini, è con Vico che inizia la battaglia contro la metafisica, giacchè è con Cartesio che essa diventa universale (a tal punto che il filosofo francese pretendeva di determinare perfino la realtà umana; significativo è, di sfuggita, che proprio Cartesio avesse proposto un “Discorso sul metodo”). Vico, in questa prospettiva, riporta in auge la retorica come sfera non legata a determinazioni meccaniche o matematiche: si tratta di una scienza “nuova” perché nata dopo e, anzi, a causa di quella cartesiana. Ma cosa significa, in definitiva, parlare di “senso comune”? Se la scienza mi dice che la terra ruota attorno al sole, viceversa il senso comune mi suggerisce che, ogni mattina, il sole sorge (Gadamer nota come Bergson traduca in modo appropriatissimo “senso comune” con “buon senso”); e Kant non fa altro che sopprimere il senso comune trasformandolo nell’ambito teoretico (la “Critica della ragion pura” per la sfera teoretica, la “Critica della ragion pratica” per la sfera morale). Gadamer, fatte queste considerazioni, nota come al giorno d’oggi chi si serve ancora del senso comune può essere accostato all’ “Idiota” di cui parlava, in età rinascimentale, Cusano: l’idiota è infatti colui che sa di non sapere e che spiega le cose senza impiegare il metodo scientifico; egli agli occhi della società moderna è un “idiota”, poiché essa ha eliminato ogni validità conoscitiva al senso comune, al socratico sapere di non sapere (ossia al non possedere la scienza). Lo sforzo che intraprende Gadamer sarà allora quello di recuperare quel senso comune andato smarrito e, in questo progetto, egli cita due pietisti, Rambach e Oetinger, il secondo dei quali aveva tradotto il senso comune con la parola “cuore”, riconnettendosi, in qualche misura, a Pascal e sottraendo con decisione la verità ad ogni forma di metodologia scientifica: a suo avviso, si può e si deve procedere con la scrittura in modo spontaneo, così come l’albero cresce nel campo, poiché non esiste un metodo per insegnare la verità, esiste invece un modo diretto e comune: il sentire. La prima parte di “Verità e metodo” è dedicata, in buona parte, alla parola Erlebnis (letteralmente “vissuto”, “esperienza vissuta”), impiegata da Gadamer in un’accezione particolare e differente da quella di Dilthey: Erlebnis era per Dilthey il fatto della vita nella quale si rispecchia ciò che si coglie nell’opera d’arte; ora, Gadamer se ne serve come parola di rottura con la tradizione illuministica, cartesiana e metodologica: già Heidegger aveva provocatoriamente asserito che “la scienza non pensa” o che “la fisica aristotelica è più vicina alla verità rispetto a quella contemporanea”, poiché quella aristotelica rendeva meglio l’unità del mondo e aveva meno bisogno di un riscontro di fatti (era, in un certo senso, una fisica del “sensus communis”, senza riscontri con l’oggettività). La convinzione di fondo è che la verità non sia sperimentale, ma del “senso comune”, e questo non va contro la scienza in sé, quanto, piuttosto, contro chi vorrebbe estendere il metodo scientifico alle cose dello spirito (evidente stoccata a Dilthey). Può tornare ancora una volta utile fare riferimento a Heidegger: questi, in “Essere e Tempo”, parte proprio da ciò che è “innanzitutto e per lo più”, cioè da quello che è, in definitiva, il mondo secondo il senso comune, non il mondo studiato dalla fisica. Heidegger dunque è contro la generalizzazione della scienza, ma, sulle orme di Hegel, a favore dell’universalizzazione come portare ad essere nel mondo (e questo vale anche per Gadamer: ” la cultura implica un senso di misura e di distacco da se stessi, e di conseguenza un innalzamento al di sopra di sé verso l’universalità “); in modo simile, i pensatori della Scuola di Francoforte parleranno di “comunità infinita della comunicazione” e di verità come “consensus omnium”. Facendo qualche anticipazione, si può notare fin da ora come, nella parte conclusiva di “Verità e metodo”, è come se tutto avvenisse nel linguaggio: la convinzione di Gadamer è che la mediazione sia avvenuta nell’Umanesimo e che, pertanto, si debba risalire ad esso e al suo “senso comune”, superando le disorsioni operate da Kant e da Schiller; ciò non toglie che lo scopo di Gadamer non sia di difendere l’arte, poiché egli è consapevole di come essa non necessiti di alcuna difesa: a dover essere difesa è, piuttosto, la verità, e per difenderla si deve mostrare come essa sia presente anche nell’arte, pressochè assente nel mondo successivo alla rivoluzione industriale. Bisogna ricordare che quando Kant parla del bello allude al bello di natura e solo raramente a quello “artificiale” dell’arte: in particolare, nella “Critica del Giudizio”, ha soprattutto in mente il bello dei fiori come bello di natura, sganciato dalla perfezione; il bello dell’arte, invece, appare ai suoi occhi come un’intellettualizzazione della bellezza, giacchè in essa interviene il concetto, anche se non in senso conoscitivo (siamo nell’ambito del giudizio riflettente, in cui non si costituisce conoscenza ma si danno determinazioni teleologiche). Il bello, secondo Kant, suscita sentimenti, ma, ciononostante, è universale, poiché quando riconosco che una cosa è bella sono convinto che anche gli altri la trovino tale: in questo senso, la bellezza è una determinazione non conoscitiva, ma tuttavia universale, una determinazione trascendentale senza concetto. Nella bellezza artificiale subentra invece l’idea di perfezione, poiché dico che un palazzo è bello in quanto è perfetto, mentre invece dico che il fiore è bello perchè orientato ad una finalità. E il genio, rispettoso della determinazione del gusto (che gli è superiore), opera come opera la natura, crea qualcosa che prima non c’era e stabilisce un libero gioco delle facoltà umane. In Kant, poi, il bello è in stretta relazione con la moralità (già nel “Filebo” di Platone il bene si rifugiava nel bello), è determinazione sensibile dei tratti morali: assegnare al bello di natura la priorità significa non tanto riportare la bellezza fuori dalla soggettività, quanto piuttosto riconoscere che la natura mira all’uomo come obiettivo (anche se questo non è provabile: è infatti legato ad un giudizio riflettente). In quest’ottica, dunque, il fiore è bello perché orientato ad un fine e tale fine è l’uomo e la sua moralità; per i Greci, invece, anche l’uomo aveva un suo posto nella natura e la bellezza naturale era connessa al kosmoV , all’ordine dell’universo; ecco perché Kant critica tanto aspramente il fatto che la filosofia morale degli Inglesi sia incentrata sul sentimento (il “sentimento morale” di cui parlava Shaftesbury), sicchè ad avviso di Kant non devo fare il dovere perché mi piace, ma perché è un dovere dettato dalla ragione. Ma Gadamer fa acutamente notare come l’estetica di Kant non sia una filosofia dell’arte, ma pure e semplici considerazioni sul bello: certo, affiorava il problema del genio artistico, inteso come produttore di bellezza e di opere d’arte e, a tal proposito, Gadamer nota come l’arte bella possa anche riprodurre cose brutte (pensiamo ad un bel quadro che raffigura qualcosa di orribile). Poiché per Kant la figura dell’uomo è l’ideale della bellezza, il genio è tale non in quanto produce determinazioni intellettuali, ma perché fa riferimento alle idee estetiche, le quali esulano dal concetto: ” proprio perché nella natura non troviamo ‘fini in sé’ e tuttavia troviamo bellezza, cioè una finalità diretta al nostro piacere, possiamo dire che la natura ci dà in tal modo un ‘segno’ che noi siamo davvero il fine ultimo, lo scopo supremo della creazione “. Tutto ciò che in Kant è legato alla morale e all’uomo, Gadamer cerca di riportarlo alle cose, riagganciandosi in questo modo agli Umanisti, poiché convinto che tra i pensatori premoderni e quelli moderni sussista una spaccatura che trova in Kant il suo più grande artefice: per i premoderni, infatti, al centro è il mondo, per i moderni è l’uomo (e Kant è la massima espressione di quest’ultimo atteggiamento). Heidegger e, ancora di più, Gadamer cercano disperatamente di riallacciarsi, in qualche modo, ai premoderni e di vedere non il mondo nell’uomo, ma l’uomo nel mondo; e, infatti, non è un caso che per gli antichi Greci il mondo fosse diviso e la sua divinità risiedesse nella bellezza che lo caratterizza (e, in tal prospettiva, l’uomo era bello perche facente parte del mondo, come l’opera d’arte stessa); con Kant, tuttavia, è il mondo che trova posto nella moralità umana e, a partire dalla modernità (da Giordano Bruno in poi), è divenuto fondamentale il concetto di infinito, prima d’allora non molto considerato: come si ricorderà, i Greci ponevano al centro del loro pensiero il finito, il limite, il confine. Fatte queste considerazioni, Heidegger e Gadamer non si propongono, banalmente, di tornare indietro ai tempi dei Greci, ma, ciononostante, si propongono di fare i conti con questo passato, cercando di capire come, rispetto ad allora, abbiamo invertito tendenza; si tratta, allora, di ricomprendere il mondo, e la posizione di Kant (che pone l’uomo al centro di ogni cosa) deve assolutamente essere rivista. E l’ermeneutica si propone di cogliere il mondo antico e di mitigare l’invadenza dell’idea di uomo: per Gadamer l’Umanesimo fa ancora parte del mondo antico, il Rinascimento segna invece la nascita della modernità. Il rapporto non è, dunque, solo tra uomo e Dio, ma anche tra uomo e mondo (particolarmente rilevante è, sotto questo profilo, il titolo di un’opera di Löwith: ” Uomo, mondo, Dio”).
LA METAFISICA DI ARISTOTELE
Kant sostiene la necessità di comprendere Platone meglio di quanto questi non comprendesse se stesso: in certa misura tale norma può essere estesa all’intero mondo greco, pur nella consapevolezza che abbiamo perso il contatto con la lingua greca e col suo lessico filosofico. Aristotele stesso si propone di comprendere la realtà nella sua enigmatica interezza, elaborando un sistema onnicomprensivo a cui nulla resta estraneo: egli sente perfino l’esigenza (e a ciò provvede il I libro della Metafisica) di fare storia della filosofia (cosa che a noi pare assolutamente normale, ma che all’epoca era sconosciuta), ripercorrendo il pensiero di quanti l’hanno preceduto. Tantissime sono le discipline che Aristotele tratta con quello spirito enciclopedico che caratterizzerà poi l’età illuministica: l’etica, la politica, la fisica, la psicologia, ecc. E nel trattarle egli si avvale (anticipando l’Illuminismo) del solo lumen naturale, mettendo da parte tutte le credenze religiose e mitologiche che affollavano la mente dei Greci (e a cui Platone sembra ancora in certo modo legato): questo processo di progressiva autonomia della ragione e, con essa, della filosofia, tale per cui essa diviene capace di gettare una luce del tutto terrena su argomenti celesti, era già stato avviato da Socrate, che peraltro aveva dovuto pagare tale innovazione con la vita. Ma l’idea di un conflitto tra religione e filosofia rispecchia solamente gli avvenimenti dell’età moderna: al tempo dei Greci, esse non configgono, ma anzi si integrano – come sottolinea Platone stesso. La Metafisica aristotelica costituisce poi, oltre che per l’autonomia della ragione che da essa traspare, un’importante novità anche sul piano formale, in quanto non si tratta di un libro unitario volto alla pubblicazione (di questo tipo erano i dialoghi platonici), ma di appunti stringati e concisi che Aristotele sviluppava poi a lezione nel Liceo dinanzi al suo uditorio. Così nel libro XII (libro
>L) ci viene presentata una specie di riassunto con un particolare sviluppo degli argomenti teologici (non a caso la Metafisica stessa può essere intesa come un libro religioso); il fatto stesso che alcune tematiche vengano trattate più volte ci aiuta a capire come si tratti di una serie di scritti slegati fra loro: così la problematica delle >aporiai compare sia nel libro III sia nell’XI. Pertanto la prima cosa da fare di fronte a questo libro è non pensare che sia un libro: e non a caso Aristotele ad esso non pone alcun titolo, tant’è che se siamo abituati a chiamarla Metafisica ciò è dovuto al titolo datole dai curatori successivi, per i quali gli scritti componenti quest’opera venivano dopo quelli di fisica ( >ta meta ta fusika). Ma questa determinazione meramente editoriale ne contiene un’altra, più profonda: gli argomenti trattati nell’opera sono quelli che si pongono al di là di quelli di ordine fisico. Se gli enti fisici, infatti, sono caratterizzati dall’essere in movimento (e noi stessi pensiamo perché in movimento), al di là (e, in certo senso, al di sopra) di essi si collocano quegli enti fissi, immutabili ed eterni quali Dio, definito dallo Stagirita come "motore immobile", che muove senza essere mosso (pur essendo anch’esso uno >zwn, ovvero un essere vivente). Proprio da qui parte quella ricerca delle cause ( >aitiai) e dei princìpi che anima l’indagine aristotelica. L’intelletto, dal canto suo, si pone al di là del moto: esiste una >fronhsiV (di cui partecipano anche gli animali) e una >sofia (che è prerogativa esclusivamente umana). Il motore della conoscenza è dato dalle sensazioni e dall’amore che per esse naturalmente provano tutti gli uomini. Un aspetto che può sconcertare è il fatto che l’opera s’intitoli Metafisica ma che, di fatto, tale termine sia ignoto ad Aristotele: anziché parlare di "metafisica", egli parla di una scienza di cui siamo in cerca ma che non ha un nome poiché non ha un oggetto preciso, se non ciò che sta "oltre". Questa concezione della metafisica come passaggio dal sensibile al sovrasensibile si protrarrà fino a Kant, che, nel definirla, la etichetterà come scienza che ha a che fare con ciò che cade al di là dell’esperienza. Per Aristotele soprasensibile può essere sia l’ambito concettuale e logico (ad esempio le categorie, trattate nel libro VII, ma anche nelle Categorie: la logica non è una scienza, ma un >organon della scienza stessa) sia l’ambito teologico (quello della >teologikh episthmh). Nel cap.8 del libro XII si parla curiosamente di molti (e non più di uno) motori immobili; similmente, nel cap.1 del libro VI la teologia è intesa come conclusione, ma nei libri XII e XIV la ricerca prosegue e verte sui numeri (non dello zero e d quelli negativi, sconosciuti al mondo greco). Sarà Kant a ribellarsi alla metafisica aristotelica, rifiutandosi – nella Critica della ragion pura – di considerare anima, mondo e Dio come "oggetti" metafisici che possono essere conosciuti. Lutero e il razionalismo di marca cartesiana, pur così diversi fra loro, costituiscono un unico fronte contro un Aristotele difeso ormai solo più – peraltro trasfigurato dal pensiero medievale – dai Cattolici; tale situazione (culminante nelle lotte galileiane contro l’aristotelismo o, meglio, contro gli Aristotelici seicenteschi) si protrae fino ai tempi di Heidegger, il quale si sforza di leggere Kant e Aristotele unitamente. Per Aristotele la scienza la si pensa, non la si fa: questo presupposto comincia a scricchiolare con Ruggero Bacone per poi crollare definitivamente ai tempi della Rivoluzione scientifica. In Occidente – è stato notato – penetra prima la figura del filosofo e solo secondariamente quella dello scienziato, tanto più che le stesse basi scientifiche trovano una loro prima fondazione in sede filosofica (così è per l’atomismo o per l’infinità dell’universo): questa priorità della filosofia si riverbera su Aristotele stesso, che in Occidente penetra primariamente come filosofo e solo successivamente (grazie alla mediazione araba) come scienziato. L’arrovellante quesito che egli si pone è: >ti to on; "che cosa è l’ente?", ma anche "perché l’ente?". Tutte le cose sono, ma di alcune devo domandarmi che cosa sono, interrogandomi sul loro essere (sulla loro >ousia); nella Repubblica Platone mette ben in luce come si tratti di un qualcosa che sta al di là dell’essere; ma l’ambiguità che caratterizza il pensiero platonico (e che invece manca in quello aristotelico) risiede nel fatto che egli, ogni qual volta si trovi in difficoltà, ricorra ai miti: così nel Fedro, anziché dirci che cosa sia l’anima, ci racconta il mito della biga alata, mito che, per quanto suggestivo, anziché risolvere il problema lo aggira abilmente. Dal canto suo, Aristotele non è ambiguo e non si abbandona all’invenzione di miti (fatta eccezione per quei dialoghi giovanili in cui l’influenza platonica era ancora predominante), bensì preferisce affidare la propria esposizione filosofica alla trattazione compiuta e sistematica; non è un caso ch’egli consideri piuttosto negativamente la dialettica (tenuta in grande considerazione da Platone), alla quale rimprovera una congenita inconcludenza: se per Platone non è possibile definire incontrovertibilmente che cosa sia la giustizia e, in forza di ciò, l’unica via percorribile consiste nell’accordarsi reciprocamente sul che cosa essa sia (in ciò sta appunto l’esercizio della dialettica), per Aristotele un discorso di questo tipo può valere esclusivamente in sede etica, là dove nel definire il bene non si può far altro che accordarsi. In tutti gli altri casi la dialettica è messa al bando, poiché poggiante sul falso presupposto che non si possano pienamente conoscere le cose. Chi è, dunque, il filosofo per Aristotele? Nel cap.2 del libro I della Metafisica è definito come colui che sa insegnare e spiegare senza fare ricorso ad atti di fede o a miti, bensì servendosi esclusivamente di argomenti probanti prodotti dall’esercizio del pensiero. Questa tesi, che conferma la teoria di un Aristotele in certa misura "illuminista", può essere smentita facendo riferimento a Jaspers e al suo confronto tra Bruno e Galileo: il primo – simboleggiante la verità filosofica – sale sul rogo e si fa martire del pensiero; egli va incontro alla morte perché la verità filosofica, per potersi affermare e per essere inverata, deve essere soggettivamente vissuta; il secondo – vessillifero della verità scientifica – abiura, rinunciando al martirio, giacchè la verità scientifica, per potersi affermare, non necessita di essere vissuta soggettivamente, ma è anzi autotrasparente. Da ciò appare evidente come l’elemento della fede non possa dirsi in toto escluso dalla filosofia, come invece ritiene Aristotele. Come accennavamo, la Metafisica può essere letta in chiave teologica, tenendo conto che, per lo Stagirita, la prova dell’esistenza di Dio risiede – come già per Platone – nell’esistenza di un mondo che si muove perché messo in moto da qualcos’altro (da Dio appunto). Cartesio – preceduto in ciò da Anselmo – rigetta questa prova dell’esistenza di Dio e la sostituisce con quella che Kant definirà "ontologica": è l’idea stessa di Dio a garantirne l’esistenza. Pur se avversato da Cartesio e da molti altri pensatori dell’età moderna, Aristotele torna nel Novecento a godere di enorme fortuna: in primis con Heidegger e con la sua scuola. A parte la successione dei libri VI, VII, VIII, IX – che presentano una loro sequenza logica -, il resto della Metafisica può essere letto in qualsiasi ordine, benché sia consigliabile partire dal principio: infatti i primi due libri dell’opera esplicano una funzione proemiale, fornendoci le nozioni preliminari. Il libro I contiene – come già notavamo – una storia della filosofia (la prima in assoluto) in cui Aristotele ripercorre le posizioni filosofiche dei predecessori, criticandole alla luce del proprio impianto filosofico. Il II libro è molto breve, ma ci presenta la metafisica come scienza della verità: uno dei sensi dell’essere è appunto l’essere come vero e come falso (concetto su cui Aristotele torna nei libri VI e IX). Heidegger (che parte da Parmenide) leggerà questo significato dell’essere come centrale, andando però in parte contro ad Aristotele stesso, per il quale il problema centrale resta l’essere come sostanza, e non come verità. Nei primi libri troviamo un Aristotele ancora seguace (seppur critico) di Platone. Il libro III si occupa delle aporie, ovvero di quelle contraddizioni che si presentano nel porre il problema metafisico: perché fondiamo la scienza di qualcosa che non sappiamo che cos’è? Appunto perché vi sono delle aporie: c’è bisogno di una scienza perché ci sono dei vicoli ciechi. Ad esempio: la scienza è una o sono tante quante le sostanze? Sono ambiti difficili da risolvere e un modo per leggere la Metafisica è leggere i luoghi in cui Aristotele discute le aporie che nel libro III sono solamente elencate: la quinta e la ottava riguardano la sostanza soprasensibile, ma se essa è soprasensibile non si possono avere garanzie sulla sua esistenza, cosicché ad essa si può pervenire esclusivamente per via extrasensoriale. I passaggi poi tra un libro e l’altro sono assai difficoltosi: ad esempio, il libro III tratta delle aporie, mentre quello seguente si occupa della negazione del principio di non contraddizione e della confutazione di chi crede che non esista la verità (chi dice "non c’è verità" già si contraddice). Il libro V è particolarmente interessante perché si configura come una sorta di glossario filosofico: si tratta senz’ombra di dubbio di un libro scritto da Aristotele in età giovanile, cosicché è interessante leggerlo per notare come molti termini mutino valore semantico man mano che Aristotele giunge alla maturità. Il sesto libro è un’introduzione alla metafisica in cui si precisa che essa è anche teologia ( >teologikh episthmh): il problema della religione è già affrontato nel libro I, ove si dice che "gli dei non sono invidiosi": tali sono, invece, i poeti che fanno di tali affermazioni (Omero, Esiodo). Anche Platone già si muoveva su questa linea di avversione per i poeti (Repubblica, X): in gioventù egli aveva composto tragedie, ma, giunto alla maturità, le distrusse, a riprova della sua insofferenza per la poesia. Aristotele dunque sospende l’atteggiamento dei poeti, i quali si affidano alla >doxa popolare, e prova a pensare il divino indipendentemente dal rapporto con l’umano, come scienza teologica. I poeti mentono perché pensano che ci sia una trasparenza del divino nell’umano: a tal proposito, Platone nel Cratilo distingue tra un linguaggio divino e uno umano, per cui lo stesso fiume – stando ad Omero – è dagli uomini chiamato Scafandro, dagli dei Xantos; ma se davvero fosse un nome divino, allora dovrebbe essere sconosciuto a tutti gli uomini (compreso Omero). Ancora più di Platone, Aristotele parla del divino come appare all’intelletto: il mondo non è creato, tempo e movimento sono eterni; sicchè i poeti, sostenendo che il mondo nasce, non fanno che mentire. Il fatto stesso che ciascuno di noi abbia un padre, a sua volta generato da un altro padre e così via, non fa che deporre in favore dell’eternità della specie, nota Aristotele. Nei libri tra VII e XI il problema teologico viene accantonato e ne affiora un altro, presente in altri scritti (De interpretatione, Categorie): il problema logico della definizione, comprendente la questione della potenza e dell’atto (libro IX). Ma quando dico che qualcosa è, di che cosa dico che è? Tali problematiche non sono solamente logiche, ma anche metafisiche, anche perché la logica (pur avendo anch’essa una propria consistenza) non è se non un >organon, uno strumento al servizio delle singole scienze: pensare è un qualcosa, e per l’esattezza è un qualcosa a cui l’uomo può dedicarsi solo dopo aver risolto i suoi problemi concreti. Solo quando li ha risolti, egli può >qeorein, ovvero "vedere come vede Dio", il quale pensa perché non ha nulla da fare; la stessa distinzione tra atto e potenza è funzionale alla definizione di Dio, inteso come atto puro. Quel che Aristotele lascia senza nome è l’io, che diventerà poi con Kant Io penso, che non è una sostanza ma una funzione (sarà l’idealismo a trasformarlo in sostanza e per di più assoluta). Per Aristotele non c’è che un intelletto non mio ma di cui posso partecipare quando sospendo tutte le attività mondane e mi dedico all’esercizio del pensiero: in quel momento vivo da Dio, giacchè conduco – seppur per brevi momenti – la vita che Dio conduce ininterrottamente. In Kant e Hegel la logica è la metafisica: se per Aristotele, come abbiam visto, la logica non è una scienza, Hegel scrive significativamente un’opera intitolata Scienza della logica, ove la logica finisce per coincidere con l’ontologia. Quella di Kant, sull’altro versante, si configura come logica trascendentale. E’ curioso come Heidegger metta costantemente in relazione Hegel e Aristotele (perfino nell’ultimo paragrafo di Essere e Tempo). Gli ultimi due libri della Metafisica sono dedicati al numero. Nel IX si parla improvvisamente del bene, cosa che fa anche Kant, in maniera cursoria, nella Critica della ragion pura. A proposito di Sofocle, Heidegger fa coincidere >poliV e essere: il problema dell’essere si determina isolando un ambito della >poliV. Heidegger si propone di pensare senza distinzione tra sensibile e soprasensibile, Aristotele e Platone sono già la fine del pensiero greco perché loro hanno teorizzato il passaggio dal sensibile al soprasensibile, dicotomia assente nei primi filosofi. In Aristotele il tempo (Fisica, IV) è determinazione apiretica, del singolo istante dico che è, ma è nel momento in cui è già passato in quello successivo: Hegel dice a tal proposito che il tempo è "il sensibile non sensibile"; le cose trascorrono rispetto al tempo, ma esso non è sensibile. Per Kant esso è forma del senso interno. La soluzione teologica di Aristotele è criticatissima da Agostino, da Pascal e da molti altri. Il messaggio centrale della Metafisica potrebbe così essere sintetizzato: c’è una dimensione del reale che è intelligibile; certo, l’esperienza insegna alcune cose, ma poi occorre chiedersi il perché e – a questo punto – l’esperienza sensibile a nulla più giova, cosicché si rende necessario il salto metafisico. L’esempio che Aristotele ha in mente è quello dell’artigiano: a rigore, Dio stesso è l’artigiano (già Platone parlava di un Demiurgo come "divino artigiano" capace di plasmare la materia sul modello delle idee) che fa il mondo (meglio: lo mette in moto) col pensiero. In questa cornice in cui all’empiria è contrapposta la metafisica rientra anche la distinzione operata da Aristotele tra gli enti matematici (ai numeri sono dedicati i libri XIII e XIV) e i >poioumena, ovvero le cose create dall’uomo. Di questi ultimi si può con grande facilità sapere a cosa servano, proprio perché n siamo noi stessi i facitori: così, a proposito del tavolo o della sedia, potrò senza tentennamenti asserire che son fatti per determinati scopi, proprio in virtù del fatto che li ho creati affinché adempissero a quel dato fine. Anche per gli enti di natura sussiste un finalismo tale per cui, per ciascuno di essi, è sempre possibile dire a che cosa serva (in ciò risiede il finalismo aristotelico), ma ciò è più difficile poiché non ne siamo noi gli autori (non siamo noi a creare la natura, ma anzi siamo un ingranaggio di essa): sicchè è ben più difficile rispondere al quesito "a cosa serve un albero?" rispetto a quello "a cosa serve un tavolo?". Si tratta, in certo senso, di un’anticipazione del principio vichiano del verum ipsum factum. Cartesio stesso parla di ens creatum: il mondo è stato creato, sebbene non dall’uomo. Il principio attribuito dalla tradizione scolastica ad Aristotele del scire est scie per causas può proficuamente essere inserito in un siffatto contesto: si conosce casualmente ciò di cui si è causa. Dicevamo che Aristotele condivide con Platone (ma in realtà con l’intero pensiero greco) l’esigenza di saltare dall’empirico al metafisico, esigenza che – abitualmente – tendiamo a leggere come caratterizzante il pensiero cristiano. Ora, Heidegger – troppo spesso erroneamente considerato come un filosofo grecofilo – mette sapientemente in luce (ad esempio nello scritto sulle Interpretazioni fenomenologiche della religione) come propriamente il passaggio dal fisico al metafisico caratterizzi esclusivamente il pensiero greco e come invece quello cristiano si risolva in un’esperienza della vita nel tempo: quando il cristianesimo arriva a porre al centro della propria speculazione il salto dal fisico al metafisico, dalla terra al cielo, lo fa perché ha ormai inglobato la tradizione greca. Kant stesso non rinuncia al passaggio alla metafisica, sebbene sia convinto che esso debba avvenire per via non già teoretica, bensì morale. Tant’è che nella Critica della ragion pratica la ricerca del soprasensibile non è affidata all’intelletto (Verstand), operante solo sui dati forniti dall’esperienza. Ma i Greci, più che distinguere tra intelletto e ragione (distinzione che avviene compiutamente solo a partire da Spinoza), preferiscono parlare di una generica facoltà del pensare ( >to noein). La metafisica, nella prospettiva heideggeriana, è un erramento: similmente Husserl si propone, con la fenomenologia, di rendere giustizia all’esperienza, e lo fa in maniera radicale (lo stesso Io penso di Kant viene etichettato come una fantasticheria). Nel libro VII Aristotele dice che il problema da lui affrontato (che cos’è l’essere della cosa?) è un problema vecchio, risalente – nella sua piena formulazione – al venerando Parmenide: la cosa è sempre un qualcosa di determinato, un >todh ti, ma non ci si può arrestare all’apparenza. Sotto questo profilo, la stessa visione del cosmo che abbiamo è – tanto per Platone quanto per Aristotele – visione di qualcosa che ci appare come caotico e spaesante e di cui dobbiamo capire l’ordine attraverso la filosofia, capace di fare esperienza delle cose e di interrogarsi sulle loro cause: a tal proposito, la matematica è la prima disposizione ordinata delle nostre conoscenze; ma anche le cose materiali hanno un loro ordine, il che lascia aperta la possibilità di una fisica. Similmente posso prendere tale determinazione dell’ordine e farne una sostanza. Ma per Aristotele non tutte le cose che cadono sotto i miei sensi sono sostanze: così il bianco andrà qualificato come accidente e non come sostanza, giacchè esiste solo in riferimento a sostanze (non esiste il bianco: semmai esistono cose bianche); di sfuggita, una tale distinzione aristotelica tra sostanze (esistenti in maniera autonoma) e accidenti (esistenti in riferimento a sostanze di cui sono qualità) ritorna nella grammatica, là dove i sostantivi sono altra cosa rispetto agli attributi. In quest’ottica, ben si capisce come la filosofia aristotelica sia una filosofia del senso comune, quasi come se Aristotele avesse dato veste filosofica a ciò che tutti quanti sappiamo per istinto (che la terra sia ferma e al centro, che il mondo sia popolato da sostanze, ecc). Esiste un intelletto comune – stando al De anima – a cui dobbiamo provare ad accedere per poter così pensare come Dio: nei brevi lassi di tempo in cui ci dedichiamo all’esercizio del pensiero conduciamo la stessa vita condotta eternamente da Dio; una tesi di questo genere non poteva che risultare blasfema agli occhi della religione tradizionale: si tratta di quella che, con un’espressione felice, è stata definita la violenza della scienza e della metafisica sulla religione. Possiamo leggere la diversità intercorrente tra Platone e Aristotele alla luce del differente rapporto da essi intrattenuto con la religione: Platone ha una visione religiosa della filosofia (come ha acutamente notato Kruger, l’allievo di Heidegger); Aristotele ha una visione filosofica della religione; non è un caso che, nel celebre dipinto di Raffaello sulla scuola di Atene, Platone venga raffigurato col dito indicante i cieli della religione, Aristotele con la mano rivolta verso la terra della filosofia. A proposito di Aristotele, Ricoeur parla significativamente di technologie, alludendo a come egli concepisce l’intelletto, come puramente determinato dallo stato delle cose; diversamente in Platone noi uomini non siamo che entità finite. Il ricorso costante che gli fa al mito non è casuale, né un omaggio ad una forma letteraria particolarmente accattivante: nota Pareyson – in merito al cristianesimo – che sussiste una sorta di "mito cristiano", giacchè la crocifissione non è che un mito (alla stregua dei miti platonici), ossia una storia raccontata. Il mito, in questo senso, interviene direttamente tra l’umano e il divino, e tal rapporto non può essere risolto in maniera meramente scientifica (come pretenderebbe Aristotele), mediante un sapere universale quale è quello proposto dalla Metafisica. I primi due capitoli del libro I costituiscono una vera e propria introduzione alla metafisica aristotelica: si tratta di cercare le cause e i principi che mancano nelle altre scienze; tali due capitoli sono stati diffusamente commentati da Heidegger nel famoso scritto Interpretazioni fenomenologiche di Aristotele, un corso scritto per Natorp al fine di ottenere la cattedra a Marburgo. Il capitolo 3 pone fin da principio in risalto la tematica delle quattro cause (con rimando al libro II, cap.3 della Fisica) ed è a questo punto che Aristotele indossa la veste di storico della filosofia, compiendo una ricognizione sul pensiero di quanti l’hanno preceduto (quelli che egli chiama >fusiologoi) per vedere a quante cause sono pervenuti nelle loro indagini: in particolare, egli parte da quei pensatori che si sono fermati alla causa materiale (cap. 4); al centro del capitolo 5, invece, troviamo i Pitagorici, i quali hanno ravvisato come causa non già un principio materiale, bensì i numeri. Il cap. 6 è dominato dall’imponente figura di Platone, mentre il 7,l’8 e il 9 non sono che una ripresa del 4, del 5 e del 6, nel tentativo di fornire soluzioni plausibili ai problemi precedentemente formulati. Ed è nel cap.9 che ricompare Platone, figura che è sempre presente in modo massiccio nella Metafisica, giacchè su di lui Aristotele costruisce criticamente la propria metafisica. Fin dalle prime pagine, si prospetta un problema difficile da risolvere: che cos’è la >sofia? Quel che è certo è che gli animali non ne sono equipaggiati, benché molti di essi possano ugualmente essere detti intelligenti: ad esempio, l’ape, che agisce sicuramente in vista di fini precisi, è un animale intelligente, benché privo dell’udito. Gli uomini, dal canto loro, tendono per natura al sapere, come recita l’incipit dell’opera e amano tutti le sensazioni, cosicché ogni conoscenza non può prescindere da esse. Ciò non toglie, però, che la conoscenza non debba arrestarsi ad esse, che anzi costituiscono una sorta di trampolino di lancio per scavalcarle. A ciò provvede la >sofia – di cui Aristotele parla anche nei trattati etici (in particolare nel libro VI dell’Etica nicomachea) – che è contrapposta alla >fronhsiV (di cui sono dotati anche gli animali). Fino al cap.3 ricorre con una certa insistenza l’espressione "la scienza che siamo cercando", come se il problema centrale su cui Aristotele si affatica potesse così essere compendiato: perché non ci bastano le singole scienze? Studiate le singole scienze, infatti, ci manca ancora l’insieme ed è a ciò che provvede la >sofia, la quale non potrà in nessun caso essere intesa come scienza poetica, giacchè non produce nulla. Nel cap.2 viene messa in luce l’importanza della meraviglia ( >to qaumazein) come fonte del filosofare: solamente quando proviamo stupore e meraviglia di fronte ad aventi per noi inspiegabili proviamo il desiderio di filosofare, in maniera tale da "sfuggire all’ignoranza" ( >feugein thn anagnoian), senza ottenere risvolti pratici. La >sofia, in questo senso, non produce nulla, è scienza totalmente fine a se stessa e trova in ciò la propria superiorità su qualsiasi altra scienza: essa è la scienza delle scienze; risolti tutti i problemi pratici che ci si parano dinanzi nel cammino, resta ancora il problema della >sofia, del sapere per il sapere. Essa è una scienza divina per due motivi: in primis, perché posseduta da Dio stesso (la cui attività consiste appunto nell’esercizio ininterrotto del pensiero); in secundis, perché ha per oggetto cose divine. Ne segue che si può vedere Dio solo se si vede come Dio. A questo punto, Aristotele inserisce nella propria trattazione la figura del poeta Simonide, il quale diceva che l’uomo è cattivo e invidioso, ragion per cui non può mai essere come Dio. Aristotele si oppone a Simonide e, in generale, alla sapienza poetica, replicando che i poeti mentono e che all’uomo è dato vedere Dio: a permettere che questo avvenga è quella scienza che stiamo cercando. Qui avviene la saldatura tra una scienza astratta che nulla produce e il sapere divino (teologia), su cui Aristotele ritornerà nei libri VI e XII; l’idea sotterranea che Aristotele lascia affiorare è che teologia e ontologia coincidano, poiché entrambe alla ricerca del sapere supremo. Per il comune modo di penare dei Greci – a cui Aristotele stesso non sfugge – l’invidia, di per sé, non è un male, è anzi la base di ogni competitività ed è su di essa che si fondano, ad esempio, le competizioni sportive (i Giochi Olimpici, ove l’importante era non partecipare, ma vincere) e non è un caso che Esiodo stesso (nelle Opere e i giorni) riconosca l’esistenza di una >eriV buona, perché stimolo di miglioramento. Aristotele, allora, non se la prende tanto con l’affermazione dei poeti secondo cui gli uomini sono invidiosi; piuttosto non accetta che tale affermazione possa essere estesa agli dei, poiché è ai suoi occhi (come del resto a quelli di Platone) assurdo che essi siano succubi di passioni umane: il divino non ha più nulla da raggiungere, cosicché la >sofia – che del divino è propria – non deve produrre nulla. Emerge a questo punto un altro quesito non da poco: sussiste un conflitto tra intelletto e passioni? O, piuttosto, essi convivono armoniosamente? Aristotele, corifeo della filosofia greca, risponde che il conflitto tra i due c’è ed è a tutti evidente. Così Socrate asseriva di sentire dentro di sé un >daimwn che gli suggeriva di agire diversamente dalle prescrizioni che gli provenivano dalla propria ragione. Nel cap.2 Aristotele mette in luce come la scienza di cui è alla ricerca non debba produrre nulla, giacchè essa giunge quando tutto ciò che serve è stato prodotto: la filosofia, in questo senso, può essere praticata solo in quelle società in cui vi è chi può dedicarsi al pensiero senza dover provvedere al proprio sostentamento, perché altri vi provvedono in sua vece. Non è un caso che Heidegger scorga nella >tecnh un pericolo e la critichi aspramente facendo leva su presupposti aristotelici, quasi come se vi fosse un rimpianto per il sapere fine a se stesso, in antitesi a quello – proprio della tecnica – ritenuto valido esclusivamente in riferimento alla sua utilità. Ed è proprio Heidegger a mettere in evidenza come il termine greco >tecnh racchiuda entro di sé il duplice significato di "tecnica" e di "arte", poiché per i Greci la >tecnh non è necessariamente legata alla produzione di qualcosa, è piuttosto una determinazione del sapere implicante progettualità. Il cap.4 si apre con l’enunciazione della dottrina delle quattro cause (materiale, efficiente, formale, finale): sapere è sapere quale è la causa, ma la causa in questione è non già quella particolare, bensì quella complessiva, capace di rendere conto del mondo nel suo insieme. Proprio alla ricerca degli >aitia kai arcai si è rivolta l’indagine dei primi filosofi della Ionia (Talete, Anassimandro, Anassimene): essi hanno tentato di rinvenire quell’ >arch che fosse >aition della realtà nel suo complesso; ciò che accomuna questi pensatori – anche se per quel che concerne Anassimandro il discorso è un po’ diverso – è l’aver ritenuto che l’ >arch in grado di rendere conto del mondo dovesse essere materiale (l’acqua di Talete, l’aria di Anassimene, il fuoco di Eraclito). Ne seguirebbe – il che appare assurdo già ad Aristotele – che tutto il mondo deriverebbe ad esempio dall’acqua, ma che poi essa stessa resterebbe presente nel mondo, come se il principio se ne stesse all’interno di ciò che da esso deriva. E’, questa, una non-spiegazione, poiché dire che tutto nasce dall’acqua non spiega che cosa sia l’acqua né la materia. Non-spiegazioni di questo genere sono anche quelle addotte da Empedocle, il quale pone come principio tutti e quattro gli elementi (perfino la terra, unico fra tutti), ma finisce poi col ridurre, a propria volta, questi quattro principi a due: l’Odio e l’Amore, introducendo con essi quella causa efficiente sconosciuta agli ionici. Discorso analogo può valere per Anassagora di Clazomene, il cui grande merito sta per Aristotele nell’aver introdotto un’Intelligenza ( >NouV) tale da porre in moto gli elementi senza però identificarsi in essi: in questa maniera, Anassagora ha intravisto la causa finale. Nell’esposizione delle dottrine anassagoree, Aristotele insiste su come – per il filosofo di Clazomene – in ogni oggetto siano presenti tutti gli infiniti elementi e su come sia l’Intelligenza a porre ordine in tale caos (Dilthey nota che questo è l’inizio della teologia): l’ordine è posto e, in forza di ciò, può essere conosciuto. La figura di Anassagora, dunque, gode in certa misura della simpatia di Aristotele, benché Socrate – stando a quel che Platone racconta nel Fedone – fosse rimasto assai deluso dalle indagini naturalistiche anassagoree. Proprio Socrate è da Aristotele menzionato, ma non collocato tra questi filosofi di cui egli si occupa nel libro I: e ciò a ragion veduta, poiché esula dagli interessi di Socrate la spiegazione della natura; egli si interessa solo di questioni etiche e, come si dice nel Fedro platonico, egli svolge a propria attività di filosofo non fuori, ma dentro le mura della città, in quanto hanno molto più da insegnargli gli uomini rispetto alla natura. Platone, invece, è da Aristotele inserito a pieno titolo tra gli investigatori della natura: e lo Stagirita gli fa dire cose che nei dialoghi (l’unico dialogo che ha per oggetto la natura è il Timeo) non leggiamo, ma che dovevano appartenere a quelle dottrine non scritte ( >agrafa dogmata) sviluppatesi all’interno dell’Accademia. Perfino Parmenide – messo accanto a Esiodo – è qui da Aristotele ricordato come naturalista, poiché – in quella parte del suo poema dedicata alla >doxa – egli trattava di quel mondo fisico in cui gli uomini scorgono illusoriamente il divenire. Sotto questo profilo, gli atomisti (Leucippo e il suo discepolo Democrito) rappresentano la perfezione del naturalismo. I naturalisti non tengono in considerazione che ci sono anche cose buone e cattive: se tutto si fa da sé, perché mai ci sono cose buone e altre cattive? E’ qui introdotto, di sfuggita, il problema del male, a cui Esiodo e Parmenide hanno provato a rispondere. Platone stesso (nel Sofista e nel Protagora) mette in luce come bello, buono e addirittura l’ente coindicano, cosicché l’ente come tale è bello e buono. Ancora una volta, ciò risponde ad un ideale greco, e più precisamente all’ideale del >kaloV kai agaqoV, secondo cui ciò che è bello è anche buono, e viceversa. Nella seconda parte del suo poema, Parmenide si interroga su tali questioni. Sembra quasi che per Aristotele sapere significhi portare le cose dal movimento all’immobilità, e la coppia potenza/atto non è se non una ripresa di questa tematica, giacchè l’atto è l’essere fisso, colto nella sua sostanzialità. Non a torto Heidegger insiste nel sostenere che, per capire realmente la metafisica aristotelica, si debbano veramente capire l’etica e la fisica di Aristotele, opere nelle quali occupa una posizione incontrovertibilmente centrale il movimento: si tratta, nella fattispecie, di capire perché il movimento non sia un’illusione (come credeva Parmenide), ma un qualche cosa di determinato. Nel cap.6 si parla di principi e di idee come di due realtà distinte: i principi reggono le idee e i numeri o stanno sul loro stesso livello? E’ difficile stabilirlo, anche perché in quei punti il testo è corrotto; tuttavia, sappiamo che per Platone vi erano principi addirittura superiori alle idee stesse. Porre il problema delle cause significa porre un problema di fisica: si dovrà allora indagare qualcosa che non appartiene al mondo fisico (su ciò verte la Metafisica) come se ad esso appartenesse. Ma l’atteggiamento materialistico dei primi filosofi appare insufficiente per spiegare le cose come stanno, poiché occorre rinvenire anche una causa del movimento non risolvibile nella materia stessa: ad essa sono pervenuti Empedocle (con la sua teoria dell’Odio e dell’Amore) e Anassagora, con la teoria del >NouV che ordina le particelle. Introdurre un’Intelligenza – come fa Anassagora – è come riconoscere che le cose siano in equilibrio ma che poi debba intervenire un’Intelligenza per riordinarle. Dal canto loro, gli atomisti cercano determinazioni meramente materiali, come l’ordine, la figura e la posizione: così A si distingue da N per figura, AN da NA per ordine, N da Z per posizione. E gli atomisti, nel loro tentativo di spiegare la realtà, non debbono in alcun caso fare riferimento ad un’Intelligenza esterna agli atomi stessi. Di tutt’altra specie è l’atteggiamento di Platone e dei Pitagorici, ad avviso dei quali la causa principale cessa di essere quella materiale o quella efficiente e diviene l’essenza (il che resta valido anche per Aristotele), sinonimo di definizione (con l’idea del determinare le cose a partire dalla loro stessa definizione). Ma quella pitagorica dev’essere intesa in realtà come una non-soluzione, giacchè asserire che la determinazione formale è il numero (per cui, per definire una cosa, dovrei ricondurla ai numeri o creare contrapposizioni legate al numero, come vuoto/pieno, finito/infinito) non risolve in maniera definitiva i problemi. Il caso di Platone è più articolato e complesso, giacchè Aristotele stesso aveva abbracciato in gioventù le sue tesi (e aveva scritto opere – andate perdute – fortemente platoniche sulle idee e sul bene); ora, nella Metafisica, la dottrina delle idee è ormai alle spalle e Aristotele può criticare il suo ex maestro (cap.6 e 9) con più argomenti, talvolta anche banali (così ad esempio quando critica le idee come raddoppiamento del numero delle cose: ogni cosa sensibile ha la sua corrispondente idea). Se non si riescono a spiegare gli enti empirici, tanto meno sarà possibile rendere conto di quelli ideali, anche perché è facile incappare in un ostacolo non da poco (di cui Platone stesso aveva preso atto nel Parmenide): se per ogni cosa c’è un’idea, allora anche per ogni idea dovrà esserci un’idea, e così via all’infinito. E’ questo l’argomento che Aristotele battezza come argomento del "terzo uomo" (Socrate in carne ed ossa rimanda all’idea di Socrate, ma questa rimanda a sua volta all’idea dell’idea di Socrate). Sempre nell’ambito della dottrina platonica delle idee sussiste l’annoso problema di come si relazionino le idee fra loro e col mondo sensibile che di esse è pallida copia: problematiche a cui Platone aveva provato a rispondere nel Sofista e ne Parmenide; ma Aristotele insiste su come il mondo delle idee non spieghi affatto quello sensibile, ma anzi renda ulteriormente difficile la sua spiegazione. Per spiegare questo mondo – che per Aristotele è l’unico – occorre spingersi al di là di esso, addivenendo al soprasensibile, che tuttavia dev’essere ben delimitato. Del resto, se ogni cosa è transitoria e sfuggente – come è nel nostro mondo – come potrò conoscere la realtà se non fisso determinazioni che non periscono? Si affaccia qui l’esigenza di porre un mondo non transeunte, ma la risposta platonica del mondo delle idee come perennemente fisso e sottratto al divenire non persuade Aristotele. Occorre rinvenire una realtà sottratta al movimento, senza nascita e morte: tale può essere il mondo dei numeri. Nel cap.9 Aristotele insiste sulle dottrine non scritte di Platone, in particolare sulla contrapposizione tra Uno e Molteplice (piccolo e grande), con riferimento alla Diade indefinita e alle cose che si oppongono. L’Uno, più che come numero, va inteso qui come ciò che manca di manifestazioni sensibili, poiché il mortale vive sempre calato nel mondo dei sensi. La >sofia è appunto la visione delle cose non soggette al processo di nascita e di morte: ma è, questa, la posizione più criticata tra quelle assunte dallo spirito greco, posizione che si rafforzerà con l’incontro del mondo dei Greci con quello cristiano (nonostante le profonde diversità trai due). Già Talete può essere considerato, lato sensu, un illuminista, benché nel suo pensiero risuonino le suggestioni mitiche: egli si avvale della sola ragione nell’indagare intorno al mondo e il principio a cui approda – l’acqua – è, nella sua materialità assoluta, qualcosa di profondamente sganciato dalla religione; sull’altro versante, un filosofo della statura di Socrate, nemico dichiarato della tragedia e della sofistica (che dell’illuminismo greco è una delle massime espressioni), pare suggerirci che la vera comprensione sia raggiungibile non tanto per via razionale quanto piuttosto passionalmente. Anche il secondo libro è un’introduzione ai problemi della metafisica, mentre col terzo si entra nel vivo dell’indagine: esso è connesso al primo in quanto anche qui troviamo il riferimento alla "scienza che stiamo cercando" (la metafisica) e di cui ancora non disponiamo: si tratta di una scienza fatta di domande e tali sono le aporie costituenti l’ossatura di questo libro terzo. In greco, >poroV è il passaggio, la via d’uscita: e >aporia designa, in tal senso, un vicolo cieco, una strada senza uscita; le aporie saranno allora domande in cui ad una tesi è contrapposta un’antitesi senza che sia possibile dire più vera l’una rispetto all’altra. Si tratta dunque di nodi da sciogliere, ma non nel senso che si debba e si possa trovare una risposta, bensì nel senso che si debba capire da dove nasca la domanda: il fatto stesso di porsi la domanda, ancorché questa rimanga irrisolta, è un passo avanti. In questo senso, l’ >aporia diventa >euporia. In fin dei conti, il cuore delle diverse aporie messe in luce da Aristotele può essere ridotta ad una sola: è vera la tesi dei naturalisti o, piuttosto, l’antitesi dei platonici? A tale domanda lo Stagirita non risponde unilateralmente: per lui, la metafisica non deve sposare né l’una né l’altra soluzione, benché nei libri I e III egli si senta in certa misura ancora – per usare l’espressione del Sofista – un >filoV twn eidwn, un "amico delle idee", pur non condividendo pienamente la dottrina platonica. Le aporie sono sparse qua e là per il libro III: Giovanni Reale, che di Aristotele è uno dei massimi interpreti a livello mondiale, ne conta quindici e tende ad attribuire maggior importanza a certe aporie anziché ad altre: ad esempio, egli ritiene assolutamente centrale quella che chiede se esistano solo sostanze materiali o se ve ne siano anche, accanto ad esse, di soprasensibili. Egli dà molta importanza anche all’aporia (la ottava) che pone il problema di come sia possibile una scienza (intesa come universalizzazione) se tutte le sostanze sono individui (ove l’individuo è il >todh ti). Non è un caso che queste due aporie siano incentrate sul problema del soprasensibile. Nel libro XII – che è per molti versi un libro a sé stante -, lo Stagirita risponde con certezza che c’è una sostanza soprasensibile: ma il libro III risale probabilmente ad un’età in cui Aristotele non era ancora addivenuto a tale certezza e ancora ignorava che cosa realmente fosse la scienza, sicchè egli non poteva che porre tali questioni per via apiretica, lasciando in sospeso il problema. Il principale punto di distacco dal maestro Platone può essere rinvenuto nel fatto che questi intendeva l’essenza come genere, tale per cui le cose sono le loro definizioni (il vero essere di Socrate è l’essere uomo): Aristotele, dal canto suo, nell’aporia tredicesima si domanda a che giovi l’introduzione delle Idee platoniche e intende l’essenza come >todh ti, come >sunolon di >ulh e >morfh. Ne segue, allora, che posso domandarmi che cosa è Socrate solo perché c’è Socrate come >todh ti, ovvero come ente in carne ed ossa, e non già perché c’è l’Idea iperuranica a cui fare riferimento: tutte le aporie sono percorse dalla contrapposizione tra genere ed elementi materiali: per i naturalisti ionici esistono solo i secondi, per i platonici solo i primi. Aristotele assume invece una posizione mediana e mantiene sia gli elementi materiali sia i generi. Inoltre per i naturalisti ionici vi è un’unica scienza perché unica è la causa (la causa materiale), ma se le cose stessero in questi termini, allora – avendo Aristotele ravvisato ben quattro cause – le scienze dovrebbero essere quattro! Se leggiamo con attenzione il libro XII, pare che la scienza sia unica e sia quella teologica: ma il motore immobile, che muove senza essere mosso, non racchiude in sé tutte e quattro le cause; esso è anzi solamente causa finale. Un’altra aporia di gran rilievo è quella con cui Aristotele chiede se la scienza che studia le sostanze sia la stessa che studia le dimostrazioni. Per i platonici parrebbe di sì, mentre Aristotele lascia in sospeso la questione. La scienza è unica o ce n’è una per ognuna delle sostanze che popolano il mondo? Come dicevamo, nel libro XII essa è unica, ma il libro XII costituisce una specie di inganno ottico, in quanto è posto alla fine della Metafisica ma in realtà non è certo tra gli ultimi ad essere stato composto, è anzi piuttosto precoce, mentre più tardi sono i libri centrali. La quarta aporia si chiede se la scienza studi solamente le sostanze o anche gli accidenti. Per i naturalisti ionici, questi ultimi rientrano a pieno titolo nella sostanza e dunque sono oggetto di scienza; sull’altro versante, i platonici sostanzializzano gli accidenti. Se però si restasse nel sensibile senza innalzarsi al di sopra di esso, non ci si potrebbe rendere conto nemmeno del sensibile stesso: da qui nasce l’esigenza di fare metafisica. L’essere e l’uno non sono sostanze, cosicché è vero che servono per determinare i generi, ma non sono sostanze (perciò il motore immobile non è né l’uno né l’essere). L’unità dei principi è specifica o numerica? I principi delle cose corruttibili sono gli stessi di quelle incorruttibili? Il moto dei corpi celesti segue le stesse regole di quello dei corpi terreni? Agli occhi di Aristotele, i platonici tendono a distinguere troppo marcatamente il mondo sensibile da quello intelligibile: quest’ultimo per Aristotele non è che il nostro mondo concepito sotto forma di pensiero, anche se poi lo Stagirita finisce per dare del platonismo interpretazioni sue (così fa quando assimila platonici e pitagorici). L’aporia dodicesima pone il problema se i numeri siano essi stesse sostanze oppure no. Lo stesso Platone (Repubblica, VI – VII) parla di scienze dianoetiche e, al di sopra di esse, di cose superiori collocantisi al di là dell’ >ousia. Aristotele tenta la fondazione di una scienza che stia al di sopra anche della scienza dianoetica (cioè matematica), seguendo in ciò (almeno nelle intenzioni) le orme di Platone. La specie vale come specificazione di un genere – l’uomo come animale (genere) bipede (specie) – e, in certo senso, la specificazione non fa che negare il genere: non c’è mai, infatti, il genere animale, ma sempre e soltanto le varie specie (il cane, il cavallo, ecc). E’ astraendo da tutto ciò che le specie hanno in comune che ricavo il genere animale, che dunque non esiste autonomamente (a dispetto di quel che credeva Platone). Così, Socrate può avere cose in comune con Callia, può essere musico o camuso, ma queste non sono Idee che si aggiungono all’uomo Socrate: ed è da queste problematiche che trae origine l’aporia con cui Aristotele si domanda se esistano oppure no gli universali; si tratta di un problema destinato a restare nel tempo e a costituire il cuore della riflessione filosofica in età medievale. Aristotele riesce a mantenere una scienza e, al contempo, a salvare l’esistenza delle singole sostanze. Per la scienza attuale vi sono solo individui, cosicché la scienza degli universali prospettata da Aristotele sembra definitivamente tramontata: ma egli già si era domandato – anticipando in ciò la scienza attuale – se la scienza dovesse riguardare gli individui o gli universali, benché poi al bivio egli avesse svoltato nella direzione opposta rispetto alla scienza attuale. Heidegger nota come Aristotele sia stato il primo fenomenologo della storia, benché di un fenomenologo del senso comune si tratti: il mondo è infatti per lo Stagirita così come appare. Tutto passa e tutto scorre, ma è necessario cogliere quelle determinazioni in cui tutto passa e tutto scorre. Per i naturalisti ionici, la forma è mera parvenza; per i platonici, ad essere mera parvenza è la materia: il comune esito che tali posizioni producono è l’impossibilità di una scienza in senso pieno, ed è a ciò che Aristotele si oppone vivamente, imboccando una via intermedia che pone aporeticamente le due alternative. Pensare significa porsi il problema del tutto, ma il tutto non è mai dato ai sensi: ed è per questo che gli animali, inevitabilmente legati ai sensi, non possono pensare. Non è però possibile asserire né che tutto sia materia né che tutto sia "spirito", sostiene Aristotele anticipando tematiche su cui si interrogherà con particolare insistenza il XVII secolo: il problema è allora quello di riuscire a pensare alla totalità senza però uscire da essa. Significativamente, Aristotele menziona uno scritto di Protagora – andato perduto – in cui il sofista negava il valore della matematica e della geometria facendo leva sul fatto che, nel momento stesso in cui ci avvaliamo di supporti fisici per fare matematica e geometria, già non stiamo più facendo matematica e geometria, giacchè nell’esperienza è impossibile trovarle. Nulla è più sbagliato di un tale ragionamento, obietta Aristotele: viceversa, la matematica è valida proprio perché sganciata dal sensibile. Dietro il nostro mondo, ne vediamo un altro: il mondo matematico e geometrico. Jaeger nota con acutezza come il libro III sia provvisorio, nel senso che il libro IV avrebbe dovuto sostituirlo, ipotesi che – se si guarda al contenuto assai vicino dei due libri – pare assai plausibile, benché Giovanni Reale la rigetti. Molte cose presentate nel libro III in via apiretica (ad esempio: gli assiomi sono anch’essi parte della scienza teoretica o fanno invece parte di una scienza a sé stante?) vengono riprese nel libro IV in maniera definitiva (si dice appunto che gli assiomi fanno parte della scienza teoretica: la logica non è scienza a sé, il che fa di Aristotele un "fondazionalista", poiché egli ritiene che i principi primi siano fondati per intuizione). Ciò non toglie, tuttavia, che alcune aporie restino tali anche nel libro IV: è questo il caso dell’essere e dell’uno, di cui Aristotele continua a non saper dire con certezza se siano o meno sostanze. Ma le aporie che vanno dall’ottava all’undicesima sono risolte tutte in favore dell’unica scienza, tant’è che nel par.1 del libro IV si parla di una "scienza che studia l’essere in quanto essere" ed essa è diversa da tutte le altre, il che è e resta aporetico: se è diversa, non è determinabile e, di conseguenza, non ha un suo determinato settore dell’essere di cui occuparsi; sicchè essa, propriamente, non ha un oggetto particolare, a differenza delle altre scienze, tutte indaganti su precise porzioni dell’essere. Ciò resta un’acquisizione fondamentale per la fenomenologia novecentesca: non è un caso che Heidegger parli delle "altre" scienze (nel cui novero pone la teologia) e, separatamente, dell’unica scienza (fenomenologica), tale per cui è come se dalle cose guardate guardasse a chi guarda. La metafisica come Aristotele la intende studia l’ente in quanto ente, non in quanto essere vivente o in quanto elemento fisico: è quasi spontaneo dire che allora essa studia l’ente in quanto pensiero. Ed è proprio in difesa del pensiero che Aristotele difende quel "principio di non contraddizione" messo in forse da Protagora: nell’impossibilità di argomentare in favore di esso, lo Stagirita ragiona per assurdo, mettendo in luce le assurdità che deriverebbero dalla sua negazione (l’assurdità più grande è che non si potrebbe nemmeno parlare!). Come notavamo, nel libro III la disposizione delle aporie non è casuale, ma segue un preciso ordine: nel par.2 sono presentate le prime cinque, nel par.3 la sesta e la settima, nel par.4 quelle che vanno dall’ottava all’undicesima e, infine, la tredicesima e la quindicesima sono affrontate nell’ultimo paragrafo. Tutte quante, se ridotte all’osso, riguardano un unico problema: la fondazione della scienza di cui siamo alla ricerca. Non v’è alcuna scienza dell’individuale e, poiché i sensi ci danno solo casi individuali, non potrò fondare su di essi la scienza: ma l’uomo, che delle sensazioni è amante (libro I), non può rinunciare ad esse e, in forza di ciò, prova a fondarle scientificamente in un sapere tale da dare la certezza di quel che si riceve dai sensi. Nel par.8 del libro IV fa la sua prima comparsa cursoria il "motore immobile", alla cui trattazione specifica è dedicato il libro XII: esso non è un qualcosa che sta al di fuori del mondo, è anzi richiesto dal mondo stesso. Il par.3 del libro III è dedicato alle aporie sui generi: i principi sono generi o elementi materiali? Ben si vede qui come Aristotele dia ragione a Platone senza però asserire che i principi siano senz’altro dei generi esistenti: i generi non esistono, se per esistenza intendiamo quel che Platone riferiva alle Idee. La nozione stessa di >ousia assume diversi significati in Platone e Aristotele: per il primo, essa è l’essenza; per il secondo è invece la sostanza individuale ( >todh ti), sinolo di materia e forma, per cui nel definire l’uomo non cogliamo la sostanza individuale Socrate (come credeva Platone). La quarta aporia si domanda a ragione se la scienza debba occuparsi solamente della sostanza (Socrate) o anche degli accidente ad essa inerenti (camuso, musico, bianco, ecc): Socrate sarebbe Socrate anche se non fosse camuso, musico, bianco ecc, poiché egli è quel che è perché è un >todh ti. Nel libro VII, Aristotele asserisce che né la forma né la materia sono creati, ma si deve cogliere la sostanza nel tempo e nel movimento, tenendo conto che non esiste alcun movimento infinito lungo una retta (ed è per questa ragione che lo Stagirita ricorre al moto circolare, che perpetuamente ritorna su se stesso). L’uno e l’essere (accomunati anche nel libro IV) sono sostanze? Pare che non lo siano, giacchè tra "uomo" e "un uomo", tra "uomo" e "uomo essente" non v’è differenza; similmente Kant nota (in L’unico argomento possibile per una dimostrazione di Dio) che tra dire quel che Cesare ha fatto e dire che Cesare è stato non v’è differenza: descritta la vita di Cesare, se poi aggiungo che "Cesare è stato", in realtà non aggiungo nulla. La posizione opposta a quella aristotelica è quella degli eraclitei e dei sofisti, per i quali non si dà scienza, se non in maniera meramente convenzionale perché fondata su determinazioni umane. Viceversa, per Aristotele sussistono assiomi e determinazioni reali che permettono la scienza; lo stesso "principio di non contraddizione" – che pure non è dimostrabile – è principio regolante il reale oltrechè il pensiero. Se accentuo troppo l’antiplatonismo finisco per dire che Socrate è solo Socrate, arrivando in maniera eraclitea a negare la possibilità della scienza: occorre schierarsi in un >mhson ariston, un’ottima via di mezzo che non neghi la scienza senza però incorrere nel platonismo. Heidegger coglie l’antipatia che l’età moderna ha per il pensiero e, dunque, per Aristotele: il parmenideo "pensare ed essere sono la stessa cosa" è diventato "essere e percepire sono la stessa cosa" (l’esse est percipi di Berkeley). In certo senso è come se il problema dell’essere fosse ricondotto al problema del numero, cosicché chiedersi che cosa sia l’uno e che cosa sia l’essere equivale a porsi un’unica domanda. Il numero, del resto, non è necessariamente la numerazione, tant’è che propriamente l’uno non è un numero, giacchè non serve per contare (dire "uomo" e dire "un uomo" è la stessa cosa, come dire "uomo" e "uomo che è"). Nel cap.2 del libro IV ci si accosta all’essere per analogia: l’essere si dice in molti modi ( >to on legetai pollacwV), ma ciò non toglie che esso abbia una sua unità: così l’aggettivo "salubre" può essere riferito all’aria o ad una punizione – cose ben diverse fra loro -, mantenendo un suo significato unitario di fondo. Parimenti di ogni cosa posso dire che è, e dietro ai tanti significati dell’essere ve n’è uno che li lega tutti: è quel significato in cui appunto emerge la connessione tra uno ed essere. C’è l’essere della "sostanza seconda" (ovvero l’essere della fisica), caratterizzato dal movimento e a proposito Heidegger nota come per i Greci >fusiV sia sinonimo di "essere" e l’essere in questione è innanzitutto quello delle cose fisiche che popolano il mondo. Ma, al di sopra di quello fisico, c’è un essere superiore, una sostanza immateriale (il motore immobile) studiata dalla teologia; è proprio tale motore immobile a permettere di non andare avanti all’infinito nella ricerca delle cause ( >anagkh sthnai ,dice Aristotele: "bisogna fermarsi"), poiché per i Greci l’infinito è – a differenza dell’eterno – sempre qualcosa di negativo. In quest’accezione, l’essere è determinazione immobile di ciò che sta al di sopra del mondo in movimento: sbagliano allora Eraclito e Cratilo a sostenere che tutto scorre ( >panta rei) senza individuare quella sostanza prima di cui nulla si perde perché nulla si muove. Ed è qui che trae origine anche l’errore di Parmenide, che descrive l’essere come una sfera immobile (dunque perfetta). Lo sforzo che Aristotele condivide con Platone sta nel mantenere la concezione parmenidea e, al contempo, mantenere il movimento non già come deformazione doxastica (quale era in Parmenide e nei paradossi di Zenone), ma di addivenire ad una concezione concreta del movimento. La scienza di cui siamo in cerca deve allora anche prendere in esame gli assiomi e non la sola sostanza: l’analitica (termine col quale Aristotele designa la logica) rientra a pieno titolo nella scienza in quanto ricerca dei principi (ad esempio il principio di non contraddizione). E se stiamo cercando una scienza è proprio perché la dialettica – alla quale si erano fermati Platone e Socrate – è insufficiente in quest’ambito. Uno dei grandi errori in cui è incappata la modernità sta nell’aver ridotto l’essere all’univocità (Duns Scoto, Ockham, Giordano Bruno, Cartesio, Suarez, Leibniz, Wolff, Kant, ecc), in antitesi ad Aristotele, ad avviso del quale esso si dice in molti modi tutti collegati soltanto da un’analogia (ancora in Verità e metodo di Gadamer risuona una condanna contro la riduzione dell’essere ad univocità). Se elimino l’analogia dell’essere, allora elimino anche la metafisica: ed è questo uno degli aspetti più tipici del moderno (pensiamo al positivismo o al pragmatismo). Significativamente Brentano intitola il suo scritto su Aristotele Sulla molteplicità dei significati dell’essere, a rimarcare come ciò sia l’argomento centrale della metafisica aristotelica, il che consente aperture religiose, benché Aristotele non nutra grandi interessi per la religione (il motore immobile stesso non ha nulla di religioso). La religione stessa, oltrechè la modernità, si ribella alla metafisica: pensiamo a Pascal che attacca il Dio dei filosofi (Aristotele) e degli scienziati, di Cartesio e di Galilei, che a loro volta attaccano tangenzialmente – pur essendo buoni cristiani – il Dio della religione. Dalle aporie emerge bene la presa di posizione antiplatonica: Socrate non è che quella determinata carne (e per Aristotele la carne è unione di terra e fuoco) che assume quella determinata forma, senza che vi sia alcuna creazione divina. Lo stesso interrogarsi platonico sull’esistenza di entità matematica è un domandare privo di senso, giacchè mal formulata è la domanda (domanda che ancora Bertrand Russell si pone): le verità matematiche sono nel senso in cui la parola "essere" è comune a tutte le espressioni in cui la si impiega. Posso indagare l’essere in tutti i suoi modi quando colgo le cose nel loro essere. Heidegger, Gadamer (il concetto di >frwnesiV è in lui centrale) e Arendt accentuano la valenza pratica della filosofia aristotelica; come si ricorderà, la filosofia pratica è l’unico ambito delle scienze in cui Aristotele fa ricorso alla dialettica e dove lo Stagirita (come nota acutamente Gadamer) è "socratico" a tutti gli effetti. Il motto di Edmund Husserl "alle cose stesse" fa – secondo Heidegger – di Aristotele il primo fenomenologo della storia, giacchè egli lascia che le cose si mostrino, in opposizione a Protagora (l’uomo misura di tutte le cose), a Eraclito e ai Sofisti in generale, dove per sofisti dobbiamo qui intendere tutti coloro che negano la possibilità di una scienza che sia realmente tale. Il breve libro VI è un’introduzione alla parte centrale della Metafisica anche se è un’introduzione che non rispecchia pienamente ciò che introduce: ad esempio, in essa troviamo esposto il concetto di teologia ma su di esso Aristotele non tornerà più fino al libro XII. Nel par.1 è posta la distinzione delle scienze teoretiche (filosofia prima, matematica, fisica): si riprende inoltre il concetto della polisemia dell’essere e i suoi vari sensi vengono ora specificati: vi sono due sensi "forti" (dei quali trattano i libri VII e VIII) e due "deboli" (dei quali tratta il libro VI). I due sensi forti sono l’essere come categorie e l’essere come potenza e atto (coppia a cui è dedicato il libro IX); i due sensi deboli sono invece l’essere come accidenti e l’essere come vero e falso, su cui Aristotele si sofferma nei cap.2-3-4 del libro VI. L’essere come vero e falso è assai importante ed è strano che Aristotele lo riprenda – peraltro in maniera differente – nel libro IX cap.10. Nel tratteggiare le differenze tra la filosofia e le altre due scienze teoretiche, lo Stagirita segnala una contraddizione: da una parte, la filosofia prima cerca un oggetto universale (l’essere in quanto essere) e, dall’altra, si dice che il suo oggetto particolare è Dio (non più metafisica, ma teologia). Perché mai questa scienza universale dovrebbe occuparsi di un oggetto particolare quale è Dio? Nel libro VII. Aristotele tratta della sostanza come sinolo di materia e forma, senza mai parlare – se non di sfuggita – dell’altra sostanza non composta. Alla luce degli insegnamenti aristotelici, gli Stoici insisteranno sulla logica, la Scolastica medievale sulla teologia naturale (Tommaso). Questa scienza si distingue dalle altre perché non è ritagliata su un certo ambito dell’ente: le altre scienze presuppongono l’essere di ciò che trattano (esistono come scienze perché c’è il loro oggetto), mentre la filosofia prima ha per oggetto il problema dell’essere in quanto tale. Le tre scienze teoretiche si distinguono tra loro per due determinazioni: l’essere separato e l’immobilità. La fisica si occupa di oggetti separati ma mobili (i corpi celesti e quelli terrestri) e Aristotele fa l’esempio del camuso e del concavo. In Saggi e discorsi, Heidegger scrive il saggio La cosa (Das ding), dove, partendo dalla considerazione degli antichi, dice che nel vaso la materia è sì essenziale, ma la vera essenza è l’interno, cioè il vuoto. Così la fisica, per Aristotele, si occupa della dimensione separata della materia non mobile. La matematica si occupa invece dei numeri: essi sono immobili e – forse – non separati. Dio, oggetto della teologia, è separato e immobile. Sembra a questo punto che Aristotele debba occuparsi di Dio, ma poi, nel libro seguente, la sua attenzione si appunta sulla sostanza: egli dirà che vi sono sostanze sensibili corruttibili, sostanze sensibili non corruttibili, sostanze soprasensibili. Egli poi non parla più né della teologia, né della matematica, né della fisica: la scienza che stiamo cercando le rende possibili e le rende tali le une rispetto alle altre (come dire che se c’è metafisica, allora ci sono la matematica, la teologia e la fisica). E’ errato credere che la Metafisica sia una teologia: ciò era già stato notato da Tommaso nel suo commento all’opera; a Dio si arriva conoscitivamente alla fine, benché egli stia all’origine di tutto. L’essere in senso debole è innanzitutto l’essere come accidente: già la quarta aporia chiedeva se la metafisica dovesse occuparsi solo della sostanza o anche degli accidenti, che non sono determinazioni necessarie. Ad esempio, che Socrate sia vestito di bianco o di nero, che sia musico o camuso, è accidentale, giacchè non toglie che egli sia comunque Socrate; sostanziale è, invece, il fatto che egli sia bipede, razionale, ecc. Il secondo senso "debole" dell’essere è quello de vero e del falso: è un significato debole perchè riferito al pensiero, alla sostanza trasferita nella mia mente. Quando ho Socrate dinanzi a me e dico che egli non c’è, sto dicendo il falso, ma si tratta di un procedimento della mia mente e, in virtù di ciò, è debole, in quanto riguardante non già l’essere, ma il mio pensare l’essere. Heidegger dedica il cap. 33 di Essere e Tempo a questa problematica, al >logoV tradizionalmente inteso come luogo della verità. Nel De interpretatione (cap.4), Aristotele si pone il problema del vero e del falso come >logoV apofantikoV ("proposizione dichiarativa"): ed egli nota con acutezza come vi siano anche proposizioni non dichiarative e, dunque, soggette ad essere né vere né false (tale è, ad esempio, il comando "chiudi la porta!"). Sulla scia di queste riflessioni aristoteliche, Heidegger parla di un "in quanto apofantico" e di un "in quanto ermeneutico": nel par.44 di Essere e Tempo, asserisce che "l’esserci è sempre nella verità", in quanto ermeneutico: la cosa è sempre in un dato modo e quel modo è sempre vero. La nozione di >ousia è il punto nodale per comprendere la distinzione tra il pensiero platonico e quello aristotelico: in Aristotele anche l’ >ousia, al pari dell’essere, si dice in molti modi e, del resto, la stessa filosofia aristotelica può essere compresa e detta in più modi, senza mai avere un senso unilaterale (benché si possa seguire, sì, un filo conduttore, nascosto dietro ad una pluralità di determinazioni). Così lo Stagirita asserisce che l’essere dev’essere inteso anche come categorie, ma poi, nello scritto sulle Categorie, egli parla di esse solamente in senso logico, mai ontologico. Resta in ogni caso vero che la ricerca metafisica non si muove nell’ambito del vero e del falso, poiché essi riguardano soltanto quel che io dico delle cose (e ciò esula dalla ricerca metafisica). Il Trattato sull’emendazione dell’intelletto di Spinosa e la IV delle Meditazioni metafisiche di Cartesio si soffermano sugli errori dei sensi (Cartesio adduce l’esempio, di sapore lucreziano, della torre che, vista da lontano, pare tonda, ma che poi in realtà, quando la avviciniamo, è quadrata). Il problema dell’essere (che cos’è l’essere?) tende a trascolorare nel problema dell’ > ousia (che cos’è l’ > ousia?), ovvero il problema della sostanza, che è senz’ombra di dubbio il più complesso tra quelli esaminati nella Metafisica. La sostanza non dev’essere intesa a partire dai sensi, benché tutti noi siamo abituati a farlo, in quanto avvezzi a muovere dalle cose materiali: si deve invece partire dall’essere in quanto tale, tenendo sempre presente che l’ordine della nostra conoscenza non necessariamente corrisponde all’ordine del reale, cosicché il sensibile, che per noi viene prima di ogni altra cosa, in realtà sta dopo il soprasensibile. I primi capitoli del libro VII sono introduttivi al problema della sostanza, mentre il cap.3 entra in medias res, mettendo in luce come la sostanza si dica in quattro modi: la sostanza come sostrato o come materia o come forma o come sinolo di materia e forma. In rottura con Platone, si fa notare come la sostanza non sia né un universale né un genere autonomamente esistente. Nei capitoli tra 4 e 6 si affronta il tema della sostanza come essenza, mentre nei capitoli tra il 7 e il 12 si parla del divenire, ma i cap.7-8-9 sono a sé stanti. Nel cap.17 c’è la conclusione, in cui si tirano le fila. Giovanni Reale dice che questo libro resta in attesa di parlare delle sostanze soprasensibili, che vengono in esso trascurate in favore di quelle a cui accediamo tramite i sensi. In realtà, però, il libro VII affronta il tema della sostanza in generale, senza distinguere nettamente tra quella sensibile e quella soprasensibile. Nel definire la sostanza mi riferisco al "per sé" ( >kaq’ >auto) e all’essenza (le definizioni): per essere sostanza, deve sussistere per sé e dev’essere definibile, il che implica un inevitabile riferimento al linguaggio (su cui Aristotele si sofferma nelle Categorie e nel De interpretatione). Parlare di sostanza come sostrato equivale a dire che non la si può predicare di qualcos’altro. La domanda che pare a questo punto spontanea è la seguente: perché ogni cosa ha una sua unità? A tal proposito Aristotele dice che l’Iliade è una cosa unica, ma che non ogni cosa mi dà un’essenza. Spinosa intende l’unica sostanza come Dio e, per far ciò, nega l’esistenza del vuoto (è infatti il vuoto a distinguere le cose le une dalle altre). Ma non ci si può arrestare alla sostanza: ci vogliono anche i generi (così l’uomo appartiene al genere animale). Ma che rapporto intercorre tra la singola cosa e l’essenza? E’ un rapporto o di totale identità o di separazione: la sostanza in quanto essenza è sempre separata, in quanto definibile. Ma non vi sono Idee separate dalle cose stesse: Socrate è Socrate perché è quella determinata carne e quelle determinate ossa che lo rendono tale. Il problema della sostanza diventa allora il problema della definizione: che cosa posso definire? Non posso mai definire il bianco se non in riferimento a cose bianche. Ma la "filosofia prima" non dice nulla della sostanza in quanto tale, bensì si limita a parlare delle sue determinazioni: c’è un rimando alle cose divine, nel senso che ci si occupa della sostanza in maniera "logica", il che lascia tutto in sospeso: non ci occupiamo della sostanza in termini sensibili, così sembra dire Aristotele. La sostanza è strumento per riconoscere l’unità delle singole cose. Per Aristotele non si tratta di cercare "un mondo dietro il mondo" (Nietzsche), come era invece per Platone: la ricerca delle cause serve invece a comprendere la cosa stessa, senza ipostatizzare la causa. Le Idee platoniche non hanno per Aristotele alcuna esistenza autentica: materia e forma sono presupposte come necessarie e sufficienti a spiegare ogni cosa. Ad esserci sono le sostanze, il problema sta nel definirle: nel cap.5 si dice che non sono possibili definizioni di cose come il "naso camuso"; seguire le orme di Platone è rischioso, poiché porta a paradossi come quello del "terzo uomo". Il problema centrale è allora quello del "per sé", ovvero di ciò che costituisce un’unità analogica: gli esempi addotti in merito da Aristotele sono quello dell’"uomo bianco" e del "bene". "Uomo bianco" ed essenza di "uomo bianco" sono due cose differenti poiché, se fossero la stessa cosa, allora sarebbero la stessa cosa anche "uomo" e "uomo bianco", il che è palesemente assurdo; similmente, "musico" e "bianco" dovrebbero coincidere. Nessun uomo è uomo perché è bianco. Il bene e l’essenza del bene, invece, coincidono, cosicché non debbo uscire dalla cosa per trarne l’essenza (un unico atto buono è sufficiente per definire il bene). Mentre nel cerchio di bronzo il bronzo non fa parte della sostanza "cerchio" , nell’uomo le ossa e la carne fanno parte della sostanza dell’uomo. La Metafisica stessa, più che come opera teoretica, si limita a descrivere le cose come esse si presentano. La materia è sostanza in senso debole, mentre il sinolo lo è in senso più forte: la forma pura è sostanza in senso pieno e tale è il motore immobile, che non ha più nulla di materiale in sé (non pensa nemmeno ad alcunchè di materiale). Lo stesso concetto di potenzialità è assente in Dio. Aristotele prova a pensare l’essere senza l’ente quando suppone Dio come sostanza attuale, scevra di materia e potenza, e dedita alla vita teoretica ( >bioV qewretikoV). I cap.7-8-9 risalgono ad una redazione più antica e infatti parlano delle cause del divenire, non più della sostanza; dal cap.10 si riprende il cammino e nel 12 si spiega che cosa è una definizione (che per Platone coincide con l’Idea). Per Aristotele interviene il genere (che non è un’Idea), il quale serve per arrivare alla definizione, che è sempre composta da due termini: "uomo bianco" non è una definizione poiché nessun uomo si definisce per l’esser bianco; "l’uomo è animale bipede" è invece una definizione, poiché esula dall’accidentale. Degli individui singoli (Socrate, Callia, ecc) non v’è definizione. Gli atomisti sono criticati perché non s’accorgono della polisemia dell’essere. Il cerchio può essere di vari materiali (bronzo, legno, ecc), mentre l’uomo deve per forza essere di carne e ossa, cosicché pare che la forma faccia a pieno titolo parte della materia. Il cap.12 è dedicato alla definizione, cui si perviene per genere e per differenza specifica: l’uomo è un animale (genere) bipede (differenza specifica). Dal cap.13 al 16 si adducono argomentazioni per mostrare come la sostanzia non sia un universale, di contro alla tesi platonica: nel cap.14, poi, si riprende il problema dell’universale come sostanza e si mette in luce come, se la dottrina platonica fosse vera, allora si dovrebbe rinvenire lo stesso animale tanto nell’uomo quanto nel cavallo. Se ne evince allora che ogni individuo è una sostanza a sé stante: il grande errore platonica sta nel prendere il genere e farne un "in sé", mentre in realtà esistono sempre e solo individui singoli calati in una data materia e in una data forma. Ciò che rende definibile l’individuo è il fatto che è legato alla materia: non vi sono Idee universali, tuttavia l’individuo non è definibile. Dal punto di vista empirico, è sostanza la materia, ma come determinazione non specificamente legata alla materia è sostanza la forma, che è la causa dell’essere: essa non è propriamente individuale, ma non è neanche idea universale, giacchè è sempre in una materia specifica. Sicchè l’uomo è una determinata forma che accade in una determinata materia, cosicché l’uomo non può essere uomo se non in riferimento ad una materia (non posso pensare Socrate separatamente dal suo corpo). Nel cap.16 è affrontato il problema delle sostanze eterne – il sole e i corpi celesti -, costituite da materia incorruttibile. La luna è il confine che separa ciò che è eterno (il mondo sopralunare) da ciò che è caduco (il mondo sublunare). Aristotele aveva aperto l’opera notando come tutti gli uomini tendono naturalmente (Heidegger direbbe "ontologicamente") all’ >eidenai, al sapere o, anche, alle forme ( >eidh). Heidegger rimproverava a Kierkegaard di essersi opposto a Hegel dimenticando Aristotele, per il quale – nota Heidegger – ad esistere sono solamente le sostanze individuali. La materia è potenzialmente tutti gli uomini, come le 24 lettere dell’alfabeto sono potenzialmente tutte le parole possibili: è poi la forma che esse assumono a farle passare a parole in atto, così come è la forma assunta a far sì che quella materia diventi Socrate in atto. Passiamo ora ad esaminare il libro IX: la difficoltà sta nel comprendere quell’insieme di determinazioni non create. Platone – almeno nella visione che Aristotele ha di lui – propone le Idee come esistenti in modo autonomo. Anche Aristotele, in certo senso, dice che esistono, ma a partire dalla considerazione che l’essere si dice in molti modi (di contro all’univocità imperante nel mondo odierno). Forme e "atto puro" sono eterni e, dunque, imperituri (ciò resta vero anche in Tommaso, per il quale Dio è actus purus). La distinzione potenza/atto (introdotta nel libro V, cap.7-8) è ora analizzata nel dettaglio: potenza ( >dunamiV) e atto ( >energeia) vanno indagati in coppia, poiché altrimenti non li si può capire: i cap. dall’1 al 5 trattano della potenza e dell’atto a partire dal movimento (è la concezione più ovvia, una concezione meramente fisica), ma una siffatta considerazione non è sufficiente: nei cap. dal 6 al 9 – nota Giovanni Reale – si parla metafisicamente di potenza e atto, e nel cap.8 v’è un’autentica dimostrazione dell’esistenza di Dio, che sarà l’argomento cardinale del libro XII. L’artigiano produce la sfera di bronzo, ma non produce la materia e la forma, le trova invece già esistenti: similmente, Dio non crea le cose, il che fa del Dio aristotelico un Dio esulante da quello della tradizione. Riprendendo le argomentazioni sulla forma e sulla sostanza alla luce della distinzione tra potenza e atto, Aristotele asserisce che esistono una potenza attiva e una potenza passiva (cap.1), giacché anche il subire è una potenza. Nel cap.2 lo Stagirita chiarisce che esistono potenze irrazionali (quelle che realizzano un’unica cosa: ad esempio, il fuoco può solo produrre calore) e potenze razionali (quelle che realizzano entrambi i contrari, ma non al contempo: così la medicina può guarire oppure non guarire, ma non può compiere nello stesso tempo le due operazioni); in particolare, potenze razionali sono tutte le scienze. In questi termini, il male è un non realizzare ciò che andrebbe realizzato (la medicina che, anziché guarire, non guarisce). Nelle potenze razionali è necessario un principio dell’attualizzazione, che può essere il desiderio ( >epiqumia) o la capacità razionale. Resta sempre, come determinazione costante, la definizione di potenza come realizzarsi di qualcosa in altro (o su se stesso, se inteso come altro: è il caso del medico che cura se stesso e che dunque è medico e paziente insieme). Sia potenza sia atto, in greco, hanno a che fare col movimento, benché per Aristotele essi siano due parole connesse ma indicanti due momenti diversi: la potenza ha a che fare con la possibilità che qualcosa si realizzi, mentre l’atto è quel qualcosa che effettivamente si realizza: a tal proposito, Aristotele adduce (cap.4) l’esempio di Ermes scolpito nel legno; il legno è potenzialmente Ermes e solo quando è effettivamente scolpito diventa Ermes in atto. Similmente, ogni retta contiene due semirette, ma se non spezzo la retta le due semirette restano a livello potenziale. L’atto è dunque qualcosa di compiuto che non rimanda ad altro: e si può capire una cosa in potenza solo se se ne considera l’atto (posso capire che cosa è il seme solo se so cosa è l’albero), cosicché l’atto viene prima sia logicamente sia cronologicamente (perché qualcosa in potenza passi all’atto occorre l’intervento di qualcosa che sia già in atto). Il cap.3 sospende l’indagine teoretica e fa considerazioni storiche sui Megarici, i quali sostenevano l’identità di potenza e atto. A loro avviso, il costruttore è tale solo nel momento in cui costruisce. Aristotele – come con il principio di non contraddizione – non può dimostrare che atto e potenza siano separati, può solo far vedere l’assurdità che deriva dal negare la loro separazione: se ciò che dicono i Megarici fosse vero, allora chi è seduto non potrebbe alzarsi, e viceversa. Per i Megarici il mondo è composto da istanti completamente separati gli uni dagli altri: manca del tutto – come già mancava per gli eleatici – l’idea del movimento, concepito come mera illusione. Nel cap.4 Aristotele si sforza di far vedere come altra cosa rispetto alla potenza sia l’impossibilità: il lato e la diagonale del quadrato sono incommensurabili nel senso che è impossibile che si commisurino; il pezzo di legno, invece, è potenzialmente Ermes nel senso che posso farlo diventare tale. Esistono però cose che paiono in potenza ma che in realtà sono impossibili e sta alla scienza capirlo. Nel cap.5 si conclude l’analisi dei concetti di potenza e atto alla luce della nozione di movimento: a partire dal cap.6 si passa al tratto metafisico di tali concetti, cosicché si analizza la sostanza stessa. Si tratta, in particolare, di mostrare come l’atto venga prima della potenza e come, se v’è qualcosa in potenza, sia tale in quanto potenza di un atto. Giovanni Reale individua due gruppi di prove e il secondo gruppo è costituito come separazione del sensibile dal soprasensibile, come se l’atto appartenesse al sovrasensibile e la potenza al sensibile. Sicchè la forma equivale all’atto, la materia alla potenza. Stando così le cose, tutto quel che abbiamo detto sulla materia trapassa qui nella potenza e così per forma e atto. Il discrimine tra potenza e atto sono la morte e la nascita: l’atto non ha inizio né fine; è eterno. Dio stesso è puramente in atto. Bergson accusa Aristotele di dar troppo poco peso al movimento, quando in realtà Aristotele – nell’attaccare i Megarici – lo difende a spada tratta. E’ il movimento stesso a porre la differenza tra reale e irreale (delle cose irreali, infatti, non posso dire che siano in movimento). E poi Aristotele torna nel cap.10 sul vero e sul falso, asserendo che pensare il vero equivale a pensare le cose come realmente sono, per cui, se penso unite due cose che sono separate, penso il falso. Si tratta di un processo tutto interno alla mente, ma l’atto è un processo che avviene nell’essere e non nella mente. La metafisica stessa è >episthmh thV alhqhiaV (libro II), dove la "verità" in questione non è l’ordine del mondo pensato, ma è adesione totale alla realtà e l’atto stesso si realizza interamente nella cosa. "Conosciamo le cose facendole", dice Aristotele: ciò significa che conosciamo le forme e l’atto nella materia, sicchè conosciamo i tavoli perché li produciamo. Nel libro XII compare l’argomento secondo cui il divenire sarebbe legato alla materia, cosicché la vera conoscenza non è mai quella riguardante cose materiali, benché essa non possa non partire da qualcosa di materiale (perfino il tempo e il movimento sono da noi conosciuti nella materia). Nel cap.1 del libro XII, Aristotele asserisce che non tutti ammettono le sostanze sovrasensibili, ma costoro si trovano poi costretti ad applicare la sola categoria della sostanza, che è la più ovvia di tutte. Lo Stagirita precisa che l’espressione "tu sei bianco" è vera per il fatto che tu sei effettivamente bianco: non è che sia vera per il semplice fatto che la pronuncio, giacchè le cose sono in un determinato modo e io non posso fare altro che prenderne atto. Che conosciamo producendo è vero anche per quel che riguarda gli oggetti della geometria e della matematica, dove ci avvaliamo sempre e comunque di supporti materiali. Ciò non toglie, naturalmente, che per Aristotele l’asserto eracliteo/cratileo del "tutto scorre" resti vero, sì, ma solo se riferito all’ambito materiale, ove ogni cosa è soggetta ad un incessante divenire; ma se lo riferiamo all’ambito della forma e dell’atto, tale asserto perde ogni validità. Tuttavia le forme sono conoscibili solamente nella materia e grazie ad essa, il che rende in parte conto dell’espressione aristotelica per cui "conosciamo le cose facendole". In certo senso, il grande sforzo di Aristotele consiste nel provare a pensare l’essere in quanto tale e non solo in quanto materia (giacchè si tratta di una delle tante determinazioni dell’essere), a differenza di quel che facevano quei naturalisti ionici che avevano reso conto dell’intera realtà servendosi esclusivamente della causa materiale. Le stesse Idee platoniche – a ben vedere – non sono che enti materiali intesi come se materiali non fossero (così l’idea di cavallo non è che il cavallo materiale concepito come extramateriale): ciò è stato perfettamente colto da Gilson e dal modo pregnante in cui egli qualifica questo aspetto del platonismo ("realismo delle idee"). Se Aristotele si fa promotore della pluralità dei significati dell’essere, la modernità si è invece appiattita sull’univocità, atteggiamento che ha raggiunto il vertice con la scienza moderna. Così Kant evita oculatamente di parlare dell’essere, limitandosi a parlare di "categorie", ovvero modi di pensare l’essere. Spetta invece ad Heidegger l’ambizioso tentativo – avanzato in Essere e Tempo – di riproporre la Frage (domanda) intorno all’essere, risollevando un problema che pare caduto nell’oblio dopo Platone e Aristotele. In particolare, lo Stagirita ha per la prima volta proposto in maniera chiara la pluralità dei significati dell’essere e, quando egli ci suggerisce che "l’essere si dice in molti modi", è come se ci stesse invitando a distaccarci da quella troppo banale visione dell’essere come sola materia. Questa è la grande scoperta di Aristotele, scoperta che sarà duramente combattuta da gran parte del pensiero moderno: non è un caso che detrattori di Aristotele siano Lutero, Pascal, Kierkegaard, i quali rifiutano in primis quella sua teologia al cui centro è un dio non religioso, non personale, privo di rapporti col mondo e – soprattutto – con l’uomo: il dio quale Aristotele lo concepisce finisce in fin dei conti per ridursi a sostanza posta come conferma della polisemia dell’essere (dio è la prova più fulgida che l’essere non è solo materia). Pur nella generale ostilità dell’età moderna verso Aristotele, vi sono anche pensatori che lo apprezzano e che a lui si rifanno: caso emblematico è quello di Tommaso, il quale – accanto alla teologia rivelata – ne ammette una naturale, la quale altro non è se non il pensiero che ammette l’esistenza di Dio a prescindere dalla rivelazione. Nel cap.8 del libro XII si parla di una pluralità di motori immobili: ciò ha indotto Giovanni Reale a sostenere che l’intero libro XII risalga alla maturità (e non alla giovinezza, come sosteneva Jaeger). Platone si accorge dell’impossibilità di superare il sensibile e, per parlare del sovrasensibile, inventa miti esulanti dalla razionalità; Aristotele, invece, parla razionalmente dell’essere in quanto tale nei suoi molteplici significati, tra i quali va ascritto quello di essere come forma. Sicchè nel libro XXI le quattro cause ammesse nel libro I (e nella Fisica) sono ridotte a due: atto e potenza; il primo, racchiude in sé la causa finale e quella formale; la seconda, invece, comprende la causa materiale e quella del movimento. Werner Jaeger legge il libro XII non già come conclusione della Metafisica, bensì come libro redatto da Aristotele in gioventù: ciò in base all’assunto jaegeriano – rivelante la sua formazione di marca positivista e comteana – per cui lo Stagirita si sarebbe in gioventù dedicato alla teologia, in età adulta alla metafisica e nella vecchiaia alla scienza. Diametralmente opposta è la posizione di Giovanni Reale. Ma, al di là delle questioni inerenti il periodo in cui il libro fu composto, al suo centro sta la nozione del Motore immobile, costituente l’unità del pensiero: esso è, infatti, una sola "cosa" e pensa ad una sola cosa, a se stesso. E’ uno >zwn, dotato di una vita risolventesi nel pensiero: anche l’uomo può vivere in tale condizione beata, ma – a differenza di Dio, che si trova eternamente in essa – solo ad intermittenze, giacchè deve continuamente interrompere la beatitudine per soddisfare le esigenze fisiche derivatigli dal suo essere materiale. Dio è sostanza senza altre determinazioni, noi siamo sostanza più altre categorie (qualità, luogo, ecc): la sua sostanza è costituita dall’intelligenza e in lui coincidono pensiero e pensato, poiché egli non fa altro che pensare a se stesso. L’argomentazione che Aristotele dispiega per dimostrare l’esistenza di dio poggia sul fatto che il moto non ha inizio: occorre necessariamente supporre un essere che metta in moto l’universo senza a sua volta essere messo in moto: tale è appunto dio. Nel libro XII, grazie alla nozione di motore immobile, è risolta l’aporia del libro III in cui ci si chiedeva se esistessero anche sostanze immateriali; è al contempo sciolta anche l’aporia con cui Aristotele si chiedeva se le cose nascessero dagli elementi o dalle sostanze. Anassagora rispondeva dicendo che ogni cosa è originariamente mescolata fino a che un’Intelligenza non trae dall’insieme le singole cose: dal caos primordiale deriva la realtà. Per Aristotele una spiegazione di questo tipo è inaccettabile: egli non la pensa né come i fisiologi né come i poeti; per lui dio si limita a mettere in moto il mondo, che verso di lui agisce come l’amante verso l’oggetto amato. Si tratta di un dio che attira a sé il mondo come finalità, quasi come se l’intero universo cercasse di imitare dio. Il pensiero è l’unico aspetto che ci accomuna ad un tale dio, cosicché pensare è l’attività più nobile che possiamo esercitare. Questa causa prima, che non fa altro che pensare, è sommamente bella e buona, va ripetendo Aristotele, poiché la vita divina non è inficiata dal mondo materiale delle esigenze fisiche (mangiare, bere, riprodursi, ecc). Ritorna nel cap.7 l’idea (già espressa nei libri I e II) secondo cui quanto più pensiamo, tanto più ci avviciniamo a dio, a tal punto che, nei momenti in cui esercitiamo il pensiero, siamo in una condizione divina. In dio non v’è nulla di potenziale, poiché egli non deve diventare null’altro rispetto a ciò che attualmente è: pensiero di pensiero, amore di amore. Proprio come le scienze teoretiche, dio non produce nulla: in lui il desiderio di sapere è continuamente attuale, benché resti desiderio (ancorché interamente realizzato: dio sa ciò che vorrebbe sapere, ovvero sa se stesso), mentre la vita umana è in cerca di un tale sapere ed è ostacolata dalla corporeità che impedisce di dedicarsi appieno al pensiero.
STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA
LA CONOSCENZA NELLA FILOSOFIA ANTICA
LA CONOSCENZA NELLA FILOSOFIA ANTICA
Che i filosofi, antichi e moderni, mirino a sapere lo dice il nome stesso della loro professione: filosofia, infatti, deriva dal greco
>filoV , "amico", e >sofia , "sapere", e i filosofi, dunque, sono coloro che "amano il sapere". Ma non solo i filosofi aspirano a sapere: come dice Aristotele nel celebre incipit della sua "Metafisica" tutti gli uomini per natura aspirano alla conoscenza. I filosofi, però, sono coloro che hanno problematizzato la questione della conoscenza, interrogandosi su svariati aspetti del sapere e fornendo risposte spesso divergenti e contrastanti. Il filosofo, quindi, si contraddistingue fin dall’inizio per il fatto che, oltre a possedere conoscenze, le problematizza; ma, ad onor del vero, anche in campi non propriamente filosofici, come ad esempio la poesia, vengono trattati problemi analoghi (pensiamo ai testi omerici), anche se resta incommensurabilmente diverso il modo di affrontarli. Ogni sapere, in generale, ha suoi oggetti specifici: è invece difficile stabilire quali siano gli oggetti dell’indagine filosofica, poiché vi è una divergenza di prospettive. I filosofi, infatti, già a partire dall’antichità, non si trovavano quasi mai d’accordo perfino su cosa significasse conoscere, cosicchè, per chiarire questi concetti, introdussero distinzioni sempre più sottili, sollevando sempre nuovi problemi e lasciandoli in eredità ai filosofi successivi. Uno dei primi problemi ad affacciarsi sullo scenario filosofico riguardava figure di competenti, come medici o artigiani, dotati di un sapere specifico e in grado di cambiare la situazione presente: ci si cominciò a chiedere che tipo di sapere fosse e che relazione intercorresse tra il loro saper fare e il sapere in generale. Ma queste domande non fecero altro che suscitare nuove questioni, a cui si provava a trovare soluzioni soddisfacenti: pareva infatti chiaro, ad esempio, che il medico, per poter guarire i pazienti, dovesse avere conoscenza pratica dei farmaci da somministrare e che quindi il suo fosse un sapere pratico indissolubilmente legato, però, con la dimensione conoscitiva. Si andava via via delineando una sempre più netta distinzione tra sapere pratico e sapere non pratico, ma, nel contempo, sorgeva un nuovo, fondamentale dilemma: la conoscenza medica può essere suscettibile di una generalizzazione, ovvero, nel caso risulti efficace se applicata a più pazienti, può allora venire applicata alla totalità di coloro che sono affetti dalla medesima malattia. Da qui nasce il problema se la conoscenza debba riguardare un oggetto (il singolo malato) o classi di oggetti (i malati nella loro totalità); problema che, con il progredire della terminologia filosofica, verrà posto in questi termini: la conoscenza riguarda il particolare (il singolo uomo Socrate) o l’universale (gli uomini)? E’ evidente che questa problematica non riguardi solo i filosofi, ma anche i medici. Ci si cominciò poi anche a chiedere quali fossero i metodi della conoscenza: una domanda che rinviava immediatamente ad un’altra questione, ovvero quale fosse la struttura dell’uomo e di quali risorse l’avesse fornito la natura. Fin dall’inizio, naturalmente, si fu propensi a ritenere che le principali vie conoscitive concesse all’uomo fossero i sensi, ovvero la capacità di ricevere sensazioni, di percepire oggetti fuori di noi. Ampi furono, in questa prospettiva, i riferimenti ai compagni di strada dell’uomo, gli animali: il problema dell’avere una conoscenza finisce per investire anche loro (e questo è vero soprattutto con Aristotele). Ci si chiese quindi: che conoscenza può avere l’uomo? Ma anche: che conoscenza possono avere gli animali? Perché anch’essi, come l’uomo, sono dotati di sensi; in epoche più mature ci si interrogherà addirittura sull’intelligenza degli animali. Ma, dopo che fu ravvisata nei sensi la principale via conoscitiva, ci si cominciò a chiedere se essi fossero strumenti conoscitivi attendibili. Possiamo fidarci della conoscenza che passa per i sensi? Eppure essi, talvolta, ci forniscono percezioni evidentemente sbagliate, come quando ci capita di vedere doppio o quando vediamo spezzato, per un’illusione ottica, il remo immerso in acqua. Chi ci dice che, parimenti, i sensi non ci ingannino sempre? E poi, a ben pensarci, la percezione è individuale: basta la mia percezione per assicurarsi oggettivamente della realtà? E, nel caso bastasse, è sufficiente una singola percezione o devo attendere la reiterazione? Anche sull’onda di queste considerazioni, ci si accorse che l’uomo disponeva di un’altra arma conoscitiva oltre ai sensi: si trattava dell’intelligenza; e nacque subito un nuovo, assillante problema su cui arrovellarsi: che rapporto intercorre tra intelligenza e percezione? E’ sufficiente una delle due da sola? L’intelligenza controlla la sensazione o viceversa? Si tratta di problemi vivi ancora oggi, anche perché, in fin dei conti, la filosofia ha sollevato una miriade di problemi ma non ne ha mai definitivamente risolto nessuno. Nascevano ulteriori considerazioni importanti: dall’abbinamento di intelligenza e sensazione scaturisce una conoscenza vera? E come posso distinguere una conoscenza vera da una che, invece, è falsa? E una autentica da una dubbia? Affiorò la problematica del rapporto tra conoscenza, avente per oggetto la verità, e opinione, suscettibile di essere vera o falsa. Il problema della conoscenza, quindi, finiva per trascinarsi appresso quello della distinzione tra vero e falso. Addirittura, nel corso della storia della filosofia, ci fu un momento in cui fu messa in forse la possibilità di avere conoscenza: è il caso degli Scettici, i quali sospendevano il giudizio (la famosa >epoch ), rinunciando a dire cosa fosse vero e cosa falso. Emerse poi un altro problema: di una medesima cosa si poteva conoscere il "che" e il "perché"; ad esempio, un conto è sapere che il fuoco brucia, altra cosa è sapere perché il fuoco brucia. Quale tra le due conoscenze è superiore, quella del che o, viceversa, quella del perché? Aristotele e Platone sostennero che conoscere il perché delle cose significa spiegarle, ossia conoscere le cause che le hanno prodotte, con l’inevitabile conseguenza che, la conoscenza del "che" è assai inferiore. In altri termini, la conoscenza del perché fornisce indicazioni generalizzabili, grazie alle quali è possibile costruire una scienza. Un altro problema che si dovette presto affrontare fu questo: per avere una vera conoscenza bastano conoscenze isolate o si deve piuttosto essere in possesso di un sistema integrato di conoscenze? Questa tematica sarà particolarmente sentita e dibattuta in età ellenistica, quando gli Stoici, gli Epicurei e gli Scettici provarono a tratteggiare la figura del sapiente: per gli Stoici, ad esempio, il sapiente sarà colui che detiene tutte le conoscenze possibili, a tal punto che, per loro stessa ammissione, un vero sapiente non è praticamente mai esistito. Naturalmente, col passare del tempo il sapere tende sempre più a specializzarsi con l’inevitabile conseguenza che diventa sempre più difficile stabilire chi sia il filosofo e capire quale sia il linguaggio mediante il quale il filosofo si esprime. Se è vero che ogni storia ha un suo punto di partenza, bisogna chiarire da dove parta la storia della filosofia: e si può notare come la questione della conoscenza umana cominci a sorgere in connessione al riconoscimento dell’esistenza di una conoscenza divina; proprio il rapporto uomo/divinità costituisce il punto di partenza e il problema può sinteticamente risolversi nella questione se l’uomo disponga o no di una conoscenza in qualche modo accostabile a quella della divinità. Ovviamente la domanda rimanda all’interrogativo: quale rapporto intercorre tra le due conoscenze, quella umana e quella divina? Per trovare qualche risposta dobbiamo rivolgerci soprattutto ai testi poetici: nei poemi omerici, ad esempio, in cui sono spesso menzionati i tecnici, gli indovini e i medici, i poeti presentano i loro canti come il risultato di un ammaestramento divino; la divinità, dunque, era posta all’origine della loro espressione, il che significa che i poeti esprimono un sapere che è a tutti gli effetti divino. Era infatti convinzione comune che la conoscenza fosse assolutamente impossibile senza l’intervento divino ed è in questa prospettiva che Esiodo e Omero presentano i loro poemi; in un passo dell’VIII libro dell’Odissea, Odisseo tesse le lodi del cantore Demodoco: " certo Apollo o la musa figlia di Zeus ti istruirono "; il cantore, solo perché il sapere gli proviene da una fonte superiore, può cantare ciò che capitò agli Achei a Troia pur senza aver visto coi suoi occhi. Anche l’incipit della Teogonia esiodea è, sotto questo profilo, particolarmente significativo: " sono le muse che un giorno un bel canto insegnarono a Esiodo ". Ma – e qui sta la cosa interessante – le muse in Esiodo raccontano anche cose false, cosicchè sta all’uomo capire gli ammaestramenti divini, evitando di riceverli passivamente; in altri termini, il messaggio è che non ogni forma di poesia, perché ispirata dalle muse, è autenticamente vera. Si affaccia così, seppur timidamente, l’idea che la conoscenza umana abbia una sua indipendenza. Si invita il poeta a vigilare sulla qualità del messaggio trasmesso; fatto sta che per Esiodo egli possiede una conoscenza eccezionale, del futuro, del presente e del passato, e tende dunque a sfumare nella figura dell’indovino detentore di un sapere totalizzante. Soffermando la nostra attenzione sul I libro dell’Iliade, a proposito dell’indovino Calcante viene detto: " conosceva il presente, il futuro e il passato […] l’arte sua di indovino che gli donò Febo Apollo ". Quella dell’indovino è una figura antica e appartiene, oltre che alla Grecia, anche al vicino Oriente: perfino ai medici è spesso attribuita la capacità di prevedere il futuro; non a caso, la "prognosi" di cui parla Ippocrate nel V secolo a.C. era, in origine, una previsione della salute per il paziente. Alcune tavolette babilonesi contenevano poi elenchi di segni desunti dal mondo animale in base ai quali si potevano formulare previsioni collegando il segno che si presentava con un evento destinato a verificarsi: ad esempio, troviamo scritto che " se una lucertola si arrampica sul letto del malato, egli guarirà ". In questa prospettiva, il futuro può essere predetto a patto che si presentino segni particolari, secondo una formula del tipo: "se x, allora y". Lo stesso contenuto dei sogni si credeva che fosse indicativo, poiché si riteneva che essi svelassero cose che si sarebbero verificate in futuro (ancora nel V secolo i medici ippocratei ne tenevano conto). Ma anche gli artigiani e i medici, dunque, oltre ai poeti, erano detentori di una forma di sapere e, stando a quel che dice Omero, compivano le loro opere con l’appoggio delle divinità: sempre Omero racconta di un’erba dai poteri straordinari che poteva essere sradicata solo da una divinità e resa nota ai medici dalla divinità stessa; anche il sapere dei medici, come quello dei poeti, era dunque concepito come divino. Tuttavia (e qui sta la differenza rispetto ai poeti) il sapere dei medici e degli artigiani si accompagna al saper fare, al saper costruire oggetti o produrre la salute. Si continuava a riconoscere che senza l’intervento divino il sapere non aveva carattere assoluto, riconoscendo in tal senso i limiti della propria conoscenza e constatando che il sapere umano non avrebbe mai potuto competere con quello divino per vastità e profondità. E dunque dal confronto con l’alto (Dio) e col basso (gli animali), si intravedeva la possibilità di definire la conoscenza umana: e tale via comincia ad essere battuta da un pensatore attivo dal VI al V secolo nella Magna Grecia, Alcmeone di Crotone, che viene solitamente messo in relazione con il pitagorismo. Medico di professione, era soprattutto mosso dall’esigenza di capire esattamente quale potesse essere la portata della conoscenza umana. Egli distingueva in modo marcato la conoscenza umana da quella divina, mettendo in luce fin dove quella umana potesse estendersi. Il sapere divino veniva da Alcmeone qualificato come >safhneia , ovvero assoluta certezza; quello umano, dal canto suo, veniva visto come notevolmente meno chiaro. Quelle cose che per gli uomini risultano invisibili, sono, ad avviso di Alcmeone, perfettamente visibili per gli dèi: il conoscere umano procede attraverso indizi ( >tekmhria) o, nel linguaggio medico, sintomi. Si deve dunque costruire il sapere a partire dai segni, così come il medico parte dai sintomi per diagnosticare la malattia. Per superare il buio, quindi, non ho bisogno di divinità che mi aiutino, ma piuttosto di >tekmhria sui quali fare inferenze, passando così dalle cose certe a cose che certe non sono. Questi indizi intorno ai quali edificare la conoscenza sono essenzialmente coglibili nell’ambito delle sensazioni, cosicchè si parte da ciò che si presenta ai sensi per arrivare a ciò che ad essi non si presenta; bisogna però spiegare come funziona questo passaggio e quale è lo strumento che consente di attuare l’inferenza. Ed è qui che entrano in gioco gli animali: infatti anch’essi hanno percezioni, ma è solo l’uomo a poterle comprendere, ossia "raccogliere e connettere" ciò che proviene dai singoli organi di senso. Ma ciò non toglie che attraverso quest’operazione di raccoglimento e connessione dei dati sensoriali l’uomo finisca per costruire una conoscenza inferiore rispetto a quella divina: " delle cose visibili e delle invisibili solo gli dèi hanno conoscenza certa ( >safhneia ); gli uomini possono soltanto congetturare […]. L’uomo differisce dagli altri animali perché esso solo comprende " (ovvero sa connettere i dati sensoriali). Questa tesi, secondo la quale la conoscenza divina è più ampia e precisa, è avanzata anche da Senofane di Colofone, che, secondo l’autorevole testimonianza di Platone, sarebbe stato il capostipite dell’eleatismo. Il punto di partenza della sua riflessione è costituito dalla critica alle concezioni antropomorfe della divinità, sintetizzabile nei suoi famosi versi: " ma se i buoi, i cavalli e i leoni avessero le mani, o potessero disegnare con le mani, e fare opere come quelle degli uomini, raffigurerebbero gli dei, il cavallo simili ai cavalli, il bue ai buoi, e farebbero loro dei corpi come quelli che ha ciascuno di loro ". E’ facile comprendere perché Platone scorgesse in lui l’archegeta dell’eleatismo: introducendo una sola divinità, Senofane finiva per proporre quell’unità tanto cara a Parmenide e ai suoi discepoli. Se è sbagliato propugnare l’antropomorfismo degli dèi, altrettanto sbagliato è, nell’ottica di Senofane, ritenere che la conoscenza divina sia paragonabile a quella umana: il sapere proprio della divinità è infatti incommensurabilmente superiore rispetto a quello umano, e gli uomini, nella migliore delle ipotesi, possono acquisire qualche certezza dopo aver percorso un faticoso itinerario conoscitivo; il tema della conoscenza come tortuosa via da percorrere sarà ripreso e approfondito da Parmenide stesso. Senofane dubitava fortemente che la divinità aiutasse gli uomini a conoscere, mettendo in questo modo l’accento sulla responsabilità umana della conoscenza: senza godere di aiuti divini, l’uomo è responsabile e artefice della propria conoscenza. Naturalmente, con la maggiore indipendenza dell’umano dal divino aumenta la fragilità della situazione umana, poiché gli uomini devono agire solo in virtù delle proprie forze, in quanto la divinità non ha fatto loro alcun dono (né le tecniche né il sapere). La prospettiva è piuttosto simile a quella di Alcmeone, ma diversa è la soluzione: se per il filosofo di Crotone agli uomini non restava che congetturare, secondo Senofane, invece, l’unica arma conoscitiva di cui essi dispongano è quella che egli definisce, introducendo un termine destinato al successo, >dokoV , l’opinione. La conoscenza umana è, dunque, essenzialmente opinione, nemmeno congettura; il termine "opinione" suggerisce, tra l’altro, l’idea di una instabilità del sapere umano, suscettibile di essere vero o falso. Ma Senofane lascia una via per sperare: agli uomini è infatti concesso di avanzare verso il meglio, verso cioè opinioni migliori: in un frammento, egli asserisce che " uno, Dio, tra gli dèi e tra gli uomini il più grande, né per aspetto simile ai mortali, né per intelligenza "; la superiore intelligenza della divinità, ovvero le superiori attività percettive e intellettive che la contraddistinguono, dice Senofane, sono tali perché coinvolgono la divinità nella sua totalità: gli uomini con un senso vedono, con un altro gustano, con un altro ancora odono, e così via, mentre la divinità non presenta, nella sua interezza, distinzioni sensoriali. Ciò non toglie, però, che, pur nella loro notevole inferiorità, gli uomini possano acquisire conoscenze via via migliori: " non è che in principio gli dèi abbiano rivelato tutte le cose ai mortali; ma col tempo, ricercando, essi trovano il meglio ". La conseguenza necessaria di questa riflessione è che, procedendo per opinioni, il sapere umano non potrà mai raggiungere certezze, ma solo, come abbiamo già detto, opinioni più accreditate di altre: " il certo nessuno mai lo ha colto, né alcuno ci sarà che lo colga né relativamente agli dèi, né relativamente alle cose di cui parlo "; sotto questo profilo, anche quando crediamo di dare una definizione esatta di qualcosa, in realtà ci muoviamo comunque nell’ambito dell’opinione: ciascuno di noi può esprimere a parole nel migliore dei modi ciò che qualcosa è, ma non per questo può conoscere con certezza, nel suo linguaggio, la cosa stessa. Anche Parmenide di Elea, maggior esponente dell’eleatismo, si propone di percorrere la via del sapere per raggiungere una forma di conoscenza quanto più precisa. Per meglio caratterizzare il proprio scopo, egli ricorreva alla metafora della via da percorrere e da seguire, inserendo questa concezione nei versi del suo poema >Peri fusewV ("Sulla natura"): proprio in quest’opera, attribuiva ad una dea il compito di illuminarlo e di guidarlo nel difficile itinerario che portava alla conoscenza; era anzi proprio l’ausilio della dea che gli permetteva di raggiungere la meta e, quindi, quella verità che sarebbe stata irraggiungibile percorrendo la via degli uomini comuni, ossia l’opinione. Come i suoi predecessori poeti, anche Parmenide ha un messaggio da trasmettere, poiché anche lui è interprete di un’illuminazione divina: il suo poema, dunque, alla pari di quello dei poeti ispirati dalle muse, contiene una verità divina, di cui il filosofo è portavoce; la grande novità, però, risiede nel fatto che Parmenide sia protagonista in prima persona e che la vicenda narrata altro non sia se non il viaggio (in greco >odoV ) che l’ha portato a scoprire la verità; la divinità si limita a mostrare al filosofo la via da seguire ed egli dovrà percorrerla contando esclusivamente sulle proprie forze. Parmenide stesso, in modo analogo, si limiterà ad indicare agli uomini la via da seguire e spetterà a loro scegliere se percorrerla o no. Il punto di partenza dell’indagine parmenidea è il rilevamento di un’evidente contraddizione: si vedono le cose di natura essere e non essere di continuo, ossia in un perenne divenire (ora ci sono, ora non ci sono), ma è soprattutto nel linguaggio, ancor più che nel mondo fisico, che possiamo rilevare la contraddizione; sono gli uomini, infatti, a parlare in modo contraddittorio delle cose e finchè questo approccio sbagliato non sarà superato si resterà nel mondo dell’opinione. La via dell’opinione è, per sua stessa natura, suscettibile di essere vera oppure falsa (la cosa ora è, ora non è) mentre l’unica via di ricerca che conduce alla verità è quella che dice che ciò che è è e non può non essere o, al contrario, che ciò che non è non è e non può essere. La contraddizione appena delineata scaturisce dall’ambito sensoriale, poiché siamo portati a vedere che, nell’ambito fisico, le cose ora ci sono, ora non ci sono, ovvero sono in costante divenire: la conoscenza sensibile è, dunque, la via dell’opinione. La vera via del sapere è quella che dice o che una cosa è o che non è, senza mediazione alcuna: al di là del dire "è" o "non è" non si può dire una terza cosa, secondo quel principio che in età medioevale sarà formulato come "tertium non datur". Sotto questo profilo, il divenire altro non è se non un’indebita mescolanza di essere e di non essere: una cosa ora è, ora non è. Va però precisato che, nei testi che ci sono pervenuti, Parmenide non specifica quale sia il soggetto di "è" e di "non è", ma, nonostante questa lacuna, il punto cardinale sta nel capire il carattere necessario di questa disgiunzione. Il filosofo di Elea distingue tra essere, pensiero, linguaggio: si può solo dire e pensare ciò che è, mentre non si può pensare o dire ciò che non è; pur non precisando il soggetto, Parmenide parla anche di "ciò che è" e di "ciò che non è", e sostiene che l’unica via percorribile è quella di dire ciò che è, poiché non è possibile imboccare la seconda strada, cioè dire o non dire ciò che non è. Ma la maggior parte degli uomini segue una terza via, quella che dice contemporaneamente "è e non è", parlando di nascita e morte e, dunque, supponendo un’assurdità: che l’essere nasca dal non essere. Uno dei problemi più sentiti (e presente in qualche misura anche in Parmenide) era rappresentato da come si potesse trarre inferenza dalle cose visibili a quelle invisibili; all’uomo, infatti, non risulta chiaro come sia fatto il mondo e perché sia fatto così, ma non è impossibile raggiungere questa forma di sapere: si tratta di andare al di là della molteplicità visibile per arrivare a cogliere uno o più princìpi capaci di spiegare in modo vero la struttura del mondo. Ed è a questo tentativo che si possono ricondurre le esperienze dei primi filosofi della storia(Talete, Anassimandro, Anassimene), i quali andavano alla ricerca di un misterioso >arch ("principio") in grado di rendere conto della struttura del mondo nella sua infinita molteplicità. Nel I libro della Metafisica, Aristotele presenta questi pensatori come primi filosofi della storia, distinguendoli dagli scrittori di miti, dai teologi e dai poeti perché essi per primi hanno investigato sul perché delle cose argomentando in maniera deduttiva. Mentre Talete e Anassimene muovono alla ricerca di un principio assolutamente fisico (e lo ravvisano, rispettivamente, nell’acqua e nell’aria), Anassimandro, invece, scorge quest’entità costitutiva primaria da cui tutte le cose si sono differenziate in un qualcosa di invisibile, non direttamente percepibile, che lui chiama >apeirov ("infinito"). L’idea, che sarà poi di Parmenide, secondo la quale non tutti gli uomini possono accedere al sapere era forte in Eraclito da Efeso: la consapevolezza della propria eccezionalità è attestata da alcuni aneddoti che confermano l’altezzosità di Eraclito, ma anche la sua oscurità espressiva. Aristotele stigmatizzava il suo stile, considerandolo oracolare e, quindi, indegno di un filosofo: il testo di Eraclito, in effetti, è molto ambiguo, volutamente ambiguo, poiché, a suo avviso, la verità non doveva essere facile da comprendere, ma, al contrario, richiedeva grandi sforzi. Esempio tipico di questo linguaggio di difficile comprensione è il frammento 1, che destò parecchi dubbi perfino in Aristotele: " di questo lógos che è sempre gli uomini non hanno intelligenza, sia prima di averlo ascoltato sia subito dopo averlo ascoltato […] ". Bastava infatti una virgola a stravolgere il senso dell’intera frase: Eraclito voleva dire "di questo lógos che è, sempre gli uomini non hanno intelligenza " oppure di questo lógos che è sempre, gli uomini non hanno intelligenza " ? Altrettanto ambiguo è il frammento 2, in cui troviamo scritto: " bisogna dunque seguire ciò che è comune. Ma pur essendo questo lógos comune ( >xunoV), la maggior parte degli uomini vive come se avesse un propria e particolare saggezza "; l’ambiguità sta nel termine "comune", che in greco troviamo espresso con il termine >xunoV ; infatti, se >xunoV significa "comune", >xun now significa "con l’intelligenza": dunque Eralicito forse vuole dire che gli uomini non hanno intelligenza di ciò che è comune, cioè il >logoV . Quest’ultimo termine, del resto, attorno al quale ruota tutta la filosofia di Eraclito, riveste una miriade di significati tutti compresenti: >logoV , infatti, è della stessa famiglia del verbo >legw, che significa "parlare" ma anche "raccogliere", "contare", "dare conto di"; e in epoche meno antiche passò anche a designare, in ambito matematico, il "rapporto", la "proporzione". Nella filosofia di Eraclito, il >logoV è espressione a livello linguistico di ciò che le cose sono (ed è appunto quel che troviamo negli insegnamenti di Eraclito stesso), ma è anche la ragione capace di rendere conto delle cose stesse e dell’ordine dell’universo. E la ragion d’essere che si esprime in questo >logoV è la dialettica tra gli opposti: nelle singole cose, nota Eraclito, sono presenti i contrari, in costante guerra tra loro; ed egli ci mostra questo conflitto tra opposti in diversi modi: nel frammento 48 dice che " l’arco ha dunque per nome vita e per opera morte ", in quanto il termine greco che designa l’arco ( >bioV ) è lo stesso che designa la vita; in modo assai simile, nel frammento 60 asserisce che " una e la stessa è la via all’in sù e la via all’in giù ". Anche Eraclito polemizza contro le opinioni degli uomini, accusandoli di fermarsi alle cose visibili senza riuscire a gettare uno sguardo all’invisibile e deridendoli per il fatto che essi prestano fede alla "multiscienza" ( >polumaqia), al sapere tanto molteplice quanto presunto delle cose. A questi uomini sfugge che " la natura ama nascondersi " e che l’armonia invisibile è migliore di quella visibile; ciononostante, Eraclito non nutre una radicale sfiducia nei sensi, ma, semplicemente, è convinto che essi, da soli, non siano sufficienti. Ed è per questo che ritiene opportuno prestare attenzione anche alla situazione in cui versano coloro che usano i sensi come unico mezzo di conoscenza: " per anime barbare i sensi sono cattivi testimoni ", dove i barbari sono, secondo Eraclito, coloro che non parlano il greco; essi si fidano dei loro sensi e, in questo modo, non riescono a comunicare con il >logoV. E’ dunque necessario spingersi oltre le barriere dei sensi per raggiungere, mediante le parole, il significato profondo delle cose stesse: chi, come i barbari, si arresta di fronte alla barriera sensoriale è da Eraclito accostato a chi è desto ma è come se dormisse (frammento 1: " agli altri uomini rimane celato ciò che fanno da svegli, allo stesso modo che non sono coscienti di ciò che fanno dormendo "). Quando si entra in contatto con ciò che è comune, allora si sveglia l’intelligenza e gli uomini si fanno intelligenti: " unico e comune è il mondo per coloro che sono desti " (frammento 89), mentre nel sogno ciascuno si rinchiude in un mondo che è solamente suo e a cui gli altri non hanno accesso. Resta ora da chiedersi che cosa si debba fare per entrare in contatto con il >LogoV comune: a tal proposito, Eraclito asserisce in modo significativo, nel frammento 101: " ho indagato me stesso "; solo chi indaga la propria persona, seguendo l’inscrizione presente sul tempio di Delfi >gnwqi sauton ("conosci te stesso"), può attingere al >LogoV comune, mentre gli uomini che non compiono quest’operazione " danno retta agli aedi popolari, si valgono della folla come maestra "; in quest’ottica, i molti non valgono nulla e a contare davvero sono i pochi. Eraclito se la prende anche con i sapienti (una delle prime polemiche della storia della filosofia), cui rinfaccia di imbandire una conoscenza che altro non è se non erudizione: " sapere molte cose ( >polumaqia ) non insegna ad avere intelligenza: l’avrebbe altrimenti insegnato ad Esiodo, a Pitagora e poi a Senofane e ad Ecateo " (frammento 40). Ad accomunare la via di ricerca intrapresa da tre filosofi diversissimi tra loro, Democrito, Anassagora ed Empedocle, è la convinzione che l’uomo possa conoscere a fondo la struttura dell’universo perché, in ultima istanza, egli è costituito dagli stessi elementi che compongono l’universo stesso: in altri termini, secondo la convinzione di questi pensatori, la similarità dell’uomo con il mondo gli permette di conoscerlo. Certo siamo di fronte a tre figure di sapiente non amalgamabili tra loro: vivono tutti a cavallo tra la prima e la seconda metà del V secolo a.C. Empedocle da Agrigento è, dei tre, il più giovane ma si configura, per molti aspetti, come il più anziano: è un sapiente eccezionale e la sua raffigurazione se la dà lui stesso, sostenendo che a conferirgli poteri fuori dal comune è il sapere di cui è detentore. Compose un’opera intitolata >Peri fusewV e una dal titolo Purificazioni: non è però ancor oggi chiaro se le Purificazioni fossero una parte del poema >Peri fusewV o un’opera indipendente. E del resto le due opere sono incommensurabilmente diverse: nel >Peri fusewV Empedocle si attiene al sapere fisico, nelle Purificazioni disserta di trasmigrazione delle anime e di colpe da scontare nelle reincarnazioni; ci troviamo dunque di fronte ad un Empedocle fisiologo contrapposto ad un Empedocle mistico. Le Purificazioni, dedicate ai migliori destinatari, si aprivano così: " o amici, che la grande città presso il biondo Acragante / abitate sul sommo della rocca, solleciti di opere buone, / porti fidati per gli ospiti, ignari di malvagità, / salve! Io tra voi come un dio immortale, non più mortale / mi aggiro fra tutti onorato, come si conviene, / cinto di bende e di corone fiorite. " Affiora chiaramente la concezione che Empedocle ha di se stesso: egli si propone come un dio immortale e dotato di poteri formidabili, preclusi ai più. La stessa tradizione ci ha descritto Empedocle come un indovino, profeta, medico, mago ed eroe: si racconta perfino che avrebbe richiamato in vita una donna che non respirava più da quaranta giorni (Galeno ne farà un caso di isteria più che di medicina). Eppure c’è un modo per conciliare le vocazioni poetiche, magiche, eroiche e mediche di Empedocle con la sua attenzione naturalistica: la filosofia così com’egli l’ha concepita l’ha portato a comprendere la struttura profonda dell’universo, penetrando quell’invisibile inaccessibile agli altri uomini; con la conseguenza che, secondo il filosofo agrigentino, solamente chi conosce l’universo può intervenire in termini pratici su di esso. Intorno alla figura di Empedocle circola un pulviscolo di aneddoti che hanno fatto quasi sfumare nella leggenda il personaggio: per esempio si narra che egli avesse arrestato il soffiare dei venti portatori di pestilenza ad Agrigento (e per questo fu detto "carceriere dei venti") o che si fosse gettato nell’Etna per dimostrare la propria immortalità divina. La convinzione di fondo che sta alla base della sua filosofia è, come abbiamo detto, la credenza che si possa conoscere il mondo perché siamo costituiti dai suoi stessi elementi: a tal proposito, egli rintraccia quattro "radici" ( >rizwmata ), ovvero quattro elementi fondamentali che compongono l’universo (acqua, aria, terra, fuoco) e legge il processo conoscitivo in chiave di attrazione del simile verso il simile. Il simile che è nelle cose riconosce il simile che è in noi, cosicchè il simile conosce il simile: ciò tuttavia non significa che la conoscenza si risolva in un processo di assimilazione, quasi come se l’uomo rendesse simili a sé gli oggetti. Viceversa, spiega Empedocle, ciascuno di noi è dotato di minuscoli pori da cui entrano flussi di materia provenienti dai corpi estranei (per attrazione del simile sul simile): riusciamo a riconoscere cosa sta fuori di noi perché noi stessi siamo costituiti dai medesimi quattro elementi. Sorge spontanea la domanda: e con che strumento avviene, concretamente, la conoscenza? Con i sensi: Empedocle non dubita della loro validità come mezzi gnoseologici, ed è consapevole che non sia facile cogliere la verità; l’errore più grave che si possa commettere (e che, di fatto, si è inclini a commettere) è di privilegiare un senso specifico trascurando gli altri: al contrario, tutti e cinque i sensi hanno pari dignità e ciascuno di essi avvalora ciò che testimoniano gli altri, sicchè tutto il nostro corpo è coinvolto nella conoscenza, la quale avviene, ad avviso di Empedocle, in tempi molto lunghi e con difficoltà consistenti. La verità che il pensatore agrigentino vuole trasmettere è racchiusa nelle parole da lui pronunciate: il suo linguaggio, dunque, è il linguaggio della verità, latore di un messaggio salvifico che redime dalla colpa originaria che ciascuno di noi sconta nella vita attuale. Ma è assai difficile persuadere la mente umana, perché essa è infestata da credenze che si fermano al sensibile ed Empedocle in persona prega Dio affinchè lo liberi da questa prigionia, dalla " follia " in cui sono immersi gli uomini comuni; ed è appunto per differenziarsi da costoro che egli impiega un linguaggio innovativo. Nella storia della filosofia antica si fa sempre più strada l’idea che la vera conoscenza attinga alla profondità delle cose, non alla loro parvenza: in questa prospettiva si muove già, come abbiam visto, Empedocle, ma non è il solo; acccanto a lui, anche Democrito e Anassagora intraprendono, entrambi nel V secolo a.C., la stessa via. Anassagora , proveniente dalla Ionia e, in particolare, dalla città di Clazomene (situata nell’attuale Turchia), riveste un’importanza particolare perché con lui il pensiero antico sbarca ad Atene, città che, da quel momento per parecchi secoli, costituirà il fulcro della vita intellettuale. Ad Atene giungeranno pensatori e uomini di cultura da tutto il mondo: grandi poeti tragici (Sofocle, Euripide), grandi commediografi (Aristofane) e illustri medici (Ippocrate). Il trasferimento di Anassagora ad Atene segna poi la fine del naturalismo ionico: da quel momento la filosofia cambia modi e oggetti, abbandonando l’indagine sulla ricerca del principio. Non bisogna dimenticare che quando Anassagora approda ad Atene, proprio in tale città Socrate stava cominciando la propria formazione (nel "Fedone", Platone ci riferisce che Socrate ebbe modo di leggere e di criticare Anassagora). Anassagora, dunque, è l’ultimo ad occuparsi, in senso stretto, di studi della natura, poiché con Socrate la filosofia cambia oggetti di riflessione e si trasforma in riflessione sui >logoi , sui discorsi e sui valori umani. Anassagora riveste un ruolo di rilievo anche perché fu uno dei primi pensatori della storia ad essere condannato di empietà (condivideranno una sorte analoga anche Socrate e Protagora) per le idee rivoluzionarie di cui si faceva portavoce: giusto per addurre un esempio, la sua convinzione che gli astri fossero costituiti da terra e il sole da fuoco non poteva che suscitare lo sdegno dei benpensanti che leggevano in essi la presenza divina. Per Empedocle gli elementi costitutivi dell’universo erano di numero limitato (quattro radici) ed erano abbinati a delle divinità; ora, per Anassagora alla base della realtà non stanno quattro radici, ma un numero infinito di princìpi , poiché l’infinita varietà della realtà non può spiegarsi se non postulando una serie infinita di princìpi che, associandosi o disgregandosi, danno origine alla composizione o alla dissoluzione dei corpi. Anassagora, per rendere più concreto il discorso, ricorreva ad una metafora di stampo biologico: chiamava "semi" i suoi princìpi, con un evidente riferimento alla generazione animale e vegetale tramite i semi. Tali semi stanno a principio di ogni generazione, sono infiniti di numero, ma anche infinitamente divisibili: infatti, dice Anassagora, per quanto li si possa suddividere, non si arriva mai ad un punto ultimo non ulteriormente divisibile. Anassagora ne traeva la conseguenza che " tutto è in tutto ": gli uomini mangiano un singolo pezzo di pane e crescono le loro unghie, i loro capelli, ecc., perché nel pane stanno nascosti i semi di tutte le cose (quindi anche dei capelli, delle unghie, ecc.); sorge spontaneo chiedersi perché, stando così le cose, non si vedano tutti i semi ma solo un pezzo di pane. La risposta di Anassagora è che tutti i semi che costituiscono il mondo sono compresenti nel pezzo di pane, ma sono invisibili perché troppo piccoli e troppo pochi rispetto ai semi del pane; sicchè vedo questi ultimi proprio in virtù del fatto che sono in stragrande maggioranza. Questa prospettiva può essere compendiata nel detto: " >oyiV adelwn ta fainomena , "le cose che appaiono sono uno sguardo sulle cose oscure", con l’idea che ciò che appare alla vista consente empiricamente di gettare uno sguardo su ciò che non si vede. Il punto di partenza, anche per Anassagora, resta il visibile: sul piano gnoseologico, questo consente di affermare che la conoscenza procede per inferenze, ovvero si parla di ciò che non si vede a partire da ciò che invece si vede. Ma il sapere umano, secondo Anassagora, procede gradualmente e l’esperienza costituisce solo il primo e il più basso, nonché il più immediato, gradino della scala conoscitiva, gradino sperimentabile con facilità da tutti quanti; ma al di là di questo livello base si colloca la memoria, formata dal ripetersi delle esperienze. Essa restringe la conoscenza al solo ambito umano, precludendola a tutti gli altri esseri. Anassagora, poi, faceva nascere dalla memoria il terzo gradino, quello della >sofia (sapienza), in riferimento alla sua dimensione teorica: la >sofia altro non è se non il sapere puro, meramente intellettuale. E al gradino più alto della sua scala gnoseologica, il pensatore di Clazomene collocava quella che a suo avviso era la conoscenza superiore a tutte le altre: la >tecnh , il sapere tecnico. Dopo aver distinto nettamente il sapere ( >sofia) dal saper fare ( >tecnh) in virtù del fatto che la "tecnica" implica il risvolto pratico della conoscenza, Anassagora predilige il saper fare rispetto al puro e semplice sapere, perché convinto che l’uomo riveli la propria grandezza conoscitiva quando produce oggetti. Anzi, a rigore, l’applicare ciò che ha appreso all’attività pratica è ciò che più contraddistingue l’uomo dagli altri animali: la supremazia dell’uomo sul mondo è, in quest’ottica, determinata dal possesso delle mani. Stando a quel che ci riferisce Aristotele, Anassagora sostiene che l’uomo è il più intelligente fra gli animali perché è dotato delle mani; dal canto suo, Aristotele capovolge l’asserto anassagoreo e arriva a dire (in una prospettiva finalistica) che l’uomo ha la mano perché è il più intelligente fra gli animali. Anche Democrito di Abdera procede in direzione piuttosto simile ad Anassagora: anche a suo avviso la conoscenza è possibile grazie alla similarità tra l’uomo e gli oggetti del suo sapere, ed è altresì convinto che la conoscenza giaccia in profondità e sia raggiungibile per inferenza a partire dal visibile. Democrito è passato alla storia, insieme al suo maestro Leucippo (di cui sappiam pochissimo), per aver gettato le basi dell’atomismo: con lui, con Anassagora e con Empedocle il problema della conoscenza diviene un problema assolutamente fisico; infatti, per Empedocle il simile attira il simile (sento il calore di un oggetto perché il calore è già presente in me), per Anassagora è il dissimile che conosce il simile (conosco il caldo in virtù del fatto che so cosa sia il freddo, attraverso una compenetrazione degli opposti); il chiamare in causa l’anima nel processo conoscitivo arriverà solo un po’ di tempo dopo. La dottrina atomistica, così come viene formulata da Democrito, ha degli sviluppi grazie ad Epicuro e a Lucrezio, anche se, in realtà, i tratti generali che la contraddistinguono restano pressochè invariati: ciò che più colpisce di tale dottrina è la sua marcata economicità, grazie alla quale con una sola ipotesi si spiegan tutti i fenomeni esistenti. Nella ricerca della chiave di lettura della perennità dei movimenti di generazione e corruzione (evitando però l’inganno eleatico della negazione del divenire), questi tre pensatori (Empedocle, Democrito, Anassagora) tendono a postulare una molteplicità di princìpi (per questo sono spesso chiamati "pluralisti") in base ai quali spiegare tali processi di aggregazione e disgregazione: i princìpi considerati da Empedocle sono le "radici", quelli di Anassagora i "semi" e quelli di Democrito sono gli "atomi", accomunati dal fatto di essere un "sostrato" (la definizione è di Aristotele) che non muta mai e garantisce in eterno la generazione e la corruzione. Come si dimostra l’esistenza degli atomi? Osservando le cose che continuamente divengono sotto ai nostri occhi: nell’aggregarsi e nel disgregarsi costante cui vanno incontro le cose, ci dovrà pur essere qualcosa che non muta mai, altrimenti le cose e, in generale, il mondo si sarebbe già disgregato da tempo; questo qualcosa sono, secondo Democrito (e secondo Epicuro, che si avvarrà di questa dimostrazione) gli atomi ( >aqumoi), strutture che non possono essere divise e che quindi sono totalmente "piene"; essi sono l’ultima parte che resta quando si divide un corpo fino ai suoi elementi di base; se i "semi" di Anassagora erano infinitamente divisibili, gli atomi democritei non lo sono (Leibniz avrà da ridire con la nozione così intesa di atomo), perché se lo fossero allora sarebbero composti da parti e quindi sarebbero soggetti alla corruzione e all’aggregazione. Accanto agli atomi, Democrito introduce la nozione di "vuoto", che deve necessariamente essere postulato come condizione per il movimento degli atomi: se infatti tutto fosse "pieno", gli atomi non avrebbero spazio in cui muoversi e l’aggregazione e la disgregazione non potrebbero avere luogo; ma i sensi ci testimoniano il contrario, per cui è necessario postulare il vuoto. E’ curioso il fatto che, influenzato dall’eleatismo, Democrito chiamasse gli atomi e il vuoto, rispettivamente, "essere" e "non essere", parlando a livello fisico di ciò che per Parmenide era a livello puramente logico. Gli atomi non sono infinitamente divisibili, ma sono di numero infinito: il che comporta importantissime conseguenze; prima fra tutte, il fatto che siano infinitamente aggregabili, ovvero possono dare vita a infinite combinazioni e, di conseguenza, a infiniti mondi. In secondo luogo, di vuoto se ne parla in due accezioni: c’è un vuoto esterno (condizione di movimento per gli atomi); ma anche nelle strutture che si formano dall’aggregarsi degli atomi vi sono parti vuote e ciò è attestato dal fatto che la struttura dei corpi è suscettibile di trasformazioni: la struttura dell’animale è indubbiamente compatta, eppure cresce (ovvero assume materia) e invecchia (cede materia), e questo si spiega solo in base al movimento degli atomi all’interno di questa struttura. Dunque ci deve essere il vuoto anche all’interno dei composti di atomi. Asserendo che tutto è costituito da atomi, Democrito presuppone la similarità di struttura tra il soggetto conoscente e l’oggetto conosciuto: tutta la conoscenza, dunque, è riconducibile ad una forma di sensazione e l’anima stessa è un composto di atomi cosicchè la conoscenza di cui essa è artefice avviene per aggregazione. Aristotele, nel "De anima", ci riferisce che per Democrito l’intelligenza è legata alla presenza di atomi ignei nell’anima, caldi e velocissimi e, dunque, idonei per spiegare la velocità del pensiero. Nell’ottica democritea, non c’è differenza di livelli di conoscenza, tutto è percezione (persino gli oggetti del pensiero): dal cielo alla terra non ci sono che corpi costituiti da atomi e contenenti il vuoto e che (proprio perché contenenti il vuoto) emanano gli >eidwla, le "immagini" delle cose; tali >eidwla altro non sono se non atomi che si staccano continuamente dai corpi (Epicuro parla di pulsazione dei corpi stessi) e si rendono così a noi percepibili. Anche il corpo del soggetto percipiente, infatti, è un aggregato atomico dotato di vuoto o, meglio, di canali vuoti: gli >eidwla si incuneano in questi canali vuoti e rispecchiano l’immagine dell’oggetto rendendolo percepibile: si ha dunque una conoscenza per contatto. Ricapitolando, la conoscenza avviene per percezione (sensismo gnoseologico) e quest’ultima avviene per contatto attraverso i cinque sensi e, se non ci fosse il vuoto, la percezione sarebbe dolorosa perché gli >eidwla colpirebbero i nostri atomi anziché infilarsi nei canali vuoti. Tuttavia, se i corpi continuano a cedere materia (gli >eidwla che si staccano), allora ne consegue che essi sussistono fin tanto che la materia ceduta è bilanciata da quella ricevuta: e la mancanza di respiro, ovvero la fine del ricambio di atomi, è la prova della fine dell’esistenza del corpo. La legge che vige nel mondo degli atomisti è il caso, nel senso che non vi è alcuna causa extranaturale capace di governare il movimento degli atomi: essi si aggregano in maniera puramente casuale (ed è anche per questo che Dante rinfaccia, nel IV canto dell’Inferno, a Democrito di porre il mondo a caso). Naturalmente sorge spontaneo un quesito: che cosa mi garantisce che gli >eidwla mi riportino tale e quale la forma dell’oggetto a cui provengono? Non potrebbe essere che, nello spazio che percorrono per giungere a me, subiscono una modificazione? Qui le posizioni degli atomisti divergono: Epicuro pensa che gli >eidwla ci raggiungano con velocità pari a quella del pensiero, cosicchè non vi è possibilità di errore. Per Democrito, invece, tutto cambia: " nulla conosciamo secondo verità perché la verità è nel profondo ", egli afferma; sembra quasi una professione di scetticismo, ma in realtà non lo è affatto. Infatti, Democrito vuol semplicemente dire che la verità sono gli atomi e il vuoto e che tutto il resto (il dolce, l’amaro, il caldo, il freddo, ecc) è opinione che, in quanto tale, è suscettibile di essere vera o di essere falsa e che varia da individuo a individuo. Democrito si accosta dunque al motto di Anassagora " >oyiV adelwn ta fainomena ": il mondo che mi appare è opinione, e anche le opinioni si formano in base alla percezione, anche se si fermano alla superficialità, alle qualità esterne del corpo (caldo, freddo, ecc). In quanto frutto di sensazioni, anche le opinioni hanno un fondo di verità, anche se l’unica verità degna di essere definita tale è quella che si conosce quando si conoscono il vuoto e gli atomi. " Non conosciamo nulla che sia invariabile, ma solo aspetti mutevoli ", dice Democrito: e ne deduce l’esistenza di due forme di conoscenza, una genuina ("legittima", secondo il linguaggio giuridico), l’altra oscura ("illegittima"): la conoscenza sensibile è oscura, mentre gli oggetti di quella genuina sono nascosti. Nel V secolo anche i Pitagorici si interrogano sul problema conoscitivo prospettando soluzioni diversissime da quelle avanzate dai loro contemporanei: anch’essi rinviano ad una struttura profonda delle cose, costituita però non da semi, da radici o da atomi, ma dai numeri. Filolao di Crotone sostiene che la vera conoscenza delle cose deriva dal fatto che esse sono esprimibili in numeri: per noi essi sono entità astratte, ma i Pitagorici ne avevano una concezione fisico-spaziale e li rappresentavano con sassolini. I numeri consentono di delimitare sezioni spaziali e lassi di tempo, il che significa che le cose stesse hanno numero ed esso non può essere uno schema arbitrario imposto alle cose, ma, viceversa, sono le cose stesse a manifestare una forma di numero che le rende conoscibili ed esprimibili: possono essere contate e distinte le une dalle altre in base alla loro struttura componente elementare. Sono i numeri che conferiscono alle cose forme e strutture, conoscibili appunto attraverso relazioni numeriche: esse per Filolao si configurano come armonia, con un evidente richiamo alla musica. La conoscenza, quindi, consiste nella ricerca dei rapporti esistenti nelle cose, poiché, come dice Filolao, " tutte le cose che si conoscono hanno numero; senza numero non sarebbe possibile pensare o conoscere alcunchè. […] ma la natura del numero e la sua grande potenza […] le si vedono anche in tutte le attività degli uomini "; le stesse azioni divine sono numerabili, poiché " nel numero non penetra menzogna ". Il numero diviene lo strumento di conoscenza della verità: Archita di Taranto segue la stessa strada di Filolao e in particolare mette in luce la funzione fondamentale del numero per una nutrita serie di discipline, fra cui troviamo anche l’astronomia e la musica, il che è interessante perché si tratta della prima attestazione dell’esistenza di scienze "speciali" all’epoca. L’impostazione matematizzante delle scienze di Archita viene curiosamente ripresa da Platone nella "Repubblica", in cui la matematica e la musica rivestono un ruolo assolutamente centrale nell’educazione dei giovani; tutte queste scienze Archita le chiamava "sorelle", perché figlie di un unico padre, il numero. Quest’ultimo costituisce la chiave d’accesso generale per conoscere le realtà particolari. Ma a quei tempi, accanto ai matematici come i Pitagorici, troviamo anche parecchi medici: ed è nei trattati ippocratei che il metodo della medicina viene teorizzato in modo completo; anche i medici, come i filosofi, partono dal visibile, in particolare dai sintomi delle malattie, e per inferenza sono in grado di risalire, con la sola forza del ragionamento, alle cause nascoste delle malattie e, in base a ciò, propongono terapie in grado di debellarle. Non tutti, però, concordavano nell’imputare a cause generali l’origine delle malattie: c’era anche chi restava saldamente ancorato alla sfera dell’esperienza, senza operare inferenze di alcun tipo; è questo il caso dell’anonimo autore di un trattato su "La medicina antica" (risalente al 430-415 a.C.). Il pubblico a cui si rivolge questo autore non è costituito esclusivamente da medici: il messaggio centrale che egli vuole trasmettere è che la medicina sta assumendo uno statuto ontologico autonomo e di scienza. La medicina può perfezionarsi solo col tempo e lo scritto si schiera contro ogni medicina "filosofica", che pretende cioè di insegnare il mestiere ai medici a partire da teorie generali sull’uomo e sul mondo: ciò implica un eccesso di generalità che le rende inutilizzabili, giacchè i filosofi ( >sofistai) non spiegano il rapporto dell’universale col particolare. Non a caso l’autore etichetta queste teorie come "ipotesi", ossia come supposizioni di come stanno le cose, ipotesi a partire dalle quali avanzano la pretesa di aver scoperto chiavi di lettura valide per tutti; e l’autore scaglia i suoi dardi contro Empedocle e contro gli altri pensatori dell’epoca. Il medico, a differenza del filosofo, può rivendicare di dare il bene reale agli uomini: molto marcato è il senso della scoperta della medicina e della sua autonomia indiscutibile, la sua capacità di fare scoperte cosicchè anche " il resto nel futuro sarà scoperto "; non ci si deve, pertanto, fermare alle scoperte fatte, ma bisogna adoperarsi per farne di nuove e questo è possibile solo se le generazioni future faranno tesoro del sapere accumulato dai loro predecessori. Coi profani si deve solamente discutere dei mali che affliggono l’uomo e loro stessi: in quest’ottica, è importantissima l’anamnesi, ovvero la ricostruzione mediante il colloquio col paziente del male passato per costruire il male presente e l’evoluzione che la malattia avrà nel futuro. Questa metodologia non è propria solo dei medici: anche gli storici, in una certa misura, partono dalla convinzione che per prevedere il futuro si debba conoscere bene il passato, perché ciò consente di formulare delle costanti. Ma come è nata la medicina? E’ un sapere naturalissimo, risponde l’anonimo autore del trattato: il momento in cui uomini illuminati si interrogarono se chi soffriva dovesse seguire lo stesso regime alimentare di chi era sano fu la causa scatenante di tale disciplina, nata, in fin dei conti, per la naturalissima esigenza di sopperire alle malattie dell’uomo, necessità ineliminabili. Il passaggio dallo stato ferino alla civiltà sta, ad avviso dell’autore, nella scoperta del fuoco e nella cottura dei cibi. Proprio così si scopersero quali cibi erano utili e quali no: il sapere medico è nato nel momento in cui l’uomo è passato ad uno stato "umano" e al progresso della condizione umana è legato quello della disciplina medica. Non c’è da meravigliarsi se i primi scopritori di quest’arte erano visti come divinità, anche se, in realtà, erano uomini che esercitavano una tecnica tipicamente umana. Ma addirittura per sapere cosa è la natura è necessario partire da studi di medicina: il medico sa cosa è l’uomo e lo deduce da ciò che l’uomo mangia e beve, studiandone la salute e la condotta di vita; medico non è, dunque, chi dice che il formaggio è un cibo cattivo, ma chi dice che il formaggio è cattivo perché genera questi determinati mali. Ma la tematica della ricerca del sapere non è solo in filosofia: nell’ "Edipo re" vengono posti a confronto alcuni tipi di sapere ed in particolare emerge la congetturalità del sapere umano: la verità nascosta nell’Edipo è la scoperta di chi è il colpevole dell’ efferato omicidio di Laio, vecchio re di Tebe, città in cui ora infuria la peste come punizione divina per tale uccisione. All’inizio della tragedia Edipo si pone, come un detective, sulle orme dell’assassino e presenta la sua ricerca come quella dei cani sulle orme della selvaggina, mosso dalla responsabilità verso la città e verso i suoi concittadini. Egli segue indizi nella sua indagine: le testimonianze di chi ha visto o sentito qualcosa dell’accaduto; e chiede anche il responso dell’indovino Tiresia, detentore di un sapere ispirato dalle divinità: fuor di metafora, ciò significa che il sapere umano può far appello al sapere divino, capace di padroneggiare tutte le cose. Tiresia viene invitato a trarre gli auspici dal volo degli uccelli e viene riconosciuta la possibilità di errore della divinazione, la quale avviene non già in base ad un ragionamento, bensì su diretta ispirazione divina. Tiresia manifesta una certa paura perché mostra di conoscere gli uomini: e infatti Edipo, dopo aver udito il suo responso, lo accusa di aver congiurato contro di lui; in questa prospettiva, affiora come la verità porti anche dei mali. " Aih, trasparente ( >diafanhV ) verità! ", grida Edipo dopo aver appreso di essere stato lui l’uccisore del padre. Il V secolo a.C. è un’epoca di grande fermento intellettuale, in cui si intensificano i rapporti con culture diverse da quella greca: protagonisti di questa nuova stagione culturale sono i Sofisti, che di fronte alla diversità di costumi e tradizioni in cui si imbatte la civiltà greca propongono la relatività (già presente, in qualche misura, in Senofane), un modo di riconoscere a ciascuna di queste culture un’autonomia e una dignità. Questo nuovo modo di vedere è anche dovuto al fatto che in questo periodo si comincia a viaggiare con maggior frequenza e si entra in contatto con nuove culture, pur non mettendo da parte il greco-centrismo. Anche gli storici rappresentano bene questa nuova fase della storia greca: essi si basano soprattutto sull’autopsia, trasmettono cioè ciò che han visto loro stessi, ma accanto alla centralità della vista viene riconosciuta anche l’importanza dell’udito, ossia si presta importanza a ciò che si sente ma non si è visto. L’abilità dello storico risiede nel ponderare le fonti e le notizie: caso lampante è quello di Erodoto, le cui "Storie" non sono solo cataloghi di usi e costumi di popoli remoti. In questo scenario si colloca la figura di Protagora di Abdera, inauguratore della prassi dei viaggi e del movimento sofistico: in origine il termine "sofista" significa semplicemente "possessore della >sofia "; fu da Platone e Aristotele in poi che assunse una sfumatura negativa, in quanto essi rinfacciavano ai sofisti il fatto che essi vendessero il sapere come una qualsiasi altra merce. Proprio sulla nozione di relatività era incentrata la più famosa delle tesi di Protagora, trasmessaci da Platone nel "Teeteto" (dialogo dedicato a cosa significhi conoscere) : " l’uomo è misura di tutte le cose, di quelle che sono in quanto sono e di quelle che non sono in quanto non sono ". Questa frase, per l’impiego del termine "sono" e "non sono", sembra inquadrarsi in un contesto vivamente eleatico, anche se viene prospettato chiaramente il criterio per distinguere l’essere da non essere: è l’uomo il metro di misura, sicchè Protagora propone un criterio di conoscenza puramente soggettivo. Resta però da chiedersi che cosa intende il sofista di Abdera per "uomo": egli, probabilmente, non alludeva all’umanità considerata nel suo insieme, ma al singolo uomo nella sua immediatezza e nella sua soggettività; tutto questo rimanda, naturalmente, alla soggettività della verità. Sarà vero ciò che a me appare tale; viceversa, per lui sarà vero ciò che a lui appare tale, e così via. La conoscenza, in questo panorama, si riduce al sensismo: cosicchè il miele appare dolce a chi è sano, ma amaro agli ammalati. Tuttavia, in questo groviglio di verità ciascuna diversa dalle altre e ciascuna non meno valida delle altre, Protagora elabora un criterio per stabilire quale opinione (quella del sano che sente dolce il miele, o quella del malato che lo sente amaro?) sia migliore: tale criterio è incentrato sull’utilità e si risolve, per tornare all’esempio del miele, nell’interrogativo se sia migliore l’opinione di chi è malato o di chi è sano. Naturalmente, si risponderà che è migliore l’opinione del sano, anche se, ad onor del vero, sul piano gnoseologico tutte le opinioni sono equivalenti: le sensazioni si traducono in conoscenza, cosicchè la mia opinione, la tua, la sua e così via sono tutte vere, poiché l’uomo è misura di tutte le cose. Contro questa posizione protagorea si schiererà Platone che, nel Teeteto, smonterà l’argomentazione protagorea facendo notare che, se tutto è vero (come asserisce Protagora), allora è anche vero che esistono tesi false; e dato che, appunto, tutto è vero, è anche vero che ciò che dice Protagora è falso. Sempre in ambito sofistico, in quegli anni Gorgia di Lentini giungeva a conclusioni diametralmente opposte a quelle del collega di Abdera: nel suo scritto "Del non essere", egli sosteneva che nulla è, se anche fosse non sarebbe conoscibile, se anche fosse conoscibile non sarebbe comunicabile. La verità, dunque, resta per Gorgia inaccessibile: ne consegue che tutto è falso, e non "tutto è vero", come invece credeva Protagora. Tutte le proposizioni possono, ad avviso di Gorgia, essere ribaltate attraverso l’arma del >logoV (la parola), equiparato dal pensatore di Lentini ad una forza irresistibile alla pari del destino dei tragici o della divinità: la parola può tutto. Anche con Gorgia Platone, a cui stava particolarmente a cuore la possibilità di distinguere il vero dal falso, compie un’operazione simile a quella operata nei confronti di Protagora: se tutto è falso, cosa ci vieta di pensare che anche ciò che dice Gorgia lo sia? Ci si è spesso interrogati se Gorgia fosse un nichilista ante litteram o se, piuttosto, volesse esercitarsi con argomentazioni dialettiche al limite del pensabile. E’ tuttavia certo che l’obiettivo polemico del suo argomentare fosse l’eleatismo: egli si serve, nelle sue argomentazioni, della dimostrazione per assurdo; in altri termini, per dimostrare la verità di A, assume per assurdo che sia vero il contrario (non-A) e, a partire da tale assunzione, si mettono in luce tutte le contraddizioni che ne derivano, a tal punto che si è costretti a riconoscere la falsità di tale assunto (non-A) e ad ammettere la veridicità della tesi di partenza ad essa opposta (A). Le tre proposizioni poc’anzi elencate con cui nega la possibilità della conoscenza non è un caso che ci vengano riportate da uno scettico, Sesto Empirico, nell’opera "Contro i dogmatici". Stando a quanto da lui riportato, Gorgia avrebbe sostenuto che se le cose pensate non sono esistenti, allora le cose esistenti non sono pensate: in altri termini, il pensiero non avrebbe un contenuto proprio (poiché ciò che è pensato non esiste) e, per converso, se ne ricaverebbe che ciò che esiste non è pensato. Alla base di quest’argomentazione sta una relazione che Gorgia pone: se A è in relazione con B, allora anche B è in relazione con A; se viceversa A non è in relazione con B, allora anche B non è in relazione con A. Dunque, dato che penso cose che non esistono (dragoni o uomini volanti), allora ciò significa che il pensato non è in relazione con l’essere e, per converso, che l’essere non è in relazione col pensato. Ammettendo, infatti, per assurdo l’esistenza delle cose pensate, ne conseguirebbe che l’uomo che vola o il carro che procede sul mare (tutti oggetti del mio pensiero) dovrebbero esistere, ma l’esperienza confuta ciò. Se poi dico che il pensiero rispecchia l’esistente, non si spiega perché nel pensiero trovino cittadinanza anche l’uomo che vola o il carro che procede sul mare. Il terzo argomento addotto da Gorgia poggia sull’analogia con l’esperienza: giacchè i sensi non interferiscono tra loro né si smentiscono a vicenda, si può essere spinti a credere che ciò valga anche per il pensato, cosicchè le cose che né vedo né sento né tocco, ciononostante il pensiero mi attesta che esistono. Ma in questo modo mi troverei costretto, ancora una volta, ad ammettere l’esistenza dell’uomo che vola e del carro che procede sul mare. Con Gorgia, quindi, viene per la prima volta messa in discussione la possibilità di conoscere alcunchè. Come nota acutamente Cicerone, con i Sofisti e con Socrate la filosofia viene riportata dal cielo alla terra, alla dimensione più squisitamente umana. Proprio con la figura enigmatica di Socrate ci si trova di fronte ad un problema imbarazzante: egli non ha scritto nulla, ma su di lui son state scritte intere opere. La testimonianza generalmente più accreditata è quella di Platone, anche se la statura filosofica di questo pensatore costituisce un nuovo dilemma: nelle opere in cui egli parla di Socrate, come si fa a distinguere il pensiero effettivamente attribuibile a Socrate da quello invece proprio di Platone? Ci sono dialoghi platonici, soprattutto quelli più "datati", in cui la figura di Socrate è centralissima e ciò ci induce a pensare che Platone si limitasse a riportare fedelmente il pensiero del suo maestro; nei dialoghi scritti nella maturità e nella vecchiaia, invece, la figura di Socrate tende a sfumare e a farsi depositaria del pensiero platonico. Ma, a monte di questo problema, ci si deve anche chiedere: perché Socrate non ha scritto nulla? Nel "Fedro", Platone presenta ciò come una libera scelta di Socrate, il quale avrebbe puntato tutte le carte della filosofia sull’oralità a scapito della scrittura. Socrate, poi, ha scelto di occuparsi esclusivamente di valori umani, respingendo l’indagine sulla natura tanto cara ai suoi predecessori: sempre nel "Fedro" viene ampiamente descritto un paesaggio idilliaco e Socrate, di fronte a questo incantevole scenario, dice di voler tornare in città, poiché gli alberi, a differenza degli uomini, non hanno nulla da insegnargli. Nel "Fedone", poi, Platone ripercorre l’itinerario culturale di Socrate: da giovane egli si era interessato di natura, finchè non si era imbattuto nel libro di Anassagora, dal quale era rimasto deluso a tal punto da dover intraprendere una "seconda navigazione" attraverso la quale fondare la dottrina delle idee. Dall’ "Apologia", scritto platonico nel quale vengono descritti gli atti del processo in cui è imputato Socrate, quest’ultimo ci viene presentato come il filosofo del non sapere: egli si professa ignorante e confessa che l’unica cosa di cui è a conoscenza è la propria ignoranza. Eppure ai suoi amici l’oracolo di Delfi aveva sentenziato che Socrate era l’uomo più sapiente: proprio a partire da ciò egli aveva avviato la propria indagine, demandando così l’origine della propria investigazione ad una forza soprannaturale. Questo è particolarmente significativo se teniamo presente che uno dei capi d’accusa che gravavano su Socrate era l’aver introdotto da parte sua delle divinità sconosciute. Proprio a partire da questo, Socrate, uomo tra gli uomini, non si era accontentato del responso e si era voluto accertare che l’oracolo avesse detto la verità. La sua è dunque un’indagine sulla verità cui non sfuggono neppure le forze divine; il suo è un procedere assolutamente empirico, poiché egli decide di far visita agli uomini comunemente ritenuti sapienti per constatare se essi davvero lo siano e di quanto più di lui: l’investigazione, cominciata " contro voglia ", lo porta dai politici (detentori di un sapere competente quale è l’amministrazione della cosa pubblica), dagli indovini e dagli artigiani; Socrate li sottopone ad esame per appurare se il loro è un sapere, e non tarda a scoprire che, in realtà, il loro è un sapere settoriale che essi presentano come totalizzante. Come Socrate stesso dice, nell’ "Apologia", " da parte mia ero consapevole di non sapere nulla ": egli pone domande e attende le risposte dai suoi interlocutori; il metro di misura è rappresentato dalla capacità che essi hanno di rispondere senza contraddirsi: è proprio nello scambio di domande e risposte intentato da Socrate che risiede quella che Platone ha definito "dialettica", ovvero, letteralmente, "discorso che va di qua e di là" ( >dia + >logoV ) . Naturalmente, tutto questo presuppone la disponibilità degli interlocutori a farsi interrogare: sul concludersi di alcuni dialoghi platonici troviamo gli interlocutori seccati dalle domande di Socrate, punzecchianti come un tafano, poiché esse mettono in crisi tutte le convinzioni di cui ciascuno di noi è imbevuto. Socrate, nel formulare le sue domande, adotta un metodo di carattere generale e universale: egli chiede ai suoi interlocutori "che cosa è x?" ( >ti estin;), dove x sta per il coraggio, l’amore, la virtù, ecc; ma gli interlocutori finiscono per dare sempre a Socrate risposte particolari, senza mai cogliere l’universale (del coraggio, dell’amore, della virtù, ecc). Ecco perché si tratta di dialoghi aporetici, che si concludono con un nulla di fatto, irrisolti. Nel "Lachete", ad esempio, tutti credono di sapere con certezza cosa sia il coraggio, ma Socrate fa notare come le loro siano risposte parziali. Essi mettono in gioco le loro opinioni e Socrate le dimostra false, poiché è necessario sgombrare il campo da esse: " solo la verità è inconfutabile ". Così il condottiero Lachete, sicuro di sé, dice che il coraggio è non indietreggiare mai di fronte ai nemici; ma Socrate gli fa notare come gli Sciiti combattano con una tecnica consistente nell’indietreggiare a poco a poco; Enea stesso, del resto, viene da Omero presentato come espertissimo e coraggiosissimo nel combattere indietreggiando. L’interlocutore si vede così costretto a cambiare opinione e a riconoscere la falsità della propria definizione, dovendo dunque ripartire da zero: ma il sapere è la scienza, per cui non si può sapere cosa sia il coraggio se non si mostra perché è una scienza che per oggetto ha le cose temibili e quelle non temibili. La virtù stessa, in questa prospettiva, è la scienza del bene e del male. La scienza deve dunque possedere un carattere di assoluta certezza, senza ondeggiare tra vero e falso come fanno le opinioni: ed è proprio su questo che Platone proietta la propria indagine nel suo scritto "La Repubblica", in cui egli si pone il problema di cosa fare di quelle opinioni vere o, come dice Platone stesso, "rette". Che esse possano essere distinte dalla scienza vera e propria, Platone lo chiarisce nel "Teeteto", dialogo in cui mostra come tutto ciò che appare sia una mescolanza di percezione e opinione e come sia facile sbagliarsi prestando fede ai sensi. Nel tentativo di spiegare ciò, Platone ricorre ad un’immagine destinata a divenire celebre: paragona l’anima umana ad una tavoletta di cera su cui ciascuno di noi imprime i segni degli oggetti di cui ha percezione. E’ dunque possibile che, quando scorgiamo in lontananza una persona qualunque, la si scambi per l’immagine che abbiamo impressa nella nostra tavoletta/anima di un nostro amico: ne consegue che, in questa prospettiva, l’errore è un errore di identificazione, e che l’opinione retta è quella che non commette tali errori ed identifica in maniera corretta l’oggetto percepito. Sempre nel "Teeteto", Platone formula una definizione del pensiero che, per molti versi, rivela una marcata influenza socratica: il pensiero è, a suo avviso, un dialogo silenzioso, analogo a quello ad alta voce che Socrate intratteneva coi suoi interlocutori. L’opinione non va dunque intesa come un’alternativa indecisa: al contrario, essa tenta, al pari della scienza, di rispondere alla domanda "che cosa è x?", ma (e qui sta la differenza rispetto alla scienza) fornisce risposte suscettibili di essere vere o false. In altri termini, la differenza tra opinione e scienza risiede nel fatto che solo quest’ultima è in grado di spiegare le cause per cui è lecito dire che X è Y o che X non è Y. In tal modo si comincia a profilare la possibilità di capire perché la scienza abbia carattere di stabilità e certezza: essa spiega gli oggetti come derivanti da determinate cause. Anche nel "Menone" viene da Platone affrontato questo problema: per illustrare il carattere oscillante delle opinioni, Platone le paragona a delle statue tanto belle da sembrare vive. Averle le une slegate dalle altre non ha alcun valore, poiché il pregio sta tutto nell’averle legate, in modo tale che si possano prendere. Le opinioni rette, dunque, stanno "ferme", ovvero rimangono vere, finchè non ricevono una smentita: si tratta dunque di collegarle attraverso un ragionamento di tipo causale, che le leghi e le stabilizzi. Sia nel "Menone" sia nel "Fedone" traspare una teoria della conoscenza basata sulla reminescenza (e legata alla dimostrazione dell’immortalità dell’anima), che porterà Platone a concludere che " conoscere significa ricordare " (Menone). In quest’ottica, la conoscenza è possibile in virtù del fatto che, prima che l’anima si incarnasse nel corpo, ha conosciuto cose che, incarnandosi, ha dimenticato: si tratta, per l’esattezza, di enti (Platone li chiamerà "idee") la cui natura è tale da poterli assumere come criterio di verità; ne consegue, dunque, che essi devono essere immutabili ed esistenti in maniera indipendente dalle cose sensibili (le quali cambiano di continuo), il che presuppone che l’anima abbia una vita precedente rispetto al corpo in cui si trova imprigionata. E’ con queste considerazioni sulle spalle che, nel "Menone", uno schiavo assolutamente ignorante di matematica e adeguatamente interrogato da Socrate perviene alla risoluzione di un complesso problema geometrico: ne consegue che lo schiavo conosceva già tale teorema e che Socrate non ha fatto altro che aiutarlo a ricordarlo; non si tratta, tuttavia, di scienza, ma di opinione, poiché lo schiavo non è a conoscenza delle cause. E la conoscenza, secondo Platone, deve partire dal mondo sensibile che ci circonda per portarci a qualcosa che sta al di sopra ma che, in qualche misura, assomiglia ad esso. Per meglio spiegare questo concetto, Platone si serve, nel "Fedone", di un esempio particolarmente calzante: così come la lira ricorda a chi è innamorato il proprio amante, anche se questo non è materialmente presente, così gli oggetti del mondo sensibile ci rimandano alle loro idee. Ne "La repubblica" questo processo conoscitivo è strettamente connesso alla tematica della formazione del filosofo e si configura, se letto in trasparenza, come un vero e proprio processo ascensivo. Al filosofo che ha raggiunto un livello supremo di conoscenza teorica deve, secondo Platone, essere affidato il governo dello Stato, cosicchè nella sua figura finiscono per coincidere il sapere pratico e quello teoretico. Infatti, solo il filosofo può governare rettamente perché lui solo conosce l’idea del Bene, a cui ispirarsi per governare. Teoria e prassi non risultano dunque ancora pienamente distinte in Platone o, almeno, non come in Aristotele. Platone, ne "La Repubblica", descrive il processo conoscitivo in due modi: uno razionale, l’altro mitologico (il famoso mito della caverna). Esaminando quello razionale, Socrate dice che la conoscenza umana può essere accostata ad una linea: immaginiamo di dividere la linea in due parti; da una parte stanno gli oggetti sensibili, conosciuti secondo l’opinione ( >doxa ), dall’altra troviamo gli oggetti intellegibili (le idee), conosciuti dalla scienza ( >episthmh ). Suddividiamo ora la parte dell’opinione in due sottoparti: una dell’immaginazione ( >eikasia ), l’altra della credenza ( >pistiV ). L’immaginazione mi fa conoscere gli oggetti sensibili in modo nebuloso e confuso, e corrisponde alla conoscenza prima facie che ho del mondo. Nella spiegazione mitologica del processo, Platone spiega l’immaginazione come l’osservazione che gli uomini incatenati sul fondo della caverna fanno delle cose che stanno in superficie ma che loro vedono proiettate sul fondo della caverna. La >pistiV (credenza) corrisponde invece al momento in cui si esce dalla caverna e si contempla il mondo che sta fuori, si vede cioè la natura e se ne ha credenza (il che significa che, a differenza di Aristotele, Platone crede che non possa esistere una scienza della natura, una fisica, giacchè le cose sensibili sono in divenire perenne). La vera conoscenza, dunque, deve scavalcare il mondo sensibile per spingersi al di là di esso: anche per quel che riguarda l’ >episthmh (scienza), avente per oggetto gli enti intellegibili (cioè le idee), la linea si divide in due parti: da un lato avremo la >dianoia (pensiero discorsivo), il pensiero che procede passando per tappe. La >dianoia ha per oggetti gli enti matematici, che si trovano a metà strada tra il sensibile e le idee, giacchè si tratta di concetti che però richiedono un supporto sensibile (pensiamo al matematico che dimostra le proprietà del triangolo disegnandolo); proprio ad essi deve dedicarsi il filosofo appena inizia il suo itinerario. Le scienze matematiche, però, sono agli occhi di Platone inferiori alla filosofia, poiché, oltre a richiedere necessariamente l’aiuto di mezzi sensibili (disegni e altro), partono da postulati, assumono cioè le ipotesi come un qualcosa di vero a monte di ogni dimostrazione. Accanto alla >dianoia troviamo la >nohsiV (ossia il "pensare"): con essa non si discorre, ma si fissano e si conoscono le idee e la scienza che ne scaturisce è la dialettica, secondo la lezione socratica. Il filosofo de "La Repubblica" è il dialettico e i suoi oggetti di studio sono, appunto, le idee: e il metodo dialettico è nettamente superiore a quello matematico proprio per l’uso che fa delle ipotesi: non le assume dogmaticamente come postulati (come invece fanno i matematici), ma le sottopone a discussione, nella convinzione che di esse si possa rendere conto (come faceva Socrate con i suoi interlocutori): saranno mantenute solo quelle sostenibili, ossia quelle le cui conclusioni non sono in contraddizione con la definizione di partenza. A differenza della matematica, poi, la dialettica non è più costretta a ricorrere ad immagini sensibili, ma ragiona soltanto su idee: parte da ipotesi e le assume come una sorta di pedana per costruire attraverso un procedimento ascensivo il proprio ragionamento ipotetico. Questo metodo, oltre che ne "La Repubblica", viene formulato anche nel "Fedone" (il che suggerisce che i due dialoghi possano essere coevi): si apre, però, un problema non da poco; se il dialettico si avvale delle ipotesi come punto di partenza, allora il suo procedimento dovrà andare avanti all’infinito nel tentativo di dimostrare ogni ipotesi? No, dice Platone: anzi, l’assunzione di ipotesi e la verificazione delle medesime procede fino a quello che egli chiama il "principio non ipotetico", la cui esistenza è certa e non necessita di ipotesi. Tale principio altro non è se non l’idea del Bene, punto culminante del processo conoscitivo ed educativo. Tuttavia, Platone, ne "La Repubblica", non ci dice in che cosa consista tale idea, ma, ciononostante, ne chiarisce la funzione in analogia con il sole: Platone dice che il sole sta alle cose sensibili come il Bene sta a quelle intelligibili. Il sole, da un lato, rende possibile, grazie alla luce che getta, la visibilità (e quindi la conoscibilità) degli oggetti sensibili e, dall’altro lato, è condizione, grazie al calore che sprigiona, del costituirsi delle cose e quindi del loro divenire. In analogia, l’idea del Bene è condizione della pensabilità stessa delle altre idee (l’analogo della luce solare è la verità, una specie di luce intelligibile) e, al tempo stesso, è condizione dell’essere delle idee (le quali però non divengono, ma eternamente sono). Occorre tuttavia chiarire che l’idea del Bene non è affatto sullo stesso livello delle altre idee: ancora una volta torna utile l’analogia col sole; come esso sta al di sopra rispetto alle cose del nostro mondo, così il Bene è incommensurabilmente al di sopra delle altre idee, che da esso ricevono luminosità ( " è al di là della sostanza ", dice enigmaticamente Platone). Ma poiché le idee sono ciò di cui le cose sensibili in qualche modo partecipano, allora conoscere il Bene vorrà dire conoscere ciò che rende buone le cose: il Bene diventa così la chiave di lettura dell’intera realtà, tant’è che anche il buon uso del sapere dipende dalla conoscenza dell’idea del Bene. Da tutto ciò emerge come in Platone sia come non mai radicata la distinzione inconciliabile tra conoscenza sensibile (avente per oggetto le cose materiali) e conoscenza intelligibile (avente per oggetto le idee), attuabile solo a patto di liberare l’anima dai ceppi che la legano al mondo sensibile. Con Aristotele si tocca il rovescio della medaglia, anche se alcune acquisizioni platoniche restano salde: anche per Aristotele la conoscenza è un processo da percorrere a tappe; però egli tende a diminuire la distanza che in Platone separa i due tipi di conoscenza, intellettuale e sensibile. E il suo tentativo di rinsaldare quel legame spezzato da Platone va di pari passo con la sua dimostrazione dell’inesistenza di quelle idee ammesse da Platone e intese come forma delle cose: nella "Metafisica", Aristotele dice che la forma non può assolutamente essere separata dalla materia, sicchè la forma "uomo" non potrà mai essere divisa dall’uomo in carne e ossa e fatta sostanza indipendente ("idea"). L’idea è, in altri termini, semplicemente un’astrazione logica con la quale separo la forma dalla materia, giacchè nella realtà non è mai possibile trovarle disgiunte, ma ogni cosa è un "sinolo" ( >sun + olon), un’unione perfetta e inscindibile di materia e forma. Il mondo delle idee prospettato da Platone risulta dunque, ad Aristotele, un inutile doppione che, più che risolvere problemi, ne crea di nuovi, anche perché Platone non è stato realmente in grado di spiegare come la materia possa acquisire una forma: egli infatti, come dice Aristotele nel I libro della "Metafisica", non è stato in grado di cogliere la causa del movimento, in virtù della quale si spiega come la materia acquisisca la forma. Per fare un esempio, Aristotele dice che è grazie al principio del movimento immesso dall’uomo nella donna che si forma l’embrione. Egli ribadisce che il punto di partenza è costituito dal mondo della percezione sensibile, il punto di partenza a noi più chiaro: si tratta infatti di quell’ambito che è a noi più vicino e più noto; così facendo, Aristotele riconosce alla percezione sensibile uno statuto gnoseologico decisivo. E sempre nel I libro della "Metafisica" egli delinea le tappe del processo conoscitivo anche sul piano storico, facendo una sorta di storia della civilizzazione umana in cui si mostra come gli uomini, spinti dall’amore per la conoscenza, sono passati al sapere utile e poi a quello disinteressato; ed è appunto in questo I libro che troviamo esposte le teorie dei pensatori precedenti ad Aristotele, poiché anche dai loro errori si possono trarre insegnamenti . Come nota nell’incipit della "Metafisica", la sensazione è amata dagli uomini; prova di ciò è il fatto che essi amano la vista indipendentemente dall’utilità che ne possono ricavare. Ma il problema della conoscenza non può essere ristretto al solo ambito umano (e del resto Aristotele fu iniziatore della zoologia), poiché l’uomo non è il solo essere vivente: proprio l’osservazione zoologica mette in luce come anche gli altri animali abbiano sensazioni (provano piacere o dolore, caldo o freddo, ecc), cosicchè per capire a fondo la specificità della conoscenza umana occorre operare un raffronto con il mondo animale. L’amore per le sensazioni, donato dalla natura, è comune a tutti gli animali: ma solo in alcuni di essi, a partire dalla sensibilità, si genera la memoria, e questo in base all’esperienza empirica. Si crea così una discrepanza tra animali dotati di sensibilità e animali dotati di sensibilità e memoria: quest’ultima altro non è se non la capacità di raccogliere esperienza. Ma, individuata questa prima differenza, se ne può ricavare un’altra: sono più adatti ad imparare gli animali provvisti di memoria. Ciò non toglie, tuttavia, che l’ape sia un animale intelligente anche se incapace di imparare: che sia intelligente lo si evince dal fatto che ogni sua azione è orientata verso un fine preciso, anche se mossa dall’istinto e non dalla ragione. Ma esistono anche animali capaci di apprendere perché dotati dell’udito, attraverso il quale è possibile sentire e quindi apprendere gli insegnamenti. Ci sono poi animali aventi la memoria e capaci di formulare immagini prescindendo dalla presenza fisica dell’oggetto ma partecipano poco all’esperienza. E l’esperienza nasce dalla memoria, perché è prodotta da molti ricordi della medesima cosa: siamo ora entrati nel campo strettamente umano; dal sedimentarsi dei ricordi nasce l’esperienza della cosa e dall’esperienza nasce il livello superiore, la tecnica, intesa come saper fare. Quest’ultima ha luogo dal ripetersi dell’esperienza: infatti, mentre l’esperienza riguarda conoscenze slegate, la tecnica nasce quando molte nozioni derivanti dall’esperienza danno luogo ad una sola credenza universale: l’esempio tipico di tecnica addotto da Aristotele è quello della medicina. Per esperienza posso sapere che un dato farmaco fa bene a più persone ammalate della stessa malattia, ma ciò riguarda solo casi particolari; la tecnica, invece, si applica a tutti i casi: il medico sa che un farmaco fa bene a tutte le persone ammalate da quella data malattia. Solo chi possiede la tecnica ha conoscenza delle cause: il medico, infatti, sa che X cura tutti gli Y e sa anche spiegare il perché. Un gradino al di sopra della tecnica troviamo la sapienza: essa consiste in quello che i Medioevali diranno "scire per causas", dove le "causae" in questione sono quattro. Se i pensatori a lui precedenti ne avevano individuate al massimo due (magari intravedendone una terza), Aristotele spiega, sempre nel I libro della "Metafisica", che le cause sono quattro e che conoscere per cause significa rispondere alla domanda "che cosa è x?"; il che vuol dire conoscere l’essenza di quella determinata cosa, cioè che essa è in quanto è quella determinata cosa. Quattro sono le cause perché quattro sono le domande che esauriscono l’essenza di una cosa: causa materiale, causa del movimento, causa formale, causa finale. Alla domanda "che cosa è x?" la risposta più immediata è dire di che cosa è fatto x e nell’indicare la materia di cui è fatto individuo la causa materiale che l’ha prodotto: così, alla domanda "che cosa è l’uomo?" la causa materiale risponde che esso è carne e ossa. Con la causa del movimento (detta anche causa efficiente) si spiega da che cosa ha avuto origine il movimento: ogni cosa, infatti, viene ad essere come effetto di un movimento e Aristotele ritiene di poter addurre a conferma di ciò esempi desunti sia dall’ambito naturale sia dall’ambito della produzione umana. Alla domanda "che cosa ha prodotto l’uomo?" si deve rispondere che è stato prodotto dal seme del genitore, alla domanda "che cosa ha prodotto la casa?" si deve invece rispondere che è stata prodotta dall’arte del costruttore. Tuttavia non ci si può fermare alla causa materiale e a quella efficiente: ed è per questo che Aristotele introduce quella formale, alludendo a quel particolare tipo di causa capace di determinare la materia di una cosa e di individuarla come quella cosa, senza possibilità di confusione. Potrò dunque chiamare Socrate "uomo" perché la sua è materia individuata da una forma che le compete necessariamente e che serve da principio di individuazione, poiché individua la materia. La causa formale corrisponde, dunque, all’essenza della cosa: Socrate è uomo perché la sua materia è individuata dalla forma uomo, che mi permette di individuare tutti i soggetti della stessa specie. Ma il punto di sutura tra queste tre cause finora tratteggiate è la quarta ed ultima causa: quella finale, che illustra lo scopo per cui quella determinata cosa è venuta ad essere così come è. La causa finale risponde quindi alla domanda "perché x è?" o anche "perché x è venuto ad essere nel modo in cui è?": perché la casa è così come la vediamo? Perché deve servire da riparo all’uomo e non potrebbe fare ciò se non fosse disposta in quel modo. Perché l’uomo è così? Per svolgere al meglio quel compito che per natura gli compete, ossia il pensare, ed è per questo che ha la testa in alto, per poter meglio pensare. E per ciascuna cosa il fine può dirsi realizzato quando l’oggetto si è formato nella migliore forma possibile per poter assolvere alle sue funzioni; così una casa funziona bene se la sua forma la mette nelle condizioni di funzionare al meglio. Ne consegue che la causa finale è legata a filo doppio a quella formale. Che cosa è, però, che mette in moto quel processo per cui alla fine la materia è formata al meglio per assolvere le sue funzioni? Aristotele risponde che è la causa del movimento, giacchè, da sola, la materia non potrebbe mai passare da potenza ad atto. Conoscere queste quattro cause significa avere scienza e chi la possiede è perfettamente distinguibile da chi invece ne è sprovvisto e possiede solo una tecnica, o chi possiede solo l’esperienza, o ancora chi ha solo sensazioni: mentre infatti la sensazione si ferma al "che" delle cose e le conosce sempre come particolari, la scienza è in grado di conoscere il "perché" delle cose e, grazie a ciò, attinge all’universale. Ciò non toglie, tuttavia, che la percezione degli oggetti sia sempre vera: questo punto è sviluppato da Aristotele nel "De anima", quando dice che la percezione nasce dall’attualizzazione di una potenzialità. Infatti, ogni singolo organo di senso percepisce secondo verità i suoi oggetti perché il soggetto percipiente, per effetto dell’azione esterna, passa da soggetto percipiente in potenza a soggetto percipiente in atto e, nello stesso tempo, l’oggetto passa da oggetto percepito in potenza a oggetto percepito in atto. Ma il grande limite della sensazione è la sua incapacità a spiegare le cause: in altri termini, grazie alla sensazione percepisco che il libro è rosso, ma poi sta alla scienza spiegarmi il perché. Il possessore della scienza è il sapiente ( >sofoV) e Aristotele si interroga su come gli uomini siano pervenuti a questi esiti: la causa scatenante è l’amore per la conoscenza insito in ciascuno di noi, ma il primo movente che ha indotto gli uomini ad amare l’indagine conoscitiva è stata (e in questo Aristotele è d’accordo con Platone) la meraviglia ( >to qaumazein). Essi infatti si meravigliarono dei solstizi o dell’incommensurabilità della diagonale col lato perché non riuscivano a spiegarsi come fossero possibili tali cose e questo perché non erano ancora riusciti a comprenderne le cause: è infatti la conoscenza delle cause a sconfiggere la meraviglia e a portare al sapere. Con la filosofia, l’uomo ha raggiunto un sapere assolutamente disinteressato, privo di ogni risvolto pratico (a differenza delle tecniche): è quel sapere che Aristotele chiama >qewria ("contemplazione") e che riguarda quegli oggetti che, nel VI libro della "Metafisica", identifica con la matematica, la fisica e la metafisica. Se per il Platone de "La Repubblica" esisteva una sola scienza (quella del Bene), per Aristotele ne esistono una pluralità, tra loro non reciprocamente riducibili le une alle altre. Addirittura, Aristotele colloca la fisica ad un livello altissimo, mentre Platone le negava lo statuto di scienza; e poi Aristotele opera una netta distinzione tra teoria e prassi, tra filosofo e politico, tra scuola e città: tuttavia sullo sfondo lascia intravedere la possibilità di una conciliazione fra le due parti, dato che l’uomo è sì un animale razionale, ma anche un animale politico. E’ curioso il fatto che Aristotele non separi radicalmente chi ama il sapere da chi ama i miti, poiché, a suo avviso, entrambi muovono dalla meraviglia, anche se si servono di diversi modi di spiegazione (razionale e causale per il filosofo, mitico e irrazionale per l’amante dei miti). Proprio perché sapere teoretico e dunque non produttivo, la filosofia è fine a se stessa e, quindi, poiché priva del legame di servitù (infatti, propriamente, non serve a nulla), è il sapere più nobile. E da questa attività, come Aristotele dice nell’ "Etica Nicomachea", si ricavano piaceri immensi, i più congeniali alla natura razionale dell’uomo. La filosofia è la sola scienza che può essere divina, perché universale e perché conosce le cause, cioè conosce oggetti divini. La scienza costituisce dunque il punto più alto della conoscenza, ma, propriamente, quando si scoprono le cause che cosa si fa? Secondo Aristotele, a tal proposito, è assolutamente centrale l’impiego della dimostrazione: il filosofo si distingue per parlare in modo consono alla verità e la conoscenza della causa (che porta alla verità) passa per la dimostrazione; il filosofo sa dimostrare le cause perché sa costruire ragionamenti concatenati (sillogismi). Il che significa che per Aristotele possono esserci anche ragionamenti concatenati che non sono dimostrazioni. Il sillogismo, dunque, è lo strumento ( >organon) della scienza e il sapiente (come dice Aristotele nell’ "Etica Nicomachea") è colui che possiede la disposizione apodittica, ovvero la disposizione a dare dimostrazioni: si tratta di una procedura deduttiva, nel senso che si pongono premesse e si deduce una conclusione ad essa conseguente. Ed è la qualità delle premesse (che devono essere vere, salde, non dimostrate) a distinguere il sillogismo dimostrativo da quello non dimostrativo: perno della dimostrazione è il "termine medio", che consente di stabilire la conclusione. Ma, nota Aristotele memore della lezione socratica, esiste anche il sillogismo dialettico, una sorta di ragionamento concludente che però assume le premesse in base all’accordo tra gli interlocutori; si tratta dunque di un ragionamento concludente ma che esula dalla dimostrazione. Per poter costruire i sillogismi, il filosofo deve partire da princìpi e qui Aristotele ne individua di due tipi, quelli propri di ogni singola scienza (e che quindi riguardano solamente gli oggetti specifici di quella data scienza) e quelli comuni a tutte le scienze; ovviamente, ciò significa che non solo la scienza per Aristotele non è una, ma che addirittura i princìpi che le governano variano da scienza a scienza. Essi però non possono essere assunti per via dimostrativa, sennò si aprirebbe un processo tendente all’infinito: c’è tuttavia un’altra facoltà presente in noi che presiede a tali principi; si tratta dell’intelligenza ( >nouV ), un atto intellettivo di adeguazione immediata a tali princìpi. Non c’è scienza se non si conoscono i princìpi dai quali procede la dimostrazione: alla conoscenza di essi si arriva per via induttiva, cioè dalla sensazione, per lo stesso cammino che porta dalla percezione alla sapienza. Con la morte di Alessandro Magno (323 a.C.) si fa convenzionalmente iniziare l’età ellenistica, caratterizzata, sul piano culturale, in primis da forti contaminazioni frutto del contatto con culture lontane e profondamente diverse da quella greca; spesso questa nuova età del pensiero è stata letta come decadente, facendo riferimento agli ineguagliati vertici filosofici raggiunti da Platone e Aristotele. Alessandro Magno si era spinto fino in India e dopo le sue conquiste nulla fu come prima: Atene perse il titolo di capitale della cultura e la Grecia si avvia a diventare (nel 146 a.C.) provincia del mondo romano. Sul piano filosofico, lo scenario è dominato da tre correnti di pensiero principali, affiancate da un pulviscolo di correnti minori: queste tre scuole fondamentali sono lo Stoicismo, l’Epicureismo e lo Scetticismo, accomunate (come tutte le altre filosofie dell’età ellenistica) dal disinteresse per la sfera metafisica, tanto cara ai loro predecessori (pensiamo ai sistemi elaborati da Platone e Aristotele), e da una marcata esigenza di individuare un modello di vita che sia compatibile con le nuove condizioni socio-economiche in cui versava la Grecia dell’epoca; l’influenza illustre di Platone e Aristotele permane, anche se, di fatto, questi due pensatori non vengono mai esplicitamente menzionati. Tutte queste correnti pongono dunque al centro della loro indagine filosofica l’etica, prefiggendosi la formazione del saggio. Accanto a queste tre grandi scuole ce ne sono molte altre: tra queste, (oltre a quella dei Cinici, dei Cirenaici seguaci di Aristippo, degli ultimi Megarici, ecc) merita senz’altro di essere ricordata quella degli Aristotelici (o Peripatetici, dal Peripato, il luogo in cui Aristotele passeggiava filosofeggiando coi suoi discepoli): emblematica è, a tal proposito, la figura di Stratone di Lampsaco, tra i fondatori della imponente biblioteca di Alessandria. Ritornando agli sviluppi delle tre scuole che dominano questa fase della cultura filosofica greca, esse sono accomunate, oltrechè dalla preminenza dell’interesse etico, dalla classificazione tripartita (già presente nell’Accademia di Platone) della filosofia in etica, fisica, logica. Epicuro dà molto peso alla logica (detta anche "canonica" perché "canone", ossia criterio della conoscenza) e gli Stoici distinguono due grandi parti all’interno della logica: la gnoseologia e la teoria dei discorsi. L’espressione "scienza della logica" è di loro conio, poiché per Aristotele la logica era "analitica": se poi la teoria epicurea è monolitica e non subisce variazioni di rilievo nel tempo, quella stoica è, al contrario, una filosofia "in fieri", soggetta a continue trasformazioni: a testimonianza della stabilità della dottrina epicurea si può ricordare come Diogene di Enoanda, nel II secolo d.C., fa incidere su una pietra nella sua città il verbo di Epicuro così come era secoli addietro. Ed è curioso come Epicuro polemizzi aspramente contro i poeti (a suo avviso mistificatori) e come il più grande divulgatore della filosofia epicurea presso i Latini, Lucrezio, scriva in versi. Epicuro, poi, sceglie in modo significativo di insegnare in un giardino fuori Atene, lontano dalle burrascose vicende politiche della città; gli Stoici , viceversa, hanno la loro sede nel "portico dipinto" nel cuore di Atene: lo stoico Crisippo paragona la filosofia ad un orto in cui la logica costituisce le mura che demarcano i confini, la fisica rappresenta gli alberi che crescono nell’orto e l’etica costituisce i frutti che pendono dagli alberi; dalla metafora, si evince come la filosofia abbia per Crisippo confini limitati (un orto chiuso) e sia difesa dall’esterno da un muro (la logica); centrale è (alla pari degli alberi in un orto), evidentemente, la fisica, alla quale è strettamente connessa l’etica: non ci possono infatti essere i frutti se non ci sono gli alberi, il che significa che per raggiungere la felicità occorre partire dalla conoscenza della natura. Con un’altra metafora alquanto efficace, gli Stoici accostano il sapere filosofico ad un uovo, il cui guscio è costituito dalla logica (quindi essa ha funzione difensiva, come nel caso del muro), l’albume dalla fisica, il tuorlo dall’etica. Tuttavia, a Posidonio, uno Stoico della cosiddetta "media Stoà", queste metafore non piacevano perché non rendevano sufficientemente conto dei rapporti reciproci tra le tre scienze: a suo avviso, è meglio accostare la filosofia ad un organismo, in cui forte è la vivacità fra le parti; le ossa sono costituite dalla logica, il sangue e la carne sono rappresentate dalla fisica e l’anima dall’etica. La filosofia, così intesa, si configura come un sapere organico e retto da una fortissima unità, che per gli Stoici ruota attorno al >LogoV , la ragione che permea ogni realtà. Nel >LogoV gli Stoici vedevano convergere tre valenze: esso è principio di verità (e quindi legato alla logica, con la quale si formulano le leggi del conoscere, del pensare, del parlare), è un principio dell’essere delle cose (e dunque connesso alla fisica e allo studio che essa conduce sulla natura), è il principio del fine e del dover essere dell’uomo come ente di natura (e dunque è connesso all’etica). La teoria della conoscenza compete, secondo gli Stoici, alla logica: essa permette di cogliere il >LogoV insito nelle cose, cioè ce le fa conoscere, pensare e dire nella loro verità; anche per Epicuro la logica è fondamentale, perché fissa il criterio di verità: la sensazione è, secondo lui, la base della conoscenza. Epicuro elimina la logica come filosofia del linguaggio e se ne interessa solo nella misura in cui essa studia il criterio di verità. Sia gli Epicurei sia gli Stoici sono sensisti ed Epicuro arriva a concordare, per quel che riguarda la conoscenza, validità assoluta ai sensi. Il suo canone di conoscenza si sviluppa in tre punti che corrispondono alle tre parti della filosofia: la logica (legata alle sensazioni), la prolessi (legata alla fisica), le affezioni (legate all’etica); egli critica le tendenze scetticheggianti che sospendono il giudizio sulla validità delle sensazioni e le proclamano aleatorie: fa notare come, propriamente, non possa esserci pensiero se non ci sono le sensazioni. Questo emerge benissimo nella nozione di prolessi ( >prolhyiV dal greco >prolambanw , "prendo prima") o anticipazione: per prolessi Epicuro intende l’anticipazione di qualcosa che non mi si è ancora presentato ai sensi (quando ad esempio penso ad una persona senza poterla percepire); se la conoscenza passa per le sensazioni, come può pensare senza percepire? Tutto si spiega proprio perché, secondo Epicuro, l’anticipazione si verifica quando ho avuto sensazione almeno una volta di quella determinata cosa, cosicchè (permanendo essa nella mia memoria) posso pensarla senza effettivamente percepirla (perché l’avevo già percepita prima). Ma come si dimostra che tutte le sensazioni sono vere? La sensazione, secondo Epicuro, è un’affezione, un >paqoV in cui subisco qualcosa dall’esterno: ne consegue necessariamente che l’affezione deve rispecchiare fedelmente la cosa percepita. Ma, allora, come nascono gli errori e le illusioni dei sensi? Epicuro dice che neppure nel caso delle illusioni dei sensi si può parlare di percezioni errate: è la precipitazione del giudizio, cosicchè si dice che un determinato oggetto tondo è quadrato prima che la sensazione ci abbia sconfessato: il pensiero è fondato sulla sensazione, e non viceversa. Anche per gli Stoici la sensazione è importante, ma, a loro avviso, non basta: occorre che il dato della sensazione sia rappresentabile dal pensiero; non basta il dato del senso, ci vuole il pensiero. La sensazione si accompagna alla >fantasia (che in Aristotele, nel "De anima", era una facoltà dell’anima che permette la formazione di >fantasmata ), ossia la rappresentazione dell’oggetto. E poi la sensazione per gli Stoici è un’impressione provocata dall’oggetto sui nostri organi sensoriali: come il suggello lascia un’impronta sulla cera (secondo la lezione platonica del "Teeteto"), come un foglio di carta pulita è adatto per copiare uno scritto, così i nostri organi di senso ricevono le impressioni. Tuttavia, la concezione dell’anima è simile a quella di Epicuro: l’impressione lasciata dagli oggetti è un’impressione corporea perché l’anima stessa è corporea; se per Epicuro essa era un composto atomico, per gli Stoici ha natura aeriforme e le impressioni ne modificano la struttura proprio come (dice Crisippo) l’aria è in grado di ricevere molte e contrastanti percussioni; Crisippo parlava anche, in maniera più raffinata, di alterazioni qualitative, come se l’anima cambiasse stato quando riceve impressioni. Bisogna però chiedersi quali rappresentazioni possano essere ritenute con certezza vere: secondo gli Stoici, questa attività di rappresentazione si articola in due momenti distinti; in un primo momento, infatti, riceviamo passivamente affezioni dall’esterno, poi il soggetto reagisce attivamente ad esse con l’ "assenso", cioè acconsentendo, approvando ciò che si è passivamente ricevuto dall’esterno; questa approvazione avviene mediante il >LogoV che è nella nostra anima e la differenza tra una rappresentazione falsa e una vera è che solo a quella vera si può e si deve dare il proprio "assenso". Ma, dicono gli Stoici, di fronte alle rappresentazioni possiamo reagire o dando l’assenso, o non dandolo, o sospendendolo: e proprio nel riconoscere questa libertà di giudizio gli Stoici garantiscono, in una certa misura, una forma di libertà all’uomo; se, infatti, non possiamo scegliere se avere o meno rappresentazioni, ciononostante possiamo scegliere come reagire ad esse, concedendo o negando il nostro assenso. Particolarmente importante è la sospensione dell’assenso ( >epoch), che costituirà il perno della filosofia scettica e sarà destinata ad avere vita lunga nella storia della filosofia. Nel momento in cui do l’assenso ad una rappresentazione, l’impressione diventa apprensione, nel senso che ci si appropria della rappresentazione e questo emerge chiaramente nell’uso che gli Stoici fanno della parola >katalhyiV ("appensione", l’afferrare la rappresentazione); la rappresentazione diventa, in tal modo, "rappresentazione comprensiva" (o "catalettica"). Ma non tutte le rappresentazioni sono attendibili: solamente quelle che presentano evidenza e sono riconducibili alla realtà. Per illustrare questo procedimento conoscitivo, Zenone usava un’immagine alquanto efficace: la mano aperta rappresenta l’immagine, curvando le dita si ha l’assenso, stringendole e chiudendo il pugno si ha poi la comprensione e, infine, accostando la mano sinistra e afferrando il pugno si ha la scienza, intesa come sistema integrato di comprensioni catalettiche. Tuttavia, di rappresentazioni ce ne sono di due tipi: quelle che colgono immediatamente la realtà (comprensione catalettica), e quelle che la colgono con qualche difficoltà (comprensione non catalettica); solo la comprensione catalettica è, per gli Stoici, determinata dall’esistente, conforme all’esistente e impressa nell’anima. Ed è solo quando c’è la presenza effettiva dell’oggetto che l’assenso è fortissimo, quasi come se (per usare un’immagine impiegata dagli Stoici) venisse strappato per i capelli: gli Scettici osservavano invece come di fatto nessuna rappresentazione si presentasse con caratteri tali da meritare, senza possibilità di equivoci, il nostro assenso (pensiamo ai sogni, quanto ci appaiono veri!). Detto questo, per gli Stoici la conoscenza non si esaurisce nell’ambito della sensazione (come invece è per Epicuro): l’attività del pensiero che crea concetti rivela un’attività intellettiva autonoma dalle sensazioni, anche se non del tutto sganciata da esse. Ogni atto intellettivo (e gli Stoici designano l’atto intellettivo con la parola >nohsiV, di forte sapore platonico) deriva da una sensazione, ma ciò avviene o per contatto (relazione diretta) o non per contatto (relazione non diretta) ed è facile capire come il pensiero possa svolgere autonomamente la sua attività: o per evidenza o per analogia o per somiglianza o per aggregazione. Per evidenza sensoriale sento il dolce, l’amaro, ecc; non per evidenza, ma per passaggio da cose evidenti creo concetti per composizione (componendo il concetto di uomo e quello di cavallo creo l’ippocentauro), per somiglianza (dall’uomo Socrate in carne e ossa creo il concetto di Socrate), per analogia (per analogia verso l’aumento dell’uomo creo il concetto di ciclope, verso la diminuzione dell’uomo creo uomini nani). E sia gli Stoici sia Epicuro insistevano tanto sulle operazioni del pensiero per polemizzare contro l’innatismo, secondo il quale le nozioni universali preesistono; gli Stoici, in opposizione a questa tesi, ammettevano che gli universali (le "prolessi" di Epicuro) fossero "connaturate" agli uomini, come se l’uomo nascesse con una predisposizione alla formazione di questi concetti perché è l’unico essere a possedere la ragione: in particolare, gli Stoici parlavano di concetti "connaturati" in riferimento alla morale e, soprattutto, all’innata disposizione dell’uomo alla virtù; infatti, poiché l’uomo è anima, cioè ragione, egli vive secondo ragione e vivere ragione vuol dire vivere secondo natura, ossia secondo virtù. Ma in quegli stessi anni compariva sullo scenario filosofico una figura inequivocabilmente nuova, destinata a diventare il fondatore dello Scetticismo : si tratta di Pirrone originario di Elide (nato circa nel 360 a.C.); egli avrebbe cominciato la sua attività filosofica ancor prima della fondazione della scuola stoica ed epicurea e avrebbe preso parte alla spedizione di Alessandro Magno in India, entrando così in contatto con i maghi e con i gimnosofisti; da questi avrebbe appreso il tipo di saggezza da lui professato. Come Socrate, Pirrone scelse di non scrivere nulla, poiché convinto di non avere nulla da affidare allo scritto e che altri potessero apprendere: ed è per questo che egli non fondò alcuna scuola e gettò le basi dello scetticismo; dal punto di vista di Pirrone e degli Scettici tutte le filosofie costituiscono un blocco unico, poiché pretendono di avere qualcosa da insegnare; si tratta, per di più, di un blocco dogmatico, dottrinario. In contrapposizione a tutto questo, gli Scettici non hanno dogmi e non hanno persone a cui trasmettere le proprie verità, proprio perché non ne possiede. Dalle testimonianze di cui disponiamo, possiamo ipotizzare che anche la filosofia scettica abbia attraversato delle sue fasi: l’immediato successore di Pirrone, Timone, ha composto in versi delle critiche indirizzate agli altri filosofi; la tradizione, poi, testimonia che anche due platonici come Carneade e Arcesilao avrebbero aderito allo Scetticismo. Dopo di che, si perdono le tracce della filosofia scettica, fino al II secolo d.C., quando ad abbracciare la causa scettica fu Sesto Empirico (detto "Empirico" perché appartenente alla setta medica degli "Empirici"), il quale si scatenò in un’accesa critica "Contro i dogmatici" e tratteggiò la figura del "filosofo pirroniano", facendo in tal modo di Pirrone un modello da seguire. Stando a quanto dice Diogene Laerzio nelle "Vite dei filosofi", Pirrone avrebbe desunto dallo Stoicismo i princìpi della >akatalhyia (letteralmente "incomprensibilità") e dell’ >epoch ("sospensione di giudizio"), mentre, attenendoci alla testimonianza di Sesto, Pirrone avrebbe cominciato da solo, senza influenze, la propria attività filosofica. L’opposizione allo Stoicismo appare tuttavia evidente: se gli Stoici parlano di "rappresentazione comprensiva", Pirrone nega invece la rappresentabilità (e quindi la comprensibilità) delle cose: la sua è una non-gnoseologia. Gli Scettici vengono così definiti dal termine greco >skeyiV , che vuol dire "ricerca", "indagine" sulla natura delle cose per stabilire cosa esse siano: nella sua ricerca, però, lo scettico scopre che le cose sono incomprensibili per due ordini di ragioni. In primo luogo per il fatto che tutte le cose appaiono diversamente a chi le osserva in condizioni diverse, in secondo luogo per il fatto che sulle stesse cose si può riscontrare che gli uomini hanno pareri contrastanti, spesso addirittura opposti (c’è, ad esempio, chi dice che tutto è costituito da atomi, chi da elementi, e così via). Lo scettico, tuttavia, non si limita a dire che le cose sono inconoscibili (poiché questo sarebbe un dogmatismo), ma ritiene che si debba sospendere il giudizio ( >epoch ): egli, cioè, non afferma né nega che le cose siano comprensibili e scopre che dalla sospensione del giudizio scaturisce una felicità irresistibile, sconosciuta a chi si ferma al dogmatismo. Secondo Timone, in particolare, occorre chiedersi tre cose per essere felici: a) quale è la natura delle cose? b) come ci si deve disporre nei confronti di esse? c) cosa risulterà a coloro che si trovano in questa disposizione? Come Timone stesso asserisce, le cose sono ugualmente indifferenti, immisurabili, indiscriminabili e perciò le nostre sensazioni e opinioni possono essere vere e false, poiché non disponiamo di criteri per distinguere le differenze tra le cose. Di fronte a quest’assoluta mancanza di certezze e verità, Carneade e Arcesilao (rivelando in ciò la loro ascendenza platonica) ovviavano, rispettivamente, con la nozione di >piqanon ("probabile") e con quella di >eulogon ("ragionevole"): ma per Pirrone, invece, " si deve vivere senza opinioni, senza inclinazioni, senza agitazioni ", poiché il seguire le opinioni ci turba; occorre, piuttosto, dire che " ogni cosa è non più di quanto non è ". Ne derivano l’ >afasia ("il non pronunciarsi") e l’ >ataraxia ("assenza di turbamenti"). Ma, in questa prospettiva, come conduce lo scettico la propria esistenza? Come dice Sesto Empirico, lo scettico è uomo tra gli uomini, sospende il giudizio ma dà assenso alle rappresentazioni naturali (la fame, la sete, ecc), non ha maestri ma impara come tutti gli altri uomini a leggere e a scrivere perché ciò è utile nella vita quotidiana; in altri termini, lo scettico si adatta alle condizioni comuni, vive seguendo i fenomeni, senza dar valori: non dice, ad esempio, che il miele è dolce, ma che sembra tale. Qualche secolo più avanti, Plotino cercherà di porre nuovamente al centro della discussione filosofica il platonismo, scivolato per molto tempo nell’oblio: secondo Plotino, non è l’anima ad essere nel corpo, ma, al contrario, è il corpo ad essere nell’anima; a suo avviso, perché sia possibile la riunificazione con quell’unico principio da cui tutto deriva, non occorre la ragione, ma, piuttosto, la mistica o, come la chiama Plotino, l’ "estasi". Si tratta, cioè, di staccarsi dal mondo fisico, di rientrare in sé (ossia di riappropriarsi della propria anima) e di ricongiungersi all’ Uno, principio da cui ogni cosa proviene. Con Plotino il mondo perde definitivamente la sua autonomia: l’uomo stesso è solo anima, anzi, è anima separata dal corpo, poiché è come se in ciascuno di noi vi fossero tre persone diverse. Infatti, la prima persona è costituita dalla nostra anima considerata nella sua tangenza con l’intelletto, la seconda è rappresentata dall’anima come pensiero discorsivo e, infine, la terza è l’anima che vivifica il corpo terreno. Sullo sfondo di queste riflessioni, vi è la distinzione aristotelica (presente nel "De anima") delle funzioni dell’anima: e, secondo Plotino, il nostro vero io è soprattutto quello della seconda persona, ossia l’anima come pensiero discorsivo, capace di tendere verso il meglio (la prima persona) o verso il peggio (la terza persona). In tale prospettiva, l’uomo altro non è se non un’anima che si serve di un corpo, il quale, a sua volta, non è che un’anima "caduta": ne consegue che l’anima, non solo è slegata dal corpo (secondo l’insegnamento platonico), ma, addirittura, è strettamente congiunta all’assoluto. Nell’ambito gnoseologico, l’anima, essendo incorporea e dunque incapace di concepire alcunchè, può solo agire, mai subire, giacchè ciò che è incorporeo non è suscettibile di subire azioni: e allora la sensazione va intesa come azione del corpo esterno sul corpo percipiente ma, in questi termini, in virtù del rapporto tra anima e corpo, sembra che l’anima subisca, in qualche modo, l’influenza degli oggetti, cosa che abbiamo poc’anzi detto impossibile. Per evitare di incappare in questa contraddizione, Plotino ricorre ad una scaltrezza di sapore stoico, distinguendo tra sensazione esteriore (che è l’affezione e l’impronta che i corpi producono sui corpi stessi, poiché, stoicamente, sussiste una simpatia universale che lega ogni cosa) e percezione sensitiva (che è l’attività dell’anima in senso stretto: un atto conoscitivo che coglie l’impressione e l’affezione corporea appropriandosene). In altri termini, secondo Plotino, il nostro corpo subisce passivamente un’affezione e, dopo ciò, l’anima cattura tale affezione corporea e, successivamente, riesce a giudicarla; in particolare, nell’impressione sensoriale l’anima riesce a vedere l’orma delle forme intelligibili e, quindi, la stessa sensazione altro non è se non contemplazione dell’intelligibile nel sensibile; in tale ottica, le sensazioni possono anche, di fatto, essere definite come "pensieri oscuri". Se non ci fosse l’anima superiore che ha nozione degli "intelligibili puri", non potrebbe nemmeno esserci la sensazione. Plotino attribuisce all’anima anche la capacità di immaginare e memorizzare, riconoscendo invece nel corpo uno strumento di impaccio a queste due attività: prova ne è, secondo Plotino, il ricordo delle dottrine scientifiche, che col corpo non hanno nulla a che fare. E occorre notare come, propriamente, solo l’anima sia dotata di memoria (in quanto solo essa è legata alla temporalità): l’Uno e l’intelletto ne sono sprovvisti. Da sottolineare è la distinzione che Plotino opera tra memoria e reminescenza: quest’ultima è un richiamare alla memoria, un conservare perennemente nell’anima ciò che le è connaturato. Non c’è da stupirsi che, nella prospettiva plotiniana, la più alta attività conoscitiva dell’anima risieda nel pensiero che coglie le idee (intese non più alla maniera platonica, come enti a sé sLA FISICA DEI GRECI
Un’ampia panoramica sulle dottrine fisiche dei Greci ci è fornita da quella sorta di manuale di storia della filosofia che è il libro primo della Metafisica di Aristotele: dopo essersi rapidamente richiamato alla dottrina delle quattro cause (materiale, formale, efficiente, finale) – la sola che, a suo avviso, possa rendere conto del reale in maniera esauriente – già ampiamente trattata nella Fisica, lo Stagirita guarda indietro ai suoi predecessori per vedere a quante e a quali cause essi siano pervenuti nel tentativo di render conto della realtà indagata. Questa ricognizione delle dottrine formulate da chi è venuto prima è un procedimento che Aristotele impiega con incredibile frequenza all’interno dei suoi scritti e affonda le sue radici nella convinzione che il sapere non nasca ex novo, come per magia, ma debba essere invece il frutto di un percorso comune e metatemporale, al quale contribuiscono anche i filosofi del passato. Ecco perché "dobbiamo prendere in esame anche coloro che prima di noi hanno affrontato lo studio degli esseri e hanno filosofato intorno alla realtà. E’ chiaro, infatti, che anch’essi parlano di certi principi e di certe cause. Ora, il rifarsi ad essi sarà certo di vantaggio alla presente trattazione: infatti, o troveremo qualche altro genere di causa, oppure acquisiremo più salda credenza nelle cause di cui ora s’è detto" (Metafisica, 983 b). In realtà, nessuno dei predecessori si è spinto ad individuare addirittura quattro cause – nota con orgoglio Aristotele -, ma anzi, nella maggior parte dei casi, si sono arrestati a una o due (in pochi ne hanno intraviste tre), dando di conseguenza una spiegazione parziale e non del tutto esauriente del reale. A questo proposito, Aristotele concentra la propria indagine innanzitutto sui filosofi che hanno individuato esclusivamente la causa materiale: ancor prima di fare nomi, egli introduce i caratteri comuni di questi autori che si sono arrestati alla causa materiale (intesa come "ciò di cui tutti gli enti sono costituiti"), senza scorgerne altre. Ad avviso di costoro, per conoscere le cose è sufficiente individuare la causa materiale, concepita come "elemento e principio degli enti" (dove "elemento" è l’ingrediente materiale componente le varie realtà, principio – in greco
>arch – è ciò che viene prima in senso cronologico e logico e dà origine alla realtà): sotto questo profilo, l’intera ricerca svolta dai primi filosofi è per Aristotele volta al rinvenimento dell’ >arch da cui tutte le cose sono venute ad essere. Nella veste di storico della filosofia, dunque, Aristotele proietta la propria indagine sulle coste dell’Asia Minore (attuale Turchia) e, più precisamente, nella città di Mileto, ove furono operativi Talete, Anassimandro e Anassimene, che lo Stagirita non esita a definire come "fisiologi" ( >fusiologoi), riservando a se stesso il più alto titolo di "fisico" ( >fusikoV). L’iniziatore della ricerca dell’ pare essere stato Talete, figura non priva di connotazioni leggendarie (ben presto sul suo conto fiorirono miriadi di aneddoti): egli muove dalla convinzione che l’ >arch, ovvero il principio da cui tutto deriva, sia l’acqua. Dalla convinzione secondo cui l’acqua sarebbe alla base di ogni realtà, Talete avrebbe addirittura fatto conseguire la tesi – che a noi non può strappare un sorriso – secondo cui la Terra stessa galleggerebbe sull’acqua e si troverebbe pertanto in un equilibrio precario. Aristotele, con la curiosità filosofica che lo contraddistingue, prova anche a domandarsi come possa essere la concezione propria di Talete dell’acqua come causa materiale: pur in assenza di certezze (il che è testimoniato dal "forse" che Aristotele premette alla propria constatazione), non si può escludere che Talete sia addivenuto alle sue note conclusioni partendo dall’osservazione che l’umido sta alla base di ogni cosa – perfino del caldo – e che i semi stessi, da cui nasce la vita, sono anch’essi umidi. Da ciò ben si evince come Talete si basasse, nel proprio procedere filosofico, soprattutto sull’osservazione diretta dei fenomeni. Aristotele sembra anche suggerire, in certa misura, che Talete, nella formulazione delle proprie tesi, tenesse conto di quella tradizione mitica – cantata nei poemi di Omero e di Esiodo – in cui Oceano e Teti non erano che i progenitori del mondo: in questo senso, Talete avrebbe sostenuto la stessa tesi dei poeti, ma da essi si sarebbe differenziato per aver dismesso la veste teologica e mitica e per aver indossato quella ipercritica della filosofia. Fare di Talete un razionalista nell’accezione moderna – affermatasi da Cartesio in poi – sarebbe però sbagliato, anche perché su di lui influiscono concezioni animistiche che lo inducono a ritenere vivo il magnete – perché capace di muoversi in presenza del ferro – o ad affermare enigmaticamente che "tutto è pieno di dei" (frase facilmente convertibile in: "tutto è pieno d’acqua"). Anche se Aristotele trascura questo aspetto, noi possiamo tentare di spiegare l’importanza da Talete concordata all’acqua facendo riferimento alla particolare zona in cui egli è vissuto: Mileto era una città marinara, in cui l’acqua era di fondamentale importanza per i traffici e, dunque, per la sopravvivenza dei suoi cittadini. Una domanda destinata a restare senza risposta è se Talete abbia avuto discepoli e, in tal caso, se Anassimandro rientrasse nella sua cerchia. Pare assai improbabile (anche se non escludibile) che ciò sia possibile, anche perché nel VII secolo a.C. non abbiamo testimonianze sull’esistenza del rapporto di discepolato: non è tuttavia da escludersi che Anassimandro abbia conosciuto e frequentato Talete. Anassimandro compie in sede filosofica un passo decisivo: accantona la poesia e scrive – primo nella storia – un’opera in prosa, tramandataci con l’usuale titolo di Sulla natura ( >Peri fusewV); ciò non toglie, tuttavia, che lo stile prosastico da lui impiegato non concedesse ampi margini ad un linguaggio immaginifico e poetico, volto ad accattivarsi l’attenzione dei lettori. Ma, oltre alle questioni di ordine stilistico, la grande innovazione apportata da Anassimandro risiede nell’aver individuato l’ >arch non già in un qualcosa di materiale ed empiricamente constatabile (al pari dell’acqua di Talete), bensì una realtà soprasensibile, forse in base al ragionamento che l’ >arch non può essere una sola delle entità visibili, ma piuttosto un qualcosa da cui tutte scaturiscano. Per questa via, Anassimandro passa dal visibile all’invisibile. Tale >arch invisibile è da lui ravvisato nell’ >apeiron, ovvero – letteralmente – in "ciò che non ha limiti" ( >a + peraV). Questo "illimitato" trova una sua collocazione fisica alla periferia di un universo sferico al cui centro è posizionata la Terra, dotata di forma cilindrica ed equidistante dalla periferia (essa è dunque in perfetto equilibrio nella sua immobilità, senza bisogno di alcun sostegno, nemmeno dell’acqua supposta da Talete). Dall’ >apeiron si generano in primis le "qualità contrarie" (caldo/freddo, secco/umido, ecc), ossia gli elementi, giacchè alla natura di ciascun elemento corrisponde una data qualità (così al fuoco corrisponde il caldo, all’acqua il freddo, ecc). In questo senso, allora, l’ >apeiron manca, oltre che di limiti, anche di qualità: proprio da questo sostrato aqualitativo nascono i quattro elementi costituenti la realtà. Non è un caso che, nell’universo, ogni cosa sia dotata di limiti precisi: dalla realtà illimitata ( >apeiron) nascono tutte le cose e ciascuna di esse diventa col nascere il limite di tutte le altre (tant’è che nel definirla non facciamo che distinguerla dalle altre). Nell’unico frammento di Anassimandro conservatosi fino a noi il limite è descritto in termini di >ubriV, ossia di violenza e di prevaricazione delle cose fra loro, una sorta di ingiustizia di cui le cose pagano il fio con la distruzione (al che provvede il processo del nascere e del perire): "principio delle cose che sono è l’illimitato… donde le cose che sono hanno la generazione, e là hanno anche il dissolvimento secondo la necessità. Infatti esse pagano l’una all’altra la pena e l’espiazione dell’ingiustizia secondo l’ordine del tempo". Sulla scia di Talete, Anassimandro fa leva sul senso comune, spiegando l’ingiustizia cosmica attraverso le ingiustizie che patiamo quotidianamente. Con Anassimene (VI secolo a.C.), invece, la filosofia in terra di Ionia compie un passo indietro: anch’egli autore di un’opera in prosa intitolata Sulla natura ( >Peri fusewV), abbandona l’indagine "astratta" intrapresa da Anassimandro e torna alla ricerca di un unico principio materiale, che egli individua non già nell’acqua, bensì nell’aria. Quanto anche la sua sia una filosofia del senso comune lo si può facilmente arguire dall’importanza rivestita dall’aria per la nostra vita, in particolare per la respirazione: secondo Anassimene, l’aria opera a livello cosmico come a livello umano, cosicché essa dà origine e tiene in vita tanto gli uomini quanto l’universo nel suo insieme. Per spiegare il processo di derivazione degli elementi (terra, acqua, fuoco) dall’aria, egli fa riferimento a due processi contrari: la rarefazione e la condensazione. L’acqua riscaldata, infatti, si trasforma in aria, e così via. In questa maniera, le trasformazioni del mondo vengono spiegate come trasformazioni dell’aria, giacchè tutte le cose costituenti l’universo non sono che aria in un diverso grado di densità. I filosofi ionici, a rigore, non si esauriscono nella triade Talete/Anassimandro/Anassimene: anche Eraclito di Efeso rientra in certo modo nel loro novero. Vissuto ad Efeso a cavallo tra VI e V secolo a.C., egli è foriero, in ambito fisico, di una tesi assai originale. A suo avviso, il mondo non è il prodotto di una divinità o di un ordinamento di tipo umano, bensì risponde ad un unico ed eterno ordine universale (il >LogoV) costituente e fondante l’essenza del cosmo: tale ordine universale viene da Eraclito identificato nel "fuoco sempre vivente", sicchè la sua può essere a ragione qualificata come una cosmologia del fuoco ( >pur). Si tratta, al pari dell’acqua di Talete e dell’aria di Anassimene, di un principio di natura materiale: è un fuoco sempre vivente, tale da non perire mai ma da andare tuttavia incontro ad una vicenda che consente ad Eraclito di spiegare il processo di generazione e corruzione. Aristotele – che pure non fa mistero della difficoltà di decifrare Eraclito – sbaglia interpretazione nel momento in cui classifica il filosofo di Efeso come mero ricercatore dell’unico >arch, giacchè il fuoco (pur essendo materiale) non dev’essere qui inteso come un unico principio, ma piuttosto come un qualcosa a cui riferirsi per analogia; in altri termini, il fuoco è per Eraclito l’emblema di ciò che accade a livello cosmico, ove ogni cosa muta incessantemente, ora nascendo, ora perendo, proprio come il fuoco alternativamente si accende e si spegne. Il Sole stesso (contenente fuoco) – egli nota – brilla di giorno e si spegne di notte. Tale concezione si riverbera in maniera netta sulla visione che Eraclito ha del mondo: esso risulta essere una totalità ordinata (e "non un mucchio") la cui vicenda è scandita secondo momenti che si ripetono sempre uguali. Il divenire universale implica un passaggio tra opposti (nascere/perire) da cui traggono origine tutti gli altri (sonno/veglia, malattia/salute, ecc): sicchè ciascuno di esse deve perire affinché possa nascere il suo opposto; ciò significa, allora, che gli opposti non sono se non momenti tra loro in guerra. Quest’ultima è l’essenza intima della realtà o, per dirla con Eraclito, "è padre di tutte le cose": l’universo, così inteso, è un insieme di contrari in guerra reciproca, ma esso risulta non già dal caotico guerreggiare de medesimi, bensì dall’armonica unità dei contrari, compresenti in ogni cosa. La guerra tra gli opposti non esprime, allora, una prevaricazione di ciascuna cosa su tutte le altre (come credeva Anassimandro), ma è anzi la legge regolante il cosmo e che può essere compendiata nell’espressione scolastica di coincidentia oppositorum. In questo senso, sbaglia quella tradizione stereotipata che ci presenta Eraclito esclusivamente come il "filosofo del divenire" (tale etichetta meglio si attaglia al suo discepolo Cratilo): egli è sì il filosofo del divenire, ma ancora di più quello della coincidenza degli opposti. Pertanto, quando egli dice che "negli stessi fiumi scendiamo e non scendiamo, siamo e non siamo" sta suggerendoci ancora una volta l’armonica unità dei contrari, per cui si è e insieme non si è immersi nelle acque. Dalle coste dell’Asia Minore saltiamo ora a quelle dell’Italia meridionale e, più precisamente, della Calabria: la scena si sposta in concomitanza con una figura anch’essa nativa della Ionia ma poi trasferitasi a Crotone per via dei dissensi col tiranno Policrate; questa figura ai confini con la leggenda è quella di Pitagora di Samo, fondatore della prima scuola filosofica che la storia ricordi. In realtà, più che di una scuola, si tratta di una comunità filosofica, religiosa e politica (in certo senso si può anche parlare di "setta" religiosa) i cui membri conducevano vita comune e venivano iniziati. Le vicende della comunità – il cui orientamento politico era decisamente aristocratico – e di Pitagora si concludono quando Crotone diviene sede di una rivolta democratica che porta alla distruzione della scuola e alla dispersione dei suoi membri. Tratto saliente dei Pitagorici è il marcato ascetismo a cui essi fanno capo: la pratica di non mangiare carni (la commedia greca ce li rappresenta ironicamente come dei morti di fame) e la credenza (di marca orfica) nella trasmigrazione delle anime e nelle loro espiazioni di colpe sono i pilastri della vita pitagorica; con loro prende via la tradizione del corpo come tomba dell’anima destinata – attraverso Platone prima e attraverso il cristianesimo dopo – a segnare in maniera indelebile la cultura occidentale. La cosa curiosa è che Pitagora ci è presentato come politico, come etico, come fisico e come matematico: insomma, come una figura a trecentosessanta gradi. Nel primo libro della Metafisica, Aristotele attribuisce ai Pitagorici la dottrina per cui i numeri costituiscono l’essenza di tutte le cose, tant’è che per lo Stagirita essi rientrano tra i primi indagatori della natura, sebbene non rinvengano l’ >arch in un unico principio, ma in una miriade di principi (i numeri); il che fa di loro non già dei monisti, bensì dei pluralisti. Tuttavia non è chiaro a quali Pitagorici faccia riferimento Aristotele (a quelli originari o a quelli a lui contemporanei?): pare difficile che egli alluda ai primi, anche perché la tradizione attesta che il nucleo originario dei loro insegnamenti fosse rigorosamente impartito per via orale e, come se ciò non bastasse, i destinatari erano tenuti al silenzio; solo più tardi, con Filolao di Crotone e Archita (IV secolo a.C. quasi), i Pitagorici mettono per iscritto le loro dottrine ed è dunque presumibile che ad essi alluda Aristotele. Dire che i numeri costituiscono l’essenza delle cose equivale a dire che ne sono la forma: essi sono cioè quel che fa sì che le cose siano quel che sono. Per effettuare i calcolo, i Pitagorici ricorrevano a pietruzze tramite le quali rappresentavano visivamente i numeri (una pietra rappresentava l’uno, due pietre il due, e così via), con l’inevitabile conseguenza che mancava lo zero; in virtù di questa concezione figurata dei numeri, essi erano inoltre in grado di rappresentare le cose: ad esempio, quattro pietruzze rappresentavano il quadrato, tre il triangolo, e così via. Da ciò segue che la forma delle cose può essere espressa in rapporti numerici, cosicché la forma non è mai casuale, ma sempre ordinata: ne risulta un universo matematizzato, ove i rapporti tra le parti sono esprimibili numericamente, con la conseguenza che il mondo stesso è perfettamente conoscibile in forza del fatto che "i numeri non mentono mai" (Filolao). Avvalendosi dei numeri, i Pitagorici spiegavano perfino i concetti astratti: così la giustizia è espressa dal 4 e dal 9, che sono i quadrati del primo numero pari e del primo dispari (l’1 non è né pari né dispari: è il parimpari, nel senso che, aggiunto ad un pari, lo rende dispari, e viceversa), il 5 esprime il matrimonio (3+2, dove 3 è il sesso maschile, 2 il femminile). Naturalmente questa mistica dei numeri esula completamente dalla scienza impiegata per investigare numericamente il cosmo. Stando ad Aristotele, i Pitagorici avrebbero spiegato col loro impianto numerico anche l’organizzazione del cielo: il 10 è, per loro, il numero sacro su cui giurare, poiché è la "tetrattide" ( >tetraktuV) compendiante in sé l’universo (l’1 è il punto, il 2 la linea, il 3 la superficie, il 4 il solido: 1+2+3+4=10). Ed è su tale base "mistica" che innestano la loro teoria astronomica: l’universo è organizzato intorno al fuoco centrale, accostato metaforicamente al focolare della casa o a quello del tempio. Attorno al fuoco ruotano terra, luna e tutti gli altri pianeti fino al cielo delle stelle fisse: in questo modo, però, si arriva solo fino a nove pianeti ed è proprio per arrivare a dieci (la tetrattide) che essi aggiungono una anti-Terra, situata tra fuoco e Terra. La cosa forse più interessante, nel discorso pitagorico, è che per la prima volta nella storia la Terra non occupa il centro dell’universo. I Pitagorici erano altresì convinti che dai cieli provenisse una musica che solo pochi eletti potevano percepire. La presa di posizione di Parmenide e della scuola eleatica che a lui fa capo segna un punto di svolta decisivo nell’indagine sulla natura. Fondatore di una scuola filosofica sulla costa campana a sud di Salerno (a Elea, poi Velia), Parmenide compone il suo poema Sulla natura in esametri, il metro tipico dell’epica, benché lo scritto parmenideo di poesia –oltre alla forma – non possegga nulla. Il protagonista del poema è, significativamente, Parmenide stesso, che in prima persona narra di un viaggio avvenuto sotto la guida di una divinità che l’avrebbe portato a varcare la porta che separa la luce dalle tenebre; qui egli avrebbe ricevuto dalla dea l’insegnamento che intende comunicare agli altri uomini. Il nucleo del poema è dunque il contenuto del messaggio divino, che fin dall’inizio (fr.1) riguarda ciò che può essere pensato e detto, ovvero l’oggetto autentico del pensiero quale può essere espresso nel linguaggio. Rispetto ai predecessori – che muovevano pressoché sempre da ciò che cadeva sotto gli occhi di tutti -, Parmenide cambia rotta e parte non già dall’empiria per giungere all’invisibile, bensì da ciò che ai sensi sfugge per poi spiegare ciò che sotto di essi cade. E il punto d’avvio è costituito da ciò che può essere autenticamente pensato e detto (si tratta quindi di un punto di partenza logico/gnoseologico); in particolare, questo punto di vista è incentrato su quello che, da Aristotele in poi, è passato alla storia come "opposizione di contraddizione", ove l’opposizione sussiste tra l’essere e il non-essere. La dea illumina Parmenide su ciò che si può pensare e dire (l’essere), di contro a ciò che né si può pensare né si può dire (il non-essere). E ciò che si può autenticamente pensare e dire è solo ciò che è, mentre ciò che non è non può essere pensato e detto, poiché pensare ciò che non è equivale per Parmenide a non pensare niente, dire ciò che non è equivale a non dir nulla. Ciò implica, allora, una netta indistinzione tra logica e ontologia. In base a questi presupposti, la dea addita a Parmenide la via della verità, quella che dice che "solo ciò che è può essere pensato e detto"; la via da non seguire (perché porta al falso) è quella opposta, la via di ciò che non è e che non può essere pensato e detto. Dopo aver succintamente delineato i capisaldi logici della riflessione parmenidea, analizziamo ora la sua speculazione in sede fisica: in opposizione alla via della verità – la sola realmente percorribile -, gli uomini comuni imboccano una terza via pericolosissima, la via dell’opinione; è una via ancora più insidiosa rispetto a quella falsa che dice che ciò che non è può essere pensato e detto, giacchè la via opinativa non è che la pseudoconoscenza che trae origine dal mondo empirico sensorialmente conosciuto. I sensi, infatti, illudono gli uomini, facendo loro credere che le cose divengano incessantemente (tale era stato l’errore di Eraclito e di Cratilo), in una continua vicenda di essere e non-essere, per cui le cose non sono sempre state né sempre saranno, bensì ora sono, domani non sono. Ne nasce l’illusione che l’essere e il non-essere si implichino continuamente a vicenda, là dove la via della verità asserisce che essi si elidono mutuamente. Connessa al divenire è l’idea della molteplicità e del movimento: in questo senso, il mondo appare come una molteplicità di cose in movimento costante e – cosa ancor più grave – gli uomini finiscono per credere che questa sia la via della verità. Con Parmenide è per la prima volta sistematizzata la distinzione tra conoscenza sensibile (svuotata di significato e meramente doxastica) e conoscenza intelligibile (l’unica vera), distinzione destinata a non essere mai più persa di vista nella tradizione successiva. Si tratta di una posizione che svaluta massimamente la fisica e il mondo naturale, inteso come sede dell’inganno: le cose di natura divengono, nascono (cioè vengono ad essere dal non essere) e muoiono (passano cioè dall’essere al non essere); la natura è dunque da Parmenide destituita di ogni fondamento e, con essa, è messa al bando la nozione di molteplicità e di movimento. In questa maniera, la riflessione parmenidea sfocia in un monismo radicale, per cui dell’essere si parla in un unico senso ed è nettamente esclusa l’eventualità del divenire, della molteplicità e del moto. Con tale esclusione, Parmenide si pone al di fuori del novero degli indagatori della natura e – per dirla con Aristotele – egli ha fatto ricerche di altro genere. Ma la posizione da lui maturata costituisce un insormontabile ostacolo per le altre, poiché pone i successori nella necessità di contravvenire il suo divieto (solo ciò che è è pensabile e dicibile): per riabilitare la natura come realtà in senso pieno e per di più come realtà indagabile scientificamente, i successori di Parmenide (i cosiddetti "pluralisti") dovranno riabilitare innanzitutto le nozioni di movimento e di molteplicità; compito reso ulteriormente difficile dal fatto che i discepoli di Parmenide – Zenone e Melisso – elaborano una congerie di argomentazioni inoppugnabili in difesa delle tesi del maestro: i "pluralisti" si troveranno dunque nella difficile situazione di dover aprire una guerra su più fronti (fisico, ontologico, logico). Aristotele ci riferisce che i pensatori immediatamente successivi a Parmenide – anch’essi etichettati come >fusiologoi – sono diversi dai naturalisti ionici poiché, a differenza di questi, assumono alla base della realtà una pluralità di principi, in antitesi al monismo parmenideo: con questi "pluralisti" (così detti perché spiegano la realtà con una pluralità di principi), dell’essere si parla finalmente in molti sensi, benché essi restino saldamente legati ad una concezione dell’essere come materia. Dunque, pur distinguendosi dagli Ionici per l’assunzione di una pluralità di principi (e non di uno solo), i "pluralisti" restano vicini ai loro predecessori ionici nella misura in cui continuano a ritenere di natura materiale i principi costitutivi della realtà. I personaggi più importanti della schiera pluralista sono essenzialmente tre: Empedocle di Agrigento, Anassagora di Clazomene, Democrito di Abdera. Il primo di essi – Empedocle –, operativo all’inizio del V secolo ad Agrigento, presenta ancora i tratti dell’antico sapiente che stende in versi la propria opera e che si occupa di tutto (di medicina, di fisica, di religione, ecc). Discendente da nobile famiglia, Empedocle sceglie di scrivere in versi perché ai suoi tempi la poesia era un’autorità da tutti riconosciuta, che tendeva a meglio diffondersi rispetto alla prosa; a differenza di Parmenide, che dalla poesia aveva ereditato esclusivamente la forma, Empedocle ne assume anche il linguaggio altisonante e roboante, tant’è che Aristotele lo considera l’inventore della retorica. C’è un alone di mistero che circonda le sue opere: il suo scritto principale – intitolato Sulla natura – è affiancato da un altro scritto, tradizionalmente noto come Purificazioni. Il mistero risiede nel fatto che le due opere trattino di cose diversissime tra loro, a tal punto da far dubitare dell’autentica paternità di Empedocle: il Sulla natura è un’opera sensu stricto fisica, mentre dalle Purificazioni traspaiono palesemente influenze pitagoriche ed orfiche, nella misura in cui Empedocle propugna l’immortalità dell’anima (che nel Sulla natura era detta mortale) e la metempsicosi. Le due opere, pertanto, ci restituiscono un Empedocle diverso e, paradossalmente, antitetico. Il mistero si infittisce nel momento in cui ci si chiede se le Purificazioni siano un’opera autonoma o, piuttosto, una parte integrante del Sulla natura. E, in quest’ultimo caso, occorre anche domandarsi in quale parte del Sulla natura debbano essere collocate (all’inizio? alla fine?). Misterioso è anche il fatto che Aristotele sembri conoscere solamente l’Empedocle del Sulla natura e che mai menzioni le Purificazioni (che non conoscesse tale opera pare assai difficile, data la straordinaria erudizione che lo caratterizza). Messo in luce il "giallo" intorno alla figura di Empedocle, proviamo ora a ricostruirne la fisica, alla luce di quanto egli stesso ci ha lasciato nel suo poema Sulla natura: qui, egli spiega la formazione del mondo a partire dall’empiria, ovvero da quel mondo in continuo fieri tanto aborrito da Parmenide. Occorre trovare a fondamento della realtà una pluralità di principi aventi caratteristiche tali da rispettare le norme fissate da Parmenide per il suo essere: unicità (se l’essere fosse molteplice, sarebbe uno e non sarebbe uno, cioè sarebbe e non sarebbe), immobilità (se l’essere fosse in moto, ora sarebbe qui e ora non sarebbe qui, cioè sarebbe e non sarebbe), eternità (se l’essere fosse generato, verrebbe ad essere mentre prima non era). Se si vuole fondare con certezza la realtà spiegandone il divenire e salvando i fenomeni (presupposto a cui tutti i "pluralisti" restano fedeli) senza trasgredire le norme parmenidee, occorre rinvenire più principi aventi tutti le caratteristiche dell’essere parmenideo. Debbono essere molti, poiché altrimenti non si spiegherebbero le molte facce in cui il reale si presenta. Empedocle ritiene di aver individuato i principi in quattro elementi: l’acqua, l’aria, la terra e il fuoco. Tali principi vengono da lui denominati radici ( >rizomata), a sottolineare come essi facciano nascere la realtà e le conferiscano stabilità. Poste a fondamento del reale le quattro "radici", Empedocle arriva a divinizzarle, cosa che può sembrare strana soprattutto se riferita alla terra, che rappresenta il basso. Esse sono all’origine della corruzione e della generazione, pur essendo esse stesse sottratte a tali processi: le cose che cadono sotto i nostri sensi nascono e muoiono non già nel senso che passino dal non essere all’essere e viceversa, bensì nel senso che siano il frutto dell’aggregazione (nascita) e della disgregazione (morte) delle quattro radici, le quali sono però eterne, immutabili, immobili. L’intera realtà – ivi compresi gli dei e l’anima – rientrano in tale processo di aggregazione e corruzione; solamente le quattro radici (corrispondenti all’essere parmenideo) ne restano fuori. Ciascun aggregato è il prodotto della combinazione delle radici, con la conseguenza che il fondamento della realtà è una struttura invisibile soggiacente a quella visibile e tale da spiegarla. Aristotele nota sagacemente che nella ricerca delle cause Empedocle compie un gran passo avanti, distinguendo per la prima volta tra la causa materiale e quella efficiente (detta "causa del movimento"): infatti, per spiegare come le quattro radici possano combinarsi e separarsi, Empedocle fa riferimento ad altre due cause, da lui chiamate Amore e Odio. Sicchè la generazione delle cose nasce dall’unione delle quattro radici in forza dell’azione dell’Amore, mentre la disgregazione è il frutto dell’agire dell’Odio. In questo senso, la cosmologia empedoclea non è che la proiezione sul mondo delle regole (l’odio e l’amore) stanti alla base dei rapporti umani. Amore e Odio agiscono dunque come causa del movimento delle quattro radici, ma non è in alcun caso possibile – nota Aristotele – attribuire ad essi la funzione di cause formali e finali: infatti, non agiscono in vista di un qualche fine, ma il loro processo è anzi, in certo senso, retto dal caso; in realtà Empedocle, alla parola "caso", preferisce "armonia": il processo messo in moto da Amore e Odio è sì casuale, ma tale da creare un’armonia. Il cosmo stesso si configura agli occhi di Empedocle come una totalità ordinata, giacchè soggetto ad una vicenda ciclica che attraversa varie fasi: dapprima prevale l’Amore e le quattro radici si trovano commiste fra loro; poi subentra l’Odio che, introducendo divisioni, permette la nascita dei viventi; in seguito l’Odio prevale e le quattro radici sono del tutto divise. A questo punto, termina il ciclo e riprende da capo. Si tratta di una vicenda ciclica non scandita da divinità, ma autoregolantesi. Con la figura di Anassagora di Clazomene la filosofia sbarca ad Atene (462 a.C.) e da questo momento per i due secoli venturi la città dell’Attica resterà il fulcro della vita intellettuale della Grecia, fino a che il primato passerà – in età ellenistica – ad Alessandria d’Egitto. Quando Anassagora giunge ad Atene, trova una città magnifica, che sta vivendo sotto Pericle i suoi anni più splendidi sul piano culturale (è in quest’epoca che vi operano Sofocle, Euripide, Erodoto e Fidia). Raggiunta Atene, la filosofia muta volto: il naturalismo ionico subisce un’autentica trasfigurazione e lo stesso naturalismo anassagoreo è accusato di empietà, con un processo analogo a quello che vedrà successivamente coinvolti Protagora e Socrate. Proprio in Socrate il naturalismo di cui Anassagora si fa portavoce troverà un ostacolo insormontabile nella propria diffusione. Anche Anassagora, al pari di Empedocle, si interroga sulla costituzione del mondo in termini pluralistici (facendo cioè riferimento a principi molteplici stanti alla base della realtà e tali da spiegarne la molteplicità). Se Empedocle era ricorso a quattro "radici", Anassagora è invece convinto che a rendere conto del mondo possano essere un’infinità di principi infinitamente divisibili: è questa l’unica maniera per spiegare l’infinita varietà in cui si articola il reale. Anch’egli, come Empedocle, ricorre ad un referente di tipo biologico: i principi primi sono da lui detti "semi" ( >spermata) di tutte le cose, ad evidenziarne la funzione (i semi sono in natura ciò da cui tutto nasce). Dunque anche Anassagora innalza a livello cosmico la realtà quotidianamente esperita. Aristotele, quando parla dei "semi" anassagorei, li etichetta come "omeomerie", ovvero come "parti simili" ( >omoioV + meroV), a sottolineare come essi siano a loro volta composti da un’infinità di parti simili fra loro. Dal combinarsi dei semi, nascono i vari composti che cadono sotto i nostri sensi: ciascuno di tali composti è una mescolanza di tutti gli infiniti semi, cosicché Anassagora può a ragion veduta asserire che "tutto è in tutto". In ogni oggetto ci sono tutti gli infiniti semi, ma non in egual quantità: anzi, l’oggetto è quel che è in forza della prevalenza numerica di determinati semi (il pane è tale perché in esso i semi di pane sono in netta maggioranza su tutti gli altri infiniti semi, che pure sono presenti). Tuttavia noi percepiamo sempre e solo i composti, mai i semi di per sé: non meno delle radici empedoclee, i semi anassagorei rappresentano la struttura profonda del reale visibile ai soli occhi della mente. E dagli oggetti visibili – che nascono dall’aggregazione dei semi – noi muoviamo per conoscere intellettualmente i semi: per meglio chiarire questo punto nodale, Anassagora adduce l’esempio dell’alimentazione. Quando mangiamo il pane, noi cresciamo in parti diverse (carni, peli, unghie, capelli, ecc), poiché nel pezzo di pane che ingeriamo sono compresenti tutti gli infiniti semi (anche della carne, del sangue, delle unghie, ecc); sicchè, mangiando il pane, stiamo non di meno mangiando anche la carne, il sangue, le unghie, ecc. Questo spiega il celebre frammento di Anassagora secondo cui " >oyiV adelwn ta fainomena", che in italiano suona: "il visibile è uno sguardo lanciato sull’invisibile"; le cose che cadono sotto i nostri sensi rimandano ai semi costituenti il reale. Non è chiaro se Anassagora riconosca la possibilità dell’esistenza di infiniti mondi, benché tale possibilità sia pienamente compatibile con l’infinità dei semi. Anche per lui, i processi del divenire dipendono dall’aggregazione e dalla disgregazione dei semi (per questa via, il problema eleatico è aggirato): stando così le cose, quale causa mette in movimento, in origine, i processi del divenire? Se Empedocle aveva mobilitato l’Amore e l’Odio, Anassagora scomoda un solo principio e sostiene che, nell’indistinzione ( >migma) originaria dei semi, è il >NouV (Intelligenza) a porre ordine; esso è un principio intelligente che mette in moto i semi. In sintonia con la tradizione a lui precedente, Anassagora individua un principio caratterizzante la vita umana (l’intelligenza) e lo assume come ordinatore del tutto. Platone prima e Aristotele dopo notano con entusiasmo la novità introdotta da Anassagora: per la prima volta compare sulla scena, come principio in grado di spiegare il mondo, un’Intelligenza ordinatrice. Pur non asserendo in alcun luogo che l’Intelligenza sia separata, egli insiste nel sottolineare come essa sia comandante assoluto della materia senza a sua volta essere comandata. Aristotele precisa che non ci si deve far trarre in inganno dalla terminologia anassagorea e credere che, parlando di Intelligenza, questi abbia introdotto una causa finale o formale: l’Intelligenza, infatti, non forma le cose in vista di alcun fine; prova ne è – nota Aristotele – che le cose determinate si formino per mera prevalenza quantitativa, ovvero secondo un criterio accidentale. Ciò non toglie, tuttavia, che Anassagora, pur non essendo stato così lungimirante da cogliere la causa finale (l’Intelligenza è e resta una causa efficiente), paia ad Aristotele "un sobrio in mezzo a degli ubriachi", giacchè egli solo ha identificato il principio ordinatore del cosmo in un’Intelligenza; questa – prosegue lo Stagirita – è stata da Anassagora impiegata come il deus ex machina, il Dio calato in scena dai tragediografi per sciogliere i nodi della vicenda. Con Diogene di Apollonia (metà del V secolo a.C. circa), la filosofia pare bruscamente far marcia indietro verso le posizioni elaborate dai naturalisti ionici e oramai superate dai "pluralisti": Diogene, infatti, è convinto che la realtà quale ci appare possa essere spiegata scomodando un solo principio e per di più di ordine materiale. In sintonia con Anassimene, egli ritiene che tale principio possa essere ravvisato nell’aria, il che – nota Diogene – risulta particolarmente evidente se prestiamo attenzione a quanta importanza abbia l’aria per la vita. Ma gli insegnamenti di Anassagora – che forse Diogene ebbe modo di conoscere – non sono passati invano: Diogene, infatti, identifica l’ >arch nell’aria (cosa che fa di lui, in certo senso, uno "Ionico in ritardo"), ma poi conferisce a tale principio quell’intelligenza che Anassagora aveva attribuito al >NouV. L’aria è dunque un principio dotato di intelligenza tale da agire in maniera finalistica (e qui sta la grande novità apportata da Diogene), organizzando le cose nel miglior modo possibile. In virtù dell’aria e delle sue qualità è poi possibile distinguere una pluralità di fasce climatiche nel mondo, le quali influenzano in maniera necessitante il carattere degli individui che in esse vivono: in ciò risiede quello che potremmo definire come "determinismo ambientale" di Diogene. Gli uomini che conducono la loro esistenza in zone particolarmente arieggiate e secche – è questo il caso dei Greci – riveleranno una particolare acutezza d’ingegno, mentre quelli che vivono là dove l’aria è umida e pesante, risulteranno più tardi e meno svegli. Un determinismo ambientale affine a quello emerso in Diogene di Apollonia ritorna nello scritto medico – appartenente al corpo ippocratico – intitolato Arie, acque, luoghi: il medico deve prestare particolare attenzione ai luoghi, all’aria e all’acqua che caratterizzano l’ambiente giacchè egli deve scientemente tenerne conto nella prescrizione delle diete e nella diagnosi delle malattie (che trovano nell’aria uno dei principali veicoli di trasmissione). Il messaggio che emerge dallo scritto è che le arie, le acque e i luoghi condizionano in maniera imprescindibile la costituzione umana, sia nel bene sia nel male, cosicché il buon medico dovrà conoscere in maniera adeguata l’ambiente circostante per poter così meglio svolgere la sua attività terapeutica. In questa prospettiva, l’autore dello scritto si lancia in un’autentica fisiognomica ambientale, facendo corrispondere a determinati individui determinati territori (ad esempio, chi è nato in zone boscose presenterà specifiche caratteristiche, e così via); tale corrispondenza si riverbera anche sui popoli: in particolare, l’autore di Arie, acque, luoghi instaura un raffronto tra i Greci e gli Orientali, notando come questi ultimi – poiché viventi in zone calde e secche – siano generalmente indolenti e pigri e, in forza di ciò, facilmente governati da tiranni. Al contrario, il clima solare e felice dei Greci fa sì ch’essi siano particolarmente briosi e agguerriti, pronti al pensiero come all’abbattimento delle tirannidi. Stante l’indiscutibile necessità della natura, resta però un interstizio in cui può inserirsi la libertà umana: tale è l’istituzione politica ( >nomoV), grazie alla quale l’uomo può liberamente ritagliarsi uno spazio d’azione i cui confini non possono essere varcati dall’agire necessitante della natura. Così, le popolazioni orientali sono rette da grandi dispotismi e il >nomoV coopera a renderle militarmente inette (manca del tutto l’interesse a ribellarsi alla tirannide); sull’altro versante, il clima e l’ambiente greco sottopongono l’uomo a cambiamenti rapidi, come rapido dev’essere il pensiero: e le istituzioni politiche presso di loro in uso non fanno che cooperare col clima controbilanciandone la necessità. Lo spazio riservato dall’autore dello scritto al >nomoV è parecchio, tant’è che egli arriva addirittura a riconoscere come il >nomoV possa diventare una seconda natura: per chiarire questo punto, egli adduce l’esempio della popolazione dei Macrocefali, presso la quale era segno di prestigio avere la testa schiacciata; per questo motivo, la testa dei bambini veniva schiacciata, cosicché – nota l’autore dello scritto -, a furia di schiacciarla, le generazioni future sarebbero nate già con la testa schiacciata. In questo senso, il >nomoV può perfino trionfare sulla >fusiV: anzi, >nomoV e >fusiV sono per l’autore ippocratico due entità combinatisi fra loro. I Sofisti, dal canto loro, tendono a leggerle piuttosto come due realtà opponentisi. Anche l’atomismo si configura come teoria "pluralistica" che si propone di spiegare il cosmo senza trasgredire le prescrizioni parmenidee: l’iniziatore della corrente atomistica sembra essere stato Leucippo, figura che per noi non è che un nome, visto la scarsissima quantità di materiale sul suo conto che possediamo; ben di più sappiamo sul suo collega Democrito di Abdera, il quale scrisse – come i Sofisti – una miriade di opere sui più svariati argomenti, benché di esse non ci siano giunti che frammenti. Anche Democrito, come già Anassagora, assume come struttura della realtà invisibile ad occhio nudo un’infinità di principi, ancorché questi non siano infinitamente divisibili: se infatti tutto fosse divisibile all’infinito, allora il mondo avrebbe dovuto cessare di essere già da tempo. I principi primi della realtà come li intende Democrito debbono essere pieni e privi di parti: tali sono quelli che egli definisce >atoma swmata, ovvero – letteralmente – "corpi non ulteriormente tagliabili", costituenti la struttura profonda del reale. Questi "atomi", per potersi muovere e per consentire la generazione e la corruzione dei composti, devono avere uno spazio entro cui muoversi ed è per questa ragione che Democrito introduce come secondo principio il vuoto ( >to kenon), condizione imprescindibile del moto atomico. Gli stessi aggregati non sono che unioni di atomi e vuoto: il che è provato dal fatto che, consumandosi, i corpi cedono atomi e, perché ciò possa avvenire, dev’esserci il vuoto. Con terminologia eleatica, Democrito chiama gli atomi e il vuoto rispettivamente "essere" e "non essere"; egli asserisce poi – riprendendo l’antitesi sofistica – che la conoscenza intellettuale (avente come oggetto gli atomi e il vuoto) è >kata fusin (secondo natura), mentre quella degli aggregati è >kata nomon (secondo convenzione). Sicchè secondo natura conosciamo gli atomi e il vuoto, secondo convenzione il bianco, il profumato, ecc. Le cose che costantemente esperiamo non sono dunque la verità, ma mera parvenza. Essendo gli atomi infiniti, infiniti saranno anche i mondi che dalla loro aggregazione trarranno origine, cosicché Democrito può relativizzare la vita che conduciamo sul nostro e può inoltre evitare di far ricorso a cause extra-materiali. Incarnando in sé l’essere parmenideo (ed essendo dunque immutabili, eterni, incorruttibili), gli atomi come si distinguono fra loro? Per Empedocle e Anassagora, i principi si differenziano qualitativamente, il che tra l’altro spiega perché i corpi composti presentino qualità; per Democrito invece – stando a quel che riferisce Aristotele – gli atomi si differenziano fra loro per caratteristiche quantitative. Per far luce su questo punto della dottrina democritea, Aristotele esemplifica servendosi delle lettere dell’alfabeto, che egli chiama >stoiceia: e >stoiceia sono anche gli "elementi", con la conseguenza che gli atomi sono un po’ come le lettere dell’alfabeto e il mondo che ne risulta si presenta come una sorta di libro le cui lettere sono gli atomi. Per forma ( >rusmoV) gli atomi si distinguono fra loro come la A si distingue dalla N; per ordine ( >diaqigh) come AN da NA; per posizione ( >troph) come Z da N. Si tratta evidentemente di differenze puramente geometriche, con caratteristiche misurabili. Tuttavia Democrito si spingeva oltre: pare infatti che, poste queste tre differenze di base, egli asserisse che gli atomi sono dotati di un numero incalcolabile di differenze, a tal punto che egli finisce col riconoscere – il che gli costerà la derisione da parte dei suoi avversari – l’esistenza di atomi di forma uncinata. Il problema cui Democrito è chiamato a rispondere è che, se gli atomi sono quantitativamente connotati, come si spiega che poi noi percepiamo qualitativamente i composti? Perché se la rosa non è che un aggregato di quantità noi la percepiamo rossa, profumata, ecc? Per render conto di ciò, Democrito spiega le qualità come epifenomeni delle quantità, cosicché il bianco deriverebbe da un assetto casuale dato dall’unione di atomi: la rosa non è che un aggregato di atomi quantitativamente connotati che però, colpendo i nostri organi di senso, generano impressioni qualitative (il profumo, il colore rosso, ecc). Un altro problema su cui Democrito deve affaticarsi riguarda la natura stessa degli atomi: se essi sono corpi invisibili e indivisibili, allora non avranno parti e saranno come enti geometrici; ma allora come è possibile ch’essi, privi di parti, si aggreghino e formino corpi divisibili costituiti da parti? Come possono muoversi? Democrito sostiene che gli atomi sono ab aeterno dotati di moto (il che implica il vuoto in eterno) e, più precisamente, si muovono in qualunque direzione senza tregua, con la conseguenza che possono casualmente incontrarsi e aggregarsi (ciò nel caso in cui le forme siano compatibili, come ad esempio quando si incontrano atomi ad uncino e atomi ad anello). A regolare il moto degli atomi non è una forza esterna o un adivinità: l’unica legge (se in questo caso di legge si può parlare) regolante il loro movimento è il caso, non già nel senso ch’essi si muovano senza causa, bensì nel senso che il loro è un moto spontaneo, scevro di finalità e non extra-naturale: è un moto che tiene conto della legge per cui il simile attira il simile. Tutto risponde ad una ragione e ad una ferrea necessità. Oltre a negare la causa finale, l’atomismo nega quella efficiente – nota Aristotele -, giacchè per Democrito essa non è se non una proprietà della materia. Con Democrito si esauriscono le filosofie della natura del V secolo a.C. prima di Platone. Mentre Anassagora e Democrito erano attivi, già operava ad Atene quella nuova figura di filosofo che è Socrate, che dalla città attica mai si allontanò. La prima difficoltà che s’incontra nel ricostruire il suo pensiero risiede nel fatto che egli non ha scritto nulla, benché le opere su di lui siano assai numerose. Nel 423 a.C., il commediografo Aristofane mette in scena Le nuvole, un’indiavolata commedia al cui centro è proprio la figura di Socrate (quella di Aristofane è la testimonianza più antica su Socrate), sebbene trasfigurata dalle esigenze comiche proprie dell’opera. Stando a quel che dice il suo allievo Platone, Socrate sceglie volutamente di non scrivere e di occuparsi di valori umani anziché di fisica; le conoscenze naturalistiche, infatti, hanno ben poco da insegnare e così egli si esprime nel Fedro (230 d): "a me piace apprendere, ma la campagna e gli alberi non vogliono insegnarmi nulla, a differenza degli uomini della città". Sempre nel Fedro (274 b e seguenti) è spiegata – con il mito di Theuth – la scelta socratica di non affidare alla scrittura il proprio messaggio filosofico: la vera filosofia è quella orale, attuatesi dialogicamente nella pratica della domanda e della risposta, mentre lo scritto è "un bronzo percosso", ovvero un bronzo che, colpito, dà sempre lo stesso suono. La testimonianza di Platone (peraltro avvalorata da Senofonte, anch’egli discepolo di Socrate) parrebbe dunque diametralmente opposta a quella di Aristofane: ne Le nuvole, infatti, Socrate ci è presentato non già come il filosofo dei valori umani, che antepone gli uomini alla natura (Fedro) e che attacca su più fronti i sofisti (Sofista, Teeteto, Apologia, ecc), bensì – e qui sta l’aspetto paradossale – come un naturalista che identifica le nuvole in divinità! In forza di ciò, Socrate è messo in scena all’interno di una cesta (il "pensatoio") sospesa a mezz’aria ed è addirittura tratteggiato come un venditore di sapere, capace di far trionfare il Discorso ingiusto su quello Giusto; in altri termini, il Socrate che Aristofane propone è un naturalista empio e assai vicino alla sofistica. E del resto questa era l’immagine che doveva far maggior presa sull’animo degli Ateniesi, se è vero che nell’Apologia Socrate ravvisa nelle "antiche accuse" (quelle appunto mossegli sulla scena da Aristofane) l’origine delle sue disavventure giudiziarie. Stando così le cose, parrebbe che la posizione socratica sia alquanto prossima a quella anassagorea, in quanto entrambe incentrate sull’indagine naturalistica, quando in realtà Platone non fa che ripeterci che Socrate mai si interessò di fisica. La lontananza tra le intenzioni animanti il pensiero di Socrate e quello di Anassagora sono ancora meglio lumeggiate nel Fedone platonico, ambientato nelle ore che precedono la morte di Socrate: in quest’opera sull’immortalità dell’anima, il filosofo ateniese narra il proprio itinerario intellettuale a partire dai suoi iniziali interessamenti per le ricerche naturalistiche, che presto avrebbe abbandonato per dedicarsi a trecentosessanta gradi all’uomo e ai suoi valori. A quell’epoca risale la sua attenzione per il pensiero di Anassagora: ma, dopo essersi procurato e aver letto il suo scritto Sulla natura, si sentì profondamente insoddisfatto, giacché Anassagora si limitava ad indicare la causa materiale e quella efficiente, trascurando del tutto quella finale, ossia la "causa del bene e del meglio". Fu allora che Socrate si accorse della necessità di dover intraprendere quella seconda navigazione ( >deuteroV plouV) che l’avrebbe fatto approdare ai lidi delle Idee (nel Fedone ancora chiamate >logoi), capaci di render conto delle cose in maniera teleologica. Se dinanzi alla domanda "perché Socrate è seduto in carcere anziché essere in fuga?" Anassagora risponde scomodando solamente la causa materiale e quella efficiente, asserendo che il suo corpo ha assunto una posizione seduta anziché retta e in fuga, Socrate risponde invece che c’è una causa del bene e del meglio che esula dalla materia di cui Socrate è costituito e che riguarda piuttosto la sua anima: in altri termini, fuggire ed evadere dal carcere sarebbe per l’anima il male peggiore. Ripercorrendo in maniera sintetica l’iter intellettuale di Socrate, non sfugge come egli, partito da interessi naturalistici (anche perché, prima di lui, non v’era stata pressoché alcuna filosofia che non fosse naturalistica), muti assai in fretta interessi, dedicandosi a ricerche di altro genere. Ciò, tra l’altro, spiega perché nella Repubblica Platone non annoveri la fisica tra le scienze componenti il curriculum del filosofo, riservando invece un posto privilegiato alla matematica, alla geometria, alla stereometria, all’astronomia e alla musica. La fisica appartiene secondo Platone e Socrate all’ambito della conoscenza doxastica, poiché i suoi oggetti sono – secondo l’insegnamento di Cratilo e di Eraclito – sempre in divenire, mai afferrabili pienamente dalla mente umana. Tuttavia anche Platone, che col maestro Socrate condivide l’avversione per la fisica, ci prende di sorpresa quando, all’interno della sua vastissima produzione, dedica alla filosofia della natura un dialogo di fondamentale importanza come il Timeo: Platone ormai anziano torna sui suoi passi e riabilita quella fisica cui in gioventù aveva negato lo statuto di scienza e fa ciò forse in virtù delle discussioni tenute nell’Accademia. Il Timeo è un dialogo in cui Socrate si è ormai ritirato dalla scena: il protagonista, Timeo di Locri, è esperto di matematica e, forse, di medicina. Anche l’esposizione è mutata: all’arioso dialogo costruito sulla prassi del "botta e risposta", Platone ha ormai sostituito una forma dialogica più pesante, in cui si procede per ampi brani espositivi intervallati da brevi risposte. Tutto ciò non deve però indurci a credere che egli smentisca se stesso e confuti quanto detto negli anni passati: prova ne è il fatto che le dottrine cosmologiche del Timeo sono esposte sotto forma di mito; questo perché il mito – come è noto – riveste in Platone una valenza fortemente pedagogica, ma anche perché egli sente la necessità di restar fedele al suo pensiero precedente, incentrato sulla convinzione che del mondo fisico non sia dato avere certezze. In sostanza, quel che Platone ci propone nel Timeo – che sarà l’opera privilegiata, in età medievale, dalla cosiddetta "Scuola di Chartres" – è un’ulteriore riflessione sul rapporto intercorrente tra le Idee e il mondo, tema già al centro del Parmenide. Poiché gli oggetti sensibili sono in perpetuo divenire, di essi sarà possibile non già l’ >episthmh, bensì la >doxa: sicchè l’opera stessa si configura, più che come trattato di fisica, come racconto immaginifico di come le cose possono essere venute ad essere. Al cuore del Timeo è la figura chiave del Demiurgo, il divino artigiano che ordina il mondo: il ricorso alla figura di un tecnico permette a Platone di chiarire fin dall’inizio come Egli operi su di una materia che Gli preesiste e che dunque non è il frutto di una Sua creazione. In questo senso, si può dire che il Demiurgo si limita a conferire la forma ad una materia autonomamente esistente: per questa via, è messa al bando ogni prospettiva creazionistica, il che dovrebbe far ricredere i vari pensatori che hanno letto nel Timeo un’anticipazione delle tesi cristiane. La negazione della prospettiva creazionistica chiarisce poi a quali cause Platone ricorra per spiegare il mondo: in primo luogo ci sarà la materia (quella che Aristotele definisce causa materiale) e, accanto ad essa, impersonificata dal Demiurgo, la causa efficiente (Egli infatti trae le cose dalla materia). Ma, trattandosi di un artigiano divino, Egli non può che disporre le cose nel miglior modo possibile, cosicché ciascuna di esse è orientata al meglio: in questo senso, sono introdotte la causa finale e quella formale. Le cause mobilitate da Platone – il Demiurgo e la materia – paiono però difficilmente conciliabili fra loro (come del resto inconciliabili sono il corporeo e l’incorporeo). Il Demiurgo agisce conferendo forma ad una materia che, originariamente, non ne ha una e che anzi si presenta come altamente caotica: il Suo agire è significativamente raffrontato da Platone a quello dei legnaioli che mettono ordine nella catasta di legna. Ne risulta – per dirla con Leibniz – il migliore dei mondi possibili, proprio perché frutto dell’azione di un principio divino intelligente. Per di più, come tutti gli artigiani, il Demiurgo lavora la materia avendo in mente un preciso modello a cui ispirarsi: tale modello non è se non l’intelligibile mondo delle Idee, cosicché Egli opera sulla materia cercando di trasferire in essa il più fedelmente possibile le Idee. Ne nasce sì il migliore dei mondi possibili, ma non è un mondo perfetto in assoluto: la materia, infatti, costituisce un insuperabile limite all’agire divino del Demiurgo, giacchè essa mai si lascia interamente "dominare" (la metafora bellica è di Aristotele); in maniera immaginifica, Platone dice che la materia non si lascia "persuadere", metafora che ritorna nella Repubblica, allorché si parla di anima razionale e di anima irrazionale. Resta ora da chiedersi perché il Demiurgo generi il mondo: Platone risponde che ciò avviene perché l’artigiano divino è buono e "in chi è buono non nasce mai nessuna invidia. […] Volle che tutte le cose si generassero simili a Lui, per quanto potevano". In altri termini, nel Demiurgo troviamo quella "causa del bene e del meglio" che Socrate non era riuscito a rinvenire nel testo di Anassagora. Il mondo sarà allora provvidenzialmente ordinato, ovvero retto fin da principio dalla divina provvidenza di un’intelligenza che lo rende ordinato e tale lo mantiene: nulla è lasciato al caso, dal cielo fino alle viscere della terra. La metafora impiegata da Platone per illustrare il rapporto tra il Demiurgo e il mondo che ne deriva è particolarmente chiarificante: in quanto "Padre" del mondo, il divino artigiano è ad esso legato da un rapporto d’amore affine a quello che lega il padre al figlio. L’opera ordinatrice esplicata dal Demiurgo già si manifesta nella forma che Egli impone ai quattro elementi costitutivi della realtà (elementi che Platone, in sintonia con Empedocle, ravvisa nella terra, nell’acqua, nell’aria e nel fuoco): la prima determinazione d’ordine della materia consiste nel qualificarla nei quattro elementi con qualità (caldo, freddo, secco, umido); la forma dei quattro elementi è a sua volta ridotta ad una figura geometrica elementare: il triangolo, il quale, formando poliedri, dà la struttura matematizzante dell’universo. Ne consegue allora che l’universo fisico rinvia ad una struttura di tipo geometrico sempre identica: in questo modo, la matematica è e resta (ciò era già vero nei Pitagorici e nella Repubblica, dove le scienze matematiche rinviano al mondo delle Idee) il vero strumento per conoscere il mondo. Così concepito, l’universo è una struttura ordinata perfettamente conoscibile, in cui tutto si ripete immutabile e regolare. L’ordine trova un suo primo garante nel moto immutabile e regolare degli astri, da Platone considerati come divinità (il che ha indotto alcuni interpreti a parlare di teologia astrale in Platone): il tempo che scandisce le vicende fisiche è misurato in base al moto degli astri ed è perciò "immagine mobile dell’eternità". Il mondo sensibile, che si presenta come un’opera d’arte, essendo generato ha un corpo (a differenza dell’incorporeo mondo delle Idee) e quest’ultimo è unico (come unico è il mondo delle Idee) e – a differenza di quel che credeva Democrito – disposto nella forma migliore di tutte: la sfera, in cui tutti i punti sulla circonferenza sono equidistanti dal centro. Dal fatto che sia dotato di corpo, Platone inferisce che il mondo possegga anche un’anima, inferenza avvalorata dal fatto che esso è popolato da esseri dotati di anima (una proprietà delle parti deve di necessità appartenere anche al tutto). Ma se quest’opera d’arte che è il mondo possiede l’anima, allora dovrà possedere l’anima migliore in assoluto: quella intellettiva. Il mondo si configurerà allora come un immenso vivente ( >zwn) che si muove in maniera ordinata, perché diretto dallo stesso principio razionale che governa l’uomo, con la cui descrizione il Timeo si chiude. Il fatto stesso che l’uomo – unico tra i viventi – abbia posizione eretta è indizio della preminenza in lui della testa, che è qui da Platone accostata all’acropoli, costituente il cuore pulsante della città. L’uomo dipende dunque dall’alto e, a rimarcare ciò, la natura ha provvisto a separare in maniera netta in lui la testa dal resto del corpo attraverso il collo. Con questi presupposti, Platone dà anche una spiegazione delle malattie: esse sono sì frutto di una cattiva disposizione del corpo, ma risentono anche di una cattiva educazione (il che rivela un recupero da parte di Platone della tematica cara a Socrate dell’analogia tra malattia dell’anima e ignoranza). L’opera si chiude con un’esortazione rivolta agli uomini a diventare come la divinità, poiché l’eliminazione dell’ignoranza porta a migliori reincarnazioni. Il Timeo platonico è il bersaglio polemico in riferimento al quale Aristotele matura la propria filosofia della natura: nello studio della fisica rientrano, secondo lo Stagirita, anche lo studio degli animali e perfino quello dell’anima, cosicché non stupisce se la maggior parte dei suoi scritti possono essere considerati scritti di fisica. Il problema preliminare che egli si pone è se la fisica debba oppure no essere ascritta tra le scienze: il fatto che egli si ponga un tale problema adombra una volontà di confronto con Platone e con la sua negazione dello statuto di scienza all’indagine sulla natura. Se per Platone una sola è la scienza (quella del Bene) e da essa derivano gerarchicamente tutte le altre forme di sapere, Aristotele, dal canto suo, ci fornisce una completa classificazione delle scienze (Metafisica, VI) in teoretiche, pratiche, poietiche. Teoretiche sono quelle che hanno a che fare con la pura teoria, pratiche sono invece quelle concernenti la prassi (la politica e l’atica) e, infine, poietiche sono quelle finalizzate alla produzione di oggetti (ad esempio, la tragedia). Sicchè nell’ambito delle scienze teoretiche Aristotele fa rientrare la metafisica ("filosofia prima"), la matematica e la fisica ("filosofia seconda"): non solo la fisica è una scienza, ma addirittura essa appartiene alle scienze supreme, quelle che debbono essere amate e perseguite in quanto tali, senza secondi fini. Ciò evidentemente rivoluziona il quadro tracciato da Platone, in cui la fisica non era nemmeno degna di essere una scienza. Le tre scienze teoretiche ravvisate da Aristotele studiano in tre maniere distinte l’essere: la matematica studia l’essere privo di movimento, la fisica studia l’essere in movimento, la metafisica studia l’essere in quanto essere e coincide (Metafisica, XII) con la teologia. Per Platone, proprio perché rivolta alle cose transeunti, la fisica non può assurgere al grado di scienza: ciò non vale per Aristotele, ad avviso del quale è possibile studiare le cose nel loro divenire. Ciò non toglie, però, che la fisica – a differenza della metafisica, che studia l’essere in quanto tale – sia una scienza particolare, giacché si occupa solo dell’essere in movimento e, perciò, difetta di universalità: oltre ad occuparsi dei corpi terreni, caratterizzati dall’essere passeggeri e non eterni, Aristotele fa rientrare nel campo d’indagine della fisica anche lo studio dei corpi celesti. Con quest’operazione, egli pone l’astronomia come scienza fisica e non come scienza matematica (quale era per Platone), poiché gli astri sono anch’essi corpi in movimento, benché – a differenza dei corpi terrestri – non siano soggetti al divenire, ma esistenti sempre e necessariamente. Ne segue che gli orizzonti della fisica finiscono per spaziare dalla terra al cielo. Il confine tra il mondo terrestre – popolato dai corpi in divenire – e quello celeste – popolato dai corpi eterni – è segnato dalla luna, che divide appunto il mondo sublunare da quello sopralunare. Le scienze teoretiche riguardano cose esistenti necessariamente, ma all’interno della fisica è ritagliato uno spazio anche per i corpi passeggeri e non eterni: le pietre, gli uomini e gli animali possono infatti non esistere e, in ogni caso, sono perituri; essi tuttavia rispondono ad una modalità dell’essere che è >epi to polu (per lo più), per cui gli uomini invecchiando diventano per lo più canuti. Nell’ambito del mondo fisico terrestre, allora, pur non valendo la necessità assoluta, ciò non di meno vale la necessità condizionale, tale per cui, se si verifica una tale condizione, si verifica un tale effetto (ad esempio: se invecchio, mi vengono i capelli bianchi). Sicchè i corpi del mondo fisico di questa terra presenta caratteristiche fluttuanti (il colore degli occhi, dei capelli, l’altezza, ecc), con l’inevitabile conseguenza che, a differenza della matematica, la conoscenza fisica non potrà mai essere esatta né potrà fare ricorso a dimostrazioni analitico/deduttive (Platone riduce invece nel Timeo gli elementi fisici a enti geometrici matematicamente studiabili). La fisica difetta dunque di universalità, di esattezza e di necessità: come ogni altra conoscenza, anche quella fisica procede per cause e quali siano tali cause Aristotele lo spiega nel II libro della Fisica, per poi riprenderlo nel I della Metafisica: le quattro cause che egli individua non sono che le risposte da fornire quando ci si interroga sulla natura di qualche cosa e tale dottrina è evidentemente dedotta dall’osservazione diretta dei corpi: osservandoli, si nota infatti che essi rispondono a quattro diversi punti di vista, ovvero risultano dalla convergenza di quattro cause. Infatti, le cose hanno una materia, sono prodotte da qualcuno, sono tali perché hanno una forma che le individua e hanno uno scopo per il quale sono venute ad essere: qui in sintonia con Platone, Aristotele crede che la struttura eretta sia stata data all’uomo affinché egli possa contemplare le realtà superne; ma Aristotele non dimentica che le cose hanno anche una materia che le condiziona: così l’uomo può stare in piedi perché possiede calore e il calore tende appunto verso l’alto. La materia e la forma non sono – secondo Aristotele – separabili l’una dall’altra, col che egli si distingue nettamente dalla posizione platonica, per cui le forme ( >eidh) sarebbero radicalmente distinte dalla materia ( >ulh); inoltre l’assetto fisico di ogni cosa è tale perché deve rispondere ad un dato fine e la forma è quella che è perché è stata organizzata in vista di tale fine. Solo chi conosce tutte e quattro le cause delle cose può essere insignito del titolo di >fusikoV (fisico), giacchè egli solo è in grado di indicare di che cosa le cose sono fatte, a quale fine tendono, quale forma hanno, che cosa le ha messe in moto. Abbiamo detto che Aristotele innalza lo studio della natura al livello di scienza: ma che cosa intende esattamente per natura? Non si tratta di una specie di griglia che si sovrappone dall’esterno alle cose che sono. La natura non è che l’insieme di tutte quelle cose che avvengono naturalmente. Esiste dunque una causa finale e divina – quale era il Demiurgo del Timeo – che fabbrica le cose in vista di un determinato fine? Secondo Aristotele tale eventualità è da escludersi per due ragioni: nel II libro della Fisica, egli asserisce espressamente che la natura non è divina e paragona la sua attività a quella tecnica; tuttavia, a differenza della tecnica divina (che è infallibile), la tecnica umana è soggetta a fallire: similmente, in natura non tutto avviene in maniera perfetta. Come il grammatico può commettere errori o come il medico può prescrivere farmaci inadeguati, così la natura può parimenti compiere errori, benché il suo agire sia sempre e comunque orientato al meglio: tale principio viene da Aristotele dedotto a partire dalla biologia, dove si registrano casi di veri e propri mostri (ad esempio esseri con parti mancanti o in sovrappiù) e devianze dalla norma della natura che vuole che gli uomini nascano per lo più in un certo modo. La possibilità dell’errore della natura è resa possibile dal fatto che si tratta di un ambito di cose materiali e, come abbiamo poc’anzi detto, la materia non sempre si lascia dominare dalla forma, a volte le oppone resistenza (tale è ad esempio il caso della mano con quattro dita anziché cinque). Si può dunque legittimamente affermare che "il caso rientra nel novero delle cause", intendendo con ciò dire che anche quel che accade per caso ha pur sempre una sua causa, anche se l’effetto risulta derivare da una causa diversa da quella in forza della quale solitamente accade: ossia avviene per accidente ( >kata sumbebhkwV). Può dunque accidentalmente accadere che, nel corso della generazione, la materia non si lasci plasmare e ne nasca un mostro. L’individuo di sesso femminile è esso stesso agli occhi di Aristotele un caso di errore della natura, un mostro prodotto dal caso: agendo sul sangue mestruale, il seme maschile forma la materia ed è a questo punto che può verificarsi la devianza; nascere femmina è, appunto, una devianza, ma si tratta pur sempre di una "mostruosità necessaria" al fine di perpetuare la specie. Il fatto stesso che i figli non siano mai del tutto uguali ai genitori, ma da essi si distinguano per altezza, colore dei capelli, degli occhi, ecc, testimonia l’accidentalità del processo. Abbiamo detto che per Aristotele la fisica è scienza teoretica dei corpi dotati di movimento: resta però da chiarire che cosa egli intenda per movimento ( >kinhsiV). Movimento è passaggio da potenza ad atto di corpi che possono muoversi e nel movimento rientra anche la nozione di mutamento ( >metabolh), poiché il greco >kinhsiV significa appunto sia movimento sia mutamento. Se il movimento riguarda lo spostamento nello spazio da un luogo ad un altro, il mutamento riguarda invece l’essere stesso delle cose che sono e, a tal proposito, Aristotele distingue quattro diversi tipi di mutamento: a) il mutamento più ovvio è quello di luogo, consistente nello spostarsi da un luogo ad un altro; b) il mutamento della sostanza è quello consistente nella generazione e nella corruzione (ovvero il venire ad essere o il cessare di essere delle sostanze): è in questo contesto che Aristotele risolve finalmente in via definitiva l’aporia eleatica del divenire fisico: venire ad essere mentre prima non si era non significa – egli nota – passare dal non essere all’essere, ma significa piuttosto passare dallo stato potenziale dell’essere in potenza a quello attuale dell’essere in atto; c) il mutamento quantitativo interessa anch’esso la sostanza, ma esclusivamente rispetto alle proprietà che essa presenta (una data sostanza può crescere o diminuire in quantità); d) infine, il mutamento qualitativo interessa – come quello quantitativo – le proprietà della sostanza (e non la sostanza in se stessa), in particolare le sue qualità (ad esempio, i capelli che da neri che erano passano ad essere bianchi; oppure Socrate che diventa musico). Come si può facilmente notare, ciò che contraddistingue il mutamento quantitativo è il fatto che esso avviene nello spazio, giacchè la sostanza – accrescendo o diminuendo – occupa spazio. Tuttavia, accanto al movimento spaziale, ve n’è anche uno locale, caratterizzato da un’unica direzione: o dal basso verso l’alto, o viceversa. Ciò vale per il mondo sublunare, poiché i corpi di quello sopralunare sono invece dotati di moto semplice (ovvero circolare: spuntano e tramontano sempre nel medesimo punto) in forza della particolare materia che li costituisce: si tratta non già dei quattro elementi empedoclei che stanno alla base dei corpi sublunari, bensì di quella materia incorruttibile che Aristotele chiama etere. Agli occhi di Aristotele, i corpi si distinguono in semplici e in composti, ed entrambe le categorie cadono nel campo d’indagine della fisica: alla base di tutti i corpi che popolano il mondo sublunare stanno i quattro elementi individuati da Empedocle: a tal proposito, Aristotele rigetta tanto gli atomi di Democrito quanto i solidi del Timeo platonico. Se infatti alla base dei corpi fossero gli atomi, allora i corpi risulterebbero meri insiemi di punti, cosicché potrebbero disgregarsi in qualsiasi momento. Platone compie innegabilmente un passo avanti quando assume come elementi i solidi scomponibili, ma ciononostante la sua proposta resta insufficiente poiché i solidi non sono in grado di subire alcunché né di aggregarsi per dare composti. Solo Empedocle, ravvisando nell’acqua, nella terra, nel fuoco e nell’aria i quattro elementi stanti alla base del reale ha colto la verità: tali quattro elementi, infatti, rendono perfettamente conto e del divenire e dell’aggregarsi dei corpi, giacchè si tratta di elementi divisibili in parti che mantengono lo stesso nome dell’elemento di partenza (ogni parte di terra è sempre terra, e così via). Inoltre essi sono elementi primi nel senso che non sono composti da altri, possono subire affezioni e trasformazioni reciproche (l’acqua che passa allo stato aeriforme), accrescere, diminuire, mutare luogo. Non stupisce pertanto che Aristotele dedichi buona parte della Fisica al loro studio. Tuttavia sbaglia Empedocle nella misura in cui li concepisce come principi (e non come meri elementi), giacché, così facendo, egli finisce per riconoscerli come eterni: ma da ciò che è eterno non può in alcun caso nascere il mutevole e il transeunte, ovvero tutto ciò che popola questo mondo. I quattro elementi rappresentano per Aristotele materia in un determinato stato (allo stato di terra, di acqua, di fuoco, di aria) e presuppongono un sostrato potenziale comune da cui vengono ad essere per effetto di fattori ambientali come il caldo e il freddo. Tale sostrato materiale non esiste indipendentemente da essi: di per sé, i quattro elementi non sono eterni; eterna è invece la loro vicenda di trasformazione, poiché eternamente si trasformano l’uno nell’altro. Dal moto dei corpi semplici dipende direttamente anche l’assetto di del mondo terrestre, risultante costituito in base alla disposizione dei quattro elementi stessi (la cui disposizione è legata alle caratteristiche fisiche di ciascun elemento). Il mondo sublunare (di natura sferica, che è la migliore tra quelle possibili) viene così a configurarsi come una serie di cerchi concentrici al cui centro sta l’elemento più pesante (la terra) e alla periferia quello più leggero (il fuoco), con in mezzo l’acqua e – più leggera – l’aria. In base a tale disposizione si spiegano anche i moti che si verificano nel mondo sublunare, che possono essere moti secondo natura ( >fusei) e moti violenti ( >bia): una pietra lasciata cadere tende a muoversi di un moto naturale verso il basso, ma se la scagliamo verso l’alto essa procede per un tratto in direzione opposta al suo luogo naturale (muovendosi con un moto contro natura), fino a che non avrà esaurito la spinta e ricadrà a terra. I corpi celesti, invece, si muovono di moto circolare. La luna segna il confine tra i due mondi (sublunare e sopralunare), ma tra essi non c’è separazione netta: c’è anzi una zona intermedia in cui si situano i fattori meteorologici, che sono da Aristotele spiegati con le vicissitudini cui vanno incontro i quattro elementi. Pur verificandosi una tantum (il terremoto o l’arcobaleno non accadono certo quotidianamente), sono fenomeni dotati di una loro spiegazione razionale facente capo ai quattro elementi: sono secondo Aristotele causati dal particolare moto del Sole, il quale avvicinandosi o allontanandosi dalla Terra fa sì che gli elementi si trasformino e diano vita alle stelle cadenti, alle comete, ecc. Aristotele parla a più riprese del moto solare come causa dei moti sublunari: egli si guarda bene dal parlare di "calore" o di "luce" del Sole, giacché ciò significherebbe ammettere che anch’esso – stante al di sopra della luna – è costituito dai quattro elementi. Ne segue allora che il garante della vicenda ciclica del mondo sublunare (il Sole) è esso stesso sopralunare, e dunque dotato di moto circolare e perfetto. Gli individui sublunari che popolano il nostro mondo (uomini, animali, piante) sono mortali come individui (poiché costituiti dai quattro elementi), ma eterno è il loro processo di generazione e corruzione, cosicché il singolo uomo è perituro, ma la specie umana è eterna (l’atto stesso con cui si ama e ci si riproduce non è che un anelito all’eternità). I corpi celesti non si muovono però tutti allo stesso modo: ciascuno di essi descrive nel suo tragitto una sfera e l’insieme complessivo di tali sfere dà un insieme concentrico che ha al suo centro la Terra stessa (in ciò risiede il geocentrismo aristotelico). Come la Terra occupa il centro del mondo, così la periferia è occupata dal "cielo delle stelle fisse", che chiude l’estremità del mondo. Le stelle fisse hanno moto eterno, circolare e semplice: via via che dall’alto si scende verso la luna, i moti dei pianeti presentano sempre maggiori irregolarità (tali sono appunto i moti apparenti) di velocità e di regradazioni. Per rendere conto di essi, Aristotele ricorre a più espedienti e argomentazioni teoriche: il problema che più di ogni altro lo interessa è che ciascuno di tali corpi celesti ha anche più d’un solo moto, cosicché diventa difficile spiegare quale realmente sia la causa prima che sta alla base di tali moti. In tale ottica, Aristotele si domanda perfino se gli astri abbiano un’anima – giacchè l’anima, come insegnava Platone stesso, è principio del movimento – e, nel rispondere negativamente, egli chiude definitivamente i conti col Timeo, nel quale si affermava esplicitamente che i pianeti fossero animati, intelligenti e divini. Pur negando l’anima ai corpi celesti, resta intatto il problema riguardante la causa del loro moto: quale è il principio motore che mette in movimento i corpi celesti? Nel XII libro della Metafisica, Aristotele propone ben due diverse possibili risoluzioni del problema: dapprima egli riconosce che ogni sfera ha un proprio motore dotato di determinate caratteristiche: deve essere una sostanza – sennò non può causare il moto di un’altra sostanza -, deve essere anteriore al corpo mosso e deve muovere sempre – altrimenti non può causare l’immutabile e perenne moto degli astri -, deve essere atto puro, giacchè se fosse potenza potrebbe ora muovere, ora no. Ma se è solo atto ed esclude la potenza, allora esclude anche il movimento e il mutamento (che della potenza sono tipici): sarà allora un motore immobile, che muove senza essere mosso. Dopo aver esposto questa teoria secondo la quale molteplici sarebbero i motori immobili (uno per ogni sfera), Aristotele – appena un capitolo dopo – cambia radicalmente prospettiva e riconosce esplicitamente la possibilità di un motore immobile unico per tutte le sfere celesti. Questo primo motore immobile, in quanto privo di potenza, è anche privo di materia ed è da Aristotele identificato con la divinità. Da ciò segue una struttura gerarchica del cosmo, poiché dall’unico motore immobile "si dirama" l’intero universo: la metafora del diramarsi è impiegata da Aristotele anche in sede biologica per spiegare il rapporto tra le vene e il cuore, che è un rapporto di unione tale per cui le vene si diramano dal corpo senza distaccarsene; similmente, il motore immobile non è staccato dal mondo, e l’universo stesso non è che una totalità in movimento incessante. L’identificazione del motore immobile con la divinità non implica tuttavia un rapporto provvidenziale tra quest’ultima e il mondo, come invece era nel Timeo: il dio di Aristotele, lungi dall’organizzare provvidenzialmente il mondo, sta fermo ed è causa finale del moto del "primo mobile", ovvero del "cielo delle stelle fisse", che a lui tende come al proprio fine. In accordo col libro XII della Metafisica, Aristotele sostiene nel libro VIII della Fisica che il motore immobile deve essere presupposto come causa in grado di spiegare il moto del mondo: la divinità muove il mondo stando ferma, ovvero causa il moto dell’universo come causa finale (giacché, se fosse causa efficiente, sarebbe essa stessa in movimento), poiché a lei tende – come l’amante verso l’oggetto amato – il "primo cielo". Ma se la divinità è immobile, in che cosa consiste la sua attività? Essendo il pensiero la migliore attività in assoluto, la divinità non farà altro che pensare (essa è, in questo senso, la proiezione a livello cosmico del filosofo) e, più precisamente, non farà altro che pensare a se stessa, poiché, se pensasse ad altro, ritornerebbe quella nozione di potenza che abbiamo bandito dalla sfera divina: dio è per Aristotele >nohsiV nohsewV ("pensiero di pensiero"). In netta opposizione all’atomismo e alla sua infinità dei mondi, Aristotele difende a spada tratta l’unicità del mondo: il mondo è uno ed eterno, assolutamente incorruttibile (l’errore del Timeo è ravvisato nell’aver posto il mondo come generato e, insieme, eterno, senza tener conto che il generato è necessariamente perituro). In difesa dell’unicità del mondo, Aristotele dice – nel De caelo – che, se ci fossero altri mondi, essi sarebbero necessariamente costituiti dagli stessi quattro elementi che formano il nostro; ma allora tali elementi tenderebbero a disporsi nei luoghi naturali del nostro mondo, cosicché se ne deve concludere che tutta la materia è già contenuta nel nostro unico mondo.L’età che si apre dopo la morte di Aristotele (322 a.C.) è particolarmente significativa sia sul piano storico sia su quello culturale, in quanto i confini della Grecia si estendono fino all’India e sono gettate le basi delle future scienze: questa nuova epoca, definita da Droysen come "Ellenismo", vede come suo genio protettore, nel bene e nel male, Alessandro Magno, con le cui strepitose conquiste il mondo greco arriva in terre remote; Atene perde il proprio predominio politico e culturale, mentre Pergamo e, soprattutto, Alessandria d’Egitto vengono assumendo un peso sempre maggiore per la cultura del tempo. Ad Alessandria, sotto i Tolomei, è fondata l’importante biblioteca che finisce per diventare il tempio dell’intera cultura greca; ad essa fu affiancato il celebre museo (letteralmente: "casa delle Muse"), circondato da incantevoli giardini. Che ne, è in quest’era così complessa, dei filosofi? La tradizione vuole che alcuni Aristotelici (Demetrio del Falero e Stratone di Lampsaco) fossero attivi nella fondazione dell’imponente biblioteca alessandrina, cosa che ci aiuta a capire come quest’epoca, più di qualsiasi altra, fosse un’epoca di filosofi e, sotto questo profilo, Atene resta ancora il principale polo di attrazione filosofica (ancorché ormai nessun filosofo sia ateniese). In breve tempo l’attività del filosofo viene sempre più istituzionalizzandosi all’interno di scuole rette da scolarchi (è questo il caso tipico degli Stoici e degli Epicurei). Anche l’Accademia platonica e il Peritato aristotelico erano scuole di questo genere e tali restano anche in età ellenistica, entrando spesso in conflitto con le nuove scuole e coi modelli da essi prospettati: particolarmente curiosa è la situazione che si vive nel Peritato, ove gli scritti autentici di Aristotele sono del tutto scivolati nell’oblio, a tal punto da non essere nemmeno più citati dai Peripatetici stessi. Anche gli esponenti delle cosiddette scuole "socratiche minori" (Cinismo, scuola cirenaica, Megarici) continuano ad essere attivi: il caso più emblematico è probabilmente quello di Diogene di Sinope, il quale porta alle estreme conseguenze gli insegnamenti cinici di Antistene. In forza delle grandi conquiste militari compiute da Alessandro Magno, la
>poliV viene a tramontare e, con essa, tramontano i suoi valori: l’uomo greco non trova più nel rassicurante baricentro dell’ >agora cittadina un sostegno morale, ma, proiettato in un nuovo mondo dalle sterminate dimensioni, dove convivono fra loro i costumi più diversi, egli prova un profondo senso di smarrimento e di insicurezza; ben si capisce allora perché le filosofie ellenistiche si configurino essenzialmente come filosofie morali, non già nel senso che la sfera gnoseologica venga trascurata, bensì nel senso che essa è subordinata all’etica. Tutte le correnti filosofiche di quest’epoca mirano alla formazione del vero sapiente. Abbiamo parlato finora di "scuole" filosofiche: in realtà, accanto ad esse, si formano correnti di pensiero che rigettano completamente l’istituzionalizzazione in scuole: è il caso dello Scetticismo, che – in virtù delle sue stesse premesse – non fonda scuole né annovera maestri, in quanto elemento portante di questa corrente di pensiero è l’impossibilità della formazione di un sapere certo. Nel 306 a.C. Epicuro fonda la sua scuola in Atene: la scelta del luogo e del modo di concepirla sono del tutto innovativi. Egli opta per la periferia della città (anziché per il centro), ovvero per una zona lontana dalla città e dai suoi travagli. Questa scuola "periferica" era dotata di un giardino ( >khpoV) e Giardino fu chiamata la scuola stessa: l’immagine che di essa ci offrono le fonti è quella di una comunità di individui (uomini e donne) legati dall’amicizia alla ricerca della felicità. In ambito fisico, Epicuro riprende l’atomismo democriteo, apportando però ad esso delle innovazioni di rilievo: anche per lui atomi e vuoto sono i principi costitutivi della realtà, benché non vengano più connotati in termini eleatici come "essere" e "non-essere" ma semplicemente come le parti ultime in cui si scompongono i corpi. Il vuoto è assunto – in perfetta sintonia con Democrito – come condizione imprescindibile di quei moti degli atomi che danno l’aggregazione e la disgregazione dei corpi, anch’essi a loro volta formati da atomi e vuoto (altrimenti non se ne spiegherebbe il nascere e il perire). Tuttavia, se per Democrito gli atomi – in quanto privi di peso – si muovevano nel vuoto in tutte le direzioni, Epicuro, dal canto suo, attribuisce ad essi peso, forse in base all’osservazione di Aristotele secondo cui, se i corpi hanno peso, allora devono averlo anche gli atomi che dei corpi sono i costituenti. Ma se hanno peso, gli atomi non si muovono a caso, bensì tendono ad andare dall’alto verso il basso secondo linee parallele: ma come possono essi allora aggregarsi se si muovono lungo linee parallele tali per cui non possono incontrarsi? Nei testi di Epicuro conservati (le tre epistole riportate da Diogene Laerzio in Vite dei filosofi, X) non è prospettata alcuna soluzione a questo problema: ma dal De rerum natura di Lucrezio e dalle opere degli avversari dell’epicureismo (Cicerone e Plutarco) sappiamo che Epicuro avrebbe escogitato un rimedio, la "deviazione" (clinamen in latino, >paregklhsiV in greco) degli atomi dalla linea retta. In quest’ottica, gli atomi si aggregherebbero perché dotati della spontanea capacità di deviare dalla traiettoria del loro movimento e, dunque, di incontrarsi. Si tratta di una capacità costitutiva e spontanea degli atomi: può cioè casualmente verificarsi che essi devino e che diano vita – in questo e negli infiniti altri mondi – agli aggregati. Dire che si tratta di una capacità innata negli atomi equivale ad escludere ogni causa esterna agli atomi stessa (è dunque negata la causa finale e, con essa, quella divina). Ne emerge un universo meccanicistico e antifinalistico, fortemente antiplatonico e antiaristotelico. Oltrechè in ambito fisico, la dottrina della deviazione" ha importanti conseguenze anche in sede morale: se infatti tutto accadesse secondo necessità, allora il libero arbitrio sarebbe spento, tanto più che l’anima stessa non è che un aggregato di atomi (ancorché di atomi ignei e sferici); ma, stando così le cose, non avrebbe più alcun senso l’etica. Ma la capacità spontanea di deviare interessa anche gli atomi dell’anima e in ciò risiede la facoltà di scegliere comportamenti che deviano dalla necessità, fermo restando che qualunque atto intellettivo muove da uno stimolo esterno. Epicuro si spingeva più in là: anche gli dei – non solo l’anima – non sfuggono alle leggi atomiche, cosicché anch’essi non sono se non aggregati di atomi e vuoto. Ciò attirò ben presto su di lui l’accusa di ateismo, benché Epicuro precisasse nella Lettera a Meneceo che ateo non è chi rinnega gli dei del volgo, ma chi agli dei applica le opinioni del volgo, prima fra tutte quella secondo cui essi agirebbero provvidenzialmente nel mondo. Che gli dei esistano è provato dal fatto che tutti gli uomini lo credano (argomento del consensus omnium): ma ciò non autorizza a credere che gli dei intervengano nel mondo e, per di più, in maniera provvidenziale, poiché altrimenti non si spiegherebbe il male che attanaglia il mondo stesso (negarlo è andare contro alla più banale delle esperienze). Di fronte al male, se gli dei intervengono e non lo rimuovono è o 1) perché non vogliono, o 2) perché non possono, o 3) perché né possono né vogliono: ma nel primo caso si tratterebbe di dei invidiosi, nel secondo di dei impotenti, nel terzo di dei impotenti e invidiosi, tutte caratteristiche che non si attagliano alla divinità. Si dovrà allora riconoscere che gli dei ci sono ma non intervengono nel nostro mondo (in netta antitesi con quanto, in quel torno di anni, sostenevano gli Stoici e con quanto già sosteneva Platone nel Timeo). Come per Aristotele, anche per Epicuro la teologia rientra a pieno titolo nella fisica, giacchè per il filosofo del >KhpoV gli dei sono materiali: come possono allora essi essere immortali? Che abbiano forma umana è evidente, poiché – in quanto perfetti – debbono avere la forma migliore, ovvero quella con struttura atomica meglio organizzata: tale è appunto la forma umana. Gli uomini, tuttavia, sono perituri, ossia soggetti alla disgregazione atomica, cosicché la divinità, per essere eterna, dovrà avere un continuo risarcimento di materia, tale da non potersi mai disgregare: ciò garantisce la loro immortalità. In quanto corporei, poi, gli dei occupano spazio: Epicuro elegge a loro dimora gli intervalli (gli intermundia di Lucrezio) che separano tra loro gli infiniti mondi. Dicevamo che il primo argomento in favore dell’esistenza degli dei è dato dal consenso di tutti gli uomini circa la loro esistenza: però esso non è il solo. Secondo Epicuro, infatti, anche la conoscenza che abbiamo degli dei è percettiva, poiché anche da essi provengono >eidwla (immagini) percettibili non già agli organi di senso, bensì – per la loro sottigliezza – alla mente stessa. Al pari di Democrito, Epicuro assume un’infinità di atomi, il che spiega anche l’infinitezza del vuoto (per poter contenere infiniti atomi deve necessariamente essere anch’esso infinito). In rottura con Democrito, però, Epicuro nega che gli atomi abbiano un numero infinito di forme, giacchè, se così fosse, si potrebbero ammettere atomi grandi quanto il mondo e dunque essi sarebbero visibili ad occhio nudo (il che contrasta palesemente con la nozione di atomo): il numero delle forme degli atomi, allora, sarà non infinito, ma incalcolabile. Anche Epicuro deve render conto di come i corpi si distinguano qualitativamente tra loro: anche a suo avviso – come già per Democrito – le caratteristiche qualitative sono un epifenomeno dell’assetto assunto dagli atomi nel formare un corpo; DEmocrito riteneva però che le qualità fossero un fatto di convenzione e che solo atomi e vuoto fossero un fatto di natura, cosicché per lui le qualità erano fluttuanti e mai stabilmente oggettive (da ciò seguiva l’incertezza della conoscenza sensibile). Per Epicuro questa è una via pericolosa, giacchè porta a dubitare della conoscenza che abbiamo e fa scricchiolare ogni sistema filosofico: per far fronte a ciò, egli asserisce che le qualità sono sì epifenomeno, ma che vi sono qualità essenziali dei corpi e qualità accidentali; ci sono cioè qualità senza le quali il corpo non è concepibile (ad esempio la statura eretta dell’uomo) e altre che sono accessorie e transeunti (il colore dei capelli o degli occhi). Anche le qualità sono percepite insieme ai corpi e, dunque, non si deve dubitare di esse. Anch’esse provengono dagli >eidwla, i quali riportano informazioni certe, giacchè si muovono con velocità istantanea, uguale a quella del pensiero: Epicuro dice che sono "equiveloci" poiché si muovo o nel vuoto. Ciò garantisce un incrollabile criterio di verità, identificato nella sensazione. Meccanicismo e sensismo sono dunque le due componenti fondamentali della filosofia epicurea, mentre la logica non contribuisce al raggiungimento della felicità, intesa come piacere. L’epicureismo si diffuse in Italia soprattutto a Napoli, ove ad Ercolano si sono rinvenuti numerosi papiri che ci hanno restituito frammenti del Sulla natura ( >Peri fusewV), l’opera fondamentale di Epicuro, in 37 libri. A Roma il verbo epicureo trovò maggiori resistenze nella sua diffusione, in quanto il suo motto >laqe biwsaV ("vivi appartato" >) mal si attagliava alla vita romana, per la quale la politica era irrinunciabile. Nel II secolo d.C., Diogene di Enoanda fa scolpire su pietra la filosofia di Epicuro – venerato dai suoi successori come un dio – e la espone nel portico della città di Enoanda. Ben diversa è la posizione degli Stoici: Zenone di Cizio (una località dell’isola di Cipro) giunge ad Atene e, con l’appoggio di personalità di rilievo, riesce a fondarvi una scuola filosofica, la >Stoa poikilh, ovvero il "portico pitturato", situato nel cuore di Atene e costellato dalle pitture raffiguranti la battaglia di Maratona. Il fatto stesso che Zenone elegga a sede della propria scuola il cuore pulsante della città già sottolinea una radicale differenza rispetto ad Epicuro e al suo Giardino: la filosofia stoica, anziché chiudersi in se stessa e rivolgersi ad una ristretta cerchia di amici, intende diffondere il proprio messaggio (non scevro da elementi politici) su ampia scala, tant’è che caratteristica portante dello stoicismo è il cosmopolitismo. L’attività di Zenone non passò inosservata e, alla sua morte, fu emanato un editto col quale egli era riconosciuto come modello di vita per gli Ateniesi. Lo stoicismo avrà lunga vita, attraverserà tre fasi distinte (antico, medio e nuovo stoicismo) e, a differenza dell’epicureismo, troverà un fertile terreno di diffusione anche a Roma: ciò si spiega anche col fatto che lo stoicismo può qualificarsi come una filosofia in fieri, sempre soggetta a innovazioni e a mutamenti introdotti dai vari filosofi stoici. Il corpo delle dottrine della scuola stoica è sì dogmatico, ma le teorie venivano discusse e modificate di autore in autore: così Panezio di Rodi – che rese lo stoicismo funzionale alla civitas romana – rigetterà la dottrina dell’ >ekpurosiV e attenuerà il rigorismo morale, ormai divenuto obsoleto. Data la struttura istituzionalizzata della Stoà, le fonti ci trasmettono solo in parte teorie abbinate a personalità singole: per lo più parlano genericamente di "Stoici", senza operare distinzioni e far nomi precisi. Il punto focale del pensiero stoico è la nozione di >LogoV, che è in primo luogo la "ragione" delle cose e, dunque, l’oggetto della fisica (che studia appunto le cose che sono); ma >logoV è anche la "ragione" esplicitata nel ragionamento e, in quanto tale, è oggetto della logica (che studia come le cose sono espresse e conosciute). Infine il >logoV, in quanto principio di comportamento, sarà oggetto di studio dell’etica. Se per Epicuro sussisteva tra le varie parti della filosofia un rapporto progressivo, per gli Stoici, al contrario, esse formano un tutto organico, cosicché essi possono paragonare le varie parti ad un campo o ad un vivente o, ancora, ad un uovo. C’è chi sostiene che la filosofia è un campo in cui il muro di cinta è dato dalla logica, la terra dalla fisica e i frutti dall’etica: sicchè la logica esplica una funzione meramente difensiva, la fisica costituisce il "terreno" su cui seminare i frutti, che son dati dall’etica (il che testimonia la sua indiscutibile preminenza). Per Crisippo di Soli, invece, l’egemonia spetta non già all’etica, bensì alla fisica e, in particolare, alla teologia. Posidonio di Apamea rigetta l’immagine della filosofia come un campo, poiché a suo avviso essa mal rivela il rapporto intercorrente tra le parti: per lui, al contrario, la filosofia è un vivente, le cui ossa son date dalla logica, la carne dalla fisica e l’anima dall’etica. Da quest’immagine ben emerge il rapporto inscindibile tra le parti in funzione del tutto, benché l’etica (in quanto anima) sia in posizione di spicco. L’accento posto da Posidonio sull’importanza della totalità organicamente connessa ci aiuta anche a capire perché la figura del sapiente stoicamente inteso possegga tutto il sapere, non singole parti di esso: chi sa molto ma non tutto si trova per gli stoici sullo stesso piano di chi non sa nulla, poiché chi è distante da Atene 5 km non è in Atene come chi da essa è distante 1000 km. Diventare sapienti in senso stoico è un traguardo umanamente irraggiungibile: i veri sapienti – dicono gli stoici – sono più unici che rari; Seneca dice che il vero sapiente nasce – al pari della fenice – ogni cinquecento anni e Crisippo sostiene che esso è raro quanto i parti di una mula. Del resto gli stoici si ritenevano filosofi ma non sapienti. L’idea dell’inattuabilità della piena conoscenza è di matrice socratica (pensiamo al Fedro), e gli Stoici non fanno che portarla all’ennesima potenza: la filosofia viene pertanto a configurarsi come ricerca e amore di un sapere che mai può essere raggiunto. La fisica è, al pari di quella logica che per Aristotele era soltanto un >organon della scienza, è conoscenza causale della generazione delle cose che sono. Gli Stoici distinguono – sulla scorta di Aristotele – tra "elementi" (i quattro elementi – aria, acqua, terra, fuoco -, ovvero specificazioni della materia) e "principi" (Dio e la materia): tutte le cose vengono ad essere perché formate dalla materia e da un principio divino, mentre gli elementi non sono se non gli ingredienti materiali che compongono ogni cosa. Le cause che spiegano la costituzione delle cose sono cause materiali (i quattro elementi già individuati da Empedocle), ma il dio stoico è causa razionale e divina che – come il Demiurgo platonico – agisce direttamente sul reale, cosicché le cose non sono frutto del caso: anche per gli Stoici, come già per Platone, questo è il migliore dei mondi possibili. In dio essi fanno convergere le altre tre cause individuate da Aristotele: dio è causa efficiente, finale e formale del mondo, al quale conferisce la miglior forma possibile agendo provvidenzialmente. La natura imperfetta di cui parlava Aristotele agli Stoici non basta: a loro avviso, infatti, la natura è il volto rivelato di Dio e, in quanto tale, non può che essere perfetta. Se per Platone dio e la materia restano due realtà assolutamente distinte (e anzi la materia si oppone all’agire divino), gli stoici, sull’altro versante, sostengono che dio e materia non si distinguono per la loro natura: essi sono entrambi corporei – dicono gli stoici -, poiché altrimenti non si spiegherebbe l’intervento di dio sul mondo (solo un corpo può agire sul corporeo). Di qui scaturisce la posizione materialistica e immanentistica degli stoici, ad avviso dei quali dio è presente nella realtà materiale delle cose. La materia, che per Platone si configurava come recalcitrante a dio, è per gli stoici caratterizzata dalla presenza di dio, per cui il mondo in cui viviamo non solo è il migliore tra i possibili, ma è anche perfetto in maniera assoluta, giacché interamente padroneggiato da dio. Memori della terminologia aristotelica, gli stoici chiamano "principio passivo" la materia e "principio attivo" dio: quest’ultimo – da identificarsi col >logoV, ovvero con la ragione universale – agisce sulla materia e fa venire ad essere ogni cosa; la prima azione da lui compiuta consiste, in particolare, nel trasformare la materia in qualcosa di preciso e determinato, ossia nei quattro elementi (che sono appunto materia in un preciso stato). Gli stoici qualificano la materia come "principio passivo" perché essa è tale da subire l’azione del principio attivo, anch’esso corporeo. Tutte le cose saranno dunque materiali, unioni inscindibili di materia e forma: esse avranno la forma migliore proprio perché dio interviene in esse dall’interno: in ciò consiste il panteismo stoico. Il mondo che ne risulta è una totalità perfettamente compiuta e razionale, dove è giustificata perfino la presenza del male: Crisippo asserisce che il rapporto bene/male è equivalente a quello luce/ombra: come non si capirebbe che cosa è la luce se non vi fosse anche l’ombra, così non si capirebbe che cosa è il bene se non vi fosse anche il male. Non è un caso che il principio divino ammesso dagli stoici sia unico: quelli che gli uomini chiamano "dei" non sono che manifestazioni dell’unica divinità. Ben si capisce perché il vivere virtuosamente sia l’uniformarsi alla ragione, che è nell’uomo una scintilla del >logoV universale: vivere secondo virtù significa vivere secondo ragione, e vivere secondo ragione vuol dire vivere secondo natura, poiché la natura è divina. Gli stoici assimilano dio ad un fuoco, a sottolineare la sua capacità di dare la vita (solo ciò che è caldo può godere di tale capacità); in quanto dotato di vita, tale fuoco accoglie al proprio interno un corpo capace di raffreddare: è quello che gli stoici chiamano >pneuma, un corpo di natura aeriforme (Seneca lo chiama spiritus) in grado di vivificare la materia conferendole forma e qualità (rende cioè la materia secca, umida, ecc). Pertanto tutta la realtà è permeata da questo soffio caldo che dà la vita e, proprio perché aeriforme, è presente ovunque nella realtà. In questo sistema, l’uomo occupa un posto privilegiato, in quanto unico essere dotato per natura di ragione: sicchè egli è l’essere che più si avvicina alla divinità, a tal punto che c’è tra loro parentela. Se Platone (Leggi, X) considerava l’uomo come minuscola particella dell’universo, gli stoici, dal canto loro, asseriscono che "l’intero mondo è città di dio e degli uomini" (Crisippo). Ma il mondo, in quanto nato, non è eterno: esso è corruttibile e, dunque, destinato a perire, anche perché andrà incontro ad una conflagrazione universale ( >ekpurosiV) legata a quello stesso fuoco che l’ha generato. Il mondo poi rinasce, giacchè si tratta di una vicenda ciclica, e il mondo nuovo rinasce tale e quale quello perito (nel nuovo mondo vi sarà lo stesso Socrate, lo stesso Platone, ecc), poiché, se rinascesse diverso, non sarebbe perfetto o perfetto non sarebbe stato quello precedente. La presenza del >logoV assicura il >tonoV, la tensione che tiene in equilibrio il mondo e le cose che lo costellano. In quanto retto da questa tensione, il mondo è una sorta di gigantesco vivente dato dalla compresenza di un corpo e di un’anima che lo tiene insieme (e per gli stoici l’anima è >pneuma). Ne segue dunque che il mondo è retto nelle sue parti da simpatia ( >sumpaqhia): le parti sono cioè connesse da un vincolo tale per cui, al modificarsi di una parte, anche le altre si modificano. Ciò giustifica la divinazione, ossia la lettura del futuro sulla base dei segni del presente: il fatto che dio ci lasci sapere in anticipo quel che accadrà non fa che avvalorare la tesi che lo vuole buono. I filosofi che definiranno se stessi come Scettici non elaborano alcuna filosofia della natura, poiché a loro avviso non c’é alcuna rappresentazione che non possa essere falsa, cosicché, se il sapiente dà il suo assenso a una rappresentazione, opinerà; ma é proprio del sapiente non opinare; dunque il sapiente sospenderà il suo assenso.Corso tenuto presso l’Università di Torino dalla professoressa Luciana Repici nell’autunno 2003
IL DE ANIMA DI ARISTOTELE
Se di Platone ci sono pervenuti pressoché tutti gli scritti, ciò non vale per Aristotele, di cui possediamo solamente quegli scritti la cui destinazione era il pubblico interno alla sua scuola. Si tratta di scritti stringati e concisi, probabilmente di appunti che Aristotele sviluppava poi a lezione; più difficile, invece, che si tratti di appunti presi dai suoi studenti durante le lezioni da lui tenute. Lo scritto "Sull’anima" ("De anima" in latino, "
>Peri yuchV" in greco) rientra fra queste opere a noi giunte: esso si articola in tre libri, dei quali il primo pone l’attenzione su quali siano i problemi da risolvere nell’indagine sull’anima. Il primo problema in cui ci si imbatte è la definizione dell’anima: che cos’è? Aristotele, per poter rispondere adeguatamente a tale domanda, ritiene indispensabile effettuare una ricognizione preliminare su quanto han detto sull’argomento i suoi predecessori e sottoporre le loro tesi ad analisi critica (incontriamo un procedimento simile anche nella "Metafisica"). Nel secondo libro, dopo aver ripercorso le definizioni precedenti e i loro difetti, lo Stagirita arriva a formulare la propria definizione di "anima" e a tratteggiarne le funzioni: proprio alle funzioni dell’anima sono dedicati il libro secondo (in particolare alla percezione sensibile) e il libro terzo (con particolare attenzione all’attività intellettiva dell’anima). Nel primo capitolo del primo libro, Aristotele afferma che quella che si accinge ad intraprendere è una >istoria , ossia un’ "indagine" diretta sull’anima ( >yuch): si tratta – egli prosegue – di una forma di sapere che rientra fra quelle più importanti; infatti, riteniamo comunemente che le forme di sapere più importanti siano quelle che si distinguono o perché hanno maggior rigore o perché si occupano degli oggetti migliori e più stupefacenti. Su cosa sia il "sapere rigoroso", Aristotele si era già soffermato negli "Analitici secondi", in cui era giunto alla conclusione che un sapere può dirsi rigoroso se dimostrabile con catene di ragionamenti (ossia con sillogismi): ora, nello studio dell’anima, è evidente che non può esserci quel rigore che troviamo nello studio della geometria o della matematica. Tuttavia, pur mancando il rigore, lo studio dell’anima è nobilitato dal fatto che l’oggetto di tale indagine è costituito da una delle cose più stupefacenti che ci siano: l’anima. Questo è particolarmente rilevante perché nelle prime pagine della "Metafisica" Aristotele indicava nella meraviglia ( >to qaumazein) il motore della ricerca, giacché si desidera conoscere una cosa perché essa desta in noi stupore (i corpi celesti o l’incommensurabilità della diagonale del quadrato): una volta scoperta la causa di queste cose che producono in noi meraviglia, non ci si stupisce più. Questo discorso, naturalmente, vale anche per l’anima: perché ci sono entità animate e altre non animate? Perché non esiste solo l’inanimato o solo l’animato, ma è come se convivessero due mondi antitetici? Secondo Aristotele, capire l’anima aiuta anche a capire gli animali (per i quali lo Stagirita è particolarmente interessato, come dimostrano i numerosi suoi scritti in materia): in senso lato, dunque, l’indagine sull’anima rientra nell’indagine sulla natura. " Ci prefiggiamo di considerare e conoscere la sua [dell’anima] natura ( >fusiV ) e essenza ( >ousia ) e, poi, tutte le caratteristiche che le competono ": tali caratteristiche sono, in particolare, le affezioni e le proprietà in virtù delle quali l’anima è quella che è. Prima di chiedersi quale sia il suo compito, è bene domandarsi che cosa sia l’anima e scoprirlo è una delle cose più difficili: bisogna anche chiarire quale procedura si debba impiegare nell’investigazione, chiarendo, soprattutto, se si tratti di un metodo comune ad altre indagini o specifico dell’anima. Ammettiamo che sia un metodo comune, dimostrativo, che inferisce conclusioni a partire da premesse, o, magari, che proceda per divisione, come immaginava Platone nel "Sofista", quando si domandava che cosa fosse la pesca con la lenza: si tratta di inserire la pesca con la lenza in un genere più ampio, l’ "arte" ( >tecnh); ma l’arte si suddivide in "arte di acquisizione" e "arte di produzione" e, ovviamente, la pesca si colloca nell’ambito dell’arte di acquisizione. Operando successive divisioni si giungerà alla definizione di pesca con la lenza: ma come si può applicare questo metodo (o anche quello dimostrativo) all’anima? E’ assolutamente impossibile, poiché tutti e due i metodi partono da princìpi che non sono gli stessi per tutte le discipline (diversi, infatti, sono i princìpi da cui partire per studiare l’anima, la fisica e la matematica). Aristotele nota, piuttosto acutamente, come di fronte al problema dell’anima si apra un ventaglio di soluzioni tutte accettabili: ci troviamo dunque di fronte a delle >aporiai , ossia a dei vicoli ciechi senza possibilità di uscita. La prima "aporia" in cui ci si imbatte riguarda la stessa definizione dell’anima: in quale genere si trovi e che cosa sia, se sia sostanza o qualità o quantità o altra categoria (secondo quanto Aristotele aveva insegnato nelle "Categorie"). L’anima potrebbe essere una "sostanza prima", ossia un >tode ti, un "questa cosa qui" in carne e ossa; ma potrebbe anche essere una "sostanza seconda" (ossia una specie), del tipo "uomo" o "cavallo"; ma, infine, nulla vieta di pensare che essa sia solo un predicato, come ad esempio lo è il colore "rosso", che esiste nella misura in cui esiste una sostanza prima (non ci sarebbe infatti il rosso se non ci fossero cose rosse). Ma c’è anche un’altra aporia: ammesso che l’anima sia un ente, occorre chiedersi che tipo di ente sia e per rispondere Aristotele si avvale di una distinzione da lui operata in altri scritti: quella tra potenza ( >dunamiV) e atto ( >enteleceia), secondo la quale il marmo è una statua in potenza (nel senso che può diventare statua) e la statua è atto, cioè realizzazione compiuta del marmo. Ora, l’anima, intesa come ente, è potenza o atto? Ci si imbatte però in una nuova aporia: ammettendo che l’anima sia un’entità, essa è fatta di parti o priva di parti? E, nel caso in cui sia costituita da parti, che rapporto sussiste tra il tutto e le singole parti? Sarà un rapporto come quello tra le parti della pietra (per cui se spacco la pietra in parti ho altre pietre) o sarà invece un rapporto come quello tra l’uomo e le sue parti (per cui se tolgo all’uomo una parte del suo corpo non ho un altro uomo)? Secondo Platone (stando a ciò che egli asseriva nel "Fedro" e nella "Repubblica"), l’anima è tripartita (parte razionale, parte impetuosa e parte desiderativa); secondo gli Stoici, essa sarà assolutamente unitaria. Ma c’è anche un’altra aporia non da poco: esiste un solo tipo di anima o ne esistono più d’uno? Aristotele si pone questo interrogativo perché ha di fronte a sé una sfilza di indagini sull’anima (condotte dai suoi predecessori) che mettevano l’accento su come solo l’uomo, propriamente, fosse dotato di anima. Lo Stagirita, sotto questo profilo, capovolge quest’idea comune e sostiene che anche gli animali e le piante hanno l’anima: bisogna tuttavia chiedersi di che tipo di anima si tratti. Posto che vi siano molte specie di anima, è possibile dare un’unica definizione che valga per tutte o bisognerà dare una definizione diversa per ogni singolo tipo di anima, così come per ogni tipo di essere (uomo, cavallo, casa, ecc)? Aristotele cercherà, in qualche modo e non senza difficoltà, di formulare una definizione universalmente valida. Ammesso invece che l’anima sia una sola ma costituita da più parti (come credeva Platone), dobbiamo prima esaminare le parti o l’anima nel suo insieme? E prima le parti o le funzioni di esse? Vale a dire: bisogna prima proiettare l’indagine sull’intelletto o sull’intellezione? Prima i colori o prima la percezione dei colori? E’ come se vi fosse un rapporto ermeneutico fra il tutto e le parti: da un lato, infatti, se ho colto l’oggetto su cui sto investigando (ossia l’anima), sarà più facile cogliere le cause delle cose che le accadono (le passioni, ecc); ma, dall’altro, se colgo la causa delle cose che le succedono, sarà allora possibile risalire alla comprensione dell’anima. E le cose che accadono nell’anima sono proprie solo di essa o anche di quella particolare cosa che possiede l’anima, ossia il corpo? Anima e corpo sono separati e indipendenti (come credevano Platone e i Pitagorici) o sono strettamente connessi per cui se cessa di esistere uno, cessa di esistere anche l’altro? In che senso il corpo possiede l’anima? Aristotele nota, a tal proposito, come la maggior parte delle affezioni dell’anima non potrebbero avvenire senza il corpo: ad esempio, secondo gli insegnamenti della medicina dell’epoca, la collera altro non è se non l’ebollizione del sangue, il che non potrebbe accadere se non avessimo il corpo. Aristotele pare più perplesso per quel che riguarda il pensiero, che assomiglia molto ad un’affezione dell’anima: in prima analisi, si potrebbe essere portati a dire che il pensiero è indipendente dal corpo; eppure anche il pensiero, in qualche modo, deve per forza passare dal corpo e, per spiegare ciò, Aristotele ricorre alla nozione di "immaginazione" ( >fantasia), intesa come l’accogliere ciò che appare ai sensi. Che il pensiero passi dal corpo appare evidente se pensiamo a quando, dopo aver visto un oggetto sensibile (una casa, un cavallo, ecc), lo ripensiamo senza averlo davanti. Ci sono, dunque, passioni ( >paqh) che riguardano l’anima e non il corpo? E su cosa si esercita l’attività del pensiero? Gli oggetti del pensiero vengono da Aristotele definiti "intelligibili" e altro non sono se non le nozioni universali (uomo, bello, giusto, ecc): ma il punto di partenza per ogni conoscenza è la sfera sensibile, che ci mette in contatto con entità sensibili individuali collocate nel tempo e nello spazio; infatti, non posso mai vedere l’uomo, ma sempre e solo singoli uomini (Gorgia, Platone, Socrate, ecc) e arrivo alla nozione universale di uomo operando un’astrazione. Tra pensiero e percezione, tuttavia, – nota Aristotele – esiste una zona di mezzo, che sta a metà strada fra le due: si tratta della fantasia ("immaginazione"), strettamente connessa con la memoria: vedo Socrate in carne ed ossa, poi se se ne va, ma, ciononostante, io conservo la sua immagine nella mia mente grazie alla memoria. E quindi il pensiero rivolge la sua attenzione a queste immagini sedimentate nella memoria: ma se esso, per agire, non può non operare sulle immagini presenti nella memoria, ciò significa che il pensiero non può essere esercitato a prescindere dal corpo. Aristotele, in tale prospettiva, sembra escludere la possibilità che l’anima possa sopravvivere dopo la morte del corpo (staccandosi in tal modo dalla tradizione platonica), poiché le due entità sono talmente dipendenti l’una dall’altra che, morta una, non può che morire anche l’altra. Infatti, se tutte le affezioni dell’anima sono in qualche modo connesse al corpo, allora l’anima non è distinta dal corpo: e, come dirà Aristotele più avanti, l’anima sarà un’ attualizzazione ( >enteleceia) di certe funzioni, cosicchè la posizione aristotelica potrà essere etichettata come "funzionalismo" (giacchè concepisce l’anima come una serie di funzioni connesse al corpo). E’ curioso notare come lo Stagirita ritenga che il cervello non sia il punto centrale della nostra riflessione, ma, in fin dei conti, un semplice organo di raffreddamento, meno importante rispetto al cuore (sede dei sentimenti). " Se allora tra le attività o affezioni dell’anima ce n’è qualcuna che le sia propria, l’anima potrebbe avere esistenza autonoma; ma se non ce n’è nessuna che le sia propria, non sarà separabile ": se si trovasse una qualche attività dell’anima assolutamente indipendente dal corpo, allora sarebbe possibile ammettere la separabilità dell’anima dal corpo, ma, poiché Aristotele non ne rinviene alcuna ( "sembra che anche le affezioni dell’anima abbiano tutte un legame con il corpo "), allora è costretto a riconoscere l’inseparabilità dei due. E, di conseguenza, con il perire del corpo cessa di esistere anche l’anima. Che tra anima e corpo intercorra un rapporto strettissimo appare anche evidente dal fatto che non appena si verificano affezioni dell’anima il corpo subisce modifiche: a seconda che io provi gioia o dolore, infatti, il corpo si modifica in un modo o in un altro. Questa considerazione implica una conseguenza di notevole importanza: in quanto connesse al corpo, le affezioni dell’anima possono essere indagate dallo studioso della natura ( >o fusikoV), il quale si occuperà, in particolare, materialmente delle produzioni corporee delle affezioni ( l’amore, la paura, ecc); tuttavia, non basta conoscere la produzione, bensì bisogna comprendere le cause, ossia occorre anche sapere che cosa siano l’amore o la paura, e ciò compete, propriamente, al filosofo. E anche per capire che cosa sia una determinata cosa (supponiamo una casa), possiamo condurre o un’indagine fisica (incentrata sulla causa materiale: la casa è un insieme di certi materiali) o un’indagine dialettica (incentrata sulla causa finale: la casa è fatta per ripararsi dalle intemperie). Aristotele chiama la procedura che intende seguire >diaporeisqai (il porre problemi) e, in primo luogo, compie un’esplorazione delle posizioni assunte in materia di anima dai suoi predecessori, per vedere se essi sono stati in grado di risolvere qualche problema: dopo aver introdotto l’argomento di cui si occuperà nello scritto, il resto del libro I è dedicato alla discussione di queste posizioni; in particolare, Aristotele si propone di prendere in considerazione le >doxai , le "opinioni". E nello scritto "Topici" aveva sostenuto che le discussioni filosofiche devo partire sì da opinioni, ma non da opinioni qualunque: bensì da quelle su cui tutti gli uomini o la maggior parte di essi si trovano d’accordo oppure da quelle espresse dalle persone più competenti in quell’ambito (tali opinioni sono dette >endoxai, ossia "illustri"). Pertanto, parlando dell’anima, non essendoci alcun punto su cui concordano tutti gli uomini, Aristotele fa riferimento alle "illustri" opinioni sostenute dai filosofi della natura a lui precedenti (poiché, come abbiamo detto, l’anima è in qualche modo connessa alla natura): e tali opinioni possono essere suddivise in due gruppi. Infatti, al di là delle specificità delle argomentazioni dei singoli pensatori, tutti, bene o male, hanno finito per intendere l’anima come causa del movimento oppure come causa della percezione (oppure, più raramente, come causa di entrambe le attività). Nel II libro del "De anima", Aristotele afferma in merito: " pare che l’essere animato si distingua dall’inanimato soprattutto per due proprietà: movimento e percezione ". Partendo dall’analisi del primo gruppo, è facile capire il percorso attraverso il quale si è arrivati a tale posizione: infatti, la prima grande differenza che distingue gli esseri animati da quelli inanimati è che solo i primi si muovono da sé, con l’inevitabile conseguenza che l’anima dev’essere quel qualcosa che conferisce il movimento. La strada percorsa dai pensatori del secondo gruppo è diversa: a loro avviso, la grande differenza tra esseri animati ed esseri inanimati risiede nel fatto che solo i primi sono dotati di percezioni. Aristotele non si trova d’accordo con l’inferenza tratta da chi sostiene che il movimento sia ciò che distingue l’animato dall’inanimato: ad avviso di costoro, infatti, dalla constatazione che ciò che si muove da sé è dotato di anima, deriva necessariamente che l’anima stessa sia in movimento incessante, partendo dalla premessa che una cosa può muoverne un’altra solamente se essa stessa è già in movimento. Ma Aristotele smaschera queste posizioni servendosi della causa finale e mettendo in luce come vi siano casi in cui ciò che muove non è mosso: in particolare, nel XII libro della "Metafisica", per spiegare l’immobilità del "motore immobile", ricorreva ad un esempio particolarmente soddisfacente: un oggetto che amiamo ci fa muovere verso di lui senza che esso debba per forza muoversi. Il primo dei predecessori su cui Aristotele si sofferma è Democrito, ad avviso del quale " l’anima è una specie di fuoco e di calore ": il pensatore di Abdera era probabilmente giunto a questa conclusione partendo dalla constatazione che un corpo morto (e quindi privo di anima) è inevitabilmente freddo. Al contrario, un’entità viva è calda, sicché dev’essere l’anima a fornire tale calore. Secondo Democrito l’anima, come ogni altra cosa, è costituita da atomi; gli atomi di cui essa è composta, però, sono sferici e quindi più mobili e veloci; e, potendosi muovere rapidamente, producono calore: ecco perché l’anima è calore e gli atomi che la compongono assomigliano, in qualche misura, al pulviscolo sospeso in aria che noi scorgiamo quando penetrano dalle finestre i raggi del sole. In tale prospettiva, ad avviso di Democrito, la respirazione è ciò che contraddistingue gli esseri animati da quelli inanimati: espirare significa buttar fuori atomi di anima, e se non ci fosse l’inspirazione, attraverso la quale vengono introdotti atomi di anima, il nostro corpo si disgregherebbe in brevissimo tempo (perché verrebbero espulsi tutti gli atomi dell’anima). Secondo Aristotele, anche l’interpretazione dell’anima data dai Pitagorici è, grosso modo, su questa linea. Anassagora, invece, ha identificato l’anima con l’Intelletto cosmico, che mette in movimento ogni cosa. Dal canto suo, Platone rientra nel novero di quei pensatori che hanno inteso l’anima come un’entità che si muove da sé: soprattutto nel "Fedro", egli dimostrava l’immortalità dell’anima a partire dal suo movimento, mettendo in evidenza come un qualcosa che per sua natura partecipa del movimento non può in alcun modo partecipare della morte (intesa come negazione del movimento stesso). Senocrate, discepolo di Platone, aveva invece enigmaticamente asserito che l’anima fosse un numero che muove se stesso. Dopo essersi soffermato sull’attribuzione, effettuata dai pensatori a lui precedenti, del movimento all’anima, Aristotele si sofferma dunque sull’anima intesa come capacità di percepire. In questo secondo gruppo di posizioni rientrano tutti coloro che hanno letto nella percezione la caratteristica peculiare dell’anima e tra questi pensatori spicca la figura di Empedocle da Agrigento, il quale (anche se nei suoi frammenti che possediamo non compare mai la parola >yuch) individua un parallelismo tra macrocosmo e microcosmo in virtù del quale l’anima umana è costituita da quattro elementi ("radici") e percepisce la realtà esterna perché anche quest’ultima è composta dai medesimi quattro princìpi. Nella sua trattazione, Aristotele riporta integralmente un passo dal poema di Empedocle: " con la terra conosciamo la terra, con l’acqua l’acqua, col fuoco il fuoco distruttore, con l’etere l’etere divino, con l’amore l’amore divino, con la discordia la malvagia discordia "; è il simile che conosce il simile. Accanto ad Empedocle, Aristotele pone Platone e le sue teorie presenti nel "Timeo", in cui l’anima è concepita come un insieme costituito da elementi che (e qui sta la differenza precipua rispetto ad Empedocle), a loro volta, sono costituiti da poliedri. E’ interessante il fatto che lo Stagirita, all’improvviso, citi il suo proprio scritto >Peri filosofiaV ("Sulla filosofia") – andato perduto – in cui troviamo una bislacca commistione di teorie geometriche ed aritmetiche impiegate per spiegare l’anima e il mondo. Ma, accanto a questi due gruppi di pensatori, ve n’è un terzo, composto da tutti coloro che hanno riconosciuto come caratteristiche fondamentali dell’anima sia il movimento sia la percezione: il principale esponente di questa compagine è Senocrate, che successe a Speusippo nella direzione dell’Accademia e che definì l’anima come " numero che muove se stesso "; da un lato, l’anima è, ai suoi occhi, in movimento, ma, dall’altro, è numero. Ma tra i pensatori antichi – nota Aristotele – alcuni hanno inteso l’anima come corporea (Democrito), altri invece come incorporea (Platone, Senocrate), altri hanno mescolato le due componenti; alcuni, poi, l’hanno concepita come unica, altri invece come composta da molte parti. Ora Aristotele, dopo aver fatto questa carrellata di opinioni illustri, può, al principio del II libro, esporre la propria tesi: in particolare, egli attua la tecnica della confutazione per dimostrare l’inconsistenza delle posizioni di coloro che hanno sostenuto che l’anima è in movimento. Forse – egli nota – non solo è falso che l’anima sia in movimento, ma addirittura impossibile; ragionando per assurdo, ammettiamo che l’anima si muova: ne consegue quanto segue. In primo luogo, due sono i possibili modi in cui essa può muoversi: o per virtù propria o perché mossa da un’altra cosa. Per comprendere meglio questo punto, pensiamo ad una nave: essa si muove da sé; ma il passeggero che sta seduto su di essa si muove perché è la nave che si muove. L’anima, dal canto suo, muove e si muove: ma in che senso? Nel senso della nave o del passeggero su di essa? Ammettiamo che si muova da sé, come la nave: ma allora dobbiamo fare un’altra distinzione, poiché la >kinhsiV ("movimento") avviene in quattro modi diversi. Infatti, è spostamento da un luogo ad un altro, ma non solo; è anche qualunque forma di mutamento: ad esempio, l’ingrassare o il dimagrire implicano uno spostamento di materia. E ciò vale anche per qualsiasi assunzione o perdita di qualità; infine, il quarto ed ultimo (nonché il più radicale) modo in cui avviene la >kinhsiV consiste nel nascere e nel morire (movimento sostanziale). Ma allora l’anima di quale di questi quattro tipi di >kinhsiV si muove? Ed è tutta l’anima a muoversi di tutti questi movimenti o solamente di uno o di alcuni? Ammettiamo che, oltre a muoversi da sé, essa si muova di tutti e quattro questi movimenti: occorre ammettere che il movimento implica uno spazio, poiché senza di esso il movimento non può avvenire (gli atomisti ammettevano il vuoto ma Aristotele lo rifiuta). L’anima, pertanto, dovrà avere uno spazio in cui muoversi: chi sostiene l’immaterialità dell’anima si trova a questo punto in serie difficoltà, perché è assurdo dover ammettere che un qualcosa di immateriale si muova nello spazio. Inoltre, le potrà accadere ciò che accade a qualunque cosa in movimento: i moti violenti (o costrittivi). Esempio di moto violento è quello della pietra scagliata verso l’alto: essa, dopo essere salita per un tratto in virtù dell’impeto impressole, cade a terra, verso il suo luogo naturale; anche l’anima, quindi, è soggetta a moti violenti? E se sì, di che genere di moto violento? Attribuendo all’anima il movimento autonomo e, con esso, i movimenti violenti, ci si trova sotto scacco: il movimento secondo natura dell’anima tende verso l’alto (come quello del fuoco) o verso il basso (come quello della terra)? Ammettiamo, poi, che essa muova il corpo e che questo si muova per traslazione (spostamento da un luogo all’altro): ne consegue che anche l’anima cambia luogo, ma ciò contraddice coloro che propugnano l’immortalità dell’anima. E se essa muta luogo, lo muta nella sua totalità o solo in parte? Se si riconosce che l’anima è in grado di spostarsi, bisogna per forza riconoscere anche che essa possa uscire dal corpo: quindi, dopo la morte, l’anima può uscire dal nostro corpo e infilarsi in un altro. Se l’anima muove se stessa, anch’essa si muoverà e quindi dovrà necessariamente sdoppiarsi (compie e subisce il movimento) e in tal modo essa uscirebbe da sé, sarebbe una >ekstasiV ("venir fuori di sè"). Lo stesso modo in cui si muovono gli animali genera parecchie difficoltà, nota Aristotele; come causa motrice, l’anima ha la >proairesiV , la "scelta libera" e, in tale prospettiva, il meccanicismo democriteo, che non lascia spazio alla libertà, va respinto. Anche il "Timeo" platonico è, sotto questo profilo, problematico: in quest’opera, Platone ammette che il cosmo stesso sia dotato di un’anima che, muovendosi circolarmente, metta in moto anche l’universo corporeo; l’anima sarebbe composta di elementi in rapporti armonici, per cui ai rapporti del cielo corrisponderebbe il movimento dell’anima. Ma ciò è riduttivo, in quanto induce a identificare l’anima con l’intelletto: secondo tale definizioni, gli animali e le piante sarebbero inanimati, alla stregua delle pietre. Platone, in realtà, sosteneva l’esistenza di altre anime (sensitive) che non si muovevano circolarmente: contro questa posizione, Aristotele muove una sfilza di obbiezioni che invocano la divisibilità all’infinito delle grandezze; gli stessi rapporti armonici su cui Platone costruisce il suo ragionamento restano poco chiari e alquanto problematici. Ma si deve paragonare il pensiero ad un movimento o ad uno stato di quiete? Platone connette il movimento dell’anima a quello rotativo del cielo ma non spiega né la causa finale né quella efficiente di tale moto rotatorio. Tuttavia, si può anche ammettere che l’anima si muova non già per virtù sua, bensì perché mossa da altro: ciò sembra possibile soprattutto in riferimento alla percezione, in quanto percepiamo un oggetto nella misura in cui esso agisce su di noi. E poi c’è un’altra grave lacuna: tutti i pensatori anteriori rispetto ad Aristotele, hanno connesso l’anima al corpo, senza però spiegare con chiarezza la causa di tale collegamento; perché, dunque, l’anima è collegata al corpo? Quale è la condizione del corpo alla quale l’anima è legata? Aristotele dice che " sembra " ( >dokei) che ciascun corpo abbia una forma propria e ciò implica che non è detto che ogni corpo abbia un’anima. I pensatori del passato, nota con sdegno Aristotele, dovevano allora spiegare quali corpi potessero avere l’anima e quali no, sennò si potrebbe essere indotti a ritenere che anche una pietra possa esserne dotata. Quale dovrà essere, quindi, la struttura del corpo suscettibile di possedere un’anima? Nel capitolo 4 del libro I, Aristotele prosegue con le obbiezioni, scagliandosi soprattutto contro la concezione secondo la quale l’anima altro non è se non un’armonia che tiene uniti gli elementi che costituiscono il corpo; si tratta di una tesi platonica, esposta nel "Fedone", ma criticata da Platone stesso, poiché, come conseguenza, porta alla negazione dell’immortalità dell’anima (venuto meno il corpo, infatti, cessa di esistere anche l’armonia tra i suoi elementi). Se invece intendiamo l’anima come una sostanza che viene ad aggiungersi al corpo, alla pari di un vestito, non si deve ammettere – notava Platone – che essa, col trascorrere del tempo, si logori fino a dissolversi? Aristotele, memore di queste riflessioni del suo maestro, dice: " sembra poi che l’intelletto sopraggiunga come una sostanza e che non si corrompa. In effetti, potrebbe corrompersi specialmente per l’indebolimento che consegue alla vecchiaia " (A 4, 409). Secondo quanto afferma qui Aristotele, l’intelletto, una volta che sia venuto meno il corpo, non potrà più svolgere la propria attività; certo, l’intelletto come sostanza non si corrompe, ma, ciononostante, l’attività di pensiero che egli svolge è possibile solo in relazione al corpo dotato dell’intelletto; sicché, quando viene a mancare il corpo, l’intelletto permane ma non pensa più: esso è una sostanza che non si logora, poiché – come dice Aristotele – è " sopraggiunto " (è però difficile capire da dove sia giunto). Le funzioni che esso svolgeva, infatti, non erano solo sue, bensì condivise con il corpo: e se ammettiamo l’incorruttibilità dell’intelletto, allora possiamo dire che esso è " forse qualcosa di più divino e di impassibile ". Il corpo muore, l’intelletto no: ma Aristotele non sta parlando dei singoli intelletti (il mio, il tuo, quello di Socrate, ecc), ma di qualcosa di più profondo (nella comprensione del quale la critica si è sbizzarrita, soprattutto quella araba). Nel libro II, dicevamo, Aristotele propone la sua concezione dell’anima e la correda di potenti argomentazioni. Proprio nelle prime righe, egli asserisce: "riprendiamo ora la strada come dall’inizio ", nel tentativo di determinare che cosa sia l’anima e quale sia il suo concetto " più generale ", più comune, ossia quello che può abbracciare sotto di sé tutti i tipi di anima. Lo Stagirita afferma che, fra i tanti significati del verbo "è" ve n’è uno primario, da cui tutti gli altri derivano, un "significato focale", come ha detto uno studioso di Aristotele: tale significato profondo sta nella sostanza ( >ousia); una cosa è se è una sostanza. Per capire meglio ciò, esaminiamo una sostanza qualunque, ad esempio una sfera di bronzo: che cosa è? Posso rispondere in svariati modi: in primo luogo, posso dire "è bronzo", indicando il materiale di cui è costituito l’oggetto (colgo cioè l’oggetto sotto l’aspetto della materia, >ulh); ma limitarsi a rispondere dicendo "è bronzo" è evidentemente sbagliato, poiché esistono altre cose di bronzo che non sono quella sostanza. Oltre alla materia, dunque, si deve anche indicare la forma ( >morfh): nel caso della sfera di bronzo, l’essere sferico. La sostanza, secondo Aristotele, è sempre un >tode ti, un "questa cosa qui", ossia la cosa materialmente presente sotto i miei occhi. Nel II libro, dunque, Aristotele prova a dare una definizione generale di anima e ad analizzarla criticamente: anima sarà, a suo avviso, l’avere la funzione del riprodursi e la possibilità di avere percezioni sensibili. Si tratta, però, di definire in concreto cosa sia l’anima e, per farlo, lo Stagirita introduce la nozione di >ousia ("sostanza"), ossia quel qualcosa che fa sì che un ente sia ciò che è propriamente. Tale concetto può essere, tuttavia, inteso secondo svariate modalità: ad esempio, posso dire che "sostanza" del tavolo è essere materia (legno), oppure essere forma rettangolare, o, ancora, essere una materia connessa ad una forma, ossia un insieme ( >sunolon) delle due cose. Da questa concezione emerge un universo popolato da un enorme numero di sostanze individuali. Ora, Aristotele traccia un’identità tra la materia e la potenza ( >dunamiV), poiché nota come dalla materia (ad esempio, un pezzo di marmo) possa ( >dunatai) derivare una molteplicità di cose (il tavolo, la statua, il tempio, ecc); e a far sì che il pezzo di marmo diventi un preciso oggetto (ad esempio, una statua) è la forma, la quale corrisponde quindi all’atto, ossia alla realizzazione. E con quest’attrezzatura concettuale Aristotele può dare una spiegazione (e di fatto lo fa) dell’intera realtà: egli paragona il rapporto tra potenza e atto al rapporto tra il possedere una scienza e farne effettivamente uso. Se, ad esempio, ho appreso la grammatica, posso dire di possederla allo stato potenziale: solo quando la applico concretamente essa viene messa in atto operativamente. Ora, per tratteggiare una definizione dell’anima, riprende questi precetti e, in particolare, quello di sostanza: comunemente si intendono come sostanze i corpi, cioè quelle realtà che sussistono effettivamente; tra essi, poi, constatiamo che alcuni hanno la vita, altri no. E, nota Aristotele, in prima analisi ciò che ci induce a dire che alcuni corpi sono animati e altri no è il fatto che solo quelli animati crescono, si nutrono, deperiscono, si riproducono, ecc. Ed è a questo punto che diventa lecito chiedersi che cosa sia a conferire a tali corpi la vita: saranno vivi perché possiedono la materia? O perché hanno la forma? Aristotele risponde che essi sono vivi perché dotati di entrambe le cose, sia della forma, sia della materia, dove la materia è costituita dal corpo, la forma dall’anima. Quest’ultima, infatti, è quel qualcosa che fa sì che la materia si animi, abbia vita e sia un corpo vivente: " di conseguenza ogni corpo naturalmente dotato di vita sarà sostanza e lo sarà precisamente nel senso di sostanza composta [di materia e forma] ". Ma, poiché si tratta di un corpo di una determinata specie, e precisamente di un corpo che ha la vita, allora ne conseguirà che l’anima non è il corpo, giacchè altrimenti anche le pietre – dotate di corpo – dovrebbero avere un’anima. Allora il corpo è un sostrato ( >upokeimenon, "che giace sotto"), un soggetto (dal latino "sub-iactum"), ossia è la materia che "sta sotto", che soggiace alla forma e, in quanto tale, è indeterminata. Il corpo, quindi, accoglie l’anima, cioè la forma: " necessariamente dunque l’anima è sostanza, nel senso che è forma di un corpo naturale che ha la vita in potenza. Ora, tale sostanza è atto, e pertanto l’anima è atto del corpo che s’è detto ". L’anima, pertanto, è sostanza nel senso di "forma" di un corpo dotato potenzialmente (e non attualmente) della vita: ma di poter accogliere la forma "anima" non sono in grado tutti i corpi (ad esempio, non lo è una pietra), ma solo i corpi di un certo tipo, quelli cioè che hanno la potenzialità di ricevere la forma "anima" che porta all’attualizzazione della vita. In particolare, deve essere un corpo tale da possedere organi: ed è grazie all’anima che la vita, da in potenza, passa in atto, anche se questa distinzione potenza/atto è semplicemente concettuale, non cronologica. Ma in che senso l’anima è atto? Nello stesso senso in cui noi facciamo grammatica in atto? Aristotele si rende conto che ciò non è possibile e che è assolutamente assurdo dire che, durante il sonno, l’uomo non ha l’anima, assurdo come dire che quando non si pratica la geometria non la si possiede. Al contrario, noi abbiamo l’anima sempre, anche se quando dormiamo essa non è attiva nelle sue funzioni, c’è ma non è in atto: " atto poi si dice in due sensi: o come la conoscenza [= possesso della conoscenza] o anche come esercizio di essa; ed è chiaro che l’anima è atto nel senso in cui lo è la conoscenza […]. Perciò l’anima è l’atto primo di un corpo naturale che ha la vita in potenza. Ma tale corpo è quello che è dotato di organi ". E la parola >organon presente nel testo (che è poi la stessa con la quale verranno denominati gli scritti aristotelici di logica) significa, letteralmente, "strumento", sicchè un corpo è dotato di parti, ciascuna delle quali è "strumento" dotato di una sua funzione, una sua operazione psichica, cioè propria dell’anima. Ecco che comincia a farsi più chiara la connessione tra anima e corpo: e, in quest’ottica, Aristotele trae una prima importante conseguenza, enunciando che, in quanto dotate di vita, anche le piante hanno un’anima e ciò è provato dal fatto che esse abbiano organi (le radici, ad esempio), ossia "parti" che consentono loro di crescere, di assumere nutrimento e di riprodursi: " organi sono anche le parti delle piante, ma incredibilmente semplici " (412 b). Il nutrirsi, il crescere e il riprodursi sono funzioni semplicissime, che vengono svolte – seppur in modi diversi – anche da altri esseri animati, quali gli animali e l’uomo: oltre alle piante, infatti, anche agli uomini e agli animali compete, evidentemente, la funzione nutritiva dell’anima; solo che non è l’unica presente in essi – e qui sta la differenza rispetto alle piante. Infatti, nell’animale troviamo anche la funzione sensitiva, e nell’uomo – oltre a quella nutritiva e a quella sensitiva – quella razionale. In tale prospettiva, quindi, il problema dell’unità anima-corpo non si pone neanche, poiché la vita si ha sempre e solo come insieme delle due cose, che non possono mai stare tra loro separate, alla pari della cera e della figura. " E’ quindi manifesto che l’anima (ed alcune sue parti, se per sua natura è divisibile in parti) non è separabile dal corpo, giacché l’attività di alcune sue parti è l’atto delle corrispondenti parti del corpo ": in altri termini, secondo Aristotele, gli occhi possono vedere, le orecchie udire solo se c’è l’anima, e così via; ciò significa che l’occhio, l’orecchio, ecc., non può vedere o sentire in potenza, e perché veda o senta in atto occorre che ci sia l’anima. " Ciononostante nulla impedisce che almeno alcune parti siano separabili, in quanto non sono atto di nessun corpo "; la definizione di anima come corpo che può avere la vita in potenza è una definizione generale, valida universalmente per tutti i corpi viventi. E ora Aristotele scende nei particolari, domandandosi quale sia l’anima delle piante, quale quella degli animali e, infine, quale quella dell’uomo. Quindi, dopo la qualificazione generale della nozione di anima, è giunto il momento di indagare su che cosa caratterizzi le singole classi di viventi (piante, animali, uomo). Aristotele, tuttavia, si sofferma ancora (nel II e nel III paragrafo) sulla nozione di anima, precisando come una buona definizione non si limiti a mostrare che cosa sia una determinata cosa, bensì esibisca anche la causa, ovvero il perché quella cosa è tale: " gli enunciati delle definizioni sono simili alle conclusioni " (413). Per lo Stagirita, un buon ragionamento deve partire da premesse vere per approdare a conclusioni altrettanto vere: un ragionamento di questo tipo rende conto della causa. Se infatti dico che "tutti gli uomini sono mortali", posso motivarlo adducendo come causa il fatto che "tutti gli uomini sono animali" e che "tutti gli animali sono mortali". Quindi, come si evince facilmente dall’esempio che abbiamo appena fatto, una buona definizione corrisponde alla conclusione di un sillogismo, giacché è solo in tal modo che si può render conto delle cause. Fatte queste considerazioni, Aristotele riprende la ricerca da lui lasciata in sospeso, ritornando su punti già assodati e arricchendoli: riprendendo, in particolare, la distinzione tra essere animato ed essere inanimato (distinzione racchiusa nel fatto che l’uno vive, l’altro no), nota acutamente come l’espressione "vita" sia carica di svariati significati. Allora Aristotele spiega come sia lecito dire che un essere vive se ad esso appartiene anche una sola di queste caratteristiche: l’intelletto, la sensazione, il movimento e la quiete del luogo, e inoltre il mutamento nel senso della nutrizione e della crescita. Ne consegue, naturalmente, che ad essere viva non è solo l’entità pensante, ossia l’uomo: anche le piante vivono, poiché crescono in più direzioni, anzi " in tutte le direzioni " e ciò vale finché riescono ad assorbire nutrimento. La funzione nutritiva, pertanto, costituisce già essa stessa una prima forma di anima e Aristotele nota come vi siano parecchi corpi che vivono in virtù di quest’unica funzione: " questa facoltà può esistere indipendentemente dalle altre, mentre è impossibile negli esseri mortali, che le altre esistano indipendentemente da essa ". Affiora efficacemente come il vivente si strutturi come una lunga scala di esseri animati (la "scala naturae"), tant’è che vi sono animali che si trovano ai confini del regno vegetale: pensiamo a certi animaletti dotati di conchiglia, che non si muovono, abbarbicati agli scogli. Ma ciò che, in ogni caso, contraddistingue l’animale dalla pianta è la sensazione, garantita dal possesso di organi di percezione: non c’è animale che ne sia sprovvisto, perfino il più semplice che si possa immaginare; tutti, anche quelli più prossimi alle piante, hanno almeno un organo di percezione: il tatto. E in una pagina magnifica del "De partibus animalium", Aristotele dice che non vi è nessuna cosa che sia indegna di essere conosciuta, perfino un verme. "L’anima è il principio delle facoltà che abbiamo detto" ed è da esse determinata (anima nutritiva perché si nutre, sensitiva perché ha sensazioni, intellettiva perché formula pensieri). A questo punto, il filosofo greco si domanda se l’anima sia suddivisa in parti e se esse – ammettendo che esistano – siano da essa separabili e, nel caso lo siano, se lo sono solo concettualmente o anche materialmente. E l’analisi che Aristotele conduce tiene conto delle distinzioni acquisite tra piante, animali e uomini: una prima cosa da constatare è un atteggiamento peculiare delle piante, in virtù del quale è possibile staccare da esse dei pezzi ed essi continueranno a vivere indipendentemente dalla pianta (pensiamo agli "innesti"). Perfino i vermi possono essere tagliati in parti e ciascuna di esse continuerà a vivere per conto suo. Ciò sembra avvalorare l’ipotesi della costituzione in parti dell’anima e della separabilità delle medesime: l’anima di questi vermi o di tali piante è, pertanto, una in atto, ma molteplice in potenza. Se l’anima ha sensazioni, poi, si può pensare che abbia la >fantasia , la capacità di conservare le immagini acquisite con i sensi. L’animale, nota Aristotele, si muove verso qualcosa, in primo luogo verso il cibo: anche nell’uomo troviamo una >orexiV, un’ "appetizione", ma in tal caso è l’intelletto ad essere il motore. Dove ci sono il piacere e il dolore c’è anche il desiderio, inteso come ricerca di ciò che procura piacere e di ciò che scaccia il dolore: a un tale desiderio, dunque, si associa la >orexiV, che si esprime mediante il movimento. Preso atto dell’inseparabilità dell’anima dal corpo, pare che solamente l’intelletto possa essere da esso disgiunto: l’intelletto, infatti, è eterno, c’è da sempre, alla pari della specie "cavallo", "uomo", "cane", ecc. Ma sorge spontanea la domanda: allora tale intelletto è unico o ce ne sono tanti, uno per ciascuno di noi? Essendo esso una forma e per di più unica, ne consegue che l’intelletto è unico per tutti gli uomini (tesi sulla quale insisteranno soprattutto – in età medioevale – gli interpreti arabi di Aristotele). Ne risulta che le singole parti che formano l’anima (nutritiva, sensitiva, razionale) sono separabili solo a livello concettuale (ossia per funzioni), ma non a livello concreto: e a conclusione del paragrafo II, lo Stagirita tenta di dare una definizione di anima che tenga in considerazione la causalità: l’anima è ciò in virtù di cui viviamo e percepiamo, dove la causa sta appunto nel "ciò in virtù di cui". Tale espressione, però, è bivalente, poiché non spiega cosa sia ciò mediante cui conosciamo. Cos’è, dunque, quel qualcosa che ci fa conoscere? Conosciamo perché possediamo le conoscenze, ma anche perché abbiamo l’anima: così come siamo sani perché abbiamo la salute, ma anche grazie ad una determinata parte del corpo. In tale prospettiva, la conoscenza e la salute vanno intese come atto del soggetto ricettivo ( >upokeimenon) che accoglie la conoscenza (funzione dell’anima razionale) e la salute (funzione del corpo). Dunque, la conoscenza e la salute sono le forme connesse all’anima e al corpo. Ciò mediante cui viviamo e percepiamo è l’anima, intesa come causa di determinate operazioni connesse ad un dato corpo. " Perciò è corretta l’opinione di quelli che sostengono che l’anima non è un corpo, ma non esista senza il corpo ": l’anima, senz’altro, non è un corpo; essa è, piuttosto, una proprietà, un "qualcosa" ( >ti) del corpo; naturalmente, non ogni corpo può accogliere una determinata funzione, come invece avveniva secondo i colleghi di Aristotele a lui precedenti. Si deve trattare, viceversa, di un corpo adatto, dotato degli organi appropriati. Focalizzando l’indagine sull’uomo, ad esso competono tutte e tre le funzioni dell’anima: egli, infatti, si nutre e cresce (funzione nutritiva), ha sensazioni (funzione sensitiva) e, in più, è dotato del pensiero (funzione intellettiva), che può essere quindi individuato come caratteristica tipicamente umana, che contraddistingue l’uomo da ogni altro ente (tant’è che la definizione più appropriata di uomo è quella di "animale razionale"). Grazie alla funzione sensitiva, l’uomo prova il piacere e il dolore e, di conseguenza, anche il desiderio ( >epiqumia ), ossia l’ >orexiV verso ciò che dà piacere. La volontà, invece, non è intendibile come >epiqumia , ma come >orexiV, in quanto è tendenza non solo verso il piacere, ma anche – talvolta – verso il dolore: ad esempio, posso volermi sottoporre ad un doloroso inrervento chirurgico. Nel paragrafo IV, Aristotele concentra la propria attenzione sulla facoltà nutritiva dell’anima, provando a darne una definizione e indagando su tutto ciò che è legato ad essa. Prima di poter dire che cosa sia tale facoltà, occorre descriverne l’attività connessa: infatti, solamente se so cos’è il nutrimento potrà capire che cos’è la funzione nutritiva, giacchè " le attività e le funzioni dal punto di vista logico sono anteriori alle facoltà ". Ciò perché la nutrizione è in atto, la facoltà di nutrirsi è in potenza: non è un caso che, in greco, >dunamiV designi tanto la "potenza" quanto la "facoltà". Ma vi è un’altra priorità: rispetto all’attività stessa, ci devono già essere prioritariamente gli oggetti con cui la facoltà in questione ha a che fare; cosicchè è vero che il nutrirsi sta prima della facoltà di nutrirsi, ma ciò non toglie che il nutrirsi venga dopo al fatto che esistano oggetti di cui nutrirsi (il cibo). Similmente, perché io veda occorre che vi siano oggetti da vedere; perché io senta, oggetti da sentire. Detto questo, è bene puntualizzare come anche le piante si riproducono (oltre a nutrirsi), ossia generano esseri viventi a loro simili (" uomo genera uomo ", ama ripetere Aristotele). Da questa concezione, è facile capire come l’immortalità, negata ai singoli, sia invece garantita alle specie: e ciò grazie alla ri-produzione, ossia alla possibilità che ogni esemplare ha di produrre un altro sé (ri-produzione), rendendo possibile l’eternità della sua specie. La riproduzione, pertanto, è la funzione più naturale degli esseri viventi, i quali la attuano per realizzare un "fine" dal duplice valore: assicurare la continuità della specie e partecipare all’eterno. " Poiché questi esseri non possono partecipare con continuità dell’eterno e del divino, in quanto nessun essere corruttibile è in grado di sopravvivere identico e unico di numero ": tematica, questa, che riaffiora nel X libro dell’ "Etica nicomachea"; la natura sa che ciascuno vorrebbe protrarsi in eterno e allora concede, come unica possibilità affinchè ciò avvenga, la riproduzione: " ciascuno ne partecipa per quanto gli è possibile, chi più e chi meno, e non sopravvive a se stesso, ma in un individuo simile ". Da queste considerazioni, si evince come, per Aristotele, perfino il fatto che un essere generi un essere a sé simile non è cosa ovvia, ma genera quella meraviglia che costituisce la causa scatenante dell’indagine filosofica. Analogamente, egli chiarisce in che senso si può dire che l’anima è causa e principio del corpo vivente: se vogliamo attribuirle tale funzione di causalità, allora dobbiamo capire che cosa effettivamente intendiamo per "causa" ( >aitia ), con un procedimento affine a quello seguito nella definizione di "sostanza" e di "anima". Essa non risponde al "che cosa?", ma al "perché?": ciò significa che non rende conto dell’ >oti ("che"), ma del >dioti ("perchè"). In particolare, la causa è quel qualcosa che permette di spiegare il perché di una cosa, ma, al contempo, è anche ciò che la fa essere in senso compiuto. Tre sono i significati attribuibili al termine "causa": altrove, Aristotele ne attribuisce anche un quarto, corrispondente alla causa materiale, ma in questo contesto lo tralascia, giacchè non ha senso parlare di "materia" a proposito dell’anima. " Causa e principio si dicono in molti sensi e in confronto a ciò l’anima si dice causa nei tre modi che abbiamo distinto ": come "principio del movimento" ( >oqen kinhsiV), come "fine", come essenza ( >ousia) dei corpi animati. E Aristotele analizza caso per caso queste tre definizioni in riferimento all’anima: " che l’anima sia causa come essenza è evidente: infatti, la sostanza è per tutte le cose la causa del loro essere [cioè del fatto che esistano e siano quel che sono] "; ma, nel caso specifico degli esseri viventi, il loro essere sta nel vivere e causa del vivere è appunto l’anima, non il corpo (poiché infatti di esso anche le pietre sono dotate). " E’ poi evidente che l’anima è causa anche come fine ": a tal proposito, Aristotele fa un parallelo tra il modo in cui agisce l’intelletto e quello in cui agisce la natura. Così come l’intelletto agisce in vista di qualcosa, ossia mi induce ad agire affinchè finalisticamente io raggiunga un obiettivo, similmente anche la natura " non fa nulla invano ", non è frutto del caso (per quel che riguarda gli avvenimenti che si verificano sempre o > epi to polu, "per lo più"). Tutti i processi naturali, dunque, si verificano secondo una certa regolarità e in vista di determinati fini, come avviene per la generazione degli animali: così certi viventi hanno i polmoni per poter respirare e l’uomo non è l’animale superiore perché ha la mano (come credeva Anassagora), ma ha la mano perché è l’animale superiore, ossia per poter esplicare al meglio le sue funzioni che lo rendono superiore. " Tutti i corpi naturali sono strumenti ( >organa) dell’anima ", strumenti nel senso che servono per realizzare quelle determinate funzioni psichiche; in quest’ottica, l’anima è il fine del corpo, ciò che fa sì che esso sia sfruttato in quel modo. Sicchè Aristotele potrà affermare, in altri scritti, che la mano è " lo strumento degli strumenti ", poiché serve all’uomo da strumento per utilizzare gli altri strumenti. Sbaglia, dunque, Anassagora a ritenere che l’organo crei la funzione; al contrario, è la funzione che crea l’organo (per vedere abbiamo gli occhi, per udire le orecchie, e così via): e tutto ciò per compiere le funzioni psichiche (nutrirsi e riprodursi per le piante; nutrirsi, riprodursi e avere sensazioni per gli animali; nutrirsi, riprodursi, avere sensazioni e pensare per gli uomini). Infine, il terzo tipo di causa è quella da cui ha origine il movimento: " l’anima costituisce la prima origine del movimento locale "; si muove perché tende a qualcosa. Successivamente, Aristotele critica alcune concezioni di come avvengono i processi di nutrizione e crescita: in particolare, la prospettiva di Empedocle, ad avviso del quale sarebbe il movimento dei quattro elementi che compongono il mondo a far sì che si verifichi la nutrizione; ma anche la teoria di coloro che hanno visto in un solo elemento (il fuoco) il fattore che dà la nutrizione. Del resto, Aristotele stesso, in alcuni scritti, parla di >peyiV, di cozione del cibo che avviene grazie ad un calore interno (quasi come se ci fosse il fuoco in noi) che riscalda il cibo che ingeriamo. La vera causa della nutrizione, a dispetto di tutte queste stravaganti fantasticherie, è l’anima (nutritiva), la quale permette al corpo di nutrirsi e di svilupparsi: ed è a questo punto che lo Stagirita si chiede se la nutrizione avvenga per assunzione di ingredienti a noi simili o contrari a quelli del nostro corpo. Già Anassagora si domandava come fosse possibile che, mangiando pane, noi cresciamo in carne ed ossa e rispondeva sostenendo che, in qualunque oggetto – anche se in diverse proporzioni -, sono presenti infiniti "semi" di tutte le cose, cosicchè mangiando un pezzo di pane ingoio anche semi di carne, di ossa, ecc. Ora, Aristotele dice che, nel momento in cui si forma un organismo, esso ha bisogno anche del suo contrario, ma, una volta diventato adulto, assume solo più il simile a se stesso. Fatte queste considerazioni, l’attenzione del filosofo greco viene proiettata sulla funzione sensitiva dell’anima, funzione che presiede ai cinque organi di senso: in particolare, il paragrafo V è dedicato all’ >aisqhsiV, e, in primo luogo, Aristotele chiarisce come la percezione sensibile consista in un >kineisqai , in un "essere mosso", in un >pascein , un "subire" qualcosa: precisamente, subisco l’azione di un oggetto esterno che mi altera. Ne consegue che la sensazione sarà un qualcosa di passivo, ricettivo che accoglie ciò che proviene da fuori. " Infatti la sensazione consiste nell’essere mossi e nel subire un’azione, giacchè sembra che sia una sorta di alterazione ": e Aristotele si serve di un’aporia per chiarire la passività della sensazione. Infatti egli si chiede: perché non ha luogo la percezione degli organi percettori? Perché quando vedo coi miei occhi gli oggetti del mondo non vedo i miei occhi stessi? Perché essi, se non ci sono oggetti esterni, non percepiscono nulla (pur essendo costituiti dagli stessi quattro elementi che compongono il resto del mondo)? La risposta è che la facoltà sensitiva propria di questo tipo di anima è una >dunamiV , una "potenzialità"; infatti, abbiamo la facoltà percettiva ma non nel senso che percepiamo costantemente in atto, bensì nel senso che la esercitiamo in certi momenti ma, anche quando non la esercitiamo, ne restiamo pur sempre in possesso. E da che cosa dipende che in certi casi percepiamo e in certi altri no? Dal fatto che in quel momento è presente in atto l’oggetto corrispondente a quella determinata facoltà percettiva: ho di fronte a me una casa e, dunque, posso percepirla visivamente e a far passare la potenzialità del vedere in atto è l’oggetto esterno (cioè la casa), così come il combustibile non può bruciare senza il comburente. Tutto cambia, però, se parliamo dell’intelletto: grazie ad esso, pensiamo secondo il nostro volere, senza che le cose pensate siano concretamente di fronte a noi. La percezione si trova quindi in una duplice condizione (in potenza e in atto) e lo stesso vale per un oggetto sensibile: qualsiasi oggetto può (potenzialmente) essere visto e se, effettivamente, viene visto, allora è visibile in atto. " Il movimento è una specie di atto, benché imperfetto ": qui Aristotele fa riferimento alla nozione di movimento, il quale è passaggio dalla potenza all’atto, e diventa compiuto solo alla fine. Ora, ogni essere che subisce un’azione ed è mosso, lo è ad opera di un oggetto in atto. Ma come mai, allora, vedo un oggetto giallo? Esso è diverso rispetto alla mia pupilla: a tal proposito, c’è un passo in cui Aristotele sembra suggerire che la mia stessa pupilla diventa gialla, cioè simile all’oggetto visibile, come se ci fosse qualcosa che assimila le proprietà dell’oggetto visto e la funzione. Aristotele fa ancora una volta presente come il concetto di potenza sia complesso, poichè articolato in più livelli non facilmente distinguibili: così l’uomo in quanto uomo, fin dalla nascita, è potenzialmente dotato del sapere, anche se non ha ancora acquisito nessuna nozione. Ma anche l’uomo dotato di sapere, non potrà applicarlo incessantemente: nel momento in cui non lo applica, ne è dotato potenzialmente; quando poi lo applicherà concretamente, allora il suo sapere passerà dalla potenza all’atto. ” Riguardo alla potenza e all’atto è necessario operare una distinzione, poichè ora ne abbiamo discusso in maniera sommaria. Un essere è conoscente o al modo che diremmo conoscente l’uomo, perchè è uno degli esseri che conoscono e che detengono il sapere; oppure al modo che diciamo ormai conoscente colui che possiede la conoscenza della grammatica. Costoro non si trovano in potenza alla stessa maniera, ma il primo perchè il suo genere e la sua materia sono di un certo tipo, il secondo perchè, qualora lo desideri, può esercitare la sua conoscenza, purchè qualche cosa di esterno non glielo impedisca. ” [417 a]. E Aristotele dice che colui che acquisisce il sapere che, in quanto uomo, possedeva potenzialmente fin dalla nascita, ” subisce un’alterazione mediante l’apprendimento “: anche quest’espressione – come il termine “potenza” – presenta un duplice significato. Infatti, posso subire un’azione o in modo tale che essa mi danneggi o, viceversa, che mi rafforzi: sicchè il ” >to pascein ” (“il subire”) può designare una particolare forma di distruzione che io subisco per l’azione di un qualcosa a me contrario o può designare un rafforzamento del mio stato. In quest’ottica, colui che conosce passa da conoscente in potenza a conoscente in atto, ma non per alterazione distruttiva, bensì rafforzativa: ” pertanto non è corretto affermare che chi pensa, quando pensa, come pure l’architetto, quando costruisce, subiscono un’alterazione “. Sottolineando come l’apprendimento non sia tanto dato dall’azione di un oggetto esterno, quanto piuttosto da un passaggio, tutto interno al soggetto, da ignoranza a conoscenza, Aristotele è mosso da suggestioni platoniche (pensiamo a quando nel “Menone” si diceva che conoscere è ricordare). Dunque, se c’è un solo significato della parola “alterazione” (intesa come distruzione), allora nella conoscenza, propriamente, non può esserci alterazione: se invece diamo a tale termine anche il significato di “rafforzamento”, di cambiamento in meglio, allora si potrà dire che anche il processo conoscitivo è una forma di alterazione, di passaggio dall’ignoranza alla conoscenza. E il primo mutamento a cui è soggetto un ente dotato di anima sensitiva è l’essere prodotto dal genitore: una volta generato, l’individuo possiede già la sensazione allo stesso modo in cui possiede – potenzialmente – la scienza. Tuttavia, vi è una differenza imprescindibile tra la sensazione e la conoscenza: nella prima, a produrre l’atto sensitivo sono gli oggetti esterni (vedo perchè ci sono oggetti esterni che producono in me il passaggio da vedente in potenza a vedente in atto); sarà invece la >fantasia a lavorare pur senza la presenza di oggetti esterni. La scienza, invece, non ha di fronte a sè oggetti esterni: cosicchè, se la sensazione ha a che fare con oggetti singolari (le entità individuali) – e la stessa ossatura dell’universo è costituita da entità singole -, la scienza ha per oggetto gli universali, i quali si trovano nell’anima stessa e non esternamente (come invece credeva Platone, che attribuiva esistenza autonoma alle Idee). Il soggetto – nota Aristotele – può pensare qualsiasi oggetto quando lo vuole, ma ciò non toglie che non pensa l’oggetto in carne e ossa, bensì l’immagine di quell’oggetto. E’ infatti il sensibile in atto che fa sì che l’immagine in potenza passi anch’essa in atto e, in questa prospettiva, è di fondamentale importanza capire che cosa siano gli oggetti sensibili e in quanti modi possa essere percepita una cosa. La prima grande distinzione operata dallo Stagirita è tra oggetto sensibile “per sè” ( >kaq’ > auto ) e oggetto sensibile per accidente ( >kata sumbebhkoV ). Propri ( >idia ) sono poi quei sensibili che competono a ciascun senso, giacchè ciascuno dei cinque sensi ha come oggetto qualcosa di specifico, che può essere solo da esso percepito. Così solo l’udito può percepire i suoni, solo il gusto i sapori, solo l’olfatto gli odori: e la vista? Quali sono i suoi “sensibili propri”? Aristotele risponde che essa ha per oggetto i colori. Egli introduce poi, sul piano gnoseologico, un’importante novità, asserendo che il senso – se funzionante – non sbaglia mai. Infatti, l’udito non potrà mai sbagliare nell’attestare che sta percependo un suono, e lo stesso vale per gli altri sensi: ciascuno di essi giudica ( >krinei ) il suo oggetto proprio e non si inganna nel dire che sente un suono, vede un colore, fiuta un odore, ecc. Tuttavia, l’errore nasce quando, ad esempio, ci si domanda “che cos’è che ha quel colore?” o “dov’è quella cosa che ha quel colore?”. Ma, se ogni senso percepisce solo i suoi sensibili propri, come si spiega il fatto che percepiamo gli oggetti nel loro complesso? Aristotele risolve questa apparente contraddizione introducendo, accanto ai sensibili propri, i sensibili comuni ( >koina ), i quali non sono legati ad un solo senso. Di sensibili comuni Aristotele ne individua parecchi: il movimento, la quiete, il numero, la figura, la grandezza. Aristotele, però, non dà indicazione sugli errori: è tuttavia verosimile pensare ch’egli ritenga che già coi sensibili comuni siano possibili errori (posso ingannarmi nel percepire un movimento). Gli errori si verificano soprattutto nei sensibili per accidente: se, infatti, vedo una macchia bianca e dico “è il figlio di Diare”, la vista percepisce il colore bianco, ma che quel bianco sia il figlio di Diare lo percepisce per accidente. Infatti, se effettivamente è il figlio di Diare, allora si tratta di una percezione corretta; se, invece, non è il figlio di Diare, allora si tratta di una percezione sbagliata. In altri termini, la vista non sbaglia nel vedere la macchia bianca, ma sbaglia nell’associarla alla persona, visto che al bianco capita per accidente di essere il figlio di Diare. ” Perciò non subiamo alcuna azione dell’ente sensibile in quanto tale “: ma l’ente sensibile cui allude Aristotele è il colore o il figlio di Diare? E’ verosimile che sia il figlio di Diare. Sensibili per accidente sono quegli oggetti che possono essere percepiti casualmente, ossia può succedere che vengano percepiti: e Aristotele si sofferma diffusamente su ciascuno dei cinque sensi e sui loro sensibili propri. Il sensibile proprio della vista è – come abbiamo detto – il colore che si trova sulla superficie dell’oggetto visto, ma, accanto al colore, Aristotele pone anche il fosforescente (cioè la luminosità che si percepisce al buio); tra l’oggetto percepito e l’organo percipiente si trova un medium, un qualcosa di intermedio che Aristotele chiama "il trasparente" ( >ti diafaneV ), che è connesso alla luce: quest’ultima, infatti, è l’attualizzazione del trasparente stesso. Ed è grazie al medium che vediamo la luce: perché si possa vedere, infatti, ci vuole la luce e, oltre ad essa, il medium trasparente che sta tra il colore e l’occhio: nel caso della vista tale medium è dato dall’aria (ma anche dall’acqua). In altri termini, il medium è mosso dall’oggetto e a sua volta muove il soggetto percipiente. Ne consegue che il colore dell’oggetto esercita un’azione non tanto sull’occhio, quanto piuttosto sul medium, modificando il trasparente illuminato: e questa modificazione produce a sua volta un’azione sull’occhio. Aristotele fa riferimento al medium anche per poter spiegare la visione di oggetti a distanza e per differenziarsi dall’atomismo (per il quale la percezione era data da pellicole atomiche che si allontanavano dagli oggetti per raggiungere i nostri sensi). Naturalmente, il discorso del medium interposto tra gli oggetti e i sensi vale non solo per la vista, ma per tutti i sensi: ogni senso ha il suo medium privilegiato, così ad esempio per la vista è l’aria, per l’udito anche, e così via. Aristotele mostra qualche riserva per l’olfatto, perché è vero che sembra che esso abbia il suo medium nell’aria, però è anche vero che – attraverso i suoi studi zoologici – Aristotele ha scoperto che diversi animali acquatici hanno l’odorato. Dopo essersi soffermato sulla vista (che di tutti i sensi è quello che gli pare più importante, come egli stesso confessa nella "Metafisica"), lo Stagirita passa all’udito, avente per sensibile proprio i suoni. Esso è la percussione di un corpo solido su un altro corpo solido e il medium è dato dall’aria (ma anche dall’acqua). L’orecchio stesso contiene aria congenita in movimento e la voce è prodotta da tutti quegli animali in grado di respirare. L’olfatto, dal canto suo, ha per sensibile proprio l’odore. Più complicato è invece il gusto, che ha per oggetto il sapore: infatti sembra essere un qualcosa ai confini con il tatto, poiché per avvenire ha bisogno del contatto con l’oggetto; ma Aristotele dimostrerà – e lo vedremo poco più avanti – come tatto e gusto siano due sensi diversi. Di tutti e cinque, il tatto è, a suo avviso, il senso più problematico, poiché sembra che il suo sensibile proprio non sia uno solo: gli altri quattro sensi, infatti, hanno solo un sensibile proprio; eppure – se ci pensiamo – è vero che, ad esempio, la vista ha per oggetto esclusivamente il colore, tuttavia, di fatto, ne vede una quantità illimitata, così come l’udito ode un’infinità di suoni diversissimi (acuti, gravi, forti, deboli…). Il tatto però sembra riferirsi sì ad una molteplicità di oggetti tangibili, ma anche opposti tra loro: possiamo infatti sentire per contatto il freddo e il caldo, il secco e l’umido, il duro e il molle; indicare quale tra questi sia il sensibile proprio del tatto non è facile (è la temperatura? Il grado di durezza? O piuttosto quello di umidità?). Un altro problema sorge nel momento in cui si vuole definire quale sia il suo medium: pare che non esista; infatti, il tatto avviene per contatto diretto e immediato (senza medium appunto) tra l’oggetto e il soggetto. E Aristotele, in merito, propone alcune risposte acute: supponendo di avere la mano coperta da un guanto, posso ugualmente toccare e avere percezioni; ciò significa che, anche col tatto, deve esserci un medium che svolga le funzioni del guanto. Aristotele individua tale medium nella carne, cosicchè l’organo del tatto (l’analogo degli occhi, delle orecchie, del naso, della lingua) è interno, giacchè non può identificarsi con il medium (ossia con la carne). Eppure pare che Aristotele finisca in un vicolo cieco: infatti, anche la lingua – che è un organo a tutti gli effetti – è fatta di carne e, per di più, percepisce sia i sapori (dolce, amaro, ecc) sia le cose tattili (freddo, caldo, umido, secco, ecc); tuttavia, i sapori vengono direttamente percepiti dalla carne che costituisce la lingua, mentre quando sente il caldo, il freddo, ecc, la carne funge solo da medium. Questo permette ad Aristotele di spiegare la differenza tra il gusto e il tatto (nel primo la carne della lingua è organo, nel secondo è medium). Nel tatto, poi, succede una cosa particolarissima: percepiamo il medium insieme all’oggetto, così come il giavellotto colpisce lo scudo e questo, a sua volta, colpisce immediatamente chi lo sorregge. I sensibili propri del tatto – dice Aristotele – sono le quattro qualità, e la percezione si verifica (ossia passa in atto) in relazione alle qualità che abbiamo in noi: così, ad esempio, per percepire qualcosa di caldo dobbiamo noi stessi essere meno caldi dell’oggetto percepito, altrimenti se fossimo ugualmente caldi non riusciremmo a percepirlo. Questo processo, però, non deve spingersi oltre un certo limite: il caldo o il freddo non devono essere eccessivamente intensi, altrimenti l’organo sensoriale ne verrebbe danneggiato; lo stesso vale per i sensibili propri di ciascun senso. In chiusura del secondo libro, Aristotele dà una celebre definizione della sensazione: " da un punto di vista generale, riguardo ad ogni sensazione, si deve ritenere che il senso è ciò che è atto ad assumere le forme sensibili senza la materia, come la cera riceve l’impronta dell’anello senza il ferro o l’oro: riceve bensì l’impronta dell’oro o del bronzo, ma non in quanto è oro o bronzo. Analogamente il senso, rispetto a ciascun sensibile, subisce l’azione di ciò che ha colore o sapore o suono, ma non in quanto si tratti di ciascuno di questi oggetti, bensì in quanto l’oggetto possiede una determinata qualità e secondo la forma " [424 a 15]. Il senso, dell’oggetto da cui riceve la sensazione, riceve la forma, non la materia (altrimenti ogni percezione sarebbe un inghiottire l’oggetto dentro di sé); e il paragone di Aristotele è calzante: riprendendo l’antica metafora – tematizzata da Platone nel Teeteto – con cui l’anima veniva accostata ad una tavoletta di cera e le impressioni alle forme che si imprimono sulla cera stessa, lo Stagirita dice che come la cera riceve l’impronta ( >shmeion ) dell’anello, ma non il materiale di cui è costituito, così i sensi ricevono la forma degli oggetti; anche se, altrove, Aristotele dice enigmaticamente che quando vediamo il giallo forse è la stessa pupilla a colorarsi di giallo. Fatte queste considerazioni, si può sostenere che " l’organo e la capacità di percepire sono la stessa cosa ", anche se " la loro essenza è diversa " (poiché l’organo è una grandezza, ossia ha dimensioni, mentre la capacità percettiva è una facoltà). Ciò aiuta anche a capire perché le piante non abbiano sensazioni: certo, in fondo anch’esse subiscono azioni per contatto (con l’aria, con gli oggetti, ecc), ma non percepiscono, poiché la loro passività non riguarda la forma, ma la materia; subiscono cioè l’azione della materia dell’oggetto, ma non sono in grado (e qui sta la differenza rispetto agli animali e all’uomo) di riceverne la forma. Le piante – nota Aristotele – non hanno una medietà ( >mesothta), nella quale avere percezioni: l’uomo e gli animali, invece, ne sono dotati e tale medietà consente in quel particolare stadio che sta nell’eccesso in più (che distrugge gli organi sensoriali) e nell’eccesso in meno. Le piante, poi, non hanno nemmeno un principio capace di ricevere le forme sensibili. Il terzo libro è incentrato sulla funzione intellettiva dell’anima, prerogativa dei soli uomini. Prima di entrare in medias res , tuttavia, Aristotele si occupa della fantasia e, ancor prima, di due importantissimi problemi: i sensi deputati alla percezione sono solo cinque o ne esistono altri? Come si spiega, poi, che io, soggetto percipiente, possa avere la percezione di percepire, ad esempio percepire che sto vedendo? Occorre ipotizzare l’esistenza di un altro senso che percepisca che sto vedendo? O, piuttosto, è il senso stesso che si auto-percepisce? Aristotele è molto preciso nel fornire le risposte a questi interrogativi: non esistono altri sensi all’infuori dei cinque; e se ci manca un senso, allora, necessariamente, mancherà anche l’organo percipiente corrispondente. Se poi esistesse un ipotetico sesto senso, allora dovrebbe anche esistere un suo organo suo specifico, mediante il quale esercitare la sua attività. In un certo senso, si potrebbe far leva sui sensibili comuni per ammettere un ulteriore senso: chi mi vieta di pensare che il movimento, la quiete, ecc, siano percepiti da un sesto senso? Ma Aristotele nega ciò: con tutti e cinque i sensi – e non con un sesto senso – percepiamo il movimento, la grandezza, la figura, e la quiete (intesa come assenza di movimento) e il numero come negazione del continuo (grandezze continue sono quelle geometriche, poiché hanno oggetti infinitamente divisibili, come le rette; grandezze discontinue sono i numeri, poiché tra 1 e 2 non c’è nulla, secondo Aristotele; e ½ è solo un rapporto, non un numero). E’ assolutamente impossibile che esista un sensibile speciale per i sensibili comuni: se ci fosse, percepiremmo i sensibili comuni in modo analogo a quello in cui percepiamo il dolce con la vista. Infatti, posso dire di percepire il dolce con la vista, quando ad esempio vedo una torta esposta in vetrina: ciò accade perché ho già percepito con il gusto, in altre occasioni, che fosse dolce. " Questo ci è possibile perché ci troviamo ad avere la percezione di entrambi questi sensibili, mediante la quale li riconosciamo nello stesso tempo in cui si presentano insieme. Se non fosse così, non percepiremmo i sensibili comuni in nessun’altra maniera che accidentalmente ". La percezione dei sensibili comuni, pertanto, è comune attraverso più sensi e non avviene accidentalmente, e non richiede un senso speciale: è l’interazione dei vari sensi che mi permette di percepire i sensibili comuni. Così della bile percepiamo che è gialla e amara: con gli occhi percepiamo che è gialla, con il gusto che è amara; ma ciò non toglie che l’oggetto (la bile) sia uno solo. Non esiste, dunque, un ulteriore senso capace di percepire insieme che la bile è gialla e amara. Ed è per questo motivo che nasce l’errore: vedo che una cosa è gialla e dico "è bile" senza averla gustata: l’errore nasce quindi nell’istituire connessioni, poiché esse non sempre sono corrette. Nel primo paragrafo del III libro, Aristotele ha dunque affrontato (e confutato) l’eventualità di un sesto senso: resta però il problema della coordinazione dei sensi e, a ciò collegato, il problema della percezione della percezione (cui è dedicato il secondo paragrafo). Occorre ammettere l’esistenza di un ulteriore senso che percepisca di percepire o, piuttosto, è il senso stesso a percepire e a percepire di percepire? In altri termini, quando vedo un oggetto percepisco anche che lo sto vedendo: che siano gli occhi a percepire l’oggetto, è evidente; ma che cos’è che percepisce il fatto che sto percependo con gli occhi? Anche qui Aristotele nega radicalmente l’eventualità di un sesto senso e fa riferimento ad una specie di "senso comune" ravvisato nel cuore (e non nel cervello) per poter spiegare la percezione della percezione. Nasce subito una difficoltà: se vedere significa – come Aristotele ha mostrato nel II libro – percepire colori, come si può ammettere che la vista percepisca – oltre ai colori – la sua azione di vedente? Esisterà un senso in grado di percepire sia la vista sia i colori? Ma allora, in questo caso, avremmo due sensi con lo stesso oggetto: sia la vista sia questo ipotetico altro senso vedrebbero, infatti, i colori e, in più, quest’ultimo percepirebbe anche la percezione di vedere. Se così fosse, tuttavia, avremmo una clamorosa smentita del principio che sta alla base della fisica aristotelica, cioè che la natura non fa nulla invano: sarebbe infatti una cosa assolutamente inutile produrre due sensi aventi per oggetto la medesima cosa. Sembra forse più percorribile la strada dell’ammissione che un senso possa avere per oggetto se stesso, la percezione della propria attività. Del resto, un altro forte argomento contro l’esistenza di un ulteriore senso è dato dalla regressione all’infinito: se ammetto che oltre alla vista esista un altro senso che percepisca la vista stessa, mi troverò costretto ad ammettere ancora un altro senso che percepisca di percepire la vista; e così all’infinito. Questa argomentazione (impiegata da Aristotele anche per argomentare in favore del "motore immobile") sconfessa definitivamente la possibilità di ulteriori sensi rispetto ai cinque: sorge però una nuova aporia. Se la vista, infatti, è dotata della capacità di auto-percezione, e il suo oggetto proprio è il colore, allora questa capacità di auto-percezione dovrà necessariamente essere dotata anch’essa di colore. " Se infatti percepire con la vista è vedere, e si vede il colore o l’oggetto che lo possiede, qualora si veda ciò che vede, ciò che vede per primo sarà colorato " [425 b 14]. Per superare questa difficoltà, Aristotele introduce due argomentazioni: la prima fa leva sul fatto che " percepire con la vista non ha un unico significato, giacchè anche quando non stiamo vedendo con la vista distinguiamo il buio e la luce, ma non allo stesso modo ". Anche al buio, infatti, ci rendiamo perfettamente conto che stiamo vedendo, distinguiamo cioè il buio dalla luce, abbiamo coscienza della vista anche quando non c’è la luce, anche se in quel dato momento non vediamo in atto. Aristotele usa il verbo >krinomen , "distinguiamo", ma anche "giudichiamo" il buio e la luce, poiché conoscere significa cogliere le differenze. La seconda argomentazione viene così formulata: " inoltre anche ciò che vede è in certo modo colorato, poiché ciascun organo sensorio è capace di assumere il sensibile senza la materia. ". Aristotele, però, non spiega in che modo " ciò che vede è colorato ": altrove, pare sostenere che, quando ad esempio l’occhio vede un oggetto giallo, sia la pupilla stessa a divenire gialla, ossia ad assumere la colorazione dell’oggetto percepito. Tuttavia ciò pare in contrasto con quanto detto prima, che cioè l’organo riceve solo la forma dell’oggetto: forse, tuttavia, Aristotele intende il colore dell’oggetto solo come forma. A questo punto, Aristotele fa notare come le forme sensibili delle cose percepite persistano in noi, anche quando la materia non c’è più: dopo aver osservato una casa gialla, io conservo dentro di me l’ "immagine" ( >fantasma) – cioè la forma sensibile – della casa stessa, cosicchè posso pensarla anche quando non ho più la casa di fronte a me; " ed è per questo motivo che, anche quando i sensibili non sono presenti, le sensazioni e le immagini permangono nei sensori ". L’oggetto visto e la vista passano in atto simultaneamente, pur non essendo essi la stessa cosa: in potenza restano distinti (il suono è infatti altra cosa dall’udito), ma, passando in atto, fanno un tutt’uno; ciò spiega l’unitarietà dell’atto percettivo, il quale deve tuttavia essere inteso come composto da due ingredienti: l’organo e l’oggetto esterno. Resta da chiarire dove abbia luogo quest’attualizzazione: Aristotele dice che essa avviene in colui che percepisce, non nell’oggetto; ciò pare piuttosto credibile, poiché in effetti all’oggetto visibile non accade nulla nell’essere visto, resta tale e quale; ad essere veramente interessato è solamente il soggetto percipiente, che ingloba la forma dell’oggetto percepito. In modo del tutto analogo, il movimento si produce non in ciò che lo causa, ma in ciò che lo subisce, e nella percezione " il suono in atto e l’udito in atto devono trovarsi in ciò che li possiede in potenza ". C’è dunque simmetria tra ciò che muove e ciò che è mosso, per cui ciò che muove non deve necessariamente avere movimento (così il "motore immobile" mette in moto l’universo senza essere esso stesso in moto). Poiché il passare in atto del sensibile e il passare in atto della facoltà di percepire sono il medesimo atto, " è necessario che simultaneamente si conservino e cessino ": con ciò, Aristotele attacca i "fisiologi", ovvero i primi indagatori della natura, rinfacciando loro di aver ingenuamente creduto che bianco e nero non esistessero senza la vista che li percepisce (la stoccata è diretta soprattutto contro Democrito); tali qualità, invece, esistono anche negli oggetti percepibili, anche se solo potenzialmente. Passano in atto quando vengono effettivamente percepiti dai soggetti dotati di anima sensitiva, ma posseggono già in potenza le loro qualità (bianco, nero, ecc); anche perché – se fosse come crede Democrito – saremmo noi gli agenti che producono il colore, mentre in realtà, per Aristotele, nel percepire siamo piuttosto passivi. Egli ha già accennato a come, per percepire la differenza tra due sensibili propri di sensi diversi, non occorra un ulteriore senso, ma basti la coordinazione tra i sensi interessati: così, per cogliere la differenza tra dolce e bianco, non si deve ricorrere ad un ulteriore senso in grado di percepire sia il dolce sia il bianco, ma occorre far riferimento al coordinamento tra la vista e il gusto. " Ciascun senso si riferisce ad un oggetto sensibile, trovandosi nell’organo sensorio in quanto tale, e discrimina le differenze del proprio oggetto sensibile: ad esempio, la vista distingue il bianco e il nero, il gusto il dolce e l’amaro, e la stessa cosa si verifica per gli altri sensi. Ma poiché noi distinguiamo sia il bianco sia il dolce e ciascuno dei sensibili in rapporto a ciascun altro, con che cosa percepiamo che essi differiscono " [426 b 9]. Ciascun senso, pertanto, percepisce i suoi sensibili propri, ma con che cosa percepiamo che il bianco è differente dal dolce? Per distinguerli (giacchè si tratta di sensibili) occorre una percezione: in particolare, Aristotele esclude che sia la carne ad essere responsabile (poiché sennò la distinzione tra bianco e dolce dovrebbe avvenire per contatto; ma noi possiamo vedere il bianco anche da lontano). " Ora non è possibile giudicare per mezzo di sensi separati che il dolce è diverso dal bianco, ma entrambi gli oggetti devono manifestarsi a qualcosa di unico. […] E’ dunque evidente che non è possibile giudicare sensibili separati mediante sensi separati ". Appare evidente come sia arduo stabilire chi percepisca la differenza tra sensibili; il gusto percepisce il dolce, la vista il bianco: e la differenza tra i due? Così come se io percepisco il dolce e tu il bianco, non possiamo dire se siano diversi, poichè ci vuole qualcosa che lo attesti, similmente, se il gusto percepisce il dolce, la vista il bianco, né la vista né il gusto può dire che il dolce sia differente dal bianco. Bisogna dunque ammettere un coordinamento tra i sensi stessi, in virtù del quale le informazioni provenienti da uno si connettano a quelle provenienti da un altro. Il discorso coinvolge anche la sfera temporale: nella proposizione "io dico ora che il bianco è diverso dal dolce", il termine "ora" qualifica il momento in cui io predico la diversità tra bianco e dolce; tale proposizione non è però uguale a "io dico che ora il bianco è diverso dal dolce", poiché il termine "ora" in questa proposizione svolge una diversa funzione, caratterizza che bianco e dolce sono diversi in un dato momento. Per Aristotele, le due cose coincidono: la simultaneità è sia nella diversità tra bianco e dolce, sia nel momento in cui la predico; ne consegue che non è accidentale. Dico simultaneamente che x è dolce e y è bianco e lo sono ora: " di conseguenza tale cosa è inseparabile ed opera in un tempo inseparabile ". Successivamente, Aristotele precisa che questa cosa unica discriminatrice delle differenze è un qualcosa di unitario ma che si distingue nelle sue funzioni discriminatrici. Sempre nel III libro del "De anima", Aristotele si sofferma con particolare attenzione sulla >fantasia , distinguendola nettamente dalle funzioni percettive (anche se ad esse strettamente connessa, in quanto i >fantasmata, ossia le "immagini", si formano in qualche modo in ambito sensibile). Si tratta di una delle prime riflessioni articolate della storia sull’immaginazione, di quel ponte che collega il sensibile al pensiero. Lo Stagirita inizia la sua indagine su tale facoltà con un parallelo tra il pensare ( >kinhsiVnoein, fronein) e il percepire: il punto di partenza è, ancora una volta, dato dalle opinioni comuni, secondo le quali il pensare e l’intelligenza sono come una percezione sensibile, sicchè pensare è come avere percezioni. Aristotele conduce quest’indagine in quanto mosso dalla convinzione che sia nel pensiero sia nella percezione l’anima distingua e conosca le cose: la percezione e l’intelligenza, infatti, >krinousi , ossia "giudicano" e "discriminano". Tale analogia tra pensare e percepire sembra trovar conferma anche nelle teorie formulate dai predecessori di Aristotele, in particolare Omero e, soprattutto, Empedocle: a loro avviso, pensare e percepire sono la stessa cosa, poiché il pensiero stesso è indisgiungibilmente legato al corpo, quasi come se fosse un’attività corporea alla pari del percepire. Ma ciò di cui essi han taciuto, senza dare spiegazione, è come avvenga l’errore: secondo la teoria empedoclea del simile che conosce il simile, sembra che l’errore sia impossibile; eppure l’esperienza comune attesta che esso si verifica assai spesso. Le paradossali conseguenze che derivavano dalla tesi di Empedocle erano sintetizzabili nell’ammissione dell’infallibilità dei sensi: questa tesi è attribuita da Platone (nel "Teeteto") al sofista Protagora, per il quale il miele è dolce per colui al quale appare tale, ed è amaro per colui a cui invece appare amaro. L’unica alternativa possibile stava nell’ammettere l’errore come contatto del simile col dissimile, ma ciò comportava una marea di nuovi problemi (in primo luogo la nozione stessa di "dissimile"). Da tutto ciò risulta chiaro che " intelligenza e sensazione non sono la stessa cosa ": questo punto viene da Aristotele inferito a partire dal fatto che gli animali hanno la sensazione (ed è ciò che li distingue dalle piante) ma non per questo l’intelligenza. Lo stesso discorso vale per il pensiero (nel cui ambito rientrano la scienza, l’opinione vera e la saggezza): a questo punto, Aristotele introduce un altro argomento a sostegno della propria tesi. Giacché la percezione dei "sensibili propri" è sempre vera, mentre il pensiero è suscettibile di essere vero o falso, ne consegue che pensiero e percezione non possono essere identificati; al contrario, il pensiero sarà presente esclusivamente in quegli animali dotati di ragione ( >logoV). Dalle argomentazioni aristoteliche emerge come il pensiero e la sensazione siano tra loro apparentati dalla comune funzione conoscitiva, ma, ciononostante, restano due cose radicalmente distinte. A cavallo tra le due realtà sta – secondo lo Stagirita – l’immaginazione ( >fantasia), cioè la sfera in cui appaiono immagini ( >fantasmata): fin dall’inizio, Aristotele precisa che l’immaginazione va distinta tanto dalla sensazione quanto dal pensiero, e in questo modo egli complica notevolmente la mappa psichica rispetto ai suoi predecessori. Il primo aspetto su cui concentra la sua attenzione il filosofo greco è come l’immaginazione, pur non identificandosi con la sensazione, sia ad essa connessa: " l’immaginazione è infatti diversa sia dalla sensazione sia dal pensiero, però non esiste senza sensazione, e senza di essa non c’è apprensione intellettiva ". Gli oggetti propri dell’immaginazione si costituiscono a partire da percezioni sensibili: è infatti solo dopo aver empiricamente percepito Socrate che posso crearmi, dentro di me, una sua immagine. E del resto ogni operazione mentale, ogni apprensione intellettiva (Aristotele usa il termine >upolhyiV , letteralmente "assumere come vero qualcosa da altro") può aver luogo solo a partire dall’immagine: se ne evince che non può esserci immagine senza percezione e che non può esserci pensiero senza immagine. Infatti, i concetti universali (l’uomo, il cavallo, la giustizia, ecc) non possono essere conosciuti se non a partire da immagini, poiché mi è impossibile crearmi il concetto universale di uomo o di cavallo se non ho raccolto dentro di me una nutrita serie di immagini di uomo o di cavallo. Ma tali immagini sono rese possibili grazie all’esperienza, giacchè si formano a partire dalla percezione sensibile dei singoli uomini o cavalli. Ben si capisce la funzione di ponte tra la sensazione e il pensiero rivestita dalla >fantasia: memore della lezione aristotelica sarà Kant stesso, quando – nella "Critica della ragion pura" – parlerà di "schematismo trascendentale" come zona di confine tra il sensibile e il pensiero. Il richiamare dentro di noi una determinata immagine è un atto libero, nota Aristotele; siamo cioè noi a scegliere liberamente di rievocare l’immagine che desideriamo (ad esempio, ho visto Socrate: ora non lo vedo più, ma posso decidere di ridestare la sua immagine dentro di me): " quest’affezione dipende infatti da noi, quando lo vogliamo " [427 b 18]. Avere un’opinione, invece, " non dipende da noi ": essa è – come abbiamo detto – una >upolhyiVe ha la proprietà di essere vera o falsa in base alla sua confrontabilità coi fatti, cosicchè è strettamente connessa con la realtà esterna; l’immagine, dal canto suo, non ha bisogno di confronti con la realtà esterna, è un qualcosa di a me interno e, pertanto, posso rievocarla quando voglio. Per dimostrare che l’opinione e la fantasia sono due cose diverse, Aristotele – oltre ad argomentare che la fantasia è libera, l’opinione no – mette in luce la strettissima connessione tra emozione ed opinione, facendo notare come la connessione tra emozione ed immaginazione sia assai meno stretta: se vedo coi miei occhi (ambito dell’opinione) una scena orribile nella realtà, essa suscita in me un’emozione di terrore che invece non necessariamente suscita se la vedo rappresentata in un dipinto o a teatro (ambito dell’immaginazione). Ne consegue, dunque, che l’opinione si accompagna sempre all’emozione corrispondente; l’immaginazione no: " quando siamo dell’opinione che una cosa è paurosa o temibile, proviamo immediatamente l’emozione corrispondente, e così pure quando riteniamo che una cosa è rassicurante, mentre nel caso dell’immaginazione ci troviamo in una situazione analoga a quella di vedere cose temibili o rassicuranti in un dipinto " [427 b 21]. Aristotele distingue l’immaginazione anche da altre operazioni, quali la sensazione, la scienza e l’intelletto. In particolare, per mettere in evidenza come essa si distingua dalla sensazione, si avvale di ben cinque argomentazioni: 1] " la sensazione o è potenza o atto, come la vista e la visione, mentre qualcosa può apparire benchè né l’una né l’altra sia in questione, come avviene per le immagini dei sogni " [428 a 6]. Mi può apparire qualcosa anche se in quel momento non esercito la vista né ho la possibilità di vedere, proprio come avviene nei sogni: mi appaiono immagini né in potenza né in atto. 2] " La sensazione è sempre presente, mentre l’immaginazione no ": perché ci sia la percezione, l’oggetto deve essere presente ai sensi (vedo la casa perché è presente agli occhi; sento i rumori perché sono presenti alle orecchie); però posso avere immagini anche di oggetti lontanissimi dai nostri sensi (posso avere l’immagine di Sparta pur essendo io ad Atene). Del resto, " se fossero la stessa cosa in atto, l’immaginazione dovrebbe trovarsi in tutti i bruti ed invece sembra di no ": con queste parole, Aristotele intende dire che, se sensazione e immaginazione coincidessero, allora laddove c’è la sensazione dovrebbe necessariamente anche esserci l’immaginazione. Eppure esistono esseri dotati dell’una, ma non dell’altra: Aristotele adduce l’esempio del verme, fornito di sensazione ma non di immaginazione; come esempio di esseri dotati di entrambe le cose, cita invece l’ape e la formica, ma potrebbe anche citare il cane, che riconosce il padrone poiché porta dentro di sé la sua immagine. 3] Le percezioni sono sempre vere, mentre la maggior parte delle immagini sono false (pensiamo soprattutto a quelle dei sogni). 4] Aristotele mette in luce come l’espressione "apparire" ( >fainesqai) sia fuorviante, perché ambigua. Quando vedo arrivare Socrate e affermo "mi appare un uomo", sto commettendo un errore linguistico, poiché dovrei in realtà affermare "vedo Socrate", giacchè ne ho percezione, non immagine. Tutt’al più è accettabile l’espressione "mi appare un uomo" quando lo vedo da distante ma non sono certo che effettivamente sia un uomo – il che testimonia, tra l’altro, come le immagini non per forza siano vere. " Non è quando esercitiamo con precisione la nostra attività su un oggetto percepibile che diciamo che quest’oggetto ci ‘appare’ essere un uomo, ma piuttosto quando non lo percepiamo chiaramente ". 5] " Appaiono immagini visive anche a chi tiene gli occhi chiusi ": se tengo gli occhi chiusi, non ho percezione visiva di nulla, ma posso tuttavia avere immagini. Dopo aver operato – nei cinque punti appena illustrati – la distinzione tra sensazione e immaginazione, Aristotele si propone di distinguere l’immaginazione dall’intelletto e dalla scienza, caratterizzati anch’essi – come le percezioni – dal non sbagliare mai; essi, tuttavia, sono superiori alle percezioni e sono " abiti che sono sempre nel vero "; nell’ "Etica Nicomachea", dirà che abiti sono le virtù, ossia quelle abitudini che si consolidano con l’essere compiute. Una volta che ho acquisito la scienza, sono sempre nel vero: se dimostrassi che essa sbaglia, non sarebbe più scienza. Rispetto alla scienza e all’intelletto, che sono sempre nel vero, l’immaginazione è – come abbiam visto – suscettibile di essere vera o falsa: ne consegue, naturalmente, che scienza e intelletto non sono identificabili con l’immaginazione. Detto questo, Aristotele torna nuovamente sull’opinione, il punto che più di ogni altro lo tormenta: ciò è in parte dovuto al fatto che Platone aveva fatto indebitamente rientrare l’opinione nell’immaginazione, senza rendersi conto dell’insuperabile differenza che le distanzia. Lo Stagirita sottolinea come l’opinione sia sempre accompagnata dalla convinzione ( >pistiV , il "credere che"), poiché quando dico "egli è buono" lo dico perché sono convinto che effettivamente egli sia buono. In molti animali, però, è presente l’immaginazione, ma non la convinzione e, di conseguenza, nemmeno l’opinione: è il caso delle api e delle formiche, ad esempio. Del resto, affinchè ci sia la convinzione, è necessario che ci sia anche la ragione, della quale sono dotati solamente gli uomini. Ciò avvalora la tesi aristotelica secondo cui l’opinione non è l’immaginazione: se infatti le due cose coincidessero, tutti gli esseri dotati di immaginazione dovrebbero anche avere l’opinione, ma ciò non è possibile. " Resta allora da vedere se è opinione, poiché l’opinione si presenta come vera o come falsa. Ora all’opinione consegue la convinzione (non è infatti possibile avere un’opinione su ciò di cui sembra che non si sia convinti), e mentre nessun bruto ha la convinzione, in molti c’è l’immaginazione ". L’opinione, nota Aristotele, è o parallela alla sensazione, o prodotta da una sensazione, o intreccio ( >sumplokh) di opinione e sensazione. Se così non fosse, l’immaginazione e l’opinione si troverebbero ad avere i medesimi oggetti, e l’immaginazione sarebbe l’intreccio dell’opinione del bianco e della sensazione del bianco. Come esempio, pensiamo al sole: esso mi appare piccolissimo, eppure so che è enorme; la percezione è diversa, dunque, dall’opinione, pur riguardando lo stesso oggetto (nel nostro caso: il sole). Ne consegue che l’immaginazione non è l’intreccio di opinione e sensazione, poiché esse attestano cose diverse: " ne segue allora o che si è abbandonata l’opinione vera che si aveva, benchè l’oggetto sia rimasto lo stesso e non ci si sia dimenticati di quell’opinione né si sia rimasti persuasi del contrario, oppure, se la si conserva ancora, necessariamente la stessa opinione sarà vera e falsa. Ma l’opinione potrebbe diventare falsa soltanto qualora l’oggetto mutasse a nostra insaputa. Pertanto l’immaginazione non è una di queste attività né risulta da esse " [428 b 5]. Infatti, l’opinione o è vera o è falsa: non è data una terza possibilità. Sgombrato il terreno dalla possibilità di confondere l’immaginazione con la sensazione o con l’opinione, Aristotele ritiene possibile definire meglio l’immaginazione stessa: essa è " una specie di movimento " , una >kinhsiV prodotta dalla percezione sensibile: " se allora nessun’altra cosa possiede le caratteristiche suddette eccetto l’immaginazione (ed essa è ciò che s’è detto), l’immaginazione sarà un movimento risultante dalla sensazione in atto " [429 a 1]. Percependo un oggetto, esso agisce su di noi e produce un movimento che si trasmette nel sangue e giunge fino al cuore. Il fatto che l’immaginazione sia un movimento spiega anche perché le immagini spesso siano sfocate: in particolare, le immagini oniriche sono da Aristotele accostate all’effetto delle pietre lanciate nello stagno. Ad attivare il movimento che dà luogo all’immaginazione è la percezione sensibile, la quale permette il formarsi di immagini che persistono anche quando la percezione non sussiste più (pur rimandando le immagini continuamente all’oggetto percepito): la centralità della percezione implica, naturalmente, che l’immaginazione sia prerogativa esclusivamente di quegli enti dotati di anima sensitiva (gli animali e l’uomo). La fantasia è anche un importante strumento per subire e compiere azioni: la stessa appetizione può essere guidata o dall’intelletto (che mi dà indicazioni su come orientarmi per raggiungere un determinato obiettivo) o dalla >fantasia stessa, sennò non si spiegherebbe perché anche gli animali abbiano appetizioni (il cane che si muove alla ricerca del cibo, ad esempio). In che senso, però, un’immagine può essere vera o falsa? Vedendo un oggetto, subito nella mente si forma un’immagine del medesimo, immagine che sarà vera fin tanto che sto vedendo l’oggetto; quando la sensazione cessa, l’immagine può sfocarsi e sbiadirsi, diventando in tal modo falsa (ossia non rispecchiante l’oggetto percepito). Nelle sensazioni per accidente – dove cioè la percezione stessa può essere falsa, poiché l’oggetto sensibile è troppo distante dai sensi – , nel caso in cui la percezione sia falsa, allora l’immagine stessa che si forma sarà inevitabilmente falsa. Aristotele si sofferma anche – seppur di sfuggita – sull’etimologia del termine fantasia , mettendo in mostra come si colleghi a >fainw ("appaio"), che a sua volta è strettamente connesso a >faoV ("luce"), privilegiando ancora una volta la sfera legata alla vista. A questo punto lo Stagirita, dopo aver trattato la facoltà nutritiva e quella sensitiva, passa alla facoltà intellettiva dell’anima, facoltà di cui solo l’uomo è provvisto: in linea preliminare, tale funzione è quella con cui l’anima conosce e pensa. Fatta questa prima precisazione, Aristotele analizza come si generi ( >ginetai) il pensiero e in tal senso la sua prima mossa consiste – come abbiamo già detto – nel considerare il pensiero come il percepire sensibile. Come la percezione ha luogo in quanto i vari sensi subiscono l’azione degli oggetti sensibili, così il pensiero ha luogo subendo l’azione degli oggetti intelligibili, ossia di quegli oggetti non coglibili dai sensi. Ma che cosa significa che l’intelletto, pensando, subisce un’azione? Come la vista in potenza passa in atto nel momento in cui c’è l’oggetto visibile, così il pensiero in potenza passa in atto quando c’è l’oggetto intelligibile; in altri termini, il pensiero – non essendo strettamente connesso al corpo (lo è solo attraverso mediazioni) – subisce azioni da parte degli intelligibili, che, per loro natura, non sono corporei. Sotto questo profilo, l’intelletto è >deiktikon tou eidoV , "ricettivo della forma", dove la "forma" in questione non è più quella sensibile, ma quella intelligibile (ossia, per fare un esempio, la nozione universale di uomo). Ciò implica che, per Aristotele, la conoscenza non sia produttiva, ma ricettiva: l’intelletto non produce concetti di suo (come sarà invece per l’idealismo), bensì si limita ad accogliere le forme provenienti dal mondo esterno, e non già presenti dentro di noi (come invece credeva Platone, soprattutto nel "Menone"). L’analogia che Aristotele fa tra pensiero e sensibile richiama alla memoria quella fatta da Platone, nella "Repubblica", tra Bene e idee: Platone diceva che, come nel nostro mondo la luce del sole ci permette di vedere le cose, così l’idea del Bene ci permette di "vedere" le altre idee; ora Aristotele afferma che il pensiero accoglie le forme così come i sensi ricevono le percezioni. Resta da chiarire in che senso l’immaginazione sia un ponte che congiunge il sensibile al pensiero: l’immagine è, secondo Aristotele, sempre meno vivida rispetto all’oggetto sensibile da essa rispecchiato; essa tende a sfocarsi, a perdere definizione ed è probabile che secondo Aristotele sia così che nascono i concetti universali: le immagini che porto dentro di me di diversi uomini (Socrate, Gorgia, Democrito, ecc) tendono a sfocarsi e a farsi sbiadite, con il risultato che si possono solo più cogliere i tratti comuni alle varie immagini. La funzione di cerniera tra sensibile e pensiero assolta dall’immaginazione potrebbe anche essere un’altra: quando mi trovo in una biblioteca, coi miei occhi vedo solo una determinata porzione della biblioteca stessa, eppure riesco ad avere una nozione di biblioteca come insieme unitario; ciò avviene grazie all’immaginazione. A questo punto, per meglio chiarire come possa originarsi il pensiero, Aristotele riprende la nota tesi di Anassagora, secondo la quale esisterebbe un Intelletto cosmico ( >NouV) dotato di un potere assoluto conferitogli dal non essere mescolato con le altre cose (altrimenti sarebbe impedito nel suo agire libero, >autokratwr). Aristotele interpreta la tesi anassagorea in termini conoscitivi: la condizione affinchè l’intelletto possa conoscere è di non essere mescolato al resto, ossia tutte le cose devono essere da esso distinte. Tra l’altro Aristotele opera una forte connessione tra conoscere e potere (" perché domini, ossia perché conosca ", 429 a 18), in virtù della quale chi conosce una cosa è in grado di padroneggiarla, mentre chi la ignora ne è padroneggiato. Sembra dunque chiaro che il >nouV, quella funzione con cui l’anima intellettiva pensa e conosce, non è alcuno degli enti intelligibili prima di pensarli: è solo pensandoli che fa tutt’uno con essi (diventa cioè conoscenza in atto dell’universale). Aristotele conclude che, se le cose stanno così, non è ragionevole ritenere che l’intelletto sia mescolato con il corpo, poiché altrimenti si troverebbe a subire le proprietà corporee (diverrebbe cioè caldo, freddo, ecc) e disporrebbe a sua volta di un organo percettivo per percepire le qualità. Sotto questo profilo, lo Stagirita si sente più vicino ai Platonici piuttosto che ai Presocratici, i quali avevano identificato l’intelletto con la percezione: i Platonici, dal canto loro, " sostengono che l’anima è il luogo delle forme, solo che tale non è l’intera anima, ma quella intellettiva, ed essa non è in atto, ma in potenza le forme " [429 a 27]. Per Aristotele è vero quanto han sostenuto i Platonici, ossia che le idee han sede nell’anima, ma è bene chiarire meglio in che senso, poiché non è corretto in tal caso parlare di "anima" in generale; l’affermazione platonica va ristretta solo all’anima intellettiva, in cui le idee risiedono potenzialmente (non sono cioè già tutte presenti, per cui si tratta di risvegliarle, come invece credeva Platone). Fatta questa precisazione, Aristotele affronta il problema dell’ >apaqhia della funzione sensitiva e intellettiva: tale >apaqhia (letteralmente "assenza di passioni") non va ugualmente intesa per le due funzioni, e per meglio chiarire questo punto, il filosofo adduce un esempio. Quando percepiamo coi sensi un qualcosa di eccessivamente forte, la nostra facoltà percettiva viene quasi a cessare: " il senso non è in grado di percepire dopo l’azione di un sensibile troppo intenso " [429 b]. Così, dopo aver udito un rumore troppo forte, le nostre orecchie non sentono più per un po’ di tempo; dopo aver visto una luce troppo intensa, i nostri occhi cessano di vedere per qualche minuto. Però per le operazioni intellettive avviene l’opposto: se conosco nozioni intensissime, ciò non mi impedisce di conoscerne altre meno intense; anzi, le conoscerò ancora meglio, perché la mia facoltà intellettiva si è acuita: " l’intelletto, quando ha pensato qualcosa di molto intelligibile, non è meno, ma anzi più capace di pensare gli intelligibili inferiori, giacchè la facoltà sensitiva non è indipendente dal corpo, mentre l’intelletto è separato " [429 b 3]. Il procedere opposto di intelletto e percezione testimonia, secondo Aristotele, che l’intelletto è una funzione separata dal corpo, la percezione no. A questo punto, il filosofo greco introduce il problema della possibilità dell’intelletto di conoscere se stesso: poiché esso conosce tutti gli intelligibili in atto, allora può pensare se stesso. Cosa significa? Probabilmente – non è sicuro – che è in grado di conoscere se stesso come conoscente le nozioni universali intelligibili. Su questo punto, comunque, Aristotele tornerà ancora all’interno della trattazione dell’anima. Egli ritiene opportuno specificare le caratteristiche di questi oggetti intelligibili, per meglio differenziarli da quelli sensibili: conduce un’analisi soprattutto in riferimento a due classi, quella degli oggetti fisici e quella degli oggetti matematici. Come esempio di oggetto fisico, prende la carne: essa è percepibile mediante i sensi, e, rispetto alla sua materialità, possiamo distinguere la sua essenza; si dovrà dire che l’essenza della carne è, a sua volta, un pezzo di carne? No, è evidente. E’, al contrario, una nozione universale che esula dalla materia, ed è la forma che fa sì che essa sia, effettivamente, carne e non qualcos’altro. Questa distinzione aristotelica avrà gran successo: ancora Heidegger, nel Novecento, dirà in apertura del suo scritto sulla tecnica che un conto è la tecnica, un conto è l’essenza della tecnica. Come esempio di oggetti matematici, possiamo considerare invece i numeri: anch’essi hanno – come la carne – una materia, ma si tratta di una "materia intelligibile". Prendendo come riferimento una linea, si può infatti notare come essa abbia una sua forma (la linearità), ma anche una sua materia (l’essere caratterizzata dal continuo, che le permette di essere infinitamente divisibile). Ritornando all’esempio della carne, è con la percezione sensibile che conosciamo i pezzi di carne, mentre con la conoscenza intellettuale ne conosciamo l’essenza, ossia veniamo a conoscere che cosa sia la carne in generale. " Poiché sono diverse la grandezza e l’essenza della grandezza, come l’acqua e l’essenza dell’acqua (e ciò vale per molti altri casi, benchè non per tutti, giacchè in alcuni essi s’identificano), il soggetto giudica l’essenza della carne e la carne o con qualcosa di diverso o con qualcosa che si trova in una diversa condizione. Infatti la carne non esiste senza la materia, ma, come il camuso, è una determinata forma in una determinata materia " [429 b 11]. Chi "distingue" ( >krinei) carne ed essenza di carne distingue tra materia ed essenza: con la facoltà percettiva giudica il caldo e il freddo, e tutte le qualità delle quali la carne è rapporto proporzionale, mentre con un’altra facoltà (cioè con l’intelletto) discrimina l’essenza della carne, priva della possibilità di essere calda, fredda, ecc. Passiamo all’esempio degli oggetti matematici: a riguardo, Aristotele parla di " enti ottenuti per astrazione " [429 b 19], dove la parola "astrazione" in greco è >afairesiV , che letteralmente significa "sottrazione". Come si origina questa astrazione/sottrazione? A partire dagli enti fisici: quando del tavolo materiale che mi sta dinanzi considero solo alcuni aspetti (ad esempio la superficie), prescindendo da altri. Sottraendo dal tavolo gli aspetti materiali, i colori, la temperatura, ecc, ottengo il concetto di rettangolo. Ciò comporta che il rettangolo, di per sé, non esiste (come invece credeva Platone); bensì esistono oggetti fisici rettangolari; lo stesso discorso vale per i numeri: non esiste il "tre" in sé, bensì esistono gruppi di tre tavoli, di tre sedie, ecc. In questo modo, sarà dunque possibile distinguere tra retta del tavolo sensibile ed essenza del rettangolo: la prima è conosciuta coi sensi, la seconda con l’intelletto. " Inoltre, nel caso degli enti ottenuti per astrazione, la retta è analoga al camuso (perché è unita al continuo), mentre la sua essenza, se l’essenza della retta è diversa dalla retta, è qualcosa di differente, e potrebbe essere la diade " [429 b 21]: in che senso potrebbe essere la diade, ossia due punti? Secondo Aristotele, posso distinguere una retta da una superficie in base ai punti: collegando due punti ottengo una retta; collegandone tre, ottengo invece una superficie. Il che fa supporre che secondo lo Stagirita l’aritmetica sia prioritaria rispetto alla geometria, poiché – secondo l’insegnamento pitagorico – all’uno corrisponde un punto, al due due punti (e quindi una retta), al tre tre punti (e quindi una superficie), al quattro quattro punti (e quindi un solido). Se ne trae la conclusione che la carne e la retta non esistono separati dalla materia cui ineriscono, in quanto separati da essa diventano intelligibili e, dunque, conoscibili solo dall’intelletto. Il paragrafo si chiude con due aporie, che Aristotele prova a superare: la prima deriva dall’ammissione che l’intelletto non subisca azioni, la seconda dall’ammissione della possibilità dell’intelletto di conoscere se stesso. " Qualora l’intelletto sia semplice e impassibile, e non abbia nulla in comune con alcunchè, come afferma Anassagora, in che modo penserà, se il pensare è una sorta di subire? " [429 b 24]: se l’intelletto non è mescolato alla realtà, allora come fa a pensare, se il pensare è subire l’azione degli oggetti intelligibili? Non vuol forse significare che tra intelletto e intelligibili non v’è nulla in comune? La seconda aporia viene così formulata dallo Stagirita: " l’intelletto è esso stesso intelligibile? ". La difficoltà a sua volta, si articola in due corni: o vengo a dire che l’intelletto è intelligibile di per se stesso, indipendentemente dagli oggetti con cui ha a che fare; in questo caso, ci sarà solo un tipo di intelligibile e allora – conseguenza assurda – ogni intelligibile sarà a sua volta intelletto. Oppure l’intelletto conosce se stesso come conosce le altre cose, ossia mediante un’affezione corporea: ma in questo caso, esso sarà mescolato con il corporeo, il che è in contraddizione con la tesi di partenza. La soluzione proposta da Aristotele a queste problematiche poggia ancora una volta sulla distinzione tra potenza e atto: l’intelletto è gli oggetti intelligibili, ma solo in potenza, mentre in atto è un intelligibile solo se pensa quel determinato intelligibile; per farsi meglio capire, Aristotele ricorre al paragone – desunto dal "Teeteto" platonico – con la tavoletta di cera: la tavoletta di cera è, potenzialmente, tutti gli oggetti che le saranno impressi; allo stesso modo, l’intelletto può potenzialmente ricevere tutti gli intelligibili, ma finchè essi non vengono effettivamente ricevuti, non li possiede (a differenza della concezione platonica, per cui son già tutti presenti e si tratta solo di risvegliarli). Ne consegue che l’elemento comune tra intelletto e intelligibili – elemento che consente un rapporto fra le due realtà – è la loro potenzialità: infatti, l’intelletto può conoscere gli intelligibili, e questi possono essere conosciuti dall’intelletto; ciò comporta che l’intelletto può solo subire un’azione, cioè il passare da in potenza a in atto, e ciò avviene grazie all’intervento degli intelligibili. Risolta in questo modo la prima aporia, Aristotele passa alla risoluzione della seconda: l’intelletto è esso stesso conoscibile intellettualmente allo stesso modo in cui sono conoscibili tutti gli oggetti intelligibili. Infatti, colui che pensa e l’oggetto pensato vengono inevitabilmente a coincidere in atto, facendo un tutt’uno. Sicchè si può affermare che la conoscenza dell’universale X coincide con l’universale X stesso (solo mentalmente possono essere distinte le due cose). Negli oggetti dotati di materia, invece, gli intelligibili (la nozione universale di tavolo, di sedia, di uomo, ecc) sono presenti solo potenzialmente, sono conoscibili solamente grazie ad un’operazione intellettuale che prescinda dalla materia astraendo. Di conseguenza, si evita l’assurdità poc’anzi proposta, quella cioè della coincidenza dell’intelletto con gli intelligibili, per cui ogni intelligibile sarebbe esso stesso l’intelletto, ossia quella facoltà che fa conoscere gli intelligibili senza far riferimento alla materia. Come abbiamo accennato, l’intelletto può conoscere se stesso come dotato di facoltà di conoscere gli intelligibili: ma i problemi non sono finiti. Infatti, dopo aver prospettato e risolto le due aporie, Aristotele tratta, nel paragrafo successivo, un problema intorno al quale prolifereranno innumerevoli scritti nel corso della storia (da Alessandro di Afrodisia a Simplicio, da Filopone ad Averroè a Pomponazzi). Infatti, sembra che Aristotele, distinto l’intelletto in atto da quello in potenza, introduca la nozione di intelletto >poihtikoV , "produttivo". Questa dottrina viene esposta in maniera criptica e sintetica, ma, ciononostante, si evince come esso non sia una prerogativa dei singoli individui, ma un qualcosa di unico per tutta la specie umana (per tutti gli uomini passati, presenti e futuri). C’è anche stato chi ha letto nell’intelletto attivo la divinità stessa. Entrambe le interpretazioni concordano sul fatto che Aristotele riconosca in quest’intelletto produttivo (e non in quello di cui son dotati i singoli) la prerogativa dell’immortalità: ciò si ricondurrebbe, in qualche modo, all’impianto generale della filosofia aristotelica, secondo la quale a poter partecipare dell’eternità sono non i singoli, ma le specie; l’intelletto passivo di cui ciascuno di noi è dotato sarebbe dunque destinato a perire; mentre quello produttivo, comune a tutta la specie, dovrebbe perdurare in eterno. Aristotele, nell’analizzare l’intelletto, fa notare come tutto ciò che appartiene alla natura abbia determinate caratteristiche, tra le quali rientra l’avere una materia propria; essa è, potenzialmente, un mare magnum di cose (il marmo, infatti, è potenzialmente tutte le cose che col marmo possono essere create). Ma, accanto a questa causa materiale, c’è quella che lo Stagirita chiama causa "produttiva" ( >poihtikon), o "efficiente", come la chiama nella "Fisica". Essa, rispetto alla materia, produce tutte le cose che sono in potenza nella materia, cosicchè la statua di marmo è causa produttiva che fa sì che dal marmo derivino tutti gli oggetti possibili che possono essere fatti col marmo. Sotto questo profilo, la natura e l’attività tecnica procedono in maniera analoga, cioè attraverso la materia e la generazione di effetti: ma questo stesso discorso vale anche per l’anima, dove sarà possibile trovare una causa produttiva. Applichiamo ciò all’intelletto: al concetto di materia corrisponde quello di potenza, sicchè la materia dell’intelletto – cioè l’analogo del marmo – sarà l’intelletto potenziale, analogo alla materia nel senso che è potenzialmente tutte le cose (cioè tutte le nozioni intelligibili). Il grosso problema che si deve affrontare è che, accanto alla materia, deve esserci una causa produttrice, un intelletto che ad essa corrisponda. Quale è? Aristotele è, in questo caso, più criptico del previsto e, per chiarire la differenza tra intelletto produttivo e intelletto potenziale, asserisce – memore della metafora impiegata da Platone nella Repubblica – che l’intelletto produttivo è una luce, poiché anche " la luce rende i colori che sono in potenza in atto " [430 a 17]. La luce è ciò che fa sì che i colori – potenzialmente visibili – siano effettivamente visti in atto; e cos’è che svolge mansioni analoghe alla luce nella sfera intelligibile? Per Platone era la verità; da Aristotele – giacchè non esistono idee come esseri universali a sé stanti – questa funzione della luce è attribuita all’intelletto produttivo, una sorta di luce che permette alle nozioni intelligibili di essere conosciute in atto. Ma qui cominciano a nascere le prime difficoltà; prima fra tutte: che cos’è questo intelletto produttivo? Chi ce l’ha? E’ – risponde lo Stagirita – un intelletto separabile, o, meglio, separato ( >cwristoV) dal corpo, è impassibile (cioè non subisce azioni), non è mescolato, essendo "atto per essenza". Il suo modo di essere specifico è di essere in atto, ossia non in potenza: eppure finoIL IV LIBRO DEL DE RERUM NATURA
Un riferimento alla grande opera di Lucrezio “Sulla natura delle cose” (“De rerum natura”) proviene da un illustre pensatore a lui contemporaneo: Cicerone. Questi, in una delle sue lettere private “Ad familiares”, riferisce di essersi personalmente curato della pubblicazione del testo lucreziano, ma poi, di fatto, in nessuno dei suoi numerosi scritti a carattere filosofico fa il nome di Lucrezio, pur menzionando costantemente Epicuro e la nutrita schiera di Epicurei. Lo stesso poema lucreziano è avvolto da un’aura di mistero, che i molti studi svolti su di esso non sono stati in grado di diradare completamente: ad una prima lettura dell’opera, si ha l’impressione che non si tratti di un’opera conclusa e rivista, e questo soprattutto perché abbondano i passi ripetuti o dal significato oltremodo oscuro. Cercheremo ora di soffermare la nostra attenzione sul IV dei sei libri in cui è strutturato il “De rerum natura”: se al centro del III era la discussione sulla natura dell’anima (intesa, secondo i dettami della filosofia epicurea, come un aggregato di atomi), il IV libro è dedicato alle sensazioni. Il proemio stesso è curiosamente diverso rispetto a tutti gli altri: non troviamo, infatti, un elogio della figura del maestro Epicuro e della sua dottrina salvifica, bensì una giustificazione che Lucrezio stesso dà della propria opera, anche sul piano della scelta stilistica. Egli può vantarsi di essere stato il primo ad intraprendere un’opera di tal genere:
Percorro remote regioni delle Pieridi, ove nessuno prima
impresse orma.
Godo ad appressarmi alle fonti intatte
e bere, e godo a cogliere nuovi
fiori
e comporre per il mio capo una corona gloriosa,
di cui prima a
nessuno le Muse abbiano velato le tempie;
anzitutto perché grandi cose io
insegno, e cerco
di sciogliere l’animo dagli stretti nodi della
superstizione;
poi perché su oscura materia compongo versi tanto
luminosi,
tutto cospargendo col fascino delle Muse.
Infatti anche questo
appare non privo di ragione.
Il merito che egli attribuisce a se stesso, come portavoce del messaggio epicureo, è di aver liberato l’uomo dal pesante fardello della superstitio , per Lucrezio sinonimo di religio (merita di essere ricordato come invece in Cicerone i due termini fossero rigorosamente distinti, tant’è che l’Arpinate poteva fieramente affermare: superstitio, non religio, tollenda est ), e, così facendo, di avergli donato la felicità, concepita come assenza di turbamenti: quella di Lucrezio, com’egli stesso tiene a sottolineare, non è una banale traduzione in latino della precettistica epicurea, ma, piuttosto, un’interpretazione ragionata, e Lucrezio asserisce di aver scelto di scrivere in versi in funzione pedagogica, per la stessa ragione per cui Platone si serviva di un linguaggio immaginifero e ricco di miti. La poesia, come è noto, fa presa sull’animo umano, e oltre a trasmettere i severi insegnamenti epicurei, può anche allietare il cuore di chi la legge:
Come i medici, quando cercano di dare ai fanciulli
il ripugnante assenzio,
prima gli orli, tutt’attorno al bicchiere,
cospargono col dolce e biondo
liquore del miele,
perché nell’imprevidenza della loro età i fanciulli siano
ingannati,
non oltre le labbra, e intanto bevano interamente
l’amara
bevanda dell’assenzio e dall’inganno non ricevano danno,
ma al
contrario in tal modo risanati riacquistino vigore;
così io ora, poiché
questa dottrina per lo più pare
troppo ostica a coloro che non l’hanno
coltivata,
e il volgo rifugge lontano da essa, ho voluto esporti
la nostra
dottrina col canto delle Pieridi che suona soave,
e quasi cospargerla col
dolce miele delle Muse,
per provare se per caso potessi in tal modo
tenere
avvinto il tuo animo ai miei versi, finché comprendi tutta
la
natura e senti a fondo il vantaggio.
L’impatto con la dottrina di Epicuro può essere aspro, poiché stravolge le convinzioni in cui la maggior parte degli uomini vive: tuttavia, mettendo in versi tali verità e quindi rendendole meno sgradite, alla pari dello stratagemma con cui i medici cospargono di miele le medicine per renderle meno detestabili, viene fornita la cura ai mali dell’uomo (di un’immagine analoga si avvarrà il Tasso nella sua “Gerusalemme liberata”). La medicina è amara ma reca salute: ne sono destinatari i bambini, ovvero tutti coloro che non hanno ancora sviluppato facoltà razionali e vivono seguendo le convinzioni comuni. Immediatamente dopo questi versi, Lucrezio introduce la dottrina dei simulacra , termine col quale traduce la parola che in Epicuro (e in Democrito) designava le rappresentazioni di costituzione atomica delle cose: gli eidwla .
Esistono quelli che chiamiamo simulacri delle cose;
i quali, come membrane
strappate dalla superficie delle cose,
volteggiano qua e là per l’aria; e
sono essi stessi
che atterriscono gli animi, presentandosi a noi,
sia
mentre vegliamo, sia nel sonno, quando spesso osserviamo
figure strane e
spettri di gente che ha perduto la luce della vita,
i quali spesso, mentre
languivamo addormentati, paurosamente
ci svegliarono: perché non crediamo,
per caso, che le anime
fuggano dall’Acheronte o che le ombre volteggino tra i
viventi
o che qualcosa di noi possa durare dopo la morte,
quando il corpo
e la natura dell’animo insieme disfatti
si sono disgregati nei loro diversi
principi primi.
Nella prospettiva epicurea, di cui Lucrezio è vessillifero, i simulacra sono immagini atomiche che provengono da tutto ciò che circonda e colpiscono i nostri organi di senso; se, tuttavia, non ci fosse l’anima e, con essa, la sua capacità di riflettere su di essi, non si potrebbero avere sensazioni. I simulacra vengono anche da Lucrezio accostati a membrane o alla corteccia, poiché, in effetti, le membrane e la corteccia ne sono il corrispettivo visivo: tali “membrane” si distaccano dalla superficie esterna dei corpi (il termine “corteccia” rende bene l’idea) per via di un “pulsare” dei corpi stessi e, volteggiando nell’aria, giungono ai nostri organi di senso, riportando fedelmente la forma dell’oggetto quale esso è (i simulacra possono tuttavia anche riportare l’interno dei corpi da cui provengono, anche la disposizione mentale degli individui da cui giungono). Questa emissione di pellicole degli oggetti si configura come un flusso continuo e ciò vale per tutti gli oggetti del mondo:
Dico dunque che immagini delle cose e tenui figure
sono emesse dalle cose
e si staccano dalla loro superficie.
Ciò si può conoscere di qui, anche con
mente ottusa.
Ma, poiché ho insegnato quali siano i principi
di tutte le
cose e quanto differenti per varietà di forme
spontaneamente volteggino,
stimolati da moto eterno,
e in che modo da questi si possa produrre ogni
cosa,
ora comincerò a dirti ciò che con queste cose è
connesso
strettamente: esistono quelli che chiamiamo simulacri delle
cose,
cui si può dare quasi il nome di membrane o di corteccia,
poiché
l’immagine presenta aspetto e forma simile all’oggetto,
qualunque sia, dal
cui corpo essa appare emanata per vagare.
Anzitutto, poiché molte tra le cose
visibili emettono
corpi, in parte liberamente diffusi,
come la legna
emette fumo e il fuoco calore,
e in parte più strettamente contesti e densi,
come si vede
talora, quando le cicale in estate depongono le fini
tuniche,
e quando i vitelli nascendo lasciano cadere membrane
dalla
superficie del corpo, e similmente quando la lubrica
serpe lascia tra i pruni
la veste: infatti spesso vediamo
i pruneti coperti di svolazzanti spoglie di
serpi –
poiché tali cose accadono, una tenue immagine deve pure
dalle cose
essere emessa, staccarsi dalla superficie delle cose.
Per Democrito, gli eidwla volteggiavano per l’aria, ma, ad avviso di Epicuro, è più corretto parlare di vuoto, poiché talvolta l’aria può distorcere gli eidwla stessi e mutarne l’essenza: Lucrezio, dal canto suo, parla espressamente di “velocità” dei simulacra . Anche quando dormiamo abbiamo percezioni: i fenomeni onirici sono, infatti, secondo Lucrezio un fatto percettivo, anche se le percezioni cui siamo soggetti nei sogni non sono vere, altrimenti non si spiegherebbe perché ci capita spesso di rivedere in sogno persone decedute o cose irreali. Questo sarà dunque dovuto ad una percezione “falsa” o, meglio, alla casuale formazione di immagini che non rispecchiano la realtà. Lucrezio si trova di fronte al difficile problema di dimostrare al suo pubblico l’esistenza di questi simulacra che volteggiano per l’aria e che rendono possibile la percezione ma che non sono direttamente visibili: per convincerci definitivamente della veridicità del suo discorso, egli cerca, sulle orme del maestro Epicuro, di ravvisare un equivalente esperibile dei simulacra , un equivalente che attesti la possibilità che queste sottilissime “pellicole” si stacchino dagli oggetti giungendo fino a noi. Così come, nell’ambito visibile, i serpenti e le cicale, nel periodo della muta, perdono la pelle o come il fumo si distacca dal fuoco, così anche, per inferenza dal visibile all’invisibile, si può pensare che accada qualcosa di simile a livello atomico, immaginando che ogni corpo ceda incessantemente flussi di sottili atomi dalla sua superficie. Dopo aver rapidamente descritto l’analogo visibile dei simulacra , Lucrezio torna, dai versi 63 in poi, a soffermarsi su ciò che gli sta a cuore, il mondo atomico:
Poiché tali cose accadono, una tenue immagine deve pure
dalle cose essere
emessa, staccarsi dalla superficie delle cose.
Infatti, perché cadano e si
scostino dalle cose quegli oggetti
piuttosto che altri più sottili, non è
possibile dire;
tanto più che le cose hanno in superficie molti
corpi
minuti, tali che possono volarne via nello stesso ordine
in cui
erano, conservando la forma esteriore,
tanto più velocemente, quanto meno
possono essere impediti,
pochi come sono, e collocati in prima linea.
Anche dai corpi, dunque, una qualche “tenue immagine” ( tenuis imago ) deve staccarsi: e, proprio perché “tenue”, e quindi leggera, non c’è da stupirsi che essa sia in grado di volteggiare per l’aria. Lucrezio afferma, con assoluta certezza, che il fatto stesso che i simulacra siano sottili fa sì che essi siano anche veloci, dinamici e penetranti: tuttavia, sul perché le cose procedano in questo modo, Lucrezio è chiarissimo (versi 65 e seguenti):
…perché cadano e si scostino dalle cose quegli oggetti
piuttosto che altri
più sottili, non è possibile dire;
E’ impossibile, egli nota, spiegare il perché (“cur”) delle cose, dal momento che si tratta di un procedimento retto dal caso e quindi esulante da ogni finalità: con quest’affermazione, già presente in Epicuro e in Democrito, viene definitivamente espunta quella causa finale che stava alla base della filosofia di Platone e di Aristotele; ancora Dante, in età medioevale, si stupirà dell’annullamento della causa finale da parte degli atomisti ed etichetterà sarcasticamente Democrito come colui “che ‘l mondo a caso pone” (Inferno, IV). Come accennavamo, la piccolezza dei simulacra ne spiega anche l’incredibile rapidità di movimento: infatti, come già notava Epicuro, solo se essi sono di velocità pari a quella del pensiero si può ammettere che riportino fedelmente le cose da cui si sono distaccati, rendendo in tal maniera certa la sensazione. Tuttavia, è necessario riconoscere che la materia che si stacca continuamente dai corpi sotto forma di simulacra non sia superiore a quella acquisita, altrimenti il corpo non sussisterebbe: questo vale, appunto, fino a che il corpo non si disgrega, e anche questo avviene casualmente, senza progettualità alcuna: ecco perché Cicerone osservava scandalizzato come non ci fosse nulla di eterno nella fisica epicurea. I versi 110/122 sono dedicati alla speciale costituzione dei simulacra:
E ora apprendi di che tenue natura consti l’immagine.
E in primo luogo,
considera quanto i primi principi
sono al di sotto dei nostri sensi e quanto
più piccoli delle cose
che gli occhi primamente cominciano a non potere più
scorgere.
Ora, tuttavia, affinché io ti confermi anche questo, apprendi
in
poche parole quanto siano sottili i principi di tutte le cose.
Anzitutto, già
ci sono alcuni animali talmente piccoli
che una terza parte di loro non si
può in alcun modo vedere.
Un viscere qualunque di questi, come si deve
credere che sia?
E il globo del cuore o dell’occhio? E le membra? E gli
arti?
Quanto son piccini? Che dire poi di ciascuno dei primi princìpi
di
cui deve constare la loro anima e la natura dell’animo?
Non vedi forse quanto
siano sottili e quanto minuti?
Gli atomi non si vedono non già perché sono incorporei, bensì perché talmente piccoli da non riuscire ad essere colti dai nostri occhi; si tratta dunque di trovare, ancora una volta, un analogo nel mondo visibile, attraverso il quale esemplificare ciò che accade anche a livello atomico. E a tal proposito Lucrezio adduce come esempio l’esistenza di animali piccolissimi, ma pur tuttavia visibili, dei quali non riusciamo però a cogliere la composizione interna. Pur non riuscendo a visualizzare le loro viscere, ciononostante sappiamo che esse esistono: così dobbiamo, similmente, pensare che ogni corpo che ci circonda e che vediamo sia costituito, nella sua struttura, da una miriade di atomi ( corpora per Lucrezio, swmata per Epicuro) a noi invisibili. Tali atomi, come aveva detto Epicuro nella “Lettera ad Erodoto”, sono “il minimo dei minimi”, la parte più piccola ch’io possa immaginare dividendo un corpo fino alle sue parti minime: il termine “atomo”, del resto, è di origine greca e, letteralmente, significa “ciò che non può essere (ulteriormente) tagliato” (da a + temnw ). Il mondo che ci circonda è continuamente percorso dai simulacra che volano e già nel libro II, per esemplificare, Lucrezio, per farci meglio capire che cosa intendesse, ci aveva invitati ad immaginare la penombra di una casa dalla cui finestra penetra un fascio di luce in cui scorgiamo una miriade di particelle di polvere. Ora, nei versi 143/160 del libro IV, Lucrezio mette in evidenza come l’aria che ci circonda sia una sorta di officina per il formarsi di immagini: svolazzando per l’aria, infatti, succede casualmente che i simulacra provenienti da oggetti diversi si incontrino e diano luogo alla formazione delle immagini più bizzarre:
Ora, in che facile e celere modo si generino quei simulacri,
e di continuo
fluiscano dalle cose e staccatisi s’allontanino,
[io esporrò…]
…
sempre infatti ciò che è all’estrema superficie trabocca
dalle cose,
sì che esse possono emetterlo. E quando ciò raggiunge
altre cose, le
attraversa, come fa soprattutto con la stoffa.
Ma, quando ha raggiunto aspre
rocce o legname, lì sùbito
si lacera, sì che non può rimandare alcun
simulacro.
Ma, quando fanno ostacolo oggetti risplendenti e densi,
qual è
soprattutto lo specchio, niente di simile accade.
Infatti non può
attraversarli, come la stoffa, né d’altra parte
può lacerarsi: a conservarlo
così illeso provvede la levigatezza.
Perciò avviene che di lì tornino a noi
riflessi i simulacri.
E per quanto subitamente, in qualsiasi momento, tu
ponga
una cosa qualunque contro uno specchio, appare l’immagine;
sì che
puoi conoscere che sempre fluiscono dalla superficie
dei corpi tessuti tenui
e tenui figure delle cose.
Dunque, molti simulacri in breve tempo si
generano,
sì che a ragione può dirsi che per tali cose sia celere il nascere.
La funzione dell’aria nella costituzione delle immagini è quella di mezzo di trasmissione tra oggetti percepiti e soggetto percipiente; e, il passo appena riportato, prelude a come possano formarsi immagini di cose inesistenti (mostri favolosi o persone scomparse): è infatti in virtù dell’incontro casuale di atomi provenienti dai corpi più disparati che ciò accade: ai versi 129/142 Lucrezio dice:
Ma, affinché tu non creda, per caso, che vadano vagando solo
quei
simulacri che si distaccano dalle cose, e non altri,
esistono anche quelli
che si generano spontaneamente
e si formano da soli in questa regione del
cielo
che si chiama aria, e foggiati in molti modi volano in alto,
come
talora vediamo le nuvole facilmente formarsi nell’alto
del cielo e oscurare
il sereno aspetto del firmamento,
accarezzando l’aria col moto: ché spesso si
vedono volare
volti di Giganti e spander l’ombra per ampio spazio,
talora
grandi monti e macigni divelti
dai monti avanzare e passar davanti al
sole,
poi una belva tirarsi dietro altri nembi e guidarli.
E fondendosi
non cessano di mutare il proprio aspetto
e assumere contorni di forme d’ogni
specie.
Particolarmente curioso è il paragone che Lucrezio fa tra le nuvole e i simulacra , un paragone che rende molto bene l’idea della sottigliezza e dell’impalpabilità di questi ultimi e di come essi cambino rapidamente forma, cosicchè ora ci appaiono come massi, ora come temibili mostri, ora come giganti. L’immagine della nuvola è destinata ad avere, in filosofia, gran successo: già Aristotele, nel suo scritto Sui sogni , per mostrare l’ingannevolezza delle immagini che abbiamo nei sogni, le accostava alle forme che vediamo nelle nuvole; molti secoli dopo, Schopenhauer si farà beffe di Hegel e del suo vedere una razionalità nella storia paragonandolo a quelli che nelle nuvole scorgono ora la forma di un cane, ora di un uomo, e così via. Ancora Heidegger, nel Novecento, ponendo l’accento sulla centralità indiscussa del linguaggio, dirà che ” il linguaggio è il linguaggio dell’essere come le nuvole sono le nuvole del cielo” (“Lettera sull’umanismo”). Dai versi 176 in poi, Lucrezio si sofferma sulla rapidità dei simulacra , sul loro muoversi celeri motu e sul fatto che attraversano ogni spazio istantaneamente:
E ora, con che celere moto procedano i simulacri
e quale mobilità
nell’attraversare a nuoto l’aria sia ad essi data,
sì che in lungo tragitto
si consuma breve tempo,
quale che sia il luogo a cui ciascuno con diverso
impulso tende,
esporrò in versi soavi piuttosto che numerosi;
così il
breve canto del cigno è migliore di quel clamore
delle gru disperso tra le
eteree nubi dell’Austro.
Anzitutto, molto spesso si può vedere che le cose
leggere
e fatte di corpi minuti sono celeri.
Di tale specie sono, certo,
la luce del sole e il suo calore
perché sono fatti di elementi minuti,
che
vengono quasi battuti e non esitano ad attraversare
l’aria interposta,
incalzati dal colpo susseguente.
Sùbito infatti luce succede a luce e, come
in serie
ininterrotta, splendore è stimolato da splendore.
Perciò bisogna
che i simulacri parimenti possano
trascorrere in un istante attraverso uno
spazio
inimmaginabile, anzitutto perché c’è una piccola causa
lontano, da
tergo, che li sospinge e li caccia innanzi,
quando, del resto, essi procedono
con tanto alata levità;
poi perché vengono emessi dotati di un tessuto così
rado
che posson penetrare facilmente in cose di qualunque tipo
e, per così
dire, infiltrarsi attraverso l’aria interposta.
Per rendere più facilmente comprensibile la dimostrazione di questo punto, Lucrezio fa di nuovo appello (come già aveva fatto nell’incipit del libro IV) alla poesia: come il canto del cigno è preferibile allo stridore delle gru, così anche le soavi parole della poesia piaceranno di più rispetto alla fredda andatura della prosa (versi 181/182):
Così il breve canto del cigno è migliore di quel clamore
delle gru
disperso tra le eteree nubi dell’Austro.
I simulacra , grazie alla sottigliezza e alla velocità che li contraddistinguono, volando fendono l’aria ( tranantibus auras ) e quanto più sono leggeri tanto più sono veloci: per i singoli atomi, come aveva acutamente notato Epicuro, è opportuno parlare di “equivelocità”, ovvero di velocità pari a quella del pensiero; i composti atomici, invece, poiché più pesanti (in quanto aggregati di più atomi) sono più lenti nel muoversi. Nel loro movimento, gli atomi possono incontrare altri atomi, più piccoli o più grandi, e nello scontro si produce un urto che fa rimbalzare gli atomi più lontano o più vicino a seconda della loro grandezza stessa. La velocità con cui viaggiano gli atomi è talmente elevata che ci è impossibile percepire la distanza che essi hanno percorso: e la loro velocità è dovuta, oltre che alla leggerezza che li contraddistingue, al fatto che, in analogia con la tessitura, essi riportano la trama dell’oggetto, un tessuto rado e fluttuante, che consente loro di penetrare ogni superficie (versi 190 e seguenti):
…bisogna che i simulacri parimenti possano
trascorrere in un istante
attraverso uno spazio
inimmaginabile, anzitutto perché c’è una piccola
causa
lontano, da tergo, che li sospinge e li caccia innanzi,
quando, del
resto, essi procedono con tanto alata levità;
poi perché vengono emessi
dotati di un tessuto così rado
che posson penetrare facilmente in cose di
qualunque tipo
e, per così dire, infiltrarsi attraverso l’aria interposta.
Così, se poniamo a terra una superficie riflettente quando c’è il cielo stellato, lo vedremo immediatamente riflesso, in modo istantaneo; e, similmente, con altrettanta velocità, gli atomi giungono ai nostri organi di senso. Lucrezio dà molto spazio al senso della vista, quasi come se -aristotelicamente- lo ritenesse un senso privilegiato, superiore agli altri; e nei versi 353 e seguenti affronta, in relazione a tale tematica, un problema su cui Epicuro si era particolarmente affaticato: se è vero che la sensazione è certa e non ingannatrice, come la dottrina epicurea ritiene, allora come si spiega che talvolta i sensi ci attestano le cose diversamente da come esse in realtà sono? Come mai il remo immerso in acqua ci appare spezzato? O, per attenerci all’esempio che Lucrezio adduce ai versi 353 e seguenti, come mai le torri quadrate, viste da distante, ci sembrano rotonde? E’ un problema di primaria importanza e la posta in palio è alta: se non si riesce ad argomentare contro la fallacia delle testimonianze sensibili salta l’intera filosofia epicurea. Restando al paradosso delle torri, secondo Lucrezio è assolutamente vero ciò che ci attestano i sensi, sia quando (da vicino) ci dicono che le torri sono quadrate, sia quando (da lontano) ci dicono che esse sono tondeggianti: i nostri occhi non cadono in inganno, ma vedono da distante le torri a forma rotonda e non quadrata perché gli atomi che da esse si staccano e che dovrebbero riportarci la spigolosità che rende quadrate le torri vengono smussati dal contatto con l’aria. L’errore, secondo Lucrezio, consiste nel dire che le torri sono rotonde anziché quadrate, poiché, così facendo, si formula un giudizio prima di aver effettivamente visto le torri direttamente da vicino:
E quando vediamo da lungi le quadrate torri d’una città,
per ciò spesso
avviene che sembrino rotonde,
perché di lontano ogni angolo si vede
ottuso
o piuttosto non si vede affatto e se ne perde
il colpo, né la
percossa perviene alle nostre pupille,
perché, mentre i simulacri viaggiano
per molta aria,
coi frequenti scontri l’aria la costringe ad
ottundersi.
[…]Né tuttavia concediamo che qui gli occhi s’ingannino in
nulla.
Giacché vedere in quale luogo sia la luce e in quale l’ombra,
è
loro proprietà; ma se sia o non sia la stessa luce,
e se la stessa ombra che
fu qui, passi ora là,
o piuttosto accada ciò che abbiamo detto
poc’anzi,
questo deve discernerlo soltanto il ragionare della mente,
né
possono gli occhi conoscere la natura delle cose.
Dunque non attribuire
falsamente agli occhi questo errore della mente.
Lucrezio, oltre all’esempio delle torri, ricorre ad un’ampia casistica di illusioni ottiche, che fanno sì che pensiamo la realtà diversamente da come essa è: in particolare, ai versi 426 e seguenti, cita il caso dell’illusione prospettica, quando un portico, visto da una certa prospettiva, può apparire stringersi a cono:
Un portico, ancora, benché sia di tracciato uniforme
e stia da un capo
all’altro sorretto su colonne uguali,
tuttavia, se vien guardato da
un’estremità per tutta la lunghezza,
a poco a poco si contrae nel vertice di
un cono angusto,
congiungendo il tetto al suolo e tutto il lato destro al
sinistro,
finché li unisce nell’oscura punta di un cono.
Ai versi 447/452, con un esempio desunto da Aristotele (dal suo scritto “Sui sogni”), Lucrezio ci fa notare come quando schiacciamo con un dito l’occhio, poi vediamo tutto raddoppiato:
E se per caso una mano, posta sotto un occhio, di sotto
lo preme, per una
certa sensazione accade che tutte le cose
che guardiamo sembrino farsi allora
doppie al guardarle,
doppie le luci delle lucerne che fioriscono di
fiamme
e doppia per tutta la casa farsi la suppellettile
e duplici le
facce degli uomini e doppi i corpi.
Tuttavia, con questi numerosi esempi, Lucrezio non vuol dimostrare l’ingannevolezza dei sensi, ma, al contrario, argomentare contro lo Scetticismo e le contraddizioni che scaturiscono da esso: dubitare della sensazione, come fanno gli Scettici, conduce infatti a dubitare di ogni cosa e, dunque, rende impossibile vivere. Peraltro, nota Lucrezio, lo stesso affermare di non sapere nulla è altamente contraddittorio: poiché, affermando con certezza di non sapere nulla, si è già in possesso di una forma di sapere: il sapere di non sapere. Tuttavia, Lucrezio non vuole ancora chiudere la partita con gli Scettici e, così, concede loro l’ammissibilità di questa tesi poc’anzi dimostrata contraddittoria: resta comunque il fatto che per affermare di non poter conoscere nulla, gli Scettici debbano almeno sapere che cosa significhi conoscere, quale sia la differenza tra certezza e dubbio, tra vero e falso, tra sapere e non sapere, ecc. E, nota Lucrezio, dove potrebbe essere il criterio per distinguere il vero dal falso, il certo dal dubbio, e così via, se non in quel qualcosa che non può mai essere contraddetto, ovvero l’esperienza? Poiché è dai sensi che nasce la nozione di vero e di falso, dal momento che ciascuna sensazione è, di per sé, vera. Questo è facilmente dimostrabile con l’arma scettica del regresso all’infinito: se non credo ai sensi (come fanno gli Scettici), devo trovare qualcosa di più affidabile rispetto ad essi, e per trovarlo ho bisogno di qualcos’altro che mi permetta di valutarlo, e così via all’infinito. Resta da chiedersi se la ratio , la ragione, sia più verace dei sensi: quasi come se essa fosse portavoce della verità e i sensi della menzogna. Ma, se così fosse, anche la ratio sarebbe distrutta automaticamente, giacchè il pensiero razionale esercitato dall’uomo poggia sulla sensazione, cosicchè se è ingannatrice questa, lo è anche quella. Ma dato che i sensi non sono ingannatori, anche la ragione è salva: ciascuno di essi, secondo Lucrezio (che qui rivela marcate influenze aristoteliche), percepisce secondo verità quelli che Aristotele definiva i “sensibili propri”, cioè propri di ciascun senso, con l’inevitabile conseguenza che i sensi non si smentiscono a vicenda, ma cooperano per costruire la conoscenza. Alla fine, ammonisce Lucrezio, se proprio questo ragionamento non ci convince, allora, data la fondamentalità dell’avere un criterio, è meglio accettare una percezione errata piuttosto che dubitare che ci sia un criterio, perché altrimenti verrebbe trascinata via la possibilità di vivere. La vita, infatti, poggia su un criterio (giusto o sbagliato che sia) e se esso viene a mancare, crolla anche la possibilità di vivere felicemente; bisogna evitare i dirupi seguendo la ragione, consiglia Lucrezio: ed è particolarmente interessante il riferimento ai “dirupi”, poiché, forse, in esso si cela una stoccata ai danni dello scettico Pirrone, che, come riferisce Diogene Laerzio, nell’assenza di un criterio per stabilire cosa fosse bene e cosa male, cosa vero e cosa falso, si gettava nei dirupi. Ai versi 513 e seguenti, il processo conoscitivo è da Lucrezio accostato (con un’immagine portante nella tradizione filosofica, antica e moderna) a quello con cui si fabbrica un edificio, l’edificio del sapere: per edificare una casa, occorrono strumenti adeguati; fuor di metafora, per costruire l’edificio del sapere occorrono le testimonianze dei sensi, poiché, senza di essi, la casa del sapere è instabile e soggetta a crolli improvvisi, a seguito dei quali è poi impossibile vivere.
Infine, se taluno crede che non si sappia nulla, anche questo
non sa se si
possa sapere, giacché ammette di non sapere nulla.
Contro di lui dunque
tralascerò di discutere,
perché da sé stesso si mette col capo al posto dei
propri piedi.
E tuttavia voglio pure concedergli che sappia anche ciò;
ma
gli domanderò soltanto: se nel mondo egli non ha prima veduto
mai nulla di
vero, donde sa cosa sia sapere e, viceversa, non sapere?
Quale cosa ha
prodotto il concetto di vero e di falso,
e quale cosa ha provato che
l’incerto differisce dal certo?
Troverai che il concetto di vero è stato
prodotto primamente
dai sensi e che i sensi non possono essere
contraddetti.
Giacché maggiore credibilità dev’essere riconosciuta
a ciò
che di per sé col vero possa confutare il falso.
Ma che cosa si deve
giudicare maggiormente credibile
che il senso? Forse, nata da un senso
fallace, la ragione
varrà ad oppugnare i sensi, essa che tutta da loro è
nata?
Se quelli non son veritieri, anche la ragione diventa tutta falsa.
O
potranno le orecchie correggere gli occhi, o il tatto
le orecchie? O,
d’altronde, questo tatto sarà convinto d’errore
dal gusto della bocca, o lo
confuteranno le nari, o gli occhi
lo smentiranno? Non è così, io penso.
Giacché ogni senso
ha un potere specialmente distinto, ciascuno ha una
facoltà
propria, e perciò è necessario percepire con un senso speciale
ciò
che è molle e gelido o infocato, e con un senso speciale
i vari colori delle
cose, e vedere quanto ai colori è congiunto.
Una speciale facoltà ha pure il
gusto della bocca, per una via
speciale sorgono gli odori, per un’altra
speciale i suoni. Si deve
perciò concludere che i sensi non possono
confutarsi a vicenda.
E neanche potranno correggersi da sé,
poiché uguale
fiducia si dovrà sempre ad essi accordare.
Quindi ciò che in ogni momento è a
questi apparso, è vero.
E se non potrà la ragione discernere la causa per la
quale
le cose che da presso erano quadrate, da lontano sembrano
rotonde,
tuttavia è preferibile per difetto di ragionamento
spiegare erroneamente le
cause dell’una e dell’altra figura,
anziché lasciarsi sfuggir via dalle mani
cose manifeste
e far violenza alla fede prima e sconvolgere
gl’interi
fondamenti su cui poggiano la vita e la salvezza.
Non solo,
infatti, la ragione rovinerebbe tutta: anche la stessa
vita crollerebbe
all’istante, se tu non osassi fidarti dei sensi
ed evitare i precipizi e
tutte le altre cose di questa specie
che si devon fuggire, e seguire le cose
che sono contrarie.
Concludi dunque che è un vano mucchio di parole
tutto
quello che contro i sensi è stato messo insieme e
approntato.
Ancora: come in una costruzione, se il regolo al principio
è
storto, e se la squadra è fallace ed esce dalle linee dritte,
e la livella da
qualche parte zoppica un pochino,
inevitabilmente tutto l’edificio riesce
difettoso e piegato,
storto, cascante, inclinato in avanti, inclinato
all’indietro
e disarmonico, sì che alcune parti sembra vogliano
già
precipitare, e tutto precipita, tradito dalle prime misure
fallaci, così,
dunque, il ragionare sulle cose deve riuscirti
storto e falso, qualora da
falsi sensi sia nato.
Dopo essersi brevemente soffermato anche sugli altri sensi, Lucrezio, dai versi 722 in avanti, concentra la propria attenzione sul pensiero: come si pensa? Il passaggio da sensazione a pensiero nel IV libro avviene senza soluzione di continuità, poiché la funzione del pensiero è spiegata in analogia con quella dei sensi: già nel libro III del “De anima”, Aristotele compiva un’operazione di questo tipo, con la conseguenza che nel pensiero così come lo concepiva lo Stagirita c’era analogia tra sensi e funzione del pensiero, non oggetti del pensiero. Per Lucrezio, invece, pensiamo nello stesso modo in cui percepiamo, e il pensiero stesso è una forma sui generis di percezione. Non è infatti possibile pensare se non perché si ricevono stimoli dall’esterno, come già sosteneva Democrito. Ora, Lucrezio distingue tra animus (inteso come funzione del pensiero e corrispondente all’anima razionale) e anima (intesa come funzione percettiva e biologica e corrispondente all’anima percettiva e nutritiva): tale distinzione tra parte razionale e parte non razionale dell’anima umana in Epicuro non era affatto scontata e viene trattata una sola volta, all’interno dell’ “Epistola ad Erodoto” (il testo per di più è assai guasto in quel punto). Pur nella sua partizione e nella pluralità delle funzioni, l’anima è una, composta, come ogni altra cosa, da atomi e vuoto : la parte razionale, però, è più veloce e quindi più dinamica (perché costituita da atomi più sottili e leggeri). Il processo conoscitivo, in tale ottica, è da Lucrezio (e da Epicuro) concepito come la messa in moto dell’ animus da parte dei simulacra penetrati nei vari sensi: ne consegue, naturalmente, che non potrà esserci pensiero se prima non c’è percezione; i simulacra, in virtù della loro sottigliezza, attraversano gli organi di senso e colpiscono direttamente l’ animus : il pensiero nascerà dunque per contatto fisico e tale analogia di funzione si spiega con l’analogia di struttura; infatti, l’anima è materiale alla pari dei simulacra , i quali mettono materialmente in moto il pensiero. Lo spazio intorno a noi, afferma Lucrezio, è affollatissimo di simulacra che si staccano dagli oggetti e che, casualmente, si aggregano tra loro; per sottolinearne la sottigliezza che li rende pressochè impalpabili, Lucrezio li accosta (ai versi 725 e successivi) alle ragnatele o alle lamine d’oro. In tale prospettiva, possiamo pensare cose inesistenti proprio in virtù del fatto che (com’è chiarito dal verso 735 in poi) i simulacra vagano ovunque e si formano aggregazioni casuali: il simulacrum di un uomo può ad esempio aggregarsi, in maniera del tutto casuale, a quello di un cavallo e, in tal modo, si formerà l’immagine del Centauro. Come Lucrezio aveva detto nel libro III, l’anima razionale si distingue da quella nutritiva perché maggiormente sottile e questo spiegava anche, come abbiamo già sottolineato, la velocità del pensiero e il fatto che esso muti tanto rapidamente e colga anche gli atomi più sottili:
E infatti questi simulacri sono di tessuto molto più sottile,
in confronto
a quelli che occupano gli occhi e provocano il vedere,
poiché questi
penetrano per i pori del corpo e dentro destano
la sottile natura dell’animo
e ne provocano la sensibilità.
E così vediamo Centauri e membra di
Scille
e canine facce di Cerberi e i simulacri di coloro
che sono morti e
di cui la terra abbraccia le ossa;
poiché simulacri d’ogni genere si muovono
in ogni dove,
e parte nascono spontaneamente nell’aria stessa,
parte son
quelli che in qualche modo si staccano dalle varie cose
e quelli che son
fatti dal comporsi delle figure di questi.
Ché certo non viene da cosa viva
l’immagine del Centauro,
poiché non è mai esistita la natura d’un tale essere
vivente,
ma, quando le immagini d’un cavallo e d’un uomo per
caso
s’incontrano, sùbito facilmente aderiscono, come abbiamo detto
prima,
per la loro sottile natura e il tenue tessuto.
Anche le percezioni che abbiamo nei sogni, come quelle della veglia, sono percezioni di oggetti che provengono dall’esterno: si formano in modo del tutto analogo e questo è particolarmente rilevante perché implica che le immagini che percepiamo nei sogni abbiano origine assolutamente naturale, cosicchè è impossibile attribuire ai sogni un significato profetico e sovraumano (se annunciano la verità, ciò è completamente casuale). Ma allora, stando così le cose, esiste un criterio per distinguere le percezioni della veglia da quelle del sonno? E’, in definitiva, possibile porre un confine tra realtà e sogno? Infatti, come spiega Lucrezio, se nei sogni mi appaiono persone defunte, ciò può ugualmente avvenire quando sono desto, poiché si tratta del risultato di un’aggregazione, retta dal caso, di simulacra che si incontrano nell’aria. La differenza, tuttavia, risiede nel fatto che, mentre nella veglia possiamo esprimere un giudizio sui dati dei sensi e tale giudizio è passibile di essere attestato o sconfessato dall’empiria, nel sonno questo manca, giacchè possiamo finire per credere che un morto sia vivo in quanto manca la possibilità di discernere il vero dal falso. Quest’attenzione riservata ai sogni spiega perché Lucrezio, all’interno del libro IV, si soffermi diffusamente sul sonno, da lui inteso come assenza temporanea di funzionamento della sensazione. Dal verso 769 in avanti viene introdotta una questione di gran peso: nel sonno, ci capita spesso di percepire immagini che cambiano, come quando vediamo una persona defunta prima giovane e poi vecchia, prima seduta e poi in piedi: come si spiega questo? Perché mai questi simulacra “muovono le braccia” (verso 769)? Ciò avviene con un procedimento analogo a quello delle moderne pellicole cinematografiche, in cui l’immagine cambia tanto rapidamente che sembra che sia la stessa immagine ad aver cambiato forma (ad esempio, prima viene proiettata l’immagine di una persona seduta, poi viene celermente sostituita da quella della stessa persona in piedi, cosicchè si crede che sia la stessa immagine che è mutata). Questo procedimento, valido a livello atomico, si spiega tenendo conto dell’incredibile velocità (pari a quella del pensiero) con cui si muovono i simulacra :
Quanto al resto, non è sorprendente che i simulacri si muovano
e in
cadenza agitino le braccia e le altre membra.
Infatti accade che nei sogni
l’immagine sembri far questo,
giacché, quando la prima è sparita e quindi
un’altra è nata
in altra positura, sembra allora che la prima abbia mutato
gesto.
Senza dubbio si deve pensare che ciò avvenga in modo celere:
tanta
è la mobilità, tanta la moltitudine delle immagini,
e tanta è l’abbondanza
delle particelle in un qualunque
minimo tempo percettibile, che può bastare
all’effetto.
La trattazione dell’argomento, però, ammonisce Lucrezio ai versi 777, è alquanto ardua, soprattutto perché è un argomento da Epicuro lasciato in sospeso o, comunque, trattato in maniera non del tutto chiara. Il nuovo problema su cui si concentra il poeta (dal verso 779 in poi) riguarda il rapporto tra pensiero e volontà: come accade che, al pensare una cosa, siamo presi da un forte desiderio della medesima, da un’irresistibile volere ( voluntas ) quella cosa?
Si chiede anzitutto perché, quando a chiunque sia venuto
il capriccio di
pensar qualcosa, sùbito la mente pensi proprio quella.
Il problema è delicatissimo, in quanto si tratta di spiegare in termini atomistici la libertà di giudizio: una prima possibile risposta che possiamo avanzare di fronte alla domanda poc’anzi formulata è che, forse, l’adeguazione immediata tra pensiero e desiderio avvenga perché i simulacra penetrano istantaneamente in noi a portarci l’immagine di ciò che vogliamo (sia esso il mare o la terra), come se la natura forgiasse immagini di ciò che noi desideriamo e ce le inviasse quando ne sentiamo il desiderio:
Forse i simulacri sono attenti al nostro volere
e, appena noi vogliamo,
accorre a noi l’immagine,
se il mare, se la terra ci sta a cuore, o infine il
cielo?
Radunanze d’uomini, una processione, conviti, battaglie,
ogni cosa
la natura crea e appronta a una nostra parola?
Sembra, in prima analisi, una risposta soddisfacente, che prevede che la natura preveda i nostri desideri. Eppure, se letta in trasparenza, rivela tutta la sua inconsistenza: come si spiegherebbe la percezione che spesso abbiamo di simulacra in movimento, che “avanzano danzando” nei sogni? Tanto più che, ammettendo per assurdo la validità di tale risposta, scaturirebbero conseguenze inammissibili: ci si troverebbe costretti ad ammettere che i simulacra sono impregnati di arte ( arte madent ) e vagano istruiti ( docta ) per realizzare di notte il loro teatrino, pronti ad esaudire ogni nostro desiderio. Non è, quindi, accettabile l’esistenza di simulacra fuori di noi che sono pronti ad entrare al nostro interno quando lo vogliamo; vero è, invece, che fuori di noi volteggia una miriade di atomi che si succedono con un’incredibile rapidità e che si sostituiscono proprio in quegli istanti in cui non percepisco: in una tale sovrabbondanza di atomi, il pensiero si focalizza esclusivamente su quelli che gli interessano in quel momento, trascurando gli altri:
O non sarà piuttosto vero ciò? Poiché in un singolo momento
in cui
sentiamo, cioè in cui viene emessa una singola voce,
si celano molti momenti,
che la ragione scopre esistenti,
perciò accade che in qualsiasi momento
simulacri d’ogni tipo
siano a disposizione e pronti in tutti i vari
luoghi:
tanta è la mobilità, tanta la moltitudine delle immagini.
Perciò,
quando la prima è morta e quindi un’altra è nata
in altra positura, pare
allora che la prima abbia mutato gesto.
E poiché sono sottili, l’animo non
può discernere distinte
se non quelle che cerca di cogliere; quindi tutte
quelle che ci sono
oltre ad esse, vanno perdute, tranne quelle cui l’animo
s’è preparato.
Esso, d’altra parte, si prepara e s’aspetta che gli accada di
vedere
ciò che segue a ogni positura dell’immagine; quindi ciò avviene.
Sorge però un nuovo problema da risolvere: come fa il pensiero a soffermarsi solo su determinati simulacra ? Per rispondere, occorre fare riferimento alla concezione lucreziana dell’anima: se l’ anima è disseminata in tutto il corpo (e ne è prova il fatto che tutto il corpo ha sensazioni ed è suscettibile di crescita), l’ animus , dal canto suo, sta nel petto e, dato che gli atomi di quest’ultimo sono leggerissimi, affinchè il pensiero funzioni gli atomi non devono assolutamente disperdersi e ciò può avvenire solamente se il pensiero si concentra esclusivamente sulle cose cui pensa. Il pensiero, dunque, si focalizzerà su alcuni atomi, lasciando cadere tutto il resto: se ciò non avvenisse in uno spazio rigorosamente limitato, gli atomi sottili si disperderebbero. Per spiegarsi meglio, Lucrezio ricorre ancora una volta ad un’analogia con il mondo sensibile (versi 807 e seguenti): come gli occhi, per poter osservare le realtà più minute, devono concentrarsi, allo stesso modo agisce anche il pensiero; se non si presta attenzione e non si pone mente si rischia di fissare un oggetto senza vederlo. Pensiamo a quando gli occhi si sforzano per mettere a fuoco un oggetto e vedono tutto il resto sfuocato.
Non vedi che anche gli occhi, quando s’accingono a scorgere
cose che sono
sottili, si tendono con sforzo e si preparano,
né senza ciò può accadere che
discerniamo distintamente?
E tuttavia, anche nel caso di cose manifeste, puoi
osservare
che, se non volgi ad esse la mente, è come se tutto
il tempo la
cosa fosse distante e di gran lunga remota.
Perché, dunque, meravigliarsi, se
l’animo perde tutte
le altre cose, tranne quelle alle quali esso è intento?
Gli atomisti, pur mettendo l’accento sulla materialità, non negano il potere del pensiero, bensì si propongono di mettere in chiaro come esso funzioni in modo non diverso rispetto ai sensi; se così non fosse, si inciamperebbe in quel dualismo centrale nella filosofia platonica e, in qualche misura presente, anche in Aristotele. La potenza del pensiero può, secondo Lucrezio, essere individuata nella sua capacità di formulare grandi teorie a partire da cose minuscole e, perfino, nella sua capacità di illudersi: esso è, in altri termini, talmente potente (di un potere per alcuni versi perverso) da riuscire ad ingannarsi (versi 816 e successivi). Da ciò scaturisce un’altra conseguenza di un certo spessore: esiste un fine in vista del quale la natura ci ha dotati di sensazione di pensiero? Assolutamente no, risponde Lucrezio al verso 822:
A tale proposito desideriamo vivamente che tu fugga
un vizioso
ragionamento, e con grande cautela eviti l’errore
di credere che il chiaro
lume degli occhi sia stato creato
affinché possiamo vedere, e che le
estremità delle gambe
e delle cosce fondate sui piedi possano piegarsi per
questo,
affinché siamo in grado di avanzare a lunghi passi,
e ancora, che
gli avambracci siano attaccati alle forti braccia
e ci siano state date le
mani per servirci dall’una e l’altra parte,
affinché possiamo fare ciò che
abbisogna per la vita.
Affiora qui la polemica epicurea nei confronti del teleologismo di ascendenza platonica e aristotelica: ad avviso di questi due filosofi, la natura prima avrebbe determinato la funzione (mangiare, respirare, afferrare oggetti) e solo dopo e in base ad essa avrebbe creato gli organi per assolverla (lo stomaco, i polmoni, le mani). Proprio al verso 830, Lucrezio fa menzione della mano, probabilmente memore della diatriba tra Aristotele e Anassagora: come è noto, secondo Anassagora l’uomo è l’animale più intelligente perché dotato della mano, mentre, secondo Aristotele, l’uomo è dotato della mano perché è l’animale più intelligente. Ora Lucrezio, senza esitazione alcuna, si schiera dalla parte di Anassagora: in natura, per prima cosa c’è l’organo e solo dopo da esso si sviluppano le funzioni: chi procede come Aristotele e Platone argomenta “a rovescio”, capovolgendo tutto (“omnia perversa praepostera sunt ratione”).
Tutte le interpretazioni di questo genere [teleologiche]
mettono il prima
al posto del dopo con ragionare stravolto,
poiché nessuna cosa è nata nel
corpo per questo,
affinché potessimo usarne, ma ciò che è nato crea esso
l’uso.
Né esistette la vista prima che nascessero gli occhi,
né il dire
con parole prima che la lingua fosse creata,
ma piuttosto la nascita della
lingua precedette di molto
la favella, e le orecchie furono create molto
prima
che si udisse il suono, e, in breve, tutte le membra
esistettero, io
credo, prima che esistesse il loro uso.
Non poterono quindi crescere per il
fine dell’uso.
Si passa dunque dal fine al caso: nel V libro, Lucrezio farà vedere come l’assetto dell’uomo altro non è se non il frutto di una serie di tentativi della natura. Nella prospettiva appena delineata, Lucrezio dice che la lingua vien prima del linguaggio, le orecchie prima dell’udire e, in generale, tutti gli organi prima delle loro funzioni: se in natura la costituzione fisica precede l’uso, nell’ambito delle tecniche, intese come escogitazioni umane, il rapporto si inverte, cosicchè prima si fissa l’utilizzo e poi si crea il mezzo con cui ottenerlo (ad esempio, prima si stabilisce che la casa serve per viverci e poi, in vista di ciò, la si edifica). La tecnica è però incommensurabilmente inferiore alla natura, in quanto stravolge il processo naturale e crea cose mostruose, come le armi (verso 843 e seguenti), create per annientare i propri simili:
… venire alle mani nella zuffa della battaglia
e lacerar membra e
insozzare di sangue il corpo
furono molto prima che volassero i lucidi
dardi,
e la natura costrinse a evitare la ferita prima che il
braccio
sinistro opponesse la difesa dello scudo foggiato dall’arte.
E
senza dubbio l’abbandonare al riposo il corpo stanco
è molto più antico che
il letto dai morbidi materassi,
e il placare la sete nacque prima delle
coppe.
Si può dunque credere che siano state inventate per l’uso
queste
cose che sono state scoperte secondo i bisogni della vita.
Con lo svilupparsi della civiltà, l’uomo ha fatto un uso atroce della tecnica, inventando le frecce, lo scudo e altri ordigni funesti. La radicale divisione operata da Lucrezio tra tecnica e natura (che egli pone agli antipodi) ha una motivazione profonda: in Aristotele e in Platone, esse erano appaiate e tale appaiamento era la base per fondare la teleologia, in quanto, secondo i due filosofi greci, sia la natura sia la tecnica mirano ad un fine; separandole (e anzi, contrapponendole), Lucrezio può ancora una volta (criticando la tecnica) criticare il finalismo, ed elogiare la natura, che procede in modo casuale. Dal verso 877 in avanti, Lucrezio affronta una questione spinosa, che costituirà uno scoglio difficilmente superabile per tutti i materialisti (Hobbes in primis): come si spiega il rapporto tra materia e pensiero? Come avviene che, all’insorgere di un pensiero, il mio corpo si muove? Adducendo un esempio non lucreziano, immaginiamo di decidere di andare a teatro: ci alziamo e andiamo. Come si spiega, in termini atomistici, questa corrispondenza tra pensiero e materia? Mi muovo perché percepisco oggetti in movimento, risponde Lucrezio: vedo cose che si muovono e mi viene voglia, a mia volta, di muovermi: l’ animus trasmette il desiderio all’ anima (la quale è diffusa in tutto il corpo), e tale trasmissione è di origine fisica: a questo punto, vengono messe in moto le parti del corpo. Questo avviene perché, tra anima, animus e corpo intercorre un rapporto di sumpaqeia , un “subire la stessa affezione”. In quest’ottica, il pensiero è eterodiretto (e non autodiretto): è cioè dipendente dall’esterno, in quanto la volontà di muoversi (“inde voluntas fit”, verso 883) sorge dalla percezione di cose in movimento:
Ora dirò come avviene che possiamo avanzare coi nostri passi
quando
vogliamo, e che ci sia dato muover le membra in vari modi,
e quale forza sia
solita spingere innanzi questo gran peso
del nostro corpo: tu ascolta
attentamente le mie parole.
Dico che dapprima simulacri di movimento
giungono
al nostro animo e lo impressionano, come abbiamo già
detto.
Quindi nasce il volere; e infatti nessuno comincia a fare
qualcosa
prima ‹che› la mente preveda quello che vuole fare.
E di quello che essa
prevede, esiste un’immagine.
Dunque, quando l’animo si muove sì che vuole
andare
e procedere, sùbito sprona la forza dell’anima
che è disseminata in
tutto il corpo per membra e giunture;
e ciò è facile a farsi, poiché
all’animo è strettamente congiunta.
Poi essa sprona a sua volta il corpo, e
così tutta
la massa a poco a poco è spinta innanzi e si muove.
Inoltre,
allora si dirada anche il corpo, e l’aria
(come naturalmente deve, giacché
sempre è di mobile natura)
arriva attraverso le aperture e penetra nei fori
in abbondanza,
e così si sparge qua e là, fino a tutte le parti minute
del
corpo. Allora, dunque, avviene che il corpo sia mosso
da due cause, operanti
da una parte e dall’altra, come una nave
spinta dai remi e dal vento. Né
tuttavia in ciò fa meraviglia
che corpuscoli tanto piccoli possano dirigere
un corpo
tanto grande e voltare attorno tutto il nostro peso.
Nella sua trattazione della sensazione del pensiero, Lucrezio si dilunga
molto (in versi divenuti celeberrimi) sulla passione amorosa, mettendo in
evidenza come essa ottenebri i sensi e, con essi, il pensiero e come dunque
debba essere respinta.
STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE
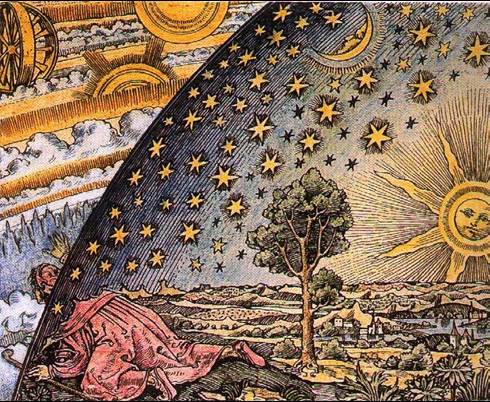 LA FILOSOFIA DEL XIII SECOLO
LA FILOSOFIA DEL XIII SECOLO
A cura di Claudia Bianco
BREVE INTRODUZIONE ALLA SCOLASTICA
Il sapere filosofico, teologico e scientifico elaborato in età medievale (secc.VI – XIV) viene designato con il termine SCOLASTICA. Il termine deriva dal fatto che nel Medioevo la produzione intellettuale è legata alle scuole; infatti, a partire dal secolo XIII la ricerca intellettuale si concentra nelle Università, libere corporazioni di studenti e insegnanti, dove la filosofia ha un ruolo centrale per la dimostrazione razionale dei contenuti di fede e coincide sostanzialmente con la lettura e il commento dei testi aristotelici. La filosofia del XIII secolo fu, però, qualcosa di diverso da una semplice esegesi di Aristotele; essa ne fu, infatti, la reinterpretazione da parte dei cristiani.
Se volessimo rintracciare i fattori che hanno favorito lo sviluppo di questo pensiero filosofico, troveremo:
1. La creazione e la fondazione delle università;
2. L’attività culturale dei due ordini mendicanti , dei francescani e domenicani, non più legati al “mondo separato” dei monasteri, ma in stretto contatto con le realtà cittadine e le università;
3. la riscoperta attraverso la mediazione araba, degli scritti di metafisica e di fisica di Aristotele;
4. Il rinnovato studio dell’opera platonica e il significativo recupero della tradizione agostiniana.
Solitamente si distinguono tre fasi storiche:
1. PRIMO PERIODO (VI-XI secc.) = caratterizzato dall’indagine razionale sulla fede con l’ausilio della filosofia neoplatonica mediata attraverso Agostino, Boezio e Dionigi Areopagita. Scoto Eriugena, Anselmo d’Aosta e Abelardo sono tra i maggiori pensatori di questo periodo.
2. SECONDO PERIODO (XIII sec.) = segnato dall’ingresso della filosofia di Aristotele e dal seguente confronto tra teologia cristiana e metafisica aristotelica. Ne derivano tre linee interpretative:
· San Bonaventura e la sua scuola respingono l’aristotelismo in favore dell’agostinismo e del neoplatonismo cristiano tradizionale;
· i pensatori noti come “averroismi latini” (Sigieri di Brabante e Boezio di Dacia) seguono un aristotelismo radicale, attribuendo piena validità alle dottrine aristoteliche sul piano razionale, e dislocando le verità relative su un piano superire;
· Tommaso d’Aquino propone una linea intermedia: il cristiano deve avvalersi della filosofia di Aristotele , dopo aver corretto le tesi contrastanti con la rivelazione.
3. TERZO PERIODO (XIV sec.) = cerca nuovi equilibri con lo studio rigoroso dei metodi e dei linguaggi propri delle singole discipline , in particolare con Duns Scoto, Guglielmo d’Ockham, Marsilio da Padova, Giovanni Buridano.
In questa sezione ci occuperemo in particolare del SECONDO PERIODO
FILOSOFI e ARGOMENTI AFFRONTATI:
§ Guglielmo d’Auvergne
§ Enrico di Gand
§ San Bonaventura
§ Raimondo Lullo
§ Roberto Grossatesta
§ Ruggero Bacone
§ Roberto Kilwardby
§ Giovanni Peckham
§ Alberto Magno
§ Teodorico di Vriberg
§ Tommaso d’Aquino
§ Egidio Romano
§ Dal peripatismo all’averroismo (Sarashel, Guglielmo di Shyrewood, Lamberto D’Auxerre, Pietro Giuliani, Sigieri di Brabante, Boezio di Dacia)
§ Il bilancio del XIII
GUGLIELMO D’AUVERGNE
Lo sforzo per assimilare l’insegnamento delle filosofie ebraice ed arabe, compiuto degli intellettuali dei periodi precedenti, aveva mostrato chiaramente i rischio che correva la fede cristiana.
Ma nonostante ciò, l’ammonimento finale di papa Gregorio IX ai teologi di Parigi (1228) di insegnare una teologia scevra da ogni scienza del secolo , senza mescolanza di fantasie filosofiche, non poteva praticamente venire seguito in un ambiente scolastico in cui queste fantasie venivano di fatto insegnate dato che nulla poteva arrestare lo slancio degli studi filosofici, i teologi non videro di meglio da fare che prenderne la direzione.
Il nome che finora domina tutti gli altri all’inizio del XIII secolo è quello di Guglielmo d’Auvergne , nato verso il 1180 ad Aurillac, professore di teologia a Parigi, consacrato vescovo di Parigi da Gregorio IX nel 1228. Guglielmo muore nel 1249 lasciando un’opera teologica considerevole, vivace, originale e molto istruttiva sullo stato dei problemi a quell’epoca
OPERE:
De primo principio (1228),
De anima (1230)
De universo (1231-1236).
Egli esprime la reazione platonizzante e agostiniana dinanzi ad un mondo arabo che questo secolo non aveva conosciuto.
Guglielmo non scrive in funzione dell’insegnamento; infatti, il suo stile abituale è pertanto piuttosto quello di un conversatore che quello di un oratore .Vivace, spiritoso, talvolta sarcastico, gran narratore di racconti.
La sua opera si configura come la riflessione critica di un teologo della vecchia scuola sulle filosofie arabe che si erano appena scoperte e ha visto chiaramente che non si possono combattere con efficacia delle idee se non si conoscono e che, conseguentemente, si può trionfare della filosofia solo da filosofi.
Egli ha ben visto l’importanza di Avicenna e il maggior interesse che la sua distinzione di essenza ed esistenza offriva per un teologo cristiano.
Il termine essere (esse) ha due significati:
1. In primo luogo l’essenza o sostanza presa in se stessa e spogliata dei suoi accidenti;
2. ma esso significa anche ciò che il verbo est designa quando lo si predica di una qualunque.
La regola ha tuttavia un’eccezione, che è Dio.
“Colui la cui esistenza si predica della sua essenza; perché la sua essenza non può essere concepita senza l’esistenza, poiché essa stessa e il suo esistere sono assolutamente la stessa cosa.”.
Guglielmo imbocca, quindi, la via della distinzione di essenza e esistenza, che parte da al-Farabi e da Avicenna per raggiungere la sua conclusione nella metafisica di Tommaso d’Aquino.
Questo principio è anche alla base delle prove dell’esistenza di Dio nel suo De primo principio.
Ogni essere è tale, sia che la sua essenza includa o non includa l’esistenza. Ogni essere è dunque tale che esiste per se stesso o per altro.
Ora, è inconcepibile che esistano soltanto degli esseri che esistono per altro, perché ogni essere di questo tipo ha una causa della sua esistenza che deve essa stessa essere per sé .
Non resta quindi posto che per tre ipotesi:
1) ammettere che la serie degli esseri che esistono per altro è in effetti infinita, il che è inconcepibile per la ragione come lo stesso infinito, d’altra parte non spiega niente, perché ciò che si tratta propria di spiegare è l’esistenza di esseri che esistono per altro;
2) ammettere una serie circolare di esseri che si causano l’un l’altro, il che è assurdo perché allora si ammette che questi esseri si causano indirettamente da se stessi;
3) ancora ammettere l’esistenza di un essere che esiste per sé, che possiede l’esistenza per essenza e che è Dio.
Dio, come lo concepisce Guglielmo, è assolutamente semplice, proprio perché in lui l’esse non è separabile dall’essenza, né dalla realtà, né per il pensiero. Non è definibile.
L’unico nome che possa convenirgli è quello che egli stesso assume nell’Esodo, Qui est, cioè l’Essere. Ci si può chiedere quale preciso significato assuma qui la nozione di essere. Ciò a cui per Guglielmo sembra mirare è la“Necessità di essere” o necesse esse di Avicenna.
Guglielmo d’Auvergne vede chiaramente che questa distinzione è di una natura completamente diversa da quella di materia e forma; egli, infatti, non la concepisce soltanto come una distinzione ideale posta dalla sola ragione, ma come una distinzione reale, il che non è meno importante.
Dal momento in cui si va oltre, l’esistenza è una specie di accidente dell’essenza, da cui deriva questa seconda differenza fondamentale, che l’esistenza sembra comporsi con l’essenza come un quo est che si aggiungerebbe dall’esterno al quod est di cui sarebbe l’atto. Egli infatti intende che l’esse della creazione è una partecipazione dell’esse divino.
Esprimendosi così, egli si distingue esplicitamente da Avicenna, per il quale l’esistenza delle cose non è che partecipazione a qualche essere precedentemente emanato dal primo, ma egli unisce così direttamente a Dio l’essenza creata che la sua propria essenza si volatilizza, non essendo più la creatura che un’essenza il cui esistere si riduce tutto ad un semplice “esistere per Dio”. Beninteso, Dio è l’essere per il quale tutte le cose sono , e non ciò che esse sono.
Guglielmo paragona, poi, al rapporto dell’anima col corpo quello dell’esse divino con le essenze create. Ed è proprio per questo che l’esistenza degli esseri rimane loro in certo modo accidentale; poiché l’unica essenza suprema che è Dio, è l’unica esistenza per cui tutto esiste- il che non deroga in nulla alla diversità essenziale delle cose – si può dire dell’esistenza per la quale esse sono, che non è loro essenziale, ma come aggiunta in più.
Nella dottrina di Guglielmo, Dio presta l’esistenza piuttosto che darla, e la creatura sembra non averne nessun’altra che quella per la quale è, piuttosto che non è.
La volontà di Dio è eterna, ma libera, e le sue decisioni sono eterne, ma da questo non ne consegue che anche il loro effetto lo sia. Dio ha eternamente e liberamente voluto che il mondo incominciasse nel e col tempo. Creato dal nulla, il mondo lo fu dopo il nulla. Ma Guglielmo rovescia l’argomento: è vero che l’esistenza o la non esistenza del mondo non impedisce a Dio di restare identicamente se stesso; ora, Dio ha creato liberamente il mondo nel tempo, nulla quindi impedisce che il mondo creato acceda all’esistenza nel tempo senza che Dio stesso ne sia in alcun modo colpito. Le creature dunque dipendono da Dio non soltanto nella loro esistenza, ma nella loro natura e nelle loro operazioni.
La loro efficacia viene quindi dalla sovrabbondanza della loro origine. Indubbiamente le natura create sono tali da poter accogliere questa efficacia; bisogna che una casa abbia delle finestre se si vuole che possa accogliere la luce, ma chi sosterrà che una finestra abbia diritto alla luce? Nella distribuzione universale dell’efficacia divina, soltanto Dio è veramente causa; le creature non sono che dei canali in cui essa circola quando Dio lo vuole, come egli vuole, finchè gli piaccia di sospenderne il corso.
La cosmologia di Guglielmo, fortemente influenzata dal Timeo di Platone, dà un posto a quell’anima del mondo che aveva conquistato nel XII secolo moltissimi spiriti. Dopo aver respinto le intelligenze separate come sostanze creatrici interposte tra Dio e le cose, egli le elimina anche come semplici sostanze motrici. La concezione avicenniana di anime delle sfere, mosse esse stesse dal desiderio delle intelligenze, gli sembra impossibile ed anche ridicola: significa assegnare a queste sostanze intellegibili funzioni paragonabili a quelle di un asino attaccato alla ruota di un mulino. La prima preoccupazione di Guglielmo è, d’altronde, qui, di sopprimere gli intermediari accumulati da Avicenna tra l’anima umana e Dio, che deve essere il nostro solo principio e il nostro solo fine. L’anima è una sostanza spirituale assolutamente semplice, cioè assolutamente scevra da ogni composizione; ciò significa che essa è una e indivisa, qualunque siano le operazioni che essa compie.
Ed è ciò che Guglielmo esprime dicendo che, nell’anima umana come in Dio, l’essenza è la causa immediata delle sue operazioni conoscitive e volontarie, senza che nessuna facoltà distinta dall’anima s’interponga tra lei e le operazioni che compie.
Poiché l’anima è una e indivisibile, non si può, senza assurdità, attribuirle due intelletti distinti l’uno dall’altro e distinti da lei, l’intelletto possibile e l’intelletto agente. Se si vuole assolutamente parlare di un intelletto , bisogna dire in primo luogo che questo intelletto è l’essenza stessa dell’anima che esercita le sue funzioni conoscitive.
Se c’è una luce dell’anima che la rende capace di conoscere non può che essere Dio.
Per quanto riguarda il problema della conoscenza, Guglielmo sostiene che la causa attiva dell’idea generale non è altro che l’oggetto individuale percepito dai sensi, e l’operazione che trae l’universale dal particolare è l’astrazione.
Questa operazione si effettua in due tempi:
1) Il punto di partenza è la sensazione.
2) La sensazione lascia nell’immaginazione soltanto un’immagine astratta; infatti le nostre immagini sono tutte vaghe come percezioni di oggetti visti da lontano. Questa prima astrazione immaginativa è per l’anima come un’occasionedi ricevere le forme intelligibili che le vengono da un’altra causa.
Se dovessimo credere ad Aristotele e ad Avicenna, questa causa sarebbe una sostanza separata, ma, come dice Guglielmo:
“L’anima umana è naturalmente posta come sulla linea d’orizzonte di due mondi e ordinata ad entrambi. Uno di questi mondi è il mondo delle cose sensibili al qual essa è strettamente unita col suo corpo ma l’altro è il Creatore (….). E’ dunque il creatore che è la verità eterna, un eterno modello di espressione assolutamente limpida e di rappresentazione espressiva , in breve, lo specchio senza macchia purissimo dove tutto accadde. Questo specchio, come ho detto, è intimamente congiunto e presentissimo agli intelletti umani, davanti ai quali egli è posto naturalmente e dove essi possono leggere, senza intermediario. E’ dunque in lui, come in un libro vivente e in uno specchio che l’intelletto legge (…).”.
Questo significa ritornare ad Agostino
In un’anima quale la concepisce Guglielmo d’Auvergne, tutto viene dall’interno, in occasione degli stimoli che il corpo subisce dall’esterno, e sotto l’azione interna della luce divina.
Una dottrina del genere comporta concepire un universo già riempito di forme intelligibili, quasi direttamente percettibili dall’intelletto. Tale era, esattamente, quello di Guglielmo d’Auvergne. Le specie non sono in esso soltanto reali esse sono in esso la realtà stessa.
Per lui tutto si riduce ad una specie di intuizionismo dell’intellegibile che duplica quello del sensibile e che si spiega con l’illuminazione del mondo archetipo, ragione e modello dell’universo, di cui, per i cristiani, il vero nome è il Verbo, figlio di Dio e vero Dio.
ENRICO DI GAND
(?-1293)
Fu un maestro delle arti e poi di teologia all’Università di Parigi.
OPERE:
§ Quodlibeta
§ Summa teologica
Enrico parte dalla nozione di essere, ma poiché egli intende evitare il necessitarismo greco da cui s’ispira Avicenna, egli spiega fin dall’inizio l’ontologia del filosofo arabo in un senso cristiano. Invece di dividere l’essere in necessario e possibile, egli lo distingue analogicamente in:
1) “qualcosa che è l’essere stesso” :essere creato
2) “ciò che è qualcosa a cui l’essere conviene o può naturalmente convenire”: contiene ogni cosa creata, e la metafisica si costruirà partendo da questa due nozioni.
Enrico di Gand precisa che si può, se si vuole, dimostrare Dio partendo dal sensibile , ma che vi si giunge + facilmente e meglio partendo dall’idea dell’essere, perché allora basta constatare che, per uno dei suoi aspetti, l’essere si presenta come ciò di cui l’essenza è identica all’esistenza.
L’essere che non è che l’essere, ma che è tutto l’essere, può chiamarsi indifferentemente il Bene o il Vero, ma egli è tutto questo solo perché egli è ciò la cui essenza è tale che egli è di pieno diritto.
L’essere che è “qualcosa di cui conviene o può naturalmente convenire essere” comprende tutto ciò che rientra o può rientrare nelle categorie. Esso si distingue quindi immediatamente dall’essere divino.
Per garantire l’auspicata scissione tra l’essere per sé e gli esseri possibili, un filosofo cristiano dispone della nozione della creazione, ma se egli s’accosta partendo dalla nozione di essere, egli incontra in primo luogo,tra il creatore e le creature, le idee divine……..poiché esse sono le idee di Dio, esse non possono essere concepite come dotate di una sussistenza:esse non hanno dunque altro essere reale che l’essere di Dio. Pertanto, poiché l’idea rappresenta una creatura possibile, bisogna bene che, come oggetto della conoscenza, essa si distingua da Dio In quanto tale, l’essenza ideale ha un proprio essere che s’aggiunge a quello di Dio,ma se ne distingue come oggetto di conoscenza; è l’essere dell’essenza in quanto essenza, l’esse essentiae.
Enrico di Gand, attribuendo all’Idea un esse essentiae, lo fa diventare un ideato (ideatum).
Enrico di Gand non può accettare il modo in cui Avicenna spiega il passaggio all’esistenza dei mondi possibili così contenuti nell’intelletto divino. Il filosofo arabo ritiene che la volontà di Dio non possa non acconsentire alle generazioni intelligibili che emanano dal suo intelletto.
Per Enrico di Gand, la volontà di Dio acconsente liberamente a concedere l’esistenza ad alcuni possibili, e questo assenso è ciò che si chiama creazione.
Andando oltre, egli ritiene che, poiché le esistenze dipendono in primo luogo dalla volontà di Dio, l’intelletto divino nn le conosca che mediante quest’atto della volontà divina. In questo caso si può parlare di un certo volontarismo a condizione però di non dimenticare che l’atto creatore distingue dallo stesso essere divino soltanto nel nostro pensiero; la creazione comporta una realtà distinta soltanto nella creatura, e cioè la relazione dell’effetto finito con la causa divina da cui dipende.
Ciò che distingue la creatura dal creatore è il fatto che Dio è inseparabile dalla sua esistenza , mentre l’esistenza attuale della creatura dipende dalla libera volontà di Dio.
Per il fatto stesso che gli esseri finiti sono delle essenze esistenti, esse sono individuali. Ogni forma creata da un soggetto, la cui unità è sufficiente a distinguerlo da tutto il resto. Attualizzandolo, la creazione pone ogni essere come identico a se stesso e differente dagli altri; è questa identità positiva dell’essere con se stesso che Enrico di Gand esprime dicendo che l’inividuazione si definisce come una duplice negazione:quella che nega ogni differenza di questo essere nei riguardi di se stesso e quella che nega ogni identità di questo essere con uno diverso da lui.
Tra queste creature l’UOMO si definisce come l’unione di un corpo e di un’anima razionale.
Corpo: costituito dalla sua propria forma
Anima: è elevata al di sopra del corpo rimanendo quindi aperta alle influenze intelligibili.
L’anima quindi non informa direttamente il corpo, essas non è la forma corporeitatis; ci sono quindi nell’uomo due forme sostanziali , quella del corpo come tale e quella del composto umano.
Accettando la distinzione tra intelletto possibile e intelletto agente, Enrico spiega l’astrazione :ciò che l’astrazione ci fa raggiungere è si ciò che la cosa è, e poiché noi la raggiungiamo quale è, la conoscenza che ne abbiamo è fondata sul vero; ma essa non ci fa aggiungere l’essenza intelligibile della cosa.
Per pervenirvi non basta astrarre dal sensibile la nozione intelligibile dell’oggetto, bisogna anche definire l’essenza con un giudizio sicuro. Questo non si può fare che con una riflessione che parta, all’opposto del concreto sensibile, dalla nozione prima di essere, e prosegua sotto l’azione regolatrice della luce divina.
SAN BONAVENTURA
(Giovanni di Fidanza) nacque a Bognorea, vicino a Viterbo nel 1221 e muore il 15 luglio 1274.
Dal 1248 al 1255 insegna all’università di Parigi.
La prima condizione da rispettare, se si vuol studiare e capire San Bonaventura, è quella di considerare la sua opera in se stessa anzichè considerarla come un abbozzo di quella che San Tommaso realizzava contemporaneamente.
La dottrina di San Bonaventura è caratterizzata da uno spirito che le è proprio ed essa procede, per delle vie che ha scelto coscientemente, verso un fine perfettamente definito. Questo fine è L’AMORE DI DIO; e le vie che conducono ad esso sono quelle della teologia. La filosofia deve aiutarci a realizzare il nostro disegno, aderendo volontariamente alle dottrine dei maestri (Alessandro di Hales); Bonaventura non esiterà ad accogliere dalle nuove dottrine tutto ciò che gli permetterà di completare gli antichi.
OPERE
· Commento alle sentenze
· Itinerarium mentis in Deum (nel quale è sviluppata la sua dottrina)
L’anima umana è fatta per cogliere un giorno il bene infinito che è Dio, per riposarsi in lui e poter goderne. Di questo oggetto supremo verso cui tende, l’anima possiede fin da quaggiù una conoscenza imperfetta, ma molto sicura, che è la fede.
Il filosofo è meno sicuro di ciò che sa di quanto non lo sia il fedele di ciò che crede. E nondimeno è la stessa fede nella verità rivelata che è l’origine della speculazione filosofica. In effetti, laddove la ragione è sufficiente a determinare l’assenso, la fede non potrebbe trovare posto, perché noi possiamo apprenderlo razionalmente. Non è più dunque per ragione, ma per amore di questo oggetto che noi facciamo atto di fede.
Ed allora entra in gioco anche la speculazione filosofica. Colui che crede per amore vuole avere ragioni per la sua fede; niente è più dolce per l’uomo che capire ciò che ama; così la filosofia nasce da un bisogno del cuore che vuole gioire pienamente dell’oggetto della sua fede.
Questo vuol dire che filosofia e teologia, distinte per i loro metodi, si continuano e si contemplano l’una con l’altra, al punto di presentarsi come guide che ci conducono verso Dio.
Il fine ci è dato dalla fede, noi lo possediamo già, aderiamo ad esso con l’amore, ma con una presa incerta e con un’adesione spesso vacillante, perché ci manca la conoscenza chiara sulla quale si fonderebbe un amore immutabile
Tutta la nostra vita è un pellegrinaggio verso Dio; la strada che noi seguiamo, se siamo sulla buona via, è la VIA ILLUMINATIVA.
Colui che segue la via illuminativa, credendo e sforzandosi di capire ciò che crede, ritrova in ciascuna delle sue percezioni, e in ciascuno dei suoi atti di conoscenza, Dio stesso nascosto all’interno delle cose.
La dottrina di San Bonaventura si pone come un “itinerario dell’anima verso Dio”; ed è per questo che tutta la sua filosofia giunge a mostrare un universo in cui ciascun oggetto ci parla di Dio, ce lo rappresenta a suo modo e ci invita a volgerci verso di lui. Se la vita non è che un pellegrinaggio verso Dio, il sensibile è la strada che ci conduce a lui.
Prima del peccato originale l’uomo poteva gioire tranquillamente della contemplazione di Dio, e per questo Dio l’aveva posto in un paradiso di delizie. Ma dopo il peccato e per esso, l’uomo è colpito dall’ignoranza nello spirito e dalla concupiscenza nella carne.Ci occorre quindi ora uno sforzo constante della volontà e l’aiuto della grazia divina per risollevare verso Dio un viso che abbiamo rivolto verso terra.
Per giungere alla sapienza bisogna ottenere con la preghiera:
§ la grazia riformatrice
§ la giustizia purificatrice
§ la scienza illuminatrice
La grazia è il fondamento di una volontà retta e di una ragione chiaroveggente; dobbiamo quindi dapprima pregare, in seguito vivere santamente, essere finalmente attenti alle verità che si scopriranno, e, contemplandole, elevarci progressivamente fino alla sommità.
Dobbiamo dapprima combattere le conseguenze del peccato e rimettere i nostri mezzi conoscitivi in una condizione più simile che è possibile a quella in cui li abbiamo ricevuti. Allora soltanto la via illuminativa ci è aperta e il senso offuscato dell’universo torna ad esseri intelligibile.
Dio, creatore dell’universo, è LA VERITA’ ESSENZIALE , TRASCENDENTE. Dio non è vero in rapporto ad altro, poiché egli è l’essere totale e supremo; sono le cose che, invece, saranno vere in rapporto a lui.
La verità delle cose, paragonata al loro principi, consiste nel rappresentare, cioè nell’imitare la prima e suprema verità ;è questa la vera somiglianza tra le creature e il creatore che ci permetterà di sollevarci dalle cose sino a Dio. Non però che questa somiglianza implichi una partecipazione delle cose all’essenza di Dio, perché non c’è niente di comune tra Dio e le cose. E non può darsi nemmeno che questa somiglianza consista in una fedelissima imitazione di Dio, perché il finito non può imitare l’infinito.
LA SOMIGLIANZA REALE che esiste tra creatore e creature è una somiglianza di ESPRESSIONE ;le cose stanno a Dio come i segni al significato che essi esprimono; esse costituiscono quindi una specie di linguaggio , e l’universo non è che un libro nel quale si legge ovunque la trinità.
E se si chiede perché Dio ha creato il mondo su questo piano la risposta da dare sarebbe semplicissima: il mondo non ha altra ragione d’essere che quella di esprimere Dio, è un libro che è stato scritto soltanto per essere letto dall’uomo e per richiamarlo incessantemente all’amore del suo autore.
Tre tappe fondamentali segneranno i momenti di quest’ascesa:
I. ritrovare le vestigia di Dio nel mondo sensibile
II. ricercare la sua immagine nella nostra anima
III. supera le cose create e ci introduce nelle gioie mistiche della conoscenza e dell’adorazione di Dio
PRIMA TAPPA: Ritrovare Dio grazie alle vestigia che egli ha lasciato nelle cose significa “entrare nella vita di Dio” e significa anche ritrovare lungo la strada tutte le prove della sua esistenza.
San Bonaventura pensa che si possa dedurre l’esistenza di Dio partendo da qualunque cosa, di modo che, per uno spirito e un cuore purificati, ogni oggetto che ogni aspetto tradisce la presenza segreta del suo Creatore.
SECONDA TAPPA: Le prove attraverso il modo sensibile che egli, presentandocele, ci dà come acceccanti evidenze, sembrano a San Bonaventura solo degli esercizi mentali quando pensa alla prova più decisiva che ci offre quest’immagine di Dio che è la NOSTRA ANIMA.
Considerando il mondo sensibile noi possiamo in effetti ritrovarvi l’ombra di Dio perché tutte le proprietà della cose richiedono una causa: possiamo anche trovarvi le sue vestigia cercando nell’unità, la verità e la bontà che esse possiedono l’impronta della loro causa efficiente, formale e finale: ma, nell’un e nell’altro caso noi volgiamo le spalle, per così dire, alla luce divina di cui nelle cose cerchiamo solo dei riflessi. Cercando Dio nella nostra anima, invece, noi ci volgiamo verso Dio stesso; il che fa sì che noi troviamo in essa non più un’ombra o un vestigio, ma l’immagine stessa di Dio; è perché non ne è soltanto la causa ma anche l’oggetto.
Per definire pienamente una qualunque sostanza particolare, bisogna richiamarsi a principi sempre più elevati finchè si arriva all’idea di un essere i s è la presenza in noi dell’idea di perfetto e assoluto che ci permette di conoscere il particolare come imperfetto e relativo.
Noi troviamo direttamente Dio ogni volta che scendiamo abbastanza profondamente in noi stessi. Il nostro intelletto è congiunto alla stessa verità eterna; abbiamo in noi naturalmente infusa l’immagine di Dio: come noi conosciamo direttamente la nostra anima e le sue operazioni, così conosciamo Dio senza l’aiuto dei sensi esterni.
Se quindi l’esistenza di Dio sembrasse mancare di esistenza, questo non potrebbe essere che mancanza di riflessione da parte nostra .Noi conosciamo Dio perchè egli è già PRESENTE.
Se è la presenza di Dio che fonda la conoscenza che di lui abbiamo, è sottinteso che l’idea che noi abbiamo di Dio ne implica l’esistenza. Essa la implica precisamente perché l’impossibilità in cui noi ci troviamo di pensare che Dio non esista risulta immediatamente dalle necessità intrinseca della sua esistenza.E’ dunque la necessità di Dio stesso che, illuminando costantemente le nostra anima, rendere impossibile per noi pensare che Dio non esista, né di sostenerlo senza contraddizione.Poiché egli è l’essere puro e semplice, immutabile e necessario, è una sola e medesima cosa dire che Dio è Dio, o dire che egli esiste.Ciò che è inseparabile dal nostro pensiero ed impresso prontamente in esso è l’affermazione dell’esistenza di Dio, non assolutamente la comprensione della sua essenza.
TERZA TAPPA: Noi potremmo superare questa seconda tappa dell’itinerario dell’anima verso Dio e chiedere alla mistica la gioia inesprimibile della presenza divina; ma uscendo dall’esprimibile, usciremmo forse dalla filosofia. Qui, dice lo stesso San Bonaventura, bisogna concedere poco alla parola e alla penna, e concedere tutto al dono di DIO, cioè allo SPIRITO SANTO.
L’anima è essenzialmente una, ma le sue facoltà, o potenze, si diversificano secondo la natura degli oggetti ai quali essa si applica. Essa può farlo, perché essa stessa è contemporaneamente una sostanza intelligibile completa in sé, al punto che può sopravvivere alla morte di un corpo, e la forma del corpo organizzato che essa anima.
In quanto anima il corpo essa esercita la sue funzioni sensitive negli organi dei sensi. L’anima stessa subisce spiritualmente quest’azione in quanto proprio essa è animatrice del corpo, ma reagisce subito, dando un giudizio sull’azione che ha appena subito e questo giudizio è la CONOSCENZA SENSIBILE (dottrina che concepisce la sensazione come azione dell’anima )
Le immagini sensibili sono i dati da cui l’intelletto astrae la conoscenza intelligibile; l’astrazione è l’opera dell’intelletto possibile che, volgendosi verso queste immagini, esercita le operazioni necessarie per ritenere di questi dati soltanto il loro elemento comune e universale astrazione viene intesa come uno sforzo di attenzione, di scelta, di raggruppamento dei dati sensibili da parte della ragione. L’intelletto possibile è una facoltà attiva dell’intelletto che prepara le nozioni intelligibili e le accoglie in sé. Lo si chiama “possibile” perché da solo non sarebbe sufficiente a questo compito. Ogni anima umana possibile possiede, oltre al suo intelletto possibile, anche il suo intelletto agente, la cui funzione è quella di illuminare l’intelletto possibile e di renderlo capace di effettuare l’astrazione.
Come l’intelletto possibile non è privo di attualità, l’intelletto agente non p esente da ogni potenzialità ;ATTO PURO, esso sarebbe un’Intelligenza agente separata
Intelletto agente e intelletto possibile sono due funzioni distinte di una sola e medesima anima nel suo sforzo per assimilare ciò che il sensibile contiene di intelligibilità;lo sforzo di astrazione si impone soltanto quando il suo pensiero volge la sua faccia inferiore verso i corpi per acquisirne la scienza, non quando esso volge la sua “faccia superiore” verso l’intellegibile per acquisirne la sapienza.
Il ricorso alla conoscenza sensibile è necessario all’intelletto per conoscere tutto ciò che gli è estraneo (prodotti arti meccaniche e tutti gli oggetti naturali gli sono estranei). Tutto è diverso quando l’intelletto si volge verso l’anima , sempre presente a se stessa e verso Dio che ancor più gli è presente .Dal momento in cui noi andiamo al di là degli oggetti sensibili per elevarci alle verità intelligibili, facciamo appello ad una lice interiore che si esprime nei principi della scienza e della verità naturale innati all’uomo.
San Bonaventura tenta una sintesi di Aristotele e Platone
ARISTOTELE: ha saputo parlare il linguaggio della scienza e ha ben visto che non ogni conoscenza si elabora nel mondo delle idee
PLATONE: ha parlato il linguaggio della sapienza affermando le ragioni eterne e le idee
AGOSTINO: illuminato dallo Spirito Santo, ha saputo parlare di entrambi i linguaggi.
Se Sant’Agostino ha potuto realizzare questa sintesi, è grazie alla sua dottrina dell’illuminazione dell’intelletto da parte delle idee di Dio.
La dottrina di San Bonaventura consiste nello spiegare la presenza di verità necessarie nel pensiero umano con l’azione diretta e immediata delle idee divine sul nostro intelletto; ci si chiede come l’intelletto umano possa raggiungere una conoscenza certa.
Una conoscenza certa presenta due caratteri:
1) essa è immutabile quanto all’oggetto conosciuto
2) infallibile quanto al soggetto conoscente
Ora, né l’uomo è un soggetto infallibile, né gli oggetti che egli raggiunge sono immutabili. Se l’intelletto umano, quindi, possiede delle conoscenze sicure, è perché le idee divine stesse, che sono degli intelligibili immutabili, illuminano l’intelletto umano nella sua conoscenza degli oggetti corrispondenti.
Non ci si allontanerebbe tuttavia dalla verità dicendo che San Bonaventura spiega ogni vera conoscenza dell’intellegibile con l’azione e la presenza in noi di un raggio affievolito debole luce divina. Diciamo raggio affievolito perché San Bonaventura dichiara sempre che noi non raggiungiamo mai le ragioni eterne o idee quali esse sono in Dio, ma come loro riflesso.
Ma è sicuro d’altra parte che le idee divine, o ragioni eterne, sono proprio la regola immediata delle nostre conoscenze.
Se ogni conoscenza vera suppone che noi raggiungiamo le ragioni eterne, e se noi non raggiungiamo che confusamente queste ragioni eterne.
domanda: non ne segue che noi, quaggiù, non abbimo nessuna conoscenza veramente fondata?
Indubbiamente, risponde San Bonaventura, e bisogna convenire. Noi abbiamo quaggiù delle conoscenze certe e chiare perché i principi creati che Dio ha posto in noi e per i quali noi conosciamo le cose, ci appaiono chiaramente e senza veli. Ma questa conoscenza chiara e certa non è completa; le manca sempre il suo fondamento ultimo .
Perché questo duplice aspetto dell’anima della conoscenza?Perché l’uomo si trova posto in una situazione intermedia, senza dubbio infinitamente più vicino alle cose che a Dio, ma tuttavia tra Dio e le cose.
L’anima, centro posto tra i due estremi, si volge per la sua parte superiore a Dio e per la sua parte inferiore si volge verso le cose. Di ciò che è al di sotto di lei essa riceve una relativa certezza; da ciò che sta al di sopra di lei essa riceve una certezza assoluta.
Per quanto concerne la concezione del mondo, San Bonaventura crede che sia contraddittorio ammettere che il mondo sia esistito dall’eternità. Se l’universo continuasse ad esistere dopo un tempo infinito già trascorso, bisognerebbe ammettere che l’infinito può aumentare dato che dei giorni nuovi si aggiungono ai vecchi; o che di due numeri egualmente infiniti come quello delle rivoluzioni lunari e quello delle rivoluzioni solari, l’uno è dodici volte maggiore dell’altro; o che il mondo non ha avuto limite iniziale, e di conseguenza non ha avuto limite iniziale, e di conseguenza non ha potuto arrivare al limite attuale poiché la durata da trascorrere sarebbe stata infinita. Osserviamo infine che non potrebbe esistere simultaneamente un’infinità di oggetti o di individui.
Se ora consideriamo la struttura stessa della creazione constateremo dapprima che in tutte le cose create l’essenza è realmente distinta dall’esistenza; ciascuna di esse richiede l’efficacia del creatore.
Ma, inoltre, tutti gli esseri creati sono composti di materia e di forma, cioè semplicemente di possibile e di atto. In se stessa la materia non è necessariamente né corporea né materiale; essa diventa questo o quello soltanto secondo la forma che riceve. Se soltanto Dio è Atto puro, è necessario che in ogni essere finito il lato da cui viene limitata la sua attività lasci posto ad una certa possibilità di essere, ed è per questo che si chiama materia; così gli angeli e le anime umane sono composti di una MATERIA SPIRITUALE e della FORMA che la determina.
L’unione della materia e della forma, ecco il vero principio dell’individuazione. Ma combinando questa teoria dell’individuazione con quella della materia universale, otteniamo due nuove conseguenze:
1. non si sarà obbligati ad ammettere con San Tommaso che l’angelo, perché privo di materia, non può essere che una specie indivudale piuttosto che un vero individuo.
2. Non avremo nessuna difficoltà a spiegare la sopravvivenza dell’anima dopo la distruzione del corpo.
L’anima è già una forma completa per se stessa, composta della sua materia e della sua forma, indipendentemente dal corpo che a sua volta essa informerà. L’anima s’impadronisce del corpo già costituito e gli conferisce la sua perfezione, ma essa conserva la sua perfezione propria distaccandosene.
Due altre dottrine:
1. la tesi della PLURALITA’ DELLE FORME: ogni essere implica altrettante forme quante sono le diverse proprietà che egli possiede; in ogni cosa si scoprirà dunque una molteplicità di forme che si dispongono gerarchicamente in modo da costituire un’unità. Ciò è vero per i corpi più semplici ed anche per gli elementi. Un corpo, infatti, implica almeno sempre due forme differenti; l’una, che è generale e comune a tutti, è la forma della luce alla quale partecipano tutte le cose; l’altra, o altre, che gli sono particolari e che sono le forme dei misti, gli elementi.
2. CONCEZIONE STOICA DELLE RAGIONI SEMINALI: la materia, che per se stessa sarebbe completamente passiva, riceve immediatamente una determinazione virtuale dalle forme sostanziali che sono in è allo stato latente, aspettando che più tardi esse,sviluppandosi, la informino. Tutti i fenomeni e tutti gli esseri dell’universo si spiegano così con lo sviluppo delle forme di ragioni seminali primitive la cui origine è Dio.
RAIMONDO LULLO
(1235-1315)
Dalla sua “Disputatio clerici et Raymundi phantastici” la vita di Raimondo ci appare interamente dominata dalle preoccupazione apostoliche; dalle sue opere si arriva ben presto a figurarselo come una persona dotata di grande immaginazione e anche come illuminato, che crede di ricevere la sua dottrina da una rivelazione divina e che si applica, con ardore un po’ chimerico, alla diffusione di un metodo di apologetica di sua invenzione.
La famosa arte di Lullo non è altro che l’esposizione di questo METODO consiste in TAVOLE sulle quali sono scritti dei concetti fondamentali, in modo che , combinando le diverse posizioni possibili di queste tavole le une in rapporto alle altre, si possono ottenere meccanicamente tutte le relazioni di concetti corrispondenti alle verità essenziali della religione.
Occorre effettivamente un metodo, ma ne occorre uno solo, per convincere di errore musulmani e averroismi nell’uno e nell’altro caso ci si trova in presenza dello stesso problema perché si ha a che fare con dei pagani.
MUSSULMANI: negano la nostra rivelazione
AVERROISTI: rifiutano, per ragioni di principio, di prenderla in considerazione.
La filosofia (argomenta con la sola ragione) e la religione (argomenta in nome dei dati rivelati) si trovano separate da un abisso e bisogna riuscire a stabilire un accordo tra le due scienze.
La teologia è madre e maestra della filosofia ; deve esserci dunque tra la teologia e filosofia lo stesso accordo che si incontra tra causa ed effetto. Per rendere manifesta questa concordanza bisogna partire dai principi che siano riconosciuti ed accettati da tutti, ed è per questo che Raimondo propone la lista di quelli che compaiono nella tavola generale, principi generali e comuni a tutte le scienze, noti ed evidenti per sé.
Questi principi sono: bontà,grandezza,eternità o durata, potenza, sapienza, volontà, virtù, verità e gloria; differenza, concordanza, contrarietà, principio, mezzo, fine, maggiore, eguaglianza, minore. Tutti gli esseri o sono implicati in questi principi, o si sono sviluppati secondo la loro essenza e la loro natura. Raimondo Lullo aggiunge alla sua lista, ed è in questo il segreto della sua Ars magna , le regole che permettono di combinare correttamente questi principi: e tutte le combinazioni che le tavole di Lullo rendono possibili corrispondono esattamente a tutte le verità e a tutti i segreti della natura che l’intelletto umano può cogliere in questa vita.
Le regole che permettono di determinare le combinazioni dei principi sono una serie di domande molto generali ed applicabili a tutte le altre; di che cosa, perché, quanto, quale, quando, dove.
In un dialogo in cui vediamo Lullo convincere senza difficoltà un Socrate eccezionalmente docile, il filosofo greco si lascia imporre come naturalmente evidenti delle proposizioni da cui risulta immediatamente la dimostrazione della Trinità. Lullo considera come una regola dell’arte dell’invenzione questa, per cui l’intelligenza umana po’ elevarsi al di sopra delle constatazioni dei sensi ed anche correggerle. Socrate ammette volentieri che l’intelletto trascende i sensi e deve trascendere perfino se stesso riconoscendo l’esistenza necessaria delle cose che non comprende.
Questi arzigogoli sui quali Lullo inscrive i suoi concetti fondamentali sono il primo tentativo di quell’“Arte combinatoria” che Leibniz ha sognato, più tardi, di costituire. Come i tempi moderni hanno voluto fondare sulla sola ragione la società universale che il Medioevo stabiliva sul fondamento della fede, così essi hanno avuto l’ambizione di mettere al servizio della scienza quest’arte universale della dimostrazione che il pensiero medievale aveva voluto mettere al servizio della fede “Il mondo moderno è pieno di idee cristiane diventate matte”, diceva G.K. Chesterton.
L’influenza del Dottore Illuminato s’è esercitata d’altronde in altre direzioni. E’ un’antica idea cristiana quella per la quale Dio s’è manifestato in due libri, la Bibbia e il Libro del mondo .Nella traslucidità di un universo in cui il più piccolo degli esseri è un vivente indizio della presenza di Dio.
Per la stessa luce, egli seppe che l’essere totale delle creature non è nient’altro che una imitazione di Dio
L’ Ars magna è possibile solo nel caso che, essendo tutte le creature imitazioni di Dio, le loro proprietà fondamentali e le relazioni di queste proprietà tra loro possano aiutarci a conoscere quelle di Dio. Stando così le cose l’arte di combinare le perfezioni delle creature in tutti i modi possibili ci svelerà al tempo stesso tutte le combinazioni possibili delle perfezioni di Dio, ma bisogna aggiungere che, la conoscenza delle cose si trasforma in teologia.
L’influenza di Lullo è riconoscibile nell’opera di Raimondo di Sebond, Liber creaturarum terminato nel 1436. Come egli crede nel 1434, Sebond intraprende ad esporre “la scienza del libro delle creature”, che ogni cristiano deve possedere per poterla difendere e , all’occorrenza, per poter morire per essa. Il carattere distintivo di questa scienza è la sua facilità. Con essa, ognuno può conoscere “realmente e senza difficoltà né fatica ogni verità necessaria all’uomo”.
I due soli libri che Dio stesso ci ha dato sono, infatti, il libro della natura e quello della Sacra Scrittura.
· Il primo ci è stato dato prima dell’altro, al momento stesso della creazione: ogni creatura vi sta come una delle lettere scritte da Dio, di cui l’uomo è la principale.
· Il libro della Scrittura non è stato dato che in seguito, dopo che l’uomo fu inventato incapace di leggere il primo in conseguenza del peccato, e non è fatto per tutti, perché soltanto i sacerdoti sanno leggerlo, mentre il libro della natura è comune a tutti. Impossibile falsificare quest’ultimo, cancellarlo o interpretarlo male; per questo la sua lettura non può rendere nessuno eretico, mentre il libro della Scrittura può essere falsificato o falsamente interpretato. Opere dello stesso Autore, questi due libri non possono mai contraddirsi.
3. Da Roberto Grossatesta a Giovanni Peckham
Si ricorderà il brusco offuscamento delle scuole di Charters alla fine del XII secolo: esse scompaiono nella luce troppo vicina della nascente Università di Parigi. L’opera che esse avevano incominciato non finisce tuttavia con loro.
La cultura inglese dei XIII secolo, soprattutto ai suoi inizi e prima della sua contaminazione per l’influenza dell’ambiente scolastico di Parigi, assomiglia molto, invece, ad una cultura chartriana arricchita degli ultimi apporti del platonismo arabo in filosofia e in scienza.
In questa città si era formato un vero ambiente anglo-francese, umanista, platonico e matematico. E’ certo in ogni caso che Oxford, dove stanno per affluire le nuove scienze prese a prestito dagli Arabi, resterà lungamente fedele all’ideale che aveva ispirato Chartres.
Il primo rappresentante di queste varie tendenze è l’inglese Roberto Grossatesta uno dei più illustri maestri di Oxford, morto vescovo di Lincoln (1175-1253).
I Maestri di Oxford
Roberto Grossatesta è uno dei rari filosofi del suo tempo che abbiano saputo il greco. Gli si deve:
· l’antiqua translatio dell’Etica nicomachea;
· inoltre egli ha scritto un importante commento agli Analitici secondi;
· un commento della Fisica ancora inedito;
· delle traduzioni e commento di Dionigi l’Areopagita, ugualmente inediti;
· infine un’ampia compilazione sull’Hexaemeron, ugualmente inedito, in cui si trova abbozzata la dottrina della luce ch’egli ha sviluppato e precisato più tardi in parecchi opuscoli.
E’ sotto l’influenza del neoplatonismo e delle Prospettive (o trattati di Ottica) arabe, che Grossatesta è arrivato ad attribuire alla luce un ruolo capitale nella produzione e costituzione dell’universo; ma nel suo De luce seu de inchoatione formarum questa vecchia concezione raggiunge una piena coscienza di se stessa e si sviluppa in modo perfettamente conseguente.
All’inizio Dio crea dal nulla e simultaneamente la materia prima e la forma di questa materia
Basta supporre che Dio abbia dapprima creato un semplice punto materiale così informato. Questa forma è in effetti la luce; ora, la luce è una sostanza corporea molto sottile, che s’avvicina all’incorporea, e le cui proprietà caratteristiche sono di generare perpetuamente se stessa e di diffondersi sfericamente attorno ad un punto in modo istantaneo.
Questa diffusione della luce non può essere ostacolata che per due ragioni:
1. o essa incontrerà un ostacolo opaco che la ferma;
2. oppure essa finisce col raggiungere il limite estremo della sua possibile rarefazione e la sua propagazione per questo finisce.
Questa sostanza formale è anche il principio attivo di tutte le cose; essa è la prima forma corporea, che alcuni chiamavano corporeità.
La formazione del mondo = Originariamente, forma e materia luminosa, poiché si riducono entrambe ad un punto, sono egualmente in estese; ma noi sappiamo che darsi un punto di luce significa darsene simultaneamente una sfera; appena dunque esiste la luce, essa si diffonde istantaneamente, e, nella sua diffusione, trascina ed estende con sé la materia da cui è inseparabile.
Avevamo dunque ragione di dire che la luce è l’essenza stessa della corporeità,o, meglio ancora, la corporeità stessa.
Prima forma creata da Dio nella materia prima, essa si moltiplica infinitamente e si espande ugualmente in tutte le direzioni, dilatando fin dall’inizio dei tempi la materia alla quale essa è unita e costituendo così la massa dell’universo che contempliamo.
Il prodotto dell’infinita moltiplicazione di qualcosa supera infinitamente ciò che viene moltiplicato. Ora, se si parte dal semplice, basta una quantità finita per superarlo infinitamente.
La luce che è semplice, infinitamente moltiplicata, deve dunque estendere la materia, ugualmente semplice, secondo dimensioni di grandezza finita. Così si forma una sfera finita, la cui materia è al suo estremo limite di rarefazione ai bordi, più spessa e più densa, invece, via via che ci si avvicina al centro. Dopo questo primo movimento di espansione che fissa i limiti dell’universo, la materia centrale resta quindi capace di rarefarsi ancora . Per questo le sostanze corporee del mondo terrestre sono dotate di attività.
Il limite esterno della sfera costituisce il firmamento che a sua volta riflette una luce (lumen) verso il centro del mondo. E’ l’azione di questa luce riflessa (lumen) che genera successivamente le nove sfere celesti, la più bassa delle quali è quella della Luna. Al di sotto di quest’ultima sfera celeste inalterabile e immutabile, si dispongono in profondità le sfere degli elementi: fuoco, aria, acqua e terra. La terra quindi riceve e concentra in sé le azioni di tutte le sfere superiori; per questo i poeti la chiamano Pan. Cioè il Tutto.
Il merito principale di Roberto Grossatesta non è forse di aver immaginato questa cosmogonia della luce; bisogna lodarlo anche perché egli afferma la necessità di applicare la matematica alla fisica. E’ estremamente utile considerare le linee, gli angoli e le figure perché, senza il loro aiuto, è impossibile conoscere la filosofia naturale.
Per questo Grossatesta scrive il suo opuscolo De lineis, angulis et figuris. Egli vi definisce il modo normale di propagazione delle azioni naturali, che avviene in linea retta, sia direttamente, sia secondo le leggi della riflessione e della rifrazione. Quanto alle figure, le due che è indispensabile conoscere e studiare sono la sfera, perché la luce si moltiplica sfericamente, e la piramide, perché l’azione più potente che un corpo possa esercitare su di un altro è quella che parte da tutta la superficie dell’agente per concentrarsi su di un solo punto del paziente.
Una simile formula rende più facile da capire la profonda ammirazione che Ruggero Bacone ebbe per il suo maestro.
Grossatesta non ha limitato la sua ipotesi alla spiegazione del mondo materiale e del regno inorganico; egli l’ha estesa ai fenomeni della vita e all’ordine della conoscenza stessa.
E’ attraverso la luce che Dio agisce sul mondo, ora, l’uomo è come un piccolo mondo in cui l’anima occupa lo stesso posto che Dio occupa nel grande. E’ ancora con la luce, quindi, che l’anima agisce sui sensi e sull’intero corpo.
Grossatesta afferma che l’anima può agire sul corpo, ma che, dato che il meno nobile non può agire sul più nobile, il corpo non può agire sull’anima.
Il problema si pone a proposito della parte superiore dell’anima, l’intelligenza.
Per risolverlo Grossatesta, introduce la luce come intermediario tra questa sostanza puramente spirituale che è l’anima e la sostanza grossolanamente materiale che è il corpo.
Esiste una luce spirituale che sta alle cose intelligibili come la luce corporea sta alle cose sensibili. Conoscere una cosa significa conoscere la causa formale che è in lei, cioè la forma per la quale questa cosa è ciò che è. L’operazione con cui noi conosciamo questa forma è l’astrazione.
Per sua natura l’intelligenza , che è la parte superiore della nostra anima, non è l’atto del corpo e non ha bisogno di nessun organo corporeo per il suo operare. Se essa non fosse appesantita dalla massa del corpo, potrebbe conoscere le forme sensibili direttamente, come le conoscono Dio e gli angeli.
Grossatesta spiega successivamente come l’anima, intorpidita, per così dire, nel corpo, si desti poco a poco all’intellegibile sotto l’urto ripetuto delle sensazioni, analizzi la complessità degli oggetti, divida il colore dalla grandezza , dalla figura e dalla massa, poi la figura e la grandezza dalla massa, e così via, finché giunge così a conoscere la sostanza corporea che regge questi diversi accidenti. Se dobbiamo passare così attraverso le sensazioni, è perché la nostra anima, accecata dall’amore che ha per il suo corpo, non può vedere che ciò che ama.
Con Ruggero Bacone, discepolo e compatriota di Roberto Grossatesta, l’interesse rivolto alle ricerche e ai metodi scientifici non fa che accentuarsi. All’esigenza della matematica va ad aggiungersi quella, non meno imperiosa, della conoscenza sperimentale.
Nato verso il 1210-1214 nei dintorni di Ilchester, nel Dorsetshire .
Egli fece i suoi primi studi ad Oxford. A Parigi, dove fu oggetto di sospetti e di persecuzioni continue fino al momento in cui il suo protettore, Guido Fulcoldi, divenne papa sotto il nome di Clemente IV ( 1265). E’ durante la breve tregua che corrispose per lui a questo pontificato (1265-1268) che Ruggero Bacone redasse il suo Opus maius, composto su richiesta dello stesso papa. Nel 1292 compose il suo ultimo scritto, il Compendium studii theologiae. Ci è sconosciuta la data della sua morte.
Bacone è innanzitutto e in primo luogo uno scolastico, ma è un uomo che ha concepito la scolastica in maniera completamente diversa da Alberto Magno o san Tommaso d’Aquino.
Egli infatti non è sfuggito all’ossessione della teologia che caratterizza il Medioevo, e questo è un tratto che è importante sottolineare se non si vuole rappresentarsi Bacone sotto una luce completamente falsa.
La seconda parte dell’Opus maius è interamente dedicata a definire i rapporti tra filosofia e teologia. Ora, il suo atteggiamento su questo punto è perfettamente chiaro: c’è una sola sapienza perfetta e un’unica scienza che domina tutte le altre, è la teologia, e le due scienze sono indispensabili per spiegarla: il diritto canonico e la filosofia.
Due ragioni decisive provano infatti che la filosofia rientra nella teologia e ci si subordina.
1. la prima è che la filosofia è il risultato di una influenza dell’illuminazione divina nel nostro spirito. Senza confondersi con gli averroismi, che egli del resto confuta vigorosamente, Bacone usa una terminologia averroista. Egli dà il nome di intelletto agente al maestro interno che ci istruisce e che sant’Agostino e san Bonaventura chiamavano il Verbo. E’ quindi l’intelletto agente che agisce sulle nostre anime versandovi la virtù e la scienza in maniera tale che noi siamo incapaci di acquisirle da noi stessi e dobbiamo riceverle dall’esterno.
2. la filosofia è il risultato di una rivelazione. Non soltanto Dio ha illuminato gli spiriti umani per permettere loro di conseguire la sapienza, ma anche gliela ha rivelata.
Ecco dunque come Bacone s’immagina la storia della filosofia. Essa è stata dapprima rivelata ad Adamo ed ai Patriarchi, e se noi sappiamo ben interpretare la Scrittura, vedremo che essa si ritrova interamente, per quanto sotto una forma immaginosa e colorita,sotto al loro senso letterale. I filosofi pagani, i poeti dell’antichità e le Sibille sono tutti posteriori ai veri e fedeli filosofi che furono i discendenti di Set e di Noè.
Dio ha dunque rivelato loro tutto ed ha concesso loro una lunga vita (600 anni) per permettere loro di completare la filosofia per mezzo dell’esperienza. Ma successivamente la malizia degli uomini e i loro abusi di ogni genere divennero tali che Dio oscurò il loro cuore e la filosofia cadde in disuso. E’ l’epoca di Atlante, di Prometeo, di Mercurio, di Apollo e di altri che si facevano adorare come degli dei per la loro scienza. Bisogna arrivare ai tempi di Salomone per assistere ad una specie di rinascimento e vedere la filosofia ritrovare la sua prima perfezione. Dopo Salomone lo studio della sapienza scompare nuovamente a causa dei peccati degli uomini, finché lo riprende Talete e tutti i suoi successori lo sviluppano nuovamente. Si arriva così ad Aristotele che ha reso la filosofia tanto perfetta quanto poteva esserlo ai suoi tempi. I filosofi greci sono dunque i discepoli e i successori degli Ebrei; essi hanno trovato la rivelazione fatta da Dio ai patriarchi e ai profeti, rivelazione che non avrebbe avuto luogo se la filosofia non fosse stata conforme alla sua legge sacra, utile ai figli di Dio, infine necessaria all’intelligenza e alla difesa della fede.
“Così dunque la filosofia non è che la spiegazione della sapienza divina, con la dottrina e con la condotta morale.”.
Bacone non è solo un filosofo, è anche un profeta.
Il pensiero segreto che anima Bacone è che il XIII secolo è un’epoca di barbarie analoga alle due precedenti che l’umanità ha dovuto attraversare a causa dei suoi peccati. E come può egli quindi concepire la sua missione se non come analoga a quella di Salomone e di Aristotele?
Questa profonda coscienza di una missione da compiere, il sentimento che egli ha di venire ad inserirsi in un posto d’onore nella storia del mondo e del pensiero umano spiegano il tono altero ed aggressivo che egli spesso usa, il suo disprezzo degli avversari, il linguaggio da riformatore e restauratore con il quale egli si rivolge allo stesso papa; e infine anche l’ostilità impietosa che gli hanno votato i suoi superiori.
Si noterà, inoltre, che quest’uomo, per il quale la filosofia non è che una rivelazione ritrovata, pone la perfezione del sapere umano vicina alla creazione. E’ dunque un progresso all’indietro che egli invita a realizzare consigliandoci il suo metodo di filosofare.
Bacone riesce ad introdurre in questa straordinaria prospettiva storica una concezione profondissima del metodo scientifico.
I termini stessi in cui Bacone ci parla della rivelazione filosofica primitiva indicano ch’essa verteva semplicemente sui principi, giacché erano occorsi ancora seicento anni per sviluppare le conseguenze. Ma c’è di più. La filosofia non può mai arrivare ad essere veramente completa, e noi non avremo mai finito di spiegare i particolari del vasto mondo in cui ci troviamo posti.
La prima condizione per far progredire la filosofia è di sbarazzarla dagli ostacoli che ne fermano lo sviluppo.
Uno dei più funesti è la superstizione dell’autorità. Egli quindi la perseguita con i suoi sarcasmi senza risparmiare nessun uomo né alcun ordine religioso, nemmeno il suo.
Quando egli critica nell’Opus maius i setti difetti della teologia, le critiche si rivolgono al francescano Alessandro di Hales e al domenicano Alberto Magno:
1. L’uno è celebre per una Summa di mole ponderosa, e che d’altronde non è sua; ma egli non ha nemmeno conosciuto la fisica e la metafisica di Aristotele e la sua famosa Summa marcisce ora senza che nessuna la tocchi.
2. Quanto ad Alberto Magno, è un uomo che non è certo privo di meriti e che sa molte cose, ma non ha nessuna conoscenza delle lingue, della prospettiva né della scienza sperimentale.
Il difetto di Alberto, del suo discepolo Tommaso e di tanti altri è di voler insegnare prima di aver imparato.
Si ha da dire che Bacone non si riconosce dei veri maestri? I due che egli cita più volentieri sono Roberto Grossatesta e Pietro di Maricourt. Ora, Roberto Grossatesta gli piace in primo luogo perché, senza averli ignorati, si è distolto dai libri di Aristotele per istruirsi per mezzo di altri autori e della sua esperienza personale; poi perché egli ha saputo spiegare matematicamente le cause di tutti i fenomeni e mostrare che questa scienza è necessaria non solo a tutte le altre, ma anche alla teologia stessa.
Il suo vero maestro è colui ch’egli non finisce di elogiare, Pietro di Maricourt, autore di un trattato sulla calamita. Infatti, in quest’Epistola de magnete, egli afferma la necessità di completare il metodo matematico on il metodo sperimentale. Non basta saper calcolare e ragionare, bisogna anche essere abili manualmente.
Non si può sapere niente delle cose di questo mondo, sia celeste, sia terrestre, se non si sanno le matematiche.
“£Ci sono infatti due modi di conoscere, il ragionamento e l’esperienza. La teoria conclude e ci fa ammettere la conclusione, ma non dà quella sicurezza esente da dubbio in cui lo spirito si riposa nell’intuizione della verità, finché la conclusione non è stata trovata attraverso la via dell’esperienza.”
Se uno possiede una dimostrazione concludente in queste materie, ma non l’ha verificata con l’esperienza, la sua mente non vi si attaccherà, non vi si interesserà e trascurerà questa conclusione finché una constatazione sperimentale non gliene faccia vedere la verità. Soltanto allora accetterà questa conclusione in tutta tranquillità.
L’esperienza quale la concepisce Bacone è duplice.
1. l’una interna e spirituale, i cui gradi più alti ci conducono alla sommità della vita interiore e della mistica
2. l’altra esterna e che noi acquistiamo per mezzo dei sensi. E’ quest’ultima che è all’origine di tutte le nostre conoscenze scientifiche veramente certe e in particolare della più perfetta delle scienze, la scienza sperimentale.
La scienza sperimentale (scientia experimentalis) , il cui nome compare per la prima volta nella storia del pensiero umano sotto la penna di Bacone, supera tutti gli altri generi di conoscenza per una triplice prerogativa.
1. La prima è che, come abbiamo detto, essa genera una conoscenza completa.
2. La seconda prerogativa di questa scienza è che essa può determinarsi nel punto ove termina ciascuna delle altre scienze e dimostrare delle verità che esse sarebbero incapaci di raggiungere con i loro mezzi propri.
3. La terza prerogativa della scienza sperimentale non è relativa alle altre scienze, ma consiste nella potenza che permette loro di frugare i segreti della natura, di scoprire il passato, l’avvenire e di produrre tanti effetti meravigliosi da assicurare il potere a coloro che la possiederanno.
E’ quanto la chiesa dovrebbe prendere in considerazione per risparmiare il sangue cristiano in questa lotta contro gli infedeli, e soprattutto in previsione dei pericoli che ci minacceranno al tempo dell’Anticristo, pericoli ai quali sarebbe facile ovviare, con la grazia di Dio, se i principi del mondo e della chiesa favorissero lo studio della scienza sperimentale, e perseguissero i segreti della natura dell’anima.
L’Opus maius di Bacone non si presenterà quindi come un’esposizione della scienza totale, perché questa scienza non è acquisita, essa rimane da acquisire. Bacone pretende soltanto di invitare alla ricerca e soprattutto alla pratica delle esperienze.
Il carattere enciclopedico della sua opera principale in cui noi incontriamo successivamente l’analisi delle condizioni richieste per uno studio serio del linguaggio filosofico, un’esposizione del metodo matematico ed esempi della sua applicazione alle scienze sacre e profane, un trattato di geografia, un trattato sull’astrologia e le sue utilizzazioni, un trattato sulla visione, una descrizione del metodo sperimentale e una morale.
Ma, ancor più del contenuto stesso della sua dottrina, è lo spirito di cui essa è animata a conferirle l’interesse e a garantirle un posto duraturo nella storia delle idee.
La cattedra domenicana di teologia fu occupata dal 1248 al 1261 da Roberto Kilwardby, eletto arcivescovo di Canterbury nel 1272 morì a Viterbo nel 1279.
Si deve a Kilwardby:
· tutta una serie di commenti a Porfirio, all’Organon di Aristotele e alle seguenti opere: Fisica, De coelo et mundo, De generatione et corruptione, Meteore, De Anima, Metafisica;
· Commento alle Sentenze, sono ancora inedite e non sono state studiate che in modo insufficiente.
Kilwardby ha voluto conservare ad Oxford, con l’insegnamento e, in caso di necessità, con la sua autorità episcopale, la tradizione di sant’Agostino.
Il solo titolo del suo De ortu scientiarum (ricorda l’opera analoga di Gundissalino). E’ una classificazione delle scienze, ispirata a quella di Aristotele e sviluppata come introduzione generale alla filosofia dove, su alcuni punti, si lasciano già indovinare le sue posizioni personali; ma esse si affermano nel suo Commento alle Sentenze. Inoltre, si sono recentemente pubblicati o studiati parecchi scritti originali di Kilwardby: De spirito immaginativo, De tempore, De unitate formarum, De natura relationis, De conscientia, De theologia, dove Kilwardby parla a proprio nome.
Nella sua qualità di arcivescovo di Canterbury, Kilwardby condannava a sua volta una lista di sedici proposizioni nella speranza di arrestare il movimento avversario e la diffusione di teologie come quella di sant’Tommaso.
Le sedici proposizioni proibite da Kilwardby ci ragguagliano infatti sulle sue posizioni personali. La terza proibisce di insegnare ad Oxford “quod nulla potentia activa est in materia” (tr. il fatto che nella materia non v’è alcuna potenza attiva): ciò equivaleva ad imporre l’insegnamento di una dottrina della causalità analoga alle ragioni seminali di Agostino.
Nel suo Commento alle Sentenze, dove egli identificava la potenza attiva della causa seconda, che muove perché è mossa, con quella che si chiama “ratio seminalis, quia latet in materia” (tr. La ragione seminale per il fatto che è latente nella materia )
Come questa proibizione d’insegnare la dottrina aristotelica della materia colpiva tutta l’ontologia e tutta la fisica, così tutta l’antropologia e la psicologia erano colpite dalla dodicesima proposizione “quod vegetativa, sensitiva et intellectiva sint una forma simplex” (tr. Per il fatto che la vegetativa, la sensitiva, la razionale sono una forma semplice).
Il commento di Kilwardby alle Sentenze aveva già generalizzato questa tesi.
Composizione ilomorfica degli angeli, illuminazione divina richiesta come complemento della nostra luce intellettiva anche per la conoscenza del sensibile, semplice distinzione di ragione tra l’anima e le sue facoltà, sono altrettante note che dipendono dal complesso agostiniano.
Egli pone la forma come causa attiva e la materia come causa passiva dell’individuazione, ma questa gli sembra un fatto complesso che include la stessa individualità. Si deve dunque dire, dapprima materia e forma, poi determinazione della materia da parte della forma, infine l’individuo stesso che ne deriva e che è l’essere atto. La forma, egli precisa, s’individua lei stessa individuando la sua materia, e l’esistenza attuale sembra la proprietà dell’individuo così costituito.
Nel 1271, il ministro generale dei frati predicatori, Giovanni di Vercelli, mandò a Tommaso d’Aquino e a R.Kilwardby un elenco di 43 domande alle quali entrambi risposero, con uno spirito tuttavia molto diverso. Alla quarta domanda di Giovanni di Vercelli “E’ provato infallibilmente che gli angeli sono i motori dei corpi celesti?” :
· San Tommaso rispose che da un lato i Dottori cristiani insegnano che Dio governa le cose inferiori per mezzo delle cose superiori, e che d’altro lato, i filosofi platonici e peripatetici consideravano dimostrativa la loro prova che i corpi celesti sono stati animati e mossi dalle loro anime (Avicenna), sia, e ciò è preferibile, mossi da degli angeli (Averroé).
· Kilwardby, che si esprime con indulgenza sulla tesi avicenniana delle anime delle sfere, rifiuta invece l’idea che i corpi celesti siano mossi da degli spiriti angelici, che non ne sarebbero né l’atto né la forma. Kilwardby la dichiara priva di valore filosofico e constata che nessun Padre l’ha accettata come sicuramente vera.
La sua riposta aderisce più da vicino alla domanda di Giovanni di Vercelli, ma il fatto è che egli stesso preferiva alle due precedenti opinioni una terza, che egli tuttavia non presenta come personale. Un terzo gruppo ammette:
Che come i corpi pesanti e leggeri sono mossi dal loro peso e inclinazione (“propriis pondoribus et inclinationibus”) verso i luoghi dove s’arrestano, così i corpi celesti si muovono circolarmente nel luogo in virtù delle loro inclinazioni naturali, che sono come il loro peso, per conservare gli essere corruttibili e impedire loro di disfarsi rapidamente e di perire
In altri termini, qui non siamo ancora alle soglie della scienza moderna, perché Kilwardby non si occupa di meccanica, ma egli pone sicuramente il principio filosofico necessario perché secondo l’espressione di Duhem, “i movimenti celesti e i movimenti sublunari dipendano da una stessa meccanica”.
Successore di Kilwarby al seggio arciepiscopale di Canterbury fu Giovanni Peckham . Era un francescano. Il suo atteggiamento personale è chiaramente definito in una lettera del 1 giugno 1285 al vescovo di Lincoln.
“Noi non disapproviamo affatto gli studi filosofici, in quanto essi servono i misteri teologici, ma disapproviamo le novità profane di linguaggio, introdotte da vent’anni nella profondità della teologia contro le verità filosofiche e a detrimento dei Padri, le cui posizioni vengono disdegnate ed apertamente disprezzate. Quale dottrina è più solida e più sana, quella dei figli di san Francesco, cioè di fratello Alessandro (di Hales) , di santa memoria, di fratello Bonaventura e altri simili che si fondano sui Padri e sui filosofi in trattati esenti da ogni rimprovero, oppure questa dottrina del tutto recente e quasi tutta contraria, che riempie il mondo intero di dispute verbali,indebolendo e distruggendo con tutte le sue forze tutto ciò che sant’Agostino insegna sulle eterne norme e la luce immutabile, le facoltà dell’anima, le ragioni seminali incluse nella materia e su innumerevoli Questioni dello stesso genere, giudichino gli antichi, poiché in essi sta la sapienza, giudichi il Dio del cielo, e che vi ponga rimedio.”.
Si noterà inoltre che Peckham non disapprovava la filosofia, ma un certo uso indiscreto di una falsa filosofia; che, malgrado il caso contrario di Kilwardby, che egli aveva avuto sott’occhio, l’opposizione delle due dottrine si traduce concretamente per lui nell’opposizione dei due Ordini:
· l’agostinismo dei francescani;
· l’aristotelismo dei domenicani.
; infine che quando egli vuol citare qualcuno dei punti sui quali i due gruppi sono in contrasto, i primo tre che gli vengono in mente sono, nell’ordine in cui li cita:
1. la dottrina dell’illuminazione divina
2. l’unità reale delle potenze dell’anima con l’essenza dell’anima
3. le ragioni seminali
Problema = Si tratta innanzitutto di sapere se l’uomo possa o no fare a meno di Dio per conoscere il vero.
Per questo vediamo Peckham stesso esaminare attentamente questo problema nelle sue Questioni De anima. Egli concede ad ogni uomo un intelletto agente creato, ma aggiunge ad esso un intelletto agente superiore, che è Dio. La sua posizione dunque non è quella di Avicenna, per il quale l’intelletto agente unico della specie umana non è Dio ma un’intelligenza separata; essa non è nemmeno quella di Tommaso d’Aquino, per il quale Dio non è il nostro intelletto agente; ma se dovesse scegliere tra Avicenna e Tommaso d’Aquino, Peckham preferirebbe Avicenna.
In realtà, l’unico che abbia posto la verità, se non totale, almeno essenziale, è sant’Agostino, che nulla pare abbia potuto scacciare da Oxford fin verso gli ultimi anni del XIII secolo.
Ricordiamo che Peckham, fedele ai Padri, lo è anche alle scienze. La sua Perspectiva communis (Ottica), il suo Tractatus spherae, la Teorica planetorum e i Mathematicae rudimenta. Anche in questo egli continua la tradizione oxoniense di Ruggero Bacone e di Roberto Grossatesta. Sarebbe forse inesatto parlare di una scuola di Oxford nel Medioevo, ma vi fu sicuramente uno spirito di Oxford nel XIII secolo.
Alberto Magno
L’adozione del peripatetismo da parte dei teologi fu una vera rivoluzione nella storia del pensiero occidentale, e la più superficiale riflessione ci permettere di coglierne ancor oggi le conseguenze.
A partire dal XIII secolo, la solidarietà tra l’aristotelismo e il cristianesimo sarà tale, che la filosofia peripatetica sta, per così dire, per entrare a far parte della stabilità e dell’impero
FILOSOFIA MODERNA
INTELLETTO E RAGIONE DA CARTESIO A HEGEL
INTRODUZIONE
Non appena cerchiamo di esaminare il problema del rapporto tra intelletto e ragione nella filosofia moderna ci troviamo ad un bivio: possiamo infatti dire, in prima analisi, che tra intelletto e ragione non vi è alcuna differenza, cosicchè si tratta di due termini diversi che designano la medesima cosa; oppure possiamo sostenere che intelletto e ragione siano termini specifici che hanno contenuti concettuali diversi fra loro: in questo caso, si tratterà allora di stabilire quale tra i due (l’intelletto? la ragione?) debba avere la priorità sull’altro. Probabilmente, il massimo esponente del primo atteggiamento è stato Cartesio stesso, il quale ha – in sostanza – considerato l’intelletto e la ragione come espressioni generiche riferibili all’attività del pensiero: secondo questa prospettiva, non esiste un’ipotetica facoltà dell’intelletto e una della ragione, ma, al contrario, esiste solamente una più generale facoltà del pensare, la quale potrà essere ora appellata "ragione", ora "intelletto", ora "coscienza". In questo caso, l’unico elemento di specificità riconoscibile è che questa facoltà è esclusivamente umana, ed è anzi ciò che contraddistingue il nostro genere da quello animale: solo l’uomo, infatti, può esercitare il pensiero. Un’importante conseguenza derivante dall’identificazione di ragione e intelletto è l’impossibilità di distinguere nettamente la funzione conoscitiva da quella pratico/morale, poiché sarà la stessa facoltà del pensare che ora si applica all’ambito teoretico, ora a quello pratico. Questa posizione, sostenuta a gran voce da Cartesio – l’iniziatore dell’età moderna – sarà condivisa da Hobbes, da Locke e da Hume, mentre sarà Spinoza a distaccarsene e a lui si rifaranno gran parte delle posizioni successive fiorite nel Settecento e prevalse dalla fine dell’età dei Lumi in poi. Prima di addentrarci nelle problematiche dell’età moderna, sarà opportuno chiedersi dove sia storicamente nata l’idea della distinzione tra intelletto e ragione: non è possibile stabilire chi per primo l’abbia prospettata, ma, ciononostante, si può dire con certezza che ad Aristotele vada fatta risalire la sua formulazione più precisa. Secondo lo Stagirita, attraverso la ragione ( >dianoia) possiamo acquisire conoscenze impiegando i sillogismi, ossia quei ragionamenti concatenati strutturati in maniera tale che, partendo da due premesse, si pervenga ad una conclusione. Classico esempio di sillogismo è il seguente: " a) tutti gli animali sono mortali, b) tutti gli uomini sono animali, quindi tutti gli uomini sono mortali". Ciascuna delle premesse costituisce, a sua volta, la conclusione di un altro sillogismo, con l’assurda conseguenza che – risalendo la scala di sillogismo in sillogismo – si correrebbe il rischio di andare all’infinito. Ed è per scongiurare questo pericolo che Aristotele fa riferimento a premesse che non sono conclusioni di nessun altro sillogismo: tali sono, ad esempio, il principio di non contraddizione, il principio del terzo escluso, il principio di identità e il principio secondo cui il tutto è maggiore della parte. Tali premesse vengono da lui dette "princìpi" e, a differenza delle normali premesse (colte tramite il ragionamento discorsivo, >dianoia), possono essere intuitivamente colti dall’intelletto ( >nouV), il quale gode pertanto di una sua superiorità logica e assiologica. Questa distinzione operata da Aristotele tende sempre più ad affermarsi nella tradizione filosofica, soprattutto presso i Neoplatonici, ad avviso dei quali la realtà è – un po’ come la luce che emana dalla fiaccola – una emanazione processuale ( >prodoV) dall’Uno assoluto, il quale non contiene in sé alcuna determinazione specifica. Ma tra l’Uno e i molti quali appaiono ai nostri sensi c’è un elemento intermedio che, da un lato, ha già in sé la molteplicità (e ne è principio) e, dall’altro, coglie l’assoluta unità della molteplicità dell’Uno: tale elemento mediano è il >LogoV ("ragione"), che sta alla base dell’ordine dell’universo; ma tale >LogoV deve contenere anche la molteplicità dell’Uno e non può cogliere ciò attraverso la ragione (intesa come ragionamento discorsivo), bensì intuitivamente, mediante il >NouV ("intelletto"). Questa concezione influenzerà fortemente il cristianesimo originario, e non è un caso che il Vangelo di Giovanni si apra con l’enigmatica espressione "in principio era il >LogoV". La ragione non può cogliere l’unità delle cose, poiché il suo ufficio è di cogliere le divisioni, di mettere ordine: spetta invece all’intelletto afferrare intuitivamente l’unità che soggiace al molteplice. Proprio sulla scia di questa remota tradizione neoplatonica (la quale porta alle estreme conseguenze la concezione aristotelica), la filosofia moderna porrà al centro della propria riflessione la differenza tra le due facoltà: in particolare, Spinoza sarà dell’idea che l’uomo, attraverso l’intelletto, possa guardare la realtà "sub specie aeternitatis", così come la vede Dio, in maniera totalizzante e assoluta; la ragione, dal canto suo, può soltanto stabilire corrette connessioni causali, procedendo discorsivamente (il che per la scienza va benissimo), ma non potrà mai giungere alla comprensione unitaria del reale. Sarà invece l’intelletto – operante intuitivamente – a rivelarci che tutte quelle cause colte dalla ragione sono effetti di una causa infinita da cui tutto deriva: Dio. La superiorità dell’intelletto sulla ragione risiede, secondo Spinoza, nella capacità del primo di cogliere la realtà nella sua interezza attraverso un colpo d’occhio "intuitivo" (dal latino "intueor", "vedo"), pur senza smarrire le infinite differenze che la animano. La distinzione spinoziana ritorna in Kant, il quale tuttavia inverte il significato dei termini e il loro valore: sarà l’intelletto (Verstand) a procedere discorsivamente, cogliendo le realtà finite e inquadrandole attraverso le dodici categorie, mentre la ragione (Vernunft) avrà a che fare con le totalità. La differenza tra le due funzioni della nostra mente risiederà soprattutto nel fatto che, se l’attività dell’intelletto produce conoscenza autentica attraverso catene causali, passando dal condizionante al condizionato, la ragione procederà in maniera illegittima: essa scende in campo quando, dopo aver colto con l’intelletto le catene causali, si pensa di poter schizzar via dall’esperienza sensibile per cercare una causa incausata, un incondizionato totale. Se orientati all’acquisizione di nuove conoscenze, l’impiego dell’intelletto sarà legittimo, quello della ragione no, così come di fronte ad un puzzle infinito possiamo aggiungere sempre nuove tessere senza però mai completarlo. Ciò avviene perché si tratta, secondo Kant, di un’irrinunciabile esigenza della nostra mente. Si tratta – è evidente – di un capovolgimento della posizione spinoziana, alla quale si proporrà invece di ritornare l’idealismo tedesco (Schelling e Hegel soprattutto): mantenendo salda la distinzione kantiana tra intelletto come facoltà che conosce il finito e ragione come facoltà che conosce l’infinito, gli Idealisti sentiranno l’esigenza di tornare – spinozianamente – ad una conoscenza che abbia per oggetto l’infinito (l’ "Assoluto"), in netta rottura con l’illuminismo e con Kant.
CARTESIO
 Entrando in medias res per quel che riguarda la coincidenza di intelletto e ragione in Cartesio, egli nega ogni possibilità di distinzione tra i due sia nel "Discorso sul metodo", sia nei "Princìpi di filosofia", cosicchè – tenendo presente che i due scritti risalgono il primo alla "gioventù" e il secondo alla maturità – si può dire che la sua è una posizione che resta invariata per tutto il corso della vita. Il "Discorso sul metodo" è spesso stato considerato come il manifesto della modernità, ma a dire il vero è teoreticamente meno significativo rispetto alle "Meditazioni metafisiche" (in cui sono ripresi e ampliati i temi contenuti nel "Discorso"), che segnano una cesura definitiva e netta con il passato. Composte mentre infuriava la guerra dei "Trent’anni" (nel 1637), in esse Cartesio si propone di dare una definizione della "ragione", prendendo le mosse dal "buon senso", da lui identificato con il corretto esercizio del pensiero in generale. Di sfuggita, possiamo notare come l’espressione che in italiano significa "buon senso", in tedesco venga meglio tradotta con "Gesunder Verstand", che letteralmente significa "sano intelletto". Il "Discorso sul metodo" si apre con la constatazione che "il buon senso è fra le cose del mondo quella più equamente distribuita": ma che cosa dobbiamo intendere per "buon senso"? a) Secondo Cartesio, esso corrisponde al giudicare rettamente, al discernimento fra vero e falso (e non tra bene e male); b) naturalmente ciò implica che non possa sussistere una contrapposizione tra l’intelletto e la ragione o l’intuito. c) A sua volta, ne deriva una evidente universalità, poiché si tratta di potenzialità appartenenti a tutti: la differenza tra individuo ed individuo non è quantitativa o essenziale, ma, piuttosto, accidentale e differisce solamente per il corretto uso che se ne fa. Proprio questa insistenza sull’uso fa sì che la filosofia sia da Cartesio intesa come metodo: potenzialmente la ragione non ha limiti, le sue variazioni dipendono esclusivamente dall’uso. L’unico elemento di specificità di tali facoltà è il fatto che appartengono solo all’uomo, ma in lui si ritrovano nella loro interezza (e Cartesio fa poi una sorta di captatio benevolentiae verso gli Aristotelici). Il problema del metodo in Cartesio matura a partire dalla sua insoddisfazione nei riguardi dell’uso logico della ratio, sia quella di Aristotele sia quella di Raimondo Lullo (l’ "arte combinatoria"), due logiche marcatamente formalizzate e poggianti su base metafisica: non erano solo funzionalistiche, né rispecchiavano la realtà della mente umana (Vico e Port-Royal), bensì avevano criteri di procedura rigorosi ed erano lo specchio riflettente in maniera esatta l’ontologia del reale. Ma ciò non poteva coesistere con la dottrina cartesiana del buon senso: Cartesio, per questo motivo, faceva crollare ogni riferimento alla formalizzazione e il legame tra logica e metafisica, poiché il buon senso non ha regole fisse, non è la traduzione dell’ordine metafisico e, in questo senso, elimina la logica, rendendola non più necessaria (basta usare il buon senso con giusto metodo). Ma che cosa rifiuta, in sostanza, Cartesio? In primis, l’eredità aristotelica – impantanatasi nei dogmi – della metafisica e della logica formalizzate, fondata sulla formula " >ousia = sostanza = essenza", con riferimento all’esistenza e alla definizione, per cui >to ti esti ma anche >to ti eneinai. L’ >ousia individua e indica oltre l’essere anche l’essere-che-cosa. Secondo Aristotele, le sostanze sono individui, l’individuo è cioè sostanza prima che rinvia a concetti superiori: ciò significa che le sostanze prime sono tutte specie che si riferiscono ad un genere che (antiplatonicamente) non esiste nella realtà. I generi sono, a loro volta, sostanze seconde: si delinea, in tal senso, una scala gerarchica che risale fino a dieci generi sommi, ossia a dieci "categorie" (sostanza, quantità, qualità, relazione, luogo, tempo, situazione, avere, agire, subire) come modi dell’essere, al di sopra delle quali non c’è più nulla di generale. Infine, dalle specie alle categorie c’è una gerarchia di sostanze: l’uomo rientra nel genere "animale", ma occorre differenziarlo dalle altre specie che rientrano nel medesimo genere. Quindi troveremo il "genere prossimo" (animale) e la "differenza specifica" (tra uomo e cane, ad esempio) e in base a ciò otterremo la "definizione essenziale". Da qui derivano le inferenze aventi premesse giuste, cioè rispecchianti le definizioni essenziali, che attendono alla metafisica e al suo ordine. Se per Aristotele il sillogismo – avente nelle due premesse il termine medio e collegante specie e generi (come nella realtà metafisica) – , per Cartesio le cose stanno in altri termini, poiché egli non crede nella definizione essenziale, nell’identità tra logica e metafisica, nella loro presunta corrispondenza. Non c’è bisogno di introdurre specie e generi, basta il buon senso, il quale non è collocato "metafisicamente". E, respingendo il sillogismo come forma di conoscenza mediata, Cartesio privilegia in maniera netta la conoscenza immediata, facendo a meno del termine medio. Non ci sono più gerarchie, bensì si procede per singole identità: A=B=C=D (mentre per Aristotele era: A=B; B=C; A=C). La deduzione stessa non è un sillogismo, ma una semplice concatenazione, una serie di intuizioni. Il "metodo" a cui fa riferimento Cartesio è – come è noto – quello di tipo matematico: così Euclide, ad esempio, partiva da definizioni indimostrate e indimostrabili e su di esse faceva affermazioni (ad es. posto che un punto sia inesteso, vi passa una sola perpendicolare), affermazioni che – è facile capirlo – erano il frutto di passaggi immediati. In questo modo, Cartesio dà una veste scientifica al pensiero e si sbarazza della "mediatezza" (l’elemento formale della matematica è minimo). La logica aristotelica era riuscita a conoscere l’essere come esso era senza creazione; dal canto suo, la logica di Lullo era una logica inventiva e combinatoria, in cui – per composizione – si arrivava ai concetti primi, i più semplici; e a tali concetti si hanno simboli che sostituiscono le quantità algebriche. Si trattava di un processo di denotazione progressiva, in cui – operando sui simboli – si potevano combinare e creare relazioni che senza tale tecnica sarebbero rimaste invisibili. Questa logica lulliana è per Cartesio una chimera, una mera fantasia, anche se opposta a quella aristotelica, che ripeteva e ribadiva la realtà (Lullo la sostituiva denotandola con i "fuochi d’artificio"). Cartesio rifiuta quindi la formalizzazione: ma l’uso può esso stesso essere formalizzato? E poi: come oltrepassare la formalizzazione? Il rifiuto cartesiano del sillogismo aristotelico (inutile strumento che rende farraginosa la conoscenza che già ci dà il buon senso) e della logica di Lullo (eccessivamente fantasiosa), accomunati dalla struttura formalizzata e dal radicamento nella metafisica, induce Cartesio a percorrere strade alternative: il sillogismo spiega cose che già si sanno (perché attestate dal buon senso), l’arte di Lullo parla di cose "nuove" ma ne parla "senza senso", senza seguire alcun filo conduttore. Occorrerà pertanto definire un metodo della ragione e del buon senso che si discosti dalla tradizione, un metodo che non sia formalizzato e che non sia più una logica, ma una serie di regole che ciascuno trae dal proprio buon senso, il quale si rivela in maniera autoevidente. C’è una certa analogia con la logica di Port-Royal (di tipo mentalistico), che descrive il funzionamento della mente umana e non della realtà (come invece faceva Aristotele), secondo quattro regole fondamentali. Cartesio aveva già scritto le "Regulae ad diretionem ingenii" (del 1627, dieci anni prima del "Discorso sul metodo"), in cui aveva rinvenuto parecchie regole, impelagandosi però in sottigliezze troppo specifiche: ed è per questo che egli compone il "Discorso sul metodo", in cui ritiene di poter ridurre le regole a quattro. La prima prescrive di "non accettare mai nulla per vero, senza conoscerlo evidentemente come tale: cioè di evitare scrupolosamente la precipitazione e la prevenzione; e di non comprendere nei miei giudizi niente più di quanto si fosse presentato alla mia ragione tanto chiaramente e distintamente da non lasciarmi nessuna occasione di dubitarne". E’ la regola dell’evidenza, assume un principio dettato dal buon senso (e quindi non dimostrabile): la verità si manifesta apertamente nella coscienza, coincide con l’evidenza, la quale non si fonda, bensì si autofonda. Cartesio si serve di questo principio (che sarà l’arma fondamentale di tutto lo spiritualismo francese, il quale sosterrà che la coscienza è la fonte della verità – per Cartesio, invece, esistono ancora criteri per stabilire se una cosa è evidente oppure no) in senso epistemico, considerandolo valido per la conoscenza. E infatti introduce un criterio per distinguere ciò che è evidente da ciò che non lo è: sarà evidente ciò che è chiaro e distinto. Spinoza dice che noi conosciamo idee e Cartesio non la pensa poi così diversamente: un’idea è connotata dalle sue "notae", ossia dalle sue caratteristiche, cosicchè posso conoscere molte, poche, nessuna delle sue "notae". Se le conosco tutte, l’idea mi sarà chiara: così, l’idea di uomo mi sarà chiara quando saprò che è bipede, animale, dotato do occhi, di mani, di ragione, ecc. Quanto meno l’idea è chiara, ossia tante minori sono le "notae" di essa ch’io conosco, e tanto più è oscura. Oltre ad essere chiara, l’idea può tuttavia essere distinta: dirò che un’idea è per me distinta se di essa conosco solo quelle "notae" che le competono, senza mescolanze con qualità che riguardano altre idee. Poniamo che io abbia un’idea chiarissima di cosa è l’uomo, poiché conosco con chiarezza tutte le sue "notae", e in più dico che è alato: l’idea è chiara, ma non è distinta, poiché ci sono, sì, tutte le connotazioni che la distinguono, ma ce n’è una (l’essere alato) che è fuori luogo: ho un’idea chiara ma non distinta, o – se preferiamo – chiara e confusa. Questa prima regola è strettamente connessa al dubbio cartesiano: se devo accettare solo ciò che è chiaro e distinto, allora devo dubitare di tutto ciò che non è tale. La seconda regola prescrive invece di "dividere ogni problema preso in esame in tante parti quanto fosse possibile e richiesto per risolverlo più agevolmente" e la terza di "condurre ordinatamente i miei pensieri cominciando dalle cose più semplici e più facili a conoscersi, per salire a poco a poco, come per gradi, sino alla conoscenza delle più complesse; supponendo altresì un ordine tra quelle che non si precedono naturalmente l’un l’altra": per risolvere un problema, devo secondo Cartesio scomporlo in tanti problemini più semplici; così, quando ho concetti complessi, devo scomporli in concetti semplici e "imporre ai miei pensieri un ordine": può essere un ordine che costituisco io stesso, un ordine cioè che non rispecchi necessariamente il reale (come invece era per Aristotele). Infatti Cartesio dice anche, con orgoglio, che la sua interpretazione del mondo ci descrive un mondo "nuovissimo", ricostruito ex novo sulla base delle nostre esperienze conoscitive. Ma Cartesio, pur rifiutando la formalizzazione della logica, non intende rinunciare al rigore del metodo, tant’è che si rifà alla matematica. Ne consegue che, dietro a queste regole, sussiste un livello interpretativo più profondo, in particolare soggiacciono due modelli matematici diversi, due diversi indirizzi interpretativi risalenti al tempo dei Greci. Uno prediligeva l’analisi, l’altro la sintesi: il primo trova il suo eroe nel matematico Pappo (del III secolo), autore di una >Sunagogh (Collezione), tradotta in latino nel 1589 da Federico Commandino; Pappo distingue tra >analusiV ("resolutio") e >sunqhsiV ("compositio"), prediligendo nettamente la prima delle due (proprio come Cartesio) perché è assai più empirica e richiede una minima formalizzazione: non richiede cioè di partire da princìpi primi da cui far discendere ogni cosa, ma di considerare i singoli problemi concreti; e Pappo, a tal proposito, distingue tra "analisi dei problemi" e "analisi dei teoremi". Così, si prende il problema, lo si scompone in problemi più semplici, li si risolve uno ad uno, li si riunisce e si trova la soluzione del problema di partenza; lo stesso avviene coi teoremi. E’ vero che uso princìpi generali primi (di non contraddizione, di identità, ecc), ma opero empiricamente sul problema dato per scomporlo. L’altro modello (detto della sintesi) è invece quello di Euclide, che nega che si possa partire dal problema particolare: si deve invece sempre partire da princìpi e da problemi generali, che riguardano le determinazioni dei problemi: il punto è realtà inestesa, per un punto passano infinite rette; poi gli assiomi. Il senso di questa procedura è che la dimostrazione ha carattere discensionale: si parte da princìpi e si ricava il tutto; il problema non viene risolto scomponendolo in tanti problemini, e non è un caso che Euclide si presenti come un aristotelico (tutto deriva dalle dieci categorie). Ora, Cartesio, pur prediligendo il metodo dell’analisi di Pappo, non dice che il metodo sintetico di Euclide non vada bene: solo, gli rinfaccia di essere eccessivamente formalizzato e di funzionare solo quando il problema è stato già risolto. Cartesio precisa le sue posizioni in merito nelle "Risposte alle obiezioni alla Meditazioni Metafisiche": una di queste obiezioni suonava così: "perché non usi abbastanza il metodo sintetico?". Cartesio risponde che la matematica non procede solo con tale metodo euclideo, bensì anche con quello analitico di Pappo, che è un metodo incredibilmente più fecondo: lo sanno tutti, ma chi scrive di geometria non lo fa vedere. Dunque, il pensatore francese mette in luce come il metodo sintetico non vada respinto, ma come comunque sia inferiore a quello analitico, che è inventivo, mostra la vera via per la quale la verità è stata scoperta e fa vedere come gli effetti dipendono dalle cause. Se spieghiamo le cose col metodo analitico, che ce le ha fatte scoprire, non veniamo compresi: il metodo sintetico, invece, mostra per via diversa in maniera apodittica derivando le conseguenze dalle premesse: anche gli antichi geometri procedevano per analisi, ma poiché si tratta di un metodo non formalizzabile, esporrò gli stessi risultati seguendo l’altro metodo, che per spiegare è molto più efficace. Lo stesso Cartesio dimostra l’esistenza di Dio in maniera analitica, ma poi, quando si tratta di esporla ai suoi lettori, fa ricorso al metodo sintetico: questo è possibile, è evidente, solo se si è preventivamente ricorsi al metodo analitico, poiché tutte le teorie si fanno dopo. La sintesi funziona benissimo in geometria, dove si parte da poche definizioni: in filosofia, però, tutto è diverso e più difficile, soprattutto stabilire quali siano i princìpi primi da cui far scendere tutto. In altri termini, rispetto alla geometria, la filosofia è meno formalizzabile e dunque meno incline ad essere assoggettata al metodo sintetico euclideo; anche se, a dire il vero, Cartesio stesso scriverà una "Geometria" in cui farà esclusivamente uso del metodo analitico. Questo spiega la quarta regola, che prescrive di "fare in tutti i casi enumerazioni tanto perfette e rassegne tanto complete, da essere sicuro di non omettere nulla": inoltre giustifica anche quel senso di pochezza che proviamo leggendola dopo aver letto le tre che la precedono. Propone di rivedere – senza spiegare quale strategia sia opportuno seguire – il tutto per sincerarsi di non aver dimenticato nulla; perciò già Vico e Spinoza rimproveravano a Cartesio che il suo non era un metodo. Lo sviluppo del discorso cartesiano prende il via dalla prima regola, la verità come evidenza (chiarezza e distinzione): fino a che non ho evidenza, devo dubitare di tutto (comprese le procedure del mio ragionare): ma come fa, allora, il soggetto pensante a sottrarsi al dubbio? Perché è evidente, risponde Cartesio. Egli gioca la carta del dubbio metodico: gran parte delle credenze, su cui si fonda la conoscenza umana, è frutto di una tradizione la cui certezza – nota il filosofo francese – viene subito meno non appena si comincia a dubitare. La prima cosa che fa Cartesio è, appunto, mettere in dubbio ogni cosa, per vedere se qualche cosa si salva e, di conseguenza, risulta vera, evidente, tralasciando invece come falsa ogni realtà dubitabile. Il filosofo francese annuncia che l’evidenza non può essere sancita da determinate procedure formali, ma è invece qualcosa che o c’è o non c’è, un qualcosa che si autopone immediatamente. E a tal proposito egli procede gradualmente: il primo oggetto del dubbio è l’esperienza esterna, la quale è ambigua e segnata da errori (già gli antichi Scettici avevano messo in dubbio le attestazioni sensibili, ricorrendo all’esempio del remo immerso in acqua che appare spezzato). In questa maniera, si arriva a dubitare di tutto ciò che proviene da "idee avventizie", ovvero da quelle idee provenienti dall’esterno. Ma si potrebbe allora obiettare che si può, sì, dubitare dell’esperienza esterna, ma non di quella interna, a livello coscienziale, ossia di quelle verità che nascono da un ragionamento interno, non inficiato dall’insicurezza dell’esperienza (ad esempio le verità matematiche, del tipo 2 + 2 = 4). E qui Cartesio non vuole lasciar fuori nulla dal dubbio e perciò dubita perfino delle verità a noi interne, ipotizzando che la nostra mente possa essere congegnata in modo tale da funzionare male: essa potrebbe cioè essere costantemente ingannata se non da Dio, almeno da un genio maligno che si insinua nei nostri processi mentali e fa sì che ci sbagliamo clamorosamente perché il nostro stesso meccanismo di pensiero porta all’errore (magari in verità due più due non fa quattro, ma cinque). Infine, Cartesio ritiene possibile mettere in dubbio complessivamente la realtà del mondo: egli arriva pertanto ad ipotizzare che le cose stiano effettivamente come sembrano e che, radicalmente, esista per davvero un mondo. Quello che noi abitualmente chiamiamo mondo, infatti, potrebbe semplicemente essere il risultato di un sogno, poiché anche nei sogni ci sembra di vivere per davvero, ci pare cioè che il sogno sia realtà: chi può assicurarci, allora, che anche la realtà – quella che noi diciamo tale – non sia il frutto di un sogno? Evidentemente, non disponiamo di strumenti per distinguere ciò che è frutto del sogno da ciò che invece è frutto della veglia: in questa tesi cartesiana converge buona parte del pensiero del Seicento, pensiamo ad esempio alle tesi emerse in "La vita è sogno" di Calderòn de la Barca, dove si fa credere al giovane sovrano in prova che il suo regno è stato solo un sogno e si giunge alla paradossale conclusione – già in qualche misura presente in Pindaro e nell’Aiace sofocleo: "Cos’è la vita? Follia. Cos’è la vita? Un’illusione, un’ombra, una finzione, e anche il bene più grande ha poco valore, perché la vita è un sogno". Anche "La Tempesta" di Shakespeare è in qualche misura sullo sfondo delle riflessioni cartesiane: in quest’opera il protagonista, Prospero, arriva a dire che "siamo tutti della stoffa di cui sono fatti i sogni" ("We are such stuff as dreams are"). Esteso il dubbio ad ogni cosa, perfino al mondo (considerato alla stegua della realtà onirica) ve n’è una sola che si salva: ed è il fatto che io dubito; infatti, dubito di tutto fuorchè del fatto che io dubito e ciò significa che io penso e allora – lo si coglie in maniera immediata in quanto è autoevidente – che io esisto, esisto (almeno) come soggetto pensante. "Cogito, ergo sum": penso, dunque sono. Non posso, tuttavia, avere garanzia di esistere come corpo (giacchè il corpo può appartenere al mondo onirico). In questo modo, dovrò necessariamente ammettere l’eventualità della falsità dell’oggetto pensato, ma mai quella del soggetto pensante: la verità "penso, dunque sono" è una verità assolutamente salda, è la prima, grande ed unica evidenza che ottengo e che non può essere minimamente scalfita dal dubbio. In molti, però, hanno attaccato l’argomentazione cartesiana, facendo leva soprattutto sulla contraddittorietà dell’ "ergo": dicendo "penso, dunque sono" – si è obiettato – è come se Cartesio giungesse alla certezza di esistere attraverso un ragionamento (quasi un sillogismo: ciò che pensa esiste, io penso; dunque io esisto), un’inferenza di tipo stoico, quando Cartesio stesso ci ha invitati a dubitare delle nostre procedure mentali (le quali potrebbero essere manovrate da un genio maligno). Se devo dubitare delle mie facoltà mentali, allora dovrò anche dubitare della veridicità del "cogito, ergo sum", giacchè esso è il frutto di un ragionamento partorito dalla mia mente (ne è prova l’ "ergo"). La risposta fieramente addotta da Cartesio è che il suo non è affatto un ragionamento, tant’è che si potrebbe benissimo eliminare l’ "ergo" e limitarsi a dire: "penso, esisto"; è infatti nel fatto stesso di pensare che ho l’autoevidenza immediata di esistere (senza passare per ragionamento alcuno). Si tratta, allora, di un’autoevidenza che si realizza a livello coscienziale e non argomentativo. Lo stesso pensiero verrà da Cartesio concepito come autoriflessione coscienziale. Con il "cogito, ergo sum" viene dimostrata l’esistenza irremovibile di qualcuno che sogna: permane tuttavia il dubbio sul mondo esterno e su tutto il resto. Scrive Cartesio (nel "Discorso sul metodo", parte quarta): "conobbi che ero una sostanza la cui essenza o natura sta solo nel pensare e che per esistere non ha bisogno di alcun luogo né dipende da qualcosa di materiale". La certezza che ho di me riguarda esclusivamente il pensiero: se penso, è evidente che esisto come soggetto pensante, ma non è affatto evidente che esista un corpo e che esistano le cose che io penso. Perché esista una sostanza, a ben pensarci, non è necessario che esistano un corpo ed un mondo esterno: basta un soggetto pensante, e così Cartesio realizza un’identificazione della sostanza col pensiero che sta alla base del suo radicale dualismo metafisico. Risulta pertanto chiaro, fin da ora, che se esiste un corpo (e Cartesio dovrà successivamente dimostrarlo), esso sarà necessariamente separato dal pensiero (il quale esiste in maniera indipendente), sicchè avremo due mondi nettamente distinti ed eterogenei: il mondo del pensiero (libero e immateriale) e quello della materia (necessario e quantitativamente esteso). Tale dualismo è, al contempo, una forza (poiché sganciando il pensiero dalla materia si può affermare l’esistenza del pensiero stesso pur mantenendo il dubbio sulla materia) ma anche una debolezza (crea non pochi problemi per quel che riguarda l’influenza dell’uno sull’altro: come faccio io, soggetto pensante, ad agire sul mondo corporeo, e viceversa?). Che cosa sono io, di cui ora ho la certezza dell’esistenza, si domanda Cartesio nelle "Meditazioni metafisiche"? Posso essere sicuro di avere un corpo? Non posso dire di essere il mio corpo, poiché esso è soltanto oggetto della mia rappresentazione. Perciò Cartesio, tralasciando momentaneamente la questione del corpo, passa ad esaminare gli attributi dell’anima (termine col quale dobbiamo intendere il pensiero, ma anche il soggetto animale, dotato di vita): i primi elementi costitutivi di essa sono il nutrirsi e il camminare, ma neanche di tali attività posso per ora avere certezza, giacchè sono indisgiungibilmente legate a quel corpo sul quale permane il dubbio (come posso camminare se non facendo riferimento al corpo?). E il sentire? Ugualmente: non si può sentire senza il corpo, per cui cade anche su tale attività il dubbio. E poi anche nel sogno si sentono cose che, al risveglio, si rivelano fasulle. E il pensare? Esso – dice Cartesio – è indipendente dal corpo, e pertanto è "attributo che mi appartiene", esulante dal dubbio. Infatti, ch’io esista come pensiero è certo, ed è vero per tutto il tempo che penso: quando smetto di pensare, tale certezza cade, poiché potrebbe accadermi di cessare di esistere. "Non sono nulla se non una cosa pensante, e cioè uno spirito, un intelletto o una ragione, i quali sono termini sinonimi il cui significato m’era prima ignoto" (Meditazioni metafisiche"): con queste parole, Cartesio assimila l’intelletto, la ragione e il pensiero e ammette che finora non eravamo in grado di attribuire un significato certo a tali termini (solo ora che abbiamo spiegato il "cogito" possiamo definire il pensiero); il pensiero è l’atto di autocoscienza esistenziale con cui l’individuo riconosce di esistere in quanto cosa pensante. Si tratta, allora, di prendere coscienza della propria esistenza come cosa pensante, il che avviene appunto con il "cogito, ergo sum". Cartesio presenta la prima regola del metodo – quella dell’evidenza – come diretta conseguenza del dubbio metodico: è infatti dubitando di ogni cosa che egli ha raggiunto la certezza del "cogito" e l’ha tradotta in una regola (accettare solo l’evidente); in realtà, si può anche dire l’esatto contrario, ossia riconoscere che il metodo non è l’effetto ma la causa del "cogito", ammettendo che, poiché devo accettare solo l’evidente, sono pervenuto al "cogito", che è la cosa più evidente che ci sia. In sostanza, il dubbio metodico e la prima regola del metodo finiscono per coincidere, e hanno comune origine nel considerare la verità come autoevidenza: infatti, la verità si impone secondo Cartesio nella sua autoevidenza, e mancano criteri formali per distinguere il vero dal falso (l’unica soluzione consiste, appunto, nel far riferimento all’autoevidenza). Nella sua unica opera sistematica – i "Princìpi della filosofia" -, che è giustamente stata considerata come il punto d’arrivo della sua riflessione, Cartesio dà (nel paragrafo 9) una definizione del pensiero non troppo distante da quella formulata nel "Discorso sul metodo": "Con la parola pensiero io intendo tutto quel che accade in noi in modo tale che lo percepiamo immediatamente in noi stessi. Ecco perché non solo intendere, non solo volere, non solo ragionare, non solo immaginare, ma anche sentire è qui lo stesso che pensare"; così nelle "Meditazioni metafisiche" diceva che solo dopo aver spiegato il "cogito" si può capire che cosa sia il pensiero e passava al suo esame. Ora, nel passo riportato dei "Princìpi della filosofia", Cartesio considera il pensiero come attività generica nella quale rientrano la ragione, l’intelletto, il volere, l’immaginazione e perfino il sentire, il che risulta piuttosto strano, soprattutto se teniamo a mente che nelle "Meditazioni metafisiche", alla domanda "che cosa sono io?", egli rispondeva "sono una cosa che pensa" ed escludeva categoricamente il sentire in quanto funzione connessa al corpo. Ora invece, enigmaticamente, il sentire è riabilitato ed è a pieno titolo inserito tra le funzioni non del corpo ma dell’anima. Tutto si spiega se attribuiamo al verbo "sentire" due diversi significati, come fa appunto Cartesio: nelle "Meditazioni metafisiche" il sentire è inteso come l’entrare in contatto, mediante il corpo, con l’oggetto esterno, un sentire la realtà dell’oggetto esterno e del corpo che fa da tramite: per questo motivo, il sentire così inteso va respinto, poiché connesso direttamente con quel corpo su cui ancora pende il dubbio. Nei "Princìpi della filosofia", invece, Cartesio fa riferimento ad un’altra accezione di "sentire", in particolare allude al "sentire" inteso come capacità di rappresentarsi "idee avventizie" (cioè provenienti dall’esterno) senza far riferimento all’esistenza reale di tali idee all’esterno. In questo mondo che è un sogno, vedo l’albero, ma ciò non vuol dire ch’esso esista: posso solamente dire che esiste una rappresentazione (l’idea appunto) di tale albero, data come sensazione distinguentesi da altre rappresentazioni (si distingue da quelle della volontà – il voler costruire una casa -, da quelle dell’intelletto – 2+2=4 -, da quelle dell’immaginazione – il cavallo alato); il che significa che le rappresentazioni del mondo esterno hanno una loro specificità, si presentano come sensazioni, hanno in comune con tutte le altre di essere "oggetti interni del pensiero" – sono parole di Cartesio. Poiché pensare è sempre pensare qualche cosa, e siccome restiamo fedeli all’ipotesi del dubbio (il mondo come sogno), allora il pensato non corrisponde ad un oggetto esterno, ma è un mero pensato la cui verità non consiste nel corrispondere a qualcosa di reale, ma piuttosto nell’essere un pensato senza il quale è impossibile pensare, così come sono certo della mia esistenza sono anche certo delle idee che penso, certo della loro esistenza come prodotto del mio pensiero. Anche il sentire, dunque, fa parte del pensiero e non della sfera corporea. Successivamente, Cartesio, a partire dal "cogito, ergo sum", recupererà la certezza su tutto ciò che aveva gettato al dubbio: in particolare, gli basterà dimostrare l’esistenza di Dio per revocare il dubbio su ogni cosa; se infatti Dio esiste e ci crea (come Cartesio dimostrerà con una pluralità di argomentazioni), essendo Egli buono e perfetto, non potrà ingannarci, cosicchè saremo autorizzati a dire che due più due dà quattro, che il mondo esiste quale ci appare, e così via. Molti autori del Seicento condividono con Cartesio la concezione del pensiero senza distinzioni tra intelletto e ragione, pur con un’importante differenza rispetto al filosofo francese: una differenza che fa di questi autori dei veri e propri precursori e, in un certo senso, preparatori dell’Illuminismo (Voltaire vedrà in Cartesio l’anti-illuminista per eccellenza). Come è noto, Cartesio legge nel pensiero un’attività tipicamente umana, ma non intende per questo limitarlo e farne qualcosa di finito (quale è appunto l’uomo): sicchè, paradossalmente, l’uomo è un ente finito, ma il pensiero – che è la peculiarità umana – è infinito, non ha limiti, può conoscere ogni cosa. Viceversa, molti autori del Seicento, riconoscendo – sulle orme di Cartesio – nell’uomo una facoltà conoscitiva di tipo intuitivo in grado di cogliere i princìpi ultimi della realtà, riterranno che nell’uomo ci sia, sì, una facoltà conoscitiva simile a quella di Dio (che tutto conosce), che fa conoscere in maniera assoluta; ma, riconducendo il pensiero ad attività squisitamente umana, essi finiscono per leggere in esso qualcosa di finito, al pari dell’uomo: se è finito l’uomo, allora sarà finito anche il suo attributo più peculiare, che è appunto il pensiero. Qui sta la differenza rispetto a Cartesio: egli vede l’uomo come finito, ma il pensiero come infinito; viceversa, molti suoi contemporanei (e da qui prenderà le mosse l’Illuminismo) vedono sia nell’uomo sia nel pensiero qualcosa di finito e limitato. Per Cartesio, invece, il pensiero è onnipotente, non ha confini, può essere solo ridimensionato dal cattivo uso, ma se lo impieghiamo correttamente allora esso non ha limiti e l’uomo può conoscere tutto in maniera assoluta. E’ questa una discrasia che trae origine dal fatto che Cartesio non formalizza il pensiero: l’autoevidenza da lui ammessa può effettivamente conoscere ogni cosa, è sconfinata. Gli autori successivi, però, vedranno nel pensiero qualcosa di limitato, poiché limitato è colui che lo esercita. Questo sarà uno dei grandi portati dell’età illuministica, un portato che sarà tuttavia superato con l’Idealismo, che ritornerà ad una conoscenza di tipo assoluto, attuantesi attraverso un’intuizione capace di cogliere la realtà nei suoi princìpi ultimi.
Entrando in medias res per quel che riguarda la coincidenza di intelletto e ragione in Cartesio, egli nega ogni possibilità di distinzione tra i due sia nel "Discorso sul metodo", sia nei "Princìpi di filosofia", cosicchè – tenendo presente che i due scritti risalgono il primo alla "gioventù" e il secondo alla maturità – si può dire che la sua è una posizione che resta invariata per tutto il corso della vita. Il "Discorso sul metodo" è spesso stato considerato come il manifesto della modernità, ma a dire il vero è teoreticamente meno significativo rispetto alle "Meditazioni metafisiche" (in cui sono ripresi e ampliati i temi contenuti nel "Discorso"), che segnano una cesura definitiva e netta con il passato. Composte mentre infuriava la guerra dei "Trent’anni" (nel 1637), in esse Cartesio si propone di dare una definizione della "ragione", prendendo le mosse dal "buon senso", da lui identificato con il corretto esercizio del pensiero in generale. Di sfuggita, possiamo notare come l’espressione che in italiano significa "buon senso", in tedesco venga meglio tradotta con "Gesunder Verstand", che letteralmente significa "sano intelletto". Il "Discorso sul metodo" si apre con la constatazione che "il buon senso è fra le cose del mondo quella più equamente distribuita": ma che cosa dobbiamo intendere per "buon senso"? a) Secondo Cartesio, esso corrisponde al giudicare rettamente, al discernimento fra vero e falso (e non tra bene e male); b) naturalmente ciò implica che non possa sussistere una contrapposizione tra l’intelletto e la ragione o l’intuito. c) A sua volta, ne deriva una evidente universalità, poiché si tratta di potenzialità appartenenti a tutti: la differenza tra individuo ed individuo non è quantitativa o essenziale, ma, piuttosto, accidentale e differisce solamente per il corretto uso che se ne fa. Proprio questa insistenza sull’uso fa sì che la filosofia sia da Cartesio intesa come metodo: potenzialmente la ragione non ha limiti, le sue variazioni dipendono esclusivamente dall’uso. L’unico elemento di specificità di tali facoltà è il fatto che appartengono solo all’uomo, ma in lui si ritrovano nella loro interezza (e Cartesio fa poi una sorta di captatio benevolentiae verso gli Aristotelici). Il problema del metodo in Cartesio matura a partire dalla sua insoddisfazione nei riguardi dell’uso logico della ratio, sia quella di Aristotele sia quella di Raimondo Lullo (l’ "arte combinatoria"), due logiche marcatamente formalizzate e poggianti su base metafisica: non erano solo funzionalistiche, né rispecchiavano la realtà della mente umana (Vico e Port-Royal), bensì avevano criteri di procedura rigorosi ed erano lo specchio riflettente in maniera esatta l’ontologia del reale. Ma ciò non poteva coesistere con la dottrina cartesiana del buon senso: Cartesio, per questo motivo, faceva crollare ogni riferimento alla formalizzazione e il legame tra logica e metafisica, poiché il buon senso non ha regole fisse, non è la traduzione dell’ordine metafisico e, in questo senso, elimina la logica, rendendola non più necessaria (basta usare il buon senso con giusto metodo). Ma che cosa rifiuta, in sostanza, Cartesio? In primis, l’eredità aristotelica – impantanatasi nei dogmi – della metafisica e della logica formalizzate, fondata sulla formula " >ousia = sostanza = essenza", con riferimento all’esistenza e alla definizione, per cui >to ti esti ma anche >to ti eneinai. L’ >ousia individua e indica oltre l’essere anche l’essere-che-cosa. Secondo Aristotele, le sostanze sono individui, l’individuo è cioè sostanza prima che rinvia a concetti superiori: ciò significa che le sostanze prime sono tutte specie che si riferiscono ad un genere che (antiplatonicamente) non esiste nella realtà. I generi sono, a loro volta, sostanze seconde: si delinea, in tal senso, una scala gerarchica che risale fino a dieci generi sommi, ossia a dieci "categorie" (sostanza, quantità, qualità, relazione, luogo, tempo, situazione, avere, agire, subire) come modi dell’essere, al di sopra delle quali non c’è più nulla di generale. Infine, dalle specie alle categorie c’è una gerarchia di sostanze: l’uomo rientra nel genere "animale", ma occorre differenziarlo dalle altre specie che rientrano nel medesimo genere. Quindi troveremo il "genere prossimo" (animale) e la "differenza specifica" (tra uomo e cane, ad esempio) e in base a ciò otterremo la "definizione essenziale". Da qui derivano le inferenze aventi premesse giuste, cioè rispecchianti le definizioni essenziali, che attendono alla metafisica e al suo ordine. Se per Aristotele il sillogismo – avente nelle due premesse il termine medio e collegante specie e generi (come nella realtà metafisica) – , per Cartesio le cose stanno in altri termini, poiché egli non crede nella definizione essenziale, nell’identità tra logica e metafisica, nella loro presunta corrispondenza. Non c’è bisogno di introdurre specie e generi, basta il buon senso, il quale non è collocato "metafisicamente". E, respingendo il sillogismo come forma di conoscenza mediata, Cartesio privilegia in maniera netta la conoscenza immediata, facendo a meno del termine medio. Non ci sono più gerarchie, bensì si procede per singole identità: A=B=C=D (mentre per Aristotele era: A=B; B=C; A=C). La deduzione stessa non è un sillogismo, ma una semplice concatenazione, una serie di intuizioni. Il "metodo" a cui fa riferimento Cartesio è – come è noto – quello di tipo matematico: così Euclide, ad esempio, partiva da definizioni indimostrate e indimostrabili e su di esse faceva affermazioni (ad es. posto che un punto sia inesteso, vi passa una sola perpendicolare), affermazioni che – è facile capirlo – erano il frutto di passaggi immediati. In questo modo, Cartesio dà una veste scientifica al pensiero e si sbarazza della "mediatezza" (l’elemento formale della matematica è minimo). La logica aristotelica era riuscita a conoscere l’essere come esso era senza creazione; dal canto suo, la logica di Lullo era una logica inventiva e combinatoria, in cui – per composizione – si arrivava ai concetti primi, i più semplici; e a tali concetti si hanno simboli che sostituiscono le quantità algebriche. Si trattava di un processo di denotazione progressiva, in cui – operando sui simboli – si potevano combinare e creare relazioni che senza tale tecnica sarebbero rimaste invisibili. Questa logica lulliana è per Cartesio una chimera, una mera fantasia, anche se opposta a quella aristotelica, che ripeteva e ribadiva la realtà (Lullo la sostituiva denotandola con i "fuochi d’artificio"). Cartesio rifiuta quindi la formalizzazione: ma l’uso può esso stesso essere formalizzato? E poi: come oltrepassare la formalizzazione? Il rifiuto cartesiano del sillogismo aristotelico (inutile strumento che rende farraginosa la conoscenza che già ci dà il buon senso) e della logica di Lullo (eccessivamente fantasiosa), accomunati dalla struttura formalizzata e dal radicamento nella metafisica, induce Cartesio a percorrere strade alternative: il sillogismo spiega cose che già si sanno (perché attestate dal buon senso), l’arte di Lullo parla di cose "nuove" ma ne parla "senza senso", senza seguire alcun filo conduttore. Occorrerà pertanto definire un metodo della ragione e del buon senso che si discosti dalla tradizione, un metodo che non sia formalizzato e che non sia più una logica, ma una serie di regole che ciascuno trae dal proprio buon senso, il quale si rivela in maniera autoevidente. C’è una certa analogia con la logica di Port-Royal (di tipo mentalistico), che descrive il funzionamento della mente umana e non della realtà (come invece faceva Aristotele), secondo quattro regole fondamentali. Cartesio aveva già scritto le "Regulae ad diretionem ingenii" (del 1627, dieci anni prima del "Discorso sul metodo"), in cui aveva rinvenuto parecchie regole, impelagandosi però in sottigliezze troppo specifiche: ed è per questo che egli compone il "Discorso sul metodo", in cui ritiene di poter ridurre le regole a quattro. La prima prescrive di "non accettare mai nulla per vero, senza conoscerlo evidentemente come tale: cioè di evitare scrupolosamente la precipitazione e la prevenzione; e di non comprendere nei miei giudizi niente più di quanto si fosse presentato alla mia ragione tanto chiaramente e distintamente da non lasciarmi nessuna occasione di dubitarne". E’ la regola dell’evidenza, assume un principio dettato dal buon senso (e quindi non dimostrabile): la verità si manifesta apertamente nella coscienza, coincide con l’evidenza, la quale non si fonda, bensì si autofonda. Cartesio si serve di questo principio (che sarà l’arma fondamentale di tutto lo spiritualismo francese, il quale sosterrà che la coscienza è la fonte della verità – per Cartesio, invece, esistono ancora criteri per stabilire se una cosa è evidente oppure no) in senso epistemico, considerandolo valido per la conoscenza. E infatti introduce un criterio per distinguere ciò che è evidente da ciò che non lo è: sarà evidente ciò che è chiaro e distinto. Spinoza dice che noi conosciamo idee e Cartesio non la pensa poi così diversamente: un’idea è connotata dalle sue "notae", ossia dalle sue caratteristiche, cosicchè posso conoscere molte, poche, nessuna delle sue "notae". Se le conosco tutte, l’idea mi sarà chiara: così, l’idea di uomo mi sarà chiara quando saprò che è bipede, animale, dotato do occhi, di mani, di ragione, ecc. Quanto meno l’idea è chiara, ossia tante minori sono le "notae" di essa ch’io conosco, e tanto più è oscura. Oltre ad essere chiara, l’idea può tuttavia essere distinta: dirò che un’idea è per me distinta se di essa conosco solo quelle "notae" che le competono, senza mescolanze con qualità che riguardano altre idee. Poniamo che io abbia un’idea chiarissima di cosa è l’uomo, poiché conosco con chiarezza tutte le sue "notae", e in più dico che è alato: l’idea è chiara, ma non è distinta, poiché ci sono, sì, tutte le connotazioni che la distinguono, ma ce n’è una (l’essere alato) che è fuori luogo: ho un’idea chiara ma non distinta, o – se preferiamo – chiara e confusa. Questa prima regola è strettamente connessa al dubbio cartesiano: se devo accettare solo ciò che è chiaro e distinto, allora devo dubitare di tutto ciò che non è tale. La seconda regola prescrive invece di "dividere ogni problema preso in esame in tante parti quanto fosse possibile e richiesto per risolverlo più agevolmente" e la terza di "condurre ordinatamente i miei pensieri cominciando dalle cose più semplici e più facili a conoscersi, per salire a poco a poco, come per gradi, sino alla conoscenza delle più complesse; supponendo altresì un ordine tra quelle che non si precedono naturalmente l’un l’altra": per risolvere un problema, devo secondo Cartesio scomporlo in tanti problemini più semplici; così, quando ho concetti complessi, devo scomporli in concetti semplici e "imporre ai miei pensieri un ordine": può essere un ordine che costituisco io stesso, un ordine cioè che non rispecchi necessariamente il reale (come invece era per Aristotele). Infatti Cartesio dice anche, con orgoglio, che la sua interpretazione del mondo ci descrive un mondo "nuovissimo", ricostruito ex novo sulla base delle nostre esperienze conoscitive. Ma Cartesio, pur rifiutando la formalizzazione della logica, non intende rinunciare al rigore del metodo, tant’è che si rifà alla matematica. Ne consegue che, dietro a queste regole, sussiste un livello interpretativo più profondo, in particolare soggiacciono due modelli matematici diversi, due diversi indirizzi interpretativi risalenti al tempo dei Greci. Uno prediligeva l’analisi, l’altro la sintesi: il primo trova il suo eroe nel matematico Pappo (del III secolo), autore di una >Sunagogh (Collezione), tradotta in latino nel 1589 da Federico Commandino; Pappo distingue tra >analusiV ("resolutio") e >sunqhsiV ("compositio"), prediligendo nettamente la prima delle due (proprio come Cartesio) perché è assai più empirica e richiede una minima formalizzazione: non richiede cioè di partire da princìpi primi da cui far discendere ogni cosa, ma di considerare i singoli problemi concreti; e Pappo, a tal proposito, distingue tra "analisi dei problemi" e "analisi dei teoremi". Così, si prende il problema, lo si scompone in problemi più semplici, li si risolve uno ad uno, li si riunisce e si trova la soluzione del problema di partenza; lo stesso avviene coi teoremi. E’ vero che uso princìpi generali primi (di non contraddizione, di identità, ecc), ma opero empiricamente sul problema dato per scomporlo. L’altro modello (detto della sintesi) è invece quello di Euclide, che nega che si possa partire dal problema particolare: si deve invece sempre partire da princìpi e da problemi generali, che riguardano le determinazioni dei problemi: il punto è realtà inestesa, per un punto passano infinite rette; poi gli assiomi. Il senso di questa procedura è che la dimostrazione ha carattere discensionale: si parte da princìpi e si ricava il tutto; il problema non viene risolto scomponendolo in tanti problemini, e non è un caso che Euclide si presenti come un aristotelico (tutto deriva dalle dieci categorie). Ora, Cartesio, pur prediligendo il metodo dell’analisi di Pappo, non dice che il metodo sintetico di Euclide non vada bene: solo, gli rinfaccia di essere eccessivamente formalizzato e di funzionare solo quando il problema è stato già risolto. Cartesio precisa le sue posizioni in merito nelle "Risposte alle obiezioni alla Meditazioni Metafisiche": una di queste obiezioni suonava così: "perché non usi abbastanza il metodo sintetico?". Cartesio risponde che la matematica non procede solo con tale metodo euclideo, bensì anche con quello analitico di Pappo, che è un metodo incredibilmente più fecondo: lo sanno tutti, ma chi scrive di geometria non lo fa vedere. Dunque, il pensatore francese mette in luce come il metodo sintetico non vada respinto, ma come comunque sia inferiore a quello analitico, che è inventivo, mostra la vera via per la quale la verità è stata scoperta e fa vedere come gli effetti dipendono dalle cause. Se spieghiamo le cose col metodo analitico, che ce le ha fatte scoprire, non veniamo compresi: il metodo sintetico, invece, mostra per via diversa in maniera apodittica derivando le conseguenze dalle premesse: anche gli antichi geometri procedevano per analisi, ma poiché si tratta di un metodo non formalizzabile, esporrò gli stessi risultati seguendo l’altro metodo, che per spiegare è molto più efficace. Lo stesso Cartesio dimostra l’esistenza di Dio in maniera analitica, ma poi, quando si tratta di esporla ai suoi lettori, fa ricorso al metodo sintetico: questo è possibile, è evidente, solo se si è preventivamente ricorsi al metodo analitico, poiché tutte le teorie si fanno dopo. La sintesi funziona benissimo in geometria, dove si parte da poche definizioni: in filosofia, però, tutto è diverso e più difficile, soprattutto stabilire quali siano i princìpi primi da cui far scendere tutto. In altri termini, rispetto alla geometria, la filosofia è meno formalizzabile e dunque meno incline ad essere assoggettata al metodo sintetico euclideo; anche se, a dire il vero, Cartesio stesso scriverà una "Geometria" in cui farà esclusivamente uso del metodo analitico. Questo spiega la quarta regola, che prescrive di "fare in tutti i casi enumerazioni tanto perfette e rassegne tanto complete, da essere sicuro di non omettere nulla": inoltre giustifica anche quel senso di pochezza che proviamo leggendola dopo aver letto le tre che la precedono. Propone di rivedere – senza spiegare quale strategia sia opportuno seguire – il tutto per sincerarsi di non aver dimenticato nulla; perciò già Vico e Spinoza rimproveravano a Cartesio che il suo non era un metodo. Lo sviluppo del discorso cartesiano prende il via dalla prima regola, la verità come evidenza (chiarezza e distinzione): fino a che non ho evidenza, devo dubitare di tutto (comprese le procedure del mio ragionare): ma come fa, allora, il soggetto pensante a sottrarsi al dubbio? Perché è evidente, risponde Cartesio. Egli gioca la carta del dubbio metodico: gran parte delle credenze, su cui si fonda la conoscenza umana, è frutto di una tradizione la cui certezza – nota il filosofo francese – viene subito meno non appena si comincia a dubitare. La prima cosa che fa Cartesio è, appunto, mettere in dubbio ogni cosa, per vedere se qualche cosa si salva e, di conseguenza, risulta vera, evidente, tralasciando invece come falsa ogni realtà dubitabile. Il filosofo francese annuncia che l’evidenza non può essere sancita da determinate procedure formali, ma è invece qualcosa che o c’è o non c’è, un qualcosa che si autopone immediatamente. E a tal proposito egli procede gradualmente: il primo oggetto del dubbio è l’esperienza esterna, la quale è ambigua e segnata da errori (già gli antichi Scettici avevano messo in dubbio le attestazioni sensibili, ricorrendo all’esempio del remo immerso in acqua che appare spezzato). In questa maniera, si arriva a dubitare di tutto ciò che proviene da "idee avventizie", ovvero da quelle idee provenienti dall’esterno. Ma si potrebbe allora obiettare che si può, sì, dubitare dell’esperienza esterna, ma non di quella interna, a livello coscienziale, ossia di quelle verità che nascono da un ragionamento interno, non inficiato dall’insicurezza dell’esperienza (ad esempio le verità matematiche, del tipo 2 + 2 = 4). E qui Cartesio non vuole lasciar fuori nulla dal dubbio e perciò dubita perfino delle verità a noi interne, ipotizzando che la nostra mente possa essere congegnata in modo tale da funzionare male: essa potrebbe cioè essere costantemente ingannata se non da Dio, almeno da un genio maligno che si insinua nei nostri processi mentali e fa sì che ci sbagliamo clamorosamente perché il nostro stesso meccanismo di pensiero porta all’errore (magari in verità due più due non fa quattro, ma cinque). Infine, Cartesio ritiene possibile mettere in dubbio complessivamente la realtà del mondo: egli arriva pertanto ad ipotizzare che le cose stiano effettivamente come sembrano e che, radicalmente, esista per davvero un mondo. Quello che noi abitualmente chiamiamo mondo, infatti, potrebbe semplicemente essere il risultato di un sogno, poiché anche nei sogni ci sembra di vivere per davvero, ci pare cioè che il sogno sia realtà: chi può assicurarci, allora, che anche la realtà – quella che noi diciamo tale – non sia il frutto di un sogno? Evidentemente, non disponiamo di strumenti per distinguere ciò che è frutto del sogno da ciò che invece è frutto della veglia: in questa tesi cartesiana converge buona parte del pensiero del Seicento, pensiamo ad esempio alle tesi emerse in "La vita è sogno" di Calderòn de la Barca, dove si fa credere al giovane sovrano in prova che il suo regno è stato solo un sogno e si giunge alla paradossale conclusione – già in qualche misura presente in Pindaro e nell’Aiace sofocleo: "Cos’è la vita? Follia. Cos’è la vita? Un’illusione, un’ombra, una finzione, e anche il bene più grande ha poco valore, perché la vita è un sogno". Anche "La Tempesta" di Shakespeare è in qualche misura sullo sfondo delle riflessioni cartesiane: in quest’opera il protagonista, Prospero, arriva a dire che "siamo tutti della stoffa di cui sono fatti i sogni" ("We are such stuff as dreams are"). Esteso il dubbio ad ogni cosa, perfino al mondo (considerato alla stegua della realtà onirica) ve n’è una sola che si salva: ed è il fatto che io dubito; infatti, dubito di tutto fuorchè del fatto che io dubito e ciò significa che io penso e allora – lo si coglie in maniera immediata in quanto è autoevidente – che io esisto, esisto (almeno) come soggetto pensante. "Cogito, ergo sum": penso, dunque sono. Non posso, tuttavia, avere garanzia di esistere come corpo (giacchè il corpo può appartenere al mondo onirico). In questo modo, dovrò necessariamente ammettere l’eventualità della falsità dell’oggetto pensato, ma mai quella del soggetto pensante: la verità "penso, dunque sono" è una verità assolutamente salda, è la prima, grande ed unica evidenza che ottengo e che non può essere minimamente scalfita dal dubbio. In molti, però, hanno attaccato l’argomentazione cartesiana, facendo leva soprattutto sulla contraddittorietà dell’ "ergo": dicendo "penso, dunque sono" – si è obiettato – è come se Cartesio giungesse alla certezza di esistere attraverso un ragionamento (quasi un sillogismo: ciò che pensa esiste, io penso; dunque io esisto), un’inferenza di tipo stoico, quando Cartesio stesso ci ha invitati a dubitare delle nostre procedure mentali (le quali potrebbero essere manovrate da un genio maligno). Se devo dubitare delle mie facoltà mentali, allora dovrò anche dubitare della veridicità del "cogito, ergo sum", giacchè esso è il frutto di un ragionamento partorito dalla mia mente (ne è prova l’ "ergo"). La risposta fieramente addotta da Cartesio è che il suo non è affatto un ragionamento, tant’è che si potrebbe benissimo eliminare l’ "ergo" e limitarsi a dire: "penso, esisto"; è infatti nel fatto stesso di pensare che ho l’autoevidenza immediata di esistere (senza passare per ragionamento alcuno). Si tratta, allora, di un’autoevidenza che si realizza a livello coscienziale e non argomentativo. Lo stesso pensiero verrà da Cartesio concepito come autoriflessione coscienziale. Con il "cogito, ergo sum" viene dimostrata l’esistenza irremovibile di qualcuno che sogna: permane tuttavia il dubbio sul mondo esterno e su tutto il resto. Scrive Cartesio (nel "Discorso sul metodo", parte quarta): "conobbi che ero una sostanza la cui essenza o natura sta solo nel pensare e che per esistere non ha bisogno di alcun luogo né dipende da qualcosa di materiale". La certezza che ho di me riguarda esclusivamente il pensiero: se penso, è evidente che esisto come soggetto pensante, ma non è affatto evidente che esista un corpo e che esistano le cose che io penso. Perché esista una sostanza, a ben pensarci, non è necessario che esistano un corpo ed un mondo esterno: basta un soggetto pensante, e così Cartesio realizza un’identificazione della sostanza col pensiero che sta alla base del suo radicale dualismo metafisico. Risulta pertanto chiaro, fin da ora, che se esiste un corpo (e Cartesio dovrà successivamente dimostrarlo), esso sarà necessariamente separato dal pensiero (il quale esiste in maniera indipendente), sicchè avremo due mondi nettamente distinti ed eterogenei: il mondo del pensiero (libero e immateriale) e quello della materia (necessario e quantitativamente esteso). Tale dualismo è, al contempo, una forza (poiché sganciando il pensiero dalla materia si può affermare l’esistenza del pensiero stesso pur mantenendo il dubbio sulla materia) ma anche una debolezza (crea non pochi problemi per quel che riguarda l’influenza dell’uno sull’altro: come faccio io, soggetto pensante, ad agire sul mondo corporeo, e viceversa?). Che cosa sono io, di cui ora ho la certezza dell’esistenza, si domanda Cartesio nelle "Meditazioni metafisiche"? Posso essere sicuro di avere un corpo? Non posso dire di essere il mio corpo, poiché esso è soltanto oggetto della mia rappresentazione. Perciò Cartesio, tralasciando momentaneamente la questione del corpo, passa ad esaminare gli attributi dell’anima (termine col quale dobbiamo intendere il pensiero, ma anche il soggetto animale, dotato di vita): i primi elementi costitutivi di essa sono il nutrirsi e il camminare, ma neanche di tali attività posso per ora avere certezza, giacchè sono indisgiungibilmente legate a quel corpo sul quale permane il dubbio (come posso camminare se non facendo riferimento al corpo?). E il sentire? Ugualmente: non si può sentire senza il corpo, per cui cade anche su tale attività il dubbio. E poi anche nel sogno si sentono cose che, al risveglio, si rivelano fasulle. E il pensare? Esso – dice Cartesio – è indipendente dal corpo, e pertanto è "attributo che mi appartiene", esulante dal dubbio. Infatti, ch’io esista come pensiero è certo, ed è vero per tutto il tempo che penso: quando smetto di pensare, tale certezza cade, poiché potrebbe accadermi di cessare di esistere. "Non sono nulla se non una cosa pensante, e cioè uno spirito, un intelletto o una ragione, i quali sono termini sinonimi il cui significato m’era prima ignoto" (Meditazioni metafisiche"): con queste parole, Cartesio assimila l’intelletto, la ragione e il pensiero e ammette che finora non eravamo in grado di attribuire un significato certo a tali termini (solo ora che abbiamo spiegato il "cogito" possiamo definire il pensiero); il pensiero è l’atto di autocoscienza esistenziale con cui l’individuo riconosce di esistere in quanto cosa pensante. Si tratta, allora, di prendere coscienza della propria esistenza come cosa pensante, il che avviene appunto con il "cogito, ergo sum". Cartesio presenta la prima regola del metodo – quella dell’evidenza – come diretta conseguenza del dubbio metodico: è infatti dubitando di ogni cosa che egli ha raggiunto la certezza del "cogito" e l’ha tradotta in una regola (accettare solo l’evidente); in realtà, si può anche dire l’esatto contrario, ossia riconoscere che il metodo non è l’effetto ma la causa del "cogito", ammettendo che, poiché devo accettare solo l’evidente, sono pervenuto al "cogito", che è la cosa più evidente che ci sia. In sostanza, il dubbio metodico e la prima regola del metodo finiscono per coincidere, e hanno comune origine nel considerare la verità come autoevidenza: infatti, la verità si impone secondo Cartesio nella sua autoevidenza, e mancano criteri formali per distinguere il vero dal falso (l’unica soluzione consiste, appunto, nel far riferimento all’autoevidenza). Nella sua unica opera sistematica – i "Princìpi della filosofia" -, che è giustamente stata considerata come il punto d’arrivo della sua riflessione, Cartesio dà (nel paragrafo 9) una definizione del pensiero non troppo distante da quella formulata nel "Discorso sul metodo": "Con la parola pensiero io intendo tutto quel che accade in noi in modo tale che lo percepiamo immediatamente in noi stessi. Ecco perché non solo intendere, non solo volere, non solo ragionare, non solo immaginare, ma anche sentire è qui lo stesso che pensare"; così nelle "Meditazioni metafisiche" diceva che solo dopo aver spiegato il "cogito" si può capire che cosa sia il pensiero e passava al suo esame. Ora, nel passo riportato dei "Princìpi della filosofia", Cartesio considera il pensiero come attività generica nella quale rientrano la ragione, l’intelletto, il volere, l’immaginazione e perfino il sentire, il che risulta piuttosto strano, soprattutto se teniamo a mente che nelle "Meditazioni metafisiche", alla domanda "che cosa sono io?", egli rispondeva "sono una cosa che pensa" ed escludeva categoricamente il sentire in quanto funzione connessa al corpo. Ora invece, enigmaticamente, il sentire è riabilitato ed è a pieno titolo inserito tra le funzioni non del corpo ma dell’anima. Tutto si spiega se attribuiamo al verbo "sentire" due diversi significati, come fa appunto Cartesio: nelle "Meditazioni metafisiche" il sentire è inteso come l’entrare in contatto, mediante il corpo, con l’oggetto esterno, un sentire la realtà dell’oggetto esterno e del corpo che fa da tramite: per questo motivo, il sentire così inteso va respinto, poiché connesso direttamente con quel corpo su cui ancora pende il dubbio. Nei "Princìpi della filosofia", invece, Cartesio fa riferimento ad un’altra accezione di "sentire", in particolare allude al "sentire" inteso come capacità di rappresentarsi "idee avventizie" (cioè provenienti dall’esterno) senza far riferimento all’esistenza reale di tali idee all’esterno. In questo mondo che è un sogno, vedo l’albero, ma ciò non vuol dire ch’esso esista: posso solamente dire che esiste una rappresentazione (l’idea appunto) di tale albero, data come sensazione distinguentesi da altre rappresentazioni (si distingue da quelle della volontà – il voler costruire una casa -, da quelle dell’intelletto – 2+2=4 -, da quelle dell’immaginazione – il cavallo alato); il che significa che le rappresentazioni del mondo esterno hanno una loro specificità, si presentano come sensazioni, hanno in comune con tutte le altre di essere "oggetti interni del pensiero" – sono parole di Cartesio. Poiché pensare è sempre pensare qualche cosa, e siccome restiamo fedeli all’ipotesi del dubbio (il mondo come sogno), allora il pensato non corrisponde ad un oggetto esterno, ma è un mero pensato la cui verità non consiste nel corrispondere a qualcosa di reale, ma piuttosto nell’essere un pensato senza il quale è impossibile pensare, così come sono certo della mia esistenza sono anche certo delle idee che penso, certo della loro esistenza come prodotto del mio pensiero. Anche il sentire, dunque, fa parte del pensiero e non della sfera corporea. Successivamente, Cartesio, a partire dal "cogito, ergo sum", recupererà la certezza su tutto ciò che aveva gettato al dubbio: in particolare, gli basterà dimostrare l’esistenza di Dio per revocare il dubbio su ogni cosa; se infatti Dio esiste e ci crea (come Cartesio dimostrerà con una pluralità di argomentazioni), essendo Egli buono e perfetto, non potrà ingannarci, cosicchè saremo autorizzati a dire che due più due dà quattro, che il mondo esiste quale ci appare, e così via. Molti autori del Seicento condividono con Cartesio la concezione del pensiero senza distinzioni tra intelletto e ragione, pur con un’importante differenza rispetto al filosofo francese: una differenza che fa di questi autori dei veri e propri precursori e, in un certo senso, preparatori dell’Illuminismo (Voltaire vedrà in Cartesio l’anti-illuminista per eccellenza). Come è noto, Cartesio legge nel pensiero un’attività tipicamente umana, ma non intende per questo limitarlo e farne qualcosa di finito (quale è appunto l’uomo): sicchè, paradossalmente, l’uomo è un ente finito, ma il pensiero – che è la peculiarità umana – è infinito, non ha limiti, può conoscere ogni cosa. Viceversa, molti autori del Seicento, riconoscendo – sulle orme di Cartesio – nell’uomo una facoltà conoscitiva di tipo intuitivo in grado di cogliere i princìpi ultimi della realtà, riterranno che nell’uomo ci sia, sì, una facoltà conoscitiva simile a quella di Dio (che tutto conosce), che fa conoscere in maniera assoluta; ma, riconducendo il pensiero ad attività squisitamente umana, essi finiscono per leggere in esso qualcosa di finito, al pari dell’uomo: se è finito l’uomo, allora sarà finito anche il suo attributo più peculiare, che è appunto il pensiero. Qui sta la differenza rispetto a Cartesio: egli vede l’uomo come finito, ma il pensiero come infinito; viceversa, molti suoi contemporanei (e da qui prenderà le mosse l’Illuminismo) vedono sia nell’uomo sia nel pensiero qualcosa di finito e limitato. Per Cartesio, invece, il pensiero è onnipotente, non ha confini, può essere solo ridimensionato dal cattivo uso, ma se lo impieghiamo correttamente allora esso non ha limiti e l’uomo può conoscere tutto in maniera assoluta. E’ questa una discrasia che trae origine dal fatto che Cartesio non formalizza il pensiero: l’autoevidenza da lui ammessa può effettivamente conoscere ogni cosa, è sconfinata. Gli autori successivi, però, vedranno nel pensiero qualcosa di limitato, poiché limitato è colui che lo esercita. Questo sarà uno dei grandi portati dell’età illuministica, un portato che sarà tuttavia superato con l’Idealismo, che ritornerà ad una conoscenza di tipo assoluto, attuantesi attraverso un’intuizione capace di cogliere la realtà nei suoi princìpi ultimi.
PASCAL
 A rinunciare all’individuazione di una facoltà che, attraverso un particolare strumento, colga i princìpi ultimi della realtà, sono tutti quei pensatori che ritengono che l’intelletto (o la ragione) sia una facoltà limitata, proprio perché specificamente appartenente a quell’essere finito che è l’uomo: si tratta di una finitezza intrinseca, interpretabile ora come data dall’oggetto della conoscenza, ora come data dal fatto che la mente proceda in modo da non poter cogliere la verità, ora dal fatto che nell’uomo la conoscenza noetica è contrapposta ad una "sentimentale" ed emotiva. Questo è il caso di Blaise Pascal, la cui filosofia è incentrata sulla fondamentale distinzione tra il cuore e la ragione, tra quelli che lui chiama "esprit de finesse" ed "esprit de geometrie". In questo caso, Pascal distingue tra due diversi modi di porsi in relazione con l’oggetto: nel primo caso, quello del cuore, si ha un rapporto immediato con l’oggetto, un rapporto fondato sull’intuito e su una percezione molto vaga e sfumata, quasi sentimentale, delle cose percepite. Nel secondo caso, invece, – quello della ragione – si ha un approccio all’oggetto che fa ricorso a strumenti razionali e precisi, a princìpi che sono formalizzabili perfettamente (al pari della matematica e della geometria). Ora, Pascal non ha difficoltà ad ammettere che la ragione costituisca una forma di conoscenza più forte e comunicabile, proprio perché formalizzabile, ma proprio per questo – egli nota – non è applicabile a tutto lo scibile umano e all’intera realtà: c’è un ambito dell’indagine umana, che è anzi la parte più importante – l’uomo stesso -, che sfugge a questo modo di affrontare la conoscenza. Tutto ciò che concerne la metafisica è infatti indagato con strumenti extra-razionali; gli stessi fondamenti della geometria, della matematica, non sono dimostrati dalla ragione, e se vogliamo accertarli dobbiamo fare affidamento sulla conoscenza che avviene attraverso il cuore. Se ne evince che la ragione non solo non fornisce risposte alle grandi questioni metafisiche (cos’è l’uomo? E la vita? Perché viviamo? Esiste Dio? E quale è il nostro rapporto con Lui?), ma addirittura non riesce a dimostrare neppure quei fondamenti sui quali si basa il suo stesso procedere (ad esempio i princìpi matematici). La contrapposizione tra "spirito di finezza" e "spirito di geometria" è assai forte: nei "Pensieri", contrapponendoli, affiorano caratteri specifici di ciascuno dei due "spiriti". Il primo elemento di contrapposizione risiede nel fatto che lo spirito di geometria procede attraverso formalizzazioni, del tutto escluse dal procedere dello spirito di finezza. Il secondo elemento di dissidio è invece rintracciabile nel fatto che lo spirito di geometria parte da pochi princìpi chiari e formalizzabili per derivare da essi tutte le altre formalizzazioni, mentre lo spirito di finezza non ha un numero definito di punti di partenza, ma prende le mosse da molti presupposti, mai formalizzati e chiariti, ma sempre sentiti in maniera allusiva e sentimentale. Il terzo elemento di disaccordo sta nel fatto che lo spirito di geometria procede discorsivamente, cioè per argomentazioni (aggiungendo una prova all’altra, in maniera concatenata), mentre lo spirito di finezza procede intuitivamente, cogliendo in maniera subitanea e immediata i princìpi e la loro connessione con quanto segue. E’ nei "Pensieri" (S. 1-4; B. 1-4) che Pascal si sofferma su tali distinzioni: " Nel primo i princípi sono tangibili, ma lontani dal comune modo di pensare, sicché si fa fatica a volger la mente verso di essi, per mancanza di abitudine; ma, per poco che la si volga a essi, si scorgono pienamente; e solo una mente affatto guasta può ragionar male sopra princípi cosí tangibili che è quasi impossibile che sfuggano. Nello spirito di finezza i princípi sono, invece, nell’uso comune e dinanzi agli occhi di tutti. Non occorre volgere il capo o farsi violenza: basta aver buona vista, ma buona davvero, perché i princípi sono cosí tenui e cosí numerosi che è quasi impossibile che non ne sfugga qualcuno. Ora, basta ometterne uno per cadere in errore: occorre, pertanto, una vista molto limpida per scorgerli tutti e una mente retta per non ragionare stortamente sopra princípi noti. Tutti i geometri sarebbero, quindi, fini se avessero la vista buona, giacché non ragionano falsamente sui princípi che conoscono; e gli spiriti fini sarebbero geometri se potessero piegare lo sguardo verso i princípi, a loro non familiari, della geometria. Se, dunque, certi spiriti fini non sono geometri, è perché sono del tutto incapaci di volgersi verso i princípi della geometria; mentre la ragione per cui certi geometri difettano di finezza è che non scorgono quel che sta dinanzi ai loro occhi e che, essendo usi ai princípi netti e tangibili della geometria, e a ragionare solo dopo averli ben veduti e maneggiati, si perdono nelle cose in cui ci vuol finezza, nelle quali i princípi non si lascian trattare nella stessa maniera". Per princìpi "tangibili" dobbiamo intendere quei princìpi dimostrabili e chiari nella loro evidenza originaria, così come appunto li concepiva Cartesio; sono tuttavia troppo lontani dalla vita quotidiana, sono generalizzazioni (e perciò son pochi) ma non immediatamente rintracciabili: con ancora un chiaro riferimento a Cartesio, Pascal spiega che solo il cattivo uso della mente impedisce la conoscenza. Con queste considerazioni, il pensatore francese non intende schierarsi contro la ragione, lui che nel Seicento fu uno dei massimi scienziati; semplicemente, è sua intenzione mettere in luce come la ragione non possa conoscere ogni cosa, come invece credeva Cartesio. Solo una persona colta effettua dimostrazioni geometriche, ma è cosa da tutti comprensibile nella vita quotidiana – senza ricorrere ad astratti princìpi – sapere quale sia l’essenza ultima dell’uomo, la sua miserevole condizione, tesa tra il tutto e il nulla. Non si tratta – come invece è nel caso dello spirito di geometria – di pochi princìpi evidenti e difficilmente comprensibili, bensì siamo di fronte, con lo spirito di finezza, ad un mare magnum di princìpi, vaghi ed incerti, informalizzabili, sentiti nell’esperienza interna e non riconducibili ad isolamenti; non è possibile cogliere distintamente il principio per cui l’uomo è misero, sono tanti princìpi sentimentali che affollano il cuore. Pascal insiste sul fatto che non ci sono strumenti di comunicazione formale delle acquisizioni del cuore: o li si sentono o non li si sentono, non vi sono procedure inferenziali chiare, non si può dimostrare che l’uomo è misero come si può dimostrare che 2+2=4, è una verità che si sente col cuore. "Bisogna cogliere la cosa di primo acchito con un solo sguardo, e non per progresso di ragionamento, almeno sino a un certo punto", dice Pascal: questa opposizione tra spirito di geometria e spirito di finezza è a poco a poco riproposta nei termini di contrapposizione tra cuore e ragione, dove Pascal sostiene che la ragione non solo non riesce a trattare i temi metafisici, ma neppure i propri princìpi, li vede con chiarezza ma con un occhio che è del cuore: "noi conosciamo la verità non solo con la ragione, ma anche col cuore". Ciononostante, egli non vuole negare che la ragione abbia le sue ragioni (per certe ricerche essa è il miglior strumento), intende semplicemente delimitare gli ambiti, mettendo in evidenza come il cuore abbia ragioni sconosciute alla ragione, ed è anzi attento a combattere quella tradizione scetticheggiante che metteva in dubbio qualsiasi certezza umana, comprese quelle matematiche, sicchè Pascal spiega che la conoscenza del cuore è superiore perchè ha a che fare con oggetti superiori (ad esempio Dio), ma ci tiene anche a specificare che ci sono ambiti in cui la ragione dà certezze assolute, e in tal caso il cuore serve a consolidare la ragione. Gli Scettici sono pertanto in errore quando negano la certezza del procedere matematico: che da P derivi P1 e poi P2 è certo, ma a dimostrare il principio P (su cui poggia tutto il resto) è il cuore, cosicchè Pascal viene in soccorso alle matematiche facendo leva sulla certezza di P, indimostrabile dalla ragione (e qui Pascal concorda con gli Scettici). C’è qui una consonanza con la tradizione aristotelica, per la quale i princìpi sono colti dal >NouV e non dalla ragione, con la differenza, però, che per Aristotele l’intelletto ha una funzione tecnica, rilevare i primi princìpi, mentre per Pascal il cuore non si limita a cogliere i princìpi primi, ma riguarda tutto ciò che cade al di là dello spirito di geometria. L’immagine che Pascal ci dà della conoscenza risulta in una stretta sezione in cui opera la ragione, e una sezione pressochè illimitata in cui opera invece il cuore, che determina i princìpi su cui lavora la ragione stessa. "Infatti la condizione dei primi princìpi […] è altrettanto salda di quelle procurateci dal ragionamento […]. Questa impotenza [della ragione] deve dunque servire ad umiliare la ragione": il limite che Pascal impone alla ragione serve a mettere in evidenza come essa, valida nel proprio ambito, non possa travalicare i suoi confini; nel suo terreno, essa è padrona (il cuore deve starne fuori), al di fuori non può far altro che tacere, senza invadere le regioni che competono al cuore. Si è detto che uno degli elementi di distinzione tra ragione e cuore è il fatto che la prima si serve di un procedimento discorsivo, il secondo di uno intuitivo; ma, allora, come può Pascal collocarsi nel novero di quei pensatori che non distinguono diverse facoltà nel pensare umano? Il punto di svolta sta qui: il pensatore francese, accanto al procedimento discorsivo della ragione, riconosce una dimensione intuitiva, ma ad essa non attribuisce in alcun modo il carattere di conoscenza assoluta; infatti, le ragioni del cuore sono sempre umane, ancorchè esso proceda intuitivamente, sempre di cuore umano si tratta, e l’uomo non può mai disporre di una conoscenza intuitiva che colga i princìpi assoluti della realtà, tant’è che i princìpi del cuore restano vaghi e confusi, sicchè Pascal è, se inserito nella sua epoca, un outsider, in quanto riconosce sì all’uomo una sfera genuinamente intuitiva, ma essa non è in alcun modo legata alla conoscenza di princìpi assoluti; certo, colgo dimensioni dell’esistenza umana che, con la sola ragione, non potrei mai cogliere, ma resto sempre nel campo dell’esistenza umana, dell’uomo finito e limitato: neanche il cuore può varcare i limiti della finitezza umana, tant’è che sento sì Dio, ma non lo colgo con certezza. Sarà poi Spinoza che assegnerà all’intuito la capacità di cogliere i princìpi assoluti (Dio stesso), mentre Pascal resta un filosofo del finito, apre spiragli verso l’infinito, ma rimangono meri spiragli: Dio resta sempre una pura trascendenza che non può essere attinta.
A rinunciare all’individuazione di una facoltà che, attraverso un particolare strumento, colga i princìpi ultimi della realtà, sono tutti quei pensatori che ritengono che l’intelletto (o la ragione) sia una facoltà limitata, proprio perché specificamente appartenente a quell’essere finito che è l’uomo: si tratta di una finitezza intrinseca, interpretabile ora come data dall’oggetto della conoscenza, ora come data dal fatto che la mente proceda in modo da non poter cogliere la verità, ora dal fatto che nell’uomo la conoscenza noetica è contrapposta ad una "sentimentale" ed emotiva. Questo è il caso di Blaise Pascal, la cui filosofia è incentrata sulla fondamentale distinzione tra il cuore e la ragione, tra quelli che lui chiama "esprit de finesse" ed "esprit de geometrie". In questo caso, Pascal distingue tra due diversi modi di porsi in relazione con l’oggetto: nel primo caso, quello del cuore, si ha un rapporto immediato con l’oggetto, un rapporto fondato sull’intuito e su una percezione molto vaga e sfumata, quasi sentimentale, delle cose percepite. Nel secondo caso, invece, – quello della ragione – si ha un approccio all’oggetto che fa ricorso a strumenti razionali e precisi, a princìpi che sono formalizzabili perfettamente (al pari della matematica e della geometria). Ora, Pascal non ha difficoltà ad ammettere che la ragione costituisca una forma di conoscenza più forte e comunicabile, proprio perché formalizzabile, ma proprio per questo – egli nota – non è applicabile a tutto lo scibile umano e all’intera realtà: c’è un ambito dell’indagine umana, che è anzi la parte più importante – l’uomo stesso -, che sfugge a questo modo di affrontare la conoscenza. Tutto ciò che concerne la metafisica è infatti indagato con strumenti extra-razionali; gli stessi fondamenti della geometria, della matematica, non sono dimostrati dalla ragione, e se vogliamo accertarli dobbiamo fare affidamento sulla conoscenza che avviene attraverso il cuore. Se ne evince che la ragione non solo non fornisce risposte alle grandi questioni metafisiche (cos’è l’uomo? E la vita? Perché viviamo? Esiste Dio? E quale è il nostro rapporto con Lui?), ma addirittura non riesce a dimostrare neppure quei fondamenti sui quali si basa il suo stesso procedere (ad esempio i princìpi matematici). La contrapposizione tra "spirito di finezza" e "spirito di geometria" è assai forte: nei "Pensieri", contrapponendoli, affiorano caratteri specifici di ciascuno dei due "spiriti". Il primo elemento di contrapposizione risiede nel fatto che lo spirito di geometria procede attraverso formalizzazioni, del tutto escluse dal procedere dello spirito di finezza. Il secondo elemento di dissidio è invece rintracciabile nel fatto che lo spirito di geometria parte da pochi princìpi chiari e formalizzabili per derivare da essi tutte le altre formalizzazioni, mentre lo spirito di finezza non ha un numero definito di punti di partenza, ma prende le mosse da molti presupposti, mai formalizzati e chiariti, ma sempre sentiti in maniera allusiva e sentimentale. Il terzo elemento di disaccordo sta nel fatto che lo spirito di geometria procede discorsivamente, cioè per argomentazioni (aggiungendo una prova all’altra, in maniera concatenata), mentre lo spirito di finezza procede intuitivamente, cogliendo in maniera subitanea e immediata i princìpi e la loro connessione con quanto segue. E’ nei "Pensieri" (S. 1-4; B. 1-4) che Pascal si sofferma su tali distinzioni: " Nel primo i princípi sono tangibili, ma lontani dal comune modo di pensare, sicché si fa fatica a volger la mente verso di essi, per mancanza di abitudine; ma, per poco che la si volga a essi, si scorgono pienamente; e solo una mente affatto guasta può ragionar male sopra princípi cosí tangibili che è quasi impossibile che sfuggano. Nello spirito di finezza i princípi sono, invece, nell’uso comune e dinanzi agli occhi di tutti. Non occorre volgere il capo o farsi violenza: basta aver buona vista, ma buona davvero, perché i princípi sono cosí tenui e cosí numerosi che è quasi impossibile che non ne sfugga qualcuno. Ora, basta ometterne uno per cadere in errore: occorre, pertanto, una vista molto limpida per scorgerli tutti e una mente retta per non ragionare stortamente sopra princípi noti. Tutti i geometri sarebbero, quindi, fini se avessero la vista buona, giacché non ragionano falsamente sui princípi che conoscono; e gli spiriti fini sarebbero geometri se potessero piegare lo sguardo verso i princípi, a loro non familiari, della geometria. Se, dunque, certi spiriti fini non sono geometri, è perché sono del tutto incapaci di volgersi verso i princípi della geometria; mentre la ragione per cui certi geometri difettano di finezza è che non scorgono quel che sta dinanzi ai loro occhi e che, essendo usi ai princípi netti e tangibili della geometria, e a ragionare solo dopo averli ben veduti e maneggiati, si perdono nelle cose in cui ci vuol finezza, nelle quali i princípi non si lascian trattare nella stessa maniera". Per princìpi "tangibili" dobbiamo intendere quei princìpi dimostrabili e chiari nella loro evidenza originaria, così come appunto li concepiva Cartesio; sono tuttavia troppo lontani dalla vita quotidiana, sono generalizzazioni (e perciò son pochi) ma non immediatamente rintracciabili: con ancora un chiaro riferimento a Cartesio, Pascal spiega che solo il cattivo uso della mente impedisce la conoscenza. Con queste considerazioni, il pensatore francese non intende schierarsi contro la ragione, lui che nel Seicento fu uno dei massimi scienziati; semplicemente, è sua intenzione mettere in luce come la ragione non possa conoscere ogni cosa, come invece credeva Cartesio. Solo una persona colta effettua dimostrazioni geometriche, ma è cosa da tutti comprensibile nella vita quotidiana – senza ricorrere ad astratti princìpi – sapere quale sia l’essenza ultima dell’uomo, la sua miserevole condizione, tesa tra il tutto e il nulla. Non si tratta – come invece è nel caso dello spirito di geometria – di pochi princìpi evidenti e difficilmente comprensibili, bensì siamo di fronte, con lo spirito di finezza, ad un mare magnum di princìpi, vaghi ed incerti, informalizzabili, sentiti nell’esperienza interna e non riconducibili ad isolamenti; non è possibile cogliere distintamente il principio per cui l’uomo è misero, sono tanti princìpi sentimentali che affollano il cuore. Pascal insiste sul fatto che non ci sono strumenti di comunicazione formale delle acquisizioni del cuore: o li si sentono o non li si sentono, non vi sono procedure inferenziali chiare, non si può dimostrare che l’uomo è misero come si può dimostrare che 2+2=4, è una verità che si sente col cuore. "Bisogna cogliere la cosa di primo acchito con un solo sguardo, e non per progresso di ragionamento, almeno sino a un certo punto", dice Pascal: questa opposizione tra spirito di geometria e spirito di finezza è a poco a poco riproposta nei termini di contrapposizione tra cuore e ragione, dove Pascal sostiene che la ragione non solo non riesce a trattare i temi metafisici, ma neppure i propri princìpi, li vede con chiarezza ma con un occhio che è del cuore: "noi conosciamo la verità non solo con la ragione, ma anche col cuore". Ciononostante, egli non vuole negare che la ragione abbia le sue ragioni (per certe ricerche essa è il miglior strumento), intende semplicemente delimitare gli ambiti, mettendo in evidenza come il cuore abbia ragioni sconosciute alla ragione, ed è anzi attento a combattere quella tradizione scetticheggiante che metteva in dubbio qualsiasi certezza umana, comprese quelle matematiche, sicchè Pascal spiega che la conoscenza del cuore è superiore perchè ha a che fare con oggetti superiori (ad esempio Dio), ma ci tiene anche a specificare che ci sono ambiti in cui la ragione dà certezze assolute, e in tal caso il cuore serve a consolidare la ragione. Gli Scettici sono pertanto in errore quando negano la certezza del procedere matematico: che da P derivi P1 e poi P2 è certo, ma a dimostrare il principio P (su cui poggia tutto il resto) è il cuore, cosicchè Pascal viene in soccorso alle matematiche facendo leva sulla certezza di P, indimostrabile dalla ragione (e qui Pascal concorda con gli Scettici). C’è qui una consonanza con la tradizione aristotelica, per la quale i princìpi sono colti dal >NouV e non dalla ragione, con la differenza, però, che per Aristotele l’intelletto ha una funzione tecnica, rilevare i primi princìpi, mentre per Pascal il cuore non si limita a cogliere i princìpi primi, ma riguarda tutto ciò che cade al di là dello spirito di geometria. L’immagine che Pascal ci dà della conoscenza risulta in una stretta sezione in cui opera la ragione, e una sezione pressochè illimitata in cui opera invece il cuore, che determina i princìpi su cui lavora la ragione stessa. "Infatti la condizione dei primi princìpi […] è altrettanto salda di quelle procurateci dal ragionamento […]. Questa impotenza [della ragione] deve dunque servire ad umiliare la ragione": il limite che Pascal impone alla ragione serve a mettere in evidenza come essa, valida nel proprio ambito, non possa travalicare i suoi confini; nel suo terreno, essa è padrona (il cuore deve starne fuori), al di fuori non può far altro che tacere, senza invadere le regioni che competono al cuore. Si è detto che uno degli elementi di distinzione tra ragione e cuore è il fatto che la prima si serve di un procedimento discorsivo, il secondo di uno intuitivo; ma, allora, come può Pascal collocarsi nel novero di quei pensatori che non distinguono diverse facoltà nel pensare umano? Il punto di svolta sta qui: il pensatore francese, accanto al procedimento discorsivo della ragione, riconosce una dimensione intuitiva, ma ad essa non attribuisce in alcun modo il carattere di conoscenza assoluta; infatti, le ragioni del cuore sono sempre umane, ancorchè esso proceda intuitivamente, sempre di cuore umano si tratta, e l’uomo non può mai disporre di una conoscenza intuitiva che colga i princìpi assoluti della realtà, tant’è che i princìpi del cuore restano vaghi e confusi, sicchè Pascal è, se inserito nella sua epoca, un outsider, in quanto riconosce sì all’uomo una sfera genuinamente intuitiva, ma essa non è in alcun modo legata alla conoscenza di princìpi assoluti; certo, colgo dimensioni dell’esistenza umana che, con la sola ragione, non potrei mai cogliere, ma resto sempre nel campo dell’esistenza umana, dell’uomo finito e limitato: neanche il cuore può varcare i limiti della finitezza umana, tant’è che sento sì Dio, ma non lo colgo con certezza. Sarà poi Spinoza che assegnerà all’intuito la capacità di cogliere i princìpi assoluti (Dio stesso), mentre Pascal resta un filosofo del finito, apre spiragli verso l’infinito, ma rimangono meri spiragli: Dio resta sempre una pura trascendenza che non può essere attinta.
HOBBES
 Thomas Hobbes si colloca a pieno titolo nello stuolo di quegli autori seicenteschi post-cartesiani che non fanno distinzione tra intelletto e ragione, e, di conseguenza, hanno una concezione finita della conoscenza umana; Hobbes preferisce il termine "ragione" rispetto a quello "intelletto", pur non operando alcuna distinzione di contenuto tra i due. I motivi della sua concezione, tuttavia, risultano differenti da quelli pascaliani, e forse sono più precisi, perché dipendono strettamente dallo stesso modo in cui funziona la ragione umana. Hobbes è un rigoroso sensista, per cui la conoscenza umana parte sempre dai sensi e dal sensibile: e il modo in cui tali sensi forniscono materiale è descritto negli usuali termini meccanicistici (così frequenti da Cartesio in poi); c’è un oggetto esterno, colpisce gli organi sensoriali periferici (l’epidermide, la cornea, ecc) e, attraverso di essi, penetra nel corpo meccanicamente. Il filosofo inglese, però, correggerà questa prospettiva cartesiana inserendo una capacità del corpo di reagire positivamente se l’impulso è piacevole, o negativamente, nel caso esso sia sgradito. Il risultato di tale impressione dei corpi esterni sull’apparato sensoriale è un’immagine, ( >fantasma o imaginatio): tra queste immagini e i concetti – nota Hobbes – non vi è alcuna differenza, poiché da buon sensista egli nota come le nostre idee si risolvano in immagini sensoriali provenienti dall’esterno, senza alcuna attività razionale, è insomma una fase meramente passiva. A queste immagini, l’uomo può imporre dei nomi, e così trae origine il linguaggio: così le sensazioni mi danno l’immagine della sedia, immagine priva di nome fino a che la ragione non gliene impone uno ("sedia" appunto), con un’imposizione arbitraria, senza corrispondenza essenziale tra nome ed immagine; in questo senso, Hobbes si oppone alla tradizione platonica – che ritorna in Vico – che vuole i nomi naturalmente corrispondenti alle cose. Tali nomi hanno due funzioni: la prima è quella di rammemorare, ossia di far sì che il soggetto che ha ricevuto l’immagine possa richiamarla attraverso il nome, che si configura così come una sorta di etichetta. I nomi sono dunque notae ("marcks" in inglese), ma hanno anche una funzione comunicativa, cioè, oltre a ricordarmi delle immagini, mi servono a comunicarle agli altri, posto che ci siamo preventivamente accordati che quella data immagine la chiamiamo "sedia". In questa maniera, oltre a notae, i nomi sono signa. E la ragione per Hobbes è un’attività molto specifica e particolare, consistente nell’addizionare o nel sottrarre immagini oppure nomi: sono le forme elementari del calcolo, e dire che ragione equivale a sottrarre e addizionare è come dire che la ragione ha la funzione di calcolare, e lo fa prendendo più immagini e addizionandole (o sottraendole), oppure – ad un livello superiore – compie questa medesima operazione con i nomi, con la differenza che finchè opera solo con immagini si stabiliscono connessioni di carattere più o meno generico, ma quando si addiziona e si sottrae coi nomi, non si stabiliscono solo connessioni generiche, ma si devono per forza stabilire connessioni causali, ossia si osservano le conseguenze di certi nomi rispetto ad altri. In questo caso, ragionare equivale a calcolare le conseguenze dei nomi. Ad una tale immagine assegno il nome "sedia", ma quando lo si è fatto non si è messa solo un’etichetta, si è anche data una definizione, si è data tutta una serie di conseguenze che derivano dal nome: "sedia" perché è un oggetto su cui ci si può sedere, sicchè quando dico "sedia" è implicito "lì c’è una sedia, se vuoi puoi sederti". Scrive Hobbes nel "Leviatano" (libro I, cap. V): "Quando uno ragiona non fa altro che ottenere una somma totale attraverso una addizione di parti, o un resto sottraendo una somma da un’altra; il che se è fatto con le parole consiste nel ricavare dai nomi di tutte le parti il nome del tutto, o dai nomi del tutto e di una singola parte il nome della parte rimanente. E sebbene in certe cose come nei numeri gli uomini annoverano accanto all’addizione e alla sottrazione anche altre operazioni come la moltiplicazione e la divisione, tuttavia queste ultime operazioni sono identiche a quelle, poiché la moltiplicazione significa nient’altro che sommare insieme quantità eguali e dividere significa sottrarre da una quantità tante volte quante si vuole. Queste operazioni non si applicano solo ai numeri ma a tutte quelle specie di cose che si possono sommare insieme e sottrarre le une dalle altre. E infatti come l’aritmetica ci insegna a sommare e a sottrarre in termini di numeri, cosí la geometria insegna le stesse cose nel campo delle linee e delle figure, solide o piane, di angoli, proporzioni, tempi, gradi di velocità, forza, potenza e simili concetti; i logici insegnano le stesse cose nel campo della connessione fra le parole: sommando insieme due nomi si ha un’affermazione, sommando due affermazioni si ha un sillogismo, sommando alcuni sillogismi si ha una dimostrazione; e dalla somma, o conclusione di un sillogismo sottraggono una proposizione per trovarne un’altra. Gli scrittori di politica sommano insieme i patti stipulati per trovare quali sono gli obblighi degli uomini, e i legislatori sommano le leggi e i patti per trovare che cosa è il diritto e che cosa è il torto nelle azioni dei privati. Insomma in qualunque campo in cui c’è posto per l’addizione e la sottrazione c’è anche posto per la ragione; dove queste cose mancano la ragione non ha niente da fare". Quando lavora sulle immagini, la ragione sta lavorando prima dell’uso linguistico: ciò significa che non necessariamente si lavora coi nomi, anche se questa è la forma più alta di ragionamento. L’esempio che adduce Hobbes (nel "De corpore") è quello dell’immagine scorta da lontano: la vedo in lontananza e per me è già un’immagine e, anche se non so bene cosa sia, posso attribuirle quella proprietà che poi chiamerò "corpo" (sono infatti certo che, qualsiasi cosa sia, è un corpo). Successivamente, noto ch’essa si muove, e allora aggiungo all’immagine di "corpo" quella che successivamente chiamerò "animale". Poi noto ch’essa ha le caratteristiche di quelle immagini a cui son solito dare il nome di "essere razionale" (perché vedo che ragiona, parla, ecc). Mi trovo così a possedere l’elemento del corpo, dell’animalità e della razionalità; sommandoli, compongo un’unica immagine e posso dire che essa è ciò a cui usando successivamente il linguaggio do il nome di "uomo"; sottraendo dall’immagine "uomo" i vari elementi posso naturalmente regredire all’immagine di "corpo". Con questo esempio, Hobbes dimostra un modo in cui la nostra mente può operare, senza ricorrere ancora alle parole. Ma c’è un’altra maniera di sottrarre e addizionare immagini, e cioè di stabilire connessioni tra un’immagine e l’altra. Se ad esempio ho constatato che tutti gli oggetti corrispondenti all’immagine "uomo" tendono a morire, allora all’immagine "uomo" sarò autorizzato ad associare l’idea di "mortalità" e a stabilire tra queste una connessione; ma la mortalità non può essere elemento costitutivo dell’immagine "uomo", semplicemente ho ricavato dall’esperienza l’immagine di uomini che muoiono e con la ragione ho addizionato l’idea di mortalità all’immagine "uomo". Ho cioè addizionato all’immagine la conseguenza dell’immagine, dicendo che l’uomo andrà necessariamente incontro alla morte. Così vedo le nuvole in cielo (e ne ho un’immagine), e penso che pioverà (è la conseguenza): è l’esperienza che mi fa connettere queste due immagini, nuvole e pioggia, ma non è che nella nuvola sia insita l’idea di pioggia. Ugualmente: vedo il sole splendere, e dico che non pioverà: ho eseguito una sottrazione. Questo tipo di connessione causale pre-linguistica è particolarmente rilevante perché implica che anche gli animali in senso lato ragionino, sicchè la ragione non è una prerogativa dell’uomo: infatti, il cane che vede il bastone alzato e scappa perché all’immagine del bastone associa quella delle botte; così come noi prendiamo l’ombrello quando vediamo le nuvole in cielo. A questo livello, gli animali compiono le stesse operazioni mentali degli uomini, addizionano e sottraggono immagini (ma non nomi): il cane vede la ciotola e ad essa addiziona la possibilità di mangiare e sottrae la possibilità di ricever botte. La differenza tra uomo e animale, tra ragione umana e ragione animale, risiede nel fatto che solo quella umana opera sui nomi (solo l’uomo dispone del linguaggio), col vantaggio che essi sono note rammemorative e comunicabili, cosicchè posso utilizzare il contenuto semantico dei nomi per creare una fitta rete di conseguenze universali, posso cioè costruire una scienza (il che naturalmente è impossibile per gli animali). L’attività della ragione umana si sviluppa in due direzioni con i nomi: sono quella che Hobbes definisce come funzione comunicativa e funzione rammemorativa, implicante il vantaggio di non dover rifare ogni volta da capo i ragionamenti precedentemente effettuati, ma poterli condensare tramite i nomi. L’esempio che a tal proposito adduce il filosofo inglese è quello delle proprietà del triangolo: col ragionamento, posso venire a sapere che gli angoli interni di un triangolo sono uguali ad un angolo piatto, senza tuttavia far uso dei nomi; mi basta sommare delle mere quantità. Se però non mi avvalgo successivamente del linguaggio, quando mi trovo dinanzi ad un diverso triangolo (magari scaleno anziché isoscele) ho l’impressione di trovarmi di fronte ad un’altra realtà, e allora mi trovo costretto a compiere la medesima operazione di calcolo che mi porta a dire che la somma degli angoli interni è uguale ad un angolo piatto, e così dovrò agire ogni qual volta mi imbatto in un qualsivoglia triangolo. Se invece impiego il linguaggio e chiamo "triangolo" tutte quelle cose aventi determinate proprietà, allora una volta che ho trovato che la somma degli angoli interni di quel qualcosa è di 180 gradi, potrò estendere tale verità a tutte quelle cose a cui ho dato il nome "triangolo". Ciò vale – oltrechè per la funzione rammemorativa – anche per la comunicativa: quando parlo con altri di un triangolo, uso il nome del "triangolo" e nella mente dei miei interlocutori si avrà il concetto a cui corrispondono tutti i triangoli, e non una singola ed individuale immagine di triangolo. E così noi disponiamo di una serie di nomina che sono gravidi di conseguenze logiche; da ciò seguono due aspetti degni di nota. In primo luogo, l’importanza di definire correttamente i nomi, perché se parto dalla definizione di triangolo come figura avente quattro angoli, ne trarrò evidentemente delle conseguenze errate perché errata è la definizione di partenza. Non è però facile avere definizioni precise, poiché esse sono completamente arbitrarie alla pari dei nomi: basta sì mettersi preventivamente d’accordo sul contenuto della definizione, ma manca pur sempre il riferimento oggettivo all’essenza della definizione stessa, tutto è frutto di un accordo originario tra gli uomini. La prima cosa da fare sarà allora esplorare le definizioni per sincerarsi che siano chiare. Il secondo aspetto degno di nota sta nel fatto che se la scienza è per Hobbes costruzione derivante dal calcolo delle conseguenze dei nomi, allora essa non è scienza di cose o di immagini, ma sempre e comunque di nomi, ossia di definizioni: la scienza è allora qualcosa di assolutamente astratto, una costruzione puramente logica in cui a contare è la rigorosa consequenzialità tra le conseguenze logiche dedotte e le definizioni da cui son dedotte. Il costrutto della scienza e la sua validità non sono di tipo mimetico, non riproducono cioè la realtà, ma risiedono invece nell’essere una costruzione coerente, improntata su costruzioni logiche a cascata e scevre di contraddizioni. Quella hobbesiana è una concezione piuttosto curiosa, perché il filosofo inglese finisce paradossalmente per trovarsi lontanissimo dal suo sensismo iniziale: la scienza, infatti, lavora su nomi arbitrari, in netta opposizione con quel processo conoscitivo che reca materialmente immagini alla mente e con quel processo del ragionamento che porta all’edificazione della scienza e che fa di Hobbes un sensista in senso pieno. Il pensatore inglese è diviso tra un atteggiamento anticartesiano per quel che concerne lo spiccato sensismo di cui è portavoce e tra uno profondamente cartesiano per quel che invece inerisce alla concezione della scienza, cartesianamente concepita a partire dall’evidenza coscienziale (il "cogito" per Cartesio, la chiarezza della definizione per Hobbes) e svincolata da ogni riferimento all’empiria; ne nasce un mondo logico senza connessioni con quello empirico. Come per Cartesio, anche per Hobbes la scienza si regge sulla coerenza delle connessioni consequenziali che derivano dalle precise definizioni primarie. E "da ciò appare chiaro che la ragione non è una facoltà nata con noi come lo sono il senso e la memoria, e nemmeno ricavata dall’esperienza, come la prudenza, ma qualche cosa che si ottiene attraverso un’operosa attività consistente in primo luogo nel sapere imporre dei nomi adeguati alle cose, secondariamente nel seguire un metodo esatto e ordinato col quale procedere dagli elementi che sono i nomi alle affermazioni ottenute collegando i nomi gli uni con gli altri, e cosí ai sillogismi che costituiscono le connessioni fra le asserzioni, finché giungiamo alla conoscenza di tutte le conseguenze dei nomi appartenenti all’argomento del quale si tratta; ed è questo ciò che gli uomini chiamano scienza. E mentre il senso e la memoria non sono che conoscenza del fatto, che è una cosa passata e irrevocabile, la scienza è conoscenza delle conseguenze e della dipendenza di un fatto da un altro, per cui, oltre a quello che noi possiamo fare presentemente, noi sappiamo come possiamo fare qualche altra cosa quando noi vogliamo, o una cosa simile in un altro momento; poiché quando noi vediamo come ogni cosa si produce, per quali cause e in quale maniera, quando le stesse cause vengono in nostro potere noi vediamo come fare perché esse producano gli stessi effetti" (Leviatano, I, cap. V). Pare che qui Hobbes recuperi una struttura decisamente aristotelica: si parte dalla definizione dei nomi (la definizione "essenziale" di cui parlava lo Stagirita) per ricavarne delle proposizioni, si congiungono due elementi in un’asserzione e, collegando tali asserzioni, nasce un ragionamento di tipo sillogistico. La differenza rispetto alla prospettiva cartesiana risiede nel fatto che per Hobbes le definizioni sono del tutto arbitrarie, mentre per Cartesio l’evidenza è originaria, ovvero nasce dalla coscienza e, conseguentemente, l’uso della ragione è in Cartesio ab origine, non è una funzione che si sviluppa gradualmente, ma è la presa di coscienza delle cose in noi evidenti (a partire dal "cogito"); in Hobbes, al contrario, dipendendo da un’attività artificiale quale è l’attribuzione dei nomi, la ragione non è qualcosa di naturale, è anzi un’attività artificiale che deve essere appresa nel tempo e con l’uso. Ne consegue che si deve imparare a ragionare e a derivare le conseguenze dei nomi dalle loro premesse, cosicchè " la scienza è conoscenza delle conseguenze" (Leviatano, I, cap.V); finchè non usiamo il linguaggio, ci possiamo affidare ad un calcolo di immagini che riguarda il passato (l’immagine che ho non è infatti utilizzabile per il futuro), ma grazie ai nomi il calcolo si riferisce immediatamente alle conseguenze e, quindi, al futuro. Da ciò consegue che l’impiego più alto della ragione è quello linguistico, che ha carattere progettuale, ossia teso verso il futuro, e non constatativo (cioè rivolto al passato): Abbagnano diceva, a tal proposito, – forse calcando un po’ la mano – che tale calcolo è "previsione". Hobbes opera poi un’importante distinzione fra errore ed assurdità: la scienza è – abbiamo visto – calcolo delle conseguenze dei nomi (e ha valore proprio per il modo in cui le concatena), ma se non si procede bene, allora si entra in una contraddizione, perché si deriva da una definizione un elemento che in essa non è contenuto, il che è importante perché quando si compie questo sbaglio non si commette solo un errore, ma una vera e propria contraddizione – un’assurdità – in quanto si fanno coesistere due realtà contraddittorie, che si elidono vicendevolmente (esempio di tale assurdità può essere la stravagante nozione di "quadrilatero rotondo"). L’errore è invece meno grave rispetto all’assurdità, e consiste nel connettere conseguenze quando in realtà tale connessione non si verifica: siamo in presenza sì di un errore, ma non di un’assurdità. Un esempio di errore può essere il seguente: "è nuvolo: pioverà", ma poi non piove; ora, è evidente come non ci sia alcuna contraddizione, ma tuttavia nel connettere le nuvole alla pioggia si è commesso un errore. Quest’ultimo si esplica sempre in un discorso di tipo non scientifico, ossia attinente non a nomi ma ad immagini, a livello di ragionamento prelinguistico. E infatti non do una definizione scientifica dell’essere nuvoloso, bensì resto ad un livello di immagine senza uso linguistico, e associo tale immagine a quella della pioggia; l’errore, in fin dei conti, non riguarda la scienza, ma la prassi, sicchè è nella pratica (dove cioè non ci avvaliamo di un linguaggio propriamente scientifico e, dunque, ragioniamo alla stregua degli animali) che commettiamo errori. Molto più cauti saranno Locke e Hume: Hobbes, dal canto suo, è piuttosto radicale, in quanto afferma che la conoscenza è o assoluta o contraddittoria, senza proporre vie intermedie. La sua posizione è ben compendiata dalle sue stesse parole: "si chiama errore […] il caso in cui si fanno ragionamenti senza termini. […] Quando però ragioniamo con termini di significato generale ed arriviamo ad un’inferenza errata […] si tratta di assurdità". Come è facile arguire, non c’è spazio per le vie di mezzo: o si è in contraddizione o si è nel giusto. Contraddittorio sarà, nella fattispecie, parlare di volontà libera, di sudditi liberi, di sostanze immateriali (come faceva Cartesio), giacchè sono parole "senza significato", ovvero assurde – nell’acezione poc’anzi chiarita. Nel "De homine" (1658), che è una delle sue ultime opere, Hobbes riprende queste tematiche, ma in una prospettiva notevolmente mutata – e più sfumata – rispetto ai tempi del "Leviatano": due sono le grandi modifiche che possiamo rinvenire nel pensiero hobbesiano di questa tarda fase della sua filosofia; in primis, egli ammorbidisce radicalmente l’opposizione netta tra scienza e non-scienza, quell’opposizione netta che regnava incontrastata nel "Leviatano": in quello scritto, la conoscenza – per essere tale – doveva necessariamente essere scienza, e si poteva avere la scienza solo quando si ragionava deduttivamente a partire da una definizione, dalla quale si traevano le conseguenze. Ora, nel "De homine", Hobbes ammette la possibilità di una conoscenza che parta dall’esperienza (e non dalle astratte definizioni), risalendo dagli effetti alle cause (e non dalle cause agli effetti, come invece era nel "Leviatano"); ciò non toglie, tuttavia, che l’autentica conoscenza resti quella che sale dalle cause agli effetti; l’altra – detta "a posteriori" – è sì una conoscenza, ma non può essere etichettata come vera scienza. La seconda basilare modifica introdotta da Hobbes è di natura terminologica: finora, abbiamo parlato esclusivamente di "conseguenze logiche", conosciute dalla scienza; ora, nel "De homine", non si parla solamente di tali "conseguenze logiche", ma anche di quella causalità che restava esclusa dal "Leviatano"; certo, anche la causalità comporta una consequenzialità, ma ha comunque un’estensione maggiore perché la causa riguarda anche il mondo reale (e non solo quello logico), cosicchè ben si spiega il cambiamento linguistico. Infatti, dal momento che Hobbes recupera la conoscenza empirico/induttiva, si trova necessitato a far riferimento al termine "causalità", ossia al risalire dagli effetti alle cause. Addirittura – nota Hobbes – la conoscenza è sempre causale: può essere conoscenza che procede dalle cause agli effetti (e in tal caso si ha la vera scienza), o dagli effetti alle cause (e allora si ha una conoscenza inferiore, da Hobbes detta "cognizione"). Se la conoscenza orbita intorno alla causalità, allora essa ruota anche attorno alla generazione dell’oggetto in questione, giacchè conoscere una cosa vuol dire vedere come essa nasce; anche la dimostrazione a posteriori è ritenuta valida, ma, parlando di generazione, viene ribadito che la vera conoscenza è quella delle cause prime che spiegano l’origine, procedendo dalle cause agli effetti, poiché se invece parto dagli effetti mi trovo in serie difficoltà nel risalire alla giusta causa. Ciò può essere chiarito con un esempio: partendo dall’effetto E, dico che C può essere la sua causa, introducendo quella possibilità esclusa dalla sfera della scienza. Se invece parto dalla causa C, posso affermare con certezza che da essa deriverà l’effetto E, senza possibilità di errore. Allora è facile evincere come il modello a priori sia preferibile non solo per la maggior garanzia della conoscenza (che non è in tal caso del possibile, ma del certo), ma anche per la diversa fruibilità di tale conoscenza: infatti, solo quella aprioristica è rivolta al futuro, perché solo la conoscenza delle cause mi permette una reale generalizzazione (data la causa X, avrò sempre e necessariamente l’effetto Y). Da queste due differenze subentrate col "De homine" ne nasce una terza: se diciamo che la scienza è conoscenza della genesi delle cose, è allora ovvio che devo a tutti i costi avere una conoscenza completa della causa e del processo, poiché se mi sfugge non posso esser certo che da C derivi E, ragion per cui posso davvero conoscere le cose solo quando sono io stesso a produrle. Se la cosa che debbo conoscere è prodotta da altri, diventa per me difficile conoscerla in maniera esaustiva, e devo allora accontentarmi di individuare la causa partendo dagli effetti (e restando nel regno della possibilità); "solo nel caso di quegli oggetti la cui generazione dipende dall’arbitrio degli uomini stessi" essi possono averne conoscenza certe, giacchè avendoli prodotti di persona, ne conoscono le cause e quindi sanno che dalla causa C deriverà necessariamente l’effetto E (ci si muove cioè nel regno della necessità). In quegli stessi anni Giambattista Vico parlerà analogamente di "verum ipsum factum", mantenendo l’idea hobbesiana (forse Vico lesse Hobbes) che la vera conoscenza è quella di ciò che abbiamo noi stessi prodotto. Potrò allora secondo Hobbes conoscere con certezza (perché sono io stesso a farle) la matematica e, soprattutto, la geometria, intese come costruzioni a partire da definizioni (se Hobbes avesse conosciuto le geometrie non-euclidee si sarebbe sentito ulteriormente confortato nelle sue idee); similmente, Vico dirà che "mathematicam veram facimus". Se però ci spostiamo all’ambito della fisica, qui troviamo cose che non abbiamo costruito noi (gli enti naturali), ma che son state prodotte niente poco di meno che da Dio stesso, il che implica che non possiamo conoscerle poiché non possiamo seguirne il processo genealogico; potremo soltanto seguire la dimostrazione a posteriori, muovendoci nel regno del possibile e del probabile, senza garanzie che le nostre conoscenze in merito siano estendibili al futuro. Sul piano teoretico Hobbes salva la matematica e la geometria (Vico salverà la storia), condannando la fisica; su quello etico, si salvano l’etica e la politica, scienze che facciamo noi, giacchè per Hobbes non esistono doveri naturali, e quelli che noi chiamiamo "doveri" sono il frutto di una statuizione umana, né esiste in natura un rapporto tra cittadini e sudditi: esso viene arbitrariamente sancito con un patto.
Thomas Hobbes si colloca a pieno titolo nello stuolo di quegli autori seicenteschi post-cartesiani che non fanno distinzione tra intelletto e ragione, e, di conseguenza, hanno una concezione finita della conoscenza umana; Hobbes preferisce il termine "ragione" rispetto a quello "intelletto", pur non operando alcuna distinzione di contenuto tra i due. I motivi della sua concezione, tuttavia, risultano differenti da quelli pascaliani, e forse sono più precisi, perché dipendono strettamente dallo stesso modo in cui funziona la ragione umana. Hobbes è un rigoroso sensista, per cui la conoscenza umana parte sempre dai sensi e dal sensibile: e il modo in cui tali sensi forniscono materiale è descritto negli usuali termini meccanicistici (così frequenti da Cartesio in poi); c’è un oggetto esterno, colpisce gli organi sensoriali periferici (l’epidermide, la cornea, ecc) e, attraverso di essi, penetra nel corpo meccanicamente. Il filosofo inglese, però, correggerà questa prospettiva cartesiana inserendo una capacità del corpo di reagire positivamente se l’impulso è piacevole, o negativamente, nel caso esso sia sgradito. Il risultato di tale impressione dei corpi esterni sull’apparato sensoriale è un’immagine, ( >fantasma o imaginatio): tra queste immagini e i concetti – nota Hobbes – non vi è alcuna differenza, poiché da buon sensista egli nota come le nostre idee si risolvano in immagini sensoriali provenienti dall’esterno, senza alcuna attività razionale, è insomma una fase meramente passiva. A queste immagini, l’uomo può imporre dei nomi, e così trae origine il linguaggio: così le sensazioni mi danno l’immagine della sedia, immagine priva di nome fino a che la ragione non gliene impone uno ("sedia" appunto), con un’imposizione arbitraria, senza corrispondenza essenziale tra nome ed immagine; in questo senso, Hobbes si oppone alla tradizione platonica – che ritorna in Vico – che vuole i nomi naturalmente corrispondenti alle cose. Tali nomi hanno due funzioni: la prima è quella di rammemorare, ossia di far sì che il soggetto che ha ricevuto l’immagine possa richiamarla attraverso il nome, che si configura così come una sorta di etichetta. I nomi sono dunque notae ("marcks" in inglese), ma hanno anche una funzione comunicativa, cioè, oltre a ricordarmi delle immagini, mi servono a comunicarle agli altri, posto che ci siamo preventivamente accordati che quella data immagine la chiamiamo "sedia". In questa maniera, oltre a notae, i nomi sono signa. E la ragione per Hobbes è un’attività molto specifica e particolare, consistente nell’addizionare o nel sottrarre immagini oppure nomi: sono le forme elementari del calcolo, e dire che ragione equivale a sottrarre e addizionare è come dire che la ragione ha la funzione di calcolare, e lo fa prendendo più immagini e addizionandole (o sottraendole), oppure – ad un livello superiore – compie questa medesima operazione con i nomi, con la differenza che finchè opera solo con immagini si stabiliscono connessioni di carattere più o meno generico, ma quando si addiziona e si sottrae coi nomi, non si stabiliscono solo connessioni generiche, ma si devono per forza stabilire connessioni causali, ossia si osservano le conseguenze di certi nomi rispetto ad altri. In questo caso, ragionare equivale a calcolare le conseguenze dei nomi. Ad una tale immagine assegno il nome "sedia", ma quando lo si è fatto non si è messa solo un’etichetta, si è anche data una definizione, si è data tutta una serie di conseguenze che derivano dal nome: "sedia" perché è un oggetto su cui ci si può sedere, sicchè quando dico "sedia" è implicito "lì c’è una sedia, se vuoi puoi sederti". Scrive Hobbes nel "Leviatano" (libro I, cap. V): "Quando uno ragiona non fa altro che ottenere una somma totale attraverso una addizione di parti, o un resto sottraendo una somma da un’altra; il che se è fatto con le parole consiste nel ricavare dai nomi di tutte le parti il nome del tutto, o dai nomi del tutto e di una singola parte il nome della parte rimanente. E sebbene in certe cose come nei numeri gli uomini annoverano accanto all’addizione e alla sottrazione anche altre operazioni come la moltiplicazione e la divisione, tuttavia queste ultime operazioni sono identiche a quelle, poiché la moltiplicazione significa nient’altro che sommare insieme quantità eguali e dividere significa sottrarre da una quantità tante volte quante si vuole. Queste operazioni non si applicano solo ai numeri ma a tutte quelle specie di cose che si possono sommare insieme e sottrarre le une dalle altre. E infatti come l’aritmetica ci insegna a sommare e a sottrarre in termini di numeri, cosí la geometria insegna le stesse cose nel campo delle linee e delle figure, solide o piane, di angoli, proporzioni, tempi, gradi di velocità, forza, potenza e simili concetti; i logici insegnano le stesse cose nel campo della connessione fra le parole: sommando insieme due nomi si ha un’affermazione, sommando due affermazioni si ha un sillogismo, sommando alcuni sillogismi si ha una dimostrazione; e dalla somma, o conclusione di un sillogismo sottraggono una proposizione per trovarne un’altra. Gli scrittori di politica sommano insieme i patti stipulati per trovare quali sono gli obblighi degli uomini, e i legislatori sommano le leggi e i patti per trovare che cosa è il diritto e che cosa è il torto nelle azioni dei privati. Insomma in qualunque campo in cui c’è posto per l’addizione e la sottrazione c’è anche posto per la ragione; dove queste cose mancano la ragione non ha niente da fare". Quando lavora sulle immagini, la ragione sta lavorando prima dell’uso linguistico: ciò significa che non necessariamente si lavora coi nomi, anche se questa è la forma più alta di ragionamento. L’esempio che adduce Hobbes (nel "De corpore") è quello dell’immagine scorta da lontano: la vedo in lontananza e per me è già un’immagine e, anche se non so bene cosa sia, posso attribuirle quella proprietà che poi chiamerò "corpo" (sono infatti certo che, qualsiasi cosa sia, è un corpo). Successivamente, noto ch’essa si muove, e allora aggiungo all’immagine di "corpo" quella che successivamente chiamerò "animale". Poi noto ch’essa ha le caratteristiche di quelle immagini a cui son solito dare il nome di "essere razionale" (perché vedo che ragiona, parla, ecc). Mi trovo così a possedere l’elemento del corpo, dell’animalità e della razionalità; sommandoli, compongo un’unica immagine e posso dire che essa è ciò a cui usando successivamente il linguaggio do il nome di "uomo"; sottraendo dall’immagine "uomo" i vari elementi posso naturalmente regredire all’immagine di "corpo". Con questo esempio, Hobbes dimostra un modo in cui la nostra mente può operare, senza ricorrere ancora alle parole. Ma c’è un’altra maniera di sottrarre e addizionare immagini, e cioè di stabilire connessioni tra un’immagine e l’altra. Se ad esempio ho constatato che tutti gli oggetti corrispondenti all’immagine "uomo" tendono a morire, allora all’immagine "uomo" sarò autorizzato ad associare l’idea di "mortalità" e a stabilire tra queste una connessione; ma la mortalità non può essere elemento costitutivo dell’immagine "uomo", semplicemente ho ricavato dall’esperienza l’immagine di uomini che muoiono e con la ragione ho addizionato l’idea di mortalità all’immagine "uomo". Ho cioè addizionato all’immagine la conseguenza dell’immagine, dicendo che l’uomo andrà necessariamente incontro alla morte. Così vedo le nuvole in cielo (e ne ho un’immagine), e penso che pioverà (è la conseguenza): è l’esperienza che mi fa connettere queste due immagini, nuvole e pioggia, ma non è che nella nuvola sia insita l’idea di pioggia. Ugualmente: vedo il sole splendere, e dico che non pioverà: ho eseguito una sottrazione. Questo tipo di connessione causale pre-linguistica è particolarmente rilevante perché implica che anche gli animali in senso lato ragionino, sicchè la ragione non è una prerogativa dell’uomo: infatti, il cane che vede il bastone alzato e scappa perché all’immagine del bastone associa quella delle botte; così come noi prendiamo l’ombrello quando vediamo le nuvole in cielo. A questo livello, gli animali compiono le stesse operazioni mentali degli uomini, addizionano e sottraggono immagini (ma non nomi): il cane vede la ciotola e ad essa addiziona la possibilità di mangiare e sottrae la possibilità di ricever botte. La differenza tra uomo e animale, tra ragione umana e ragione animale, risiede nel fatto che solo quella umana opera sui nomi (solo l’uomo dispone del linguaggio), col vantaggio che essi sono note rammemorative e comunicabili, cosicchè posso utilizzare il contenuto semantico dei nomi per creare una fitta rete di conseguenze universali, posso cioè costruire una scienza (il che naturalmente è impossibile per gli animali). L’attività della ragione umana si sviluppa in due direzioni con i nomi: sono quella che Hobbes definisce come funzione comunicativa e funzione rammemorativa, implicante il vantaggio di non dover rifare ogni volta da capo i ragionamenti precedentemente effettuati, ma poterli condensare tramite i nomi. L’esempio che a tal proposito adduce il filosofo inglese è quello delle proprietà del triangolo: col ragionamento, posso venire a sapere che gli angoli interni di un triangolo sono uguali ad un angolo piatto, senza tuttavia far uso dei nomi; mi basta sommare delle mere quantità. Se però non mi avvalgo successivamente del linguaggio, quando mi trovo dinanzi ad un diverso triangolo (magari scaleno anziché isoscele) ho l’impressione di trovarmi di fronte ad un’altra realtà, e allora mi trovo costretto a compiere la medesima operazione di calcolo che mi porta a dire che la somma degli angoli interni è uguale ad un angolo piatto, e così dovrò agire ogni qual volta mi imbatto in un qualsivoglia triangolo. Se invece impiego il linguaggio e chiamo "triangolo" tutte quelle cose aventi determinate proprietà, allora una volta che ho trovato che la somma degli angoli interni di quel qualcosa è di 180 gradi, potrò estendere tale verità a tutte quelle cose a cui ho dato il nome "triangolo". Ciò vale – oltrechè per la funzione rammemorativa – anche per la comunicativa: quando parlo con altri di un triangolo, uso il nome del "triangolo" e nella mente dei miei interlocutori si avrà il concetto a cui corrispondono tutti i triangoli, e non una singola ed individuale immagine di triangolo. E così noi disponiamo di una serie di nomina che sono gravidi di conseguenze logiche; da ciò seguono due aspetti degni di nota. In primo luogo, l’importanza di definire correttamente i nomi, perché se parto dalla definizione di triangolo come figura avente quattro angoli, ne trarrò evidentemente delle conseguenze errate perché errata è la definizione di partenza. Non è però facile avere definizioni precise, poiché esse sono completamente arbitrarie alla pari dei nomi: basta sì mettersi preventivamente d’accordo sul contenuto della definizione, ma manca pur sempre il riferimento oggettivo all’essenza della definizione stessa, tutto è frutto di un accordo originario tra gli uomini. La prima cosa da fare sarà allora esplorare le definizioni per sincerarsi che siano chiare. Il secondo aspetto degno di nota sta nel fatto che se la scienza è per Hobbes costruzione derivante dal calcolo delle conseguenze dei nomi, allora essa non è scienza di cose o di immagini, ma sempre e comunque di nomi, ossia di definizioni: la scienza è allora qualcosa di assolutamente astratto, una costruzione puramente logica in cui a contare è la rigorosa consequenzialità tra le conseguenze logiche dedotte e le definizioni da cui son dedotte. Il costrutto della scienza e la sua validità non sono di tipo mimetico, non riproducono cioè la realtà, ma risiedono invece nell’essere una costruzione coerente, improntata su costruzioni logiche a cascata e scevre di contraddizioni. Quella hobbesiana è una concezione piuttosto curiosa, perché il filosofo inglese finisce paradossalmente per trovarsi lontanissimo dal suo sensismo iniziale: la scienza, infatti, lavora su nomi arbitrari, in netta opposizione con quel processo conoscitivo che reca materialmente immagini alla mente e con quel processo del ragionamento che porta all’edificazione della scienza e che fa di Hobbes un sensista in senso pieno. Il pensatore inglese è diviso tra un atteggiamento anticartesiano per quel che concerne lo spiccato sensismo di cui è portavoce e tra uno profondamente cartesiano per quel che invece inerisce alla concezione della scienza, cartesianamente concepita a partire dall’evidenza coscienziale (il "cogito" per Cartesio, la chiarezza della definizione per Hobbes) e svincolata da ogni riferimento all’empiria; ne nasce un mondo logico senza connessioni con quello empirico. Come per Cartesio, anche per Hobbes la scienza si regge sulla coerenza delle connessioni consequenziali che derivano dalle precise definizioni primarie. E "da ciò appare chiaro che la ragione non è una facoltà nata con noi come lo sono il senso e la memoria, e nemmeno ricavata dall’esperienza, come la prudenza, ma qualche cosa che si ottiene attraverso un’operosa attività consistente in primo luogo nel sapere imporre dei nomi adeguati alle cose, secondariamente nel seguire un metodo esatto e ordinato col quale procedere dagli elementi che sono i nomi alle affermazioni ottenute collegando i nomi gli uni con gli altri, e cosí ai sillogismi che costituiscono le connessioni fra le asserzioni, finché giungiamo alla conoscenza di tutte le conseguenze dei nomi appartenenti all’argomento del quale si tratta; ed è questo ciò che gli uomini chiamano scienza. E mentre il senso e la memoria non sono che conoscenza del fatto, che è una cosa passata e irrevocabile, la scienza è conoscenza delle conseguenze e della dipendenza di un fatto da un altro, per cui, oltre a quello che noi possiamo fare presentemente, noi sappiamo come possiamo fare qualche altra cosa quando noi vogliamo, o una cosa simile in un altro momento; poiché quando noi vediamo come ogni cosa si produce, per quali cause e in quale maniera, quando le stesse cause vengono in nostro potere noi vediamo come fare perché esse producano gli stessi effetti" (Leviatano, I, cap. V). Pare che qui Hobbes recuperi una struttura decisamente aristotelica: si parte dalla definizione dei nomi (la definizione "essenziale" di cui parlava lo Stagirita) per ricavarne delle proposizioni, si congiungono due elementi in un’asserzione e, collegando tali asserzioni, nasce un ragionamento di tipo sillogistico. La differenza rispetto alla prospettiva cartesiana risiede nel fatto che per Hobbes le definizioni sono del tutto arbitrarie, mentre per Cartesio l’evidenza è originaria, ovvero nasce dalla coscienza e, conseguentemente, l’uso della ragione è in Cartesio ab origine, non è una funzione che si sviluppa gradualmente, ma è la presa di coscienza delle cose in noi evidenti (a partire dal "cogito"); in Hobbes, al contrario, dipendendo da un’attività artificiale quale è l’attribuzione dei nomi, la ragione non è qualcosa di naturale, è anzi un’attività artificiale che deve essere appresa nel tempo e con l’uso. Ne consegue che si deve imparare a ragionare e a derivare le conseguenze dei nomi dalle loro premesse, cosicchè " la scienza è conoscenza delle conseguenze" (Leviatano, I, cap.V); finchè non usiamo il linguaggio, ci possiamo affidare ad un calcolo di immagini che riguarda il passato (l’immagine che ho non è infatti utilizzabile per il futuro), ma grazie ai nomi il calcolo si riferisce immediatamente alle conseguenze e, quindi, al futuro. Da ciò consegue che l’impiego più alto della ragione è quello linguistico, che ha carattere progettuale, ossia teso verso il futuro, e non constatativo (cioè rivolto al passato): Abbagnano diceva, a tal proposito, – forse calcando un po’ la mano – che tale calcolo è "previsione". Hobbes opera poi un’importante distinzione fra errore ed assurdità: la scienza è – abbiamo visto – calcolo delle conseguenze dei nomi (e ha valore proprio per il modo in cui le concatena), ma se non si procede bene, allora si entra in una contraddizione, perché si deriva da una definizione un elemento che in essa non è contenuto, il che è importante perché quando si compie questo sbaglio non si commette solo un errore, ma una vera e propria contraddizione – un’assurdità – in quanto si fanno coesistere due realtà contraddittorie, che si elidono vicendevolmente (esempio di tale assurdità può essere la stravagante nozione di "quadrilatero rotondo"). L’errore è invece meno grave rispetto all’assurdità, e consiste nel connettere conseguenze quando in realtà tale connessione non si verifica: siamo in presenza sì di un errore, ma non di un’assurdità. Un esempio di errore può essere il seguente: "è nuvolo: pioverà", ma poi non piove; ora, è evidente come non ci sia alcuna contraddizione, ma tuttavia nel connettere le nuvole alla pioggia si è commesso un errore. Quest’ultimo si esplica sempre in un discorso di tipo non scientifico, ossia attinente non a nomi ma ad immagini, a livello di ragionamento prelinguistico. E infatti non do una definizione scientifica dell’essere nuvoloso, bensì resto ad un livello di immagine senza uso linguistico, e associo tale immagine a quella della pioggia; l’errore, in fin dei conti, non riguarda la scienza, ma la prassi, sicchè è nella pratica (dove cioè non ci avvaliamo di un linguaggio propriamente scientifico e, dunque, ragioniamo alla stregua degli animali) che commettiamo errori. Molto più cauti saranno Locke e Hume: Hobbes, dal canto suo, è piuttosto radicale, in quanto afferma che la conoscenza è o assoluta o contraddittoria, senza proporre vie intermedie. La sua posizione è ben compendiata dalle sue stesse parole: "si chiama errore […] il caso in cui si fanno ragionamenti senza termini. […] Quando però ragioniamo con termini di significato generale ed arriviamo ad un’inferenza errata […] si tratta di assurdità". Come è facile arguire, non c’è spazio per le vie di mezzo: o si è in contraddizione o si è nel giusto. Contraddittorio sarà, nella fattispecie, parlare di volontà libera, di sudditi liberi, di sostanze immateriali (come faceva Cartesio), giacchè sono parole "senza significato", ovvero assurde – nell’acezione poc’anzi chiarita. Nel "De homine" (1658), che è una delle sue ultime opere, Hobbes riprende queste tematiche, ma in una prospettiva notevolmente mutata – e più sfumata – rispetto ai tempi del "Leviatano": due sono le grandi modifiche che possiamo rinvenire nel pensiero hobbesiano di questa tarda fase della sua filosofia; in primis, egli ammorbidisce radicalmente l’opposizione netta tra scienza e non-scienza, quell’opposizione netta che regnava incontrastata nel "Leviatano": in quello scritto, la conoscenza – per essere tale – doveva necessariamente essere scienza, e si poteva avere la scienza solo quando si ragionava deduttivamente a partire da una definizione, dalla quale si traevano le conseguenze. Ora, nel "De homine", Hobbes ammette la possibilità di una conoscenza che parta dall’esperienza (e non dalle astratte definizioni), risalendo dagli effetti alle cause (e non dalle cause agli effetti, come invece era nel "Leviatano"); ciò non toglie, tuttavia, che l’autentica conoscenza resti quella che sale dalle cause agli effetti; l’altra – detta "a posteriori" – è sì una conoscenza, ma non può essere etichettata come vera scienza. La seconda basilare modifica introdotta da Hobbes è di natura terminologica: finora, abbiamo parlato esclusivamente di "conseguenze logiche", conosciute dalla scienza; ora, nel "De homine", non si parla solamente di tali "conseguenze logiche", ma anche di quella causalità che restava esclusa dal "Leviatano"; certo, anche la causalità comporta una consequenzialità, ma ha comunque un’estensione maggiore perché la causa riguarda anche il mondo reale (e non solo quello logico), cosicchè ben si spiega il cambiamento linguistico. Infatti, dal momento che Hobbes recupera la conoscenza empirico/induttiva, si trova necessitato a far riferimento al termine "causalità", ossia al risalire dagli effetti alle cause. Addirittura – nota Hobbes – la conoscenza è sempre causale: può essere conoscenza che procede dalle cause agli effetti (e in tal caso si ha la vera scienza), o dagli effetti alle cause (e allora si ha una conoscenza inferiore, da Hobbes detta "cognizione"). Se la conoscenza orbita intorno alla causalità, allora essa ruota anche attorno alla generazione dell’oggetto in questione, giacchè conoscere una cosa vuol dire vedere come essa nasce; anche la dimostrazione a posteriori è ritenuta valida, ma, parlando di generazione, viene ribadito che la vera conoscenza è quella delle cause prime che spiegano l’origine, procedendo dalle cause agli effetti, poiché se invece parto dagli effetti mi trovo in serie difficoltà nel risalire alla giusta causa. Ciò può essere chiarito con un esempio: partendo dall’effetto E, dico che C può essere la sua causa, introducendo quella possibilità esclusa dalla sfera della scienza. Se invece parto dalla causa C, posso affermare con certezza che da essa deriverà l’effetto E, senza possibilità di errore. Allora è facile evincere come il modello a priori sia preferibile non solo per la maggior garanzia della conoscenza (che non è in tal caso del possibile, ma del certo), ma anche per la diversa fruibilità di tale conoscenza: infatti, solo quella aprioristica è rivolta al futuro, perché solo la conoscenza delle cause mi permette una reale generalizzazione (data la causa X, avrò sempre e necessariamente l’effetto Y). Da queste due differenze subentrate col "De homine" ne nasce una terza: se diciamo che la scienza è conoscenza della genesi delle cose, è allora ovvio che devo a tutti i costi avere una conoscenza completa della causa e del processo, poiché se mi sfugge non posso esser certo che da C derivi E, ragion per cui posso davvero conoscere le cose solo quando sono io stesso a produrle. Se la cosa che debbo conoscere è prodotta da altri, diventa per me difficile conoscerla in maniera esaustiva, e devo allora accontentarmi di individuare la causa partendo dagli effetti (e restando nel regno della possibilità); "solo nel caso di quegli oggetti la cui generazione dipende dall’arbitrio degli uomini stessi" essi possono averne conoscenza certe, giacchè avendoli prodotti di persona, ne conoscono le cause e quindi sanno che dalla causa C deriverà necessariamente l’effetto E (ci si muove cioè nel regno della necessità). In quegli stessi anni Giambattista Vico parlerà analogamente di "verum ipsum factum", mantenendo l’idea hobbesiana (forse Vico lesse Hobbes) che la vera conoscenza è quella di ciò che abbiamo noi stessi prodotto. Potrò allora secondo Hobbes conoscere con certezza (perché sono io stesso a farle) la matematica e, soprattutto, la geometria, intese come costruzioni a partire da definizioni (se Hobbes avesse conosciuto le geometrie non-euclidee si sarebbe sentito ulteriormente confortato nelle sue idee); similmente, Vico dirà che "mathematicam veram facimus". Se però ci spostiamo all’ambito della fisica, qui troviamo cose che non abbiamo costruito noi (gli enti naturali), ma che son state prodotte niente poco di meno che da Dio stesso, il che implica che non possiamo conoscerle poiché non possiamo seguirne il processo genealogico; potremo soltanto seguire la dimostrazione a posteriori, muovendoci nel regno del possibile e del probabile, senza garanzie che le nostre conoscenze in merito siano estendibili al futuro. Sul piano teoretico Hobbes salva la matematica e la geometria (Vico salverà la storia), condannando la fisica; su quello etico, si salvano l’etica e la politica, scienze che facciamo noi, giacchè per Hobbes non esistono doveri naturali, e quelli che noi chiamiamo "doveri" sono il frutto di una statuizione umana, né esiste in natura un rapporto tra cittadini e sudditi: esso viene arbitrariamente sancito con un patto.
GIAMBATTISTA VICO
 Vico è legato a Hobbes da (almeno) un punto di contatto: anch’egli è convinto che possiamo conoscere pienamente solo ciò che noi stessi facciamo. Però la divergenza tra i due pensatori c’è, anche se sfumata: Cartesio aveva propugnato una concezione dell’inferenza nella quale influivano immediatamente l’aspetto discorsivo e quello intuitivo, giacchè per lui il ragionamento consiste in una serie di intuizioni che, connesse, dan le deduzioni, che altro non sono se non catene di intuizioni. Per Hobbes, diversamente, ragionare è calcolare, in particolare calcolare le conseguenze in maniera causale: conoscere sarà dunque sapere che A causa B, che B causa C e così via. E’ una procedura deduttiva e discorsiva, ma non intuitiva, giacchè in nessun modo A e B vengon colti dall’intuizione. Si ha invece una progressiva successione non per intuizione ma per deduzione causale (e Hobbes recupera la logica sillogistica di Aristotele). Dunque, se Cartesio assegna il primato all’intuizione, Hobbes privilegia invece il modello deduttivo. Dal canto suo, Vico – nel "De antiquissima Italorum sapientia" – distingue tra un modello intuitivo (l’ "intellegere") e un momento deduttivo (il "cogitare"): egli si avvale di questi due verbi latini perché mosso dal suo filosofico interesse per le etimologie (interesse che lo induce a scrivere il "De antiquissima Italorum sapientia", anche se poi finisce per inventarsi le etimologie, come farà lo stesso Heidegger). Infatti, a suo avviso, "intellegere" deriva da "intus" e da "legere", e può esser tradotto con "leggere dentro", "penetrare", sicchè tale verbo designa una conoscenza intuitiva, realizzantesi attraverso l’andar dentro a ciò che si conosce. "Cogitare" deriverebbe invece da "coagere", "mettere insieme", e quindi indica una comprensione data non dall’intuizione e dalla penetrazione, ma dal mettere insieme elementi giustapponibili: questa distinzione è usata da Vico per polemizzare con Cartesio, per il quale la conoscenza è data dalla raccoltà ("coagere") delle qualità delle idee. Il cogitare è secondo Vico una forma inferiore di sapere, poiché vede le cose dall’esterno (mette insieme qualità senza cogliere l’essenza delle cose) e perché non si è mai certi di esaurire tutti gli elementi che si raccolgono; per comprendere in profondità il reale occorre invece penetrare al suo interno, ossia intellegere. Scrive Vico ("De antiquissima Italorum sapientia"): "Dai latini verum e factum sono usati scambievolmente o, come si dice comunemente nelle scuole, si convertono l’uno con l’altro. Di qui è dato supporre che gli antichi sapienti d’Italia convenissero, circa il vero, in queste opinioni: il vero è il fatto stesso; perciò in Dio c’è il primo vero perché Dio è il primo fattore: infinito, perché fattore di tutte le cose, perfettissimo, perché rappresenta, a sé, in quanto li contiene, sia gli elementi esterni sia quelli interni delle cose. Sapere è allora comporre gli elementi delle cose: sicché il pensiero è proprio della mente umana, l’intelligenza propria di quella divina. Infatti Dio legge tutti gli elementi delle cose, sia esterni che interni, perché li contiene e li dispone; ma la mente umana, che è finita, e ha fuori di sé tutte le altre cose che non sono essa stessa, è costretta a muoversi tra gli elementi esterni delle cose e non li raccoglie mai tutti: sicché può certo pensare le cose ma non può intenderle, in quanto è partecipe della ragione ma non è padrona di essa. Per chiarire tutto ciò con un paragone: il vero divino è l’immagine solida delle cose, come una scultura; il vero umano è un monogramma o un’immagine piana, come una pittura; e come il vero divino è ciò che Dio, mentre conosce, dispone ordina e genera, cosí il vero umano è ciò che l’uomo, mentre conosce, compone e fa. E cosí la scienza è la conoscenza della genesi, cioè del modo con cui la cosa è fatta, e per la quale, mentre la mente ne conosce il modo, perché compone gli elementi, fa la cosa: Dio, che comprende tutto, fa l’immagine solida; l’uomo, che comprende gli elementi esterni, fa l’immagine piana". A differenza sia di Cartesio sia di Hobbes, Vico distingue due facoltà conoscitive: una è l’intuizione, l’altra è il pensiero cogitante che ci fa procedere discorsivamente (aggiungendo pezzo a pezzo). Sulla base di questa distinzione, sembra che tali due modalità gnoseologiche siano meramente contrapposte e che quindi Vico non solo si distingua radicalmente da Cartesio (che le faceva convergere) e da Hobbes (che eliminava l’intuizione), ma che addirittura sposi la tesi pascaliana della netta e inconciliabile distinzione delle funzioni (dello spirito di finezza e di quello di geometria), accordando maggiore importanza all’intuito. Se però prestiamo attenzione al testo, notiamo che le cose stanno in altri termini: le due modalità conoscitive sono sì distinte, ma non per questo contrapposte, giacchè è possibile un intellegere in cui rientri il cogitare (mentre non è possibile un cogitare che comprenda l’intellegere). In questo senso, la conoscenza intuitiva è intesa in due modi: a) come un colpo d’occhio immediato, che non ha bisogno di passaggi discorsivi ma coglie la totalità nella sua essenza; b) come un conoscere l’essenza totale della cosa, ma non per questo escludendo che all’interno di tale totalità si possa riconoscere un’articolazione discorsiva (cogliere cioè gli elementi connessi tra loro discorsivamente). In questa maniera, la discorsività non è esclusa, ma riguarda anzi la totalità stessa: immaginiamo un puzzle ricomposto; un conto è avere una sua visione per conoscenza discorsiva perché tessera per tessera l’abbiamo costruito (ciò equivale al cogitare); altra cosa è avere una intellezione (intus legere) dell’intero puzzle, pur tenendo presente la connessione delle varie tessere. Sarà questa un’alternativa che tornerà nell’idealismo tedesco: da un lato Schelling parlerà di un intuizionismo assoluto, dall’altro Hegel dirà che nel tutto si mantengono i rapporti fra le singole parti. Vico opta per la strada per cui l’intus legere non esclude il coagere (a differenza della scelta di Pascal): e per meglio spiegarsi, mette a confronto la conoscenza di Dio con quella dell’uomo per quel che riguarda il mondo esterno. L’uomo, trovandosi di fronte a fenomeni esterni prodotti non da lui, non può far altro che sommare A + B + C e cercare di allargare la sua conoscenza aggiungendo elemento a elemento, non può cioè far altro che cogitare. La cogitatio può farlo arrivare a risultati anche molto estesi (grandi catene di connessioni), ma in ogni caso non potrà mai raggiungere la totalità degli eventi e, poi, non potrà mai conoscere la catena nel suo insieme. Dio, che del mondo è l’autore, e quindi il responsabile non solo di A e di B, ma di tutti gli elementi, e non solo della connessione di A e di B, ma di tutta la connessione di tutti gli elementi, cosicchè Egli conosce tutta quanta la sequenza causale e la successione di elementi senza però perdere la possibilità di coagere, ma ciò sarà interno ad un punto di vista totalizzante che Gli permette di intus legere la totalità, sia pur nella sua successione causale. L’intellegere e il cogitare non sono dunque opposti, ma anzi l’intellegere è la forma più alta del cogitare, è quel cogitare in cui non ci si limita a raccogliere le tessere del puzzle, ma lo si vede subito nella sua interezza; ma ciò è possibile solo per chi ha creato quella data cosa. Solo chi ha creato una cosa può conoscere tutta la serie causale che ha portato a essere quella cosa; chi se la trova già fatta può solo mettere insieme i pezzi che la compongono (coagere): questo punto è compendiato da Vico nell’espressione "verum ipsum factum" ("il vero è il fatto stesso"), con la quale egli intende appunto dire che si può avere vera conoscenza solo di ciò che si è effettivamente fatto. Se ho progettato io il puzzle, anche quand’esso è scomposto mi basta vedere una tessera per capire la sua posizione esatta (perché nella mia mente ho l’immagine completa del puzzle), ma se non l’ho creato io posso solo mettere insieme pezzo per pezzo, senza mai arrivare a completarlo. La natura non la fa l’uomo e, quindi, egli non può conoscerla a fondo; solo Dio può penetrarla, perché è Lui che l’ha creata: la posizione vichiana è qui vicinissima a quella hobbesiana. Fin qui, Vico ha distinto l’uomo da Dio, ma in realtà ciò vale solo per il mondo naturale, perché può sussistere anche una forma di analogia tra l’uomo e Dio: se solo ciò che si fa può essere pienamente conosciuto, allora ciò che l’uomo fa può conoscerlo perfettamente: "il vero umano è ciò che l’uomo, mentre conosce, compone e fa". Egli potrà intus legere non la natura (che è stata creata da Dio), ma – hobbesianamente – la matematica ("mathematicam veram facimus", dice Vico), che è costruzione del tutto umana (e in questa fase del pensiero di Vico è la sola cosa che l’uomo crei davvero). Essa è la scienza più esatta, e perciò più lontana dalla natura e, quindi, può vigere il pensiero per cui le cose quanto più sono concrete e tanto più dipendono da Dio (e sfuggono alla nostra conoscenza), e quanto più sono astratte tanto più sono umane (e quindi conoscibili dall’uomo). E – nel "De antiquissima Italorum sapientia" – pone elementi intermedi tra i due estremi rappresentati dalla matematica e dalla natura: la meccanica è una sorta di matematica applicata al movimento, ma non considera mai entità fisiche reali, ma sempre astratte ed è per questo la scienza più vicina alla matematica; la fisica, invece, si serve della matematica, ma la applica al mondo reale, e perciò è meno perfetta della meccanica. La morale, infine, è una disciplina in cui c’è di mezzo il reale, poiché l’uomo è creatura di Dio, però ciò è solo il punto di partenza per costruire regole comportamentali astratte e, quindi, conoscibili. Nella sua opera più importante – "La scienza nuova" – Vico scopre che vi è un altro ambito che è prodotto esclusivamente dall’uomo: la storia. E’ infatti l’uomo a fare la storia e, dunque, si tratta di un ambito disciplinare che può perfettamente conoscere. Vico ritiene che nei fatti storici si riverberi il modo di pensare dell’uomo, cosicchè essi non sono assimilabili a quelli naturali, giacchè dipendono del tutto dalla struttura mentale umana e hanno impronta completamente umana, e poiché possiam conoscere la mente umana, possiam di conseguenza conoscere anche la storia, che si configura allora come "scienza nuova" contrapposta a quella cartesiana. Essa è perfetta alla pari della matematica, è una vera scienza, contrariamente a quel che di essa credeva Cartesio, il quale la intendeva come conoscenza del probabile. Per Vico, invece, gli uomini nel fare la storia non hanno fatto altro che proiettare all’esterno il loro procedere mentale.
Vico è legato a Hobbes da (almeno) un punto di contatto: anch’egli è convinto che possiamo conoscere pienamente solo ciò che noi stessi facciamo. Però la divergenza tra i due pensatori c’è, anche se sfumata: Cartesio aveva propugnato una concezione dell’inferenza nella quale influivano immediatamente l’aspetto discorsivo e quello intuitivo, giacchè per lui il ragionamento consiste in una serie di intuizioni che, connesse, dan le deduzioni, che altro non sono se non catene di intuizioni. Per Hobbes, diversamente, ragionare è calcolare, in particolare calcolare le conseguenze in maniera causale: conoscere sarà dunque sapere che A causa B, che B causa C e così via. E’ una procedura deduttiva e discorsiva, ma non intuitiva, giacchè in nessun modo A e B vengon colti dall’intuizione. Si ha invece una progressiva successione non per intuizione ma per deduzione causale (e Hobbes recupera la logica sillogistica di Aristotele). Dunque, se Cartesio assegna il primato all’intuizione, Hobbes privilegia invece il modello deduttivo. Dal canto suo, Vico – nel "De antiquissima Italorum sapientia" – distingue tra un modello intuitivo (l’ "intellegere") e un momento deduttivo (il "cogitare"): egli si avvale di questi due verbi latini perché mosso dal suo filosofico interesse per le etimologie (interesse che lo induce a scrivere il "De antiquissima Italorum sapientia", anche se poi finisce per inventarsi le etimologie, come farà lo stesso Heidegger). Infatti, a suo avviso, "intellegere" deriva da "intus" e da "legere", e può esser tradotto con "leggere dentro", "penetrare", sicchè tale verbo designa una conoscenza intuitiva, realizzantesi attraverso l’andar dentro a ciò che si conosce. "Cogitare" deriverebbe invece da "coagere", "mettere insieme", e quindi indica una comprensione data non dall’intuizione e dalla penetrazione, ma dal mettere insieme elementi giustapponibili: questa distinzione è usata da Vico per polemizzare con Cartesio, per il quale la conoscenza è data dalla raccoltà ("coagere") delle qualità delle idee. Il cogitare è secondo Vico una forma inferiore di sapere, poiché vede le cose dall’esterno (mette insieme qualità senza cogliere l’essenza delle cose) e perché non si è mai certi di esaurire tutti gli elementi che si raccolgono; per comprendere in profondità il reale occorre invece penetrare al suo interno, ossia intellegere. Scrive Vico ("De antiquissima Italorum sapientia"): "Dai latini verum e factum sono usati scambievolmente o, come si dice comunemente nelle scuole, si convertono l’uno con l’altro. Di qui è dato supporre che gli antichi sapienti d’Italia convenissero, circa il vero, in queste opinioni: il vero è il fatto stesso; perciò in Dio c’è il primo vero perché Dio è il primo fattore: infinito, perché fattore di tutte le cose, perfettissimo, perché rappresenta, a sé, in quanto li contiene, sia gli elementi esterni sia quelli interni delle cose. Sapere è allora comporre gli elementi delle cose: sicché il pensiero è proprio della mente umana, l’intelligenza propria di quella divina. Infatti Dio legge tutti gli elementi delle cose, sia esterni che interni, perché li contiene e li dispone; ma la mente umana, che è finita, e ha fuori di sé tutte le altre cose che non sono essa stessa, è costretta a muoversi tra gli elementi esterni delle cose e non li raccoglie mai tutti: sicché può certo pensare le cose ma non può intenderle, in quanto è partecipe della ragione ma non è padrona di essa. Per chiarire tutto ciò con un paragone: il vero divino è l’immagine solida delle cose, come una scultura; il vero umano è un monogramma o un’immagine piana, come una pittura; e come il vero divino è ciò che Dio, mentre conosce, dispone ordina e genera, cosí il vero umano è ciò che l’uomo, mentre conosce, compone e fa. E cosí la scienza è la conoscenza della genesi, cioè del modo con cui la cosa è fatta, e per la quale, mentre la mente ne conosce il modo, perché compone gli elementi, fa la cosa: Dio, che comprende tutto, fa l’immagine solida; l’uomo, che comprende gli elementi esterni, fa l’immagine piana". A differenza sia di Cartesio sia di Hobbes, Vico distingue due facoltà conoscitive: una è l’intuizione, l’altra è il pensiero cogitante che ci fa procedere discorsivamente (aggiungendo pezzo a pezzo). Sulla base di questa distinzione, sembra che tali due modalità gnoseologiche siano meramente contrapposte e che quindi Vico non solo si distingua radicalmente da Cartesio (che le faceva convergere) e da Hobbes (che eliminava l’intuizione), ma che addirittura sposi la tesi pascaliana della netta e inconciliabile distinzione delle funzioni (dello spirito di finezza e di quello di geometria), accordando maggiore importanza all’intuito. Se però prestiamo attenzione al testo, notiamo che le cose stanno in altri termini: le due modalità conoscitive sono sì distinte, ma non per questo contrapposte, giacchè è possibile un intellegere in cui rientri il cogitare (mentre non è possibile un cogitare che comprenda l’intellegere). In questo senso, la conoscenza intuitiva è intesa in due modi: a) come un colpo d’occhio immediato, che non ha bisogno di passaggi discorsivi ma coglie la totalità nella sua essenza; b) come un conoscere l’essenza totale della cosa, ma non per questo escludendo che all’interno di tale totalità si possa riconoscere un’articolazione discorsiva (cogliere cioè gli elementi connessi tra loro discorsivamente). In questa maniera, la discorsività non è esclusa, ma riguarda anzi la totalità stessa: immaginiamo un puzzle ricomposto; un conto è avere una sua visione per conoscenza discorsiva perché tessera per tessera l’abbiamo costruito (ciò equivale al cogitare); altra cosa è avere una intellezione (intus legere) dell’intero puzzle, pur tenendo presente la connessione delle varie tessere. Sarà questa un’alternativa che tornerà nell’idealismo tedesco: da un lato Schelling parlerà di un intuizionismo assoluto, dall’altro Hegel dirà che nel tutto si mantengono i rapporti fra le singole parti. Vico opta per la strada per cui l’intus legere non esclude il coagere (a differenza della scelta di Pascal): e per meglio spiegarsi, mette a confronto la conoscenza di Dio con quella dell’uomo per quel che riguarda il mondo esterno. L’uomo, trovandosi di fronte a fenomeni esterni prodotti non da lui, non può far altro che sommare A + B + C e cercare di allargare la sua conoscenza aggiungendo elemento a elemento, non può cioè far altro che cogitare. La cogitatio può farlo arrivare a risultati anche molto estesi (grandi catene di connessioni), ma in ogni caso non potrà mai raggiungere la totalità degli eventi e, poi, non potrà mai conoscere la catena nel suo insieme. Dio, che del mondo è l’autore, e quindi il responsabile non solo di A e di B, ma di tutti gli elementi, e non solo della connessione di A e di B, ma di tutta la connessione di tutti gli elementi, cosicchè Egli conosce tutta quanta la sequenza causale e la successione di elementi senza però perdere la possibilità di coagere, ma ciò sarà interno ad un punto di vista totalizzante che Gli permette di intus legere la totalità, sia pur nella sua successione causale. L’intellegere e il cogitare non sono dunque opposti, ma anzi l’intellegere è la forma più alta del cogitare, è quel cogitare in cui non ci si limita a raccogliere le tessere del puzzle, ma lo si vede subito nella sua interezza; ma ciò è possibile solo per chi ha creato quella data cosa. Solo chi ha creato una cosa può conoscere tutta la serie causale che ha portato a essere quella cosa; chi se la trova già fatta può solo mettere insieme i pezzi che la compongono (coagere): questo punto è compendiato da Vico nell’espressione "verum ipsum factum" ("il vero è il fatto stesso"), con la quale egli intende appunto dire che si può avere vera conoscenza solo di ciò che si è effettivamente fatto. Se ho progettato io il puzzle, anche quand’esso è scomposto mi basta vedere una tessera per capire la sua posizione esatta (perché nella mia mente ho l’immagine completa del puzzle), ma se non l’ho creato io posso solo mettere insieme pezzo per pezzo, senza mai arrivare a completarlo. La natura non la fa l’uomo e, quindi, egli non può conoscerla a fondo; solo Dio può penetrarla, perché è Lui che l’ha creata: la posizione vichiana è qui vicinissima a quella hobbesiana. Fin qui, Vico ha distinto l’uomo da Dio, ma in realtà ciò vale solo per il mondo naturale, perché può sussistere anche una forma di analogia tra l’uomo e Dio: se solo ciò che si fa può essere pienamente conosciuto, allora ciò che l’uomo fa può conoscerlo perfettamente: "il vero umano è ciò che l’uomo, mentre conosce, compone e fa". Egli potrà intus legere non la natura (che è stata creata da Dio), ma – hobbesianamente – la matematica ("mathematicam veram facimus", dice Vico), che è costruzione del tutto umana (e in questa fase del pensiero di Vico è la sola cosa che l’uomo crei davvero). Essa è la scienza più esatta, e perciò più lontana dalla natura e, quindi, può vigere il pensiero per cui le cose quanto più sono concrete e tanto più dipendono da Dio (e sfuggono alla nostra conoscenza), e quanto più sono astratte tanto più sono umane (e quindi conoscibili dall’uomo). E – nel "De antiquissima Italorum sapientia" – pone elementi intermedi tra i due estremi rappresentati dalla matematica e dalla natura: la meccanica è una sorta di matematica applicata al movimento, ma non considera mai entità fisiche reali, ma sempre astratte ed è per questo la scienza più vicina alla matematica; la fisica, invece, si serve della matematica, ma la applica al mondo reale, e perciò è meno perfetta della meccanica. La morale, infine, è una disciplina in cui c’è di mezzo il reale, poiché l’uomo è creatura di Dio, però ciò è solo il punto di partenza per costruire regole comportamentali astratte e, quindi, conoscibili. Nella sua opera più importante – "La scienza nuova" – Vico scopre che vi è un altro ambito che è prodotto esclusivamente dall’uomo: la storia. E’ infatti l’uomo a fare la storia e, dunque, si tratta di un ambito disciplinare che può perfettamente conoscere. Vico ritiene che nei fatti storici si riverberi il modo di pensare dell’uomo, cosicchè essi non sono assimilabili a quelli naturali, giacchè dipendono del tutto dalla struttura mentale umana e hanno impronta completamente umana, e poiché possiam conoscere la mente umana, possiam di conseguenza conoscere anche la storia, che si configura allora come "scienza nuova" contrapposta a quella cartesiana. Essa è perfetta alla pari della matematica, è una vera scienza, contrariamente a quel che di essa credeva Cartesio, il quale la intendeva come conoscenza del probabile. Per Vico, invece, gli uomini nel fare la storia non hanno fatto altro che proiettare all’esterno il loro procedere mentale.
JOHN LOCKE
 Dopo Cartesio, invale una forte differenziazione nel pensiero filosofico: si comincia a credere che la conoscenza umana non sia onnipotenza, ma, al contrario, che abbia dei limiti intrinseci, ravvisati da Pascal nella distinzione tra cuore e ragione, da Hobbes nella ragione come calcolatrice delle conseguenze e da Vico nella diversificazione tra cogitare e intellegere, cosicchè se anche la usiamo nel miglior modo possibile, non per questo essa è illimitata. Questi limiti congeniti della ragione umana sono anche sottolineati dall’empirismo moderno inglese, di cui Locke è il più insigne esponente. Il motivo per cui egli pone fin da principio un forte limite all’estensione della conoscenza umana sta nel fatto che la fonte di tale conoscenza è data dall’esperienza empirica: in un passo, egli polemizza duramente contro le filosofie che sostengono la possibilità di idee innate (Cartesio, Malebranche, ma ancora di più il platonismo di Cambridge e, in qualche misura, anche l’aristotelismo di Oxford). Se ammettiamo l’esistenza di idee innate, esse sono chiare, complete, totali e la conoscenza di esse finisce per essere sconfinata, senza limiti empirici, come appunto era in Cartesio. Ora, Locke nega che possano esistere idee che occupino la nostra mente fin dalla nascita: al contrario, tutto deriva dall’esperienza, ed essa non è mai assolutamente oggettiva – anche senza scomodare le argomentazioni scettiche è facile notarlo – e, quindi, non è mai illimitata e sicura; contro le idee innate, Locke fa ricorso all’esempio delle "idee innate teoriche" e delle "idee innate pratiche": in entrambi i casi, chi le sostiene parte dal presupposto che con esse si attui un sapere universale (poiché se sono innate, tutti gli uomini le hanno), in contrapposizione al sapere empirico, secondo il quale le idee passano dall’esperienza. Ma se le idee fossero innate dovrebbero allora averle tutti, sicchè in ogni individui dovremmo trovare la conoscenza del principio di non contraddizione o di identità: eppure, né i bambini né gli idioti ne sono provvisti; ciò è un forte indizio contro la possibilità dell’esistenza di idee teoriche innate. Similmente, sul versante pratico, Locke sbaraglia l’eventualità dell’innatismo ricorrendo al relativismo culturale: basta leggere qualche libro in cui si parli di viaggi in terre remote per accorgersi come in quelle terre sperdute sussistano costumi diversi dai nostri e ciò che per noi è grave colpa (l’incesto, l’antropofagia, l’uccisione dei genitori), per altri popoli non lo è. Ne consegue, allora, che non esistono neanche idee pratiche innate, e i costumi e le norme comportamentali provengono anch’essi dall’esperienza: "supponiamo che lo spirito sia come si dice un foglio di carta bianco, privo di qualsiasi segno, senza nessuna idea; come arriva a essere fornito di idee? […]. Dall’esperienza, nella quale è fondata tutta la nostra conoscenza, e dalla quale essa in ultima analisi deriva" ("Saggio sull’intelletto umano", II, capp. I, 2-4; II, 1-2). Con ciò Locke sta dicendo che tutte le idee si formano empiricamente; ma che cosa intende egli per "idea"? Locke parte dal presupposto che la mente sia una tabula rasa (riprendendo l’immagine stoica della mente come foglio bianco), priva di contenuti, ma che l’unica cosa conoscibile siano le idee: paradossalmente, sotto questo aspetto, egli resta nell’alveo del cartesianesimo e della sua ammissione che possiamo conoscere soltanto idee (intese come contenuti mentali). Ora, pare dunque evidente che pure in un empirista quale è Locke resti qualche traccia cartesiana: non conosco mai le cose, ma sempre solamente le idee, non posso pensare altro che idee e quindi quando faccio riferimento agli oggetti della conoscenza faccio sempre riferimento alle idee stesse, le quali però (e qui sta la divergenza da Cartesio) sono acquisite dall’esperienza, perfino l’idea di Dio è acquisita per tale via (prova ne è che sussistano popoli che non hanno alcuna idea di Dio). Per Cartesio la garanzia della corrispondenza tra cose e idee era radicata nella bontà di Dio: in Locke questo (comodo) ponte di congiunzione manca e, quindi, la conoscenza rimane sempre confinata a idee, ovvero resta aperto il problema della corrispondenza delle idee al mondo esterno (ciò significa che non è detto che il mondo esterno sia quale io me lo immagino). In altri termini, se per Cartesio quando penso all’idea di tavolo sono certo che essa abbia riscontro nel reale perché esiste un Dio buono, per Locke ciò non è valido, sicchè non posso aver la certezza che l’idea abbia riscontro nel reale. Ne consegue, allora, che neanche Locke, che pure si professa empirista, creda che le idee provenienti dall’esterno siano mere fotocopie della realtà, come invece credevano un Democrito o un Epicuro. Al contrario, dirà che alcune idee ci ritraggono la realtà così come essa effettivamente è (tali sono le "idee semplici" della solidità, dell’estensione, del numero, e così via), mentre altre idee (l’idea del caldo, del blu, etc) non raffigurano la realtà esterna, ma la deformano a nostro uso e consumo: ci sono cioè qualità primarie e qualità secondarie, e così dicendo Locke commette un indebito passaggio, poiché come è possibile affermare che vi siano qualità che corrispondono alla realtà se si conoscono solamente idee e mai la realtà stessa? Dovrei poter disporre di un termine di confronto, che però Locke non ammette, e infatti Berkeley e Hume elimineranno la distinzione fra qualità primarie (le quantità) e qualità secondarie (le qualità), riconducendo tutte le idee a rappresentazioni del soggetto, sulla base delle quali non si può sostenere la corrispondenza con la realtà. Ma – concentrandoci su Locke – come può egli asserire che le idee derivino dall’esperienza? A suo avviso, ciò si verifica secondo due differenti modalità: a) attraverso l’esperienza esterna, ovvero mediante la sensazione: le idee giungono alla mente perché i sensi sono sollecitati da una realtà esterna. Ma non tutto è percepito oggettivamente nella stessa maniera (ciò che percepiamo come colore, nella realtà potrebbe non essere un colore); b) attraverso la percezione delle operazioni che la nostra mente compie dentro di sé: non si tratta più di esperienza esterna, ma di esperienza interna, una sorta di riflessione della mente sulle proprie operazioni; il materiale su cui essa riflette è quello già ricevuto attraverso l’esperienza esterna. La riflessione è qui intesa come un percepire mediante l’esperienza. Come nel caso dell’esperienza esterna vi sono le qualità delle cose che producono certe idee superando la barriera fra interno ed esterno, così nell’esperienza interna accade che tali idee vengano rielaborate dalla mente, unificate, confrontate e così via, e queste operazioni si riflettono sulla mente così come le qualità si riflettono sui sensi. Mi vedrò dunque operare sulle idee al mio interno. Come l’esperienza esterna, anche quella interna è caratterizzata da una certa passività. Leggiamo cosa scrive Locke a proposito della distinzione tra sensazione e riflessione: "in primo luogo i nostri sensi, avendo rapporti con oggetti sensibili particolari, convogliano nello spirito diverse percezioni distinte delle cose, secondo i vari modi in cui quegli oggetti agiscono sui sensi. […] Chiamo sensazione questa grande fonte della maggior parte delle idee che abbiamo, poiché essa dipende completamente dai nostri sensi e perché attraverso i sensi agisce sull’intelletto. In secondo luogo l’altra fonte dalla quale l’esperienza fornisce l’intelletto con idee è la percezione delle operazioni del nostro proprio spirito dentro di noi, quando esso è impiegato intorno alle idee che ha ottenuto. […] Ma come chiamo sensazione la prima fonte delle idee, cosí chiamo riflessione questa seconda fonte, perché, le idee che essa fornisce sono soltanto quelle che lo spirito ottiene riflettendo sulle proprie operazioni dentro se stesso" ("Saggio sull’intelletto umano", II, capp. I, 2-4; II, 1-2). Si può leggere in filigrana una qualche assonanza con il discorso di Hobbes, quand’egli diceva che la scienza conosce i nomi e mai le cose stesse: anche per Locke la conoscenza non riguarda mai le cose, ma sempre e soltanto non i nomi hobbesiani ma le meno astratte idee cartesiane. Ma le idee, se singolarmente prese, non costituiscono ancora la conoscenza: per Cartesio se ho conoscenza evidente di un’idea, si tratta già di una conoscenza in senso pieno, anche se tale idea non è connessa ad altre; per Locke, viceversa, una o singole idee non bastano per costituire una conoscenza, la quale è al contrario data dal rapporto tra le idee, in una relazione di accordo o di disaccordo: "mi sembra che la verità, in quello che il nome propriamente vuol dire, non significhi nient’altro se non unire o separare segni secondo che le cose significate da quei segni sono in accordo o disaccordo l’una con l’altra" ("Saggio sull’intelletto umano", IV, cap. V, 2, 8-9). Così, se dico che "il cerchio non è un quadrato" la verità non risiede né nella parola "cerchio" né in quella "quadrato", ma nella relazione di disaccordo instaurata tra le due idee, e la conoscenza sta appunto nel percepire l’accordanza o la discordanza tra le idee. Dove manca tale percezione, non si ha conoscenza, giacchè anche nelle operazioni mentali più semplici, come quando diciamo che "il bianco non è il nero", che altro facciamo se non percepire una discordanza tra idee? Ma per costruire la conoscenza le singole idee non sono sufficienti, tant’è che "sebbene possiamo fantasticare o credere o indovinare, tuttavia non arriviamo mai alla conoscenza"; Locke sta qui dicendo che ci sono cioè casi in cui metto in connessione (fantasticando) idee che non hanno nulla a che vedere tra loro, come quando penso all’ippogrifo come cavallo volante. Ciò significa che, per avere reale conoscenza, non basta mettere in relazione idee o inventarsi rapporti di accordo o disaccordo, ma bisogna scoprire relazioni che oggettivamente corrispondano ai rapporti che ci sono fra le idee: si pone qui il problema della certezza della conoscenza o – per riesumare termini cartesiani – della sua evidenza. E secondo Locke sussistono diversi gradi di evidenza: il grado massimo è quando si intuisce (ossia quando si vede immediatamente) la concordanza o la discordanza tra due idee, come quando ad esempio vedo l’idea di 2+2 e quella di 4 e subito colgo la loro identità (oppure 2+2 e 5 in cui colgo il disaccordo), quasi con un colpo d’occhio. Fin qui Locke resta profondamente cartesiano. Si tratta di una conoscenza immediata, come – dice Locke – l’occhio coglie immediatamente la luce, così a prima vista la mente coglie che il triangolo non è quadrato: è la conoscenza più certa ed evidente che l’uomo possa avere. Ad un secondo (ed inferiore) grado troviamo non più l’identità di 2+2 e di 4, ma quella di una quantità X con una quantità Y: si tratta di una conoscenza che non è più immediatamente evidente, ma che è dimostrabile solo attraverso il passaggio per molti momenti intermedi. Succede cioè che ci troviamo ad avere una dimostrazione, la quale non è altro che una catena di intuizioni. Anche qui Locke si muove in una sostanziale ottica cartesiana. Tuttavia c’è tra i due filosofi una differenza, non grande ma che può avere grandi conseguenze: per Cartesio questa seconda procedura (dimostrativa) ha la stessa certezza della prima (intuitiva), sempre con l’avvertenza di usare bene la ragione senza tralasciare nulla; Locke, dal canto suo, è meno fiducioso e ritiene che quanto più la catena dimostrativa si allunga, tanto più si rischia di commettere errori e quindi tanto più la conoscenza non è certa ma probabile. Così facendo, il pensatore inglese introduce la probabilità (pressochè sconosciuta a Cartesio) anche a livello di dimostrazione (quando cioè ragioniamo), poiché esse – in quanto catene – non possono garantire la certezza che invece troviamo nelle intuizioni (2+2=4). Il successivo livello proposto è quello che si ha quando la mente percepisce la concordanza e la discordanza tra idee non immediatamente: si ha in questo caso quella che Locke definisce una "congettura probabile", esulante dalla certezza propria dell’intuizione. Il ragionare consiste allora nel costruire le catene dimostrative coi nessi intuitivi: ma che cosa ci garantisce che in tali catene non si creino fratture, sbagli o dimenticanze? Se ad esempio dico che X=Y=Z, posso essere sicuro che X e Z siano uguali ad uno stesso Y, e che non siano invece uguali rispettivamente ad un Y e ad un Y1? Non vi è strumento alcuno per poter verificare ciò e dunque in tale ambito regna il probabile, che ha così detronizzato il certo. Quello lockeano è un impianto rigorosamente cartesiano, con la sola aggiunta della probabilità, un’aggiunta innovativa importante per le conseguenze che crea (Hobbes stesso quando parlava di scienza riferendosi ai nomi escludeva – cartesianamente – che potesse infiltrarsi la probabilità al posto della certezza), stonando decisamente con il razionalismo di marca cartesiana e intonandosi perfettamente con l’empirismo. In qualche modo, proponendo una simile concezione del sapere umano, Locke ritorna su posizioni razionalistiche di stampo cartesiano, tradendo così la propria impostazione empiristica di partenza: le idee derivano sì dall’esperienza, ma una volta che le ho acquisite posso lavorare analiticamente su di esse senza far più riferimento all’esperienza. Un regresso simile dalle posizioni assunte in partenza si era verificato in Hobbes, che, partito da un sensismo esasperato, era approdato all’astratta elaborazione della teoria dei nomi, propugnando una conoscenza razionalistica non così distante da quella cartesiana. Ma Locke resta più cartesiano di Hobbes, poiché rimane fedele alla teoria della conoscenza intuitiva, mentre Hobbes obbedisce (nel "De homine") ad una struttura di tipo causale (A produce B, e quindi B è diverso da A): per usare una terminologia kantiana, è come se Locke fosse analitico, Hobbes sintetico. E del resto Locke ritiene che l’intelligenza ("understanding") abbia una funzione squisitamente attiva (a differenza della mera passività dell’esperienza), che si esplica nel mettere insieme le idee; e per meglio chiarirsi, egli riconosce tre diversi tipi di attività: 1) il percepire la relazione intercorrente tra idee; 2) il comporre le idee e fare di idee semplici idee composte; 3) l’astrarre, ossia il ricavare da tante idee un qualcosa di comune ad esse (da tante idee di uomini diversi astraggo l’idea di uomo): ma Berkeley e Hume gli rinfacceranno che, se si vuol davvero essere empiristi, si hanno solo immagini individuali date dall’esperienza, e da dove mai deriverebbe tale facoltà dell’astrarre? Locke sta qui effettivamente impiegando un meccanismo tipicamente razionalistico (cartesiano, aristotelico e tomistico), sganciato dall’esperienza. In sostanza, egli, più che un empirista, può configurarsi come un cartesiano che ha perso la fede e si impasta di empirismo. Dall’esperienza ci provengono sempre idee semplici (l’idea di blu, di pesante, di grande, ecc) e poi l’intelletto le compone in idee complesse (aggregando l’idea di nero, di freddo, di pesante crea l’idea complessa di tavolo).
Dopo Cartesio, invale una forte differenziazione nel pensiero filosofico: si comincia a credere che la conoscenza umana non sia onnipotenza, ma, al contrario, che abbia dei limiti intrinseci, ravvisati da Pascal nella distinzione tra cuore e ragione, da Hobbes nella ragione come calcolatrice delle conseguenze e da Vico nella diversificazione tra cogitare e intellegere, cosicchè se anche la usiamo nel miglior modo possibile, non per questo essa è illimitata. Questi limiti congeniti della ragione umana sono anche sottolineati dall’empirismo moderno inglese, di cui Locke è il più insigne esponente. Il motivo per cui egli pone fin da principio un forte limite all’estensione della conoscenza umana sta nel fatto che la fonte di tale conoscenza è data dall’esperienza empirica: in un passo, egli polemizza duramente contro le filosofie che sostengono la possibilità di idee innate (Cartesio, Malebranche, ma ancora di più il platonismo di Cambridge e, in qualche misura, anche l’aristotelismo di Oxford). Se ammettiamo l’esistenza di idee innate, esse sono chiare, complete, totali e la conoscenza di esse finisce per essere sconfinata, senza limiti empirici, come appunto era in Cartesio. Ora, Locke nega che possano esistere idee che occupino la nostra mente fin dalla nascita: al contrario, tutto deriva dall’esperienza, ed essa non è mai assolutamente oggettiva – anche senza scomodare le argomentazioni scettiche è facile notarlo – e, quindi, non è mai illimitata e sicura; contro le idee innate, Locke fa ricorso all’esempio delle "idee innate teoriche" e delle "idee innate pratiche": in entrambi i casi, chi le sostiene parte dal presupposto che con esse si attui un sapere universale (poiché se sono innate, tutti gli uomini le hanno), in contrapposizione al sapere empirico, secondo il quale le idee passano dall’esperienza. Ma se le idee fossero innate dovrebbero allora averle tutti, sicchè in ogni individui dovremmo trovare la conoscenza del principio di non contraddizione o di identità: eppure, né i bambini né gli idioti ne sono provvisti; ciò è un forte indizio contro la possibilità dell’esistenza di idee teoriche innate. Similmente, sul versante pratico, Locke sbaraglia l’eventualità dell’innatismo ricorrendo al relativismo culturale: basta leggere qualche libro in cui si parli di viaggi in terre remote per accorgersi come in quelle terre sperdute sussistano costumi diversi dai nostri e ciò che per noi è grave colpa (l’incesto, l’antropofagia, l’uccisione dei genitori), per altri popoli non lo è. Ne consegue, allora, che non esistono neanche idee pratiche innate, e i costumi e le norme comportamentali provengono anch’essi dall’esperienza: "supponiamo che lo spirito sia come si dice un foglio di carta bianco, privo di qualsiasi segno, senza nessuna idea; come arriva a essere fornito di idee? […]. Dall’esperienza, nella quale è fondata tutta la nostra conoscenza, e dalla quale essa in ultima analisi deriva" ("Saggio sull’intelletto umano", II, capp. I, 2-4; II, 1-2). Con ciò Locke sta dicendo che tutte le idee si formano empiricamente; ma che cosa intende egli per "idea"? Locke parte dal presupposto che la mente sia una tabula rasa (riprendendo l’immagine stoica della mente come foglio bianco), priva di contenuti, ma che l’unica cosa conoscibile siano le idee: paradossalmente, sotto questo aspetto, egli resta nell’alveo del cartesianesimo e della sua ammissione che possiamo conoscere soltanto idee (intese come contenuti mentali). Ora, pare dunque evidente che pure in un empirista quale è Locke resti qualche traccia cartesiana: non conosco mai le cose, ma sempre solamente le idee, non posso pensare altro che idee e quindi quando faccio riferimento agli oggetti della conoscenza faccio sempre riferimento alle idee stesse, le quali però (e qui sta la divergenza da Cartesio) sono acquisite dall’esperienza, perfino l’idea di Dio è acquisita per tale via (prova ne è che sussistano popoli che non hanno alcuna idea di Dio). Per Cartesio la garanzia della corrispondenza tra cose e idee era radicata nella bontà di Dio: in Locke questo (comodo) ponte di congiunzione manca e, quindi, la conoscenza rimane sempre confinata a idee, ovvero resta aperto il problema della corrispondenza delle idee al mondo esterno (ciò significa che non è detto che il mondo esterno sia quale io me lo immagino). In altri termini, se per Cartesio quando penso all’idea di tavolo sono certo che essa abbia riscontro nel reale perché esiste un Dio buono, per Locke ciò non è valido, sicchè non posso aver la certezza che l’idea abbia riscontro nel reale. Ne consegue, allora, che neanche Locke, che pure si professa empirista, creda che le idee provenienti dall’esterno siano mere fotocopie della realtà, come invece credevano un Democrito o un Epicuro. Al contrario, dirà che alcune idee ci ritraggono la realtà così come essa effettivamente è (tali sono le "idee semplici" della solidità, dell’estensione, del numero, e così via), mentre altre idee (l’idea del caldo, del blu, etc) non raffigurano la realtà esterna, ma la deformano a nostro uso e consumo: ci sono cioè qualità primarie e qualità secondarie, e così dicendo Locke commette un indebito passaggio, poiché come è possibile affermare che vi siano qualità che corrispondono alla realtà se si conoscono solamente idee e mai la realtà stessa? Dovrei poter disporre di un termine di confronto, che però Locke non ammette, e infatti Berkeley e Hume elimineranno la distinzione fra qualità primarie (le quantità) e qualità secondarie (le qualità), riconducendo tutte le idee a rappresentazioni del soggetto, sulla base delle quali non si può sostenere la corrispondenza con la realtà. Ma – concentrandoci su Locke – come può egli asserire che le idee derivino dall’esperienza? A suo avviso, ciò si verifica secondo due differenti modalità: a) attraverso l’esperienza esterna, ovvero mediante la sensazione: le idee giungono alla mente perché i sensi sono sollecitati da una realtà esterna. Ma non tutto è percepito oggettivamente nella stessa maniera (ciò che percepiamo come colore, nella realtà potrebbe non essere un colore); b) attraverso la percezione delle operazioni che la nostra mente compie dentro di sé: non si tratta più di esperienza esterna, ma di esperienza interna, una sorta di riflessione della mente sulle proprie operazioni; il materiale su cui essa riflette è quello già ricevuto attraverso l’esperienza esterna. La riflessione è qui intesa come un percepire mediante l’esperienza. Come nel caso dell’esperienza esterna vi sono le qualità delle cose che producono certe idee superando la barriera fra interno ed esterno, così nell’esperienza interna accade che tali idee vengano rielaborate dalla mente, unificate, confrontate e così via, e queste operazioni si riflettono sulla mente così come le qualità si riflettono sui sensi. Mi vedrò dunque operare sulle idee al mio interno. Come l’esperienza esterna, anche quella interna è caratterizzata da una certa passività. Leggiamo cosa scrive Locke a proposito della distinzione tra sensazione e riflessione: "in primo luogo i nostri sensi, avendo rapporti con oggetti sensibili particolari, convogliano nello spirito diverse percezioni distinte delle cose, secondo i vari modi in cui quegli oggetti agiscono sui sensi. […] Chiamo sensazione questa grande fonte della maggior parte delle idee che abbiamo, poiché essa dipende completamente dai nostri sensi e perché attraverso i sensi agisce sull’intelletto. In secondo luogo l’altra fonte dalla quale l’esperienza fornisce l’intelletto con idee è la percezione delle operazioni del nostro proprio spirito dentro di noi, quando esso è impiegato intorno alle idee che ha ottenuto. […] Ma come chiamo sensazione la prima fonte delle idee, cosí chiamo riflessione questa seconda fonte, perché, le idee che essa fornisce sono soltanto quelle che lo spirito ottiene riflettendo sulle proprie operazioni dentro se stesso" ("Saggio sull’intelletto umano", II, capp. I, 2-4; II, 1-2). Si può leggere in filigrana una qualche assonanza con il discorso di Hobbes, quand’egli diceva che la scienza conosce i nomi e mai le cose stesse: anche per Locke la conoscenza non riguarda mai le cose, ma sempre e soltanto non i nomi hobbesiani ma le meno astratte idee cartesiane. Ma le idee, se singolarmente prese, non costituiscono ancora la conoscenza: per Cartesio se ho conoscenza evidente di un’idea, si tratta già di una conoscenza in senso pieno, anche se tale idea non è connessa ad altre; per Locke, viceversa, una o singole idee non bastano per costituire una conoscenza, la quale è al contrario data dal rapporto tra le idee, in una relazione di accordo o di disaccordo: "mi sembra che la verità, in quello che il nome propriamente vuol dire, non significhi nient’altro se non unire o separare segni secondo che le cose significate da quei segni sono in accordo o disaccordo l’una con l’altra" ("Saggio sull’intelletto umano", IV, cap. V, 2, 8-9). Così, se dico che "il cerchio non è un quadrato" la verità non risiede né nella parola "cerchio" né in quella "quadrato", ma nella relazione di disaccordo instaurata tra le due idee, e la conoscenza sta appunto nel percepire l’accordanza o la discordanza tra le idee. Dove manca tale percezione, non si ha conoscenza, giacchè anche nelle operazioni mentali più semplici, come quando diciamo che "il bianco non è il nero", che altro facciamo se non percepire una discordanza tra idee? Ma per costruire la conoscenza le singole idee non sono sufficienti, tant’è che "sebbene possiamo fantasticare o credere o indovinare, tuttavia non arriviamo mai alla conoscenza"; Locke sta qui dicendo che ci sono cioè casi in cui metto in connessione (fantasticando) idee che non hanno nulla a che vedere tra loro, come quando penso all’ippogrifo come cavallo volante. Ciò significa che, per avere reale conoscenza, non basta mettere in relazione idee o inventarsi rapporti di accordo o disaccordo, ma bisogna scoprire relazioni che oggettivamente corrispondano ai rapporti che ci sono fra le idee: si pone qui il problema della certezza della conoscenza o – per riesumare termini cartesiani – della sua evidenza. E secondo Locke sussistono diversi gradi di evidenza: il grado massimo è quando si intuisce (ossia quando si vede immediatamente) la concordanza o la discordanza tra due idee, come quando ad esempio vedo l’idea di 2+2 e quella di 4 e subito colgo la loro identità (oppure 2+2 e 5 in cui colgo il disaccordo), quasi con un colpo d’occhio. Fin qui Locke resta profondamente cartesiano. Si tratta di una conoscenza immediata, come – dice Locke – l’occhio coglie immediatamente la luce, così a prima vista la mente coglie che il triangolo non è quadrato: è la conoscenza più certa ed evidente che l’uomo possa avere. Ad un secondo (ed inferiore) grado troviamo non più l’identità di 2+2 e di 4, ma quella di una quantità X con una quantità Y: si tratta di una conoscenza che non è più immediatamente evidente, ma che è dimostrabile solo attraverso il passaggio per molti momenti intermedi. Succede cioè che ci troviamo ad avere una dimostrazione, la quale non è altro che una catena di intuizioni. Anche qui Locke si muove in una sostanziale ottica cartesiana. Tuttavia c’è tra i due filosofi una differenza, non grande ma che può avere grandi conseguenze: per Cartesio questa seconda procedura (dimostrativa) ha la stessa certezza della prima (intuitiva), sempre con l’avvertenza di usare bene la ragione senza tralasciare nulla; Locke, dal canto suo, è meno fiducioso e ritiene che quanto più la catena dimostrativa si allunga, tanto più si rischia di commettere errori e quindi tanto più la conoscenza non è certa ma probabile. Così facendo, il pensatore inglese introduce la probabilità (pressochè sconosciuta a Cartesio) anche a livello di dimostrazione (quando cioè ragioniamo), poiché esse – in quanto catene – non possono garantire la certezza che invece troviamo nelle intuizioni (2+2=4). Il successivo livello proposto è quello che si ha quando la mente percepisce la concordanza e la discordanza tra idee non immediatamente: si ha in questo caso quella che Locke definisce una "congettura probabile", esulante dalla certezza propria dell’intuizione. Il ragionare consiste allora nel costruire le catene dimostrative coi nessi intuitivi: ma che cosa ci garantisce che in tali catene non si creino fratture, sbagli o dimenticanze? Se ad esempio dico che X=Y=Z, posso essere sicuro che X e Z siano uguali ad uno stesso Y, e che non siano invece uguali rispettivamente ad un Y e ad un Y1? Non vi è strumento alcuno per poter verificare ciò e dunque in tale ambito regna il probabile, che ha così detronizzato il certo. Quello lockeano è un impianto rigorosamente cartesiano, con la sola aggiunta della probabilità, un’aggiunta innovativa importante per le conseguenze che crea (Hobbes stesso quando parlava di scienza riferendosi ai nomi escludeva – cartesianamente – che potesse infiltrarsi la probabilità al posto della certezza), stonando decisamente con il razionalismo di marca cartesiana e intonandosi perfettamente con l’empirismo. In qualche modo, proponendo una simile concezione del sapere umano, Locke ritorna su posizioni razionalistiche di stampo cartesiano, tradendo così la propria impostazione empiristica di partenza: le idee derivano sì dall’esperienza, ma una volta che le ho acquisite posso lavorare analiticamente su di esse senza far più riferimento all’esperienza. Un regresso simile dalle posizioni assunte in partenza si era verificato in Hobbes, che, partito da un sensismo esasperato, era approdato all’astratta elaborazione della teoria dei nomi, propugnando una conoscenza razionalistica non così distante da quella cartesiana. Ma Locke resta più cartesiano di Hobbes, poiché rimane fedele alla teoria della conoscenza intuitiva, mentre Hobbes obbedisce (nel "De homine") ad una struttura di tipo causale (A produce B, e quindi B è diverso da A): per usare una terminologia kantiana, è come se Locke fosse analitico, Hobbes sintetico. E del resto Locke ritiene che l’intelligenza ("understanding") abbia una funzione squisitamente attiva (a differenza della mera passività dell’esperienza), che si esplica nel mettere insieme le idee; e per meglio chiarirsi, egli riconosce tre diversi tipi di attività: 1) il percepire la relazione intercorrente tra idee; 2) il comporre le idee e fare di idee semplici idee composte; 3) l’astrarre, ossia il ricavare da tante idee un qualcosa di comune ad esse (da tante idee di uomini diversi astraggo l’idea di uomo): ma Berkeley e Hume gli rinfacceranno che, se si vuol davvero essere empiristi, si hanno solo immagini individuali date dall’esperienza, e da dove mai deriverebbe tale facoltà dell’astrarre? Locke sta qui effettivamente impiegando un meccanismo tipicamente razionalistico (cartesiano, aristotelico e tomistico), sganciato dall’esperienza. In sostanza, egli, più che un empirista, può configurarsi come un cartesiano che ha perso la fede e si impasta di empirismo. Dall’esperienza ci provengono sempre idee semplici (l’idea di blu, di pesante, di grande, ecc) e poi l’intelletto le compone in idee complesse (aggregando l’idea di nero, di freddo, di pesante crea l’idea complessa di tavolo).
HUME
 David Hume ha in comune con Locke e con Hobbes il riconoscimento che tutto il materiale della nostra conoscenza provenga dall’esperienza; egli asserisce – in termini meno compromissori col cartesianesimo rispetto agli altri due autori – che tutte le nostre rappresentazioni sono impressioni e idee: le "impressioni" – spiega Hume – sono le rappresentazioni delle cose nel momento in cui tali cose sono attualmente percepite attraverso l’empiria (vedo il tavolo, ne ho una rappresentazione), mentre le idee sono le rappresentazioni che abbiamo delle cose quando queste non sono più percepite attualmente, ma vivono solo nella nostra memoria (penso al tavolo senza averlo di fronte); in sostanza, si può legittimamente dire che l’idea è ciò che resta dell’impressione quando viene a mancare l’oggetto esterno dell’esperienza, sono cioè impressioni illanguidite e meno vivaci. Hume concorda pienamente con Locke sul fatto che le singole idee e le singole impressioni non costituiscano conoscenze, ma siano solo le tessere sparpagliate di un mosaico che devono essere riconnesse: ma tale connessione (e in ciò Hume prende le distanze da Locke, da Hobbes e dal cartesianesimo) avviene perché certe conoscenze possono attuarsi solo per procedure razionalistico/analitiche, ma oltre un certo limite tale procedura si rivela assolutamente impotente. Il primo ambito in cui vale il metodo razionalistico/analitico è quello delle conoscenze astratte e universali derivanti dal semplice confronto tra le idee, e qui Hume si limita a ripetere quanto già detto da Cartesio e da Locke, ma esplicitando meglio come alla base di tali conoscenze stia il principio di identità (da Hume sfumatamente detto "criterio di somiglianza"). Si tratterà, allora, delle conoscenze matematiche, del tipo 2+2=4, in cui da una parte abbiamo l’idea del 2+2 e dall’altra quella del 4, e non appena le mettiamo a confronto appaiono immediatamente uguali (2+2 è appunto uguale a 4). Ora, per sottolineare la consonanza col razionalismo, occorre notare come – qualche anno prima rispetto a Hume – un razionalista convinto come Leibniz avesse detto cose del tutto analoghe, parlando esplicitamente di "verità di ragione"): "vi sono pure due specie di verità, quelle di ragione, e quelle di fatto. Le verità di ragione sono necessarie ed il loro opposto è impossibile, quelle di fatto sono contingenti ed il loro opposto è possibile" (Leibniz, "Monadologia", 33). Così, quando dico che la somma degli angoli interni di un triangolo è uguale a 180 gradi, con tale proposizione esplicito qualcosa di già del tutto contenuto nella nozione stessa di triangolo, senza aggiungere un’idea ad un’altra: appunto, mi limito ad esplicitare qualcosa di già presente, sicchè l’intera matematica è per Hume un’immensa tautologia: da A si tira fuori B, che però era già implicito in A (Kant parlerà a tal proposito di "giudizi analitici a priori", ma vorrà spingersi al di là di essi). Hume si trova in questo d’accordo con il razionalismo cartesiano: quando facciamo ragionamenti di tipo logico, necessariamente ci basiamo sul principio di identità, ma non tutte le conoscenze sono secondo Hume di questo genere. Quando ad esempio vedo che sul tavolo da biliardo la palla A urta la palla B e questa si muove, ciò non può essere spiegato con il medesimo criterio analitico con cui spiegavo che 2+2 dà 4, poiché l’effetto (il moto della palla B) non è già contenuto in A (mentre invece il 4 era già contenuto nel 2+2), ma è qualcosa di diverso e, essendo tale, non mi è possibile indovinarlo in base ad A, non basta cioè esaminare A per capire che da essa scaturirà B, come invece basta guardare l’idea di 7+5 per ricavarne automaticamente il 12. E l’errore dei razionalisti sta appunto nel non aver seguito il metodo dell’identità (anticipato da Cartesio e ripreso da Locke e Leibniz) e nell’aver ritenuto possibile derivare con la ragione le conseguenze dalle cause: si tratta – nota Hume – di una mera illusione della ragione, giacchè essa, confrontando le idee, può solo tirarne fuori (con un’operazione analitica) ciò che esse già contengono, ma non può estrarre dall’idea di causa quella di effetto. Scrive a tal proposito Hume: "se un uomo fosse creato, come Adamo, già nel pieno vigore dell’intelligenza, non potrebbe mai, senza farne l’esperienza, concludere al movimento della seconda palla dal movimento e dalla spinta della prima. La ragione non vede nulla nella causa, che la muova ad inferire l’effetto"; era Hobbes che pretendeva di dimostrare la derivabilità dell’effetto dalla causa, ma ciò è secondo Hume impossibile, poiché il modello razionalistico è eccellente se applicato alla matematica e alla logica, ma quando devo spiegare un dato di fatto (matter of fact), quale può essere il moto della palla B urtata dalla palla A, la ragione non può analiticamente dirmi che da A derivi B, ed ecco che allora si pone un problema del tutto nuovo. Come giustificare le connessioni che si riferiscono non a idee astratte (2+2=4), ma a dati concreti (il moto delle palle sulla tavola da biliardo)? Una possibile via per un empirista quale è Hume sta nell’ammettere che il rapporto causale non lo trovo nella ragione ma nell’esperienza: ma posso davvero dire che l’esperienza mi dia ciò? Parrebbe di sì: quando vedo la palla A urtare la palla B, posso dire di vedere la causalità? Vedo davvero A che sposta B o vedo qualcos’altro? Hume risponde che in realtà io non vedo A che sposta B, ma vedo semplicemente una successione spazio/temporale (A e B che si muovono nello spazio e nel tempo), non vedo mai A che sposta B, potrebbe benissimo essere che A si ferma proprio nel momento in cui B parte, senza che tra le due sussista un rapporto causale; gli Occasionalisti arriveranno a dire che B si sposta perché Dio interviene per spostarla in occasione del movimento di A (in sostanza, il moto di A sarebbe occasione affinchè Dio sposti B). Ma – nota Hume – se ripeto più volte l’esperimento, facendo urtare B da A nello stesso modo, l’esperienza mi fornisce la ripetitività, ossia attesta che tutte le volte che A colpisce B, B si muove; ma non mi dice mai che A causa il moto di B. Hume ne trae la conseguenza che l’esperienza non dà la conoscenza necessaria del rapporto causale, ma che la reiterazione dell’esperienza (cioè quella che Hume chiama "abitudine") può indurmi a credere con plausibilità che ciò che è avvenuto più volte avverrà anche in futuro, ma si tratta non di una conoscenza certa, bensì semplicemente di una "credenza" (come è la stragrande maggioranza delle nostre conoscenze: perfino che io sia sempre io o che gli oggetti da me percepiti continui a sussistere anche quando non li penso più è il frutto di una credenza): ho sempre visto che quando A tocca B, B si muove, e – per abitudine – è nata in me la credenza che ogni volta che A toccherà B, B si muoverà. Tale credenza, naturalmente, non è raffrontabile con la certezza del razionalismo cartesiano. Scrive Hume sul concetto di causa: "è evidente che tutti i ragionamenti sulle questioni di fatto si fondano sulla relazione di causa ed effetto, e che noi possiamo inferire l’esistenza di un oggetto da quella di un altro soltanto se si pone tra loro un nesso mediato o immediato. Per comprendere quei ragionamenti, ci occorre quindi una perfetta conoscenza dell’idea di causa. A questo scopo, guardiamoci attorno per trovare qualche cosa che sia la causa di un’altra. Ecco qui una palla ferma sul tavolo del biliardo, e un’altra palla che rapidamente si muove verso di essa. Si urtano, e la palla che prima era ferma ora acquista un movimento. Questo è un caso di relazione tra causa ed effetto, non meno perfetto di qualsiasi altro, che la sensazione o la riflessione ci facciano conoscere: conviene dunque esaminarlo. é chiaro che le due palle si sono toccate prima della trasmissione del moto, e che non c’é stato alcun intervallo tra l’urto e il movimento. La contiguità nel tempo e nello spazio è dunque una condizione necessaria dell’azione di ogni causa. È anche chiaro che il movimento, che era la causa, deve precedere l’altro, che era l’effetto. La priorità nel tempo è quindi un’altra condizione necessaria per ogni causa. Ma non basta. Facciamo l’esperimento con quante altre palle vogliamo, della medesima specie e in una situazione simile: troveremo sempre che la spinta dell’una produce il movimento dell’altra. Abbiamo dunque una terza condizione, ossia una unione costante tra causa ed effetto: qualunque oggetto simile alla causa produce sempre un oggetto simile all’effetto. Oltre a queste tre condizioni di contiguità, priorità, unione costante, io non so trovare altro in questo rapporto di causalità. La prima palla si muove e va ad urtare la seconda; subito la seconda si muove; e quando rifaccio la prova con palle uguali e simili, in condizioni uguali e simili, trovo che al movimento e all’urto della prima palla segue sempre il movimento della seconda. Da qualsiasi parte giri la questione e comunque la esamini, non vi so scoprire niente di piú. Cosí vanno le cose quando la causa e l’effetto sono presenti ai nostri sensi. Vediamo adesso quale fondamento abbia la nostra inferenza, quando dall’esistenza dell’una concludiamo all’esistenza passata e futura dell’altro. Se io osservo una palla che si muove verso un’altra in linea retta, subito ne deduco che esse si urteranno e che la seconda entrerà in movimento. é questa l’inferenza dalla causa all’effetto, e di tale natura sono tutti i nostri ragionamenti nella pratica quotidiana; su di essa si basa tutta la nostra fiducia negli avvenimenti storici e ogni scienza, tranne la geometria e l’aritmetica. Se riusciamo a spiegare l’inferenza che facciamo dall’urto di due palle, saremo in grado di giustificare la stessa operazione dello spirito in ogni altro caso". Hume distingue – sulla scorta di Locke – tra sensazioni (provenienti dall’esterno) e riflessioni (il rispecchiamento della mente su se stessa), ovvero ritiene che il principio di causalità valga anche per il mondo interno a noi: e, una volta che la causalità verrà risolta in abitudine, ciò varrà ovviamente anche per il mondo a noi interiore, e in qualche misura la libertà d’arbitrio verrà negata. L’esperienza – come abbiam visto – non ci dà il concetto di causalità, ma si limita a fornirci serie spazio/temporali e la possibilità di ripetere lo stesso esperimento conseguendo gli stessi risultati, sicchè il resto è frutto di una nostra aggiunta e non proviene dall’esperienza né dalla ragione (la quale lavora analiticamente), bensì nasce dall’abitudine a vedere sempre quella stessa cosa. La spiegazione causale, allora, ha natura extra-razionale, giacchè sfugge al rapporto analitico e non è data ad un rilevamento razionale dell’esperienza. Servendoci di una terminologia kantiana sensu stricto, possiamo legittimamente sostenere che tutti gli autori di impianto razionalistico che abbiamo esaminato finora si distinguono perché adottano un modello analitico (connettendo cioè elementi in base alla loro identità: A=B, il che significa che B è già tutto contenuto in A), seguito perfino da Locke (nella conoscenza prevale l’intuizione sulla dimostrazione, intesa come catena di intuizioni), e da Leibniz (che esplicita il principio su cui si regge tale modello analitico: il principio di identità e di non contraddizione): anche l’empirismo estremo (e scetticheggiante) di Hume lo accetta, ma lo limita al settore delle conoscenze logico/matematiche, ossia delle conoscenze certe (sarà poi Kant a demolire questo modello), cosicchè assistiamo ad un passaggio dall’atteggiamento gnoseologico che lo vuole valido universalmente ad una posizione (quella di Hume appunto) per cui è il modello più rigoroso ma anche meno estendibile nella realtà; come dice Leibniz stesso, un tale modello è valido solo per le "verità di ragione", ossia per l’ambito logico/matematico. Nel razionalismo seicentesco, tuttavia, accanto al modello analitico, è anche emerso il modello sintetico (per il quale la conoscenza è data dall’aggiunta di un elemento ad un altro e tale aggiunta si esprime in termini causali: B non è già contenuto in A, ma si aggiunge ad A, configurandosi come diverso e nuovo), propugnato da Hobbes e da Vico. Il fatto che se B non è già contenuto a priori in A (ossia il fatto che l’effetto differisca dalla causa) implica che non si possa mai essere sicuri che si tratti di una connessione necessaria, cosicchè non possiamo mai dire con certezza che B deriva da A; a meno che non vi sia l’autocausalità: se cioè sono io stesso la A che causa B posso esser certo della loro connessione, appunto perchè sono io stesso a causarla (e tale è la situazione di Dio, che è la causa dell’intero mondo); se però non sono io la causa, allora posso solo fare delle supposizioni più o meno probabili: solo di ciò che io stesso sono causa posso avere certezza (verum ipsum factum). C’era però un altro modo per garantire la certezza di B in tutti i casi (e non solo quando sono io stesso la causa), e questo modo consiste nel cercare di mostrare come il rapporto causale (il rapporto sintetico intercorrente fra A e B) sia nella natura ontologica della realtà, e non sia solo un mero principio gnoseologico: in questo caso, la conoscenza non sarebbe altro che rilevare tale criterio (così per Aristotele la struttura del sillogismo rispecchiava la struttura della realtà); ovvero basterebbe dimostrare che la realtà ha struttura causale e che non è solo la mia mente a legare tra loro causalmente A e B. Si può, seguendo questo percorso, procedere lungo vie diverse, che però portano alla medesima destinazione: è questo il caso di Leibniz e di Spinoza. Finora, i termini "intelletto" e "ragione" erano stati sinonimici, ma con Spinoza cominciano a distinguersi nettamente.
David Hume ha in comune con Locke e con Hobbes il riconoscimento che tutto il materiale della nostra conoscenza provenga dall’esperienza; egli asserisce – in termini meno compromissori col cartesianesimo rispetto agli altri due autori – che tutte le nostre rappresentazioni sono impressioni e idee: le "impressioni" – spiega Hume – sono le rappresentazioni delle cose nel momento in cui tali cose sono attualmente percepite attraverso l’empiria (vedo il tavolo, ne ho una rappresentazione), mentre le idee sono le rappresentazioni che abbiamo delle cose quando queste non sono più percepite attualmente, ma vivono solo nella nostra memoria (penso al tavolo senza averlo di fronte); in sostanza, si può legittimamente dire che l’idea è ciò che resta dell’impressione quando viene a mancare l’oggetto esterno dell’esperienza, sono cioè impressioni illanguidite e meno vivaci. Hume concorda pienamente con Locke sul fatto che le singole idee e le singole impressioni non costituiscano conoscenze, ma siano solo le tessere sparpagliate di un mosaico che devono essere riconnesse: ma tale connessione (e in ciò Hume prende le distanze da Locke, da Hobbes e dal cartesianesimo) avviene perché certe conoscenze possono attuarsi solo per procedure razionalistico/analitiche, ma oltre un certo limite tale procedura si rivela assolutamente impotente. Il primo ambito in cui vale il metodo razionalistico/analitico è quello delle conoscenze astratte e universali derivanti dal semplice confronto tra le idee, e qui Hume si limita a ripetere quanto già detto da Cartesio e da Locke, ma esplicitando meglio come alla base di tali conoscenze stia il principio di identità (da Hume sfumatamente detto "criterio di somiglianza"). Si tratterà, allora, delle conoscenze matematiche, del tipo 2+2=4, in cui da una parte abbiamo l’idea del 2+2 e dall’altra quella del 4, e non appena le mettiamo a confronto appaiono immediatamente uguali (2+2 è appunto uguale a 4). Ora, per sottolineare la consonanza col razionalismo, occorre notare come – qualche anno prima rispetto a Hume – un razionalista convinto come Leibniz avesse detto cose del tutto analoghe, parlando esplicitamente di "verità di ragione"): "vi sono pure due specie di verità, quelle di ragione, e quelle di fatto. Le verità di ragione sono necessarie ed il loro opposto è impossibile, quelle di fatto sono contingenti ed il loro opposto è possibile" (Leibniz, "Monadologia", 33). Così, quando dico che la somma degli angoli interni di un triangolo è uguale a 180 gradi, con tale proposizione esplicito qualcosa di già del tutto contenuto nella nozione stessa di triangolo, senza aggiungere un’idea ad un’altra: appunto, mi limito ad esplicitare qualcosa di già presente, sicchè l’intera matematica è per Hume un’immensa tautologia: da A si tira fuori B, che però era già implicito in A (Kant parlerà a tal proposito di "giudizi analitici a priori", ma vorrà spingersi al di là di essi). Hume si trova in questo d’accordo con il razionalismo cartesiano: quando facciamo ragionamenti di tipo logico, necessariamente ci basiamo sul principio di identità, ma non tutte le conoscenze sono secondo Hume di questo genere. Quando ad esempio vedo che sul tavolo da biliardo la palla A urta la palla B e questa si muove, ciò non può essere spiegato con il medesimo criterio analitico con cui spiegavo che 2+2 dà 4, poiché l’effetto (il moto della palla B) non è già contenuto in A (mentre invece il 4 era già contenuto nel 2+2), ma è qualcosa di diverso e, essendo tale, non mi è possibile indovinarlo in base ad A, non basta cioè esaminare A per capire che da essa scaturirà B, come invece basta guardare l’idea di 7+5 per ricavarne automaticamente il 12. E l’errore dei razionalisti sta appunto nel non aver seguito il metodo dell’identità (anticipato da Cartesio e ripreso da Locke e Leibniz) e nell’aver ritenuto possibile derivare con la ragione le conseguenze dalle cause: si tratta – nota Hume – di una mera illusione della ragione, giacchè essa, confrontando le idee, può solo tirarne fuori (con un’operazione analitica) ciò che esse già contengono, ma non può estrarre dall’idea di causa quella di effetto. Scrive a tal proposito Hume: "se un uomo fosse creato, come Adamo, già nel pieno vigore dell’intelligenza, non potrebbe mai, senza farne l’esperienza, concludere al movimento della seconda palla dal movimento e dalla spinta della prima. La ragione non vede nulla nella causa, che la muova ad inferire l’effetto"; era Hobbes che pretendeva di dimostrare la derivabilità dell’effetto dalla causa, ma ciò è secondo Hume impossibile, poiché il modello razionalistico è eccellente se applicato alla matematica e alla logica, ma quando devo spiegare un dato di fatto (matter of fact), quale può essere il moto della palla B urtata dalla palla A, la ragione non può analiticamente dirmi che da A derivi B, ed ecco che allora si pone un problema del tutto nuovo. Come giustificare le connessioni che si riferiscono non a idee astratte (2+2=4), ma a dati concreti (il moto delle palle sulla tavola da biliardo)? Una possibile via per un empirista quale è Hume sta nell’ammettere che il rapporto causale non lo trovo nella ragione ma nell’esperienza: ma posso davvero dire che l’esperienza mi dia ciò? Parrebbe di sì: quando vedo la palla A urtare la palla B, posso dire di vedere la causalità? Vedo davvero A che sposta B o vedo qualcos’altro? Hume risponde che in realtà io non vedo A che sposta B, ma vedo semplicemente una successione spazio/temporale (A e B che si muovono nello spazio e nel tempo), non vedo mai A che sposta B, potrebbe benissimo essere che A si ferma proprio nel momento in cui B parte, senza che tra le due sussista un rapporto causale; gli Occasionalisti arriveranno a dire che B si sposta perché Dio interviene per spostarla in occasione del movimento di A (in sostanza, il moto di A sarebbe occasione affinchè Dio sposti B). Ma – nota Hume – se ripeto più volte l’esperimento, facendo urtare B da A nello stesso modo, l’esperienza mi fornisce la ripetitività, ossia attesta che tutte le volte che A colpisce B, B si muove; ma non mi dice mai che A causa il moto di B. Hume ne trae la conseguenza che l’esperienza non dà la conoscenza necessaria del rapporto causale, ma che la reiterazione dell’esperienza (cioè quella che Hume chiama "abitudine") può indurmi a credere con plausibilità che ciò che è avvenuto più volte avverrà anche in futuro, ma si tratta non di una conoscenza certa, bensì semplicemente di una "credenza" (come è la stragrande maggioranza delle nostre conoscenze: perfino che io sia sempre io o che gli oggetti da me percepiti continui a sussistere anche quando non li penso più è il frutto di una credenza): ho sempre visto che quando A tocca B, B si muove, e – per abitudine – è nata in me la credenza che ogni volta che A toccherà B, B si muoverà. Tale credenza, naturalmente, non è raffrontabile con la certezza del razionalismo cartesiano. Scrive Hume sul concetto di causa: "è evidente che tutti i ragionamenti sulle questioni di fatto si fondano sulla relazione di causa ed effetto, e che noi possiamo inferire l’esistenza di un oggetto da quella di un altro soltanto se si pone tra loro un nesso mediato o immediato. Per comprendere quei ragionamenti, ci occorre quindi una perfetta conoscenza dell’idea di causa. A questo scopo, guardiamoci attorno per trovare qualche cosa che sia la causa di un’altra. Ecco qui una palla ferma sul tavolo del biliardo, e un’altra palla che rapidamente si muove verso di essa. Si urtano, e la palla che prima era ferma ora acquista un movimento. Questo è un caso di relazione tra causa ed effetto, non meno perfetto di qualsiasi altro, che la sensazione o la riflessione ci facciano conoscere: conviene dunque esaminarlo. é chiaro che le due palle si sono toccate prima della trasmissione del moto, e che non c’é stato alcun intervallo tra l’urto e il movimento. La contiguità nel tempo e nello spazio è dunque una condizione necessaria dell’azione di ogni causa. È anche chiaro che il movimento, che era la causa, deve precedere l’altro, che era l’effetto. La priorità nel tempo è quindi un’altra condizione necessaria per ogni causa. Ma non basta. Facciamo l’esperimento con quante altre palle vogliamo, della medesima specie e in una situazione simile: troveremo sempre che la spinta dell’una produce il movimento dell’altra. Abbiamo dunque una terza condizione, ossia una unione costante tra causa ed effetto: qualunque oggetto simile alla causa produce sempre un oggetto simile all’effetto. Oltre a queste tre condizioni di contiguità, priorità, unione costante, io non so trovare altro in questo rapporto di causalità. La prima palla si muove e va ad urtare la seconda; subito la seconda si muove; e quando rifaccio la prova con palle uguali e simili, in condizioni uguali e simili, trovo che al movimento e all’urto della prima palla segue sempre il movimento della seconda. Da qualsiasi parte giri la questione e comunque la esamini, non vi so scoprire niente di piú. Cosí vanno le cose quando la causa e l’effetto sono presenti ai nostri sensi. Vediamo adesso quale fondamento abbia la nostra inferenza, quando dall’esistenza dell’una concludiamo all’esistenza passata e futura dell’altro. Se io osservo una palla che si muove verso un’altra in linea retta, subito ne deduco che esse si urteranno e che la seconda entrerà in movimento. é questa l’inferenza dalla causa all’effetto, e di tale natura sono tutti i nostri ragionamenti nella pratica quotidiana; su di essa si basa tutta la nostra fiducia negli avvenimenti storici e ogni scienza, tranne la geometria e l’aritmetica. Se riusciamo a spiegare l’inferenza che facciamo dall’urto di due palle, saremo in grado di giustificare la stessa operazione dello spirito in ogni altro caso". Hume distingue – sulla scorta di Locke – tra sensazioni (provenienti dall’esterno) e riflessioni (il rispecchiamento della mente su se stessa), ovvero ritiene che il principio di causalità valga anche per il mondo interno a noi: e, una volta che la causalità verrà risolta in abitudine, ciò varrà ovviamente anche per il mondo a noi interiore, e in qualche misura la libertà d’arbitrio verrà negata. L’esperienza – come abbiam visto – non ci dà il concetto di causalità, ma si limita a fornirci serie spazio/temporali e la possibilità di ripetere lo stesso esperimento conseguendo gli stessi risultati, sicchè il resto è frutto di una nostra aggiunta e non proviene dall’esperienza né dalla ragione (la quale lavora analiticamente), bensì nasce dall’abitudine a vedere sempre quella stessa cosa. La spiegazione causale, allora, ha natura extra-razionale, giacchè sfugge al rapporto analitico e non è data ad un rilevamento razionale dell’esperienza. Servendoci di una terminologia kantiana sensu stricto, possiamo legittimamente sostenere che tutti gli autori di impianto razionalistico che abbiamo esaminato finora si distinguono perché adottano un modello analitico (connettendo cioè elementi in base alla loro identità: A=B, il che significa che B è già tutto contenuto in A), seguito perfino da Locke (nella conoscenza prevale l’intuizione sulla dimostrazione, intesa come catena di intuizioni), e da Leibniz (che esplicita il principio su cui si regge tale modello analitico: il principio di identità e di non contraddizione): anche l’empirismo estremo (e scetticheggiante) di Hume lo accetta, ma lo limita al settore delle conoscenze logico/matematiche, ossia delle conoscenze certe (sarà poi Kant a demolire questo modello), cosicchè assistiamo ad un passaggio dall’atteggiamento gnoseologico che lo vuole valido universalmente ad una posizione (quella di Hume appunto) per cui è il modello più rigoroso ma anche meno estendibile nella realtà; come dice Leibniz stesso, un tale modello è valido solo per le "verità di ragione", ossia per l’ambito logico/matematico. Nel razionalismo seicentesco, tuttavia, accanto al modello analitico, è anche emerso il modello sintetico (per il quale la conoscenza è data dall’aggiunta di un elemento ad un altro e tale aggiunta si esprime in termini causali: B non è già contenuto in A, ma si aggiunge ad A, configurandosi come diverso e nuovo), propugnato da Hobbes e da Vico. Il fatto che se B non è già contenuto a priori in A (ossia il fatto che l’effetto differisca dalla causa) implica che non si possa mai essere sicuri che si tratti di una connessione necessaria, cosicchè non possiamo mai dire con certezza che B deriva da A; a meno che non vi sia l’autocausalità: se cioè sono io stesso la A che causa B posso esser certo della loro connessione, appunto perchè sono io stesso a causarla (e tale è la situazione di Dio, che è la causa dell’intero mondo); se però non sono io la causa, allora posso solo fare delle supposizioni più o meno probabili: solo di ciò che io stesso sono causa posso avere certezza (verum ipsum factum). C’era però un altro modo per garantire la certezza di B in tutti i casi (e non solo quando sono io stesso la causa), e questo modo consiste nel cercare di mostrare come il rapporto causale (il rapporto sintetico intercorrente fra A e B) sia nella natura ontologica della realtà, e non sia solo un mero principio gnoseologico: in questo caso, la conoscenza non sarebbe altro che rilevare tale criterio (così per Aristotele la struttura del sillogismo rispecchiava la struttura della realtà); ovvero basterebbe dimostrare che la realtà ha struttura causale e che non è solo la mia mente a legare tra loro causalmente A e B. Si può, seguendo questo percorso, procedere lungo vie diverse, che però portano alla medesima destinazione: è questo il caso di Leibniz e di Spinoza. Finora, i termini "intelletto" e "ragione" erano stati sinonimici, ma con Spinoza cominciano a distinguersi nettamente.
LEIBNIZ
 Gottfried Leibniz segue una strada particolare ed esclude radicalmente che il rapporto causale abbia validità esterna: tra le cose non sussiste alcuna causalità, sicchè quando sul tavolo da biliardo la palla B si muove quando è urtata dalla palla A, ciò non avviene perché A causa il moto di B. In questa maniera, Leibniz si spiana la strada, aggirando più che risolvendolo il problema: di fronte all’evidente difficoltà del giustificare la causalità tra le cose, egli la nega. Ma come si spiega allora che quando la palla A urta quella B, quest’ultima si muove? Leibniz dice che a noi pare che A sia la causa del moto di B, ma si tratta di mera apparenza, giacchè in realtà è Dio che ha voluto che la palla A avesse una sua storia e che colpisse B, la quale è dotata a sua volta di una sua storia per cui ad un certo punto si mette in moto: A e B si muovono indipendentemente l’una dall’altra. Con questa posizione, Leibniz si avvicina molto all’occasionalismo di Malebranche, anche se il pensatore tedesco non concepisce l’intervento divino come continuo (come se ogni volta che A tocca B Dio intervenisse a muovere B stessa), ma piuttosto come una predisposizione originaria: in origine Dio ha – secondo Leibniz – creato ogni cosa in un’armonia perfetta, predisponendo le varie cose come orologi caricati sincronicamente, in grado di procedere per loro conto senza necessità di intervento; la posizione occasionalista, invece, prevede che Dio debba continuamente intervenire nel mondo. Pur bandito dai rapporti fra le sostanze, il rapporto causale sussiste all’interno delle singole sostanze stesse, e Leibniz si fa portavoce di un pluralismo metafisico, sostenendo – aristotelicamente – che le sostanze sono tante quanti sono gli individui. Per addurre prove a sostegno della sua tesi, egli arriva a far coincidere il rapporto causale con la relazione (aristotelica) fra sostanza e predicato: da sempre siamo abituati a concepire il predicato come un qualcosa che si aggiunge al soggetto, cosicchè dire che "Socrate" (soggetto) è "camuso" (predicato), significa appunto aggiungere qualcosa alla sostanza individuale "Socrate". Ora, tradizionalmente, tale inerenza del predicato al soggetto è considerata come espressione meramente logica, esistente non nella realtà esterna, ma nella nostra mente (la quale congiunge, appunto, il soggetto e il predicato, dicendo che "Socrate è camuso"), sicchè potrò dire che "la penna è nera", aggiungendo a livello logico al soggetto "penna" il predicato "nera" che le inerisce. Ma – continua Leibniz – in realtà sussiste una coincidenza assoluta tra logica e metafisica, tra pensiero ed essere, sicchè il soggetto non è mai meramente logico, ma è sempre una sostanza individuale precisa (Cesare, Socrate, Alessandro Magno, ecc.) e il predicato che logicamente le inerisce è anch’esso non già una nozione puramente logica, bensì una determinazione reale di tale sostanza reale: non è un caso che, quando noi diciamo "inerire", Leibniz usi invece l’espressione latina inesse, con un evidente significato ontologico (inesse significa "essere dentro"); in questo modo, viene dimostrato che non si tratta di una relazione meramente logica, esulante dal reale. Al contrario, sussiste una sostanza reale (ad esempio Alessandro Magno), a cui ineriscono determinati predicati (l’esser uomo, il diventare re dei Macedoni, il vincere Dario, il nutrire grande affetto per il
Gottfried Leibniz segue una strada particolare ed esclude radicalmente che il rapporto causale abbia validità esterna: tra le cose non sussiste alcuna causalità, sicchè quando sul tavolo da biliardo la palla B si muove quando è urtata dalla palla A, ciò non avviene perché A causa il moto di B. In questa maniera, Leibniz si spiana la strada, aggirando più che risolvendolo il problema: di fronte all’evidente difficoltà del giustificare la causalità tra le cose, egli la nega. Ma come si spiega allora che quando la palla A urta quella B, quest’ultima si muove? Leibniz dice che a noi pare che A sia la causa del moto di B, ma si tratta di mera apparenza, giacchè in realtà è Dio che ha voluto che la palla A avesse una sua storia e che colpisse B, la quale è dotata a sua volta di una sua storia per cui ad un certo punto si mette in moto: A e B si muovono indipendentemente l’una dall’altra. Con questa posizione, Leibniz si avvicina molto all’occasionalismo di Malebranche, anche se il pensatore tedesco non concepisce l’intervento divino come continuo (come se ogni volta che A tocca B Dio intervenisse a muovere B stessa), ma piuttosto come una predisposizione originaria: in origine Dio ha – secondo Leibniz – creato ogni cosa in un’armonia perfetta, predisponendo le varie cose come orologi caricati sincronicamente, in grado di procedere per loro conto senza necessità di intervento; la posizione occasionalista, invece, prevede che Dio debba continuamente intervenire nel mondo. Pur bandito dai rapporti fra le sostanze, il rapporto causale sussiste all’interno delle singole sostanze stesse, e Leibniz si fa portavoce di un pluralismo metafisico, sostenendo – aristotelicamente – che le sostanze sono tante quanti sono gli individui. Per addurre prove a sostegno della sua tesi, egli arriva a far coincidere il rapporto causale con la relazione (aristotelica) fra sostanza e predicato: da sempre siamo abituati a concepire il predicato come un qualcosa che si aggiunge al soggetto, cosicchè dire che "Socrate" (soggetto) è "camuso" (predicato), significa appunto aggiungere qualcosa alla sostanza individuale "Socrate". Ora, tradizionalmente, tale inerenza del predicato al soggetto è considerata come espressione meramente logica, esistente non nella realtà esterna, ma nella nostra mente (la quale congiunge, appunto, il soggetto e il predicato, dicendo che "Socrate è camuso"), sicchè potrò dire che "la penna è nera", aggiungendo a livello logico al soggetto "penna" il predicato "nera" che le inerisce. Ma – continua Leibniz – in realtà sussiste una coincidenza assoluta tra logica e metafisica, tra pensiero ed essere, sicchè il soggetto non è mai meramente logico, ma è sempre una sostanza individuale precisa (Cesare, Socrate, Alessandro Magno, ecc.) e il predicato che logicamente le inerisce è anch’esso non già una nozione puramente logica, bensì una determinazione reale di tale sostanza reale: non è un caso che, quando noi diciamo "inerire", Leibniz usi invece l’espressione latina inesse, con un evidente significato ontologico (inesse significa "essere dentro"); in questo modo, viene dimostrato che non si tratta di una relazione meramente logica, esulante dal reale. Al contrario, sussiste una sostanza reale (ad esempio Alessandro Magno), a cui ineriscono determinati predicati (l’esser uomo, il diventare re dei Macedoni, il vincere Dario, il nutrire grande affetto per il
LIBERTA’ E NECESSITA’ DAI GRECI AD OGGI
INTRODUZIONE
Nel corso della storia assistiamo al contrapporsi di due diversi modelli di libertà: da un lato, la libertà come libero arbitrio, ossia come possibilità di decidere arbitrariamente tra due o più alternative (si tratta di quella che gli scolastici definivano potestas ad utrumque): essa è la libertà di indifferenza, tale per cui quando ci si trova a dover compiere una scelta è indifferente che si scelga A piuttosto che B, nel senso che non vi è nessun condizionamento che implichi dall’esterno una differenza e che ci indirizzi a scegliere una cosa anziché un’altra. In quest’accezione, questo modello può essere concepito come modello della “libertà di” fare così oppure non così. Dall’altro lato, troviamo la libertà come assenza di costrizione, la libertas a coactione degli scolastici: non è più l’indifferenza della scelta, tale per cui posso decidere liberamente di scegliere o A o B, ma si tratta piuttosto di una libertà in virtù della quale sia che io scelga A sia che io scelga B non sono condizionato da una costrizione, sia essa esterna (qualcuno che mi obbliga ad agire in un determinato modo) sia essa interna (le mie passioni). Questo secondo modello implica non già una “libertà di”, bensì una “libertà da”. Stando a quanto abbiamo finora detto, questi due tipi di libertà possono apparire non troppo diversificate, cosicché è opportuno produrre altre distinzioni più incisive: innanzitutto, possiamo notare come la “libertà di” sia sempre considerata come libertà positiva, in quanto si tratta di determinare l’oggetto del volere e sono io stesso a deciderlo; sicchè la “libertà di” comporta la libertà di volere ciò che ancora non si vuole, per cui siamo noi stessi a determinare la nostra volontà: l’uomo non sceglie perché vuole, ma vuole perché sceglie. Sull’altro versante – quello della “libertà da” – ci troviamo dinanzi ad una libertà di tipo negativo, giacchè ciò che si vuole è sempre già presupposto, cosicché io so già che cosa voglio e non sono io a sceglierlo. Dunque, si può dire che nel caso della “libertà di” ciò che voglio non mi è imposto (e per ciò sono realmente libero), mentre nel caso della “libertà da” mi è imposto (e perciò non sono libero). Un’ulteriore distinzione può essere operata tenendo conto del rapporto che queste due forme di libertà intrattengono con la contingenza o con la necessità: entrambe le due tipologie di libertà presuppongono una razionalità dell’azione (voglio e scelgo qualcosa sulla base di un disegno razionale), ma diverso è il rapporto sussistente tra la razionalità e il contesto in cui essa si esprime. Nel caso del libero arbitrio (la “libertà di”), il contesto in cui mi trovo ad operare deve presupporre un certo livello di contingenza, giacchè, affinchè io possa scegliere A anziché B, occorre che l’ordine esterno delle cose sia tale da consentire tanto la realizzazione di A quanto quella di B: ciò significa che non deve essere già predeterminato che si verifichi A anziché B. Questa condizione di indeterminatezza non è invece richiesta dal modello della “libertà da”, il che sembrerebbe a dir poco assurdo: come si può, infatti, parlare di libertà e, al contempo, ammettere che viga un determinismo in forza del quale sia già decretato che si verifichi A piuttosto che B? Tale assurdità cessa di essere tale se teniamo presente che a togliere la libertà non è la necessità in sé, ma solamente quella esterna, ovvero quel che agisce sul soggetto essendo ad esso esterno. Anche le forze interne (ad esempio le passioni o le abitudini) vengono considerate come esterne alla razionalità del soggetto agente, sicché se mi trovo ad esser determinato dalle mie passioni nell’agire sono coatto da qualcosa a fare ciò che la mia ragione mi indurrebbe a non fare: se ne evince che anche ciò che pare di primo acchito essere una forza interna (le passioni), è in realtà esterna, in quanto opponentesi alla razionalità del soggetto. Se questi agisce mosso da un principio di razionalità assoluta, allora agisce seguendo una necessità che rispecchia l’ordine necessario del mondo: non è costretto da forze esterne, ma obbedisce ad un principio necessario dell’azione, essendo in tal modo libero in quanto la forza che mi condiziona è identica alla mia stessa soggettività: in altri termini, sono io stesso quella forza. In questo senso, la libertà risulta conciliabile con la necessità: il caso paradigmatico di questa concezione è rappresentato da Spinoza, per il quale l’uomo che segue la necessità imperante nel cosmo realizza la sua libertà, intesa ovviamente non come facoltà di scegliere A anziché B, bensì come “libertà da” costrizioni. Sotto questo profilo, il livello della libertà intesa come negativa e come positiva viene un po’ corretto e sfumato, giacchè la “libertà da” porta ad identificarsi con il principio causale dell’agire, che così cessa di essere vincolante e negativo. Tuttavia, deve essere sottolineato come, se il problema della libertà è così complesso e irrisolvibile, ciò sia dovuto precipuamente alla difficoltà e alla polisemia dei termini impiegati nell’affrontarlo, tali da non afferrare mai del tutto che cosa realmente la libertà sia: se almeno si sapesse con certezza che cosa essa sia, si potrebbe per lo meno univocamente capire se l’uomo ne sia equipaggiato oppure no. Invece risulta assai arduo, ancor prima di decidere se l’uomo sia libero o no, capire che cosa effettivamente la libertà sia, e ulteriori complicazioni sono introdotte dal fatto che, accanto ai due modelli da noi proposti, se ne sono sviluppati molti altri da essi derivanti.
trovo ad operare deve presupporre un certo livello di contingenza, giacchè, affinchè io possa scegliere A anziché B, occorre che l’ordine esterno delle cose sia tale da consentire tanto la realizzazione di A quanto quella di B: ciò significa che non deve essere già predeterminato che si verifichi A anziché B. Questa condizione di indeterminatezza non è invece richiesta dal modello della “libertà da”, il che sembrerebbe a dir poco assurdo: come si può, infatti, parlare di libertà e, al contempo, ammettere che viga un determinismo in forza del quale sia già decretato che si verifichi A piuttosto che B? Tale assurdità cessa di essere tale se teniamo presente che a togliere la libertà non è la necessità in sé, ma solamente quella esterna, ovvero quel che agisce sul soggetto essendo ad esso esterno. Anche le forze interne (ad esempio le passioni o le abitudini) vengono considerate come esterne alla razionalità del soggetto agente, sicché se mi trovo ad esser determinato dalle mie passioni nell’agire sono coatto da qualcosa a fare ciò che la mia ragione mi indurrebbe a non fare: se ne evince che anche ciò che pare di primo acchito essere una forza interna (le passioni), è in realtà esterna, in quanto opponentesi alla razionalità del soggetto. Se questi agisce mosso da un principio di razionalità assoluta, allora agisce seguendo una necessità che rispecchia l’ordine necessario del mondo: non è costretto da forze esterne, ma obbedisce ad un principio necessario dell’azione, essendo in tal modo libero in quanto la forza che mi condiziona è identica alla mia stessa soggettività: in altri termini, sono io stesso quella forza. In questo senso, la libertà risulta conciliabile con la necessità: il caso paradigmatico di questa concezione è rappresentato da Spinoza, per il quale l’uomo che segue la necessità imperante nel cosmo realizza la sua libertà, intesa ovviamente non come facoltà di scegliere A anziché B, bensì come “libertà da” costrizioni. Sotto questo profilo, il livello della libertà intesa come negativa e come positiva viene un po’ corretto e sfumato, giacchè la “libertà da” porta ad identificarsi con il principio causale dell’agire, che così cessa di essere vincolante e negativo. Tuttavia, deve essere sottolineato come, se il problema della libertà è così complesso e irrisolvibile, ciò sia dovuto precipuamente alla difficoltà e alla polisemia dei termini impiegati nell’affrontarlo, tali da non afferrare mai del tutto che cosa realmente la libertà sia: se almeno si sapesse con certezza che cosa essa sia, si potrebbe per lo meno univocamente capire se l’uomo ne sia equipaggiato oppure no. Invece risulta assai arduo, ancor prima di decidere se l’uomo sia libero o no, capire che cosa effettivamente la libertà sia, e ulteriori complicazioni sono introdotte dal fatto che, accanto ai due modelli da noi proposti, se ne sono sviluppati molti altri da essi derivanti.
I GRECI
Dopo aver preso atto di quanto sia difficile la problematica, possiamo allora chiederci quando storicamente ci si sia per la prima volta interrogati su di essa: la cultura greca, pur così acuta e ingegnosa, non si pose più di tanto il problema della libertà, prova ne è il fatto che la lingua greca sia sprovvista di un termine che designi propriamente la “libertà”, tenendo conto che eleuqeria designa esclusivamente la libertà in sede politica (libertà dalla tirannia, dai Persiani, ecc) e ha ben poco a che vedere con la possibilità di riconoscere all’uomo una responsabilità dell’azione. Non è poi un caso che nelle tragedie, che dello spirito greco furono il vertice, il coro, per spiegare le azioni dei protagonisti, faccia costante riferimento alla anagkh Moira tuch , tutte forze che condizionano l’uomo impedendogli di esercitare qualsiasi forma di libertà. Anche quando si fa più vivo il senso della responsabilità – e ciò avviene con le scuole fiorite in età ellenistica – e spiccato diventa l’interesse etico, la giusta azione dell’uomo non è mai sottrazione alla forza che regna nell’universo, ma anzi adeguamento ad essa, intesa come razionalità positiva (il LogoV degli stoici) – permeante ogni cosa, ivi compreso l’uomo – a cui conformarsi o a cui opporre stupidamente resistenza, come fa il cane che, legato al carro, anziché seguirlo sua sponte, gli si oppone, con il risultato che è da esso ugualmente trascinato, ma con maggiori sofferenze. Questa concezione è sinteticamente ducunt volentem fata, nolentem trahunt. Già Gorgia, nel comporre il suo Encomio di Elena, di questa donna universalmente disprezzata come fedifraga, la giustifica spiegando che è stata persuasa dalla parola – la quale può tutto – e che dunque non avrebbe potuto agire altrimenti. Si affaccia cioè la prospettiva che anche il linguaggio sia un’altra di quelle forze estrinseche che necessitano gli uomini (e le donne), e non è un caso che Nietzsche scorga l’esordio del crollo greco proprio in Socrate e in Euripide, che per primi hanno cercato nell’uomo una responsabilità dell’agire. Anche in Platone e Aristotele il problema della libertà umana è molto opaco e, per così dire, solo accennato: data l’incredibile statura di questi due pensatori, ciò non fa altro che avvalorare la nostra tesi secondo cui la cultura greca era ancora troppo poco matura per interrogarsi seriamente su tale problematica, alla quale forse solo Epicuro dedica degna attenzione quando – nella Lettera a Meneceo – sente il bisogno di sconfessare il determinismo derivante dalla anagkh . In Platone compare un accenno alla possibilità di scegliere liberamente, ma è una comparsa cursoria e, per di più, all’interno di un mito: si tratta del famoso mito di Er (esposto nel libro decimo della Repubblica), di questo glorioso quanto esotico guerriero morto e risorto che narra ciò che accade nell’aldilà; egli racconta che le anime, prima di incarnarsi e di riprendere il loro ciclo vitale sulla terra, hanno l’opportunità di scegliere il tipo di vita a cui andare incontro e – osserva Platone – la scelta non è assoluta, poiché chi sceglie per primo non ha più possibilità rispetto a chi sceglie per ultimo con minor disponibilità di scelta. A contare realmente nello scegliere liberamente è, invece, la saggezza, cosicché il primo a scegliere – riferisce Er a riguardo di ciò che lui stesso ha visto – dà prova di stoltezza nel voler reincarnarsi in un tiranno, mentre l’ultimo – Ulisse stesso – si rivela intelligente nell’optare per una vita comune, quieta e senza lodi o accuse. Poi però Platone non tornerà più su queste idee, qui accennate in forma mitologica, ma si può notare come la scelta descritta da Er sia comunque una scelta esclusivamente iniziale, tale per cui ciascuno di noi sceglie all’inizio in quale vita calarsi ma, dopo di che, non ha più libertà di scelta, il che ben rispecchia l’adesione platonica all’imperativo socratico – ostacolante a monte la possibilità di un’autentica scelta tra bene e male – dell’impossibilità di scegliere deliberatamente il male: ad avviso di Socrate – qui risiede il suo “intellettualismo etico” -, nessuno compie il male volontariamente, bensì lo fa solamente perché ignora la sua reale entità, cosicché basta sapere che cosa sia il male per evitarlo. Contro questo principio socratico secondo cui sarebbe impossibile scegliere scientemente il male si schiera Aristotele, il quale obietta che, se le cose stessero davvero in quei termini, non si spiegherebbe perché vengano comminate pene a chi fa il male ed elargiti premi a chi fa il bene, come se effettivamente sussistesse la responsabilità dell’agire negata da Socrate. Si tratta allora – nota Aristotele – di rinvenire un principio di imputabilità per stabilire che – il paragone è aristotelico – siamo padri delle nostre azioni non meno che dei nostri figli: per fare ciò, lo Stagirita elabora un’attenta distinzione tra azioni volontarie (ecousia ) e azioni involontarie ( acousia ): le seconde sono compiute “per costrizione ( bia ) e per ignoranza ( diagnoia )“, mentre le prime sono quelle “il cui principio risiede nel soggetto che conosce le condizioni in cui si svolge l’azione“. In questo senso, l’ aition dell’agire non è a me esterno, ma sono io stesso a sceglierlo spontaneamente, in quanto il soggetto ha conoscenza della situazione (è questa una concessione all’intellettualismo etico di Socrate): se ne evince che spontaneità e consapevolezza costituiscono il motore dell’agire volontario. Si affaccia per la prima volta sullo scenario greco il principio di imputabilità, che garantisce la responsabilità dell’azione, anche se in realtà Aristotele ritiene poi che alla base di tali azioni (volontarie o involontarie che siano) vi sia sempre una orexiV boulh proairhsiV , “preferenza” – altro non è se non il preferire certe cose ad altre (ritenendo queste ultime meno utili ed efficaci rispetto alle prime), ma non si tratta mai sensu stricto di una “libertà di”, giacchè è sempre e comunque soggiogata alla orexiV e alla boulh . In questo senso, è lecito affermare che in Aristotele manchi tanto la “libertà di” quanto la “libertà da”.I CRISTIANI
Col tramonto della cultura greca e il sorgere di quella cristiana si inverte rotta, in primis perché il cristianesimo propugna una concezione personale di Dio, tale per cui sussiste un’analogia tra Dio e l’uomo anche sul piano delle facoltà spirituali: Dio non è solo pensiero (come credeva invece Aristotele), ma è anche – e soprattutto – volontà, e tale dualismo si riverbera sull’uomo, che è stato creato a Sua immagine e somiglianza. Sicchè l’uomo, oltre a pensare, sa anche volere liberamente: la priorità in Dio della volontà sull’intellettualità costituisce il cavallo di battaglia della tradizione cristiana non tomista (Duns Scoto e Guglielmo da Ockham soprattutto), poiché al Dio come mero pensiero rispecchiante l’ordine del cosmo (a cui Egli non può sottrarsi) si sostituisce un Dio onnipotente, tale da poter liberamente fare ciò che vuole, a tal punto da determinare secondo la Sua volontà le leggi del pensiero: alcuni filosofi medioevali arriveranno a dire che due più due fa quattro perché Dio ha deciso così, ma se Egli avesse deciso che facesse cinque, allora due più due farebbe cinque. Da qui prende le mosse una lunga tradizione volontarista (tipicamente francescana) che fa dell’uomo un ente pensante e – soprattutto – capace di scegliere liberamente se fare il bene oppure il male. Nella cultura greca le azioni erano riflesso di una legge generale corrispondente ora al logoV, ora alla tuch , ora alla anagkh , e ciò si trascina in parte fino ai cristiani, che molto ereditano dal mondo greco: in particolare, questo strascico della cultura antica affiora in seno al cristianesimo nella concezione ch’esso ha della Provvidenza come forza imperscrutabile che regge, trascendendolo, il mondo; nel mondo musulmano, poi, ciò è ancora più forte, in quanto l’Islam è – letteralmente – una totale sottomissione. Accanto a questa ripresa di modelli greci – seppur largamente modificati – compare anche l’innovativo elemento del premio e del castigo, in virtù del quale, a seconda che si sian rispettate o meno le prescrizioni divine su questa terra, si ricevono punizioni o compensi nella vita ultraterrena. Nell’ebraismo si trattava soprattutto di punizioni collettive e terrene (specialmente cataclismi naturali, alluvioni, terremoti, ecc), mentre nel cristianesimo sono di ordine individuale, cosicché ciascun individuo finisce per avere la sua propria responsabilità, a cui è legata a filo doppio la libertà dell’arbitrio. E’ questa, al contempo, una “libertà di” e una “libertà da”, con la conseguente maturazione del diritto a un premio o a un castigo nell’aldilà. Quest’insistenza sulla libertà è testimoniata da innumerevoli passi di autori cristiani: così Giustino dice che “l’uomo compie o omette il giusto per libera scelta“, Clemente Alesandrino parla addirittura di una proairhsiV di scegliere il bene oppure il male, e Gregorio di Nissa riferisce di una dunamiV proairhtikh. Siffatto atteggiamento è poi sollecitato, oltreché dalle dottrine cristiane, dal fatto che l’imputabilità delle azioni fosse messa in forse dalla tradizione greca (specialmente nella sua veste stoica) e, soprattutto, da alcune eresie che pullulavano ai confini della cultura cristiana, primi fra tutti i Manichei, i quali, concependo il mondo come il teatro dello scontro tra il Bene e il Male e intendendo le azioni umane come il manifestarsi di quei due stessi princìpi, finivano per spogliare l’uomo di ogni responsabilità personale. E’ soprattutto Agostino a brandire la spada della critica contro i Manichei, lui che in gioventù era stato uno di loro: sia nel De libero arbitrio sia nel De duabus animabus contra Manicheos, egli insiste su come il male sia da noi accettato per libera scelta. “Nessuno è costretto a esser schiavo del piacere“, dice Agostino, e rincara la dose aggiungendo che “la volontà è un moto dell’anima senza nessuna costrizione esterna o a non accettare qualche cosa o a ricercare qualche cosa“. L’altra faccia della medaglia del cristianesimo – accanto a quella della libertà dell’arbitrio – era quella data dal riconoscimento dell’assoluto dominio della Provvidenza sulla natura e sul mondo umano (dominio espresso bene dal motto popolare “non cade foglia senza che Dio lo voglia“): ora, è evidente che, almeno in apparenza, risulta impossibile una convivenza tra la libertà dell’agire e la forza provvidenziale, in virtù della quale tutto è decretato dai disegni divini. Uno dei grandi problemi contro cui si scontra la teologia cristiana sarà appunto quello di ricercare una conciliazione tra questi due princìpi, ma raramente si riuscirà in questo intento, poiché il più delle volte prevarrà il carattere necessitante o quello del libero arbitrio, e l’egemonia dell’uno o dell’altro dipende anche dall’esigenza di difendere dogmi cristiani dai pericoli eretici che via via si manifestano esaltando ora la libertà umana (e negando la Provvidenza) o, viceversa, celebrando la Provvidenza a scapito della libertà. Accanto al manicheismo e al bipolarismo da esso propugnato, sorgono altre eresie, altrettanto insidiose: e così, nell’ultima parte della sua vita, Agostino si trova indaffarato a combattere contro in Pelagiani, i quali sostenevano l’assoluta libertà dell’uomo, svincolato da ogni principio necessitante a tal punto che il peccato di Adamo non si sarebbe trasmesso agli altri uomini; ciò era evidentemente inaccettabile in una ortodossa prospettiva cristiana, tanto più che i Pelagiani vedevano Cristo semplicemente come un uomo dalla perfetta condizione morale. Contro di essi, Agostino fa ora leva sulla Provvidenza, giungendo a propugnare la predeterminazione e, in tal modo, contraddicendo palesemente quanto sostenuto contro i Mancichei, quando aveva parlato di una libertà assoluta nell’uomo: il libero arbitrio – egli obietta ora contro i Pelagiani – si ha solo nella condizione in cui si è trovato Adamo, libero di scegliere se peccare o no; ma dopo il suo peccato originale tale facoltà è svanita ed è rimasta un appannaggio meramente teorico, cosicchè l’umanità è divenuta una massa dannata costretta a peccare e priva di libertà d’arbitrio. Da questa condizione, tuttavia, l’uomo è risollevato dall’opera di redenzione di Cristo e dall’intervento della Grazia divina, frutto di un gratuito dono di Dio in favore dell’uomo e tale per cui quest’ultimo non può più peccare: anche in questo caso, dunque, non potendo più peccare (e cioè non essendo libero di peccare) l’uomo non è dotato di libero arbitrio più di quanto lo fosse prima dell’intervento della Grazia, quando non poteva non peccare. In realtà, questa posizione di Agostino non è radicalmente nuova, ma è già presente nelle Scritture, in particolare nell’autore che più di tutti fu promotore della concettualizzazione del cristianesimo: Paolo di Tarso, che in una delle sue tante epistole (la Lettera ai Romani, 6) inviate alle comunità cristiane al fine di dare loro i quadri teorici entro cui orientarsi, sostiene che l’uomo entra in stato di Grazia non per suo merito, ma in virtù della redenzione di Cristo: “il peccato infatti non dominerà più su di voi poiché non siete più sotto la legge, ma sotto la grazia. Che dunque? Dobbiamo commettere peccati perché non siamo più sotto la legge, ma sotto la grazia? È assurdo! Non sapete voi che, se vi mettete a servizio di qualcuno come schiavi per obbedirgli, siete schiavi di colui al quale servite: sia del peccato che porta alla morte, sia dell’obbedienza che conduce alla giustizia? Rendiamo grazie a Dio, perché voi eravate schiavi del peccato, ma avete obbedito di cuore a quell’insegnamento che vi è stato trasmesso e così, liberati dal peccato, siete diventati servi della giustizia“. Il presupposto filosofico che soggiace a tal pensiero è che l’uomo sia necessariamente in schiavitù, cioè sottomesso e mai libero, cosicché l’alternativa tra esser sottomessi al peccato o essere sottomessi alla Grazia non implica in alcun caso l’esistenza della libertà di scelta. Più che di un’alternativa si tratta allora di una non-alternativa. L’unico vero atto di libera scelta è stato quello compiuto da Adamo, attraverso il quale è stato scelto il male: la posizione paolina è ben più radicale di quella platonica del mito di Er, secondo cui si sceglie sì solo una volta all’inizio della propria vita, ma ciò vale per ogni singolo individuo e non per uno solo che sceglie per tutti. A sua volta la posizione paolina godrà di grande fortuna (e sarà portata alle estreme conseguenze) presso i Riformati luterani: fino a quel momento l’esigenza della libertà conviveva in certo modo (spesso contraddittoriamente) con l’incontrastata egemonia della Provvidenza, cosicché queste due istanze antitetiche venivano sapientemente coniugate in maniera tale che la libertà umana non si spegnesse mai del tutto di fronte all’incontrastata Provvidenza; le soluzioni prospettate dagli autori cristiani erano spesso puerili e ricche di contraddizioni – Calvino parlerà a tal proposito, con irrisione, di frivolum effugium: la meno credibile era senz’altro quella imperniata sulla distinzione tra Provvidenza e prescienza, distinzione tale per cui Dio sa tutto quel che avverrà, ma non lo determina, lasciando dunque che sian gli uomini stessi a decidere; in questi termini, Dio si limita a sapere che cosa l’uomo sceglierà (perciò si parla di “prescienza”) senza però intaccare la sua libertà d’arbitrio. La Riforma rappresenta una svolta epocale nella cultura cristiana in primis perché Lutero estirpa ogni ambivalenza e, conseguentemente, ripropone gli effetti della posizione di Paolo – attraverso la mediazione di Agostino – portandoli all’ennesima potenza: nel De servo arbitrio (1525) Lutero arriva a dire che “Dio non ha alcuna prescienza in forma contingente […]. Compie ogni cosa con immutabile, eterna, infallibile volontà“. La conseguenza logica di siffatta prospettiva è che “qualsiasi cosa venga da noi compiuta non è opera del libero arbitrio, ma della pura necessità“: il discorso sulla salvezza va dunque rivisitato, giacché è assurdo illudersi di potersi guadagnare la salvezza con quelle che noi crediamo essere opere compiute liberamente ma che in realtà sono frutto di un arbitrio “servo” e necessitato. Tale posizione viene radicalizzata da Calvino nel 1536, nella sua Institutio Christianae religionis, in cui riprende la scansione agostiniana che porta dall’originale scelta peccaminosa di Adamo alla conseguente servitù al peccato dell’uomo, fino alla salvezza predestinata, una sorta di doppia predestinazione per cui Dio avrebbe ab aeterno diviso l’umanità in un gruppo di pochi eletti che si salveranno e in un altro di dannati che andranno in rovina. E pertanto – dice Calvino – le buone azioni non sono il frutto di una presunta libera scelta, ma, viceversa, vengono compiute da chi è già stato prescelto dalla Grazia divina. In questa maniera il libero arbitrio è del tutto azzerato: nel De libertate Christiana (1520), Lutero asserisce che l’unica libertà per l’uomo consiste nell’esser libero dal peccato perché schiavo della Grazia. In tale ottica, la cultura cattolica, che continua a farsi portavoce delle esigenze precedenti alla Riforma, si vede costretta a rivisitare le proprie posizioni tenendo conto delle obiezioni sollevate da Lutero, con la conseguenza che – gradualmente – verranno fatte sempre più concessioni al luteranesimo, soprattutto in sede tomistica. E tuttavia a difendere a spada tratta il cristianesimo nella sua veste originaria, contro le folleggianti aberrazioni di Lutero, sono i Gesuiti, le cui posizioni sono emblematicamente sintetizzate nella figura di Luis de Molina, professore in Portogallo: egli, nel suo Concordia liberi arbitrii cum gratiae donis (1588) tenta di coniugare ancora una volta il libero arbitrio con la Grazia. Scrive Molina: “si dice libero quell’agente che, pur essendo posti tutti i requisiti dell’agire, può agire o non agire“; egli riconosce, dunque, il fatto che per agire occorrano dei moventi, cosicché la libertà non nasce da un punto zero, bensì devono esservi le cause che producono l’azione ed esse, pur essendoci, non sono determinanti; sicchè l’uomo mantiene la sua facoltà (agostiniana) di far sì che esse diventino attive e producano un effetto oppure di far sì che rimangano inattive. Ogni azione pertanto ha sempre i suoi moventi, cosicché non sono mai io a causare le mie azioni (ed è questa una concessione al determinismo di Lutero), ma ciononostante sono libero di lasciare che tale causa agisca, il che significa fare una cosa oppure un’altra. Se ne evince che, in siffatta ottica, il libero arbitrio altro non è se non il sospendere alla radice un meccanismo deterministicamente procedente. Per difendere la Provvidenza, poi, senza perciò seppellire la libertà, Molina ricorre ad uno scaltro quanto brillante espediente: il “concorso simultaneo”, per cui ogni evento scaturisce dalla intima cooperazione di ben due cause. La prima corrisponde all’intervento di Dio (che di tutte le cose è autore), la seconda riguarda invece l’azione di un agente creato: sicchè da un lato Dio è il principio della causalità e, in questo senso, è autore di tutto ciò che avviene, ma, dall’altro lato, quale sia la causa specifica che si attiva nel momento X, ciò dipende dall’intervento di una creatura. Dunque, per i fatti fisici l’azione della creatura è sempre data da un corpo naturale che non può agire altrimenti da come agisce: così il fuoco riesce a scaldare la pietra perché vi è la causalità generale garantita da Dio e, in aggiunta, la specifica proprietà di bruciare peculiare del fuoco. Nel caso dei fatti morali, poi, da una parte c’è sempre l’influsso di Dio come causa generale, ma, dall’altra, c’è la libera volontà dell’uomo, che può applicare la causalità divina o lasciarla inoperante. Ad esempio, se siamo indotti per passione a compiere un delitto, da un lato c’è la possibilità di essere causa di tal delitto (e ciò deriva da Dio), dall’altro però come causa seconda io posso decidere se rendere operante tale causalità (e compiere il delitto) o renderla inattiva (astenendomi dal compiere il delitto).CARTESIO
La soluzione prospettata al problema della libertà dai Gesuiti – soluzione che andrà per la maggiore nel Seicento, pur essendo facilmente attaccabile per via della sua eccessiva macchinosità – si oppone alla necessità ammessa dai Luterani e dai Calvinisti e riconosce un irrinunciabile ambito di libertà all’agire umano. Quando la filosofia moderna, che personifichiamo innanzitutto con Cartesio, viene a trattare del problema della libertà, si trova immediatamente dinanzi ad un terreno ingombro da molto materiale: da un lato, c’è la lineare e drastica soluzione dei Riformati – negatori di ogni libertà -, dall’altro vi è invece la compromissoria posizione dei Gesuiti, in cui si cerca concordanza fra aspetti che difficilmente paiono poter stare insieme. Queste due alternative rientrano nell’unica cornice della discussione teologica della libertà, tale per cui la problematica della libertà si trova ad essere subordinata a quella inerente Dio. L’ulteriore alternativa possibile consisteva allora nello smarcarsi dalla teologia e nel considerare finalmente il problema della libertà esclusivamente in riferimento all’uomo e alle sue realizzazioni: ciò significava dare una soluzione esplicitamente filosofica, ed è appunto questa la controversa strada imboccata da Cartesio, la quale sarà via via condannata o rinforzata dai pensatori successivi, che da essa prenderanno le mosse. Il primo tentativo di Cartesio di fronteggiare la problematica della libertà resta però ancora saldamente vincolato alla prospettiva teologica e risulta essere autenticamente fallimentare: la prima prova a sostegno della debolezza di Cartesio sta nel fatto che egli sia indeciso e continui a fluttuare tra posizioni opposte, a tal punto da sostenere dapprima il libero arbitrio e, secondariamente, la necessità assoluta. Così, in Le passioni dell’anima (articolo 146), egli asserisce che “dobbiamo renderci conto che tutto è guidato dalla Provvidenza“: tutto ciò che accade è necessario – dice Cartesio -, ma Dio ha limitato la sua stessa Provvidenza per lasciare un margine di libertà all’agire umano; naturalmente quest’idea di una Provvidenza a pelle di leopardo fa acqua da tutte le parti, ma non più di quella – sostenuta in una lettera a Elisabetta, datata 3 novembre 1645 – in cui Cartesio si fa foriero di posizioni diametralmente opposte: qui egli dice che, se badiamo esclusivamente all’uomo, non possiamo accorgerci di come qui esista un libero arbitrio, ma tutto cambia se guardiamo le cose in connessione alla Provvidenza: ci accorgiamo, in questo caso, di come anche il nostro libero arbitrio dipenda da essa (in questo modo la zona franca di libertà riconosciuta nello scritto Le passioni dell’anima è cancellata), poiché altrimenti ci si troverebbe costretti a dire che la Provvidenza è al contempo infinita e finita (perché autolimitantesi). Qualcosa di analogo Cartesio sostiene in un’epistola del 6 ottobre 1645, in cui afferma a chiare lettere che sostenere un libero arbitrio indipendente da Dio significherebbe negare la sovrana perfezione di Dio, il quale “non sarebbe sovranamente perfetto se nel mondo potesse capitare qualcosa che non dipenda interamente da Lui“. E la filosofia ci fa conoscere che “nello spirito dell’uomo non potrebbe entrare il minimo pensiero senza che Dio lo voglia“. Si prospettano dunque due esigenze che cozzano fra loro e che Cartesio prova a conciliare: che sian conciliabili – egli nota – lo attesta automaticamente l’esperienza del libero arbitrio che ciascuno fa, in questo mondo retto dalla Provvidenza, guardando dentro se stesso; e, per argomentare tale conciliazione, Cartesio compie un passo decisamente malriuscito e goffo, provando a chiarirsi con un esempio: immaginiamo un gran signore che abbia proibito i duelli all’interno del suo regno e che però sia al corrente che due suoi vassalli si odiano a tal punto che sicuramente si batteranno nel caso in cui si incontrino; immaginiamo ora che il sovrano decida che essi si incontrino per strada e duellino fra loro, contravvenendo le prescrizioni stesse del sovrano, il quale sapeva che si sarebbero scontrati e li ha fatti appositamente incontrare. Similmente, sussiste una volontà assoluta per cui Dio prevede come avverranno le cose, ma ciò non toglie che sussista anche un’azione relativa di Dio che comanda agli uomini di fare certe cose ed evitarne altre, cosicché non li costringe a far le cose proibite, ancorchè li metta in condizione di farle. Bayle obietterà a Cartesio che in realtà il signore di cui ha parlato fa di tutto affinchè i due vassalli si incontrino, mettendo così in luce l’inaccettabilità della posizione cartesiana. E prosegue Bayle nella critica a Cartesio: immaginiamo un padre che voglia far morire il primogenito: può farlo uccidere da un sicario oppure provocargli un dolore così grande che sia egli stesso a suicidarsi: non vi è differenza, giacchè l’effetto sortito è il medesimo, con la sola differenza che nel secondo caso si ha l’impressione che il figlio si uccida liberamente. La stessa cosa avviene nella prospettiva delineata da Cartesio, dice Bayle. Ma Cartesio stesso era in certa misura consapevole della debolezza dei suoi argomenti e, pertanto, nei Princìpi di filosofia, riprende lo stesso problema e ripete la tesi della conciliabilità fra Provvidenza e libertà, ma dicendo – molto più modestamente – che di tale compatibilità siam certi come credenti ma non possiamo renderne conto con la ragione. E’ questo l’abbandono del problema teologico del rapporto tra libertà e Provvidenza all’ambito della fede; viene in questa maniera aperta la possibilità di impostare la problematica della libertà non più in riferimento a Dio (giacchè in tale ambito solo la fede può illuminarci), ma in riferimento all’uomo, in quell’ambito cioè in cui la ragione può procedere con sicurezza. La soluzione prospettata da Cartesio per il problema della libertà si basa sul cardine della sua stessa metafisica: quel dualismo in virtù del quale sussistono due sostanze separate ed autonome; da un lato, la sostanza pensante (res cogitans) e, dall’altro, la sostanza estesa (res extensa). La separatezza tra le due induce Cartesio a pronunciarsi circa la loro eterogeneità, in forza della quale si potrà imputare la libertà alla sostanza pensante e relegare la successione causale deterministicamente intesa alla sostanza estesa. Per dimostrare ciò, Cartesio si avvale di una definizione scolastica della sostanza, concepita come “ciò che non ha bisogno che di se medesima per esistere” (Princìpi di filosofia, paragrafo 51): così intesa, la sostanza è ciò che esiste autonomamente; successivamente, però, Cartesio torna sui propri passi e si accorge che tale definizione si attaglia solo a Dio, perché Lui solo è causa sui, ossia Lui solo basta a se stesso per esistere; per questo motivo, il pensatore francese corregge la definizione e arriva a dire che la sostanza è ciò che per esistere non ha bisogno di nulla, fuorchè di Dio. Stando a questa precisazione – che sarà duramente criticata da Spinoza -, il concetto di sostanza può essere applicato al creato nella sua totalità: in questa maniera, si vengono ad avere due diversi tipi di sostanza, giacché solo due son le realtà che in effetti sussistono indipendentemente: il pensiero e l’estensione, nel senso che l’estensione non dipende dal pensiero e viceversa. Tra le due realtà manca dipendenza reciproca in quanto gli attributi – ovvero le qualità essenziali – delle due sono radicalmente diverse e indipendenti tra loro: le une sono sostanze intelligenti, le altre son sostanze corporee; alle prime competono il pensiero, la volontà, la spiritualità, ecc, alle seconde ineriscono invece la profondità, la larghezza, ecc. L’unico aspetto comune che lega in certo modo la res extensa e la res cogitans sta nell’essere dipendenti entrambe da Dio. Questo esasperato dualismo è il punto di partenza della filosofia di Cartesio: e se consideriamo i corpi, subito ci accorgiamo di come essi siano caratterizzati dall’inerzia meccanica, dal fatto che le loro relazioni reciproche sono date sotto forma di rapporti di causalità necessaria tali per cui tutto è meccanicamente regolato (si noti che ciò vale tanto per la natura fisica esterna quanto per l’organismo umano, concepito alla stregua di una macchina assolutamente assimilabile ad un automa, per cui i muscoli sono come i tiranti, i nervi come i tubi, e così via). Questo rigoroso materialismo concernente i corpi trova il suo contraltare nel pensiero o, se riferito agli uomini, nell’anima, la quale – opposta al corpo – non ha ampiezza, lunghezza e inerzia, ma, viceversa, è spontanea, vivace ed irriducibile al meccanismo causale necessario, cosicché il soggetto causa molte cose senza a sua volta essere causato. Asserire che il pensiero è attività spontanea equivale a dire che esso è libero e incondizionato: ecco perché Cartesio, in più luoghi della sua opera, sostiene che la libertà non ha bisogno di essere dimostrata, in quanto la sentiamo immediatamente dentro di noi in tutta la sua evidenza. In questo modo, Cartesio è padre di due correnti filosofiche antitetiche: grazie alla res extensa, egli è padre del materialismo settecentesco, che giungerà all’apice con la concezione dell’uomo-macchina di La Mettrie, e, grazie alla res cogitans, è padre dello spiritualismo, specialmente di quello francese. La sua è dunque una doppia paternità: l’anima diventa un mondo a sé o, per dirla con Spinoza, un impero dentro l’impero. Ora, la forza della posizione di Cartesio risiede tutta nella totale indipendenza dell’anima dal corpo, e ciò gli consente una fondazione assoluta della libertà, tale per cui basta guardare in se stessi per accorgersi di essere liberi: si tratta però di una posizione indimostrabile, di fronte alla quale ci si trova costretti “a prendere o a lasciare”. Il dualismo ontologico e metafisico che fonda la libertà finisce poi per creare seri problemi a Cartesio, giacchè finchè consideriamo il rapporto tra le due res, possiamo pensare che esistano due mondi a sé stanti (quello spirituale e quello materiale) senza interferenze reciproche, ma non appena rivolgiamo l’attenzione all’uomo, tale indipendenza pare difficilmente giustificabile, in quanto l’uomo è anima e corpo, sintesi perfetta di quelle realtà che abbiam detto essere separate. Come si spiegherà, ad esempio, il fatto che l’impressione del freddo generi idee, con un evidente passaggio dalla materia al pensiero? O, al contrario, come renderemo ragione del fatto che io voglia agire sul mondo esterno e il mio atto di volontà si traduca in movimenti corporei? Ciò vale anche per le passioni (amore, odio, ira, gelosia, ecc), che sono da Cartesio considerate come movimenti degli “spiriti animali”, cosicchè mi adiro perché nel mio corpo si genera un turbinio di particelle che si scatenano e il corpo muta; ma le passioni sono anche passioni dell’anima, cosicchè l’ira – oltre a modificarmi fisiologicamente – mi fa sentire diversamente nella mia interiorità (ad esempio, avrò volizioni cattive verso qualcuno); sempre le passioni indicano il passaggio dall’anima al corpo: se infatti la morale consiste nel dominare stoicamente le passioni, allora l’anima deve agire sul corpo tenendolo a freno il più possibile. Tutti questi esempi rivelano come nell’uomo anima e corpo entrino in conflitto tra loro, il che crea non pochi problemi a Cartesio: come può l’anima – che è del tutto diversa dal corpo – agire su di esso? E, nel caso in cui ciò sia possibile, non si crea forse un inquinamento tra la libertà dell’anima e la necessità del corpo? Cartesio cerca di togliersi d’impiccio asserendo che anima e corpo sono strettamente congiunti pur restando tra loro indipendenti: per spiegare tale congiunzione, occorre superare l’ostacolo rappresentato dal fatto che nel corpo la comunicazione avviene causalmente e nell’anima no; per superare tale ostacolo, Cartesio ricorre alla poco convincente soluzione della ghiandola pineale, ossia di una particolare ghiandola, ubicata nel cervello, che, pur essendo un organo fisico, è così sensibile e sottile da poter apprezzare sia le sollecitazioni materiali del corpo sia quelle incorporee dell’anima. La ghiandola pineale può cioè esser mossa sia dagli “spiriti animali” che percorrono senza tregua il corpo sia dall’impalpabile azione della volontà: tuttavia su come ciò avvenga, Cartesio tace. Sicchè egli fa del dualismo la struttura portante del suo pensiero e poi deve continuamente correggerlo, ipotizzando una costante interazione tra le due sostanze indipendenti: è questa una debolezza intrinseca del sistema cartesiano, che gli costerà le critiche più severe. Da un lato, grazie al dualismo, egli può affermare vivamente la libertà dell’anima, dall’altro l’esigenza di limitare e correggere il dualismo stesso con un modello enigmaticamente interattivo riduce e cancella al massimo questa fondazione della libertà: consolidando il sistema interattivo, viene ad essere fiaccata la libertà. Le difficoltà teoriche emergenti dalla soluzione cartesiana sono state brillantemente colte da Gilbert Ryle, che – nel suo The concept of mind (1949) – ha parlato di un vero e proprio dogma dello spettro nella macchina: Cartesio – nota -Ryle – descrive il corpo come una macchina e poi in essa situa uno spettro che, essendo altro dalla natura fisica, non è ben chiaro come possa reggere la macchina. Sicchè l’anima finisce secondo Ryle per essere in Cartesio un fantasma magicamente operante in un corpo non diverso da una macchina. Accanto alla testè illustrata giustificazione metafisica della libertà, Cartesio ne escogita un’altra, tutta interna all’anima, senza impantanarsi più con la res extensa: egli instaura un dualismo interno all’anima tra volontà ed intelletto. Abbiam visto come nel cristianesimo l’intelletto e la volontà fossero le due prerogative fondamentali di Dio (con un netto primato della volontà) e come di esse si trovasse un riflesso anche nell’uomo: anche Cartesio si incammina lungo questa via, per dimostrare come nell’anima umana convivano l’intelletto e la volontà e come la seconda sia prioritaria rispetto alla prima. Cartesio nota che se io considero il mio intelletto mi accorgo subito di come esso sia infallibile, anche se limitato quantitativamente: conosce poche cose, sì, ma le conosce in maniera perfetta. Sull’altro versante, se concentro l’attenzione sulla volontà, subito mi avvedo di come essa, intesa come libertà di scelta, sia illimitata, giacchè posso volere tutto ciò che la mia mente forma: sotto questo profilo, è dunque possibile dire che “latius patet voluntas quam intellectus“. “Mi posso lamentare di non aver ricevuto da Dio una volontà o libertà di arbitrio non sufficientemente ampia e perfetta; vedo infatti che non è certamente circoscritta da alcun limite. E cosa che mi sembra molto degna di nota in me non vi sono altre cose tanto perfette o tanto estese, che, a mio giudizio, non possano essere più perfette o più grandi. Se, ad esempio, considero la facoltà di comprendere, subito riconosco che essa è assai incompleta e molto limitata in me – e nello stesso tempo io mi formo l’idea di un’altra facoltà molto più grande, ed anzi assoluta ed infinita – e per il solo fatto che posso concepire l’idea di lui, comprendo che essa appartiene alla natura di Dio. Allo stesso modo, se esamino la facoltà di ricordare o di immaginare, o qualunque altra, non ne trovo nessuna, che non comprenda essere in me tenue e circoscritta, in Dio immensa” (Meditazioni metafisiche, IV). La maggiore estensione della volontà rispetto all’intelletto presenta importanti conseguenze anche a livello gnoseologico: viene infatti impiegata da Cartesio per spiegare l’errore; essendo infallibile l’intelletto, l’errore viene imputato alla volontà, la quale pretende – in quanto infinita – di dare l’assenso o il rifiuto prima che vi siano gli elementi conoscitivi adeguati: anche in sede morale, poi, posso per volontà dare l’assenso al male, travalicando pertanto le prescrizioni dettate dall’intelletto. In questo modo, la volontà diventa centrale per quel che riguarda la libertà, poiché ovviamente se la volontà fosse subordinata all’intelletto, allora non potrebbe volere qualsiasi cosa (vorrebbe solo il giusto) e non vi sarebbe libertà assoluta, bensì l’uomo dovrebbe adeguarsi ad un ordine della realtà rivelato dall’intelletto. Se, viceversa, la volontà può andare al di là dell’intelletto, l’uomo è assolutamente libero di volere ciò che vuole. Tali premesse parrebbero garantire una libertà assoluta ed in effetti Cartesio se ne serve in vista di questo scopo: il pericolo è però che la libertà così fondata – su una volontà sganciata dall’intelletto – possa configurarsi come libertà di indifferenza, ossia come capacità di decidere arbitrariamente tra A e B senza far riferimento ad alcun criterio normativo: se così fosse, come si potrebbe stabilire che cosa è bene e che cosa è male? L’uomo arriverebbe a scegliere il male anziché il bene e ciò con pieno diritto; per ovviare a questo problema, Cartesio precisa che la libertà di indifferenza non è per l’uomo la più alta forma di libertà: essa è tipica di Dio, poiché Egli, essendo onnipotente, deve essere veramente libero di volere quel che vuole, senza essere condizionato da regole che distinguano il giusto dall’ingiusto, il bene dal male, il vero dal falso, ecc; Dio gode di una libertà così estesa – la sua è un’assoluta “libertà di” – da essere Lui stesso a decidere che cosa sia il bene e che cosa il male, che cosa il giusto e che cosa l’ingiusto; perfino che 2+2 dia 4 o che il tutto sia maggiore della parte dipende dall’incontrastata volontà divina. Per l’uomo, però, tale forma di libertà non è quella suprema, giacchè l’uomo non è un essere infinito, ma è creato da Dio e, perciò, si innesta in un contesto in cui è Dio ad aver stabilito che cosa sia vero e che cosa falso, che cosa giusto e che cosa ingiusto; ne segue che per l’uomo la vera libertà non è volere ciò che vuole (“libertà di”), ma volere ciò che è giusto (“libertà da”), cosicché la libertà di indifferenza è la forma più bassa e più nociva di libertà, poiché consente di scegliere il falso anziché il vero, l’ingiusto anziché il giusto: la vera libertà consiste allora nel decidere in conformità all’ordine decretato da Dio, e ad illuminarci sull’ordine del mondo non può essere la volontà – che per sua natura non opera distinzioni -, ma l’intelletto, che così diventa il vero principio della libertà, il faro seguendo la cui luce si è liberi; la volontà deve quindi autosubordinarsi ad esso e decidere di volere ciò che l’intelletto dice essere bene, giusto, vero, ecc. In questo modo, Cartesio sconfessa la tradizione cristiana dell’egemonia della volontà sull’intelletto e si ricollega direttamente a Tommaso, per il quale è l’intelletto ad individuare la ratio boni, il criterio del bene su cui la volontà deve modularsi. Sicchè, dopo aver definito la volontà come assoluta e indifferente, Cartesio cambia repentinamente rotta e asserisce che la capacità di scegliere tra A e B è subordinata all’avere gli strumenti adeguati (intellettuali) per scegliere B piuttosto che A: “poiché essa [la libertà] consiste unicamente in ciò: che noi possiamo fare una cosa o non farla (cioè affermare o negare, seguire o fuggire); o piuttosto solamente in questo: che, per affermare o negare, seguire o fuggire le cose che l’intelletto ci propone, noi agiamo in modo che non ci sentiamo costretti da nessuna forza esteriore. Infatti, affinché io sia libero, non è necessario che sia indifferente a scegliere l’uno o l’altro dei due contrari; ma piuttosto, quanto piú inclino verso l’uno, sia che conosca evidentemente che il bene e il vero vi si trovano, sia che Dio disponga cosí l’interno del mio pensiero, tanto piú liberamente ne faccio la scelta e l’abbraccio. E, certo, la grazia divina e la conoscenza naturale, ben lungi dal diminuire la mia libertà l’aumentano piuttosto, e la fortificano. Di modo che questa indifferenza che io sento, quando non sono portato verso un lato piú che verso un altro dal peso di niuna ragione, è il piú basso grado della libertà, e rende manifesto piuttosto un difetto nella conoscenza, che una perfezione nella volontà; perché se conoscessi sempre chiaramente ciò che è vero e ciò che è buono, non sarei mai in difficoltà per deliberare qual giudizio e quale scelta dovrei fare, e cosí sarei interamente libero, senza mai essere indifferente” (Meditazioni metafisiche, IV). La libertà consiste dunque, ad avviso di Cartesio, nel fatto che, affermando o negando ciò che suggerisce l’intelletto, non mi sento coartato da una forza esterna, e ciò in forza del fatto che l’intelletto che detta legge sono io stesso, identificantemi con la mia ragione: ed è questa – come abbiamo visto – la definizione della “libertà da”, consistente nello scegliere A o B secondo un principio che sento come mio e come non imposto dall’esterno; la “libertà di” resta una prerogativa squisitamente divina.SPINOZA
Il modello compromissorio avanzato da Cartesio è messo alla berlina dal pensiero immediatamente successivo, fatta eccezione per l’Occasionalismo, che del cartesianesimo fu la scolastica: in particolare non è accettato il dualismo cartesiano per due ordini di ragioni. In primis, esso è respinto perché sostituito da un rigoroso monismo che assorbe la sostanza estesa e quella pensante in un’unica sostanza (è il caso di Spinoza), oppure lo rigetta privilegiando una componente sull’altra (spesso addirittura eliminandone una delle due): o si elimina lo spirito riducendo tutto a corpo (è il caso di Hobbes), o si riconduce l’estensione a epifenomeno dello spirito (come fa Leibniz). In tutte le soluzioni, perfino in quella spiritualistica di marca leibniziana, venendo a mancare il dualismo, viene di conseguenza a mancare la distinzione tra un ambito in cui vige la libertà e uno in cui regna la necessità. Partendo tutti dal presupposto che scire est scire per causas, questi pensatori immediatamente successivi a Cartesio sostengono in ultima istanza il determinismo, sopprimendo in tal modo la libertà nell’agire umano. Il crollo del modello dualistico prospettato da Cartesio che separava libertà e necessità comporta allora l’entrata in crisi della libertà e il trionfo del determinismo, pur secondo modalità diverse da filosofo a filosofo. Il primo modello che si pone come superamento di quello cartesiano e dei problemi che esso lasciava irrisolti è quello di Spinoza: questi accetta la definizione di sostanza fornita da Cartesio, tale per cui essa è ciò che esiste autonomamente, ma ne trae la rigorosa conclusione – correggendo in ciò la modifica cartesiana secondo cui sostanza è ciò che per esistere non ha bisogno di nulla fuorchè di Dio – che esiste un’unica sostanza infinita coincidente con Dio e con la natura (Deus sive natura). Tale sostanza infinita ha infiniti attributi, dei quali noi conosciamo solo il pensiero e l’estensione, giacché sono gli unici due di cui partecipiamo. Per Spinoza continua a valere quel determinismo causale di cui parlava Cartesio, cosicché il rapporto tra i corpi è dato da una sfilza di connessioni causali necessarie e immanenti alla sostanza stessa di Dio, poiché l’estensione non è che una qualità di Dio stesso. Per Cartesio, tutt’altro discorso valeva per il pensiero, che era una sostanza distinta e opposta all’estensione: per Spinoza, invece, il pensiero è attributo della sostanza infinita, sicché è – alla pari dei corpi – espressione di un’unica sostanza. La sequenza delle idee nel pensiero non è che un modo diverso di considerare quel processo causale che abbiam visto per i corpi materiali: ne segue che anche le idee sono relazionate tra loro secondo rigidi rapporti rigorosamente causali, senza quella libertà spontanea riconosciuta da Cartesio. Qualunque siano i modi con cui la sostanza si manifesta nei suoi diversi attributi, tale manifestazione avviene sempre secondo quello che Spinoza definisce un “ordine geometrico“, ovvero causale: il dualismo tra estensione e pensiero è azzerato, proprio come la possibilità che uno dei due ambiti si sottragga al determinismo. Cartesio aveva introdotto anche un secondo tipo di dualismo, quello interno al pensiero tra intelletto e volontà, ritenendo che i due fossero in certo senso indipendenti, poiché la volontà si estende ben di più rispetto al pensiero. Ora anche questo dualismo è accanitamente combattuto da Spinoza, il quale dice che esiste un unico attributo del pensiero e al suo interno la volontà e l’intelletto non sono facoltà diverse (altrimenti tale attributo si dividerebbe in sotto-attributi), bensì sono due modi diversi di indicare il pensiero e, di conseguenza, le singole volizioni e le singole intellezioni sono la stessa cosa, ovvero sono gli stessi modi del pensiero: sicché se per Cartesio con l’intelletto posso concepire una data azione (ad esempio rubare) e la volontà può dare l’assenso o negarlo a tale concezione dell’intelletto, per Spinoza, al contrario, volontà e intelletto, volizione e intellezione, sono lo stesso modo del pensiero, manca cioè la distinzione tra volto pratico e volto teoretico del pensare, cosicché siamo noi a chiamare in due maniere diverse una singola idea. Ne segue che quando mi rappresento l’idea del rubare, a tale idea è necessariamente connessa una qualche volontà, nel senso che quando penso a rubare, sto già sempre e comunque volendo o non volendo rubare; non esiste – come invece pretendeva Cartesio – un momento meramente intellettuale in cui penso al rubare e un momento successivo in cui voglio o non voglio rubare: una siffatta argomentazione muove da una falsa prospettiva, dovuta al fatto che talvolta abbiamo l’impressione di pensare al rubare e, dopo, di poter volere o non volere rubare; in realtà, stiamo – secondo Spinoza – semplicemente oscillando tra il voler rubare e il non voler rubare, senza che ci sia il momento neutro del pensare al rubare e a cui dare o no l’assenso con la volontà. Da ciò si evince come il fatto che io poi rubi o meno non sia frutto dell’esercizio della libertà, ma della sequenza causale in cui mi trovo inserito. Anche sotto questo profilo, non è possibile individuare alcun dualismo, né è possibile riconoscere una libertà che si sottragga al determinismo: la volontà è sempre vincolata alla necessità, a tal punto da essere da Spinoza definita come “causa necessaria” e non come “causa libera“, poiché il fatto che io voglia rubare piuttosto che non rubare è causalmente necessitato dall’anello immediatamente precedente nella catena causale. Si deve allora concludere che per Spinoza non esiste libertà? Se per libertà intendiamo che un singolo modo possa svincolarsi dalla catena causale che lo lega agli altri, allora non esiste alcuna libertà (intesa qui come “libertà di”). Se tuttavia la intendiamo come “libertà da” costrizioni esterne, allora possiamo a ragion veduta sostenere che per Spinoza la libertà esiste: essa sarà, in particolare, non una libertà di agire in un modo anziché in un altro, ma di obbedire alla propria natura, ancorchè quest’ultima sia necessaria. In questo senso, la libertà non si oppone alla necessità: perfino Dio obbedisce alla propria natura e proprio per ciò non è determinato da altro; la libertà, così intesa, è dunque opposta non alla necessità (che è ineliminabile), ma alla coazione, ovvero l’esser necessitati da altro. A godere perfettamente della libertà come l’abbiamo poc’anzi delineata sarà solo Dio, mentre ogni altro ente sarà sempre necessitato e per di più coartato. Nelle ultime parti dell’Ethica more geometrico demonstrata, Spinoza ci parla significativamente della schiavitù degli uomini nei confronti delle passioni (De servitute humana) e, in secondo luogo, della liberazione da esse (De libertate humana): ogni singolo modo della sostanza (uomo compreso) è determinato dalla catena causale nella misura in cui è inteso, appunto, come singolo modo; ma ciascuno può vedere se stesso non come un momento particolare della catena, bensì sotto il profilo del tutto, eliminando per tale via la propria separatezza dal tutto stesso: in questo caso, il soggetto considera se stesso come sub specie aeternitatis, ossia vede con l’occhio di Dio (e gode della Sua libertà) e perde la propria individualità schiava: obbedisce cioè alla propria natura necessaria senza costrizioni esterne, ed in ciò è libero (“libero da”). La libertà è dunque il frutto della conoscenza intellettuale, di quell’intelletto che intuitivamente ci fa vedere le cose sotto l’aspetto dell’eternità e non dal nostro limitato punto di vista.HOBBES
L’altra soluzione di fronte al dualismo lasciato in eredità da Cartesio consiste nell’eliminare lo spirito e nel ridurre tutto a materia, consegnando ogni cosa nelle mani della più rigida necessità, dal momento che nell’estensione regna la determinazione causale: è questa la soluzione prospettata da Hobbes, specialmente in tre dei suoi numerosi scritti: Elementi di legge naturale e politica (1640), Leviatano (1651) e Della libertà e della necessità (1646). Quest’ultima è un’opera particolarmente polemica, in cui Hobbes si contrappone con veemenza alle tesi di un vescovo che propugnava la libertà dell’arbitrio. Secondo Hobbes l’azione dell’uomo, infatti, è sempre necessitata: per capire il perché, occorre far riferimento alla gnoseologia hobbesiana, che fa leva su un rigoroso sensismo per cui tutte le nostre conoscenze derivano dai sensi secondo un modello necessario simile a quello cartesiano, con però l’aggiunta che, allorchè le impressioni arrivano alla sede centrale del corpo umano, gli urti prodotti dalle impressioni esterne provocano una reazione che è da Hobbes detta conatus (in inglese endeavour); il che implica la presenza nell’organismo umano di una vitalità non meramente meccanica. Nello sforzo si autoproduce energia, e tale conatus può esser di due tipi (positivo o negativo) a seconda che l’impressione ricevuta sia gradevole o sgradevole. Nel primo caso, si ha un appetito verso la cosa desiderata (Hobbes nota con acutezza come la radice latina di adpetere indichi sempre un movimento); nel secondo caso si ha invece l’avversione verso la cosa sgradita. Sulla base di questi due conati fondamentali (in realtà Hobbes parla anche di un terzo: il timore come avversione proiettata nel futuro), il filosofo inglese costruisce tutta la sua dinamica delle passioni, in maniera vicina a Cartesio (che ne aveva individuate sei fondamentali combinantisi in vari modi). La nostra azione di desiderio o di ripulsa non è qualcosa che venga deliberato da un atto di volontà, ma è la risposta condizionata ad una determinata sollecitazione; ciò non esclude la volontà, tant’è che per Hobbes volontarie sono quelle azioni che si compiono per appetito o per timore, mentre involontarie sono quelle compiute per coazione esterna: se mi precipito in un fiume perché spinto da qualcuno, si tratta di un’azione involontaria; se invece lo faccio perché preso da angoscia, è un’azione volontaria. Secondo Hobbes, esiste (come secondo Spinoza) un’immediata coincidenza tra pensiero e volontà, e tuttavia egli ammette che noi abbiamo quotidianamente esperienza della cosiddetta deliberazione, tale per cui ci si chiede se rubare o meno e poi si delibera di rubare. La deliberazione – nota Hobbes – non è che un’alternanza di passioni contrarie, appetiti e timori (desiderio di rubare e desiderio di non rubare), passioni che si confrontano nella nostra mente quasi come se fosse in atto una lotta per cui ora sembra prevalere l’una, ora l’altra. Ciò si traduce nell’impressione di volere e di non volere, e alla fine prevarrà una delle due: questa sarà quella che noi chiamiamo decisione o volontà. Dunque, ciò che a noi orgogliosamente pare una nostra iniziativa, è in realtà il meccanico trionfo di una passione, trionfo di fronte al quale siamo interamente passivi: “la deliberazione non è altro che un’immaginazione alternata […] di appetito e timore. […] La deliberazione è successione alternata di appetiti contrari nella quale l’ultimo è quello che chiamiamo decisione” (Della libertà e della necessità). Il processo cade del tutto sotto il giogo della necessità: non solo c’è rigoroso determinismo nel processo mentale, ma anche tra volontà ed azione. Tra il mondo psichico delle idee e quello fisico delle azioni non vi è alcuna frattura, ma vi è continuità causale, cosicché noi non abbiamo libertà né di agire né di volere, se non illusoriamente. Infatti la volontà è determinata dalla lotta delle passioni e l’azione è determinata dalla già determinata volontà. Hobbes ci tiene però a precisare che la causalità qui in questione non è quella “sufficiente”, quella “a cui non manca nulla perché sia necessaria alla produzione dell’effetto”, ossia quella che ha tutti gli elementi necessari per poter produrre il suo effetto, ma non per questo necessita l’effetto: essa è, insomma, tale da avere in sé gli elementi necessari per spiegar l’effetto, ma non lo necessita. Al contrario, Hobbes, quando parla di causalità, intende la causalità “necessaria”, quella cioè in cui ci sono gli elementi per produrre effetti che non possono non essere prodotti. La distinzione tra queste due causalità è agli occhi di Hobbes artificiosa, giacchè ogni causalità che sia davvero tale è sempre necessaria: se in me ho tutti gli elementi per alzarmi, mi alzo. Se, viceversa, non mi alzo, ciò avviene perché non ne avevo gli elementi, e non perché li avevo ma non erano necessitanti (causalità sufficiente). Perciò Hobbes insiste sul fatto che parlare di volontà libera sia un’assurdità alla pari di quando si parla di cerchio quadrato: è ben più che un semplice errore, quale può essere il sostenere che pioverà perché si son viste le nuvole quando poi in realtà non piove. La volontà è sempre necessaria, e parlare di una volontà libera è un’aberrazione: non esiste, allora, alcuna forma di libertà intesa come “libertà di”; semmai esiste la “libertà da” costrizioni esterne: sono cioè libero quando non sono in catene, quando mi muovo liberamente senza che nessuno mi trattenga, anche se la mia volontà di muovermi è necessitata. Per chiarirsi, Hobbes adduce l’esempio del fiume: esso è libero di scendere a valle perché non c’è nessuna diga che lo ostacoli; ma non è libero di invadere i campi perché è trattenuto dagli argini che lo limitano: tale è, appunto, la libertà umana, intesa meramente come libertà da costrizioni.LEIBNIZ
La soluzione di Leibniz consiste nella riduzione della res extensa a epifenomeno, ossia a manifestazione secondaria dello spirito, con un’operazione opposta rispetto a quella compiuta da Hobbes. Leibniz si oppone soprattutto a Spinoza, ad avviso del quale la sostanza era una e infinita; per Leibniz, al contrario, le sostanze sono molteplici e indefinite nel loro numero perché coincidenti aristotelicamente con le sostanze individuali; e il carattere dell’individualità è a tal punto spinto da individuare il singolo con l’elemento atomico, sicchè non è né ulteriormente scomponibile né riconducibile ad altri individui. L’atomismo era stato in età seicentesca recuperato nella sua veste epicurea da Gassendi: ora, Leibniz osserva che parlare di atomi materiali significa automaticamente contraddirsi, giacchè, coincidendo la materia con l’estensione, se gli atomi sono estesi, allora saranno divisibili. Alla materia è da Leibniz contrapposto l’elemento energetico della forza, che è una delle strutture portanti del suo pensiero ed è il concetto che gli serve per opporsi al cartesianesimo e alla sua filosofia della natura sfociante nel meccanicismo. Stando al meccanicismo di Cartesio, nel mondo c’è una quantità definita di energia (o di movimento che dir si voglia) impressa da Dio – all’atto della creazione – nella materia ed essa può esser redistribuita nella materia stessa passando per traslazione da una parte all’altra, cosicchè per Cartesio il movimento sarebbe il prodotto della massa e della velocità; Leibniz sostiene invece che in realtà il movimento non è esprimibile con tale formula, bensì deve essere espresso come prodotto della massa per il quadrato della velocità, e il fatto che la massa possa moltiplicarsi implica che il movimento sia una forza autogenerantesi, sicchè non è che un corpo sia meccanicamente spostato da un altro corpo, bensì il corpo è dotato di un’energia spontanea non riconducibile al meccanicismo. E a questa teoria fisica Leibniz fa corrispondere una teoria metafisica, nel senso che spiega tale capacità della velocità di automoltiplicarsi sostenendo che tale forza non è solo elemento fisico, ma è l’essenza stessa della realtà, la quale è dunque energia e slancio autoespansivo: le monadi sono dunque atomi non di materia, ma di forza, di quest’energia metafisicamente intesa, cosicchè ciascuna monade ha in sé una tendenza a svilupparsi e a diventare qualcosa d’altro da ciò che era: ogni monade è attività, è energia, non vi è elemento statico e materiale, manca la substantia. L’attività della monade è semplicemente un’attività percettiva, è una continua percezione che comporta il passaggio costante da una percezione all’altra, da percezioni più basse e meno coscienti a percezioni più alte e coscienti: ma che cosa è ad esser percepito dalla monade, essendo essa inestesa? Come punti geometrici, le monadi sono tra loro distinte ma definibili in base alla loro relazione, cosicché la monade X sarà definita dai rapporti che essa intrattiene con le altre monadi. X percepirà la sua posizione rispetto a tutte le altre monadi, con la conseguenza che la monade finisce per essere un punto di forza che percepisce tutte le altre monadi, sicchè essa è un autentico punto di vista sull’universo, in quanto è definita da tutte le altre monadi dell’universo, come un punto geometrico è definito da tutti gli altri punti geometrici. La dimensione corporea scompare e permane quella metafisica, giacchè i corpi non sono che aggregati di monadi che stanno insieme: gli individui e le anime, dal canto loro, sono monadi che hanno determinate relazioni con tutte le altre, ma quando parlo della monade come individuo (ad esempio Alessandro Magno) parlo di una monade che non ha estensione materiale, ma è pur sempre un’entità che si trasforma, ovvero ha continuamente relazioni diverse con tutte le altre monadi: il punto di vista di Alessandro Magno che guarda il suo cavallo sarà diverso da quello di Alessandro Magno che, un attimo dopo, guarda a terra, cosicchè siamo di fronte ad un mutar continuo di prospettive e relazioni. Ma come avviene tale successione di stati? Già sappiamo che il passaggio da uno stato all’altro è il risultato del processo autoevolutivo dell’energia della monade che non viene dall’esterno, in quanto la monade non ha finestre, ovvero interferenze causali con altre monadi, giacchè manca il nexus physicus (essendo immateriali le monadi): Leibniz dirà che le monadi sono orologi caricati insieme, in maniera tale da segnare in accordo la stessa ora, dall’orologiaio Dio secondo un’armonia prestabilita. Tale successione di stati è dunque tutta interna alla monade e alla sua autocausalità: ma il rapporto di causazione che c’è tra uno stato e l’altro all’interno della monade sarà libero, determinato o necessario? Ecco qui che affiora il problema della libertà, che nasce dal tipo di sviluppo interno alla monade: Leibniz si rende ben conto del fatto che anche nella cornice della cultura del Seicento – come nella tradizione aristotelica – l’unico modo per spiegar le cose è mostrarne la causa e che una causa non è tale se non è determinata (una causa che non determini l’effetto non è una causa): quindi, scire est scire per causas e, per di più, le cause in questione sono cause determinanti, tali per cui A deve necessariamente determinare B. Ciò vuol dire che ciascuno dei nostri stati interni – e la monade non è che la sequela di essi – può esser spiegata solo se vista come effetto determinato dallo stato precedente, e tuttavia Leibniz sostiene che l’uomo è libero. Nella Teodicea, Leibniz afferma nella maniera più drastica la natura determinata dell’azione dell’uomo, presentandoci dei passi sconcertanti per un filosofo anti-materialista. Nel paragrafo 35 di tale opera, egli scrive: “quando si presta attenzione a sé, si noterà che c’è stata sempre una causa che ci ha inclinati verso il partito che abbiamo preso, anche se non ci si accorge che ciò ci muove“. Anche quando facciamo cose che ci sembrano nuove e da noi inventate, in realtà notiamo che c’erano impulsi (magari inconsapevoli) determinanti, posizione, questa, confortata anche dalla teoria delle piccole percezioni, secondo la quale anche le percezioni consapevoli (appercezioni) sono il risultato della chiarificazione di percezioni oscure e non consapevoli di sé. “Un’infinità di grandi e piccoli movimenti interni ed esterni concorrono con noi e per lo più non ci si accorge di essi, e ho già detto che quando si esce da una camera ci sono ragioni che ci portano a mettere davanti il piede destro senza pensarci“: i piccoli gesti sono automatici e tale determinismo induce anche a prendere le decisioni più importanti; ciò vuol dire che l’uomo è un automa, e a dirlo è Leibniz, cosa atipica per uno spiritualista che aborre il materialismo. L’uomo è sì un automa, ma un automa spirituale, e in una pagina della Teodicea Leibniz asserisce che è bene prendere esempio da Hobbes, giacchè se fossimo liberi non si spiegherebbe il fatto che compiamo un’azione anziché un’altra; tuttavia, Hobbes sbaglia nel dire che la volontà dell’uomo è necessitata. La determinazione non equivale per Leibniz alla necessità: perciò egli ritiene di poter sostenere che la volontà umana è determinata, ma che ciononostante l’uomo sia libero; il che emerge dalla contrapposizione che Leibniz fa tra contingenza e necessità, da una parte, e tra determinazione e necessità dall’altra. Si ha la necessità quando “di due proposizioni contraddittorie, l’una è vera e l’altra è falsa“, cosicché la necessità si regge sul principio di non contraddizione e si dice necessario ciò il cui opposto non è possibile (così intesa, la necessità ha innanzitutto carattere logico). E’ invece contingente ciò che si basa sul principio di “ragion sufficiente”, ossia sul principio che stabilisce che nulla accade senza che vi sia una causa, o, meglio ancora, “senza che vi sia qualcosa che possa render ragione a priori del perché (cur sit) questo esista anziché non esistere e del perché esista così (quomodo sit) anziché esistere in altro modo“. Il principio di ragion sufficiente ha in comune con la necessità il riferimento alla causa, con però la differenza che – rispetto alla necessità – tale causa non è necessaria, ma può ammettere anzi il suo contrario: così, dire che il tutto è maggiore della parte è esprimere una verità necessaria, mentre dire che sono andato a scuola perché lo sentivo come mio dovere è esprimere una verità contingente, incentrata appunto sul principio di ragion sufficiente (magari potrei essere andato a scuola per paura di esser punito e non per mio dovere). In questo senso, Leibniz sta qui schierandosi in linea antitetica a Hobbes, per il quale – come è noto – la causa necessaria e quella “sufficiente” coincidevano, nel senso che non vi è causa che non sia necessaria. Per Leibniz, invece, si tratta di due cause diverse e non riconducibili in toto l’una all’altra: “l’evento il cui opposto è possibile è contingente; quello il cui opposto è impossibile, è necessario“. Sull’altro versante – quello della distinzione tra necessità e determinazione -, la tesi di Leibniz è che la causa determinante è sicuramente un principio di ragion sufficiente, ossia basta a spiegare perché (cur) una cosa avvenga e perché avvenga a quel modo (quomodo), ma non è una causa necessaria, poiché l’effetto potrebbe essere spiegato in altro modo: la determinazione è, allora, compatibile con la contingenza, sicchè determinare non significa necessitare: così, io sono stato determinato ad andare a scuola da certi impulsi, ma ciò non è necessario, giacché non è impossibile pensare ch’io mi sia recato a scuola per tutt’altro ordine di ragioni (per paura, perché ne avevo voglia, ecc). In questa maniera – tenendo lontana la necessità dall’agire umano -, Leibniz salva la libertà e fa dell’uomo un automa libero e spirituale; la libertà così come egli la intende è sinonimo di contingenza: pertanto, A contiene soltanto la ragion sufficiente di B, e non la sua necessità, sicchè si può affermare che l’uomo è determinato ma libero, anche se la libertà in questione non è la “libertà di” fare ciò che si vuole, secondo il proprio capriccio. A tal proposito, la tesi dell’asino di Buridano che, dinanzi a due mangiatoie ugualmente colme di fieno, muore di fame non sapendo scegliere presso quale sfamarsi, è per Leibniz una finzione che non può trovar spazio nell’universo, giacchè vi sono sempre differenze tra un’opzione e l’altra, differenze magari impercettibili ma comunque esistenti (Leibniz rideva delle madame che cercavano nel parco due foglie identiche), alle quali non possiamo sottrarci, ci determinano (ma non ci necessitano); ne segue che la “libertà di” presupporrebbe che in noi non ci sia un elemento che ci predetermini a scegliere A anziché B, ma se la monade è la storia dei suoi stati precedenti (e Bergson riprenderà tale concetto), anche scegliere il gelato alla fragola piuttosto che quello al pistacchio implica sempre una determinazione nella scelta. Per Leibniz, tuttavia, è solo un bene che non sia possibile la “libertà di”, sennò l’uomo si troverebbe abbassato al livello dei bruti, in quanto non potrebbe spiegare perché ha scelto una cosa anziché un’altra, sicchè la sua sarebbe una scelta del tutto casuale, priva di motivazioni e alla connessione causale si sostituirebbe quella casuale. Il che eliminerebbe l’imputabilità all’uomo (come incolparmi del fatto che ho scelto B se l’ho scelto per caso?): per poter volere A anziché B, non a caso ci deve essere in me un movente determinante, che tuttavia non è necessitante ma compatibile con la contingenza.LOCKE e HUME
Locke e Hume sono i due pensatori che danno vita al filone empiristico anglo/scozzese e che si sottraggono con decisione all’alternativa dell’accettazione o del rifiuto del dualismo cartesiano per il fatto che entrambi i corni dell’alternativa sono espressione di una concezione metafisica che ritiene possibile definire il concetto di sostanza (sia essa la sostanza infinita di Spinoza, o il corpo materiale di Hobbes o, ancora, le monadi spirituali di Leibniz). La possibilità di un discorso sulla sostanza è dunque messa in crisi dall’empirismo di Hume e di Locke: quest’ultimo nota come forse la sostanza esista, ma come in ogni caso essa resti per noi inconoscibile; per Hume – su posizioni ben più radicali – essa è un concetto fasullo. Locke non se la sente di arrivare a tanto, ma resta convinto del fatto che, sia nel senso della sostanza come sostrato che soggiace agli accidenti sia nel senso della sostanza come ciò che è comune a più cose (l’oro come elemento di unione del giallo, della lucentezza, ecc), si introducono concetti inconoscibili. Per esprimere questa sua posizione, egli ricorda la storia di quell’indiano che sosteneva che il mondo è sorretto da un elefante, che a sua volta è sorretto da una tartaruga, la quale però non si sa bene su cosa poggi: similmente, quando cerchiamo il substrato metafisico, giungiamo ad una X sconosciuta, proprio in virtù del fatto che noi possiam conoscere solo gli accidenti. La posizione di Hume è ben più radicale: tutte le nostre percezioni sono, a suo avviso, o impressioni (percezioni nella loro vivida attualità) o idee (percezioni meno vivide e corrispondenti all’immagine illanguidita che conserviamo nella memoria); tutte le nostre percezioni derivano dunque da impressioni, cosicchè se ci chiediamo che cosa corrisponda all’idea di sostanza – ossia a quale impressione corrisponda – non troviamo risposta, giacchè abbiamo sempre e solo impressioni del freddo, del caldo, del pesante, ecc, e mai della sostanza. Quest’ultima altro non è, dunque, se non un’invenzione della mente umana, alla pari del cavallo alato o dell’uomo volante. Ciò fa sì che il problema del dualismo sia un falso problema, perché riferentesi ad una sostanza inconoscibile o inesistente; tuttavia, anche per questi pensatori, resta vero il credo del determinismo della volontà, per cui non si può affermare che essa sia libera. C’è tuttavia l’esigenza di riconoscere anche una dimensione di libertà all’uomo, che però non è riconducibile alla libertà della volontà, cosicchè questi autori affermano una chiara distinzione tra la libertà dell’agire (che viene ammessa) e quella del volere (che è negata). Si tratta, peraltro, di una distinzione già delineata da Hobbes, il quale, pur negando recisamente la libertà del volere umano, ammette che l’uomo sia libero – in quanto privo di impedimenti esterni – di fare ciò che la volontà determinata lo necessita a fare, cosicchè non posso decidere se star qui o andarmene, ma ciononostante, se sono necessitato ad uscire, sarò libero di farlo, a patto che la porta non sia sbarrata. Questa tesi è ripresa soprattutto da Locke – seppur raffinata – specie nella definizione della libertà di agire, intesa come l’insieme di tutte quelle condizioni (anche quelle interne) che possono promuovere la messa in atto di una volontà determinata. In particolare, Locke individua (nel capitolo 21, paragrafo 35 del Saggio sull’intelletto umano), tra le varie forme di potere, anche la libertà e la volontà, provando a darne una definizione: “noi troviamo in noi stessi un potere di cominciare o non cominciare, continuare o interrompere varie azioni della nostra mente e vari moti del nostro corpo semplicemente con un pensiero o con una preferenza della mente […]. Questo potere è ciò che noi chiamiamo volontà“. La volontà è qui definita come il potere di fare o non fare qualcosa sulla base di un pensiero o di una preferenza della mente che decide se fare così o no; ma l’elemento della preferenza non è il frutto di una libera scelta, ma è piuttosto il presupposto dato per determinare la scelta. “La libertà è l’idea del potere che un agente ha di fare o di tralasciare qualunque azione particolare secondo la determinazione della sua mente […] cioè secondo la sua volontà“: la libertà di cui qui si parla è la libertà di fare ciò che è deciso dalla volontà, testè definita come un qualcosa che troviamo già in noi stessi e che, quindi, non possiamo liberamente determinare, con la conseguenza che dove io non sono in grado di mettere in atto quella volontà che trovo in me, là io non sono libero. Preliminarmente è bene osservare come i concetti di volontà e libertà non siano coestensivi, giacchè se la libertà comporta sempre la volontà, non vale l’inverso: così posso volere uscire dalla stanza e non poterlo fare perché la porta è sbarrata. La questione ora più generale è chiedersi se l’uomo sia libero oppure no: la risposta è che l’uomo è libero nella misura in cui – a meno che non vi siano impedimenti esterni – può compiere quelle azioni che la volontà gli ordina: “che cosa possiamo pensare di più, affinchè l’uomo sia libero, che egli possa fare ciò che vuole?“. Per esser libero, non vi è bisogno che sia libera la volontà, ma basta poter mandare liberamente ad effetto ciò che essa ci comanda di fare: così se trovo in me la volontà di uscire (volontà che però non sono io a determinare), non v’è nulla in me che impedisca di mettere in atto quella libertà, intesa naturalmente come “libertà da” impedimenti intrinseci a fare ciò che la volontà prescrive. Ma, allora, dobbiamo chiarire se la volontà sia libera oppure no: essa – dice Locke – non è affatto libera, giacchè consiste appunto in una preferenza, cosicchè non possiamo non preferire ciò che preferiamo. Sarò allora libero di fare ciò che la volontà mi impone, ma non sarò in alcun caso libero di voler diversamente da come voglio. “Chiedere se l’uomo sia libero di volere il movimento o il riposo […], secondo che gli piaccia, significa chiedersi se vuole ciò che vuole“: l’uomo non può dunque preferire altro da ciò che preferisce, sicchè la libertà non potrà mai riguardare la volontà, ma sempre e comunque l’agire, il rispondere o meno ai comandi di tale volontà. Ci si può allora chiedere – ed è quel che fa Locke – che cosa determini la volontà: su questo punto, il filosofo inglese assume una posizione oscillante o, meglio, differente nella prima e nella seconda edizione del Saggio sull’intelletto umano. Nella prima edizione, egli fornisce una risposta assolutamente incongruente rispetto alla sua tesi sulla volontà determinata, ragion per cui nella seconda edizione cambia posizione, conscio dell’incongruenza in cui era incappato. Così, nella prima edizione, leggiamo che la volontà è determinata dalla felicità (e lo dice anche nella seconda), la quale è un bene (questo compare solo nella prima), o, meglio è la ricerca del maggior bene: e per sapere quale esso sia, l’analisi pratica trapassa necessariamente in quella teoretica, giacchè è l’intelletto ad indicare quale sia il bene maggiore, intelletto che per Locke coincide con la ragione, la quale a sua volta è la mia coscienza stessa, sicchè sono io a scegliere il bene maggiore e a scegliere che cosa sia la felicità: ne segue allora che la volontà non può più essere una preferenza che trovo già determinata in me; viceversa sono io a determinarla col mio intelletto, il che è in evidente contraddizione con la tesi di partenza. Locke si avvede di questa contraddizione e, nella seconda edizione, corre ai ripari sostenendo che a determinare la volontà è sì la felicità, però determinata dal piacere, cosicchè la massima felicità sarà data dal massimo piacere; da qui prende spunto quell’eudemonismo settecentesco che riconduce la felicità al piacere sensibile. Ma resta da chiarire da che cosa sia dato il piacere: esso è, ad avviso di Locke, dato dall’eliminazione della condizione di disagio, sicchè a muover l’esigenza di felicità e la volontà è il disagio in cui mi trovo. Rispetto alla prima edizione, la differenza fondamentale è che là interveniva inevitabilmente l’intelletto come momento cognitivo dominante la situazione; ora, invece, l’intelletto non ha più voce in capitolo, e l’esempio che Locke adduce per chiarire questo punto è quello dell’ubriaco, la cui felicità è data dal bere che gli consente di uscire dal disagio in cui si trova; la ragione gli suggerisce di non bere perché ciò è nocivo, ma egli continua a farlo pur di uscire dal disagio, contravvenendo le prescrizioni della ragione: così facendo, Locke pone alla base della volontà un elemento che sfugge al controllo dell’uomo e ci determina. Locke tenta anche di correggere un po’ questo determinismo, dicendo che quando l’uomo sente un disagio, egli può qualche volta sospendere l’esecuzione (che prima appariva automatica) e valutare le conseguenze di queste azioni, per vedere se esse portino all’eliminazione del disagio o se piuttosto non lo incrementino. E’ questo un momento di ponderazione che tuttavia Locke ritiene possibile “soltanto qualche volta“; anche qui, però, si agisce in vista di uscire da un disagio maggiore, sicchè sono sempre condizioni che sfuggono alla sovranità razionale dell’uomo. A conclusioni pressoché analoghe perviene Hume, il quale, nel Trattato sulla natura umana (III, 1), asserisce che “la volontà è quell’impressione interna che avvertiamo e di cui diventiamo consapevoli quando diamo origine a qualche nuovo movimento del corpo o a qualche nuova percezione della mente“. Da ciò si ricava che le impressioni possono essere esterne o interne (di riflessione), ma tanto le une quanto le altre sono passive, sono il frutto dell’azione di qualcosa che si imprime in noi, cosicchè esse son sempre un dato di fatto, tant’è che son la pietra di paragone delle idee (le quali sono vere a fasulle a seconda che rispecchino o meno l’impressione); sicchè se la volontà è l’impressione proveniente dalla mia coscienza di iniziare qualche cosa, tale impressione è indiscutibile. La volontà e il suo contenuto sono un qualche cosa di dato, il che ci rivela già come non possiamo controllare la nostra volontà né le nostre impressioni: così come non possiamo non dire che il tavolo è giallo, ugualmente non posso dire di non voler agire in quel dato modo. Tale controllabilità è meglio chiarita applicando alla volontà – come alle cose – quel concetto di causalità che per Hume non è deducibile a priori né dimostrabile empiricamente, è una credenza poggiante sull’abitudine. Sicchè la categoria della causalità è il concetto fondamentale con cui ci regoliamo per tutte le “matters of fact” (i “dati di fatto”); ne segue che tal concetto diventa rilevante non solo per la connessione dei dati di fatto del mondo esterno, ma anche per quelli inerenti al mondo interno, per cui la causalità necessaria investe anche la volontà, così come qualsiasi altra impressione. Ora, per mostrare ciò, Hume ricorda che il principio di causalità implica: 1) l’unione costante e necessaria della causa con l’effetto; 2) la possibilità da parte della mente di inferire un certo effetto data una certa causa. Hume si chiede allora se questi due caratteri, validi per il mondo esterno, valgano anche per il regno delle impressioni interne e risponde affermativamente: “le nostre azioni possiedono un’unione costante coi nostri motivi, coi nostri caratteri e con le circostanze in cui ci troviamo“; ciò equivale a dire che le nostre azioni hanno una connessione costante con la volontà, cosicchè quando i motivi, i caratteri e le circostanze saranno uguali, allora si determineranno la stessa volontà e le stesse azioni: anche nella sfera delle azioni umane, cause simili producono effetti simili. E Hume adduce l’esempio del carcerato che vorrebbe evadere ma che dispera di farlo perché la porta e la finestra sono sbarrate e perché non è possibile corrompere il guardiano, inflessibile e timoroso di esser punito dai suoi superiori: il prigioniero inferisce la conseguenza che in nessun caso il guardiano lo lascerà evadere. Sono due cause diverse: una è fisica (la porta e la finestra chiuse), e l’altra è morale (l’atteggiamento del guardiano), aventi tuttavia il medesimo effetto (l’impossibilità di evadere), cosicchè la connessione è necessaria, non vi è in alcun modo più probabilità che il guardiano faccia uscire il prigioniero di quanta ve ne sia che questi attraversi la porta o la finestra. Ciò avvalora la tesi secondo cui la causalità vale nel mondo morale non meno che in quello fisico, sicchè l’uomo non ha “libertà di”, è solo libero – come per Locke – di fare ciò che la volontà gli impone. Ma Hume aggiunge alla posizione di Locke alcune valenze positive, mettendo in luce la positività di tale concezione deterministica della volontà: egli nota, in primis, come i motivi che determinano la volontà e che la rendono necessitata implichino che io la possa considerare come espressione della mia personalità individuale, giacchè essa è determinata da motivi, caratteri e situazioni che sono sempre miei (perfino le circostanze sono sempre il mio modo di considerarle); la volontà dunque è determinata, ma non dipende che da noi, cosicchè essa esprime la nostra specifica individualità e deve essere considerata non come una passività, ma come una spontaneità. E’ questa la libertà psicologica, per cui non ho reale libertà di scelta, ma poiché la volontà coincide con me, non mi sento coartato, ma psicologicamente libero. E poi Hume nota – sulle orme di Leibniz – come solo una volontà determinata renda possibile il principio di imputazione, ossia la possibilità di attribuire la responsabilità all’individuo.KANT
Abbiamo visto, da un lato, il modello dualistico prospettato da Cartesio, che garantisce alla sostanza pensante la libertà, e, dall’altro, il modello negante il dualismo e, perciò, rinunciante alla contrapposizione tra una res libera e una necessaria, il tutto a svantaggio della libertà, che viene inequivocabilmente a trovarsi schiacciata dall’imperare del determinismo più rigoroso. Ma la soluzione dualistica, tramontata immediatamente dopo la formulazione datane da Cartesio, ritorna periodicamente nella storia della filosofia successiva al Settecento, e il primo caso significativo in cui la ritroviamo sostenuta con energia – in difesa della libertà – è costituito da Kant: il suo è però un dualismo diverso da quello cartesiano, giacché provvede ad eliminare le difficoltà contro cui il filosofo francese s’era scontrato; questi aveva parlato di due sostanze opposte ma appartenenti ad un medesimo livello di realtà, tant’è che nell’uomo finivano per interferire – sotto forma di anima e di corpo -, implicando una seria difficoltà nello spiegare come due sostanze così eterogenee possano compenetrarsi in maniera tale che l’anima si intrufoli enigmaticamente nel corpo a dirigerlo secondo libertà, quasi come uno “spettro nella macchina” (Ryle). Il dualismo kantiano, invece, è molto più raffinato, in quanto non implica il sussistere di due sostanze opposte ed interagenti nella stessa realtà, ma comporta piuttosto l’esistenza di due diversi livelli di realtà, uno sovrastante l’altro: così, da un lato troviamo la realtà sensibile (“fenomenica”), cui appartengono il corpo e tutte le sue determinazioni, e dall’altro una realtà intelligibile non data dai sensi ma a cui si può pervenire tramite un’esperienza extra-sensibile. Così inteso, l’uomo finisce per essere non una combinazione di due sostanze (quale invece era secondo Cartesio), ma come un’entità appartenente a due diversi ordini di realtà, sicchè si tratterà di spiegare l’interazione tra questi due ambiti, ossia si dovrà render conto di come le azioni originate dalla realtà intelligibile possano trovare una loro precisa corrispondenza in quella sensibile. Prima di entrare in medias res, occorre tuttavia chiarire come questo dualismo consenta a Kant di recuperare due giurisdizioni diverse, riconoscendo, per un verso, un regno (il mondo fenomenico) in cui vige la causalità meccanica e, per un altro verso, un regno (quello intelligibile) in cui impera invece una causazione non necessaria; pertanto il dualismo kantiano, nel cercare un terreno per la libertà, assolve la stessa funzione di quello cartesiano, ma senza incappare in quelle grette contraddizioni in cui Cartesio era scivolato. Con la sua soluzione, Kant, compiendo tale operazione di difesa della libertà nel mondo noumenico, è rigoroso nell’escludere ogni forma di libertà in quello fenomenico, cosa che pare ovvia ma che, se bene analizzata, non lo è affatto, giacché, nella misura in cui gli autori post-cartesiani filo-deterministi si preoccupavano di salvare un margine di libertà anche all’interno del determinismo, ricorrevano solitamente alla bislacca tesi per cui, nel caso della determinazione psicologica, gli elementi che determinano il mio agire coincidono con la mia soggettività e quindi rappresentano una forma di spontaneità tale per cui è impossibile dire che l’uomo non sia in certo modo libero. E’ questa la soluzione propugnata soprattutto da Hume, ma anche da Leibniz: quest’ultimo aveva difeso la libertà dell’agire in primis operando una decisa distinzione tra necessità e contingenza, mettendo in luce come il determinismo fosse espressione di contingenza (e non di necessità), nel senso che implica la ragion sufficiente delle cose ma non comporta che necessariamente quella sia la causa del dato effetto. In secondo luogo, Leibniz difendeva la libertà dell’uomo, pur restando nell’alveo del determinismo, facendo leva sulla spontaneità: è vero, sì, che nell’anima tutto è determinato da una consecuzione causale interna di stati, ma tuttavia tali stati appartengono all’anima stessa (che anzi è essa stessa il suo sviluppo), cosicchè viene difesa una sfera di libertà intrinseca al determinismo e incentrata sulla spontaneità dell’anima e Leibniz può affermare: “per quel che riguarda la spontaneità, ci è propria perché abbiamo in noi il principio delle nostre azioni […]. Infatti, in termini rigorosamente filosofici, le cose esterne non hanno influenza su di noi“. Escluso il nexus physicus, l’evoluzione della monade è tutta interna, con la conseguenza che sarei coatto se ci fosse una determinazione dall’esterno, ma, non essendoci, sono sì determinato, ma da me stesso. Ora, Kant dice chiaramente che questi discorsi “psicologici” sulla libertà sono privi di fondamento, sono dei raggiri che rivelano subito la loro debolezza: è inutile che io cerchi di dire che il determinismo interno è meno forte di quello esterno, poiché essi sono entrambi espressione del determinismo fenomenico, con l’unica differenza che, per quel che concerne la mia interiorità, esso è dato nel tempo, mentre per l’esteriorità nello spazio. In entrambi i casi, tuttavia, è e resta parimenti fenomeno, ossia un qualcosa di dato sensibilmente e, per ciò stesso, solo in termini di causalità necessaria. L’errore che ha indotto fior di pensatori a fantasticare una libertà psicologica trae secondo Kant origine dal fatto che chi lo commette riconduce la nozione di causalità necessaria solamente con l’elemento dello spazio, come avviene quando la palla da biliardo A urta quella B e ne causa il movimento sul tavolo da biliardo. Ma Kant ricorda come in realtà la categoria della causalità – come tutte le altre undici – non è che una determinazione nel tempo, e, per spiegare ciò, egli ricorre ad un duplice esempio: in primo luogo, egli ci rammenta di come tutti i nostri dati sensibili ci sian dati nello spazio ma poi – nel momento in cui diventano miei – son ricondotti nell’interiorità, ove regna il tempo, cosicchè vengono prontamente temporalizzati; ne segue che tutti i fenomeni – sia esterni sia interni – son connessi secondo un determinato ordine di successione nel tempo. Si possono allora dare due diversi casi: tale successione temporale non è il prodotto di una categoria, ma dell’immaginazione: a sostegno di ciò, possiamo immaginare di guardare un palazzo facendo scorrere lo sguardo dal tetto alle fondamenta; in questo caso, si ha una successione di immagini, di dati e di fenomeni, ma essa non è necessaria, giacchè posso far scorrere lo sguardo dal tetto alle fondamenta o viceversa, sicchè, per quanto i fenomeni interni sian sempre dati in successione, quest’ultima può non essere costitutiva dell’oggetto stesso proprio perché non interviene la categoria della causalità. Passiamo ora ad esaminare il secondo caso, in cui l’ordine di siffatta successione non è arbitrario, ma necessario in quanto costitutivo dell’oggetto stesso: così, il giocatore di biliardo sposta la palla B urtandola con quella A; in questo caso, non si può che immaginare quella determinata sequenza per cui la stecca colpisce A e questa urta e muove B, giacchè tale ordine è costitutivo dell’oggetto ed è tale perché è subentrata quella causalità che mi fa concepire le cose così e non in un altro modo. Allora la categoria della causalità non è se non una determinazione nel tempo: ciò che mi induce a dire che il movimento delle palle da biliardo segue una certa sequenza non è lo spazio, ma il tempo e dunque è un grave errore illudersi che la causalità abbia la sua radice nello spazio e che il tempo possa esentarsi da essa. Ciò significa che in tutti i casi la successione causale è strettamente necessaria, giacchè è la stessa categoria della causalità ad essere applicata ora nel fenomeno esterno, ora in quello interno: così, quando penso ad un ricordo triste e mi intristisco, tra il ricordo e il nascere della mia tristezza applico la causalità, poiché non posso dire che prima mi sono angosciato e poi ho pensato al ricordo triste. Dunque, è la causalità a legare ciò, e non l’immaginazione, alla pari di quel che avviene con le palle da biliardo, senza far distinzioni tra fenomeni esterni o interni. A contare davvero è che in entrambi i casi si tratta di fenomeni, di conoscenze che, per costituirsi, necessitano di essere causalizzate, per cui posso capire la dinamica delle palle sul tavolo da biliardo o del mio intristirmi solamente se applico la causalità. E allora – prosegue Kant – la libertà di cui favoleggia Leibniz quando vagheggia una determinazione spontanea è in realtà la spontaneità di un girarrosto che gira da solo, ma non già perché sia libero di girare, bensì perché necessitato a farlo, esattamente come se subisse una determinazione esterna. Sicchè quando pensiamo alla nostra vita interiore fenomenica dobbiamo pensare ad un mondo determinato necessariamente non di meno di quello fisico. Allora la conclusione a cui Kant perviene è che o riesco ad uscire dal fenomenico (sia esterno sia interno) e giungo ad attingere un livello di realtà extra-fenomenico oppure non c’è scampo e non vi è alcuna forma di libertà. Si tratta dunque di esaminare se vi sia la possibilità di un livello di realtà che si sottragga alla fenomenicità, distinguendo il fenomeno dalla cosa in sé e riconoscendo nel primo la necessità, nella seconda la libertà: se non potessimo operare tale distinzione, “l’uomo sarebbe una marionetta […], costretto e caricato dal sommo maestro di tutte le arti“. L’uomo, così inteso, sarebbe un automa, magari anche un automa illudentesi di essere libero, poiché non in grado di scorgere la causazione operata dal burattinaio (Dio), le sue volizioni sarebbero determinate da altre sue volizioni, e queste da altre ancora, ma all’inizio qualcuno deve aver messo in moto l’automa, che così viene a dipendere dall’azione esterna di un artefice. Se tempo e spazio esprimessero la realtà ultima della cosa in sé (e non fossero solo forme a priori della sensibilità), non vi sarebbe libertà alcuna e vigerebbe lo spinozismo, tale per cui tutto cadrebbe sotto il dominio della fredda necessità. Il rimprovero mosso da Kant al post-cartesianesimo non è tanto di aver rinunciato al dualismo, quanto piuttosto di essere stato incoerente, poiché, rinunciando al dualismo, si è poi impossibilitati ad ammettere la libertà a livello fenomenico. Il passo verso il noumeno non può esser compiuto con quegli strumenti conoscitivi che si servono delle forme a priori della sensibilità (spazio e tempo) e dell’intelletto (le dodici categorie), poiché conoscere qualcosa significa fenomenizzarla, ovvero riconnetterla ad una rete di connessioni causali neganti la libertà. Per giungere al noumeno, si dovrà allora percorrere una strada alternativa, extra-gnoseologica, la strada dell’esperienza morale e pratica. Il problema è risolto nella Critica della ragion pratica, ma è già lumeggiato nella Critica della ragion pura, seppur qui non sia minimamente risolto: discutendo sulle modalità conoscitive, Kant ammette la possibilità della libertà, una possibilità non verificabile in un’opera inerente alla conoscenza (quale è la Critica della ragion pura) ma comunque non escludibile, aprendo in tal modo uno spiraglio al di là del determinismo fenomenico. Nella Dialettica trascendentale – che è la parte della Critica della ragion pura in cui Kant prende in esame le facoltà della ragione, contrapposta all’intelletto – si parla dell’idea del mondo come totalità incondizionata di tutti i fenomeni e Kant sostiene che, proprio perché idea di un concetto incondizionato mai esperibile, su tale idea del mondo si possono sostenere affermazioni contraddittorie senza poter provare l’errore teorico né delle une né delle altre, cosicchè si può procedere ad un’antinomia della ragion pura in cui, da un lato, si sostiene la tesi, dall’altro l’antitesi, senza che sia possibile trovare un errore formale nelle argomentazioni addotte a favore della tesi o dell’antitesi (sarebbe possibile trovarle se si potesse fare esperienza dell’idea di mondo). Delle quattro antinomie individuate da Kant, la terza consiste nella contrapposizione tra una tesi secondo cui la libertà esiste e un’antitesi negante tale libertà. La tesi recita che “la causalità in base alle leggi della natura non è l’unica da cui sia possibile far derivare tutti i fenomeni del mondo: per la loro spiegazione, si rende necessaria l’ammissione di una causalità secondo libertà“. Accanto alla causalità necessaria, ne è dunque riconosciuta una libera, che concorre alla causazione dei fenomeni che, per altro verso, sono già spiegabili con la causalità fenomenica: così, il moto della palla da biliardo B sarebbe causato da una causa noumenica, inserendosi poi in una serie causale fenomenica per cui può esser ritenuto l’effetto di un’altra causa fenomenica (l’urto della palla A). Ci verremmo dunque a trovare di fronte a due causalità complementari. Di contro, l’antitesi recita l’esatto opposto, negando ogni forma di libertà: ora, queste due affermazioni paiono elidersi mutuamente e Kant ritiene che invece esse possano essere entrambe vere, appunto se, anzichè riferirle entrambe al regno fenomenico, riferiamo l’affermazione della necessità al mondo fenomenico e quella della libertà ad un mondo non fenomenico, la cui esistenza sarà postulata nella Critica della ragion pratica: nella Critica della ragion pura, invece, Kant non dispone di alcuno strumento per ammetterlo e perciò si limita a dire che esiste la possibilità di una causalità libera e che tale possibilità è solo problematica, ossia non può essere esclusa teoricamente poiché non si può teoricamente escludere l’esistenza di una realtà noumenica. La Critica della ragion pura si affaccia al problema della causalità libera come possibilità problematica che non può essere né esclusa né affermata; la Critica della ragion pratica risolve tale problema, ma in sede pratica, senza risvolti teoretici. Che cosa si debba intendere per “causalità libera” – affermata nella tesi della terza antinomia – viene da Kant spiegato in questi termini: essa è una causalità in cui il soggetto è principio di una serie causale, ovvero in cui il soggetto causante non è a sua volta effetto di una causa. La possibilità di un mondo intelligibile garantirebbe l’esistenza di siffatta causalità libera, ma ciò nella Critica della ragion pura resta una problematica eventualità: è solo con l’ingresso nel campo morale della Critica della ragion pratica e della Fondazione della metafisica dei costumi che il problema trova una sua debita risoluzione. Il problema è nelle due opere posto in maniera terminologicamente diversa: nella Fondazione della metafisica dei costumi, Kant si chiede se sia possibile una volontà buona di per sé, tale per cui la sua bontà non sia funzionale ad un determinato obiettivo, ma sia intrinseca alla volontà stessa. Invece, nella Critica della ragion pratica – che, tentando di seguire le orme della Critica della ragion pura, si configura come un’opera più tecnica – Kant si domanda se la ragion pura possa essere pratica, ossia se, accanto alle mansioni conoscitive e teoretiche esercitate a priori, essa possa anche determinare la norma dell’agire umano. Ciò equivale a chiedersi se essa possa determinare una regola pratica d’azione che sia universale, cioè per tutti valida. Quale sia questo elemento di universalità, lo troviamo nella formulazione dell’imperativo categorico, così recitante: “agisci soltanto secondo quella massima che , al tempo stesso , puoi volere che diventi una legge universale“. Ora, questa soluzione del problema morale comporta che la volontà intrinsecamente buona (ovvero la ragion pura immediatamente pratica), oltre ad esprimere l’universalità, esprima un principio di autonomia, giacchè, per essere universale, la volontà non può essere determinata da passioni o da interessi estranei alla ragione, in quanto questi sono necessariamente particolari. L’unico elemento che possa determinare immediatamente la volontà stessa, senza farla precipitare nella particolarità, è la ragione stessa nella sua universalità, cosicché la volontà sarà universale nella misura in cui è determinata dalla ragione. Tra questa e il mio io intercorre un rapporto di identità, nel senso che io sono la mia ragione e, nella misura in cui la volontà è da essa determinata, sono io ad autodeterminarmi, senza che vi sia un principio esterno che mi coarti; se invece la volontà è determinata da passioni o da interessi particolari generati dalla sensibilità, allora tutto cambia, poiché la sensibilità è manifestazione della natura interna, che è un qualcosa che non esprime l’essenza dell’umanità (come invece è la ragione), giacchè anche gli animali ne sono equipaggiati. La sensibilità è allora un qualcosa di altro rispetto a noi, sicchè, quand’anche obbediamo alle passioni nostre, stiamo in realtà obbedendo a qualcosa che non siamo noi. Pertanto se agisco in modo tale che solo la ragione determini la mia volontà, il mio agire sarà autonomo, mentre se la volontà è determinata dalla sensibilità, allora la mia azione sarà eteronoma. A tal proposito, nella Fondazione della metafisica dei costumi, Kant scrive che “l’autonomia della volontà è quel carattere della volontà per cui essa è legge a se stessa, indipendentemente dai caratteri“. L’autonomia è la più alta espressione di libertà, in quanto esprime entrambi gli elementi componenti della libertà: da un lato, la libertà negativa (“libertà dalla” natura, dalla sensibilità, dalle passioni e dai “moventi eteronomi“); dall’altro, la libertà positiva come autodeterminazione, per cui non mi limito a rifiutare l’impulso sensibile, bensì lo rimpiazzo con le prescrizioni della ragione, che detta una legge coincidente con me stesso, senza determinazioni esterne. Comincia qui ad affiorare, seppur opacamente, il problema della causalità libera. “La volontà è una specie di causalità degli esseri viventi in quanto ragionevoli […]. La libertà è […] quel carattere per cui essa può agire senza dipendenze da enti esterni“: anche la causalità libera ha le sue leggi (altrimenti l’agire umano ricadrebbe nel caso), ma si tratta di leggi interne al soggetto, in quanto è la ragione stessa a promulgarle. Ne deriva che autonomia (o libertà) e morale sono indisgiungibilmente connesse, giacchè non può esserci moralità senza libertà e viceversa. Ma finora non abbiamo dimostrato che la libertà esista o che la moralità sia principio obbligante per l’uomo: il legame tra le due – libertà e moralità – è stato illustrato sul piano teoretico, senza tuttavia dimostrare che esse realmente esistano, sicchè quel passaggio (richiesto nella Critica della ragion pura) ad un fondamento morale della libertà non è ancora stato compiuto. A questo punto, Kant cambia improvvisamente idea dinanzi al bivio: si può dimostrare che l’uomo è libero – egli sostiene – e che perciò ha in sé la legge morale (vista la stretta connessione fra le due); oppure è possibile mostrare che nell’uomo vi è la legge morale e che, per ciò, egli è libero. Nella Fondazione della metafisica dei costumi, Kant sceglie la prima via, dimostrando in primis la libertà e, sulla base di ciò, deduce la moralità; per dimostrare l’esistenza della libertà, basta rivolgersi – con atto di introspezione – alla propria coscienza e accorgersi che in quanto essere ragionevole faccio parte di due mondi: come animale, appartengo al mondo fenomenico, ma in quanto detentore di ragione (facoltà intelligibile) sono parte integrante di un mondo non fenomenico, per cui la libertà è indipendente da cause precedentesi; al contrario, essa è autocausantesi e, perciò, è principio di una serie causale. In questo modo, l’uomo, anfibio tra due mondi, verifica la libertà in quanto avverte la propria appartenenza anche ad un mondo non-fenomenico, cosicchè la dimostrazione della libertà dell’uomo diventa anche fondamento della dimostrazione della sua moralità, data l’indisgiungibile connessione fra le due cose: “gli imperativi categorici sono dunque possibili perché l’idea della libertà mi rende membro di un mondo intelligibile“; posta la libertà, è necessariamente data anche la moralità, a tal punto che se l’uomo fosse – per dirla con Schopenhauer – una “pura testa alata d’angelo“, ovvero un’entità meramente intellettuale e priva di corpo, sarebbe immediatamente un essere morale, senza il contrasto prodotto da elementi esterni alla ragione. Ma, essendo l’uomo anche ente animalesco, la moralità si dà sotto forma di imperativo implicante sofferenza e sforzo contro gli istinti sensibili che contro tale imperativo confliggono, sicchè in noi la moralità non è automatica ma comandata e sofferta. Nella Critica della ragion pratica il rapporto è ribaltato, giacchè qui Kant fonda la libertà sulla moralità: per tutta l’opera, egli va ripetendo che condizione della libertà è la moralità. Perché mai egli avverte l’esigenza di stravolgere la prospettiva? Nella Fondazione della metafisica dei costumi, la libertà era ricavata dalla coscienza data dall’introspezione, senza venir conosciuta teoreticamente, cosa che non soddisfa pienamente un filosofo rigoroso quale è Kant, che già in tale opera denuncia il limite noetico di questa coscienza, quasi come se fosse un’intuizione spinozianamente intesa. In effetti, si trattava di una posizione alquanto debole e difficilmente sostenibile, poggiante sulla coscienza di non appartenere solo al mondo fenomenico; era, come Kant stesso nota con amarezza, un “punto di vista“, una sorta di ipotesi. Come non posso avere un’autentica conoscenza oggettiva di appartenere al mondo noumenico, così non posso avere un’autentica conoscenza di essere libero. Nella Critica della ragion pratica, Kant sente l’esigenza di fondare la morale come conoscenza di tipo costitutivo, in maniera non meno debole della conoscenza incentrata sulla sintesi a priori della Critica della ragion pura, e non a caso la legge morale è una conoscenza sintetica a priori, data da una sintesi differente da quella della Critica della ragion pura (dove si sintetizzavano intuizioni sensibili in un concetto), in quanto vengono qui sintetizzate la volontà e la ragione, dimostrando che tra esse sussiste un rapporto sintetico per cui la ragion pratica le pensa unite così come la ragion pura pensa unite in concetto le intuizioni e le categorie. La moralità sarà allora un sapere con pari dignità noetica rispetto al sapere della ragion pura. Per ribaltare la prospettiva, Kant asserisce che se la connessione tra volontà e ragione è identica e costitutiva della ragion pratica, allora la legge morale è un fatto della ragione, e non un qualcosa di derivato (come invece era nella Fondazione della metafisica dei costumi): la Deduzione trascendentale (che nella Critica della ragion pura riguardava le dodici categorie) ha appunto per oggetto la giustificazione (“deduzione”) della legge morale, sicchè la deduzione non riguarda un quid facti, ma un quid juris, cioè un qualcosa che accampa un diritto da dimostrare. Se la legge morale è il fatto fondamentale della ragion pratica, allora non necessita di esser giustificata; ma qui avviene qualcosa di paradossale, giacchè tale legge morale giustifica a sua volta (senza dover essere giustificata essa stessa) la libertà, in quanto questa è condizione essenziale per l’esercizio della moralità. Il rapporto rispetto alla Fondazione della metafisica dei costumi è invertito: là la libertà era un concetto meramente negativo ed era una prospettiva debole e negativa, cosicchè, se si vuol dare valore conoscitivo forte (ed è ciò che Kant vuole), occorre far derivare la libertà dalla moralità, che so essere una conoscenza assolutamente oggettiva della ragion pura nella sua veste pratica. Per superare quest’apparente incongruenza, Kant distingue – in una nota della Critica della ragion pratica – tra due piani: da un lato, la libertà è la ratio essendi della moralità (ovvero la condizione per la sua esistenza), dall’altro la moralità è la ratio cognoscendi della libertà (ossia la condizione per conoscerla). Dunque l’ordine noumenico interferisce su quello fenomenico, per cui l’evento x è noumenicamente determinato dalla mia ragione e nello stesso tempo tale azione si inserisce nella serie causale fenomenica; e il fatto x è a sua volta spiegabile facendo riferimento ad una causa fenomenica, senza far riferimento all’imperativo categorico. L’intero discorso è condotto in base ad una conoscenza morale e non teoretica, sicchè sarà una conoscenza certa dell’esistenza della libertà e della moralità, ma non per questo è una conoscenza teoretica.IL NEOKANTISMO
Mantenendo due piani diversi di realtà, Kant salva il dualismo senza imbattersi nei problemi contro cui si era scontrato Cartesio: il noumenico e il fenomenico restano due piani di realtà diversi, ma tuttavia vi è un punto di contatto tra i due. In questa maniera, il problema dello spettro nella macchina è solo allontanato, ma non debellato: queste difficoltà sparirebbero se si cancellasse il discorso metafisico sui diversi livelli di realtà e si parlasse più semplicemente di punti di vista differenti, abbandonando il discorso ontologico e analizzando il problema sotto forma prospettivistica. E’ esattamente ciò che fanno alcuni esponenti del neokantismo di inizio Novecento. Uno dei caratteri portanti del movimento neokantiano è l’avversione ad ogni forma di metafisica: l’idealismo, lo spiritualismo e anche il positivismo, che a suo modo, parlando di leggi della realtà, finiva per essere una specie di metafisica. Secondo i Neokantiani, non è possibile fare un discorso oggettivistico di questo stampo, puntando sul fatto che vi sia un oggetto che vada al di là del mio modo di conoscerlo: questo è per loro il vero insegnamento kantiano, a cui il filosofo tedesco ha tenuto fede nella Critica della ragion pura, ma che ha poi clamorosamente tradito nella Critica della ragion pratica, ove postulava una sfera noumenica, ricorrendo in tal modo ad una scorciatoia di bassa lega. Essi negano radicalmente che si possa parlare di un oggetto indipendente dalle modalità conoscitive aliene al soggetto: per questa via, ogni metafisica è infallibilmente bandita. Wilhelm Windelband scrive nel 1904 un’opera intitolata La libertà del volere, in cui parte dai seguenti presupposti: la conoscenza non può mai essere assoluta, sicchè mai conosciamo la realtà quale essa è effettivamente; la nostra conoscenza, dunque, non attinge altro che fenomeni. Ma Windelband – dopo questo incipit kantiano – estende quello che era l’orizzonte di Kant: se per questi la conoscenza fenomenica è determinata da forme a priori (spazio e tempo nel sensibile; le 12 categorie per l’intelletto), per Windelband, invece, essa è determinata dall’applicazione di criteri diversi (“punti di vista“) in forza dei quali si legge la realtà, con l’inevitabile conseguenza che la connessione causale necessaria legante i fenomeni l’uno all’altro è solo un “punto di vista“, un modo di fenomenizzare (e di distorcere) che non può pretendere di conoscere la realtà nella sua noumenicità. Dunque, se per Kant c’è una sola forma di fenomenizzazione, per Windelband, viceversa, ne esistono una pluralità, tutto dipende dal punto di vista che si assume. Così, accanto alla causalità necessaria – usata nell’ambito delle scienze -, esistono anche altri modi di fenomenizzare il reale, ad esempio considerando gli oggetti in una sequenza non di cause ed effetti, ma di mezzi e fini in vista di valori: e il valore è, evidentemente, qualcosa di nettamente diverso da quella causalità necessaria in cui a contare è solamente la connessione necessaria, a prescindere dai valori; qui invece – cioè nell’ambito dei valori – vale l’esatto opposto, a contare sono i valori e, conseguentemente, la possibilità di creare gerarchie assiologiche, senza che la causalità necessaria perda il suo valore. Anzi, essa è affiancata dalla causalità libera, senza la quale non sarebbe in alcun modo possibile parlare di valori: ne segue che ci troviamo dinanzi non già a realtà diverse, bensì a diverse modalità di fenomenizzazione di una stessa realtà. In perfetta sintonia con Windelband, Cassirer – in Determinismo e indeterminismo nella fisica moderna (1937) – sostiene che vi sono diversi modi di determinazione dell’oggetto, diverse perché obbedienti a diverse forme di conoscenza, che Casirer chiama forme “simboliche“, a sottolineare che non c’è oggettività, ma soggettivitàFILOSOFIA MORALE
INTRODUZIONE
LA LOTTA TRA LE PASSIONI E LA RAGIONE
ANTICHITA’
I problemi di filosofia morale, dall’antichità ad oggi, sono andati incontro a notevoli sviluppi ed evoluzioni: morale deriva dal latino mos, che significa "costume", sicchè la filosofia morale avrà a che fare con la domanda "come devo comportarmi?", a sua volta connessa ad un’altra questione: "che cosa è il bene? Per me? E per gli altri? E la relazione tra il bene per me e quello per gli altri?" Risulta fin da ora evidente come, per poter capire che cosa sia il bene per me, io debba preliminarmente capire chi sono io e, di conseguenza, che cosa sono gli uomini. Ne consegue che non possiamo interrogarci sulla morale se non partendo dalla filosofia in generale, soprattutto quella greca, che ha lucidamente formulato tutte le domande possibili. Ci imbattiamo subito in una radicale differenza tra la storia come magistra vitae (maestra di vita) e la filosofia come meditatio mortis, secondo l’interpretazione che dà Platone nel Fedone (60 d, e seguenti): prendendo alla lettera queste due massime, sembrerebbe che alla storia spetti il compito indubbiamente più gratificante di guida nella vita, di narrazione di ciò che è avvenuto, mentre alla filosofia toccherebbe l’ufficio più opprimente di riflettere sulla morte. Tutto ciò può essere facilmente smentito se teniamo presente la scarsa attenzione e la poca importanza riservata dagli antichi alla storia: già Aristotele – nella "Poetica" – opera una distinzione tra storici e poeti, mettendo in luce come i primi si limitino alla cronaca degli accadimenti, registrati nel loro singolare e contingente succedersi, mentre i secondi (alla pari dei filosofi) si occupano dell’universale, non di cosa accadde ad Alcibiade, ma di cosa potrebbe accadere ad uno come Alcibiade, cogliendo in tal modo i tratti eterni dell’universale umanità dell’uomo : narrano cioè le coseoia an genoito, "quali potrebbero avvenire". Anche il filosofo si occupa dell’universale, in quanto si sforza di conoscere ciò che accomuna determinate cose, costituendone – al di là delle loro accidentali differenze individuali – il vero essere che le identifica per quelle che sono. In questa prospettiva, l’arte e la filosofia si pongono al di sopra del sapere proprio dello storico, confinato al particolare e alla banale catalogazione degli aventi. Un’analoga svalutazione della storia – forse anche più accentuata che in Aristotele – troviamo in Schopenhauer, il quale dice che gli oggetti della storia sono gli uomini e le loro imprese nel loro contesto storico, ricostruito dalla storia su un piano illustrativo; secondo il filosofo tedesco – in sintonia con Aristotele – se poesia e filosofia conoscono l’uomo in quanto tale, il filosofo coglie l’in sé di quelle cose che lo storico si limita ad elencare. Tutte queste considerazioni ci inducono a rivedere le due massime da cui siamo partiti: la storia è maestra di vita nel senso che, esibendoci il comportamento degli uomini, ci introduce alle innumerevoli difficoltà del vivere nel tempo, ma non è in grado di fornirci spiegazioni di più vasta portata. E’, in altri termini, maestra di vita nella misura in cui illustra il disagio esistenziale: dal canto suo, la filosofia è meditazione sulla morte nel senso che ha a che fare con questioni ultime e di ordine generale, tanto più che il filosofo stesso implica una morte. Infatti, questa superiorità della filosofia sulla storia e, più in generale, sul punto di vista comune è segnalata dalle grandi difficoltà che l’accesso al punto di vista filosofico implica. Questo passaggio – dal punto di vista comune a quello filosofico – comporta un autentico trauma, paragonabile a quello della conversione religiosa o del passaggio dall’adolescenza all’età adulta, sicchè non è sbagliato dire che si tratta di una morte e di una rinascita: muore il vecchio (il punto di vista comune, o – per restare alla metafora della religione – il profano) e nasce il nuovo (il punto di vista filosofico, o il religioso). Il processo è pertanto accompagnato sia dai dolori della morte del vecchio sia da quelli del parto con cui viene al mondo il nuovo: questo passaggio lo troviamo per la prima volta esposto nei dialoghi platonici, il cui protagonista – Socrate – è l’ostetrico del filosofare, colui che ha assistito e coadiuvato la nascita del punto di vista filosofico, e ciò implica che egli inevitabilmente sia il becchino del punto di vista comune. Seguendo Platone, assistiamo al nascere e al crescere del filosofare, all’individuarsi e al distinguersi dei diversi punti di vista in virtù di una curiosità radicale e insoddisfatta di ciò che via via si trova a sapere. Viene in tal modo a delinearsi una netta separazione tra le opinioni (doxai) – proprie del punto di vista comune – e la scienza (episthmh) – propria del sapere filosofico: le prime sono suscettibili di essere vere o false, mentre la seconda è solidamente radicata nel vero. Nel Teeteto (180 e) Socrate si domanda: "chiami tu pensare quel che chiamo io? Un discorso che fra sé e sé l’anima tiene su ciò che esamina […]. Altro non è l’anima se non un discorrere". Ciascuno di noi, secondo Platone, quando pensa è come se dialogasse tra sé e sé: ed è per questa ragione che il filosofo ateniese ravvisa nel dialogo la forma più adatta per fare filosofia, preferendola di gran lunga alla trattatistica. Le opinioni, ad avviso di Platone, sono acritiche, infondate e passivamente subite, mentre la scienza è costantemente critica e frutto della ragione, giudica e mette inkrisiV un’opinione, mette in crisi ogni sapere dubbio, ogni pregiudizio ("si dice", "si crede", ecc): così si spiega come, se la filosofia è dialogo, l’opinione è invece monologo, assolutamente priva di confronti e aperture. In questo senso, l’Oriente non greco monologa, e infatti non scrive dialoghi ma libri sapienziali, mentre sono i Greci a scoprire la filosofia, intesa come messa in discussione di tutto, smascherando le opinioni, qualunque sia l’autorità di cui esse si ammantano. Si tratta, naturalmente, di un passaggio doloroso, giacchè si abbandona il certo per l’incerto, il noto per l’ignoto: e non è un caso che la filosofia nasca con l’assassinio del suo ostetrico Socrate; mentre l’innocenza è immediata e, perciò, più fragile, la virtù non è immediata e dunque è meno fragile, poiché è stata messa alla prova. Il sapere filosofico, dai Greci ad oggi, è andato sviluppandosi lungo due direttrici: da un lato, dopo aver attraversato il fondamentale momento della critica delle opinioni, si articola in una visione onnicomprensiva e metafisica del mondo (Leibniz, Kant, Hegel, Marx); dall’altro, si è sviluppato un sapere in cui la riflessione critica della ragione non costituisce solo un momento imprescindibile, bensì costituisce essa stessa l’aspetto fondamentale di un filosofare in cui permangono dubbi e difficoltà di conoscenza: si tratta di un sapere lontano dalle pretese onnicomprensive e metafisiche, un sapere che procede con circospezione, che formula congetture più che teoremi. Tra i suoi esponenti – antichi, moderni e contemporanei (giacchè questa forma di pensiero è tipica dell’età moderna e contemporanea) – possiamo ricordare i Sofisti, gli Scettici, i Cinici, i Cirenaici, i Megarici, Machiavelli, Hobbes, Montaigne, Erasmo, Vattimo. Assodata la diversità tra punto di vista comune e punto di vista filosofico, si può anche vivere senza filosofare, cosicchè la filosofia sarebbe qualcosa di accessorio e di cui si potrebbe benissimo fare a meno (anche se contro questa tesi si schiera apertamente Aristotele nel Protreptico). Del resto, che la filosofia sia un lusso pare tramandato dalla massima primum vivere, deinde philosophari, con la quale si mette in luce come la vita venga prima della filosofia e come quest’ultima sia ad essa subordinata: ma – chiediamoci – se è vero che si può vivere senza fare filosofia, è anche vero che si può vivere bene senza fare filosofia? In particolare, sia Aristotele sia Bergosn distinguono tra "vivere" e "vivere bene", domandandosi entrambi se il vivere non-bene possa dirsi vivere. Anche il filosofo deve soddisfare i suoi bisogni primari (la sete, la fame, ecc), altrimenti non sarebbe un essere umano ma un Dio: ciò non toglie, però, che nella misura in cui filosofa, egli si dedica ad un’attività divina, ingrediente della vita felice. Tuttavia, se considerati separatamente, sia il sapere critico sia quello metafisico sono insufficienti: anche se, a prima vista, sembrerebbe che i risultati del primo siano evidenti (quelli del secondo appaiono infinitamente meno soddisfacenti). In quanto conoscenza del vero bene, la ragione è confutazione delle passioni, sicchè queste nulla più possono contro di essa: la ragione sa anche che cosa ogni cosa deve essere, che cosa è giusto che ogni cosa sia. Attribuendo a ciascuno il suo, la ragione fa il giusto. Ma nel corso della storia è anche andato spostandosi il punto di vista verso Dio: se Tommaso è convinto che il teologo possa anticipare la scienza di Dio, la filosofia è per Hegel "la domenica della vita", nel senso che è il compimento più alto e l’ornamento più squisito della vita umana. Tutt’altra concezione della ragione (e di Dio) è quella propria dei filosofi "critici", per i quali – date le interminabili dispute che contrappongono tra loro i vari pensatori – è impossibile raggiungere una verità ultima; addirittura, agli occhi di costoro la metafisica , oltrechè inutile, appare nociva, poiché distrae dal sapere coerente dei propri limiti intrinseci di essere umano che procede per congetture e ipotesi, non per verità assolute. Questi pensatori tendono a concepire il bene come l’utile collettivo che la ragione di volta in volta individua e calcola: già Montaigne nota come basti spostarsi sull’altra sponda del fiume per accorgersi che tutte le leggi e le usanze cambiano, cosicchè ciò che di qua era lecito, di là non lo è. Emerge chiaramente, allora, come la giustizia altro non sia se non il frutto di un accordo mirante al bene della collettività, senza voler per questo arrivare alle note conclusioni di Trasimaco (nella Repubblica di Platone) secondo cui "il giusto altro non è che l’utile del più forte". E’ una ragione rinunciataria, che rinuncia alla verità assoluta e si accontenta di piccole certezze acquisite un po’ alla volta. Una prospettiva rinunciataria, sì, ma con funzione strumentale, non ornamentale: mira infatti a promuovere un miglioramento della vita umana sulla terra anche attraverso lo sviluppo di quella scienza sempre troppo poco considerata dalla metafisica. Ecco perché la filosofia trasforma la vita vegetale in esercizio critico e mosso da sincera curiosità, contraddistinguendoci da tutti gli altri animali: per i metafisici, però, si tratta sempre della contemplazione della verità assoluta, ma, sotto questo profilo, è la prospettiva critica (sofistica e scettica) – tendente ad organizzare il nostro sapere terreno – a poter effettivamente migliorare le nostre condizioni di vita terrene, ed è per questo che oggigiorno tende a prevalere tale posizione. Ma dove va a finire la metafisica? Possono gli uomini eticamente fare a meno dell’ornamento? Non è un caso che nel Novecento l’architettura sia stata caratterizzata dall’abolizione di ogni abbellimento, promuovendo esclusivamente il funzionalismo e la completa oggettività. C’è anche stato chi ha detto che "l’ornamento è un delitto", una sorta di reazione al culto del bello nella architettura liberty di inizio ‘900. Ma possiamo abbandonare il superfluo? Può il sapere rimanere chiuso e fare a meno di ogni forma di trascendenza? Forse la questione può essere, se non risolta, almeno chiarita in analogia con il ruolo che Kant assegna alla metafisica, da lui smascherata come un errore della mente umana, incline a spingersi erroneamente al di là del sensibile e del finito: secondo Kant, la metafisica è sì un errore, ma non per questo può essere debellata; così come quando in riva al mare vediamo l’orizzonte più in alto e, pur sapendo che si tratta di un’illusione, non per questo riusciamo a vederlo allo stesso livello del mare. Così come la metafisica viene da Kant, in qualche maniera, relegata all’ambito dell’ornamentale, impossibilitata ad una completa assolutizzazione, similmente possiamo capire come, da una parte, il superfluo non vada mai abbandonato e, dall’altra, come la metafisica rientri in tale superfluo/ornamentale. Dicevamo che è con Platone e con i suoi dialoghi che vede la luce la filosofia: ma il vero ostetrico del sapere filosofico è la figura di Socrate, colui che distingue la scienza dalle opinioni, cerca spiegazioni razionali, cerca di darsi ragione delle norme della propria condotta e del proprio sapere vagliando criticamente le opinioni e distruggendole quando – come spesso accade – si rivelano fasulle. Egli è armato dell’ironia e della maieutica: la prima è la figura retorica con la quale si farebbe intendere il contrario di ciò che si dice (cfr. Encyclopedie di Diderot; De oratore, III, di Cicerone; Quintiliano). Ma il tono della voce segnala una discrepanza tra il detto e il significato: se prendiamo il verbo greco eironeuomai notiamo come esso significhi "dissimulare", "nascondersi parlando", ma anche "canzonare", "prendere in giro"; o eirwn , poi, vuol dire "colui che si spaccia per". L’ironia può essere dunque definita come un espediente tecnico impiegato da avvocati e da oratori: Quintiliano la tratteggia come un modo di relazionarsi con gli altri improntato sulla comunicazione, un modo non soltanto indiretto, ma addirittura complicato e articolato. Non sorprende, pertanto, che l’ "ironista" sia più preparato rispetto al suo uditorio: il che si verifica soprattutto in due casi, quando cioè l’interlocutore è ignorante (ma si crede colto), o anche quando è intellettualmente debole, cosicchè gli si può dar ragione fino a che non vengano alla luce tutte le contraddizioni derivanti dall’ammissione delle sue tesi. Chi si avvale dell’ironia ne fa, in certo senso, un uso narcisistico, quasi umiliante nei riguardi del proprio interlocutore, cosicchè non è sbagliato dire che l’ironista esercita una forma di crudeltà verso gli altri, una sorta di sadismo, un irresistibile gusto che si prova ad essere superiori. Così il commediografo Aristofane fa del termine "ironista" un vero e proprio insulto con cui zittire chi asseconda falsamente i propri interlocutori, fingendo furbescamente di approvare le loro tesi; lo stesso Platone (Repubblica, I) mette in bocca agli interlocutori di Socrate parole piuttosto aspre verso la sua ironia canagliesca. Così, con Trasimaco finge di ignorare che cosa sia la giustizia, sfugge alle domande che gli vengon poste appellandosi alla propria ignoranza e spazientendo i propri interlocutori: si può allora dire che la difficoltà della ricerca sia ironia? Platone libera il maestro Socrate dal luogo comune mettendo in evidenza come l’ironia, propriamente, sia una relazione – indiretta – con la verità e per questo motivo dotata di valenze pedagogiche, poiché innalza l’interlocutore ad un sapere certo; così si ha l’impressione che Socrate si faccia beffe di Trasimaco e degli altri protagonisti della Repubblica, ma in realtà li incalza, li sprona come fa la mosca coi cavalli e li fa uscire dal vicolo cieco dell’opinione verso la retta via della scienza. In questo caso, la dissimulazione si configura quasi come una benevola conquista, non come un gesto di mera superiorità dettata da uno sprezzante orgoglio, poiché è finalizzata a portar fuori dal circolo della limitatezza: l’interlocutore non è più schernito e deriso, ma soccorso, l’ironia sacrifica il proprio sapere per redimere gli altri dall’ignoranza, è un abbassamento (khnosiV), un farsi piccoli per salvare gli altri. Ma – attenzione – ad abbassarsi è Socrate, non il sapere in quanto tale, altrimenti l’ironia si trasformerebbe in divulgazione. Il concetto greco di khnosiV come "svuotamento" (in greco kenon significa "vuoto") lo ritroviamo nella teologia cristiana quando si parla dell’incarnazione di Dio e della sua liberazione dal peccato: e, in parallelo, c’è stato chi ha guardato in analogia alla figura di Socrate e di Cristo (Hegel stesso lo fa), poiché sia con l’uno sia con l’altro si ha un’autentica liberazione, ci si maschera per smascherare, si mistifica per demistificare ciò che pare certo ma che, in realtà, non lo è affatto. In questo senso, l’ironistica porta la guerra laddove c’è una pace illusoria, getta scompiglio, spiazza, è – in altri termini – pars destruens ma, in certo senso, anche pars costruens. Infatti, distrugge, sì, le opinioni, ma per partire da zero e fondare un sapere certo, che oltrepassi il limite e lo riconosca come ormai sorpassato, per rendere partecipi di ciò anche gli altri uomini: per far riferimento al celebre "mito della caverna" di Platone, è l’uomo che, liberatosi dalle catene che lo tenevano prigioniero sul fondo della caverna, sale in superficie, scopre la verità e ritorna dai suoi compagni per trasmetterla anche a loro. L’ironia socratica può allora essere definita come impegno totale per il Bene, uno slancio verso l’esistenza autentica e contro il lasciarsi vivere passivamente in cui molti incappano. Un tale sapere dovrà necessariamente essere di tipo concettuale, e del concetto Socrate stesso può dirsi inventore: esso è una definizione della cosa in questione (il bene, il bello, il giusto, ecc), una definizione che prende le mosse dalla domanda "che cosa è (ti esti) quella cosa?" e a cui si dà una risposta scientifica, esulante dall’opinione. In questo modo, tale aspirazione a spingersi al di là del dato si traduce in scienza dell’essere, come la metafisica (che è scienza dell’essere in quanto tale): e così la figura di Socrate va incontro ad un enigmatico sdoppiamento, per cui ci troviamo di fronte ad un Socrate platonico/metafisico e ad un Socrate empirico/cirenaico, uno speculativo, l’altro esistenziale (basato sull’ammissione della propria ignoranza e nella massima delfica del "conosci te stesso"). Ma il gnwqi sauton può dare adito a due diverse interpretazioni, una metafisica, l’altra esistenziale: al "conosci che cosa sei in quanto essere umano", ossia "conosci che cosa è l’uomo" (scienza di sé), si contrappone il "conosci te stesso come singolo" (coscienza di sé), cercando di vivere la tensione al bene come tua propria esclusiva. Così Platone interpreta l’ignoranza come iniziale critica dell’opinione, mentre le scuole socratiche la concepiscono diversamente, come direttiva di vita più che di sapere, con la conseguenza che il vivere da filosofo vorrà dire comportarsi contro convenzioni e vivendo in pura naturalezza. Non si tratta pertanto – secondo le scuole socratiche – di cercare che cosa sia l’uomo, ma, piuttosto, di cercare degli autentici uomini, ossia coscienze adatte a ricercare il vero bene, coscienze che siano realmente se stesse senza cadere in convenzioni culturali, sistematiche e, in definitiva, conformistiche. Da questo atteggiamento (congiunto ad una valenza fortemente critica della ragione) deriva una forte autarchia (autarkeia), un esistere autonomamente senza farsi toccare dagli accadimenti esterni. Il problema dell’ignoranza era posto sul tappeto da Platone a proposito dell’immortalità dell’anima: nell’Apologia, invece, era lasciato aperto uno spiraglio di scetticismo, anche se poi – con la voce della metafisica – il filosofo ateniese avrebbe debellato del tutto l’ignoranza, arrivando ad ammettere la certezza di una vita ultraterrena e dell’immortalità dell’anima. L’ignoranza viene dunque bandita? Con Platone, Socrate arriva a verità iperuraniche e assolute, mentre con le scuole socratiche egli resta avvolto da un alone di ignoranza, di una "dotta ignoranza" (per usare le parole di Cusano), consapevole dei propri limiti intrinseci ma, non per questo, disposta a rinunciare al sapere. Se in Socrate sussiste un perfetto equilibrio tra i due atteggiamenti, in Aristotele e in Platone prevale decisamente l’indirizzo metafisico, mentre nella successiva età ellenistica trionfa quello scettico/critico: dal VI al XII secolo c’è poi una parentesi non filosofica ma teologica, dove l’attenzione per Dio e i problemi di fede prendono il posto in precedenza occupato dall’indagine filosofica, ora detronizzata. Dal XIII al XVI secolo torna invece a dominare l’indirizzo metafisico, ma da Machiavelli fino all’età illuministica (e così sarà anche nel Novecento post-marxista) trionfa l’atteggiamento critico/scettico. All’atteggiamento metafisico corrisponde un’etica saldamente basata sulla virtù, mentre a quello critico/scettico un’etica che fa dell’utile il suo parametro: ad esse sono sottese due differenti concezioni della ragione e del suo rapporto con l’etica. I pensatori dell’uno e dell’altro indirizzo si trovano d’accordo nell’individuare nell’uomo un’entità dotata di ragione e di passioni, ma quando si tratta di dire che cosa sia la ragione già nascono le prime divergenze di prospettiva. Per individuare i due tipi di etica, dovremo pertanto capire che cosa effettivamente siano le passioni e poi la ragione metafisicamente e critico/scetticamente concepita. Il termine greco che traduce "passioni" è paqoV, che letteralmente significa "quel che si prova", dal verbo pascw; significa anche subire la presenza di qualcuno o di qualcosa, sicchè passione è il contrario di azione e il termine coincide con "affezione", che vuol dire subire un’azione essendone influenzato e modificato: passione è dunque, in primo luogo, qualsiasi modificazione dell’anima. Tali sono anzitutto le sensazioni che ci giungono dal mondo esterno e dalle quali l’anima è affetta, ma tali sono anche le passioni in senso stretto, ossia le modificazioni di natura affettiva, dalle quali l’anima è mossa. L’anima (sia che sia sconvolta da passioni interne sia che lo sia da esterne) è mossa, è paziente, subisce un’azione, patisce sia le sensazioni provenienti dall’esterno sia le passioni producentesi all’interno (stati d’animo, emozioni, pulsioni: l’ira, l’odio, la paura, ecc), proprio come il paziente patisce la malattia e la cura somministratagli dal medico. L’anima è passione perché si ritrova ad essere preda di tali passioni, stati e pulsioni di volta in volta occasionate da certe circostanze, inerenti all’anima in quanto tale, latenti in essa e risvegliate dalle circostanze: le passioni sono – secondo Platone e Aristotele – una sfera dell’anima, l’anima sensitiva, che sta a monte della ragione. Esse invadono e tendono a dominare l’anima determinando il comportamento dell’individuo che ne è preda; un tale individuo è tutt’uno con la passione, è mero patire: esse sono necessarie, nel senso che si trovano naturalmente ad essere quel che sono, sicchè l’operare delle passioni è, a ben vedere, un operare subìto e patito, il passionale non sa perché opera a quel modo né ha deliberato di operare così, ma subisce passivamente quell’operare delle passioni in lui (come si dice: la passione è cieca). Sorprendono e catturano l’individuo che ne è vittima ignara: se l’uomo fosse solo passioni, ignorerebbe di esserlo. Ma finchè sono passioni, il mio agire resta un patire, un essere necessitato. Il linguaggio comune dice giustamente che si è spinti dalla passione, dall’odio, dalla paura, ecc; si è cioè spinti ad operare alla cieca, non discernendo e perciò non deliberando. Ma l’anima non è solo passioni: c’è anche, al suo interno, la ragione, la facoltà del pensiero discorsivo che guida l’uomo. Il problema della morale resta, in questo senso, il rapporto tra ragione e passioni: quale è il rapporto? Quale concetto di ragione fanno valere i diversi orientamenti filosofici? La ragione è dialogo (nell’accezione greca di dia + logoV), ossia un trascorrere da un concetto all’altro organizzandoli ed articolandoli in un sapere che risulti organico. Il concetto è così il risultato della definizione, dice che cosa una cosa è, ne coglie cioè l’essenza, costituendone l’essere che la identifica per quella che è, individuando ciò in forza di cui essa è se stessa, ciò che essa deve essere per essere se stessa. In altri termini, il concetto individua e coglie ciò che ritroviamo permanente e accomunante in tutte le cose che in virtù di quel qualcosa di permanente e accomunante formano una specie. Ma tale essere permanente e accomunante è per i metafisici l’essenza universale e comune, colta dalla definizione e fissata nel concetto. La domanda "che cosa sono Tizio, Caio e Sempronio?" rimanda a quella "quale è l’essenza universale che li costituisce?" Essi sono corpo e discorso, ovvero sono animali razionali: questo è il concetto che li identifica nella loro essenza, cogliendo il genere prossimo (sono animali, come molti altri esseri) e la differenza specifica (sono uomini); alla base di ciò stanno il principio di identità (A è A e deve essere A) e quello di non contraddizione (A è non uguale a non-A). Il termine "essere", che abbiamo più volte trovato dispiegato nelle definizione, è però fortemente ambiguo: servendoci del linguaggio degli Scolastici, possiamo dire che si tratta di un termine non univoco, ma equivoco, ossia dotato di più significati. Soprattutto due: ha un significato essenzialistico e un significato esistenzialistico. Di un soggetto, infatti, possiamo predicare il verbo "essere" in due modi diversi, a seconda che si risponda a due diverse domande: "quid est?" e "an est?". Nel primo caso, mi chiedo che cosa una cosa è, mentre nel secondo mi interrogo se essa c’è, ossia se esiste: così domandarsi "che cosa è " Socrate è differente da chiedersi "c’è Socrate?". Nel primo caso, voglio sapere in che cosa consista il suo essere, nel secondo caso, invece, mi interrogo intorno alla sua anitas, mi domando cioè se esiste oppure no. A questa seconda domanda, rispondo di volta in volta con una constatazione: se Socrate c’è, risponderò con "c’è"; se invece non c’è dirò "non c’è". Alla prima, invece, rispondo allorchè vengo alla definizione della cosa, "Socrate è animale razionale"; posso rispondere solo se conosco la definizione. Se poi esperisco anche l’esistenza, potrò dire che effettivamente esiste un uomo di nome Socrate. Definendolo, siamo venuti a determinare il suo essere, ne abbiamo definito l’essenza, ossia ciò che ne costituisce la permanente ed irrinunciabile peculiarità del suo essere, tolta la quale cesserebbe di essere quel che è. Quando i metafisici parlano di essere, usano sempre l’accezione essenzialistica: l’ultimo grande metafisico – Plotino – dice che l’essere deve essere un questo (todh ti) e quindi alcunchè di delimitato, tant’è che l’ ousia stessa è un todh ti. All’essere non compete, secondo Plotino, il librarsi qua e là nell’indeterminatezza, bensì di essere consolidato da determinazioni e da forma, da delimitazioni, da stabilità e la stabilità è delimitazione e forma: l’essere è, anzi, sempre forma, un qualcosa di determinato, un essere conformato, il determinato esser qualcosa proprio di un certo ente, coglibile dal pensiero che lo coglie definendolo. Si scopre un’intenzionalità tra pensiero ed essere: il pensiero è fatto per l’essere che è forma, e l’essere in quanto è forma è definibile dall’esser ridotto al pensiero intelligibile, fatto per il pensiero stesso. E’ questo l’ottimismo razionalistico greco, che vede nella ragione l’arma appositamente data per conoscere il mondo. Sempre Plotino dice che occorre che il pensante afferri qualcosa di in sé distinto e il pensato, colto dal pensiero, deve essere alcunchè di indifferenziato, altrimenti non se ne dà pensiero, ma solo uno sfiorare – senza toccarlo – il concetto. In questo senso, Plotino sta introducendo la teologia: tutto ciò che è informe non può essere conosciuto, al massimo può essere alluso: tale è l’Uno, che è situato al di là dell’essere, è ineffabile, è nome al di sopra di ogni altro nome. Per il greco, l’informe è perciò stesso impensabile. La domanda "che cosa è?" prende di mira un esser qualcosa che ritorna in molti enti diversi, ma nei molti in cui lo riconosciamo appare sì diverso, ma è sempre lo stesso. Socrate è, in questo modo, identico e diverso dagli altri uomini: sono tutti ugualmente uomini, ma ciascuno lo è in maniera diversa. I tanti uomini si trovano accomunati da una stessa quidditas (l’esser uomo) che tutti sono, ma ciascuno a suo modo. L’esser qualcosa che li identifica e li accomuna è l’universale che li mostra come membri di una stessa specie. Oggetto del sapere filosofico è la quidditas delle cose esistenti nello spazio e nel tempo e che in quanto permanente e comune è coglibile dal pensiero e fissabile nel concetto: la scienza del sapere filosofico per oggetto ha l’universale e il necessario, mentre il mutevole e l’accidentale può essere raccontato ma non saputo nel senso più forte del termine. Così il sapere storico – ritornando al punto di partenza – è inferiore rispetto a quello filosofico. Non c’è infatti sapere stabile di Tizio o di Caio, ma dell’uomo che Tizio e Caio sempre e comunque sono: alla ragione filosofica compete pertanto un punto di vista peculiare, che non solo ha per oggetto l’universale, ma che proprio perché ha un tale oggetto deve esso stesso essere universale, vale a dire un punto di vista che trascende quello dei singoli individui empirici, variamente determinato dalle diverse impressioni sensibili, dalla mutevolezza della facoltà immaginativa, dall’influsso delle passioni. E’ il punto di vista della ragione stessa presente in tutti gli uomini. E il filosofo è colui che, riflettendo e ragionando, si converte dal punto di vista empirico (dove la ragione latita o dorme, e l’anima è ridotta a sensitiva) in cui trionfano le opinioni a quello superiore, in cui si è solo ragione, l’identica e oggettiva ragione presente in ogni uomo a prescindere da pulsioni, impulsi, fantasie: si tratta di un punto di vista super partes, in cui vige la pura e disinteressata conoscenza contemplativa del che cosa le cose sono, al di là degli accidenti, una pura e disinteressata contemplazione dell’essere, di cui la metafisica è scienza (secondo la definizione di Aristotele). Sia Platone sia Aristotele sono concordi nel concepire la filosofia come conoscenza degli universali, ma differiscono nell’intendere gli universali stessi, da Platone chiamati "idee" e intesi come ante rem, in re e post rem; da Aristotele (che li chiama "forme") intesi solo in re e post rem. Dal diverso modo di intenderli, il differente tipo di conoscenza prospettato dai due filosofi: per Platone si tratta di anamnesi, per Aristotele di astrazione. Ma che cosa è l’idea (eidoV) per Platone? A partire da Cartesio, "idea" designa cumulativamente ogni genere di nostra percezione, è una rappresentazione mentale (l’immagine mentale che ho del rosso, del cane o di Dio). Ma per Platone non è così: essa coincide con la morfh, ossia con la forma, e allude ad un contorno racchiudente qualcosa, altro non è se non un essere qualcosa. L’esser uomo è una modificazione nel tempo e nello spazio dello stesso essere uomo che sussiste nell’eternità, immutabile, come pienezza di quel certo essere qualcosa, sussiste come complicazione di tutti i possibili modi di essere quella certa cosa. L’eterna, infinita pienezza dell’essere un certo qualcosa altro non è se non il mondo delle idee presupposto e principio di questo temporale mondo di singoli enti empirici, ciascuno dei quali è una modificazione delle idee a cui fa capo. E’ un particolar modo di essere quella o quelle infinite idee. Tizio e Caio sono diversi modi di essere dell’idea uomo e animale. A produrre queste modificazioni che sono le cose empiriche sono le idee stesse, che non cessano di essere quelle che sono (eterna pienezza d’essere) ma si modificano divenendo nel tempo e nello spazio i singoli enti che ad esse fanno capo, ai quali partecipano. Conoscere il vero essere delle cose sarà conoscere le idee. La ragione ridestata dalle sensazioni risale dal mondo sensibile (che sulle prime le appare come l’unica realtà) a quello iperuranico, di cui il nostro è copia sbiadita: la ragione si è destata e ad essa sola il filosofo si è ridotto, avendo trasceso i sensi da cui aveva preso le mosse. Che cosa sono gli enti? Esistono in virtù di se stessi o di un’altra realtà? Secondo Platone, essi esistono in virtù dell’esistenza di un’altra realtà, le idee, che ne sono il presupposto e il principio; le idee sono siffatte che esistono necessariamente come tali, la loro perfezione ontologica non può mancare di esistenza (prova ontologica). Universali sono per Platone le idee, perfette perché costituenti l’infinita pienezza d’essere: l’idea di cavallo, cioè, è la perfetta attuazione di tutti i possibili cavalli. Il che significa che l’idea di cavallo non è un enorme cavallo in cui stanno tutti i cavalli sensibili: l’idea è secondo Platone qualcosa di immateriale, fuori dal tempo e dallo spazio (altrimenti sarebbe finita e non infinita). La conoscenze delle idee sarà razionale, mera intuizione intellettiva, il che segnala che la ragione è tutt’altra dalla sensazione e dalle passioni, è completamente autonoma. Il motivo per cui Platone ipotizza il mondo delle idee può almeno in parte essere compreso se facciamo riferimento al nostro mondo: come può esso spiegarsi se non facendo riferimento ad un altro mondo di cui il nostro sarebbe copia? Che cosa può spiegarmi l’essere identico e diverso che accomuna le differenti famiglie di enti empirici, per cui vedo gli uomini uguali e diversi fra loro? Si tratta, naturalmente, di fare riferimento al mondo delle idee, per capire come l’esser cavallo (o, se preferiamo, l’idea di cavallo) sia presente nei diversi cavalli sensibili, che di essa partecipano. Gli enti sono appunto classificabili in forza di un’identità che li accomuna, ma un tale principio in grado di render conto del mondo quale a noi appare non è rintracciabile nel mondo sensibile, poiché tutti gli enti che in esso ci appaiono di volta in volta sono se stessi, determinati, e perciò non possono fungere da princìpi dell’esser uomo di Caio e di Tizio. Ciascun ente empirico, cioè, non può render conto della sterminata molteplicità di enti finiti, cosicchè essi si spiegano a partire da altro: proprio qui sta la differenza riconosciuta dagli Scolastici tra l’ "ens a se" (l’ente che sussiste di per sé) e l’ "ens ab alio" (l’ente che esiste nella misura in cui dipende da qualcos’altro). Il nostro mondo empirico non è "a se", secondo Platone, ma "ab alio", dipende cioè da qualcos’altro, e quel qualcos’altro è appunto il mondo eterno delle idee: l’essere quel che sono gli enti lo devono per l’appunto alle idee di tale mondo intelligibile, che, diventandoli, li fanno essere quel che effettivamente sono. E così il mondo esiste in virtù del parteciparsi delle idee, le quali continuano ad essere quel che sono e diventano la molteplicità degli enti finiti che ad esse fanno capo. Tuttavia né Platone né nessun altro neoplatonico ha mai azzardato a spiegare come ciò possa avvenire, come le idee si modifichino, poiché tale processo si sottrae al nostro sapere, il quale abbraccia solo la conoscenza del fatto che tale partecipazione è la sola cosa in grado di render conto dell’esistenza del mondo empirico (e che la ragione può conoscere le idee). Un’altra questione non irrilevante lasciata in sospeso da Platone è perché il mondo delle idee "crei" questo mondo: ricorrendo ad un’immagine che sarà propria dei Neoplatonici, potremmo dire che è come se Dio, nella sua esuberanza di essere, traboccasse perché "diffuisivus sui", dandosi in maniera discendente, per cui il mondo è assolutamente inferiore rispetto alle idee. Nel mondo, dunque, non c’è nulla di veramente nuovo, l’unica relativa novità è che si tratta di un mondo deficiente rispetto a quello delle idee, che ne è modello. La conseguenza che ne deriva per quel che concerne la concezione della ragione è che conoscere empiricamente l’idea di cavallo significherebbe conoscere concretamente tutti i singoli cavalli esistiti nel presente, nel passato e nel futuro, senza trascurare alcun esemplare; e, del resto, noi possiamo predicare la cavallinità di questo o di quel cavallo empirico perché abbiamo già insita nella nostra testa, in qualche modo, l’idea di cavallo, alla quale raffrontiamo i cavalli sensibili quando diciamo che sono cavalli (riconoscendo in essi la cavallinità in noi presente a livello concettuale). Ciò significa che abbiamo già dentro la nostra mente, fin dalla nascita, l’idea di cavallo ed è in virtù di essa che possiamo riconoscere i singoli cavalli empirici dinanzi a cui ci troviamo: sono anzi tali cavalli sensibili a risvegliare in noi l’idea latente di cavallo. Si deve pertanto trattare, è evidente, di un’intuizione sovrasensibile, non ottenibile a posteriori, ma a priori, ossia è già sempre presente in noi, fin dalla nascita: come potremo allora dire che Tizio è più perfettamente uomo rispetto a Caio? Ciò avviene – risponde Platone – perché conosciamo il criterio, il modello, l’idea di uomo, con la quale confrontiamo Tizio e Caio, analizzando quale dei due meglio la imiti: in tale confronto si ha l’anamnesi, ovvero il ricordo di quell’idea di uomo già conosciuta (perché da sempre insita in noi) che ora, stimolata dall’esperienza sensibile (vedo Tizio e Caio) riaffiora alla memoria. Sicchè possiamo dire che la conoscenza sensibile è occasione perché nella ragione si sviluppi un’anamnesi che permetta di contemplare le idee: conoscere l’essere non sarà, quindi, un apprendere ex novo. Aristotele, dal canto suo, rifiuta la dottrina platonica delle idee, giudicandola una superflua complicazione il cui risultato è, tra l’altro, una ingenua svalutazione di questo mondo, che è secondo lo Stagirita l’unico e che per Platone era invece una pallida copia di quello iperuranico. Platone si avvaleva della dottrina delle idee, da lui elaborata, per una congerie di motivi, tra i quali merita di essere ricordato quello di sapore religioso: la dottrina delle idee permetteva al pensatore ateniese quell’anelito infinito verso l’assoluto che tanto gli stava a cuore, e l’intero suo sistema era pervaso da una profonda nostalgia per l’assoluto stesso, una nostalgia sconosciuta ad Aristotele; proprio tale nostalgia l’aveva indotto ad immaginare quello che Nietzsche definisce come il "retromondo" platonico, ossia quel mondo dietro il mondo che è l’Iperuranio. Questo mondo – dice Aristotele – si spiega benissimo da se stesso, senza far ricorso alle idee: le "forme", infatti, sono atti d’essere un certo qualcosa, è un certo esser qualcosa in atto che ha in se stesso, nel suo esser atto, il proprio principio e la propria ragion d’essere. Naturalmente, nessuno di questi atti sussiste, in questo mondo, perfettamente attuato: mentre Platone parla di perfezione come infinita pienezza d’essere qualcosa (le idee), Aristotele la intende invece come piena attuazione d’un finito atto d’esser qualcosa. Nessuno degli atti d’esser qualcosa è perfettamente attuato, però, e ciò avviene perché ciascuno è legato a una parziale porzione di materia; così ogni anima razionale e sensitiva è sempre congiunta ad un corpo che limita quell’anima facendone l’umanità relativamente attuata di Tizio, di Caio e di Sempronio; similmente, l’anima vegetativa è sempre unita ad una porzione di materia che ne fa quella certa pianta. La visione del mondo che ha Aristotele è quella di un mondo eterno che sussiste in forza dei suoi princìpi costitutivi – le forme e la materia (sempre unite): l’essenza di una cosa, allora, è l’atto di quel certo esser quella cosa che la fa essere quella che è, ma è più o meno attuata a seconda del corpo che la natura le ha assegnato. In Aristotele, dunque, le forme sono causa e fine di se stesse: causa in quanto sono ciò in virtù di cui gli enti esistono; fine nel senso che sono ciò a cui essi tendono, sono la tensione verso la propria attuazione, una tensione ostacolata dalla materia e che riesce nella misura in cui la resistenza da essa opposta viene superata. Così l’uomo è tanto più uomo quanto più è filosofo, ovvero quanto maggiormente esercita lo strumento di cui egli solo è equipaggiato: la ragione. Come è facile capire, nella prospettiva aristotelica non c’è alcun bisogno di rimandare ad un mondo ulteriore ed ultraterreno: basta e avanza il mondo terreno, un mondo increato, eterno, in cui Dio – pensiero che pensa se stesso – è una sorta di magnete che mette in moto ogni singolo ente che tenta di emularlo nella sua immobile perfezione. In quest’accezione, il senso della vita risiederà in questo, nella realizzazione – meglio o peggio riuscita – del proprio essere. Anche Aristotele ritiene di poter spiegare l’identità/differenza aggirata da Platone grazie al ricorso al fantomatico mondo delle idee: gli enti empirici sono le sostanze, unioni di forma e di materia, e a spiegare l’identità/differenza sarà il fatto che in ciascuna sostanza di una specie è presente virtualmente lo stesso identico atto d’esser uomo, virtualmente identico ma variamente attuato nella materia. Così tutti gli uomini sono identici perché dotati dell’anima razionale, ma sono diversi per via della materia, che li distingue gli uni dagli altri. L’universale sarà allora conoscibile per astrazione, ovvero astraendo dall’oggetto sensibile la forma, pervenendo, attraverso il particolare, all’universale (per induzione): così da una miriade di singoli uomini, operando un’astrazione, ricaverò la forma uomo, come forma presente "in re" in tutti gli uomini singoli. Ma l’induzione non è il solo ragionamento, altrimenti avrebbe ragione Platone ad ammettere il mondo delle idee quale modello da cui il nostro enigmaticamente deriva: secondo Aristotele, l’induzione comincia, sì, come ragionamento, che paragona e raffronta, ma poi cessa di essere tale e culmina in un’intuizione dell’essenza, un’intuizione che giunge alla definizione dell’essenza stessa attraverso un salto in qualche misura extra-razionale. La ragione, in questo senso, approda intuitivamente a due diversi ordini di verità: le definizioni (ossia la conoscenza degli universali) a cui si giunge per induzione, e i princìpi primi (principio di non contraddizione e derivati) a cui si perviene invece per intuizione, poiché essi appaiono immediatamente evidenti alla ragione in quanto tali. A questo punto, il sapere è puramente razionale e da induttivo diventa deduttivo, cioè trae le conseguenze dalle definizioni e dai princìpi deducendo sillogisticamente. Sicchè definire l’uomo come animale razionale comporterà conseguenze morali e politiche che la ragione coglie per deduzione: il punto di vista della ragione è altro rispetto a quello delle passioni, questo è il nucleo centrale cui pervengono – per vie diverse – Platone e Aristotele (nonché tutti gli altri pensatori); l’etica della metafisica classica greca può essere condensata, a tal proposito, in tre punti fondamentali: 1) l’alterità della ragione rispetto alle passioni; 2) la superiorità della ragione sulle passioni; 3) l’immancabile vittoria della ragione sulle passioni. La superiorità della ragione risiede nel fatto che, conoscendo essa l’essere e quindi il bene e, di conseguenza, il vero e il giusto, è in grado di confutare le passioni e gli pseudo-beni che esse propongono all’uomo. Conoscere l’essere di una cosa significa conoscerne la verità, ma anche conoscerne il bene, giacchè esso è l’affezione del suo essere, e il bene è anche la giustezza della cosa (infatti una cosa è giusta quando effettivamente è se stessa): giusto, per un ente, sarà tutto ciò che inerisce al suo essere, anzitutto il diritto di essere se stesso. E’ giusto che l’uomo, dotato di ragione (la quale è attitudine al comando), sia libero, ed è giusto che chi della ragione è privo non sia libero: è un buon esempio (anche se rischioso, per le conseguenze a cui può portare) di deduzione. La ragione ci indirizza al bene confutando le passioni e in ciò possiamo già leggere la sua immancabile vittoria su di esse; dove si attua la vittoria, là primeggia ciò che è superiore, al quale l’inferiore non può in alcun modo resistere. La ragione è il superiore e si sa come tale e, in virtù di ciò, sconfigge le passioni, che non possono distoglierla dalla sua strada allettandola coi loro pseudo-beni effimeri; essa è inattaccabile dalle passioni, poiché rivela come quelli da esse proposti non sono veri beni; in questo senso, la ragione è eterna confutazione delle passioni: chi ne è preda lo è o perché in lui la ragione dorme o perché del tutto privo di essa. Le passioni magari non saranno cieche, ma senz’altro sono assai miopi, soprattutto se confrontate con l’occhiuta ragione: esse non si accompagnano, in realtà, ad un’assenza assoluta di pensiero; pullulano quando però manca la retta ragione e dominano la fantasia e l’immaginazione, producenti immagini mentali (i fantasmata di Aristotele), ossia immagini a metà strada tra il pensiero e il sensibile. Infatti, una cosa è il concetto di uomo, altra cosa è l’immagine di uomo: nel secondo caso, ce lo si rappresenta in quel determinato modo perché lo si è effettivamente visto in carne ed ossa: le conclusioni che poggiano su tali immagini, nate dal sensibile, non possono che essere (al pari del sensibile) fluttuanti, ondeggianti, instabili: così dirò, padroneggiato dalle passioni, che "mi piace, lo voglio" o "non mi piace, lo fuggo". Si tratta, evidentemente, di un pensiero frutto delle inclinazioni sensibili, un pensiero configurantesi come elementare calcolo (cosa è che mi diletta di più?), dominato dalle passioni, strumento dell’appetito sensibile, gratificazioni empiriche mal fondate. Si tratta di pseudo-beni proposti come fini dell’ambizione, della volontà, del piacere: insomma, è un pensiero che finisce per opinare che il benessere fisico sia il bene supremo. Come possono, tuttavia, le passioni controbattere alle argomentazioni dispiegate dalla ragione scatenatasi contro di esse? Questa è appunto la loro insopperibile impotenza: non sanno argomentare. In secondo luogo, poi, l’intellettualismo greco (che abbiamo già visto in atto nella concezione dell’essere e del pensiero come fatti l’uno per l’altro) dà una clamorosa smentita delle passioni: la volontà è, per i Greci, una funzione della ragione, cosicchè è la stessa ragione che, conosciuto il vero e il bene, lo vuole a tutti i costi, senza soluzione di continuità. L’anima sensibile è, sotto questo profilo, conoscenza (perché sensazione e fantasia) e volontà (in quanto appetente), mentre l’anima razionale è conoscenza razionale e volizione razionale (cioè deliberativa): la ragione è sempre le due cose – pensiero e volontà – giacchè conosce il bene e, dopo di che, lo vuole adempiere a tutti i costi; si può a ragion veduta affermare che dove c’è la ragione c’è anche la volontà di raggiungere il bene conosciuto. Marsilio Ficino, in età umanistica, ha perfettamente colto quest’aspetto dell’intellettualismo greco: "come l’appetito irrazionale segue i sensi, così la volontà, che è avidità della ragione, segue ciò che l’intelletto conosce", altro non essendo la volontà se non "un’inclinazione della mente al bene". Del resto, la ragione è da sempre anche desiderio, desiderio di conoscere e di conseguire il bene che conosce, il che vuol dire che la volontà non è una dimensione ulteriore rispetto alla ragione: così Kierkegaard dirà che una cosa è sapere cosa sia il bene, un’altra volerlo. La ragione è, in questo senso, un Giano bifronte: nell’atto in cui conosce il bene, lo vuole; ed è per questo motivo che trionfa sulle passioni. Per il mondo greco, dunque, la volontà è, in certo senso, la ragione stessa in un’altra sua veste: ma, in età moderna, si opporranno a tale prospettiva Kant e molti altri, ad avviso dei quali la volontà è cosa diversa, e anzi opposta, alla ragione. Dove la ragione vige, essa è già sempre essa stessa oltre gli appetiti sensibili, risulta l’imprendibile per essi, il che è stato formulato brillantemente dal detto scolastico "voluntati naturale est quae bona iudicata sunt velle" ("per la volontà è naturale volere ciò ch’è stato giudicato buono"): ciò vuol dire che la volizione è il frutto necessario di una conclusione logica (con cui si individuano il bene e il giusto), sicchè nell’atto con cui conosce delibera coerentemente. La vittoria della ragione sulle passioni si configura in modi diversi in Platone e in Aristotele: in Platone, la ragione si separa dai sensi e dal sensibile diventando pura contemplatrice del mondo delle idee, a tal punto che l’anamnesi platonica è appunto quest’ascesa dell’io empirico spazio/temporale del filosofo al vero io che è la ragione eterna contemplatrice delle idee, di una dimensione divina (tema, questo, che verrà approfondito da Plotino e dai suoi seguaci, per i quali la ragione ridestata corre dall’empirico all’intelligibile). L’anima si fa secondo Platone mera anima razionale, e se la reminiscenza è recupero dell’io autentico, è allora evidente che l’anamnesi platonica ha una dimensione specificamente ontologica, cioè implica una trasmutazione ontologica del soggetto e non ha nulla a che fare con una presunta reminiscenza psicologica (come è invece quella ammessa da Proust). Tale ascesa platonica comporta, sul versante etico, una fuga (fugh dice Plotino) dai vizi dell’individualità empirica e sensibile, giacchè è un’evasione dal sensibile (pensiamo al mito platonico della caverna), è un andare oltre le deficienze dell’io empirico, che invece tenderebbe ad assolutizzare il livello sensibile. La virtù platonica per eccellenza sarà, in quest’ottica, la sapienza, poiché è conseguendo questa che l’io raggiunge la propria autenticità, rirecupera la "plenitudo essendi" della ragione contemplante e tale sapienza implica la giustizia e la capacità di esercitarla. Per Platone, dunque, la dimensione etica si configura nei termini di una vera conversione radicale (di metabolh si parla nella Repubblica) che presenta le caratteristiche di una fuga da questo mondo. Diversa è, invece, la posizione sostenuta da Aristotele, il quale – come sappiamo – tiene ben saldi i piedi per terra: anche quando è filosofo, l’uomo resta, secondo lo Stagirita, indissolubilmente legato al corpo e il conoscere stesso muove pur sempre dalla conoscenza sensibile (la quale non è pertanto un mero trampolino di lancio, come in Platone); ma anche per Aristotele la ragione, in ultima analisi, si colloca su un punto extra-razionale, puro e disinteressato, un livello di mera contemplazione delle forme che costituiscono l’in sé delle cose e, di conseguenza, l’ordine del cosmo, astraendo del tutto dal sensibile, ma non per questo distaccandosi dal corpo e dalle sue esigenze. Non potersi completamente distaccare dal corpo equivale a dire che si può filosofare solo ad intermittenza, ossia solo dopo aver soddisfatto i propri bisogni fisici, di fronte al cui ritornare bisognerà nuovamente sospendere l’attività filosofica per poterli soddisfare. E’ nell’ Etica nicomachea di Aristotele che troviamo, in nuce, l’etica del mondo classico: al cuore di questo scritto sta la distinzione tra "virtù etiche" (cioè pratiche) e "virtù dianoetiche" (cioè proprie della speculazione). Le virtù etiche sono degli atti della ragione, delle volizioni secondo ragione e questi atti – a furia di ripetersi – si consolidano, ma non in abitudini (ovvero in azioni di natura meccanica), bensì in abiti, che sono il frutto di successive e sempre rinnovantesi deliberazioni: il ripetersi di una deliberazione consolida la tendenza della ragione a comportarsi in un dato modo. La virtù, quindi, è quell’atto della ragione consolidatosi in abito, cioè nella disposizione ad agire secondo ragione: così la ragione subordina e limita le inclinazioni passionali che le si parano dinanzi. Temerità e viltà – dice Aristotele – sono due passioni contro ragione, mentre il coraggio è una forma di virtù razionale: ma chi è coraggioso? Colui che è permanentemente disposto ad osare o a temere secondo ragione, e questo può essere acquisito solo con la ripetizione dei singoli atti di coraggio che instaurano l’abito stesso del coraggio, atti che sono sempre consapevoli e razionalmente deliberati. La ragione, allora, modifica le passioni subordinandole a sé: gli impulsi a osare o a temere, se abbandonati a sé, si trasformano nelle mostruose passioni della temerità e della viltà, ma è la ragione a trasformarle in coraggio: non le elimina, ma le modifica, deliberando di avvalersene come essa stabilisce. In questa maniera, compio un atto coraggioso quando, di volta in volta, temo e oso secondo ragione: in presenza delle inclinazioni a osare o a temere, la ragione delibera di osare e di temere quando e quanto sente che è giusto e, così facendo, si esercita nel coraggio, trasformando le disposizioni passionali nel coraggio (che è appunto una virtù etica). In questo senso, da passioni subite diventano azioni deliberate, novità prodotte dalla ragione che doma e soggioga le aberranti passioni, impedendo che nasca la viltà e la temerità. Ben si capisce come per Aristotele (e in ciò concorda l’etica greca tutta) non sia la ragione ad essere al servizio delle passioni, ma viceversa: è essa a deliberare autonomamente il comportamento virtuoso a cui uniformarsi. Aristotele dice apertamente che la superiorità della ragione si manifesta nella suprema virtù etica: la giustizia. Essa è la virtù suprema perché ad essa sono subordinate le altre, che essa comprende ed organizza; è infatti solamente grazie alla giustizia che le altre virtù sono quello che sono. Esse, infatti, sono il giusto mezzo tra due inclinazioni opposte: così il coraggio è il giusto mezzo tra la viltà e la temerità, la liberalità è il giusto mezzo tra la prodigalità e l’avarizia. Ma Aristotele intende qui la giustizia sensu lato: ha infatti in mente la "giustizia politica" (o "universale"), quella cioè che ha per oggetto ciò che è giusto per natura e che costituisce il bene comune. La giustizia politica concerne l’universalmente e il naturalmente giusto, che altro non è se non l’universale ordine dell’essere, ovvero l’ordine del mondo e umano. E la giustizia è, appunto, quella virtù che è disposizione permanente a riconoscere, conservare, promuovere ed eventualmente restaurare tale ordine; ciò significa che un uomo è giusto nella misura in cui riconosce l’ordine, nel duplice senso che lo conosce (ragione speculativa) e lo promuove (ragione pratica), affinchè esso si preservi e prosperi e nel tutto sopravviva la parte, intesa come parte contestualizzata nel posto che le compete nell’economia del tutto. E l’uomo giusto si deve adoperare anche attraverso giuste limitazioni e rinunce, anche attraverso la rinuncia a volere tutto e immediatamente. Allora potremo dire che giustizia è favorire e promuovere il tutto, il giusto ordine delle cose: ma tale ordine va anzitutto conosciuto ed è conoscibile solo da una ragione che prescinda dai punti di vista particolari e che sia collocata da un punto di vista universale, come disinteressata contemplatrice della verità delle cose, verità che coincide con la giustezza stessa delle cose (esse sono giuste nella misura in cui sono se stesse). Ma questo è il sapere metafisico, possibile solamente in quanto sviluppantesi da un punto di vista universale e disinteressato: tale giustizia coincide col bene comune, dove ciascuna cosa attua coerentemente il proprio essere. E questo bene comune è naturale, tutt’uno con la natura delle cose, altro non essendo questa se non la loro essenzialità. Si tratta, dunque, di un bene colto da una ragione attenta, giacchè in grado di trascendere quello che Machiavelli chiama "il particulare". Soltanto chi ha una simile visione del giusto ordine potrà sempre sapere come agire giustamente, sarà ad esempio in grado di agire quando è giusto e con il giusto coraggio, evitando oculatamente sia la viltà sia la temerarietà. Solo chi ha una simile visione e agisce sempre di nuovo deliberando acquista l’abito della giustizia, virtù delle virtù. Egli sarà giusto in tutto ciò che fa, e sarà colui che realizza pienamente se stesso, attuando in pieno la propria razionalità di uomo, ossia la propria struttura metafisico-etico-politica; sa, conosce e agisce di conseguenza all’interno della poliV, in cui si trova a posto con se stesso perché è al suo giusto posto. Vive interamente secondo ragione, conosce la giustizia ed è ad essa che mira (nella duplice accezione che la contempla e ad essa aspira), esercita la "giustizia distributiva", consistente nel dare a ciascuno il suo ("dare cuique suum"), ossia recapitandogli ciò che naturalmente gli spetta. Ma il vero filosofo – oltrechè col dare a ciascuno il suo – esercita la giustizia anche correggendo le disuguaglianze, ripristinando la giustizia venuta meno: in questo modo, egli esercita la "giustizia correttiva" (o "commutativa"). E’ facile capire come, nella prospettiva aristotelica, sapienza e giustizia siano le due facce della stessa medaglia, poiché il sapiente è il giusto e il giusto è il sapiente, in cui la retta ragione non incontra ostacoli nel suo dispiegarsi. In questo senso, si può dire che le virtù sono attitudini prodotte dalla ragione e, perciò, inesistenti prima di essa: se le passioni sono subite, le virtù sono attivamente agite (in quanto deliberate). Questo vale per quel che riguarda le virtù: ma Aristotele si riferisce spesso anche alla virtù in senso lato, come atto della mente umana; egli dice che la ragione conoscente e agente, se funziona correttamente, realizza le sue possibilità ed è in ciò che consiste l’areth, il perfetto compimento della natura umana, compimento che corrisponde del resto alla felicità. Sicchè l’uomo potrà dirsi felice quando e nella misura in cui si sente realizzato, e per realizzarsi dovrà attuare metafisicamente la propria natura, esercitando quell’elemento che più di ogni altro lo rende uomo: la ragione. Non è, dunque, il lavoro a realizzare l’uomo, come credeva Anassagora e come crederà Marx, bensì il pensiero. Tale areth è realizzabile entro i confini della poliV (perciò è politica), è la condizione del sussistere del soggetto umano, il quale – se vivesse al di fuori della città e, quindi, isolato – non sarebbe altro che una bestia. Anche l’esercizio della ragione si realizza al meglio nella vita di relazione, solo in tale contesto è dato praticare le virtù etiche: è solo nella poliV, infatti, che si realizza la vera filosofia platonicamente intesa in forma dialogica, come scambio reciproco di idee che si attua nella relazione interpersonale. Ed è solo nella poliV che può svilupparsi l’amicizia, da Aristotele distinta in amicizia fondata sui bisogni (un’amicizia di mutuo soccorso, che nasce dalla necessità di soddisfare reciproche esigenze) ed amicizia disinteressata (solo questa autentica e duratura, poggiante sulla reciproca attuazione della propria razionalità). L’animale razionale è, secondo lo Stagirita, tale in quanto è animale politico, cosicchè la poliV può essere etichettata come naturale approdo della ragione umana. Questo significa che il consenso politico è quello naturale e implicito di tutti gli uomini, dei veri uomini liberi, ossia di tutte le rette ragioni, è – in altri termini – il consenso a cui naturalmente la ragione perviene. Allora alla base dello Stato non vi è il patto sociale, cioè l’opzione soggettiva di una molteplicità di individui che si accordano a tavolino e convengono su cosa è il bene comune, ma, al contrario, c’è l’esigenza oggettiva dell’universale natura umana, ossia dell’uomo concepito come animale razionale/politico. Dove c’è una molteplicità di individui dotati di retta ragione, lì si produce lo Stato, come insieme spontaneo di individui governati dalla loro ragione. Naturalmente, in una concezione del genere pare serpeggiare un esasperato ottimismo antropologico, che sarà deriso dagli uomini rinascimentali. Tuttavia, onde evitare di scivolare in facili fraintendimenti, è bene domandarsi cosa dobbiamo intendere per "uomo" quando sentiamo Platone e Aristotele parlarne: chi è uomo? Chi ha la ragione e la esercita rettamente, cosicchè uomini in senso pieno sono i soli filosofi, ossia una esigua minoranza. L’ottimismo di partenza già scricchiola. La posizione stoica, poi, pare sotto questo profilo significativa: gli Stoici, infatti, dicono che il vero saggio (l’unico essere degno di essere detto "uomo") non è mai esistito né mai esisterà, sicchè di uomo non ce n’è mai stato (né mai ce ne sarà) neanche uno. Senza arrivare agli estremismi stoici, ma restando a Platone e ad Aristotele, all’ambito dell’umano vengono da loro sottratti molti individui che noi, abitualmente, riteniamo uomini in senso pieno: così già Platone – nella Repubblica – nota come gli esseri umani siano stati plasmati con tre diversi metalli, con la conseguenza che ci sono uomini superiori e uomini inferiori dalla nascita, senza possibilità di cambiare status; l’educazione stessa, più che trasformare l’essenza di ciascuno, porta a svilupparsi ciò che ciascuno è potenzialmente fin dalla nascita. La posizione di Aristotele è più drastica: a suo avviso, non sono propriamente esseri umani tutti coloro che non possono esercitare rettamente la ragione: restano così esclusi dalla cittadinanza umana schiavi, ragazzi e donne. Solo i Sofisti – gli illuministi del mondo greco – avevano affermato a gran voce che la schiavitù esiste solo convenzionalmente e che, alla nascita, gli uomini sono tutti uguali: tesi, questa, abbracciata, seppur con sfumature diverse e piuttosto variegate, da Ippia, Antifonte e Alcidamante. Già Platone, invece, sosteneva che solo i Barbari potevano essere fatti schiavi, mentre ciò era impossibile con individui di origine greca. Ma è legittimo domandarsi quale sia la differenza (ammesso che ci sia) tra uomini liberi e schiavi: Platone la individua nel fatto che gli schiavi sono sprovvisti di logoV e dotati esclusivamente della doxa, possono cioè opinare senza però formulare ragionamenti, con la conseguenza che lo schiavo è un mero esecutore incapace di autodeterminarsi e in tutto e per tutto dipendente dal padrone. Questa distinzione la troviamo in Aristotele (Politica, I 13), il quale opera una diversificazione tra individui dotati di ragione (e perciò capaci di pensare e di prevedere) ed individui sprovvisti di essa e tenuti solo a faticare col proprio corpo; questi ultimi sono puri e semplici strumenti nelle mani del padrone, alla pari del bue e dell’aratro. "Differiscono quanto alle capacità di deliberare derivata dalla riflessione razionale: tutti hanno le parti dell’anima, ma in maniera diversa. Lo schiavo non possiede in tutta la sua pienezza la parte deliberativa; la donna la possiede ma senza autorità; il ragazzo la possiede ma non ancora sviluppata". E – aggiunge Aristotele – si è degni di stare dentro o fuori le mura della poliV a seconda che si possegga o meno il boulhtikon, la capacità di deliberare. Lo schiavo può apprendere la ragione dal padrone, poiché la sua è una razionalità riflessa, che imita ed emula quella del padrone appunto. La donna, invece, la possiede ma senza autorità: ella ragiona poco, non al punto da persuadere, cosicchè, quando si trova a discutere col filosofo, ella si trova costantemente in uno stato di minoranza. Solo il maschio adulto (e per questo il ragazzo risulta escluso) ha piene facoltà razionali: esso solo è uomo nel vero senso della parola (animale razionale e politico). E non è un caso che lo Stagirita distingua l’adrapodon (l’essere dai piedi umani) dal tetrapodon (l’essere a quattro zampe, ovvero la fiera), identificando il primo con l’uomo, il secondo con lo schiavo. Secondo Aristotele, la schiavitù è giusnaturalisticamente costituita, giacchè esistono esseri dotati di ragione e per questo destinati al comando, ed esseri che sembrano essere uomini ma che in realtà non lo sono e, in virtù di ciò, mancano degli stessi diritti del cittadino, il quale è secondo lo Stagirita un greco, maschio, adulto, ozioso, urbano e libero, cosicchè – contrariamente alle tesi sofistiche – la schiavitù è naturale e legittima. Altra cosa, invece, sono gli schiavi per legge, ossia quegli uomini che perdono in guerra, poiché vinti, la loro libertà: una schiavitù di questo tipo è giusta solamente se i vinti fatti schiavi sono tali già per natura, altrimenti, se ci troviamo dinanzi a uomini un tempo liberi e ora privati della loro libertà e ridotti in catene, trattasi di una schiavitù illegittima. A corollario di quanto detto, ricordiamo la dottrina aristotelica del dispotismo e la distinzione ch’egli opera con la tirannia: il despota è per natura il padrone della casa (oikoV), e il dispotismo da lui esercitato è il potere arbitrario del padrone sugli schiavi e su quanti (donne e bambini) non sono propriamente uomini, sebbene Aristotele si renda perfettamente conto che la relazione intrattenuta dal "pater familias"/despota con la moglie non si configuri come un dispotismo, ed è per questo che lo Stagirita tende a parlare di un’aristocrazia all’interno della casa, dove a governare sono il marito e la moglie congiuntamente; in questo modo, viene reintrodotto il potere femminile, precedente negato. In sostanza, il dispotismo è il legittimo rapporto di potere che si instaura tra chi possiede il bouleutikon e chi ne è sprovvisto, un rapporto che è esercitato non nei confronti di cittadini, ma verso strumenti quali sono per Aristotele lo schiavo e il bambino. Al contrario, la tirannia è un sopruso esercitato nei confronti dei cittadini e per questo motivo è del tutto illegittimo, e reso ulteriormente illegittimo dal fatto che se il despota è il cittadino razionale e virtuoso per eccellenza, il tiranno invece è colui che meno possiede la ragione, e che anzi è preda delle proprie passioni, sicchè l’illegittimità del suo potere è fondata dal suo padroneggiare sui cittadini e sulla tipica incapacità di comandare propria di chi è in balia delle nocive passioni. In questi termini, il dispiegato ottimismo del popolo greco trova una sua clamorosa smentita: l’uomo, che così spesso troviamo tratteggiato nelle pagine dei filosofi, è in realtà un personaggio meno frequente del previsto, anche se non è mai possibile fugare completamente l’ambiguità di fondo, quell’ambiguità che ci assale puntualmente ogni qual volta ci imbattiamo nel termine "uomo", così ricorrente negli scritti di Platone e di Aristotele. Alla diffusione di tale ambiguità ha contribuito il massimo divulgatore del pensiero greco, Marco Tullio Cicerone, troppo spesso presentato semplicemente come un avvocato capzioso e verboso, e non come una delle più lucide menti filosofiche dell’antichità, quale effettivamente fu. Il suo De officiis è la quint’essenza dell’etica antica: vi troviamo un costante elogio reiterato dell’uomo raziocinante, virtuoso, instancabile cultore del bene, interamente dedito all’esercizio della ragione, e, presi dal magnifico periodare ciceroniano, finiamo per dimenticare che quello da lui descritto è un animale rarissimo, quasi inesistente.
IL MEDIOEVO
Tentata un’ardita sintesi, proveremo ora a delineare succintamente il mutamento intervenuto in ambito filosofico grazie al cristianesimo, tra il VI e il XII secolo d.C. La grande e fondamentale novità che l’avvento del cristianesimo ha introdotto è il ridimensionamento netto della ragione antica, la cui celebrazione greca deve fare ora i conti con l’instaurarsi del principio di autorità e con il dogma della destinazione divina dell’uomo, nonché della beatitudine eterna e, ad essa correlato, il peccato originale. Nel mondo antico, la ragione era la sola, suprema autorità, a tal punto che si potrebbe parlare di sovranità della ragione: nessuna autorità le contendeva il primato di autorevolezza teorica ed etica, il saper dire "che cosa fare" e "come agire". Un tale agonismo tra la ragione e un’autorità da essa distinta interviene con il cristianesimo, che ha caratteristiche diversissime dalla religione degli antichi Greci e che lo conducono inevitabilmente ad un conflitto con la ragione, una belligeranza lunghissima e dapprima risolta (in età medioevale) con la subordinazione totale della ragione alla Rivelazione; tale subordinazione si attua in due momenti distinti: in un primo momento, nella fase patristica; in un secondo, in quella scolastica. Il momento patristico (che si protrae fino al XII secolo) ha la sua sistemazione in Agostino di Ippona e informa di sé la cultura teologica e monastica che domina fino al XII secolo a.C, quando subentreranno novità che porteranno ad una riformulazione – la "scolastica" – del rapporto intercorrente tra rivelazione e ragione, soprattutto grazie all’opera di Tommaso d’Aquino. Grazie all’Aquinate, verrà restituito, almeno parzialmente, alla ragione qualcuno dei diritti di cui era stata spogliata dalla patristica. Ma – chiediamoci – perché la religione antica non si era opposta alla ragione (come invece accade in età cristiana)? Le fonti su cui poggiava la religione antica, in special modo quella greca, erano due: la mitologia e gli oracoli, e, per di più, la mitologia di marca greco/romana non si configura come una rivelazione divina, ma come un’affabulazione umana, come interpretazione del mondo, e ne sono portavoce i poeti (Omero ed Esiodo), i quali scoprono, immaginano e inventano gli dei, le loro reciproche relazioni e quelle con gli uomini; si tratta, dunque, di un’affabulazione anteriore e parallela rispetto alla riflessione razionale, ma – al pari di questa – è pur sempre umana e, perciò, risolvibile nella speculazione filosofica, secondo un passaggio dal muqoV al logoV, passaggio che si concretizza nella cultura antica, quando cioè i filosofi hanno fatto propri i miti e ne hanno dato formulazioni razionali. Così hanno agito Platone, gli Stoici e i Neoplatonici, rielaborando in chiave razionale i miti; anche Epicurei e Scettici si sono mossi in un contesto non del tutto differente, demistificando la mitologia come cumulo immane di fandonie liquidate dalla ragione: da tutto ciò si evince come, nel mondo antico, ragione e mitologia non siano mai, propriamente, entrati in conflitto. Sull’altro versante, l’oracolo è parola divina comunicata agli uomini in luoghi precisi (i templi) attraverso una persona consacrata alla divinità venerata in quel determinato luogo: un tale verbo divino ha, tendenzialmente, contenuto di pronostici, di oroscopi, di divinazioni, ed è rivolto ai singoli che di volta in volta interrogano l’oracolo. Ciò segnala che alla religione antica ineriva una funzione eminentemente profetica, e il profetismo era risolto in una precisa casistica, il Dio si esprimeva attraverso il medium umano (la Pizia, la Sibilla, ecc), che rispondeva di volta in volta a puntuali e circoscritte domande, quali "che cosa fare nei momenti di ansia e di paura?" Le risposte, quindi, erano altrettanto puntuali rispetto alle domande, cosicchè la parola oracolare del Dio non si organizza mai in un configurarsi di rivelazioni, ossia in una visione complessiva, totalizzante e veritiera del reale; al contrario, il verbo divino non concerne la verità, e d’altro canto quando tende ad articolarsi in verità si presenta sempre come affabulazione poetica, che può essere rielaborata dai filosofi. Non è un caso che, in tale prospettiva, agli antichi greci fosse sconosciuta una Bibbia rivelante la verità, una Chiesa intorno alla quale raccogliersi, poiché questa si costituisce solamente in seguito ad una rivelazione, di cui è l’unica autentica interprete. Non sussiste nel mondo antico alcun problema di fede e ragione come due possibili e diversi accessi alla verità: il problema, invece, si pone con le "religioni del libro", con il cristianesimo, l’ebraismo e l’islamismo, dove ci si imbatte in una rivelazione divina che si scontra con la ragione, ai cui occhi tale rivelazione appare come una folle stranezza, in quanto non solo predica cose nuove e non pronunciate dalla ragione, ma addirittura incomprensibili e opposte alla ragione stessa e ai suoi dettami (tale è il caso della Trinità, che si oppone al principio di identità). E per di più tali stranezza vengono dalla Rivelazione sentenziate con una veste di autorità sovrannaturale, come verbo divino. Con il mondo cristiano, ci si trova dinanzi a due distinti fonti della Verità immediatamente contrastanti e guerreggianti, cosicchè diventa inevitabile interrogarsi sul loro rapporto: per i non cristiani, la Rivelazione è mera invenzione umana e, come tale, viene prontamente liquidata. Ma, con l’erezione del cristianesimo a religione dell’impero avvenuta sotto Costantino, si ha l’insediamento del principio di autorità, e questo perché la natura divina della Rivelazione del libro è imposta e riconosciuta dal potere politico, spesso – se necessario – con la forza. In quanto parola divina, essa è l’assoluta verità cui la ragione umana è chiamata a sottomettersi, con la conseguenza che la "pagina sacra" e la dottrina che i suoi legittimati interpreti ne traggono è la Verità stessa, cui deve piegarsi ogni pretesa verità puramente umana. Ne sorge una società in cui la cultura non potrà essere se non cultura del "Libro sacro", cultura cioè di un solo libro, e configurantesi precipuamente come sua lettura e, rispetto a ciò che il testo detta, l’atteggiamento della ragione non potrà che essere ricettivo e strumentale, un passivo ascolto e una mera fornitura dei mezzi volti alla comprensione quel dettato dell’auctoritas: ed è appunto questo che si compie nei monasteri fino al secolo XI (lectio divina). Ma, accanto alla novità dell’autorità, è introdotta l’innovazione della mutata immagine dell’uomo: creato da Dio e destinato a godere di beatitudine eterna, anche se parzialmente compromessa dal peccato originale, ma recuperabile col soccorso della grazia divina, l’uomo non può contare soltanto sulla propria ragione. L’obiettivo centrale e imprescindibile della vita umana diviene lo sforzo di meritarsi la beatitudine eterna e, dunque, il tentativo di conseguire con le buone opere la giustizia divina occorrente per acquisire tale beatitudine, una giustizia che è però radicalmente diversa da ogni altra. Si tratta tuttavia di un obiettivo irraggiungibile in questa vita, stante quel peccato originale che ha corrotto la ragione e ha tarpato le ali alla volontà di ottenere la beatitudine; è però in virtù della Grazia che tale impegno viene finalmente premiato, e la vita acquista senso in riferimento al suo tendere alla santità. L’uomo che si sforzi di vivere rettamente (secondo la legge divina, non quella umana) è destinato allo scacco qualora pretenda di raggiungere tale fine esclusivamente con le sue forze, poiché – come nota Agostino – si trova ineluttabilmente vinto dal peccato se non fa riferimento alla Grazia divina liberatrice. In quest’ottica, le morali elaborate dagli antichi sbagliano nel proporre fini puramente umani e terreni, che alla luce della Grazia si rivelano come illusori ed effimeri, lungi dall’autentico Bene. E il raggiungimento di quel bene terreno e umano – vuoi l’areth aristotelica, vuoi l’ascesa razionale platonica – richiede l’esercizio di virtù che sono tali solo per chi ignora la natura di Dio e dell’Amore (agaph) che Egli pretende dalle sue creature, quell’amore disinteressato per il prossimo che è sconosciuto all’etica antica; il falso eudaimonismo dei Greci poggia, secondo i cristiani, sull’ignoranza di quale sia la natura divina, giacchè tutto ciò che concerne la relazione intercorrente tra uomo e Dio (e dunque la Grazia, il peccato originale, la perfezione dell’Amore, ecc) esula dalle capacità conoscitive della ragione resa incapace dal peccato originale. Allora la relazione con questo Dio rivelatosi diventa l’essenziale, e così l’uomo in quanto ragione mira a conoscerLo e in quanto volontà tesa a compiere quella divina è rimandato continuamente a tale Rivelazione, alla quale deve in tutto e per tutto sottomettersi, piegandosi anche alla Grazia che si sviluppa in un nuovo agire reso possibile dal concorrere della Rivelazione e dalla Grazia: è, questo, l’unico vero sapere e l’unico vero agire, l’unico a contare davvero per la salvezza, frutto della Grazia agente sulla ragione e sulla volontà, secondo quanto stabilito da Dio. Con la "patristica" assistiamo ad una radicale delegittimazione di ogni punto di vista che non sia quello imposto dalla fede, e pertanto il sapere viene concepito e praticato unicamente come teologia, ovvero come LogoV intorno a QeoV, come scienza di Dio: si tratta di un genitivo sia soggettivo sia oggettivo, in quanto Dio è l’oggetto di tale scienza, ma è al contempo Dio stesso il soggetto che sa, è la Grazia divina che con la Rivelazione informa il fedele circa Dio. La delegittimazione di ogni altro sapere finisce per investire anche la filosofia e viene scandita secondo due modalità: in primo luogo, il filosofare umano è congedato come errore frutto dell’ignoranza di che cosa sia la natura divina; in secondo luogo, qualora non venga così brutalmente messo alla porta, viene etichettato come una vana curiosità intorno a cose di poco conto se raffrontate all’unica cosa che davvero conta: la salvezza umana; tutto ciò che non ha ad essa attinenza è vana curiositas e, come tale, va rigettato, si abbandona il sapere umano e si abbraccia la fede, viatico alla beatitudine eterna, una fede che è un assenso e una fiducia in ciò che viene rivelato, ma è altresì notizia di ciò che è rivelato, ossia è nozione di ciò in cui si ripone la fiducia. La fede, pertanto, incrementando questa sua spinta conoscitiva, si sviluppa in intelligenza di sé e dà così vita ad un sapere in cui è al contempo oggetto e soggetto; tale sapere è intellectus fidei, l’intellezione della fede, l’intellezione che ha ciò in cui crede. Agostino dice che vi è un primo momento di "fede semplice", e un secondo in cui si è fatta intellectus fidei. Nello stato di fede semplice, la ragione aderisce strettamente alla parola scritturale, la tiene per vera e si riduce ad essa, si ha cioè una ragione come mera ricezione del Verbo. In un secondo momento, in forza dell’illuminazione proveniente da quella parola, l’intelletto muove dalla parola mirando ad una più ampia comprensione della parola stessa e, quindi, dirigendosi ad essa: la parola è principio della fede, e la fede illuminata tende ad una più profonda comprensione della parola. Sempre muovendosi entro l’orizzonte della parola, la fede da semplice diventa teologia, anche se tale passaggio non si verifica in tutti i fedeli (nella stragrande maggioranza resta fede semplice), ma solo in pochi eletti. Agostino nota come nello sforzo di articolazione della fede da semplice a complessa, accada al teologo di ricorrere alle dottrine di alcuni filosofi che lo hanno preceduto e che lo sorprendono per la loro straordinaria somiglianza con quel che la Rivelazione dice: tali sono, secondo Agostino, i Platonici e i Neoplatonici. Ma non per questo il teologo abbandona i suoi panni per indossare il mantello del filosofo: non si rinuncia al proprio punto di vista, poiché le dottrine filosofiche accostabili a quelle dettate dalla Rivelazione altro non sono se non un plagio o il frutto di una Rivelazione parallela; Platone stesso non è altro che un "Mosè atticizzato". Come Mosè ha ricondotto il popolo dall’Egitto alla terra promessa, così Platone ha fatto il suo viaggio in Egitto e ha trovato le tracce della Rivelazione ebraica e se ne è impadronito per riformularle come propria filosofia. Ne deriva che il platonismo è un plagio. La seconda teoria (formulata da Clemente Alessandrino) è quella della "Rivelazione parallela": stando ad essa, bisogna riconoscere che se ci sono (e, di fatto, ci sono) analogie tra alcune ragioni cristiane e alcune filosofiche, ciò dipende dal fatto che, accanto alla Rivelazione vera e propria, Dio ne ha prodotta un’altra – in senso lato -, ed essa corrisponde ad un certo filone della filosofia greca; e del resto la ragione di cui si son serviti nel loro incedere i filosofi antichi non è forse anch’essa il frutto della creazione divina? Sicchè il teologo che si impadronisce di certe dottrine filosofiche non fa altro che recuperare ciò che per natura è suo, formula cioè la stessa verità nello stesso modo in cui l’avrebbe prima o poi formulata, anche senza incontrare quelle dottrine filosofiche, poiché si tratta della medesima fonte di Verità. Fino a Bonaventura (XIII secolo d.C.), passando per Bernardo di Chiaravalle, domina questa prospettiva teologica che vuole la ragione interamente guidata dalla fede, e ciò non solo in sede teoretica, ma anche in campo etico, dove le improbabili virtù della sola ragione vengono surclassate dallo sforzo verso la santità supportato dalla Grazia, con la conseguenza che il vero comportamento è quello del monaco asceta e della sua assidua lotta contro il peccato, ch’egli conduce vivendo fino in fondo, nel suo cuore, la distinzione – soprattutto agostiniana – tra città divina e città terrena. Quando alla sovranità della ragione socraticamente intesa come curiosa di tutto si sostituisce l’autorità di un solo punto di vista imposto dalla fede, sovrarazionale e perciò inattaccabile dalla ragione, il dialogo cede il passo al monologo, la cultura da vivace che era diventa statica e stagnante, con un unico orizzonte entro il quale la ragione è mero strumento passivo, illuminato dalla Grazia: non vi è altro da sapere se non la vita eterna che si vivrà, e il nostro mondo perde in tal modo di rilevanza, quasi diventa favola, il monaco il monastero assurgono a simboli di una fuga dal mondo e dalla vita terrena, con l’apparentemente irrisolvibile paradosso che in quei monasteri in cui ci si vuole sottrarre dal mondo e dall’esercizio della ragione abbondano i copisti, che – attraverso il loro strenuo lavoro di copiaggio – trasmettono ai posteri un sapere puramente umano. In realtà, è un paradosso solo apparente, giacchè tali copisti, che ricopiavano per intero le opere dei grandi filosofi dell’antichità, facevano ciò solo per penitenza, per guadagnarsi il paradiso, senza nemmeno leggere quel che copiavano (sarà poi il mondo umanista che tornerà a leggere con rinnovato interesse i testi tramandatici dall’antichità). In tutte queste componenti del mondo medievale troviamo conferma della tremenda depressione culturale in cui è immersa quest’epoca: ma, a partire dalla metà del XII secolo d.C., si assiste al ritorno di Aristotele e del suo bagaglio di scritti, che irrompono portati dagli Arabi (soprattutto Avicenna e Averroè), e l’ingresso dello Stagirita in Occidente è uno shock culturale, in quanto ci si ritrova dinanzi ad una sistematica visione del mondo (precisamente: di questo mondo) che è così articolata, complessa e diffusamente argomentata – e perciò istruttiva – che non sembra più possibile sbarazzarsene come di un blocco fatto passare per menzogna o vana curiosità. E’ un sapere così autonomo che non sembra neppure possibile farlo rientrare in qualche modo nell’alveo della Rivelazione, poiché si tratta di un sapere improntato sull’esercizio non della fede, ma della ragione: con Aristotele, torna in Occidente – con rinnovato vigore – il sapere filosofico, dopo un esilio durato qualche secolo, con un effetto assolutamente dirompente, dal momento che costringe i teologi ad ammettere una forma di sapere altrettanto legittima rispetto alla loro, e li induce ad elaborare una nuova teologia che tenga conto di questa realtà poggiante su di un positivo sapere umano impostosi inconfutabilmente. Così, Bonaventura avrebbe preferito che Aristotele non fosse mai "risorto", ma, di fronte al monumentale corpus aristotelico, non può non riconoscergli lo statuto di un sapere razionale valido, diverso sì da quello del teologo, ma non per questo da rigettarsi. Per questa via, la filosofia (opus rationis) e la teologia (intellectus fidei) si configurano come due ordini distinti, caratterizzati ciascuno da un proprio statuto, cosicchè alla teologia si impone di trasformarsi per poter intrattenere con la risorta filosofia un rapporto che le consenta di esserle superiore: prima che Aristotele facesse irruzione nell’Occidente medievale, la superiorità della teologia era scontata e aproblematica; ora, invece, la si deve riformare per far sì ch’essa sia in contatto con la ragione filosofica, ma restando ad essa superiore. Ed è in questa prospettiva che si orienta Tommaso, il quale fa nascere la teologia scolastica, ribadendo l’egemonia della teologia, pur non respingendo la ragione. Compie questo in due mosse congiunte: fa all’interno dell’economia della salvezza maggior spazio al puramente umano di quanto non venisse ad esso riservato dalla tradizione agostiniana. Prima del ritorno in Occidente di Aristotele, la ragione era del tutto appiattita sulla fede ("intellectus fidei") e il sapere era meramente teologico: la ragione poteva sì conoscere qualcosa, ma unicamente in forza dell’illuminazione della Rivelazione. Con l’irruzione di Aristotele, anche i teologi più renitenti (quale fu Bonaventura) sono ora costretti a riconoscere, accanto a quello teologico, un sapere filosofico non scevro di una sua dignità, e il teologo deve quindi riaffermare la supremazia della teologia sulla filosofia, senza potersi sbarazzare tout court di quest’ultima: Tommaso non si esime da questo compito strategico con – come abbiamo già detto – una duplice mossa. Viene dall’Aquinate aperto maggior spazio di quanto non ne venisse lasciato da Agostino alla capacità razionale e alla volontà dell’uomo, poiché, se per Agostino il peccato originale ha fatto tabula rasa demandando l’uomo all’intervento salvifico della Grazia, secondo Tommaso tale peccato ha solo tangenzialmente ferito la natura umana, l’ha vulnerata di ferite non tali da impedire all’uomo l’esercizio delle sue naturali facoltà, ed è così (equipaggiato di efficaci doti conoscitive) che lo descrive Aristotele e, sulle sue orme, Tommaso. La ragione crea proficui processi argomentativi, ma risulta altresì in grado di innalzarsi, elaborando una teologia naturale (meramente razionale), ossia una vera – seppur parziale – conoscenza di Dio, razionalmente inteso come principio del mondo. Ed è a questo punto che subentra la seconda mossa di Tommaso: non solo il retto uso della ragione è possibile e dà buoni risultati, ma è il solo che, producendo una veritiera conoscenza del mondo e di Dio, non solo non è contrario alla fede, ma anzi prelude e introduce ad essa. Sicchè il percorso razionale è meritorio e degno d’esser praticato, e questo perché i due ordini (della ragione e della fede) provengono dallo stesso ed unico Dio, cosicchè la retta ragione non può contraddire la fede: la verità della fede e quella della ragione non si elidono vicendevolmente. Ciò vuol dire che una filosofia contraria alla fede è un errore della ragione che la ragione stessa è in grado di individuare e di correggere: la filosofia corretta è l’aristotelismo che culmina nella teologia razionale tomistica, quel tale aristotelismo sviluppato appunto da Tommaso nei suoi scritti; devono invece essere rigettate come errate tutte quelle interpretazioni dell’aristotelismo che hanno esiti diversi, prima fra tutte quella espressa da Averroè (contro i cui seguaci l’Aquinate si schiera soprattutto nel De unitate intellectus contra Averroistas), la cui rielaborazione dell’aristotelismo finiva per predicare l’eternità del mondo. La sola ragione può qualcosa da sé, se correttamente esercitata, e configura il filosofare come introduzione alla fede, giacchè un tal corretto filosofeggiare culmina naturalmente nella conoscenza di Dio. Ma la filosofia non si riduce a questo: il suo esercizio prosegue dopo l’incontro della ragione con la Rivelazione, la quale non fa altro che potenziarla; illuminata, la ragione è ora in grado di dare alla fede l’intelligenza di sé e la propria comprensione, cui è la fede stessa ad aspirare. Ne nasce il sapere teologico propriamente detto, sicchè il teologo è colui che anticipa la beatitudine conoscitiva propria degli eletti. In questo modo Tommaso, nell’atto stesso in cui riconosce la bontà e la legittimità del filosofare (se direzionato dalla fede), pone la filosofia sotto la tutela della teologia, ribadendo così l’incontrastata preminenza di quest’ultima. E’ sì legittimo filosofeggiare, ma tale attività – se corretta – è preludio alla fede: la filosofia è in tal modo ridotta al rango di ancilla theologiae. Non vi è contraddizione e neanche soluzione di continuità, giacchè il sapere filosofico si prolunga nella teologia positiva, cosicchè si tratta di un unico sapere frutto dapprima della sola ragione, poi anche della fede, il tutto sotto l’egida della Rivelazione e della fede stessa, il cui primato è costantemente messo in evidenza. Da una parte c’è la ragione senza fede ed è preambolo alla fede, ossia le cammina davanti; e, successivamente, abbiamo il sapere ottenuto dalla ragione congiunta alla fede, ci troviamo cioè di fronte all’inveramento di quel preambolo costituito dal solo procedere della ragione. Tra le due – ragione e fede – vige una nuova relazione anche sul versante etico/pratico: la stessa continuità che sussiste sul piano teoretico (culminante in teologia rivelata) regna anche sul piano pratico tra etica filosofica ed etica rivelata. A tal proposito, Tommaso parla di lex divina, di lex naturalis e di lex humana: quella divina è rivelata da Dio nella Scrittura, quella naturale è scoperta dall’investigare della ragione ed è anch’essa di natura divina, poiché insita nelle cose prodotte dal Creatore; infine, quella umana è deliberata e messa in atto dall’uomo, legittima solo in quanto derivata da quella naturale. In quanto dotato di ragione, l’uomo conosce la legge naturale, il cui nocciolo – apparentemente tautologico – è così esprimibile: fai il bene ed evita il male. Ora, il bene a cui fa qui riferimento Tommaso è il bene a noi noto nel significato aristotelico e colto, appunto, dalla ragione: si tratta, cioè, del bene come piena attuazione dell’essere proprio di ogni ente; tale processo si scandisce in fasi diverse: la conservazione di sé, la procreazione, la crescita della prole, la vita in società, la conoscenza della verità, l’agire secondo ragione. Ed è in ciò che consiste anche il raggiungimento della perfezione umana e della felicità terrena: ma questa, che per Aristotele era la massima felicità, per il cristiano Tommaso risulta invece una felicità imperfetta e depotenziata, terrena e perciò mutila. Occorre notare, a tal proposito, che in questo discorso di etica filosofica ritroviamo invariate tutte le caratteristiche del filosofare etico/aristotelico, ivi compreso l’intellettualismo, in particolare là dove esso asserisce che la volontà è funzione della ragione: non a caso Tommaso dice che "si ratio recta, et voluntas recta", ad indicare che dove la ragione procede bene, lì anche la volontà – che ad essa è indisgiungibilmente connessa – funziona bene. Ma tutto ciò vale esclusivamente nell’ambito dell’etica naturale, cioè nell’adempimento della legge di natura: c’è però – come sappiamo – anche una legge divina, che la ragione non può conoscere né la volontà può adempiere, bensì necessita della Rivelazione per essere conosciuta e della Grazia per essere osservata. Essa prescrive all’uomo la iustitia divina, ossia il puro e disinteressato Amore divino, conosciuto con la Rivelazione e praticato con la Grazia: è solo tale morale a fornire la vera felicità, mentre l’etica naturale funge da preambolo ad essa proprio come la filosofia è preambolo al sapere teologico, nel senso che predispone l’uomo – distogliendolo dagli istinti passionali – ad ascoltare la volontà divina. Ugualmente, l’etica filosofica prepara l’uomo all’etica cristiana, è una prima tappa di raccoglimento in vista del conseguimento dell’eterna beatitudine. Siamo tuttavia in presenza di un evidente duplice ottimismo: da un lato, la ragione conosce le virtù (il che le era dalla patristica precluso) e, dall’altro, pur non soddisfando l’esigenza divina di giustizia, prepara ad essa, ottenibile solo in virtù del soccorso della Grazia; così la ragione, rinforzata dalla Grazia stessa, riesce per un po’ a perseguire la santità. Infine, la legge umana è quella stabilita dal potere politico amministrato dagli uomini: essa è legittima nella misura in cui è trasposizione fedele della legge naturale, e se la contraddice non è legge, così come quando la filosofia contravviene alla fede non è filosofia, ma erramento. Sicchè è lecito affermare che la legge è tale solo e nella misura in cui è giusta, altrimenti va respinta: ed è per questo che Tommaso riconosce la liceità politica della ribellione e della lotta contro il tiranno (con il conseguente abbattimento del medesimo). E tuttavia, nella legge umana, traduzione di quella naturale e divina, tale legge esprime parallelamente all’etica la medesima funzione propedeutica, poiché, costringendo a non fare il male e a non delinquere – anche solo per il timore di essere puniti – indirizza verso il bene, cosicchè c’è da aspettarsi che quanti costretti dalla legge non fanno il male solo per paura delle pene derivanti (ed è questa la tesi proposta nella Repubblica platonica attraverso il mito di Gige) si abituino a non farlo e a fare volontariamente ciò che prima facevano sotto costrizione. Da tutto questo discorso si evince come le novità apportate da Tommaso non siano poche e di scarso valore: prima fra tutte, la legittimazione del filosofare in quanto tale, seppur subordinato alla teologia e nonostante il persistere della subordinazione del terreno al divino; similmente, beatitudine eterna e santità restano lo scopo ultimo a cui tendere e per cui impegnare le proprie energie. Il tomismo restituisce alla sfera umana un respiro che per secoli era stato abolito: legittimare il sapere filosofico significa rilegittimare la conoscenza di questo mondo, e nelle università urbane fiorite ai tempi di Tommaso nel loro massimo splendore si insegna e si studia la filosofia come una conoscenza squisitamente razionale, soffermandosi sull’aristotelismo presentato in tutte le sue molteplici forme, anche le più radicali (l’averroismo). Anche se nella metà del 1200 si terrà a Parigi il processo intentato a Sigieri di Brabante e agli altri pensatori che, sulla sua scorta, ponevano la filosofia in antitesi con la fede, ciononostante la filosofia continuerà ad essere costantemente insegnata, godendo di grande fortuna. Ciò non toglie, però, che nella cultura dell’età medievale la relativizzazione della vita terrena e mondana resti dominante e sancita, e l’esigenza della santità rimanga discriminante; l’uomo deve sì raggiungere le virtù, ma non fermarsi ad esse, giacchè al di là vi è la santità. In questo panorama, la figura del monaco, ovvero di colui che impegna tutto se stesso nel raggiungimento di suddetta santità, resta un modello imprescindibile per tutti, di contro a cui la vita civile e mondana si rivela periferica e imperfetta. Del resto, non è un caso che ancora il Concilio di Trento minaccerà l’anatema a chi azzardi sostenere la superiorità del matrimonio sulla castità monacale: ciò testimonia come la vita nel mondo terreno resti per lungo tempo soggetta al sospetto e alla diffidenza, e come, nonostante le innovazioni e le aperture apportate da Tommaso e da altri pensatori illuminati, la modernità resti ancora all’orizzonte. La riscoperta di Aristotele impressiona fortemente l’Aquinate, ma viene spontaneo domandarsi perché non sortisca effetti altrettanto profondi su Agostino e sulla cultura del suo tempo, che aveva liquiditato lo Stagirita (inserito nel tutto della cultura antica) come errore e vana curiositas. Come è possibile che Tommaso resti affascinato dal pensiero greco espresso da Aristotele, mentre Agostino lo congeda come se fosse una bagatella? Una possibile risposta a tale interrogativo potrebbe essere quella che invoca la categoria hegeliana di "Spirito del tempo", ossia la tendenza peculiare e irresistibile di una certa epoca storica e della sua cultura: la tendenza trionfante in una determinata epoca è, in definitiva, una manifestazione dello "Spirito del tempo", e in effetti la categoria hegeliana è più complessa di quanto si possa pensare sulle prime, giacchè lo "Spirito del tempo" risulta composto da innumerevoli e imperscrutabili fattori che, variamente combinandosi, determinano i mutamenti epocali (ad esempio la fine del mondo antico e l’avvio di quello medievale). Tali fattori sono così numerosi (pressochè infiniti) da richiedere un’analisi quasi interminabile: ci troviamo pertanto di fronte ad una categoria vaga, perché in ultima istanza lo "Spirito del tempo" hegeliano sfugge alla presa della ragione discorsiva, è un certo nonsochè di sfumato, che non può essere colto dal pascaliano "esprit de geometrie", ma dall’opposto "esprit de finesse". Ed è in quest’ottica che dinanzi ad Aristotele si reagisce in maniere diverse, per svariati e non precisi motivi legati allo "Spirito del tempo", forse perché ai tempi di Agostino la ragione era in declino e la fede rappresentava una novità sollecitante, mentre ai tempi di Tommaso, viceversa, si cominciava a nutrire un rinato interesse per le facoltà razionali così a lungo sepolte. In maniera del tutto analoga alla reazione di fronte ad Aristotele, capita che una stessa città, se vista nel cuore della notte, quando vi si giunge stanchi, appaia orribile; ma, al contrario, se osservata alla luce del sole, da riposati, risulti meravigliosa, pur essendo sempre la stessa.
LA MODERNITA’
A partire dal XIII secolo d.C. si instaura un processo di progressiva rivendicazione di affermazione di sé da parte della ragione umana, e questo ridestarsi della ragione dopo il lungo letargo medievale sfocia nell’Umanesimo, da alcuni concepito come l’alba della modernità. Cronologicamente, per modernità si è propensi ad intendere il periodo che va dalla seconda metà del XV secolo fino ai giorni nostri; in termini generalissimi, stando alla definizione che ne dà Hegel, tale modernità è la "conversione dal cielo alla terra": non più l’al di là, bensì l’al di qua, non la beatitudine eterna, ma la felicità mondana, non la vita futura ma la presente, costituiscono il centro dell’interesse dell’uomo umanistico, per il quale tanto il cielo religioso quanto quello metafisico delle immutabili idee platoniche e delle forme aristoteliche si scostano per cedere il posto alla finita vita terrena. In realtà, questo processo prende le mosse in pieno XIII secolo e dura per parecchio tempo, raggiungendo l’apice nel XVIII secolo con l’illuminismo, e passando per due grandi momenti emancipativi: emancipazione dal principio di autorità e la rinascita della curiosità. Sgombrare il campo dal principio di autorità significa far rinascere l’autonomia della ragione, incensurata e non sottoposta al comando di alcuna entità; la modernità risiede anzi soprattutto nel libero esercizio della ragione, il che vuol dire che essa ridiventa socraticamente curiosa, e – per dirla con Kant – cessa di essere impigrita dal dominio del Libro. I "moderni" hanno legittimato la rinata curiosità in tre fondamentali momenti: il primo di essi è segnato dall’Ulisse nell’Inferno di Dante, che col suo ardore "a divenir del mondo esperto" si spinge fin oltre le Colonne d’Ercole, imbattendosi infine nella morte; il secondo trova invece espressione in un passo di Giordano Bruno (De gli eroici furori, dialogo 5), in cui il Nolano scrive: ">O curiosi ingegni, / […] Per largo e per profondo / >Peregrinate il mondo, />Cercate tutti i numerosi regni", con una chiara allusione alle grandi scoperte geografiche di quei tempi. Infine, il terzo e ultimo momento è scandito da una lettera di Cartesio inviata il 9 febbraio 1639 a padre Mercenne: "io studio per la mia utilità e per la mia curiosità"; particolarmente interessante è il riferimento cartesiano alla categoria dell’utile, che da quel momento in poi assumerà un ruolo fondamentale in sede filosofica. Da queste tre tappe appare evidente come siamo incommensurabilmente distanti dalla dannazione monastica della curiosità (quale era stata sancita da Pier Damiani e da Bernardo), la quale è conditio sine qua non per sbarazzarsi del principio di autorità: è sì una condizione necessaria, ma ciononostante non sufficiente, poiché – affinchè il principio di autorità venga scalzato – è altresì necessario che la ragione diventi anche critica, quale era presso gli antichi. Essa torna appunto tale nell’Umanesimo, un termine, questo, che troviamo solo a fine Settecento e inizio Ottocento: l’Umanista è chi ha accesso a una cultura superiore, è chi si umanizza studiando i testi tramandati dagli antichi, presi a modello di umanità in quanto paradigmi del libero esercizio della ragione, non più ancella della teologia, ma libera e disincantata padrona del mondo. Questo era già, sostanzialmente, il significato della humanitas presso gli antichi, e tale viene compendiato da Aulo Gellio nelle sue Notti attiche (libro XIII, cap. 17): "chi parlava una volta bene latino, designava col termine humanitas quello che i Greci denominavano paideia […]. Sono dotati di humanitas quanti mostrano per le arti una passione sincera e perciò meritano di esser detti i più umani tra gli uomini". Nell’età umanistica, in sintonia con la nozione antica di humanitas, si diffondono con incredibile rapidità espressioni del tipo humanae litterae, humanitas o studia humanitatis, che ben rispecchiano il clima di profonda attenzione per la produzione degli antichi (che in età medioevale era stata letta in maniera strumentale alla fede) che si respirava in quel periodo. Scriverà Giambattista Vico: "gli uomini prima sentono senza avvertire, dappoi avvertiscono con animo perturbato e commosso, finalmente riflettono con mente pura"; con questa celebre riflessione, egli mette in luce come gli uomini in un primo momento siano ancora dei bruti, mera sensazione inconsapevole; poi accedono ad una consapevolezza perturbata dall’emozione e, infine, pervengono alla pura ragione discorrente e ragionante (il che corrisponde appunto all’età antica di Aristotele e Platone e al ritorno di quell’epoca nel mondo umanistico), impadronendosi della "bilancia dello spirito critico", che – aristotelicamente – non può essere posseduta né dai primitivi né dai fanciulli e che nasce con l’Umanesimo. Non è casuale che in età umanistica torni in auge il dialogo, che soppianta il monologare del principio di autorità dell’età medievale: si attua in tal maniera una straordinaria moltiplicazione dei punti di vista e delle prospettive, perché le più disparate concezioni vengono riscoperte e riproposte. Non domina più quel tutt’uno onnisciente che è la dottrina cristiana, ma pullulano tantissime filosofie nella loro individualità, anche scuole di pensiero espunte o tralasciate dai Medievali (l’epicureismo, lo scetticismo e lo stoicismo). Sicchè la tradizione, a partire dall’età umanistica, è messa in krisiV, cioè sottoposta a giudizio e ricomposta nelle sue differenti componenti – spesso inconciliabili – e questa è la condizione imprescindibile affinchè possa farsi strada la tolleranza, ovvero la pacifica convivenza di punti di vista diversi e, spesso, contrari. Il primo importante manifestarsi della rinascente coscienza critica è la filologia umanista, che non può essere ridotta ad un arido grammaticalismo, ma va piuttosto intesa come tensione a reinterpretare nella sua complessità la cultura antica quale ci è pervenuta. Insomma, non si tratta di una mera restaurazione linguistica (non è, cioè, un banale ritorno al latino di Cicerone, come lo intenderà certo umanismo, quale quello di Ermolao Barbaro), ma è piuttosto l’esercizio critico della ragione; tale è, per l’appunto, la critica filologica condotta da Lorenzo Valla contro la "Donazione di Costantino", da lui smascherata – col solo utilizzo di mezzi filologici – come un falso posteriore, redatto da un monaco ignorante. Siamo in altri termini di fronte ad una riappropriazione critica della tradizione antica, considerata in sé come un valore smarrito nella buia età medievale. Risulta a questo punto opportuno indagare – seppur sinteticamente – su che cosa sia accaduto alla ragione nei cosiddetti "secoli bui" dell’età medievale: dal prevalere egemonico della consuetudine sulla ragione, nasce una cultura nella quale si assiste al sopravvento di un unico punto di vista (quello cristiano), spesso imposto con la violenza, un punto di vista che non è il frutto del libero investigare del raziocinio, ma, piuttosto, è un qualcosa che viene tramandato consuetudinariamente di padre in figlio, ed è in tale condizione che si palesano gli effetti deleteri giocati dal cristianesimo sulla ragione umana. Quanto più la consuetudine prende il sopravvento, tanto più viene stimolata la pigrizia del filosofare, imponendo la comoda facilità del risaputo, con l’inevitabile conseguenza che la capacità di giudizio propria della ragione si ottunde ed essa subisce un precoce ed artificioso invecchiamento che ne atrofizza le funzioni riducendola a mero portavoce e a pura cassa di risonanza della prospettiva cristiana. Un simile esempio di sclerotizzazione di un’intera civiltà – quale si è avuto nel Medioevo – ci è fornito anche dalla Cina, così come essa si è sviluppata fino al XIX secolo d.C., in un incredibile immobilismo che Hegel ha rintracciato nella produzione artistica, tristemente rimasta invariata nelle sue forme, a tal punto da essere nel XVIII secolo ancora ridotta a riprodurre prototipi del tutto uguali a quelli dei secoli precedenti, in una repititività assoluta, peraltro presente anche nelle istituzioni politiche di quell’immenso Paese. Ora, qualcosa di affine al caso cinese avviene in Occidente nell’età medievale: prova ne è che se ci chiediamo in che cosa si differenzi l’Ottocento dal Novecento o dal Mille, ci troviamo alquanto in imbarazzo nel fornire risposte soddisfacenti, proprio come non riusciamo a rispondere se interrogati su quali siano le distinzioni tra la Cina del XIX secolo e quella del XII. Lo shock culturale prodotto dal rientro in Europa di Aristotele ha, in tal prospettiva, l’effetto di una vera e propria scarica di adrenalina; e, del resto, l’intellettualismo greco, così profondamente venato di ottimismo, da cos’altro trae origine se non dallo stupore continuo che sorprende la ragione che scopre se stessa? I dialoghi platonici non sono forse un incessante stupore della ragione che disvela le sue virtù? Ora, la modernità non esita a condannare il Medioevo e il suo rifiuto della ragione come faro della vita umana: e, bandito il principio di autorità e ripristinata la curiosità di marca socratica, i moderni procedono con una terza importantissima via emancipativa con la quale convertirsi dal cielo alla terra, e quella via è una diretta conseguenza del ripudio del principio d’autorità. Scrive Hegel in merito all’età medievale, epoca della "coscienza infelice" che vede in Dio tutto e nell’uomo nulla – e al suo trapasso in modernità: "gli uomini avevano un cielo ornato con ricca abbondanza di pensieri e di immagini […]. Anziché sostare in questo pensiero, che invece sorvolava, lo sguardo si innalzava al cielo, ad un essere divino, ad un presente – se così si può dire – al di là. Si rese così necessario, in età moderna, costringere l’occhio dello Spirito sulle cose di questa terra e trattenerlo". Il cielo della religione cristiana, delle idee platoniche e delle essenze aristoteliche viene dai moderni abbandonato: anche le essenze aristoteliche – è bene notarlo – fanno parte del cielo e non della terra, poiché esse sono contemplabili da parte della ragione solo attraverso un’astrazione che le svincoli dall’empirico e, di conseguenza, dalla vita. In età moderna, è la ragione, ridestatasi dal lungo letargo medievale, che – critica e polemica ad un tempo – costringe l’occhio alla terra, svuotando i cieli allestiti dalla religione e dalla metafisica, le quali appaiono alla ragione stessa come vane fantasticherie o fumose congetture, ossia come mondi fantasmagorici o, quanto meno, incerti, privi cioè di salde prove e perciò immeritevoli di convogliare su di sé tutta l’attenzione e la sollecitudine dell’uomo. La pretesa di fare di questi cieli il fine ultimo dell’uomo appare agli occhi vigili della ragione critica non solo infondata, ma anche nociva, giacchè distoglie l’uomo stesso dall’occuparsi di quegli obiettivi in larga misura certi e tangibili: le cose ch’egli potrebbe compiere quaggiù, finirà per trascurarle completamente se si ostina a perder tempo in questi fantomatici e sedicenti cieli; la ragione nella sua veste critica, dunque, distoglie da essi, mentre quella nella sua veste critica e operatrice trattiene a terra lo sguardo, mettendo mano ad una ben calcolata (cioè scientifica) trasformazione della terra, volta a trarre la massima utilità e il massimo profitto possibili per l’uomo. Ecco allora che l’emancipazione dal cielo si articola in una prima riappropriazione della terra grazie alla ragione calcolatrice che sfocia in una prospettiva eudemonistica e utilitaristica tipica della modernità, sfocia in un filantropismo che culminerà nell’illuminismo. E allora ciò che la risvegliata ragione sortisce è un allontanamento dal miraggio d’una lontana e dubbia beatitudine celeste (distacco anche dalle forme aristoteliche e dalle idee platoniche), avviandosi all’indubbia e prossima felicità terrena, frutto di un corretto impiego della ragione, il quale è sì un impiego critico e polemico, ma non più metafisico (come quello antico), la ragione non si interessa cioè più di speculare, ma concentra la sua attenzione sul calcolare e sull’operare. In piena età illuministica, Voltaire e Diderot affermano concordi che "la felicità è l’unico dovere dell’uomo", ma non si tratta della felicità platonicamente ed aristotelicamente intesa, culminante nella sapienza speculativa; al contrario, è la felicità di chi riesce a rendere questo mondo più comodo e agevole, in un significato piuttosto vicino a quello che odiernamente attribuiamo al "benessere". Ne segue che l’emancipazione dal cielo comporta la riappropriazione della terra, ma anche una seconda riacquisizione: affinchè l’uomo si riappropri della terra trasformandola a proprio vantaggio, è necessario che egli sia presente hic et nunc a se stesso, edotto e consapevole delle proprie caratteristiche e qualità, fiducioso nei propri mezzi e padrone di far di essi l’uso più consono. Occorre cioè la riappropriazione di sé da parte dell’uomo, il che significa che i moderni elaborano una nuova e diversa immagine dell’uomo stesso, rispetto a quella affiorata in età medievale. Una lunga tradizione storiografica che parte da La civiltà del Rinascimento in Italia (1860) di Jacob Burckhardt e arriva fino a Giovanni Gentile scorge i prodromi di questa rinnovata immagine dell’uomo nei trattati umanistici sulla dignità e sull’eccellenza dell’uomo, nei quali si tesse un elogio del genere umano e se ne segnalano la superiorità e l’egemonia su tutti gli altri esseri. Ma sono veramente questi i testi in cui emerge l’immagine dell’uomo nuovo? Sono per davvero gli incunaboli di un genere umano dal volto rinnovato? O non sono piuttosto altri? Scendendo nello specifico, notiamo come i trattati umanistici a cui fan riferimento Burckhardt e Gentile siano suddivisibili in due diversi filoni – uno platonico e l’altro aristotelico – , nessuno dei quali tuttavia delinea veramente la nuova immagine dell’uomo moderno. Il più noto esponente del filone platonico è indubbiamente Pico della Mirandola e la sua Oratio de hominis dignitate, nella quale sostiene che l’uomo è stato creato ad immagine di Dio e, perciò, come un microcosmo, in maniera tale da riprodurre entro di sé l’infinita pienezza di Dio (la pienezza delle idee platoniche si configura per Pico come pienezza dell’essere divino, infinito perché racchiude in sé l’infinita totalità delle idee). Il mondo stesso è, del resto, un’immagine (deficiente) di Dio e l’uomo rappresenta un mondo in miniatura, in quanto egli è virtualmente ogni forma possibile di vita: vegetale (poiché possiede l’anima vegetativa), animale (perché dotato di anima sensitiva e, quindi, di istinti e passioni), umana (in quanto equipaggiato di ragione e pensiero), angelica (nel caso raggiunga la pura intuizione intellettuale). Ben si capisce come l’uomo compendi entro di sé l’intero cosmo, perfino la vita divina. E tale microcosmicità fonda la libertà dell’uomo, chiamato a scegliere quali seguire tra queste vite virtualmente presenti in lui: con un libero slancio di volontà, può decidere se restare pianta, animale, uomo, o se innalzarsi alla natura angelica e magari anche a quella divina. Tale libertà è la prima ragione della particolare eccellenza e dignità da Pico riconosciuta al nostro genere, strettamente imparentato con Dio stesso: è solo l’uomo, infatti, a poter scegliere liberamente se rimanere pianta o innalzarsi a Dio, mentre tutti gli altri enti (le piante, gli animali, e gli angeli stessi) sono destinati a rimanere quali sono, fissati nella loro determinatezza. Certo, non si tratta di una libertà assoluta, ma relativa, in quanto non costituisce i valori tra i quali scegliere, ma li trova già costituiti: ma è comunque tale da consentirci una nostra dignità eccellente. E Pico – qui in sintonia con Ficino e con il suo De immortalitate animorum – sviluppa un’attenta riflessione sul "desiderio naturale", che è un desiderio congenito alla natura di un certo ente; ora, esso è presente in tutti gli enti e in tutti ha per oggetto un bene che è – aristotelicamente – il proprio bene, ossia la perfezione dell’essere di quel dato ente, sicchè ogni cosa appare come in cammino verso la propria piena realizzazione. Anche nell’uomo trova spazio tale desiderio naturale, ma con la prerogativa di non potersi appagare di un simile perfezione: al contrario, mira alla perfezione dell’essere in quanto tale, e perciò a quella dell’essere divino. Sotto le spoglie del desiderio naturale divino di cui parla Pico non è difficile riconoscere l’eros socratico/platonico, quell’anelito all’infinito che tornerà ancora nella cultura romantica: tale sforzo verso l’infinito alimenta la nostra anima per tutta la sua esistenza, poiché nessuno dei beni che conquista è in grado di estinguere la sua sete; da ciò deriva che l’esistenza dell’anima, tendente all’infinito e per questo motivo mai appagata pienamente, dovrà essere infinita, cosicchè essa sarà immortale. E’ una contraddizione solo apparente quella in cui ci imbattiamo quando Pico parla dell’uomo come ente finito e del suo desiderio naturale come mirante all’infinito: l’uomo, infatti, è atto al fine soprannaturale ed è in ciò soccorso dalla Grazia, secondo quel celebre motto medievale "Gratia perfecit naturam"; è pertanto concesso all’uomo di raggiungere l’infinito, grazie all’intervento della Grazia: ciò avviene nell’estasi mistica, il che vuol dire che in questa suprema possibilità di unirsi a Dio Pico ravvisa la superiorità umana su tutto il creato, giacchè solo l’uomo (e non l’angelo) può indiarsi. Gli è permesso di innalzarsi fino alle sfere celesti o di abbassarsi fino ai bruti: che l’uomo si trovi in qualche misura in una posizione privilegiata rispetto agli angeli è anche provato dalla tradizione biblica, che vuole che, caduti sia gli uomini sia gli angeli (Lucifero), Dio si prenda cura esclusivamente dei primi, concedendo loro la possibilità di redimersi. Questo discorso di Pico rileva la centralità dell’uomo nell’economia del cosmo, di cui l’uomo appunto è il massimo prodotto: "o somma liberalità di Dio Padre, somma e mirabile felicità dell’uomo! Al quale è dato avere ciò che desidera, essere ciò che vuole. […] I quali [uomini] cresceranno in colui che li avrà coltivati e in lui daranno i loro frutti. Se saranno vegetali, diventerà pianta; se sensibili abbrutirà. Se razionali, riuscirà animale celeste. Se intellettuali, sarà angelo e figlio di Dio. E se, non contento della sorte di nessuna creatura, si raccoglierà nel centro della sua unità, fattosi uno spirito solo con Dio, nella solitaria caligine del Padre, colui che è collocato sopra tutte le cose su tutte primeggerà" (Oratio de hominis dignitate). L’uomo così inteso è faber fortunae suae: eppure la prospettiva di Pico (condivisa in gran parte da Ficino e da Landino) può davvero dirsi moderna in senso pieno? Getta davvero le basi del nuovo uomo? Sia Pico sia Ficino mantengono il cielo come mèta ultima (platonica e cristiana), restando lontanissimi dall’affermazione hegeliana secondo cui il moderno sarebbe un passaggio dal cielo alla terra. Se ci spostiamo sul filone aristotelico, ci imbattiamo in tre grandi pensatori: Manetti (autore del De dignitate et excellentia hominis), Alberti (di indirizzo stoico) e Bracciolini. Essi si occupano della nobiltà dell’uomo, rinvenuta nell’esercizio delle virtù etiche e politiche (per questo motivo questi tr
FRIEDRICH SCHILLER
Nell’età illuministica si assiste al convivere della prospettiva moderna del criticismo con quella arcaica della metafisica e della religione, di cui Schiller è espressione in senso pieno: ciò che egli rifiuta duramente è la riduzione dell’uomo a bisogni, ad amor di sé e a ragione calcolatrice (ragione calcolatrice che sul versante etico sfociava nell’utilitarismo, su quello teoretico nella scienza moderna). In una prospettiva in cui l’uomo è ridotto ad un livello così basso – ridotto “alla prosa”, dice Hegel -, quale appunto è quello in cui l’avevano proiettato Machiavelli e Hobbes, – si domanda Schiller (ma non solo lui) – che spazio può esserci per attività quali l’arte? Ad essa vengono assegnate le funzioni del divertimento e della distrazione oppure quelle dell’istruzione dei cittadini, mettendo in luce come il miglior modo di perseguire il proprio interesse particolare è subordinarlo a quello collettivo (ed è ciò a cui mira lo stesso patto sociale). Ma l’uomo non può esser ridotto a mero animale, ancorchè come il più lungimirante fra gli animali, e ciò vuol dire rigettare il fondamento della machiavellica e hobbesiana immagine dell’uomo, anche se non in vista di un fantomatico ritorno alla tradizione metafisico/religiosa, bensì in direzione tale per cui fiorirà una nuova metafisica che tiene conto delle istanze del moderno: pensiamo all’idealismo tedesco e, in certo senso, a Marx, il quale, con la sua pretesa di assolutezza, presenta i caratteri veritativi tipici del pensiero metafisico. Viene invece prospettata una diversa immagine che tiene conto dei mutati tempi e si oppone alla tradizione critica imperante nell’età della Ragione, pur condividendone certe critiche alla metafisica antica: basti pensare a Kant (che di Schiller è maestro), il quale resta fedele alla scienza moderna (newtoniana) ma è pienamente consapevole dei limiti della ragione metafisicamente intesa, rifiutando l’immagine illuministica dell’uomo come mero agglomerato di interessi e pulsioni passionali. Dal canto suo, Schiller è, oltreché uno dei massimi poeti di tutti i tempi, eccellente filosofo, tragediografo e storico, compendiando entro di sé le caratteristiche tipiche del genio universale, alla cui conoscenza nulla sfugge. Vissuto a cavallo tra il Settecento e l’Ottocento, egli dirige dapprima i suoi studi verso la medicina e, divenuto medico nel 1781, pubblica il suo primo grande lavoro teatrale, I masnadieri, redatto clandestinamente quando aveva diciott’anni. Nel 1783 compone La congiura di Fiesco a Genova, nel 1784 Amore e raggiro, nel 1785 vede la luce il celebre Inno alla gioia (musicato da Beethoven), nel 1787 il Don Carlos. Nel 1787 Schiller si trasferisce a Weimar e, dal 1788, si dedica assiduamente agli studi storici, scrivendo la Storia dell’insurrezione dei Paesi Bassi contro il governo spagnolo e, nel 1789, su suggerimento di Goethe, viene nominato professore di Storia presso l’università di Jena, dove pubblica la Storia della guerra dei trent’anni. Ma è solo a partire dal 1791 che egli proietta – influenzato soprattutto dal pensiero di Kant e della sua Critica della ragion pratica – tutti i suoi interessi sulla filosofia, componendo tre opere di centrale importanza per la filosofia moderna: Grazia e dignità (1793), Dell’educazione estetica dell’uomo (1795), Della poesia ingenua e sentimentale (1795). Al 1799 risale la trilogia del Wallenstein e nel 1800 Maria Stuarda. Nel 1804, poi, compone la sua opera forse più famosa: il Guglielmo Tell; l’anno successivo muore. L’opera filosofica di Schiller vanta tra i suoi padri, oltre a Kant, Rousseau e Winckelmann: si tratta di tre autori a cui corrispondono tre posizioni diverse, sì, ma accomunate dalla critica severa dell’antropologia illuministica di ascendenza hobbesiana e machiavellica; il pensiero di Schiller – merita di essere ricordato – godrà di grande fortuna per lungo tempo, fino a trovare una sua punta di vigore nel 1968, quando Marcuse – che del Sessantotto mondiale fu il padre spirituale – compose due testi – L’uomo a una dimensione e Eros e civiltà – da cui traspariva palesemente il pensiero di Schiller, abilmente mixato – in Eros e civiltà – con quello di Freud. Dobbiamo meglio chiarire, a questo punto, perché Schiller si ispiri soprattutto ai testè citati autori: Rousseau era stato il primo a protestare contro l’uomo ridotto dai moderni ad animale lungimirante, e aveva condotto la sua critica facendo sue alcune posizioni affiorate in seno al pensiero inglese di inizio Settecento – specialmente quello di Shaftesbury e Hutcheson – che si era inviperito contro Hobbes. Questi due pensatori, aristocratici e dalle condizioni agiate, asseriscono che, lungi dal ridursi a mero sforzo di autoconservazione, l’uomo è naturalmente simpatia per gli altri suoi simili: viene in questo modo fondato il Settecento “sentimentale” che protesta e rompe con il razionalismo e l’intellettualismo all’epoca dilaganti; l’uomo non è solo ragione, ma è anzi anche e soprattutto sentimento, tale per cui prova per natura simpatia verso i suoi simili e, seguendo gli slanci di siffatto sentimento, dà vita alla famiglia e allo Stato. Si tratta di un sentimento naturale nel senso che è immediato e spontaneo, è cioè un qualcosa che la natura ci detta al di qua di ogni riflessione e di ogni arte, è un “istinto divino” in tutti presente e a cui tutti tendiam l’orecchio: suoi oggetti sono, innanzitutto, le evidenze preriflessionali quali la benevolenza e la simpatia per i nostri simili, nonché un senso di giustizia volto a realizzare nella società un’armonica convivenza (rispecchiante quella della natura) fra gli individui. Ciò che nello specifico Shaftesbury predica è un umanesimo della simpatia, il cui fine naturale consiste primariamente nel raggiungere la virtù e la felicità che ne scaturisce. Hutcheson, esprimendosi in termini affini, va dicendo che l’uomo è animato da un immediato sentimento morale, che è sentimento del bene comune e che noi proviamo inintenzionalmente, a prescindere da ogni riflessione: tale sentimento si sostanzia del desiderio che ciascuno sia felice, sicchè l’uomo non si muove esclusivamente per promuovere e tutelare i suoi individuali interessi, ma, viceversa, per garantire quelli di tutti e non agisce così in vista del proprio bene: se per Machiavelli e Hobbes il perseguimento dell’interesse comune era la cornice per meglio perseguire quello individuale, per Hutcheson e Shaftesbury quello comune vien prima di quello individuale, e anzi quest’ultimo è a al primo subordinato. E questo sentire, configurato come disinteressato, non si colloca né sul piano della razionalità né su quello delle passioni, bensì su un altro e più elevato livello: di esso la metafisica classica non era ignara, e anzi in buona parte tanto l’eros platonico quanto la meraviglia aristotelica – che della filosofia è il motore – ne erano una prima precisa formulazione, quasi come se in essi si presentisse per via arazionale la verità a cui la ragione perviene solo secondariamente. La grande importanza di Rousseau, poi, risiede soprattutto nell’aver per primo affrontato certi temi, influenzando col suo pensare intere generazioni di filosofi (da Kant a Marx), essendo lui il primo moderno ad interrogarsi con serietà sulla modernità in quanto tale e a domandarsi se essa sia realmente positiva o meno. Il filantropismo che alimentava l’illuminismo è reale o fasullo? E la cultura e la società così come si sono evolute presso i moderni rendono per davvero felice e perfetto l’uomo o, piuttosto, lo allontanano sempre più dalla felicità e dalla perfezione? Rousseau è, in altri termini, il primo a problematizzare la cultura moderna, guardandola con occhio critico e contrapponendo l’uomo colto e moderno a quello originario e naturale (il buon selvaggio) nella sua immediata e spontanea naturalezza; e, così facendo, egli elabora una nuova e dirompente concezione dell’uomo: se per i moderni l’iter positivo è quello che guida l’uomo dalla sua condizione originale – attraverso la ragione – alla civiltà, al cui interno sviluppare le proprie facoltà e soddisfare i propri bisogni signoreggiando sulla natura, Rousseau mette in dubbio una tale concezione, chiedendosi se davvero un tale viaggio finisca nell’accogliente porto della felicità e del benessere o, se piuttosto, non si risolva in un naufragio che fa smarrire all’uomo la sua armonia e la sua tranquillità originaria. La ragione, per Rousseau, è sì in grado di smascherare le imposture ordite dalla metafisica e dalla religione (e in ciò essa svolge una funzione altamente positiva), ma non sa comunque essere una guida affidabile e capace di pilotare proficuamente l’uomo, producendo solo un inestricabile caos di opinioni filosofiche contrastanti e poco convincenti che portano generalmente allo scetticismo. Il che, anziché migliorarci, sconcerta e svia la voce naturale della nostra coscienza e riduce i princìpi etici che da essa promanano a pretesto per giochi di opinioni e di sofisticherie di filosofastri. Se ne evince che, quanto più la nostra esistenza si è fatta colta, tanto più è andata persa quella calorosa immediatezza in cui è racchiusa la nostra felicità, giacchè il processo di acculturazione ci ha trasformati da organismi naturali certi del proprio sentire in artificiosi meccanismi razionali: dal naturale e originario timore di Dio siam giunti non solo alla desolante giungla del cristianesimo, ma addirittura – come reazione ad esso – ad un deleterio e pernicioso materialismo ateo, cosicchè l’innata bontà della natura umana è stata rovinata dai sofismi dei sistemi etici eudemonistici, ribaltandosi così nel suo opposto: un’avida macchina calcolatrice. Il primo guasto è l’aver disorientato l’uomo producendo una miriade di sistemi filosofici che si elidono mutuamente; il secondo guasto è l’aver tacitato nell’uomo l’ingenua certezza originaria della voce della coscienza; e il terzo, non meno grave, è l’aver fatto sì che egli possa prevedere razionalmente il futuro, il che non fa altro che impedire di vivere nel presente: la snervatezza della riflessione finisce per inibire l’azione stessa, secondo la formula vita ante acta est vita sine acta (la vita prima delle azioni è vita senza azioni), con cui si lumeggia come le riflessioni che facciamo prima di agire finiscano per paralizzare le azioni: quanto più si fantastica il da farsi, tanto meno lo si realizza. L’eccesso di riflessione è dunque, agli occhi di Rousseau, una grave malattia e in ciò – oltreché nel privilegiamento del sentimento sulla ragione – egli apre i cancelli al Romanticismo. La stessa società moderna, che della culturizzazione è il frutto, altro non è se non la progressiva disintegrazione e atomizzazione dell’uomo, giacchè la ragione finisce per dividere il lavoro, le classi, le condizioni sociali e l’uomo (che per natura è un tutto), in questa maniera, diventa uno specializzato, cosicché la sua vita, da piena che era, si fa angusta e delimitata. Avviene così che l’uomo perda la libertà naturale e sia sempre più precocemente sottoposto all’influsso delle categorie sociali nella loro inflessibilità oggettiva: il suo baricentro finisce per coincidere con ciò che la società per lui decide; da libero soggetto è divenuto una componente oggettiva ed eterodeterminata del sistema sociale in cui è inserita. Riflessione e società espropriano dunque l’uomo della sua naturale e armonica felicità: ecco come la protesta rousseauiana è rivendicazione di un uomo nuovo non riducibile a raziocinio e a società, un uomo che sia anche cuore e sentire, nel senso pascaliano del termine. Si tratta, allora, di una rivendicazione della libertà dalle strettoie della ragione calcolatrice, che per un verso ha sì spezzato le catene dell’oscurantismo metafisico e religioso, ma che, per un altro verso, ha anche instaurato – come notano lucidamente Adorno e Horkheimer nella Dialettica dell’Illuminismo – un nuovo ordine oppressivo che conculca la spontaneità umana. Sicchè la critica di Rousseau ai suoi contemporanei è soprattutto una critica al loro costume di intendere l’uomo come mera razionalità e la civiltà attuale come migliore di quella originaria. In questo senso, egli può sostenere che la riflessione razionale è la fonte di ogni male in quanto produce l’amor proprio, facendo ripiegare l’uomo su se stesso appunto perché, riflettendo, egli separa e contrappone le cose: così, appena nato, l’amor di sé è costretto ad un continuo confronto ed è perciò sempre scontento; ne nascono l’invidia, l’avidità, l’ira, l’odio e, soprattutto, l’ostilità reciproca, onnipresente là dove domina la riflessione razionale. Ne segue il trionfo della simulazione per cui gli uomini con cui si parla non sono quelli con cui si conversa, giacchè di essi non vediamo che le loro figure: le loro buone maniere altro non sono se non la vernice che copre magicamente la loro essenza, una vernice che si configura per Rousseau come il “velo perfido e uniforme dell’educazione” e che è tale da coprire la realtà “sotto questa vantata urbanità che dobbiamo ai Lumi del nostro tempo“. Presso i moderni le buone maniere sono sempre valutate positivamente come pilastri della modernità (insieme con la legalità), pur senza nascondere la dimensione simulatrice e ipocrita ad esse inerente. Dal canto suo, Rousseau – in rottura con i suoi tempi – contesta radicalmente perfino la funzione civilizzatrice delle buone maniere, rigettandole dunque in toto e non solo per la simulazione a cui inducono. In mezzo a tanta filosofia e a tante massime sublimi, non ci resta che un’apparenza esteriore e mistificatoria: l’errore clamoroso del filantropismo illuministico consiste appunto nel paralogismo in virtù del quale si vuol fare della riflessione – fonte di ogni male – e del calcolo razionale la panacea universale, pretendendo che ciò che dei mali è causa si proponga anche come loro antidoto. La coscienza calcolatrice è dunque assolutamente negativa, mentre buona è la coscienza sensibile, ovvero quella di quei buoni sentimenti che hanno per Rousseau origine in due princìpi anteriori alla ragione: uno di questi si interessa ardentemente al nostro benessere e alla nostra conservazione, l’altro ci ispira una naturale ripugnanza a vedere soffrire e morire qualsiasi essere vivente. Tali princìpi sono l’amor di sé e la pietà, che, immediati e spontanei, vengon prima della ragione: da essi procedono le passioni della dolcezza e della tenerezza, della benevolenza e della commiserazione. Questi due sentimenti sono naturali, ma si vuol forse dire, allora, che la riflessione sia innaturale? Certo che no; naturale, infatti, è ciò che le cose si ritrovano ad essere, e alla natura umana ineriscono la pietà e l’amor di sé, ma anche la riflessione, che però non è da Rousseau definita come naturale in quanto, a differenza di quei sentimenti immediati e spontanei, essa procede e diviene nel tempo, non è immediatamente data una volta per tutte. Dal concetto di natura come essenza delle cose, definiremo ora come naturali quegli aspetti che presentano i caratteri della natura nella sua immediatezza mentre postnaturale sarà ciò che interverrà in un secondo tempo (tale è appunto la riflessione): mentre l’uomo si trova immediatamente ad essere pietà e amor di sè, diventa riflessione solamente a seguito di quell’attività che è il pensare discorsivo, così come l’artista è tale sia perché dotato di doti naturali sia perché ha saputo sviluppare attraverso l’esercizio il proprio talento. L’amor di sé, anteriore alla riflessione, non è però indotto a far paragoni e non entra perciò in contrasto con gli altri, bensì la sua massima è “vivi e lascia vivere”; a sua volta la pietà precede l’uso di ogni riflessione: ma l’amor di sé è opposto all’amor proprio, in quanto quest’ultimo è deviazione e corruzione del primo, sbandamento causato dall’insorgere della riflessione. Ecco che amor di sé e pietà configurano uno stato di natura buono, di contro ad un pessimo stato di riflessione, giacchè cattiva è la riflessione che trasforma l’uomo in un animale depravato. Ciò vuol dire che ad esser buona è la coscienza che non si lascia sviare dalla capziosità dei sofismi, ma sa ascoltare il proprio sentimento interiore, che non è altro se non la naturale voce della coscienza, soffocata ma non repressa dal sovrapporlesi della riflessione: basta tacitare il blaterare della riflessione ed ecco che torna a farsi sentire la voce della coscienza, pietosa e disinteressata, chiara e spontanea. “Dispensati dallo studio della morale, noi disponiamo a minor prezzo di una guida più certa in questo immenso dedalo delle opinioni umane“: la coscienza è, per l’appunto, la guida a cui qui allude Rousseau. E per questa via l’uomo scopre di essere naturalmente buono e di poter dar vita ad un’etica – alternativa a quella utilitaristica – del disinteresse e dell’universalità. Nella sua accesa polemica contro gli Illuministi, Rousseau non si limita a mettere alla berlina la presunta bontà della cultura illuministica, ma anche la sua fantasticheria di migliorare l’uomo e di renderlo davvero felice: “la riflessione non serve che a rendere infelice l’uomo, gli fa rimpiangere i beni passati e gli impedisce di godere del bene presente”; essa, insomma, è destinata a culminare ineluttabilmente in un calcolo previdenziale deleterio e destabilizzante che impedisce di godere del presente, portandoci senza tregua al di là di noi, moltiplicando i desideri e le speranze e, in questo modo, travolgendoci in una spirale di attese e quindi di tormenti: “mi è vietato identificare semplicisticamente la felicità del genere umano con la prosperità derivante dalla soddisfazione ora di questo, ora di quel bisogno“. Ed è qui che il discorso di Rousseau – dopo aver abbattuto i capisaldi dell’Illuminismo utilitaristico – si fa propositivo: se la riflessione impedisce di raggiungere la felicità, è forse possibile intervenire sulla riflessione stessa non per eliminarla, ma almeno per attenuarla, in modo tale che il presente diventi almeno in parte godibile. Nella misura in cui si depotenziano i bisogni e i desideri, allineandoli alle risorse disponibili e quindi rendendoli soddisfabili, il presente si fa più vivibile e meglio usufruibile. Tale dovrebbe essere la condizione che vige nello stato di natura, ove è assente la sproporzione fra desideri e capacità di soddisfarli (sproporzione che causa l’infelicità regnante nella nostra società). Nello stato di natura, l’uomo ha pochi e semplici desideri in un contesto in cui può sempre soddisfarli, raggiungendo dunque con grande agilità la felicità: i suoi desideri non oltrepassano mai la possibilità di soddisfarli, giacchè la ragione non prospetta ancora le sue chimeriche immagini che spingono a volere sempre di più cose che, essendo difficilmente raggiungibili, creano infelicità. La sua anima s’abbandona unicamente al sentimento della sua esistenza attuale: ma lo stato di natura, più che una realtà concreta andata perduta, è un’ipotesi di quel che l’uomo potrebbe essere a prescindere dalla riflessione; tuttavia, non di meno, nella realtà concreta la riflessione è componente dominante nell’uomo ed è capace di pervenire ad un autentico autocontrollo, giacchè è essa stessa a rendersi conto dei danni da lei provocati. Essa può dunque indurre alla rinuncia a perseverare nel calcolo e può spingere a desistere dall’amor proprio, dando spazio all’amor di sé e ai sentimenti naturali, adottando la riaffiorata prospettiva non antagonistica e non competitiva dell’amor di sé che si accontenta di provvedere ad un’amministrazione delle risorse disponibili per supplire ai bisogni naturali di ciascuno e non di ampliarsi ossessivamente secondo la logica di una spietata concorrenza. Può così instaurarsi un ordine di cose che si limiti ai bisogni naturali, in cui l’uomo si scopre autosufficiente e “trova nel proprio stato tutto ciò che gli occorre per essere contento e per non volerne uscire“. Nella quinta parte della Nuova Eloisa, Rousseau tratteggia una tenuta in Svizzera abitata da uomini “sensibili” (cioè capaci di sentire la voce della coscienza) e saggiamente amministrata dal suo tenutario, la cui saggezza consiste precipuamente in una riflessione che trascura di inventare artifizi e che si mette al servizio dell’amor di sé: è una comunità che modera i propri bisogni e vive quindi stabilmente felice. Proprio perché a loro non manca nulla, possono stabilizzarsi appagati nel loro presente ed è questa la felicità di un essere bastevole a se stesso, felicità paragonabile a quella di Dio. Ma quello che Rousseau descrive è un idillio utopistico, non una realtà fattualmente esistente: la sua è la proposta di un correttivo che muti l’uomo dell’età utilitaristica per poter lasciar spazio al sentimento e alla naturalità. Sulla formazione di Schiller incide profondamente la lezione rousseauiana, soprattutto attraverso la ripresa che di Rousseau fa Kant in sede etica: quest’ultimo, infatti, scopre grazie a Rousseau l’originale autonomia della legge morale e la “ragion pratica” non è altro che l’immediata e profonda voce della coscienza di cui aveva parlato Rousseau. L’uomo non è buono in forza del suo sapere, ma in forza dell’immediata presenza in lui dell’imperativo categorico che può essere sì non seguito, ma mai messo a tacere. Rousseau – nota Kant – scopre, sotto le implicazioni storiche, geografiche ed economiche che condizionano l’uomo, la legge morale che fa dell’uomo un essere morale, segnalando la sua superiorità su tutti gli altri esseri viventi. Anche Kant combatte la tesi illuministica dell’uomo come agglomerato di passioni e sensibilità, e propone come antidoto la prospettiva di un uomo come razionalità universale e libera, sicchè quella di Kant è la proposta di un’etica della libertà nel senso che la grandezza dell’uomo è scorta nella sua capacità di scegliere da chi (l’imperativo categorico oppure le sensazioni) farsi determinare nelle sue azioni. Gli imperativi ipotetici sono appunto quelli in cui la ragione calcolatrice fornisce i mezzi in vista del soddisfacimento dei bisogni dettati dall’amor proprio: su di essi non si può fondare un’etica universalmente valida; Kant asserisce che l’uomo sente sempre in sé la voce della ragion pura pratica, la quale gli chiede senza tregua di universalizzare il proprio comportamento e di atteggiarsi in maniera tale da considerare gli altri mai come meri mezzi e sempre anche come fini (viene così smentita, ancora una volta, l’etica utilitaristica). Nello sforzarsi di conformare le proprie azioni all’imperativo categorico, rifuggendo alla lusinghiera voce della sensibilità animalesca, l’uomo esercita pienamente la propria libertà, sollevandosi per tale via al di sopra degli altri animali: il valore squisitamente umano dello sforzo morale è da Kant messo all’ordine del giorno, scalzando così la stolida ricerca della felicità utilitaristicamente intesa. Allo sforzo morale spetta la felicità come doveroso riconoscimento (il che porta – come è noto – Kant a postulare l’esistenza di un Dio che premi la virtù), ma tale felicità non è quella utilitaristica né è il motivo dell’osservanza della legge: è, piuttosto, un qualcosa che corona la virtù, la quale è e resta disinteressato perseguimento della legge morale. E il sommo bene è proporzionale connessione tra massima felicità e massima perfezione, il che non ha nulla a che vedere con la ricerca della felicità. In un passo del primo Schelling – quello ancora influenzato da Kant e da Fichte -, viene con forza ribadita la filosofia trascendentale, di contro alla ricerca della felicità condotta stoltamente dagli utilitaristi, e per far ciò Schelling parla espressamente dello Streben, ossia dello sforzo etico all’osservanza della legge morale: “l’uomo in cui opera la libertà della ragion pratica ripudia la felicità sensibile. Quanto più diventiamo liberi, quanto più diventiamo conformi alla ragione, tanto meno necessitiamo della felicità” (Lettere sul dogmatismo e sul criticismo), perché “l’uomo libero arriva a sentirsi innalzato dall’ideale sensibile di felicità” in quanto diventa mera ragion pratica, “pura e illimitata libertà” e, perciò, gode della beatitudine. In quanto agisco moralmente, tendo all’identità del mio essere, ma è una condizione ideale, poiché l’uomo resta sempre e comunque un animale: si tratta allora di un ideale a cui tendere – potremmo dire: un’idea nel senso kantiano – e a cui indirizzare il proprio sforzo morale; sicchè per Schelling la destinazione dell’uomo morale è un costante tendere, così come lo intende Fichte, ed è in tale conato che l’uomo trova la propria eccellenza, e non già in ciò che cerca di far credere l’illuminismo utilitaristico. Tuttavia, le vedute di Kant e di Rousseau, pur vicine in alcuni punti, non possono essere certo intese come sinonimiche: per Rousseau è sufficiente lasciar riaffiorare il lato naturale dell’uomo (l’amor di sé e la pietà) e far sì che questi si abbandoni all’empito dei sentimenti; in tale prospettiva, il selvaggio è buono perchè meno soggetto alla riflessione e per ciò stesso più naturale e maggiormente abitato da buoni sentimenti rispetto a quell’uomo civilizzato che colonizza il mondo sconosciuto per esportare la sua pretesa civiltà. Del resto, la pedagogia di Rousseau – delineata nell’Emilio – si muove in questa sfera testè delineata e la sua ricetta consiste nel lasciar agire la natura in maniera tale che i fanciulli crescano naturalmente, cosicché la ragione è riequilibrata dall’emergere della dimensione naturale. Sull’altro versante, Kant è meno ottimista del suo collega francese ed allestisce una vera e propria gigantomachia, giacchè le inclinazioni sensibili sono a suo avviso in continua conflittualità con la legge morale: le passioni non sono mai del tutto debellabili, poiché i buoni sentimenti di cui parla Rousseau sono pure chimere prive di riscontro nella realtà; l’uomo – se vuole essere tale – è dunque tenuto a forzare la propria natura animalesca per conformarsi alla legge morale che gli detta la sua coscienza. Si tratta di un’autentica scalata alle vette dell’eroismo. Schiller fa a sua volta proprio questo punto di vista di derivazione rousseauiana e kantiana, e non lo abbandonerà mai, pur non accettandolo in toto e coniugandolo con la lezione di Winckelmann, che fu il primo – nel pieno infuriare della cultura illuministica – a guardare alla statuaria greca e a vedere qualcosa che già avevano visto i Rinascimentali: un’umanità profondamente diversa da quella contemporanea. La scultura greca raffigura “un’umanità nello stato dell’unità e della quiete” e le statue greche ci guardano dalla loro sufficienza, rievocando in noi i concetti di interezza e di perfezione: ci pongono dinanzi ad un’umanità in cui non v’è traccia dell’insoddisfazione tipica dei comuni mortali, ovvero un’umanità che sembra appagata della sua beatitudine e non tormentata dal bisogno né percossa da desideri; nelle statue greche non possiamo non scorgere una “nobile semplicità” e una “serena grandezza”, di contro ai meschini affanni che travagliano noi moderni, sicchè quella greca è una “bella umanità” e l’ideale di umanità che Schiller propone si configura appunto come mediazione dell’istanza kantiana – derivata da Rousseau – e di quella winckelmanniana: un’umanità cioè che sia al contempo morale e bella, agli antipodi di quella riflettente, calcolatrice e in preda ai suoi desideri e alle sue angosce, impossibilitata a sostare nel presente perché già sempre proiettata verso il futuro. Nelle Lettere sull’educazione estetica è ben rappresentata quest’esigenza di mediazione fra la moralità kantiana e la bellezza winckelmanniana attraverso un’educazione imperniata sull’arte, di cui Schiller si rivela espertissimo conoscitore. Bisogna però chiarire in via preliminare che cosa effettivamente sia la bellezza e come la intenda Schiller: che cosa essa sia, lo suggerisce il termine latino formosus (che significa appunto “bello”), contrapposto a deformis (“brutto”). La bellezza è forma piena e perfetta, mentre brutto è ciò che è solo in parte la forma che dovrebbe essere. Nelle Enneadi, Plotino si domandava significativamente: “dove sarebbe la bellezza se fosse privata della perfezione?“. Sicchè si può dire che essa sia il riverbero della forma perfetta ed è per questo motivo che – prosegue Plotino – “le cose belle ci incantano“: la forma seduce e piace allorchè è forma perfetta, ma dobbiamo allora chiederci che cosa si debba intendere per “forma perfetta”. Secondo Platone, essa coincide con l’idea, ovvero con quell’ente che esiste realmente – pur nella sua idealità – più di ogni ente empirico; secondo Aristotele, invece, forma perfetta è una certa essenza nella sua piena attuazione, che – in quanto tale – non sussiste mai: infatti, vi è sempre e comunque la materia a limitare la forma, cosicchè l’essenza aristotelica non è mai in pieno atto e dunque la forma perfetta è un ideale irraggiungibile. In entrambi i casi resta vero che la forma è l’universale che troviamo presente in una molteplicità di enti che costituiscono una specie a cui la forma conferisce identità; ne segue, allora, che ogni ente empirico è più o meno bello a seconda che sia più o meno se stesso. In una siffatta prospettiva, tuttavia, che ne è del bello artistico? L’arte è esibizione della bellezza e lo è (ciò vale tanto per Aristotele quanto per Platone) in quanto è imitazione della natura. Se così fosse, se ne evincerebbe che l’arte è mera riproduzione della bellezza naturale: in realtà, però, essa è piuttosto raffigurazione della bellezza in sé, è cioè imitazione delle forme universali. L’elaborazione classica del concetto di arte come mimhsiV della natura non comincia forse proprio con quell’aspra condanna platonica ai danni dell’arte stessa, imputata di essere copia di una natura che è a sua volta copia di un mondo intelligibile? L’arte, così intesa, va aborrita in quanto copia di una copia (mimhsiV mimhsewV): su tal concetto, Platone insiste nel libro decimo della Repubblica, in cui l’arte è condannata come mimhtikh tecnh: per un verso, essa è mera copia delle cose – e dunque non fa che allontanare dalla verità delle cose -, per un altro piace solamente perché ha funzione evasiva e titilla i sensi: quest’arte sortisce dunque un’inutile duplicazione del mondo empirico; eppure, accanto e parallelamente a questa concezione, ne troviamo un’altra in Platone, diametralmente opposta: e del resto – domandiamoci – non era forse egli stesso un artista di prima qualità? Leggendo certi suoi dialoghi (soprattutto il Simposio e il Fedro) non si ha forse l’impressione di essere di fronte ad un filosofo che fa della filosofia un’arte raffinatissima? Soprattutto nello Ione e nel Fedro, Platone fa balenare un’altra concezione dell’arte, per cui l’artista sarebbe ispirato direttamente – e anzi posseduto, in uno stato di mania – dalla divinità stessa, che dirige dall’alto la sua attività artistica. L’arte, così intesa, è vero e proprio contatto col divino: sicchè pare che possano in Platone convivere due antitetiche concezioni, cosicchè da una parte troviamo una pseudo-arte che imita un’imperfetta realtà, e perciò va condannata in quanto distoglie dalla conoscenza del vero; dall’altra, un’arte autentica, che, sotto la tutela della divinità, porta al contatto col divino. Solo questa seconda tipologia di arte imita la fusiV in quanto tale, ovvero la natura naturans, principio delle cose, e finisce così per imitare in forme sensibili (poesie, dipinti, ecc) qualcosa che sensibile non è. Nel De oratore (II, 7), Cicerone ci dà una ben riuscita descrizione di questo tipo di arte: “secondo me, nessuna cosa di qualsiasi genere è bella come il suo originale, ma quest’originale noi non possiamo percepirlo né con l’occhio né con l’orecchio, ma solo con lo spirito e col pensiero; perciò possiamo immaginare cosa tale che superi in bellezza le stesse sculture fidiache, giacchè quando Fidia creava lo Zeus o l’Atena non contemplava alcun uomo reale, ma il suo spirito era abitato da un’eccelsa forma di bellezza e questa egli contemplava dirigendo la mano e l’arte in base a siffatto modello“. Cicerone ci sta dicendo che l’artista non è mero copista e che l’opera d’arte è qualcosa di divino e di più rispetto alla realtà empirica preesistente alla quale l’opera d’arte fa riferimento. Da un lato, l’arte è inferiore alla natura, di cui è una pura e semplice copia – arrivando a sortire, nel migliore dei casi, una perfetta illusione -, dall’altro è superiore agli enti naturali in quanto corregge i limiti e le deficienze di tali enti, raffigurando qualcosa di più bello rispetto a ciò che esiste in natura. A tal proposito, così si esprime Quintiliano (Institutio oratoria, XII, 10, 70): “le opere di Policrate hanno dato alla figura umana grazia superiore al vero“, il che permette a Quintiliano di biasimare Demetrio per aver anteposto la somiglianza alla bellezza; ancora Senofonte – nei Memorabili di Socrate – sostiene che “la pittura sceglie, perché non è facile individuare un individuo del tutto esente da imperfezione“. Lo stesso Aristotele (Politica, III) asserisce che “un dipinto sommamente pregevole si distingue dalla realtà perché in essa è disperso ciò che nel dipinto è unitariamente raccolto”: se ne ricava che l’arte è emulazione e, insieme, superamento della natura, le cui imperfezioni sono prontamente corrette ed eliminate dalla mano divina dell’artista. Così Dione di Prusa ricorda che “nemmeno uno stolto crederebbe che lo Zeus olimpico di Fidia somigli per grandezza e beltà ad un comune mortale“, in quanto l’artista ha sì in certo modo raffigurato la natura, ma modificandola del tutto e cogliendola nella sua solenne perfezione. Nella metafisica platonica occupa un posto assolutamente centrale – come abbiam visto – la nozione di mimhsiV, che peraltro finisce per coincidere con quella di partecipazione: il mondo sensibile è immagine di un esemplare intelligibile corrispondente all’essere pieno e i singoli enti empirici sono quel che sono grazie all’idea a cui fanno capo. Il partecipare all’idea è ciò che fa sussistere gli enti sensibili, sicchè l’idea, pur restando se stessa, diventa gli enti partecipandosi e restringendosi. In questo senso, gli enti sono ideam diversimode imitantem, ciascuno di noi è imitatore dell’idea di umanità; mentre il mondo sensibile è ab alio, le idee sono ab se, cosicchè solo esse sono veramente e, se c’è qualcos’altro oltre ad esse, c’è solamente perché le idee lo fanno essere. Dobbiamo dunque presupporre le idee perché da sé il mondo sensibile non si spiega: così Caio, Tizio e Sempronio non possono essere assunti a spiegazione di ciò che essi stessi sono, giacchè ciascuno è di volta in volta solo il proprio modo di esser uomo e quindi non può mai esser la causa degli altri infiniti modi d’esser uomo: non avendo in sé la loro ragion d’essere, essa dovrà essere ricercata altrove, e più precisamente nell’iperuranico mondo delle idee, eterne, immutabili e corrispondenti al pieno essere, a differenze degli enti sensibili, che invece sono anfibi tra l’essere e il non essere, in quanto nascono e periscono. Se ne evince – se il ragionamento platonico non è zoppo – che i tanti enti sono quel che sono in virtù del fatto che l’idea corrispondente si partecipa, tramutandosi in essi pur restando se stessa, cosicchè finisce per esistere al contempo come eterna pienezza e come limitatezza empirica: gli enti empirici altro non sono, allora, che diverse varianti dell’idea, la quale, partecipandosi, si mima: significativamente, Tommaso d’Aquino asserisce che “in verità le cose superiori stanno alle inferiori secondo una certa qual deficiente similitudine”, giacchè l’idea, partecipandosi, crea dei suoi imperfetti imitatori: da grande che è, si fa piccola. Su quale sia l’obiettivo di questa partecipazione in forza della quale trae origine il nostro mondo, Platone tace. Certo è però che le idee, in quanto perfezione assoluta, corrispondono alla bellezza, ed è per questa ragione che i Neoplatonici propongono un’autentica forma d’arte che sia imitazione diretta dell’idea nella sua accecante perfezione: in questo senso, l’artista intuisce i princìpi stessi dell’essere, e a differenza del filosofo riesce ad incarnare sensibilmente quest’intuizione. Stante questa superiore forma d’arte – superiore appunto a quella condannata da Platone nella Repubblica, imputata di esser mera copia di una copia -, bello naturale e bello artistico potranno essere distinti come due diversi modi di empirizzazione dell’idea del bello, in cui decisivo è che il bello artistico supera di gran lunga quello naturale, poiché non v’è dubbio alcuno sul fatto che l’idea sia più presente nelle opere d’arte che non nella natura e ciò conferisce all’artista lo speciale statuto di creatore, in quanto quella che egli produce è una seconda e migliore partecipazione delle idee nell’imperfetto mondo sensibile, idee che sono da lui colte in maniera più vivida ed è proprio in ciò che risiede il miracolo dell’arte: essa è più reale – e dunque più bella – della realtà naturale stessa. Da qui scaturisce il carattere rivelativo dell’arte: a tal proposito, Plotino dice nelle Enneadi che “le statue rappresentano divinità o uomini; se sono statue di uomini, allora sono non di una qualunque persona da noi prediletta, ma di una tale persona che soltanto l’arte possa ritrarla“. Troviamo, da un lato, un’arte mimetica – e falsa – e, da un altro, un’arte euretica, che trova e scopre le idee, senza macchiarsi della colpa di imitazione della natura sensibile. Più in generale, all’arte compete dunque una natura ancipite: per un verso è apertura e svelamento del mondo delle idee, ma dall’altro presenta sempre il rischio di essere un velo alle idee e perciò la filosofia – priva di tale rischio – resta comunque ad un livello superiore. Con Aristotele la prospettiva estetica va incontro a radicali trasformazioni: convinto che per spiegare questo mondo quale appare ai nostri sensi siano sufficienti le sue eterne componenti – la materia e le forme -, egli sostiene che non è necessario far riferimento ad un presunto mondo iperuranico: al contrario, per comprendere davvero il nostro mondo, non bisogna uscire da esso, in quanto è pienamente comprensibile in se stesso. Nella fattispecie, Dio – l’atto puro, il pensiero di pensiero – è il magnete che mette in moto il mondo nella sua eternità, e tutte le cose che lo popolano si sforzano di essere pienamente se stesse imitando la perfezione di Dio, cosicché gli enti sono in un interminabile cammino verso la loro piena attuazione. Dal canto suo, in un siffatto mondo, l’imitazione ha funzione operativa: essa descrive un produrre proprio degli animali e specialmente dell’uomo, che di essi segna il punto più alto in quanto equipaggiato di ragione; in particolare, l’uomo è naturalmente portato ad imitare, in quanto trae diletto dal riconoscere e dal comprendere. Ne segue che – come nota Aristotele nella Poetica – l’arte è mimhsiV e lo è in senso positivo, giacchè imita sì il particolare, ma universalizzandolo. In particolare, l’arte rappresenta non già che cosa singolarmente è accaduto, bensì il verosimile: ci mette dinanzi non a cosa si è verificato una sola volta, ma a ciò che può verificarsi sempre e comunque in ogni individuo e in ogni tempo. Pertanto Achille ed Ettore non sono mai esistiti, ma non di meno Omero ha detto la verità, giacchè essi esistono in vario grado in ciascuno di noi. Dell’universale quale è colto dall’arte, poi, possiamo abbozzare un’idea in questo modo: essa ci suggerisce che ad un individuo di tale natura ( o toioutoV) accade di fare e di dire cose di tale natura, in corrispondenza alle leggi della verosimiglianza; proprio a ciò mira la poesia, sebbene poi ai suoi personaggi metta dei nomi che sembran farle perdere quel carattere di universalità che le è peculiare. Sull’altro versante, si ha il particolare quando, anziché dirmi le cose quali potrebbero accadere (oia an genoito) ad un uomo come Edipo o come Aiace (come fa l’arte), mi si dice che cosa concretamente fece (ti epraxen) Alcibiade in quel determinato momento storico. Viene in questo modo da Aristotele segnata la spaccatura tra l’arte, mirante all’universale, e la storia, saldamente ferma ai particolari, enunciati in via cronachistica: di contro ad un’arte che ci dice cosa potrebbe accadere a noi che siamo affatto simili agli uomini che vediamo in scena nelle tragedie, la storia raffigura l’individuo nella sua accidentalità e nella sua particolarità, ed in ciò essa si rivela incommensurabilmente inferiore rispetto all’arte, che è – dice Aristotele – “più filosofica” di essa e, dunque, più veritiera. Stando così le cose, l’ira di Achille altro non è se non l’ira in tutte le sue sfumature, nella sua generalità universale. Sia per Platone sia per Aristotele, dunque, l’arte è tale nella misura in cui imita l’universale: quest’ultimo, poi, per i Platonici coincide con l’idea, per gli Aristotelici con la forma che l’artista raffigura nella sua piena e ideale attualità, in tutte le sue molteplici sfaccettature. In questo senso, l’arte è trasfigurazione della natura tale per cui se ne mostra una perfezione che la natura stessa, di per sé, non avrebbe: è, in altri termini, l’ideale perfezione cui la natura tende e che l’arte anticipa. Quando Aristotele asserisce che l’artista raffigura l’universale, sostiene che a cogliere tale universale egli perviene nello stesso modo in cui vi perviene il filosofo: per un tratto questi procede per induzione, considerando cioè svariati casi individuali; successivamente, egli passa all’astrazione, chè se restasse al livello dell’induzione il suo processo andrebbe avanti all’infinito. Grazie all’astrazione, egli ricava dai tanti casi singolari presi in esame la forma comune. Similmente, l’artista – che al pari del filosofo mira all’universale – paragona fra loro i tanti uomini empirici e poi, per astrazione, riesce a scorgere in essi la forma uomo. Con dire aristotelico, Vasari così si esprime: “perché il disegno padre delle tre arti nostre procedendo dall’intelletto, cava di molte cose un giudizio universale; simile a una forma ovvero idea di tutte le cose della natura, la quale è singolarissima nelle sue misure; di qui è che non solo nei corpi umani e degli animali, ma nelle piante ancora, e nelle fabbriche e sculture e pitture, conosce la proporzione che ha il tutto con le parti fra loro e col tutto insieme. E perché da questa cognizione nasce un certo concetto e giudizio, che si forma nella mente quella tal cosa che poi espressa con le mani si chiama disegno, si può conchiudere che esso disegno altro non sia che una apparente espressione e dichiarazione del concetto che si ha nell’animo, e di quello che altri si è nella mente immaginato e fabbricato nell’idea” e il disegno altro non è se non la traduzione del concetto nel sensibile. Similmente, parecchi secoli prima, Dionigi di Alicarnasso aveva raccontato le vicende dell’artista Zeusi e delle vergini di Crotone: incaricato dagli abitanti di Crotone di dipingere Elena in maniera da rappresentare il canone della bellezza femminile, egli da più corpi di donne trasse quanto di perfetto essi avevano; sotto questo profilo, la sua è una costruzione dell’intelletto frutto dell’induzione e dell’astrazione, in quanto, partito da cinque corpi femminili empirici, arriva alla bellezza femminile nella sua piena attuazione. Ancora Federico Zuccari così scriveva nella sua L’Idea de’scultori, pittori e architetti (1607): “se io voglio intendere che cosa sia il leone, è necessario che il leone da me conosciuto sia termine di questa mia intellezione; non dico il leone che corre per la selva […] ma dico una forma spirituale formata dall’intelletto mio“. L’artista viene allora a configurarsi come un visionario che vede la bellezza, ovvero la perfezione della forma, e la fissa su materiale sensibile, cosicché le opere d’arte non sono che visioni della bellezza offrentisi alla contemplazione dei fruitori: e la dottrina dell’arte classica – che va dall’umanesimo al romanticismo – poggia su tali presupposti. Plotino dice che “se si disprezzano le arti perché imitatrici della natura, bisogna dire che la natura stessa imita; quindi si deve riconoscere che esse non riflettono solo il visibile, ma si richiamano ai princìpi [le idee] da cui la natura trae per proprio conto le sue origini“: la natura è, in quest’accezione, sensibilizzazione delle idee e l’arte altro non è se non una diversa e migliore apparizione sensibile delle medesime, tanto più che le arti sono per loro stessa natura detentrici della bellezza. Da ciò scaturisce la celebre tesi plotiniana secondo cui “Fidia non ha creato il suo Zeus secondo una realtà visibile, ma così come Zeus stesso apparirebbe se si volesse manifestare ai nostri occhi“: per l’appunto, Zeus si è manifestato agli occhi di Fidia, dando prova di come l’arte superi la natura ed in ciò consista il miracolo dell’arte. Nel Quattrocento, Leon Battista Alberti, nel suo trattato Della pittura, si esprimeva aristotelicamente dicendo: “et di tutte le parti, gli piacerà non solo rendere similitudine ma più aggiungervi bellezza“, a sottolineare come la bellezza stessa non risieda in una pedestre imitazione della natura quale appare ai nostri sensi; tanto più che “nella pittura la bellezza non è tanto gradita quanto richiesta“. D’altro canto, Giovan Pietro Bellori – con il suo L’idea del pittore, dello scultore e dell’architetto (1672) – è il fautore della dottrina classica in Italia e la trasmette fino al neoclaccisismo tedesco: “ciò che l’artista raffigura nelle sue opere è l’idea che originata dalla natura supera l’origine e fassi l’originale dell’arte“, come se l’originalità dell’arte stesse nel suo superare la natura e nel perfezionare ciò che in essa è imperfetto. “L’idea costituisce il perfetto della bellezza naturale e unisce il vero al verosimile delle cose sottoposte all’occhio” dell’artista che ne vede la perfezione, “sempre aspirando all’ottimo e al maraviglioso“, onde non solo emula, ma si fa superiore alla natura “palesandoci le opere sue eleganti e compite quali essa non è solita dimostrarci perfette in ogni parte“. E Bellori, sulla scia dell’esempio addotto da Dionigi d’Alicarnasso a riguardo delle vergini crotonate, porta due esempi significativi: per dipingere una bella donna se ne devono vedere diverse, che sian tutte belle; ma, in assenza di belle donne, occorre saper vedere la bellezza in sé, saltando la fase dell’induzione e passando direttamente a quella astrattiva. Così Guido Reni – narra Bellori – dipingeva la bellezza non quale si offriva agli occhi, ma quale la vedeva nell’idea, poiché in natura le cose non possono mai esser perfette. In questo senso, l’artista vede l’enteleceia, il fine perfettamente attuato delle cose ch’egli raffigura; la famosa battuta di Wilde, secondo cui non è l’arte che imita la natura, ma è la natura che imita l’arte, ben si inquadra nei princìpi di questa specie di koinh platonico/aristotelica di cui stiam parlando: l’arte raffigura infatti le idee e il teloV, e la natura non può che imitare l’arte. Similmente si esprimono Ovidio (Metamorfosi, III, 158) e Torquato Tasso (Gerusalemme liberata, XVI, 10). Per Bellori, dunque, l’arte raffigura gli uomini non quali sono, ma quali dovrebbero essere, sicchè mentre l’imitazione riproduce le cose empiriche, l’arte ci fa veder con l’occhio intelligibile le cose che ancora non si vedono. In sintonia con questi princìpi, Bellori dà una precisa definizione della bellezza classica, asserendo che essa non è altro che “quella che fa le cose come sono nella loro propria e perfetta natura, la quale gli ottimi pittori si eleggono contemplando la forma di ciascuno“: tale bellezza è dunque “la perfetta cognizione della cosa cominciata sulla natura“, cioè iniziata induttivamente e conclusa per via astrattiva. Nel 1584, Gerolamo Fracastoro pubblica il Navagero, ovvero della poetica, un dialogo in cui tratta delle affinità e dei contrasti tra il filosofo e l’artista: mentre il filosofo ha di mira solamente l’apprendimento, il poeta “non è mosso da alcun altro fine che di esprimere bene assolutamente ciò che si è proposto“; ciò che questi cerca nel raffigurare le cose è la bellezza, quella dell’universale. Perciò quel che i pittori e i poeti aggiungono non è estraneo all’oggetto considerato, ove lo si consideri perfetto e animato quale lo considerano i sommi artisti. Al 1561 risale la Poetica di Giulio Cesare Scaligero, che presenta i poeti come coloro che trovano cose che restano celate agli altri e, a tal proposito, Scaligero cita Virgilio, additandolo come altera natura, ovvero come una “seconda natura”, giacchè nelle sue opere troviamo una natura perfezionata: ne segue allora che il mare lo vediamo meglio nei versi di Virgilio che non quando siamo in spiaggia. Il succo del discorso di Scaligero è che non dobbiamo accontentarci di apprendere dalla natura le cose quali essa ce le fornisce, ma dobbiamo interpretarle come se dovessimo noi darle una legge. Dai molteplici aspetti della natura, dobbiamo trarne una perfezione inesistente in ciascun singolo, cosicchè per esser poeti non basta saper verseggiare, bensì occorre essere scopritori di cose mai viste ed è qui che si insidia il precetto – di derivazione oraziana – della doctrina iucunda, incentrata sul docere attraverso il delectare: si tratta, appunto, di insegnare la verità dilettando, in quanto si raffigura quella bellezza coincidente col buono e col vero. In questo senso, ars est simia veri (“l’arte è scimmia del vero”), oltrechè simia naturae, ed è questo un motto che si trascina dagli antichi fino ai moderni. Il senso originario di tal motto è negativo e si riferisce a quegli attori che praticavano un naturalismo esasperato: Aristotele stesso (Poetica, 26) cita beffardamente un tale Callipide che recita in questo modo scimmiesco, calandosi del tutto nella parte assegnatagli: ancora una volta, qui affiora la concezione dell’arte come deteriore imitazione della natura, quella concezione contro cui si era apertamente scagliato Platone. Un altro motto sulla linea dei suddetti è quello secondo cui simia est morum hypocrisis (“l’ipocrisia scimmiotta i buoni costumi”). La prospettiva viene però ribaltata già a partire da Dante, il quale afferma (Inferno, XXIX, 139): “com’io fui di natura buona scimia“; lo stesso Filippo Villani – nella sua Cronaca di Firenze – definisce Stefano, l’allievo di Giotto, come simia naturae, facendo propria la valenza positiva attribuita da Dante a tale espressione. Il classicismo è così detto dal latino classis, che designa la “classe”, ciò che pertiene ad una classe eccellente, sicchè l’arte, se è tale, è sempre classica, poiché propone sempre modelli e gli artisti son tutti dei classici (in ciò risiede la loro esemplarità), con conseguenze latamente etiche: il classicismo finisce per essere al contempo un’estetica e un’etica, è la teoria dell’arte classica ma anche dell’uomo classico. In quanto raffigurazione della natura, l’arte è caratterizzata né da un’assoluta originalità né da un’irripetibile individualità: è, allora, una relativa originalità dell’artista, capace di una visione preclusa agli uomini comuni e che egli condivide solo col filosofo. Nella variante aristotelica, poi, l’arte imita il verosimile, la perfezione della natura è un eterno da scoprire, giacchè è sempre iscritto come possibilità nella natura stessa, senza che si crei nulla di nuovo: semplicemente, si esplicita qualcosa di già implicito nella natura e rispetto a cui l’artista ha funzione maieutica. Sia i Platonici sia gli Aristotelici parlano di meraviglie paradisiache dell’arte, senza però far riferimento ad una meraviglia che trascenda la natura: al contrario, tale meraviglia resta inscritta nel suo orizzonte. Pertanto l’artista è costretto dal modello, e questa è la precettistica inerente all’arte. Il momento inventivo è contenuto in quello imitativo, cosicché la vera creatività è possibile solo come imitazione dell’esemplare e, in tale prospettiva, non v’è posto per un’irripetibile individualità come requisito indispensabile dell’artista: l’intuizione artistica presenta, allora, qualche analogia con l’anamnesi platonica, oltrechè con l’induzione aristotelica; si è artisti in quanto si accede al punto di vista universale, non ci si lascia imprigionare dalla propria personalità, ma ci si svincola da essa, manca ogni arbitrio e ogni stranezza. Deve essere oculatamente bandito dalle opere d’arte ogni eccesso e i particolari che sviano dall’universale, altrimenti si finisce per mimare la natura nella brutalità dei suoi dettagli, abbandonandosi ad un rozzo naturalismo. Lo scopo dell’arte non è dunque quello di stupire e di colpire, in quanto lo stupore è l’effetto prodotto da ciò che supera le nostre capacità (esempio tipico di stupore è quello prodotto dal prestigiatore); al contrario, lo scopo autentico dell’arte è di destare in noi la meraviglia, il qaumazein che – a dire di Platone e di Aristotele – accende la filosofia, un po’ come il motto cristiano del “timor Domini, initium sapientiae“; è cioè qualcosa che ci sbalordisce sempre in forza della sua infinitezza. In quanto raffigurazione dell’universale, l’arte deve evitare le intromissioni soggettive, le quali recherebbero danno alla sua universalità; l’artista deve dunque essere in funzione dell’opera d’arte, e non viceversa: ciò spiega il mancare delle firme nei quadri fino a fine Settecento, quasi come se la firma nuocesse all’universale e permettesse all’artista di fare una deleteria irruzione nella sua opera. Ne segue la “normatività” dell’estetica: l’artista prima deve scoprire il modello della sua raffigurazione e poi deve attenersi ad esso; ciò significa che l’opera d’arte raffigura sempre qualcosa. La prima regola è la verosimiglianza con il meraviglioso, la seconda sarà quella della convenienza, ossia l’attenersi alla naturalezza (se devo raffigurare un vecchio, deve essere un vecchio e non un giovane), la terza sarà invece la norma delle tre unità, tale per cui se l’opera d’arte deve essere un tutto compiuto, allora deve avere unità di tempo, di luogo e di azione. Infine, la quarta regola sarà quella dell’umanesimo, tipico del classicismo: l’uomo è il più alto soggetto dell’opera d’arte, il più degno da imitare, giacchè egli è in natura l’ente più complesso e, in virtù della sua razionalità, compendia l’universo intero entro di sé. In quanto più ricca, la forma umana è anche la più bella: ciò si traduce però non tanto in ritratti (dove si indulge all’eccessiva somiglianza), ma nella pittura di storia, l’epica, la scultura raffigurante divinità. Stando così le cose, i due nemici dell’arte classica sono il manierismo e il naturalismo. Il dipingere di maniera è un dipingere soggettivo sottraentesi all’imitazione della natura (così Parmigianino dipinge le Madonne raffigurandole con un collo oltremodo lungo), fa prevalere il fantasticare soggettivo, mettendo in luce – a dire di alcuni critici – la debolezza della mano e dell’intelligenza dell’artista. In origine, maniera era il modo di procedere di un certo artista, sicchè si parla di maniera francese, italiana, inglese; nel classicismo, tuttavia, diventa un termine negativo che indica il dipingere di polso, più con la mano che con la testa. A tal proposito, scrive il già citato Bellori: “gli artefici, abbandonando lo studio della natura, viziarono l’arte con la maniera o, vogliamo dire, con la fantastica idea“; in questo senso, allora, la poesia lirica è la forma d’arte che più rischia di scadere nel soggettivismo. Per quel che riguarda l’altro grande nemico di ogni arte – il naturalismo -, si può con certezza dire che Caravaggio fu il primo esempio di questa pittura fuorviante, corrotto – stando a quel che attestano i critici – dai pittori olandesi raffiguranti i “bamboccianti” (lo spazzacamini, il dentista, ecc), tratteggiati con gretta aderenza al vero. Dal canto suo, l’arte classica si situa aristotelicamente a metà fra naturalismo e manierismo: di ciò è infallibile prova l’arte degli antichi, naturale e al contempo più che naturale, in quanto attiene alla natura colta nella sua perfezione; ecco perché è opportuno, ad avviso dei neoclassici, imitare gli antichi, questi maestri nella corretta imitazione della natura; imitarla significa procedere secondo ragione, in maniera simile a quella del filosofo – seppure senza la consapevolezza che di esso è tipica -, e secondo quel buon senso identificantesi con la razionalità stessa. E’ infatti la ragione a distinguere il sostanziale dall’accidentale, l’eterno dal temporale, il necessario dal contingente, cosicchè imitare gli antichi equivale ad apprendere la lezione di ragionevolezza e di buon senso estetico che essi ci hanno lasciato, in senso sia etico sia teoretico (in virtù dell’identità fra buono, bello e vero). Sotto questo profilo, gli antichi ci hanno tramandato una precettistica basilare e insormontabile: essi furono i primi ad aver correttamente sviluppato la ragione anche in sede artistica, riuscendo in quella perfetta imitazione della natura che insieme diletta e stupisce; ne segue che il richiamo ad essi come modelli da seguire diventa automaticamente richiamo all’eterna ed universale ragione, con l’inevitabile conseguenza che tra antichi e moderni non v’è frattura, sempre che questi ultimi non si abbandonino ai capricci e alle stravaganze del loro arbitrio soggettivo. Così Racine – nella prefazione all’Ifigenia in Aulide – constata un’assoluta identità fra l’antichità e la modernità e, paradossalmente, fra l’attuale Parigi e l’antica Atene: “ho avuto modo di compiacere grazie all’effetto che ha prodotto sul nostro teatro tutto ciò che ho imitato da Omero e da Euripide; il buon senso e la ragione erano gli stessi in tutti i secoli: il buon gusto di Parigi è risultato conforme a quello di Atene“. Anche il grande teorico del classicismo francese Boileau – nell’Arte poetica – così scrive: “amate la ragione: nulla è bello se non il vero“; lo stesso Diderot diceva: “non mi stancherò mai di gridare ai nostri Francesi: la verità, la natura, gli antichi“. Tesi del tutto analoghe troviamo nel Saggio sulla critica (1771) di Pope e nelle Riflessioni sopra il buon gusto nelle scienze e nelle arti (1708) di Ludovico Antonio Muratori, il quale va sostenendo che il buon gusto dell’artista altro non è se non la retta ragione, quasi una sorta di istinto di essa. Se ne ricava, allora, che il buon gusto è l’attitudine al vero e al bello che gli uomini di gusto (filosofi e artisti) possiedono innatamente, senza che sia possibile apprenderli. Ben si può capire, allora, di qual rilevanza siano gli esiti etici dell’estetica così intesa: l’arte raffigura la perfezione della natura e, dunque, l’uomo – che della natura è il vertice – nella sua universalità, come modello a cui tendere e a cui conformarsi, cosicchè l’arte non fa che mettere il contemplatore dinanzi al proprio paradigmatico modello, ossia di fronte ad un’umanità pienamente attuata, in cui razionalità e sensibilità hanno trovato una così perfetta composizione che la ragione riesce a trasformar le passioni in virtù, con la conseguenza che in esso la ragione può temperare le passioni e conciliarle. Questo è, in sostanza, il modello aristotelico dell’arte e della sua funzione catartica: un po’ più complicata è invece la questione relativa alla variante platonica, in cui la dimensione sensibile finisce per essere enigmaticamente sussunta in quella razionale; l’eros, che inizia come amore sensibile e fisico, si trasforma gradualmente in amore per la bellezza intelligibile, innalzandoci dall’eros per le singole cose sensibili a quello intelligibile per la bellezza in sé. Ciò per Platone non significa che la sensibilità sia stata o debba essere repressa – tale è invece l’amor platonico quale è inteso in età medioevale -, ma, semplicemente, che si sia trasfigurata, giacchè la vita sensibile altro non è se non una deficiente modificazione della vita intelligibile, cosicchè, nella sua ascesa dal sensibile all’iperuranico, non viene in alcun modo repressa la dimensione sensibile, ma la si riconduce a quella – di più alto livello – intellettuale. Sicchè è facile capire perché le statue greche non ci raffigurino mai l’uomo perfetto colto nel suo sforzo, ma, viceversa, sempre oltre ogni tensione, in una perfezione ormai raggiunta: è questo l’emblema del trionfo riportato dalla ragione sulle passioni, sue accanite nemiche ormai debellate, cosicchè la ragione quale trasuda dalle statue greche è colta al di là di ogni antagonismo con esse: l’uomo perfetto così inteso è un tutto armonioso ed è perciò espressione di una bella umanità perfetta, in uno stato di beatitudine che si è sviluppato solo in forza della ragione stessa, infallibile vincitrice delle passioni. Ci troviamo pertanto di fronte ad un uomo autosufficiente ed appagato, che è tale stabilmente, senza essere travagliato da sforzi, bisogni o disagi: questa bellezza dell’anima non può non riverberarsi anche sul corpo. A tal proposito, Schiller dirà che la bellezza interiore traspare anche all’esterno in veste di grazia, attraverso un corpo spiritualizzato e transumanizzato: cosa, questa, segnalata nelle statue antiche dall’assenza di peli o di vene; è, in certo senso, l’antico ideale del kaloV kagaqoV che ritorna, quell’ideale per cui ciò che è buono non può non essere bello, e viceversa. Ciò spiega anche perché, nella statuaria antica, torni con tanta frequenza la figura dell’eroe e non dell’uomo comune: l’eroe è l’uomo perfetto nella realizzazione di se stesso ed è perciò mirabile, un uomo quale nella natura sensibile non esiste né mai potrà esistere; sicchè, entro qualche misura, questi eroi affascinanti e beati, più divini che umani, possono destare in noi – imperfetti mortali – una certa antipatia, dovuta all’inumana astrattezza che li avvolge nella loro quieta imperturbabailità; e così finiamo per provare maggior simpatia per l’umanissima Didone, preda di un’insana passione del tutto umana, che non per l’iperuranico ed eroico Enea, perfetto, sì, ma troppo lontano da noi per essere francamente apprezzato. La definizione di Winckelmann delle statue greche come espressione di “nobile semplicità e serena grandezza” calza allora a pennello: semplicità nel senso di essenzialità, universalità e non esagerazione, naturalezza e spontaneità, naturale sviluppo di una forma verso la sua perfezione; grandezza, invece, nel senso di onnicomprensività, magnanimità, frutto di un animo lungimirante che tutto abbraccia e nulla esclude, una grandezza serena che è tale poiché di nulla abbisogna. Ciò si traduce nello sguardo di beata introversione con cui queste statue ci osservano, paghe della propria perfezione, in antitesi con la lacerazione che caratterizza gli uomini comuni. L’interruzione medievale – con il suo temporaneo smarrimento del mondo antico – non implica tuttavia una frattura nella continuità che lega antichi e moderni grazie alla ragione di cui essi sono parimenti dotati; ed è per questo motivo che il neoclassicismo settecentesco condivide, per un verso, la concezione del ritorno agli antichi come riattualizzazione della ragione, ma, per un altro verso, presenta spiccate varianti nazionali: così in Francia e in Germania esso si rivela particolarmente interessato alla sfera etica, prendendo gli antichi a modello di comportamento. Ma – chiediamoci – da dove trae origine questo improvviso interesse per il mondo greco? Soprattutto dagli scavi di Ercolano e di Pompei che si stavano a quei tempi realizzando e che inducono a far cambiare radicalmente i gusti per quel che concerne l’arredo: dal barocco si passa rapidamente alla linea dritta, con un maniacale attaccamento allo stile greco. I Francesi, poi, guardano soprattutto alle virtù civili e repubblicane degli antichi, che sono una “scuola di costumi” (Diderot) da prendere come esempio per il proprio comportamento; così gli eroi di cui parla Plutarco nelle sue Vite parallele (Muzio Scevola, Attilio Regolo, ecc) assurgono ora – grazie soprattutto ai capolavori di David – a modelli comportamentali imprescindibili per i Francesi; è, in certo senso, la borghesia che rivendica i suoi diritti di contro ad un’aristocrazia sempre più antiquata e soffocante, che si ostina a conservare un ruolo che più non le compete, coprendosi sempre più spesso di ridicolo, come lascia trasparire Parini in Il giorno. Il proposito è dunque quello di edificare con l’arte il cittadino, ed è in questo clima che nasce e si sviluppa a dismisura il museo, come luogo di conservazione e di tesaurizzazione di questi modelli greci che non finiscono mai di istruirci. Sull’altro versante, il neoclassicismo tedesco non guarda tanto alle virtù civiche quanto piuttosto all’uomo greco in quanto tale, oggetto di ammirazione, imitazione e nostalgia: la bella umanità dei Greci suscita un profondo senso di nostalgia e di rimpianto, e ad attirare i Tedeschi non è la filosofia o l’arte greca in quanto tali, ma è l’uomo greco stesso, nella sua perfezione stupefacente, di contro al classicismo rinascimentale che invece si proponeva di riattualizzare innanzitutto la cultura antica. Ciò implica un’accesa polemica contro il cristianesimo in favore della cultura greca (o, meglio, dell’uomo greco), sfociante in un generalizzato tentativo di tornare ai greci imitando le loro opere: la cosa forse più interessante è che i Tedeschi imitano le opere greche in maniera funzionale, e, più precisamente, per cercar di essere Greci, quasi come se ciò fosse il tramite che conduce all’imitazione di quell’umanità. La stessa bellezza dell’arte greca è del tutto dovuta alla bellezza di cui gli uomini greci rifulgevano in modo abbagliante: un’arte che ci presenta in maniera sorprendente l’uomo quale deve essere, forse quale veramente è stato e, magari, quale potrebbe tornare ad essere. Là dove interviene la nostalgia, essa non fa che segnalare che c’è stata una frattura tra il presente ed il passato, a cui si vorrebbe tornare, consapevoli di quanto esso fosse diverso (e migliore): da ciò si evince come gli antichi fossero altri rispetto ai moderni; in particolare, la differenza è data da una diversa esperienza della finitezza. Infatti, quella greca è un’umanità capace, pur nei propri limiti, di una pienezza d’essere pressoché divina in cui trovare appagamento, sicchè a quell’umanità resta completamente estranea la percezione della propria finitezza come di un limite al raggiungimento della propria perfezione (cosa peraltro su cui Nietzsche avrà da ridire): ai Greci manca, dunque, quell’anelito all’infinito che caratterizza la dilacerata umanità dei moderni, consapevoli della propria limitatezza e, perciò, infelici. Ciò che ai greci manca è la consapevole distinzione tra finito e infinito, distinzione di cui solo la filosofia greca è conscia: ma la filosofia greca, per quanto importante, non può essere in alcun caso fatta coincidere con l’uomo greco in quanto tale, quale lo troviamo nell’epoV omerico. Si tratta in certo senso di un’autentica greco-mania dilagante nella Germania di quegli anni, in cui i più vivaci ingegni avvertono la propria finitezza di moderni come un doloroso limite al raggiungimento della perfezione, onde il loro anelito all’infinito. Così scrive Herder: “i greci non ammettevano nessuna sfrenatezza, si fosse anche trattato di indagini su Dio; ritenevano anzi che queste ultime fossero contrarie alla natura dell’uomo, alla misura delle sue forze, alla durata della sua vita […]. Ciò che s’aveva da fare era riconoscere la propria dimensione umana […]. Si direbbe che noi abbiamo alquanto perso di vista i placidi contorni di questa esistenza umana, giacché a quei limiti preferiamo di gran lunga l’infinito e crediamo che l’unica occupazione della Provvidenza debba essere di sottrarci a quei limiti“. Nel 1805, Goethe scrive un saggio su Winckelmann e il suo secolo, in cui afferma: “mentre l’uomo, moderno quasi in ogni sua meditazione, si lancia verso l’infinito per poi far ritorno – quando gli riesce – ad un punto delimitato, gli antichi, senza perdersi in ulteriori deviazioni, si sentivano immediatamente e pienamente a proprio agio entro gli amabili confini di questo che era un mondo bello“. Augusto Gustavo Schlegel così si esprime in merito: “presso i Greci, la natura umana era autosufficiente e non aspirava ad altra perfezione che non fosse quella realmente raggiungibile con le proprie forze […]. Nella prospettiva cristiana tutto si è capovolto […]. La poesia degli antichi era poesia del possesso, la nostra della nostalgia“. Scrive ancora Federico Schlegel: “l’antichità è compiuta rappresentazione della vita, reale conciliazione di finito e infinito, e, perciò, immune dal loro conflitto” e quindi da ogni tensione del finito verso l’infinito; nel mondo greco viene ravvisato un autentico teomorfismo in cui l’uomo, perfetto, può bearsi di se stesso, in quanto egli è, in primis, pieno e armonico sviluppo di tutte le parti umane, cosicchè “solo l’armonica temperanza di tutte le facoltà può produrre uomini felici e perfetti” (Schiller) ed è appunto in ciò che risiede la perfetta natura dei greci di cui parla Winckelmann. Federico Schlegel così si esprime: “come nell’animo del Diomede omerico tutte le forze si accordano perfettamente, così l’intera umanità si sviluppò in Grecia in maniera armonica e perfetta“, poiché risultato dell’armonia di tutte le facoltà. In secundis, il prodursi di siffatta armonica perfezione non poteva che essere naturale, ossia immediato e irriflesso. “Il moderno ebbe assegnato dall’intelletto che tutto separa le proprie forme“, nota Schiller, e di conseguenza “il moderno non sviluppa mai l’armonia del suo essere” a causa della riflessione, sicchè mentre il moderno è dominato dal nefasto intelletto, “l’individuo greco ebbe assegnate le sue forme dalla natura che tutto unisce“. Federico Schlegel asserisce a tal proposito che “l’arte greca è libera dalla signoria dell’intelletto” e perciò non è impacciata dalla riflessione intellettuale e può svilupparsi liberamente alla stregua di un organismo; infatti – prosegue Schlegel – “in Grecia la bellezza crebbe senza cure artificiali e – per così dire – allo stato brado. Sotto questo cielo felice, l’arte figurativa non fu abilità appresa, ma natura originaria; la sua formazione non fu che il liberissimo sviluppo di una felicissima disposizione“. La contrapposizione tra la cultura naturale degli antichi e quella artificiale dei moderni non può non richiamare alla memoria Rousseau e la sua tesi, seppur qui arricchita dal mondo greco. L’intelletto produce infatti indebite divisioni e mescolanze, cosicchè all’armonia dell’uomo greco doveva corrispondere una coscienza in cui la riflessione discorsiva ancora non spadroneggiava ed egli si trovava sospeso in una percezione beatifica della propria perfezione naturale, a tal punto che – per dirla con Schiller – “quell’uomo era uno con se stesso e felice nel sentimento della propria umanità“, di contro alla riflessione che distingue e contrappone finito ed infinito, dando all’uomo la dolorosa percezione della propria limitatezza. Tale riflessione mancava ai greci e, quindi, presso di loro non vi era contrapposizione tra sensibilità e ragione né, di conseguenza, il prevalere dell’una sull’altra, come invece avviene ai moderni, divisi o per un unilaterale sviluppo del sensismo materialistico o per via di un unilaterale razionalismo sfociante nel rigorismo etico a cui era approdato Kant. I Greci di cui qui Winckelmann, Schiller, Schlegel e Goethe parlano non sono tuttavia quelli della filosofia – anch’essi già alle prese con la riflessione -, ma piuttosto quelli di Omero e della statuaria, cosicchè la filosofia greca subentra come un elemento di disturbo proveniente dall’Oriente, e non tanto come una componente che porta all’apice il mondo greco. Già nella tragedia e nella poesia lirica, del resto, si palesa la contrapposizione tra finito e infinito, quella contrapposizione che porterà alla morte dell’umanità greca. Per i filosofi greci – perfettamente consapevoli della distinzione tra finito e infinito – la perfezione dell’arte è già un ideale, e non qualcosa di realmente esistente nella natura, tant’è che l’artista è da essi concepito come colui che raffigura una perfezione fittizia, che mai potrà darsi in questo mondo. Secondo Winckelmann, invece, l’artista greco non faceva altro che cogliere l’umanità greca nella sua reale (e non ideale) bellezza, dando vita a statue raffiguranti un uomo perfetto che è tale perché non ancora signoreggiato da quella riflessione che, dove presente, rende insicuri e sofferenti. Merito storico di Winckelmann è soprattutto la scoperta e la rivelazione della grecità e della sua perfezione; egli intende se stesso, più che come archeologo o storico dell’arte, come pedagogo che rivela l’uomo greco e tale è lo scopo che affida alle sue veementi descrizioni delle opere greche; la grecità quale egli la concepisce non è un passato ineluttabilmente trascorso, ma è piuttosto una forza viva e presente, un modo d’esser uomini che può e che deve tornare ad essere operante, educando l’uomo a raggiunger la sua vera umanità. Nei suoi scritti – soprattutto in Storia dell’arte e dell’antichità (1764) -, Winckelmann attacca duramente il barocco e sostiene che l’arte greca racchiude in sé un’etica e una pedagogia, cosicchè all’opera d’arte spetta – in quanto veicolo dello spirito greco – uno statuto e una funzione sacramentale, e tale è l’esperienza personale che Winckelmann ha avuto, vivendo in sé l’accendersi di una interiore e latente grecità che torna a rivivere al contatto con quella esteriore delle opere d’arte greche; ed egli invita tutti a rivivere ciò che egli ha vissuto, giacchè la grecità è una possibilità perenne dell’uomo, innata e coltivabile: si tratta di assimilarsi all’uomo greco, facendo rivivere in sé ciò che si imita, cosa possibile appunto perché il greco è virtualmente presente in ciascuno di noi. Si tratta solo di risvegliarlo e, per far ciò, occorre entrare in intimo contatto con le opere greche e con il mondo che da esse trasuda: è, questa, una rivisitazione del concetto cristiano dell’imitazione di Cristo, secondo cui l’incontro col Cristo annunciato dalle Scritture ridesta in noi il Cristo, quella scintilla divina rimasta latente nell’uomo nonostante il peccato originale. Come il vero imitatore di Cristo è colui in cui Cristo rinasce e rivive, così il vero imitatore dei Greci è chi si trasmuta in essi, facendoli rivivere entro di sé, in tutta la loro bella umanità; e in Winckelmann l’imitazione dei greci non fa che scacciare e rimpiazzare quella di Cristo, cosicchè la salvezza dell’uomo è racchiusa nei greci stessi. Ma si tratta di una grecità aspaziale e atemporale (Winckelmann mai giunse in Grecia), che in realtà finisce per identificarsi con Roma; egli contrappone gli antichi e i moderni e, per di più, scalza il cristianesimo, sostituendolo con la grecità, accentuando al massimo l’immanentismo, di contro al trascendentismo a cui porta il cristianesimo: l’uomo è, grecamente, artefice e creatore di sé e della propria humanitas, e la paideia dell’arte antica mira appunto ad educare a questo ideale per cui l’uomo diventa veramente uomo e mito al tempo stesso, tramutandosi in essere prometeico. Nella lirica I segreti così scrive Goethe: “allorchè la sana natura dell’uomo agisce come un tutto, allorchè egli si sente nel mondo come in un grande tutto e allorchè l’armonico equilibrio produce in lui una pura e libera estasi, allora il cosmo, se mai potesse aver sentimento, esulterebbe perché avrebbe raggiunto il proprio fine“. L’uomo greco, così inteso, appare come teofania del nuovo dio della religione umanistica quale appare nell’arte. Così si interroga Hölderlin: “perché son legato alle coste della Grecia e le amo più della mia stessa patria? Perché sono il paradiso e il regno di Dio“. Così concepita, la grecità non è un mero passato, ma anzi si configura come un possibile futuro: significativamente, Quasimodo ha intitolato una sua raccolta di versi L’antichità come futuro, con un titolo che ben rispecchia la concezione di questi autori, per cui la nostalgia non è sterile, ma produttiva, tesa a ripartorire quell’uomo ideale che visse coi Greci. Un punto nodale del pensiero di Winckelmann è dato dalla sua dura critica ai danni del barocco, età in cui – egli nota amaramente – trionfano i due grandi errori condannati dal classicismo: l’eccessivo naturalismo e il dilagare incontrollato della soggettività dell’artista; nell’arte barocca – l’arte della controriforma, tendente dunque ad una serrata propaganda religiosa – l’uomo è raffigurato nella sua finitezza peccaminosa e, al contempo, nella sua redentrice relazione con Dio: in questo modo, egli è homo viator, colto in tutta la sua contraddittorietà derivantegli dalla sua finitezza, cosicchè ci si trova dinanzi ad un’umanità in lotta tra sensualità e ascesi, tra gioia di vivere e negazione del mondo, in costante tensione e in perenne sforzo. Non è un caso che la cifra dell’arte barocca sia la torsione: così, in torsione sono le statue (pensiamo all’Estasi di S. Teresa del Bernini) ed esse non fanno altro che raffigurare un’umanità contorcentesi in preda a lacerazioni irrisolte, mai in quiete (non a caso i personaggi sono spesso raffigurati col corpo voltato, in preda allo stupore, o col corpo perigliosamente poggiante su di un sol piede): Ninfe rapite e Santi martirizzati ben simboleggiano questo turbinio di movimento incessante di un’arte che è analoga all’umanità che raffigura. Winckelmann asserisce che quest’arte (ai suoi tempi divenuta rococò), lungi dal condurre l’uomo a se stesso, lo perde nel contraddittorio labirinto della sua finitezza, salvo poi predicare la redenzione divina (e qui sovvengono i dipinti barocchi dei cieli divini sulle volte affrescate). La seconda caratteristica deteriore del barocco è il suo soggettivismo, il narcisismo di cui l’autore si macchia, come ben sapeva il Marino quando predicava che “è dell’artista il fin, la meraviglia“. Mentre l’artista classico è preso dalla contemplazione e dalla raffigurazione della bellezza, sgombrando l’opera dalla sua presenza, l’artista barocco visibilizza innanzitutto se stesso e non l’oggettiva bellezza, e, così facendo, mantiene il fruitore dell’opera d’arte nella sua soggettiva finitezza. La bella umanità dei Greci è tale perché totalità e armonia delle facoltà e ciò è stato possibile perché tale era realmente la natura greca: in questa maniera, Winckelmann fa proprie alcune notazioni di Montesquieu sull’influenza del clima nell’evolvere delle culture che in esso si sviluppano. Il clima greco è il clima dell’eterna primavera, ottimale per la nascita di una cultura strepitosa: di qui – secondo Winckelmann – i corpi snelli dei Greci che, sotto il loro cielo azzurro e terso, rispecchiante il loro beato stato d’animo, hanno raggiunto in pieno l’umanità. Beffardamente interrogato se tutti i Greci fossero belli quali li si osservano nelle statue, Winckelmann rispose causticamente che magari non tutti eran così belli, ma che comunque davanti a Troia vi era un solo Tersite. Winckelmann identifica di volta in volta la propria concezione dell’umanità greca in diversi topoi, uno dei quali è dato dall’Apollo adolescente, raffigurazione tipica dell’armonia, in quanto nell’adolescente è raffigurata la tipica totalità aurorale di chi è giovane; si tratta dello svelarsi di un cosmo virtuale, che fa sì che l’adolescente sia un plesso di possibilità ancora inespresse, giacchè è ancora un tutto non specializzato, si trova in uno stato di grazia scevro di scissioni e contrapposizioni. In questo senso, è colta l’eterna giovinezza di questa umanità eterna e priva di artificio, poiché la riflessione c’è, sì, ma non domina ancora incontrastata, senza comunque che vi siano eccessi di spontaneità. Tale condizione di puer aeternus appare sì come un dono di quel cielo azzurro e terso che risplende sulla Grecia, ma è un dono coltivato e sviluppato opportunamente, e tal bellezza è massima espressione di benessere; ne emerge quella che Winckelmann definisce come la nonchalance dei Greci, e che ancora Kierkegaard – quando parla di Socrate – battezza come “noncuranza” greca. “Nel contegno delle figure antiche, non si vede il piacere manifestarsi col riso, ma esso mostra soltanto la serenità della contentezza interiore” e – prosegue Winkelmann – “nella quiete e nella tranquillità del corpo si palesa la grandezza posata dell’animo, sublime e nobile immagine di una così perfetta natura“; quello che leggiamo sulle statue greche è l’atteggiamento di chi, lungi dal nuotare faticosamente contro corrente, si lascia portare dalla corrente, galleggiando con leggerezza perché è già compiutamente se stesso. Così, gli eroi greci son sempre colti in posa, stanno e sono se stessi, dunque in riposo, appoggiati, “gli dei e gli eroi sono rappresentati in piedi come nei luoghi sacri ove alberga la quiete, e non come nel gioco dei venti o in una sbandierata“, come invece vengono tratteggiati nell’arte barocca (pensiamo ai suoi mantelli svolazzanti). Sono in pace con se stessi perché in loro essere e dover essere coincidono, sicchè siamo lontanissimi da una vita febbrile e fabbrile, con un evidente parallelismo con la polemica rousseauiana condotta contro il modus vivendi della borghesia. Quella dei Greci era una vita trascorsa in ozio (la scolh greca), una vita in cui non ci si occupava che della propria umanità e del resto Winckelmann, nel suo epistolario, ringrazia di continuo i suoi protettori, che gli han consentito l’ozio romano, quel dolce far niente italiano, senza scomposte agitazioni e sfociante nell’olimpica serenità del meridionale (non è un caso che Winckelmann viva in anni che costituiscono i prodromi della rivoluzione industriale). Quando egli parla dell’umanità dei meridionali, intende dire che essi son più uomini di quanto non lo siano i moderni suoi conterranei, sempre più integrati, come ingranaggi, nei ranghi della trionfante borghesia, sicchè il benessere di cui Winckelmann parla non è esente da coloriture epicuree. “A Roma sono vissuto“, egli nota beatamente, e non diversamente Goethe dirà: “a Roma sono rinato“. E’ infatti l’ozio – nella fattispecie quello vissuto a Roma – ad illuminare sul vero valore dell’esistenza, che deve essere coltivata e non sprecata. Nel paradiso dell’umanità si gioca e non si lavora, perché il gioco – in antitesi col lavoro – impegna e insieme non impegna tutte le facoltà dell’uomo, rendendo la sua vita un po’ come una festa giocosa. Ma le feste, come tutti sappiamo, son sempre minate dagli spettri del passato e da quelli del futuro, cosicchè il loro carattere peculiare è la costante delusione rispetto all’attesa (tematica brillantemente colta da Leopardi). Le feste risultano infatti perennemente insidiate dallo spauracchio del lavoro, di cui sono solo una vuota interruzione; si limitano a soppiantare temporaneamente l’angoscia con il vuoto. E tale vuoto della festa è un vano diversivo, astratto dal lavoro ma ad esso connesso, cosicchè nella festa il lavoratore si sente fuori luogo: l’autentica festa – nota Winckelmann – è l’ozio, reso possibile dalla pienezza e dalla compattezza che fan sì che si sia presenti a se stessi e non proiettati nel passato o nel futuro. Ciò avviene quando si contempla l’opera d’arte e, del resto, l’etimologia stessa di negotium (il termine latino che noi traduciamo con “lavoro”, “impegno”) è nec otium, il che rivela come il lavoro altro non sia se non la corruzione dell’ozio, quella condizione originaria dell’uomo celebrata anche da Federico Schlegel. Schiller, dal canto suo, cercherà una democratizzazione di quest’ozio elitariamente inteso da Winckelmann, che esalta sempre e di nuovo la libertà di Roma e della Svizzera, di contro al dispotismo nordico e francese. Si tratta della libertà non solo da mode, costumi, educazioni e morali soffocanti, ma anche dallo Stato e da una legislazione oppressiva, sicchè in questo senso Winckelmann apre veri e propri spiragli in direzione liberale; la libertà così intesa era a suo avviso presente presso i Greci, tant’è che la tunica greca non costringeva i corpi e così pure la nudità fisica era orientata ad un libero sviluppo psicologico. Dunque il contatto con quell’arte antica è di importanza vitale, e nell’Ottocento si darà vita ad una variante estetizzante del pensiero di Winckelmann, massimo esponente della quale fu Walter Pater col suo romanzo Mario l’epicureo. Schiller invece darà della visione di Winckelmann un approfondimento filosofico e soprattutto tenterà di coniugarla con la rigorosa prospettiva morale di Kant, fuggendo perciò agli estetismi. Ed è nei drammi che Schiller espone la prima critica – fortemente rousseauiana – indirizzata contro la società a lui contemporanea. Ma, prima di divenire grecomane, egli aderì allo Sturm und Drang (“tempesta e impeto”), quel movimento preromantico – di reazione all’illuminismo e al suo razionalismo dilagante – a cui aderì, fra i tanti, Goethe stesso con il suo I dolori del giovane Werther. C’è chi ha acutamente sostenuto che lo Sturm und Drang è stato per la Germania ciò che la Rivoluzione è stata per la Francia, avendo essi come comune denominatore la rivendicazione di libertà per il singolo: da ciò scaturiscono la netta avversione per l’illuminismo, le spiccate tendenze anarchiche e il culto del genio. Schiller tuttavia occupa in tale ambito una posizione del tutto particolare e a sé stante, giacchè – esente da tendenze anarchiche – fa sua la rivendicazione di libertà per l’individuo, non però nel senso elitario (winckelmanniano) del genio, ma nel senso democratico di far essere uomo ogni uomo, e la libertà che egli rivendica trova nella legge morale della ragione kantiana il proprio vertice. Nei suoi drammi, Schiller rivendica anzitutto la libertà politica in senso antitirannico, in direzione di uno Stato libero e costituzionale, fondato sul patto sociale. Così, nel Guglielmo Tell viene esaltata la libertà svizzera di contro all’opprimente tirannide degli Asburgo, ne La congiura di Fiesco a Genova. Un dramma repubblicano. Fiesco combatte contro la tirannide dei Doria a Genova. Il più importante di questi drammi rivendicanti la libertà resta indubbiamente il Don Carlos, ambientato nel corso delle sanguinose guerre di liberazione dell’Olanda dal dominio spagnolo, dove la lotta di liberazione è anche – e soprattutto – lotta contro l’oppressione religiosa perpetrata dalla cattolicissima Spagna. Mentre in La congiura di Fiesco a Genova il dispotismo è inteso come il frutto della malvagità del tiranno, nel Don Carlos la tirannide si articola in una complessa struttura repressiva che abbraccia l’intera esistenza e che giunge fino alla feroce repressione religiosa. Il deuteragonista di Filippo II – il sanguinario tiranno – è il marchese di Posa, suo consigliere, che, mosso da nobili sentimenti, risponde al suo sovrano e alle sue aberrazioni che la pace di cui egli parla è la pace di un cimitero. Posa ritiene la repressione – vagheggiata e attuata da Filippo II – come propria di un uomo che non sopporta la libertà, nella convinzione che l’uomo medio non sia capace né della libertà di pensiero né di quella d’azione e che, se abbandonato a sé, non perverrebbe né alla fede né ad una morale accettabile. Ne segue che, nella prospettiva di Filippo, l’uomo non è nato per essere libero, ma è anzi schiavo del peccato; è, evidentemente, una prospettiva reazionaria facente capo ad una concezione antropologica a dir poco pessimistica, di remota ascendenza machiavelliana. Il marchese di Posa nutre una concezione antitetica dell’uomo, che, a suo avviso, è fatto per la libertà e solo in condizione di libertà può diventare pienamente se stesso; ove essa manchi, egli diventa ciò che Filippo II crede che sia per natura. Dunque per Posa – vessillifero della veduta di Schiller – l’uomo è rousseaianamente libero per natura ed è il dispotismo a renderlo schiavo, è l’oscurantismo a mantenerlo forzosamente in uno stato di inferiorità e poi ad accusarlo di essere ciò che l’oscurantismo stesso ne ha fatto. Dal dramma traspare la convinzione schilleriana che la libertà sia il presupposto della vera umanità. La trama del Don Carlos non è architettonicamente complessa: l’Olanda rischia di essere ispanizzata dal terribile duca d’Alba e il magnanimo marchese di Posa cerca di impedire che ciò avvenga cercando di convincere Filippo II a rimpiazzare il duca D’Alba con il suo stesso figlio don Carlos, che è da sempre conquistato dall’ideale di libertà. Tratteggiando la nobile figura di don Carlos, Schiller pare avanzar l’idea che la libertà conquisti moralmente, senza far violenze d’alcun genere, e don Carlos descrive appunto questa irresistibile conquista operata dalla libertà, che finisce per lambire perfino lo spietato Filippo II. Così Schiller dimostra abilmente la forza naturale della libertà autoespansiva, ricordando da vicino il Nerone quale sarà tratteggiato da Kierkegaard: chi lo circonda teme il suo potere, ma non rispetta la sua persona. Anche Filippo II, almeno per un attimo, si ribella al proprio dispotismo, vorrebbe essere libero e non più solo, e proprio in ciò risiede la tragicità del suo personaggio, trasceso da quel dispotismo che egli ha sviluppato nel tempo. Il marchese di Posa congiura politicamente contro di lui e avviene così che il passato si vendichi sul re proprio nel momento in cui questi pare convertirsi alla libertà: accecato dal furore, Filippo ricade nel proprio sistema tirannico e consegna il figlio – don Carlos – alla tremenda inquisizione. Filippo è dunque condannato al dispotismo perché troppo tardivo è stato il suo tentativo di liberarsene. Il dramma si chiude male, col trionfo della repressione del corifeo della libertà, ma la certezza interiore del primato egemonico della libertà è assoluta e incrollabile; da una parte si vede come quella del dispotismo sia una non-umanità, e dall’altra si mette in luce l’incontrollabile potenza della libertà. Altro dramma in cui Schiller affronta questa tematica è I Masnadieri, in cui viene rivendicata la libertà del singolo contro una società o ingiusta o troppo opprimente, tale da manifestarsi come profonda simpatia per il delinquente. L’epigrafe dell’opera è – significativamente – “in tyrannos!” (“contro i tiranni!”), ad indicare l’avversione schilleriana contro la tirannide della società, dello Stato e della legge. E la lotta avviene a due livelli: contro la degenerazione di società e Stato, e contro la società in quanto tale, giacchè questa limita e danneggia la libertà delle grandi individualità, imponendosi illiberalmente su di loro. L’eroe dell’opera è Carlo Moor, è il masnadiero protagonista che si è oggettivamente opposto alla legge, ma che soggettivamente è vittima di essa e della società. Egli è uomo forte, a tal punto da sentirsi stretto e ingabbiato nella società, cosicchè – esaltato dalla lettura di Plutarco e delle gesta eroiche dei suoi personaggi – decide di andar contro questo secolo “sporco di inchiostro” che tanto lo nausea; è una fiacca epoca di castrati quella in cui Moor si trova a vivere, poiché la natura umana è in essa stata corrotta con disgustose convenzioni che intrappolano e reprimono ogni impulso eroico, sicchè egli si rifiuta di costringere il proprio torace entro un panciotto e la propria volontà sotto la legge positiva della società. Tale legge non ha mai prodotto grandi uomini, mentre la libertà produce “colossi ed estremismi“, quella di Moor è una natura eroica che si trova spaesata nel mondo borghese; respinto dal padre per via dei suoi ideali, si mette in lotta contro la società, facendo proprio un ideale di rivoluzione sociale. Divenuto capo di una banda di masnadieri, immaginandosi vendicatore di un’umanità tradita, egli intende rappresentarla nella sua libertà rousseauianamente concepita, specializzandosi in omicidi, frutto non di un basso istinto, ma di un superiore ideale che Schiller – nella prefazione al dramma – accosta all’idealismo fantastico di Don Chisciotte. Moor uccide tutti i pezzi grossi della società borghese (in primis preti e banchieri), ma poi la soluzione del dramma rientra nell’alveo della tradizione illuministica, in quanto egli, accortosi dell’assurdità del suo agire da masnadiero, si consegna alle autorità per pagare il fio delle sue colpe. In realtà, questo finale è un ingegnoso escamotage dispiegato da Schiller per rendere digeribile il proprio dramma dalla censura, e prova ne è il fatto che, pur concludendosi con la disfatta di Moor, resta in apertura dell’opera l’epigrafe “in tyrannos!“. Intrigo e amore narra di una vicenda ambientata nella società borghese contemporanea; Schiller vi rivendica il naturale diritto dell’amore che deve trionfare sull’artificiosa distinzione delle classi sociali. Sicchè al centro dell’opera troviamo un giovane nobile sinceramente innamorato di una ragazza borghese: egli si batte contro le convenzioni sociali che vorrebbero proibirgli il matrimonio in quanto frutto dell’amore e non combinato dalla ragione calcolatrice mirante all’utile; la tematica è evidentemente desunta da Rousseau e dal suo La nuova Eloisa. Di centrale importanza nella formazione di Schiller è il suo incontro con Goethe, e in una lettera del 28 agosto del 1794 egli afferma che ciò che Winckelmann fu per Goethe, Goethe stesso è stato per lui: a colpire Schiller fu soprattutto la grecità di cui Goethe era imbevuto, la presenza in lui di una sensibilità antica che lo rendeva un tutto compiuto e che segnalava in lui e nella sua compiuta bellezza una possibilità greca. Del resto, l’antico quale era concepito da Winckelmann è da Goethe definito come “un tutto bello e compiuto“, a segnalare che in lui vi è stata reale esperienza della totalità greca; lo sguardo di Goethe – nota Schiller – si posa quieto e puro sulle cose, rendendolo un uomo tutto d’un pezzo che vive in pieno accordo e in stupenda unità con se stesso, nella sua grecità interiore – scoperta nel suo viaggio in Italia. Se Goethe fosse nato greco o italiano, non avrebbe avuto bisogno di questo peregrinare per riscoprire la propria interiore grecità, ma sfortunatamente il suo spirito fu gettato in una creatura nordica. Oltre al personale contatto con Goethe, Schiller – fin dal 1784 – era entrato in contatto con l’antichità nei musei, ove aveva inteso le statue greche come “scuola di umanità” e nelle Lettere di un viaggiatore danese (1785) dà espressione alla sua ancora estemporanea grecomania dicendo: “mi sento più nobile, mi sento migliore“, potenziato e ampliato nella propria umanità, e non solo grazie ad una fruizione estetica, bensì attraverso l’esperienza che egli ha fatto della propria umanità ampliatasi. Notiamo qui affiorare il tema winckelmanniano del teomorfismo: “i Greci rappresentarono i loro dei solo come uomini più nobili e avvicinarono i loro uomini agli dei“. Questo è l’invito che i greci rivolgono a tutti gli altri popoli della terra: “siate come noi!“. Al 1788 risale la poesia Gli dei della Grecia, un componimento che già costituisce un’ulteriore tappa nella grecofilia schilleriana, giacchè Schiller è ormai entrato in contatto con l’ambiente grecizzante di Weimar (dove erano operativi Goethe e Herder) ed è sprofondato nella lettura delle Vite parallele di Plutarco. Gli dei della Grecia può essere suddivisa in tre parti: innanzitutto, Schiller rievoca l’antica Grecia come età felice, di giocosa armonia dispiegantesi in feste, giochi e danze; da una tal società ogni bruttezza è bandita e perfino la morte non desta orrore, ma è anzi raffigurata nei termini mitigati dei Campi Elisi. Nella seconda parte, vi è invece una lamentazione sull’età moderna e sulla sua religione (il cristianesimo), che ha introdotto angoscia e amarezza nel mondo, con una tetra serietà e un’etica della rinuncia, sottraendo la felicità al cuore degli uomini e sostituendo gli amabili dei col Dio vendicativo della predestinazione. Gli dei, presso i Greci, erano umani, gli uomini erano divini; al contrario, ora l’uomo è meno di un verme di fronte a Dio, cosicchè non può non sentire quella dolorosa distinzione tra finito (umano) e infinito (divino) che ai greci mancava. Proprio perché è un verme, l’uomo moderno non può che dolersi e prostrarsi, provando nostalgia per un’età andata perduta; ma la poesia – e qui entriamo nella sua terza parte – non si chiude con un nostalgico lamento, ma con un’esortazione alla restaurazione e alla rinascita della grecità. Sicchè si tratta di trasformare la nostalgia dell’età dell’oro, una nostalgia che non si riduce a rimpianto di un’Arcadia perduta, ma è aspettativa di un Elisio futuro. Quella Grecia è l’eterna manifestazione di una gaia possibilità di vita ed è basandosi su di essa che Schiller auspica una nuova vita fantastica, che appare impossibile senza rimando al dinamico modello greco, unità di spirito e di natura. In quest’ottica, la dignità dell’uomo si è consegnata nelle mani dell’arte antica ed è solo al contatto con essa che l’uomo può riacquisire la propria umanità, accostandosi a quello che fu “il popolo più armonico che sia mai esistito“, come dice Vittorio Alfieri, che in certo modo partecipa della temperie neoclassica. Il riconoscimento del proprio compito e della propria destinazione nasce al contatto con l’arte antica e muove dall’imperativo delfico del gnwqi sauton, sicchè così può affermare Schiller: “ed ecco vedi, il sole di Omero sorride anche a noi“. Al 1789 risale un’opera più articolata, il poemetto Gli artisti: in esso, Schiller sostiene che l’arte è peculiarità umana, giacchè esistono, sì, animali industriosi e laboriosi, ma artisti sensu stricto sono solo gli uomini, che producono opere d’arte non funzionali ad altro se non alla rappresentazione della bellezza; quest’ultima è oggetto della sensibilità congiunta alla ragione. E Schiller osserva come l’uomo sia anzitutto appetito, inclinazione sensibile caos di desideri ciechi, e come a lui sfugga “la bella anima della natura“. Ciò significa che un tale uomo non è in grado di cogliere la bellezza della natura perché unicamente intento a desiderarvi e ad appetirvi, non vede in essa altro che strumenti. L’uomo coglie la bellezza naturale degli oggetti quando, anziché desiderarli e conoscerli, li contempla; in tal caso, essi cessano di essere oggetti e si palesano come parvenze, come mere figure, appare l’intrinseca bellezza della loro forma. Queste ombre apparenti sono “l’Elisio dipinto con amabile illusione sulla parete del carcere dell’uomo” e qui implicitamente Schiller sta asserendo che quando l’uomo desidera e conosce è chiuso in un carcere, sicchè la sua vita quotidiana è un carcere; l’eventuale evasione è possibile solo nel caso della contemplazione. Nel desiderio appetito si rivela la dimensione sensibile dell’uomo, nel conoscere si palesa invece quella razionale: nella dimensione estetica le due si incontrano e avviene il miracolo della contemplazione, che è sì sensibile ma non appetitiva, è sì conoscitiva ma non aridamente razionale. Accade così che la contemplazione educhi l’uomo realizzando anche in lui quella bellezza che egli coglie contemplando le cose fuori di lui; sicchè la contemplazione lo rende pienamente uomo perché le sue due componenti (la ragione e la sensibilità) trovano un armonico accordo. Nella contemplazione, infatti, la sensibilità è educata alla ragione, ad essa si apre senza però cessare di essere la sensibilità che è, ma perdendo la propria unilateralità possessiva, il suo esser cieco desiderio. Dal canto suo, la ragione è temperata e aperta alla sensibilità, con la quale collabora nella contemplazione. In questa dimensione particolare, il desiderio non esclude la voce della ragione e questa legge (che è la legge morale) si presenta conciliata con la sensibilità stessa. Questa che contempla è l’anima bella, caratterizza dalla spontanea adesione della spontaneità alla legge morale della ragione, che non respinge, ma anzi accoglie la sensibilità stessa, cosicchè – dice Schiller – l’anima bella è anche anima libera e dalle inclinazioni della sensibilità e dal dovere imperioso della ragione. La relazione da Schiller intrattenuta con Kant a livello filosofico è ancipite: da un lato, il pensatore di Köenigsberg ha per lui il merito incommensurabile di aver confutato quella dottrina che concepisce il piacere come unico motivo per cui si agisce razionalmente; senonchè – e qui troviamo il limite che Schiller imputa a Kant – l’esposizione kantiana, tentando di sconfessare l’edonismo, finisce per mettere in posizione altamente negativa l’inclinazione sensibile in quanto tale. Sicchè Kant agisce bene nel mettere in luce come, in sede etica, la ragione calcolatrice non sia la sola, ma come, accanto ad essa (che genera gli imperativi ipotetici), vi sia anche la ragion pura pratica, produttiva dell’imperativo categorico. Tuttavia, il filosofo della “rivoluzione copernicana del pensiero” sbaglia nel momento in cui vede le inclinazioni sensibili come nemico da eliminare. Ciò a cui Schiller mira è, infatti, una rivalutazione della sensibilità, pur concordando pienamente con Kant sul fatto che il valore morale di un’azione dipenda solamente dalla sua diretta determinazione da parte della legge morale. Ma Kant, per tenere fermo questo valido principio, esagera nello svalutare la sensibilità, cosicchè avviene che, per esser certi che l’inclinazione sensibile non partecipi a determinare la volontà, si preferisca vederla in lotta – e non in armonia – con la legge della ragione. Ora, è sì vero che il consenso della sensibilità alla legge morale non è garanzia della conformità della sensibilità al dovere, ma tale consenso non è d’altro canto un segnale della non-moralità della volontà. Kant, nei suoi scritti, va contro lo spirito della propria etica, spirito che è innanzitutto adesione alla legge morale dettata dalla ragione; ciò significa sì che non deve essere la sensibilità a determinarmi, ma non che essa possa in qualche modo non essere coinvolta dalla (e nella) legge morale. Il rigorismo morale che alimenta il pensiero di Kant riguarda la sua esposizione infelice che si oppone allo spirito stesso dell’etica kantiana, e da ciò Kant è indotto dalla sua accesa polemica contro l’edonismo e il materialismo dilaganti ai suoi tempi. Ma – contesta Schiller -, pur essendo necessario attaccare l’edonismo materialistico, tale battaglia non implica un’opposizione alla sensibilità in quanto tale: “nella filosofia morale di Kant, l’idea del dovere è presentata con una durezza che fa indietreggiare spaurita la grazia e che potrebbe facilmente indurre un cervello debole a cercar la perfezione morale sulla via di un ascetismo tenebroso e monacale“. Scrive ancora Schiller: “come in Lutero, così anche in Kant c’è qualcosa che ricorda il monaco, un monaco che ha sì aperto il proprio convento, ma che non è riuscito del tutto a cancellarne le tracce“. Dire che a determinarmi deve essere il dovere, non vuol dire che la volontà è buona solamente se opposta alle inclinazioni naturali: si tratta, allora, di riaffermare la verità della dottrina etica kantiana correggendone gli eccessi polemici e anti-sensibili, rispettando anche le esigenze e i diritti della sensibilità, la quale deve rientrare nella sfera morale, pur non determinando l’azione morale. Se escludiamo dall’uomo la sua sfera sensibile – come pretende di fare Kant -, egli rimane impoverito e sminuito, privo di una parte di sé: sicchè da Schiller la perfezione morale è intesa nei termini di totalità, una complicità di sensibilità e ragione, per cui l’uomo veramente morale è quello il cui sforzo è anche di educare la propria sensibilità al fine di promuoverne l’accordo con la sensibilità. Ne risulta che l’azione è morale se dettata dal dovere, ma la sfera della sensibilità non è mai del tutto esclusa. Ciò che conta, secondo Schiller, non sono le singole azioni morali, ma la condotta morale nel suo complesso: “l’uomo infatti non è destinato a compiere singole azioni morali, ma ad essere un essere morale“, mettendo d’accordo piacere e dovere, obbedendo con gioia ai dettami della ragione: si tratta cioè di fare del dovere un piacere (ma non viceversa). Nel dovere morale è allora racchiusa l’esigenza di un accordo tra ragione e sensibilità, poiché, in quanto costituito da entrambe le sfere, l’uomo non deve separarle, come pretendeva di fare Kant quando voleva estirpare dall’uomo la sua parte sensibile e animalesca: lo spunto schilleriano è qui fortemente anti-ascetico. Finchè per comportarmi moralmente devo obbligarmi con sforzo, il problema della moralità è rimosso ma non risolto, il nemico non è debellato: il nemico in questione è la sensibilità non in quanto tale, ma quella assolutizzata, stante al di sopra della ragione. La vittoria si ha quando la ragione eleva e trasforma la sensibilità, senza indurre diffidenza verso una parte di noi, ma aprendosi e alleandosi ad essa. Questa è veramente un’anima morale: “un uomo che non si fida, ma teme il proprio istinto, anziché abbandonarglisi, non è ancora un vero uomo morale“. Schiller, polemizzando contro il rigorismo, attacca Kant ma anche il primo Fichte, in cui il rigorismo kantiano è addirittura potenziato: come e più di Kant, Fichte intende la subordinazione della sensibilità alla ragione nel senso che il fine della morale è l’unità dell’uomo, unità però concepita come risoluzione della sensibilità in razionalità. Per Schiller, la sensibilità dovrebbe diventare il braccio della ragione, evitandole di compiere ogni volta uno sforzo sovraumano che forse non è nemmeno il fine della moralità. Sicchè l’ideale schilleriano è un ideale morale che trascolora in un ideale estetico, in quanto mirante alla bella e armoniosa vita morale dell’uomo, all’anima bella e buona insieme, tale perché armonia delle due componenti umane. Ma si può essere morali senza tuttavia esser belli: è questo il caso in cui la moralità è raggiunta con lo sforzo, sicchè si avrà – dice Schiller – un’anima sublime. La bellezza è allora un di più, è uno sviluppo ulteriore della morale stessa che, coinvolgendo la sensibilità, potenzia se stessa diventando anche bellezza. In COLOR=”#ff0000″>Grazia e dignità(1793) appare evidente come il rigorismo kantiano sia del tutto unilaterale, e ciò in base alla sua incapacità di render conto del fattore sensibile quale era stato trattato dalla mitologia greca: la favola greca attribuisce a Venere, la dea dell’amore, una cintura capace di conferire grazia a chi la indossi e di procurare l’amore; non è un caso che Venere venga raffigurata accompagnata dalle Grazie. Per Schiller,COLOR=”#0000ff”>grazia è ciò che impressiona piacevolmente, ciò che innamora: e questo fenomeno, a cui allude la mitologia greca, è quella particolare forma di bellezza fisica che definiamo “grazia”. E’ una bellezza mobile e contingente ed è perciò distinta dalla bellezza fissa, data necessariamente con l’individuo. Schiller distingue dunque tra una bellezza fissa e una mossa: la prima è prodotta dalle leggi plastiche della natura secondo necessità; la seconda è invece il prodotto dello spirito secondo libertà. Schiller chiama la bellezza fisica anche “architettonica” e la fa coincidere con la bellezza della figura, distribuita dalla natura e data fissamente una volta per tutte, non libera, ma necessitata. L’uomo, però, non è solo un essere determinato dalla natura: viceversa, è anche persona moralmente determinantesi secondo libertà e ciò significa che anche la fisicità è in parte sottratta al dominio delle leggi naturali e necessarie, ed è dunque piegata alla libertà. Di qui, appunto, deriva alla figura umana la possibilità – oltrechè di una bellezza fissa – di una bellezza dinamica, prodotta dalla libertà. Quella architettonica rende onore alla natura, mentre quella in movimento a chi la possiede, giacché è espressione fisica della sua libertà morale: la prima è un talento naturale, la seconda è un merito personale derivante dal manifestarsi nel mondo sensibile dello spirito come movimento: e qui Schiller allude alla gestualità e alla mimica facciale. Se il movimento è manifestazione dello spirito, allora tal bellezza spirituale sarà per forza in movimento, mentre la figura nella sua bellezza naturale resta stabilmente se stessa. Se la grazia, poi, è accidentale, sarà bellezza di movimenti accidentali e non necessari (quale invece può essere la respirazione), in quanto questi ultimi sono tutt’uno con la figura e perciò rientrano nella bellezza strutturale. Ma non tutti i movimenti accidentali sono graziosi: solamente quelli umani, giacchè le membra di un animale o i rami di un albero, anche quando si muovono accidentalmente, non sono graziosi; sicchè la grazia appartiene solo ai movimenti volontari, tali da essere solamente propri dell’uomo: di questo tipo sono i movimenti che esprimono la volontà. Solo questi possono essere graziosi: “movimenti i quali non abbiano altra fonte che il senso appartengono, malgrado ogni volontarietà, soltanto alla natura, che di per sé sola non si leva mai fino alla grazia; se la brama e l’istinto potessero manifestarsi con grazia, questa non sarebbe più in grado né degna di servire da espressione all’umanità“. “Natura” è qui inteso da Schiller come tutto ciò che non è umanità e, dunque, razionalità: quei movimenti che all’uomo son suggeriti dalle passioni e dalle inclinazioni sensibili non sono graziosi, poiché – in quanto indotti da passioni – esprimono un bisogno e un desiderio, ovvero disagio e ansia, e dunque sono sempre scomposti e violenti. La grazia, allora, altro non è se non questa bella espressione dell’anima nei movimenti volontari, è il trapelare della moralità dei movimenti, cosicchè, dove c’è grazia, lì l’anima è il principio movente. Si tratta di una bellezza non data dalla natura, ma prodotta dal soggetto morale; ciò significa che essa è l’ulteriore bellezza che il soggetto morale aggiunge a quella naturale, incrementandola. Ne segue che la grazia ha il potere di render piacevoli e amabili anche i brutti: “anche il meno bello può muoversi bene, sopperire con la grazia alla sua scarsa avvenenza“; grazioso è allora chi è mosso da moralità libera (la ragion pratica kantiana), dalla volontà o, meglio ancora, dal carattere morale: perché il movimento risulti grazioso, non è sufficiente che manifesti la moralità, ossia che sia volontario; al contrario, deve anche essere spontaneo e, dunque, per certo verso involontario. I movimenti esclusivamente volontari, esprimenti singoli volizioni della ragion pura pratica – ovvero d’una volontà agonista contro le passioni – esprimono, sì, la moralità, ma anche la costrizione e lo sforzo in cui tale ragion pura pratica è impegnata. Ma sforzo e costrizione non sortiscono certamente movimenti graziosi: la volontà, infatti, si trova di volta in volta affaticata a resistere alle inclinazioni e ciò produce non grazia, ma COLOR=”#0000ff”>dignità, frutto della lotta trionfante della ragion pratica contro le inclinazioni sensibili attraverso un’incredibile tensione morale. Ma la grazia, oltre ad essere il trasparire sensibile della moralità, è leggerezza e assenza di costrizioni: “la leggerezza è il carattere principale della grazia“, la quale deve quindi essere spontanea e immediata. Graziosi saranno solo quei movimenti insieme volontari e involontari. Involontari sono quei movimenti meramente fisici prodotti nell’ambito sensibile dalle passioni: “se l’uomo soggiogato dal bisogno lascia dominare su di sé l’illimitato istinto naturale, con la sua indipendenza interiore scompare anche ogni traccia di grazia nella sua figura” e a trasparire nel sensibile è solo l’animalità, che è la sola a parlare “dall’occhio languente“, “dalla voce soffocata e tremante“, “da tutto il corpo rilassato“: un uomo in questo stato ripugna al senso morale, ma anche a quello estetico; è un uomo senza grazia. Ci troviamo dinanzi a due forme alternative di rapporto nell’uomo tra razionalità e sensibilità: da un lato, l’uomo può soffocare le esigenze della sua natura sensibile per obbedire alla sua sfera razionale, sottraendosi ad uno sforzo morale che produce non grazia ma dignità; dall’altro, l’uomo può del tutto subordinare la razionalità alla sensibilità e, anziché la grazia, avremo il trionfo dell’animalità più sfrenata nell’uomo, ridotto a pura fiera. Ecco che allora la grazia deve inerire a movimenti volontari (frutto della moralità) e involontari (prodotti dalla spontaneità), per cui il motore della grazia è una razionalità che non è in contrasto, ma anzi in armonico equilibrio con la sensibilità. Nei movimenti volontari dettati dalla moralità vi è sempre anche una componente involontaria che determina il modo in cui si realizza il gesto volontario: la pura volontà decide il gesto, ma non il modo in cui esso avviene; il modo è infatti deciso non dalla singola volizione, ma dal carattere morale, dallo stato morale della persona che decide e compie il movimento. Ogni movimento volontario è accompagnato da una serie di movimenti simpatetici e concomitanti determinati anch’essi dallo stato morale e, per ciò, involontari perché non frutto di una puntuale decisione della volontà, ma necessariamente prodotti dal carattere morale in cui quella morale si è rappresa e che integrano il movimento deliberato: “mentre una persona parla, noi vediamo contemporaneamente i suoi sguardi, i suoi lineamenti, le sue mani, spesso tutto il corpo che parla insieme e non di rado la parte mimica della conversazione è giudicata la più eloquente“. Dunque la mimica è quell’insieme di movimenti volontari e involontari in cui può essere ricercata la grazia: volontari perché generati dalla moralità, involontari perché originati dal carattere morale, essi sono i movimenti che accompagnano quella volontà e ad essa fanno da sfondo, sono come la risonanza esteriore e fisica dell’anima di cui sono la manifestazione e di cui rivelano il profilo morale. Tale è l’anima bella, perfetta conciliazione di razionalità e sensibilità, “armonia che è il suggello dell’umanità completa ed è quella che si intende per anima bella: si dice anima bella quando la moralità è riuscita ad assicurarsi tutti i voti dell’uomo, al punto da poter lasciare senza timore all’affetto e alle inclinazioni la guida della volontà“; la sensibilità è dunque guadagnata alla causa della moralità, sicchè “in un’anima bella non sono morali le singole azioni, ma tutto il carattere“: agisce come se in essa agisse solamente l’istinto, compiendo “i più penosi doveri dell’umanità e il più eroico sacrificio“. La sensibilità non è forzosamente, ma spontaneamente sottomessa alla legge morale, cosicchè non v’è traccia né della tirannide della ragion pratica né dell’anarchia della sensibilità. Di qui la leggerezza del suo agire, sempre morale ma con così tanta facilità da esserne quasi inconsapevole: e, proprio perché tale, l’anima bella si esprime con grazia, cosicchè “sensibilità e ragione, dovere e inclinazioni sono in armonia e la grazia è la sua espressione nel fenomeno“. Scrive Schiller: “un’anima bella diffonde una grazia irresistibile anche sopra una figura che manca della bellezza architettonica e spesso la si vede trionfare perfino sui difetti di natura. Tutti i movimenti che da essa provengono saranno leggeri e dolci“. Ma – sorge spontaneo chiedersi – la grazia può essere simulata? E Schiller propone – e subito liquida – tale eventualità: se per Baldesar Castiglione il “cortegiano” deve simularla al fine di risultar gradito al signore, ciò per Schiller è assolutamente impossibile, giacché la grazia è lo splendore sensibile della moralità (la quale evidentemente non può in alcun caso essere simulata). “Nessuna tensione si potrà notare nei lineamenti del volto, nessuna costrizione nei movimenti volontari: la voce sarà una musica e commuoverà il cuore col puro fluire delle sue modulazioni; la bellezza architettonica può suscitare compiacimento e stupore, ma solo la grazia affascina“: solo i movimenti simpatetici prodotti dall’anima bella sono graziosi, poiché anche i suoi movimenti volontari non sono mai del tutto volontari, poiché prodotti non da una ragione sganciata dalla sensibilità, sicchè tutti i movimenti dell’anima bella sono volontari e involontari e, in virtù di ciò, graziosi, frutto di una spontaneità morale. Diversamente si atteggerà un’anima teatro della lotta tra la ragione eroica e le riottose passioni: “il dominio degli istinti ad opera della forza morale è libertà di spirito, e dignità si chiama la sua espressione nel fenomeno“. Già qui si intravede come l’anima bella sia più un ideale – quasi un’idea nel senso kantiano – che non realtà, poiché la moralità è quasi sempre lotta tra passioni sensibili e ragione; all’origine della dignità vi è non l’anima bella, ma l’COLOR=”#0000ff”>anima sublime, ovvero quella che si è elevata sulla sensibilità: la dignità si manifesta essenzialmente come compostezza nel dolore e nello sforzo, nell’impedire che ad esprimersi nei movimenti siano unicamente gli istinti. L’esempio che in merito Schiller adduce è la statua di Laoconte che, pur avviluppato e strozzato dai serpenti, mantiene una pacata tranquillità, senza scomporsi e senza emettere urla (Schopenhauer nota come in realtà non urli semplicemente perché è impossibile riprodurre le urla in una statua). La dignità, poi, può estrinsecarsi anche in caso di gioia eccessiva, quando interviene la ragione a sedare la scompostezza: nella dignità, lo spirito si comporta da padrone nel corpo, affermando la propria autonomia di contro all’imperioso istinto che vorrebbe sottrarsi al suo giogo. Nella concretezza della nostra esistenza, l’ideale sarebbe la dignità tradottasi in grazia, nota Schiller: dunque l’anima bella sta al di là dell’anima sublime, sta cioè oltre quel sublime che ha superato e risolto in sé. E in questo modo, Schiller sta in qualche modo anti
SCHLEGEL E NOVALIS FONDATORI DEL ROMANTICISMO
CENNI INTRODUTTIVI
Occuparsi della riflessione di Federico Schlegel e di Novalis significa in prima battuta occuparsi del movimento di cui essi sono i padri fondatori: il Romanticismo, che nasce tra il 1797 e il 1801 nella città di Jena, situata nei pressi di Weimar, e che è sede di una piccola università che, in quel torno di anni, diventa la capitale culturale non solo della Germania, ma dell’intera Europa (tra gli altri, vi insegneranno Fichte e Schelling). Sia Schlegel sia Novalis nascono nel 1772 e, fin dalla prima gioventù, sono attorniati da una costellazione di amici di prim’ordine, fra i quali spiccano Guglielmo Schlegel, Schleiermacher e Schelling: appena venticinquenni, possono già essere definiti dei geni. In particolare, Schlegel può essere definito l’inventore stesso del concetto di “poesia romantica”, la quale, prima ancora di essere categoria estetica, è categoria etica, giacché pretende di essere la teoria di una nuova e superiore forma di esistenza. Sicché, predicando la poesia romantica, i nostri autori predicano non solo una nuova forma d’arte, ma anche e soprattutto una nuova forma dell’esistere. E in quanto è vita, la poesia romantica si vuole diversa dall’esistenza predicata dall’Illuminismo e praticata da una borghesia che, all’indomani della Rivoluzione Francese, si presenta sullo scenario sociale come classe vincente. Proprio in forza di ciò, l’Illuminismo è il grande avversario dei giovani Romantici, i quali però non sono semplicemente dei reazionari e dei tradizionalisti che si limitano a demonizzare gli infausti portati dell’età dei Lumi: è vero che, con la Restaurazione, si assistette anche al proliferare di una forma reazionaria e tradizionalista del Romanticismo, ma non è sicuramente il caso di Novalis e del giovane Schlegel (discorso diverso varrà per lo Schlegel maturo, che, mutata rotta, sarà cattolico, reazionario e funzionario alla mercé di Metternich). I giovani Romantici, infatti, lungi dall’essere conservatori, sono spregiudicati, innovatori e dirompenti, arditi teorici dell’emancipazione: la loro polemica anti-illuministica avviene – per così dire – da “sinistra” e si configura innanzitutto come polemica anti-borghese e anti-generazionale, cosicché la lotta che essi conducono è, prima di tutto, lotta contro i loro padri, fautori della passata Rivoluzione. Sicché essi sono dei veri e propri contestatori e la loro vuole essere una rivoluzione contro il pregiudizio e contro il sistema; così la famosa e dirompente espressione “l’immaginazione al potere”, comparsa in un’aula della Sorbona nel ’68 e tradotta da Marcuse in progetto filosofico, è di Novalis. E a un certo punto di Lucinde, il celebre romanzo di Schlegel, uno dei protagonisti è così tratteggiato, in termini che sembrano preludere al ‘68: “aborriva anche il più lontano ricordo dei legami borghesi, come pure ogni sorta di costrizione”. Quella che Schlegel, Novalis e gli altri giovani Romantici si propongono è una rivoluzione contro le ristrettezze entro cui uno spirito libero si sente limitato, una rivoluzione anche e soprattutto condotta contro le regole opprimenti e soffocanti di una società insostenibile. In questa prospettiva contestataria, il Romanticismo si presenta allora come una forma di anticonformismo ed è dunque paradossalmente vicino all’atteggiamento critico che aveva caratterizzato l’Età dei Lumi, a quell’atteggiamento demistificante, anti-oscurantista ed emancipatorio che aveva trovato in Kant il proprio eroe. Da ciò si evince come quella romantica sia critica non già del criticismo illuministico (cui anzi i Romantici stessi paiono rifarsi), ma della sclerotizzazione di quell’Illuminismo che era andato vieppiù istituzionalizzandosi, fino a rendersi tale da imprigionare gli spiriti liberi. Nell’agosto del 1793, anticipando le tematiche che saranno proprie dell’esistenzialismo kierkegaardiano, Schlegel scrive a Novalis: “io miro ad una vita autentica”, ossia ad una vita che sia libera da ogni condizionamento e da ogni costrizione. E così prosegue nella sua lettera: “io, esule, non ho casa, sono stato gettato via verso l’infinito”. Già da queste rapide battute si capisce come lo spirito romantico si senta a disagio nel mondo borghese, che per lui rappresenta una gabbia insostenibile; egli non può aver casa nel finito illuministico, ma si sente proiettato verso l’infinito. Sempre Schlegel scrive che “la Rivoluzione Francese, la ‘Dottrina della scienza’ di Fichte e il ‘Guglielmo Meister’ di Goethe sono le grandi tendenze dell’epoca”, segnalando come il Romanticismo abbia in qualche modo (e successivamente dovremo meglio comprendere in quale modo) a che fare con la Rivoluzione Francese, con la filosofia trascendentale di marca fichteana e con il romanzo. Ma, in termini più propriamente filosofici, che cos’è il Romanticismo? E, da un punto di vista storico, qual è la posizione ch’esso occupa nel panorama della storia del pensiero moderno? Sostenere che il Romanticismo è reazione all’Illuminismo e al razionalismo è corretto, ma troppo generico. Pertanto, per meglio rispondere alla domanda, è opportuno interrogare l’autore che per primo meditò sul rapporto intrattenuto dal Romanticismo con l’Illuminismo: Hegel. Questi, contemporaneo di Schlegel, di Novalis e degli altri giovani Romantici, mai aderì al Romanticismo, di cui anzi fu aspro avversario. In quasi tutte le opere della sua vasta produzione, Hegel esamina con grande sagacia il rapporto tra le due età e tra i due atteggiamenti (quello romantico e quello illuminista), a partire dallo scritto giovanile Fede e sapere (1802), poi nella Fenomenologia dello spirito (1807), nell’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, nelle Lezioni di filosofia del diritto e nell’Estetica. Il risultato dell’Illuminismo – nota Hegel – è l’appiattimento del sapere in scienza del finito, ovvero in scienza di questo mondo, con l’inevitabile conseguenza che l’unico sapere ritenuto valido finisce per essere quello utile e immediatamente fruibile nei problemi d’ordine quotidiano, rinunciando ad ogni pretesa metafisica, ad ogni impossibile quanto inutile ricerca della verità eterna: l’Illuminismo, infatti, esorta i pensatori ad occuparsi solo delle verità terrene di questo che è l’unico mondo, cosicché il sapere che ne sorge è materialistico, pragmatistico, utilitaristico, filantropico. In questi termini, la modernità non è che una “conversione dal cielo alla terra”, abbandonando per sempre le celesti verità tanto della religione quanto della metafisica, in favore di un sapere che sia frutto di una ragione calcolatrice. Il Romanticismo, dal canto suo, si pone come reazione a tutto ciò: esso è innanzitutto “scontentezza del solo finito”, incapacità di accontentarsi del semplice finito – tanto caro agli Illuministi – e di questo mondo disciplinato dalla scienza. Il Romanticismo è allora un deciso e perentorio rifiuto della proposta illuministica di realizzarsi solamente in terra: è, pertanto, rifiuto della terra e nostalgia del cielo. Ma se è nostalgia del cielo, allora può riassumersi in certa misura come rivendicazione dell’eros – di contro alla sua soppressione tentata dall’Illuminismo -, di quell’eros platonicamente inteso come desiderio e nostalgia dell’infinito e dell’Uno. Il Romanticismo, dunque, si configura come nostalgia di un altro mondo rispetto a questo in cui viviamo, nostalgia dell’infinito rispetto al finito che quotidianamente ci soffoca. Se le cose stanno in questi termini, abbiamo trovato la ragione ultima e il significato filosofico di quella che è forse la caratteristica più nota del Romanticismo: il desiderio e la nostalgia dell’infinito, ribaditi in forma quasi ossessiva tanto da Schlegel quanto da Novalis. Ancor prima di definire che cosa sia l’infinito, limitiamoci a dire che i nostri autori ne hanno una nostalgia esasperata e sconvolgente: come le litanie religiose, che sempre si ripetono, così negli scritti di Schlegel e Novalis ritorna sempre e di nuovo questa nostalgia dell’infinito, ancorché declinata in forme diverse: “anelito all’infinito”, “vocazione all’eternità”, “dolce nostalgia”, “sete bruciante di infinito”, “nuovo mondo”, “eterno archetipo”, “patria”, “territorio dell’aldilà”, “spiaggia celeste”, e così via. L’idea dell’infinito come una patria a cui fare ritorno rinvia a Plotino e alle Enneadi (I 6.8), in cui si dice: “Fuggiamo dunque verso la nostra cara patria […]. La nostra patria, da cui siamo venuti, è lassù, dove è il nostro Padre. Ma che viaggio è, che fuga è? Non è un viaggio da compiere con i piedi, che sulla terra ci portano per ogni dove, da una regione all’altra; nè devi approntare un carro o un qualche naviglio, ma devi lasciar perdere tutte queste cose, e non guardare. Come chiudendo gli occhi, invece, dovrai cambiare la tua vista con un’altra, risvegliare la vista che tutti possiedono, ma pochi usano”. Ed è in questi termini di ritorno alla “cara patria” che i Platonici e i Padri della Chiesa leggono l’Odissea: sicché le peripezie di Odisseo per far ritorno a Itaca altro non sono se non le peripezie dell’anima che brama di ritornare in patria; si tratta cioè della nostalgia che l’uomo prova per il proprio principio originario, cui è chiamato a ritornare passando per i pericoli del mondo. Si tratta di una metafora che ha vita lunga, la ritroviamo in Ficino – che parla di “patria celeste” e di “dolcezza del ritorno in patria” – e poi nei Romantici di cui ci occupiamo. Se quello che abbiamo a grandi linee tratteggiato è il cuore della prospettiva romantica, fin da ora possiamo dedurne una pletora di motivi portanti, a partire dalla malinconia, che è in origine sentimento che compendia la tristezza del finito (il suo tedio e la sua noia) e l’ansia bramosa dell’infinito, verso cui si prova nostalgia. Un motivo portante del Romanticismo è anche il culto della notte, la quale è metafora dell’infinito nella sua sfuggente ineffabilità e del sentimento stesso dell’infinito; del resto, la notte si contrappone in maniera diretta ai lumi della ragione illuministica, che pretende di gettar una luce rischiarante su ogni cosa. Un altro leitmotiv del Romanticismo è il culto della morte, fisica e spirituale, ossia del morire ai propri e dolorosi limiti della finitezza: si tratta di una mors mystica alla finitezza che serve come passaggio all’infinito, cosicché la morte diventa affermazione di una vita superiore, infinita e autentica. In stretta relazione con la morte, si impone una nuova concezione dell’amore, inteso dai Romantici come veicolo di morte (di qui il celebre nesso amore/morte), ossia come porta che si apre su una vita superiore. Amare significa infatti morire a se stessi, è cioè il modo più alto di realizzare la morte della finitezza indispensabile per attingere l’infinito. Amare vuol dire cessare di vivere solo per se stessi e prendere a vivere per un altro, rompendo i vincoli della propria egoità. In questo senso, gli amanti si aiutano ad uscire dai limiti angusti del proprio io, amandosi a vicenda: e dunque si mettono sulla via che porta all’infinito; essi sono in cammino verso l’Assoluto e non è un caso che il tema del viandante sia uno dei più diffusi in età romantica. L’amore che lega gli amanti è, platonicamente, amore dell’infinito, cosicché essi amandosi muoiono al finito per rinascere all’infinito. Nasce in questo contesto il gusto, tipicamente romantico, per il viaggio, per l’avventura, per il vagabondare senza una meta, errando all’infinito. E del resto, a ben pensarci, la mobilità continua – reale e metafisica -, l’incapacità di star fermi (che si traduce in nomadismo e irrequietezza) manifesta l’irrequietezza stessa dell’eros, che è tutto fuorché un quid immobile e stazionario. Altro tratto portante dei Romantici è il gusto per l’esotico, per il diverso, per lo strano e per lo sconfinato, rifiutando tutto quel che si caratterizza come ordinario e limitato. All’origine di questo atteggiamento v’è la polemica generazionale dei Romantici contro i loro padri, che vivono in un sistema e giudicano entro confini preordinati senza riuscire perciò a capire quel che è fuori dagli schemi. Questo ribellismo si declina anche nella forma di rivolta metafisica, in quanto rivendicazione dell’infinito, e religiosa, giacché la relazione con l’infinito è intesa come religione stante al di là di ogni confessione, appunto come religio in senso latino (da religare, cioè “connettere”, “unire”): una rivolta indirizzata contro la modernità antimetafisica e antireligiosa, della quale però i Romantici fanno propria la dimensione perennemente critica; da ciò segue che il Romanticismo, lungi dall’essere una frattura nei confronti della modernità, rappresenta piuttosto una tappa di essa, un tentativo di correggerla dal suo irrigidirsi nelle istituzioni vigenti. A questa religione aconfessionale e metafisicizzante spetta l’arduo compito di riaccendere l’amore per ciò che è più alto e di trasformare la vita, da volgare, in superiore, secondo le eleganti parole di Schlegel: “di nulla il nostro tempo ha tanto bisogno quanto di un contrappeso spirituale al dispotismo che esso esercita sugli spiriti con la concentrazione del massimo interesse profano”. In rottura con la filosofia dell’Illuminismo, che si presenta nelle vesti di etica utilitaristica e dell’amor proprio, “dobbiamo – dice Schlegel – guarire dal timore dell’infinito” e “dobbiamo combattere il finito, che vuole usurpare i sacri diritti dell’infinito”. Occorre dunque innalzarsi al di sopra di tutti gli scopi che sono finiti e, per ciò stesso, spregevoli: “liberate la religione e un’umanità nuova avrà inizio”, dove la religione a cui Schlegel fa qui riferimento è pura relazione con l’infinito, mero rifiuto del riduzionismo economicistico: “l’odio dell’economia è il contrassegno della religione”. I nostri autori assumono spesso una prospettiva chiliastica, quasi come se avessero il sentore di un imminente inizio di qualcosa di realmente nuovo: il tono dei loro scritti è, perciò, frequentemente profetico, come in questo breve brano di Schlegel: “prossimamente si manifesterà religione: essa è la grande incognita dell’epoca. Religione, cioè contrappeso dell’economia”.
BIOGRAFIE


Friedrich Schlegel e Novalis (pseudonimo di Georg Philipp Friedrich von Hardenberg) nascono entrambi nel 1772: dei due, il primo è meno geniale ma sicuramente più inventivo sul piano teorico; il secondo, invece, è il poeta per antonomasia. Schlegel è figlio di un pastore protestante e di un’insegnante di matematica: la sua è una famiglia assai colta, che lo indirizza alla carriera di commercio. Ma, come spesso accade nelle biografie dei grandi personaggi, egli non è soddisfatto di tale carriera e decide perciò di cambiare rotta: si prepara da solo all’Università, percorrendo in pochi anni il percorso del Liceo. A diciassette anni assimila interamente, nell’arco di soli tre anni, la letteratura e la filosofia greca. Nel 1790, a Gottinga, si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza, per poi trasferirsi a Lipsia, dove intrattiene i suoi primi contatti col mondo e inizia, per così dire, a mondanizzarsi. Due anni dopo, nel 1792, egli formula il proponimento di diventare “uomo di mondo” e incontra lì, per la prima volta, Novalis, anch’egli studente. I due stringono un legame di amicizia molto forte e, quando si separano per le vacanze estive, Novalis scrive una lettera – nell’agosto dello stesso 1792 – a Schlegel, in cui afferma: “grazie a te ho imparato a conoscere il cielo e l’inferno”. Questa frase, che a prima vista parrebbe un’espressione di gratitudine per esperienze conoscitive e culturali condivise con l’amico, allude invece ad esperienze di tutt’altro genere, in particolare ad avventure amorose con due ragazze sorelle di cui i due, all’epoca ventenni, avevano fatto conoscenza. Il che peraltro conferma come perfino l’emancipazione sessuale costituisca un momento fondamentale della generale emancipazione fatta valere dai giovani Romantici. Una delle due sorelle, quella a cui si era legato Schlegel, aveva ventiquattro anni; l’altra, quella di Novalis, ne aveva appena diciassette e l’amore per donne giovanissime resterà una costante nella vita di Novalis. Nel 1793 abbandonano entrambi la facoltà di Giurisprudenza: Schlegel si trasferisce a Dresda, ove a soli ventidue anni compone le sue opere più famose, che lo consacreranno ad una fama imperitura; esse saranno poi pubblicate qualche anno più avanti, nel 1797. Nell’estate del 1796, egli si sposta a Jena, dove ritrova l’amico Novalis: entrambi subiscono l’influsso decisivo di Fichte, che teneva le sue lezioni presso l’ateneo di Jena. La prima grande opera di Schlegel a vedere la luce è I Greci e i Romani; il secondo capolavoro si intitola Sullo studio della poesia greca. Entrambe testimoniano dell’attenzione riservata al mondo greco. Prima della rivoluzione romantica, il giovane Schlegel è un fervido seguace di Winckelmann ed è un neoclassico dichiarato: ma già nel 1797 egli cambia rotta e, sulle pagine della rivista Liceo, pubblica frammenti che annunciano la svolta romantica. La formulazione compiuta della nuova e dirompente dottrina arriverà tra il 1798 e il 1800, gli anni in cui vede la luce la celebre rivista Ateneum, sulla quale Schlegel e Novalis pubblicano una nutrita serie di frammenti che danno una compiuta formulazione della teoria romantica. Inoltre Schlegel vi pubblica il Dialogo sulla poesia, che contiene l’importantissima Lettera sul romanzo, in cui è esposta la tesi del Romanticismo come teoria del romanzo. Nel 1798, ha luogo a Dresda il primo incontro dei Romantici: vi prendono parte Novalis, i due fratelli Schlegel (Friedrich e Wilhelm), Schelling e Fichte. Ma sarà a Jena che la cerchia romantica giungerà al completo. Al 1799 risale il più grande romanzo di Schlegel, intitolato Lucinde e fortemente autobiografico: esso desterà grande scalpore perché si presenta come un romanzo erotico, che racconta la convivenza intrattenuta da Schlegel con Dorothea Mendelssohn, la divorziata nipote, nota per la sua immensa cultura, di quel Moses Mendelssohn fondatore della “filosofia popolare tedesca”. Nel 1801 si trasferisce a Berlino, ma il 25 marzo di quello stesso anno muore Novalis, all’epoca appena ventinovenne: ciò segna la fine del primo romanticismo. Scomparso il suo amico, la storia del pensiero di Schlegel è la storia di un progressivo allontanamento dal Romanticismo, processo che giungerà al culmine nel 1808, quand’egli scriverà Sulla lingua e sulla saggezza degli Indù, opera che testimonia del suo nuovo interessamento orientalistico. Sempre nel 1808, egli si converte al Cattolicesimo. Nel 1814 pubblica un’interessante storia della letteratura antica ed è al servizio di Metternich a Vienna: ormai lontanissimo dal suo romanticismo iniziale, Schlegel è ora un cattolico tradizionalista. Così, nel 1829, si chiude il suo itinerario biografico e intellettuale. Sull’altro versante, Novalis, nato anch’egli nel 1772, è di famiglia nobile. Nel 1781 è soggetto a una malattia che, in breve tempo, lo trasforma in genio precoce; egli studia a Jena, dove segue i corsi di Schiller. Nel 1794 consegue la laurea in Diritto ed è amministratore delle miniere in Sassonia: l’attività del minatore che si cala negli abissi della terra per estrarne i diamanti come metafora del poeta che scava in sé per portare alla luce i suoi sentimenti sarà a lui particolarmente cara. Nel 1794, incontra Sofia, una ragazza che aveva all’epoca appena dodici anni. Nel 1795, studia la filosofia con dedizione, viene a conoscenza della dottrina della scienza di Fichte e, nel marzo di quello stesso 1795, si fidanza con Sofia. Quest’ultima, però, a novembre contrae la tisi, che la porterà a morire nel 1797: dalla morte della donna amata, Novalis prenderà spunto per tratteggiare il celebre nesso romantico tra amore e morte. Col titolo Polline, egli pubblica nel 1798 sulla rivista Ateneum un pulviscolo di frammenti e, nello stesso anno, esce il suo romanzo, intitolato I discepoli di Sais: questa traduzione italiana rende in maniera poco corretta quella tedesca, che suona Die Lehrlinge zu Sais, dove il termine “Lehrlinge” andrebbe tradotto, più che con “discepoli”, con “apprendisti”, in riferimento alla massoneria – con cui il Romanticismo ha forti legami – e alla sua gerarchia di iniziazione. Continua a studiare filosofia e, nel dicembre del 1798, si fidanza di nuovo, pur giurando eterna fedeltà alla defunta Sofia, che per lui svolge le stesse funzioni della Beatrice di Dante o della Laura di Petrarca e che, pertanto, incarna in pieno l’eros platonico. Nel 1799 pubblica Cristianità o Europa e nel 1800 – su Ateneum – gli Inni alla notte (toccando il tema, squisitamente romantico, della notte contrapposta ai Lumi dell’Età della Ragione) e il suo romanzo più celebre: Enrico di Ofterdingen. Ammalatosi di tisi, termina la sua esistenza nel 1801, quando aveva soltanto ventinove anni.
LA LEZIONE DI ROUSSEAU, KANT E FICHTE
Il Romanticismo si pone innanzitutto in forte polemica con quella riduzione dell’uomo ad amor proprio e a ragione calcolatrice operata dalla modernità e giunta a compimento con l’Illuminismo. La prima reazione a questa indebita riduzione era avvenuta nell’Inghilterra, con i cosiddetti “filosofi del sentimento” (Shaftesbury e Hutcheson in primis): questi, in risposta alla riduzione dell’uomo a ragione e ad amor proprio, vanno sostenendo che l’uomo è innanzitutto sentimento e, nel sostenere tali tesi, esercitano un’influenza decisiva sul pensiero di Rousseau, che per molti versi si presenta come l’antesignano del Romanticismo. Al cuore della sua riflessione vi è una dura critica contro la cultura illuministica, colpevole di aver innalzato la riflessione critica e calcolatrice a unica dea. Ma tale riflessione razionalistica, lungi dal trasformare la terra in paradiso, – nota Rousseau – non fa che causare tutti quei mali che pretenderebbe invece di guarire: sicché essa è non il rimedio, ma la causa di tutti i mali, primo fra tutti la nascita dell’amor proprio. Con la riflessione si operano distinzioni e, conseguentemente, contrapposizioni (io/tu e, poi, mio/tuo): nasce così la tendenza a paragonarsi e a contrapporsi e da ciò rampolla la volontà di primeggiare dell’io sul tu. Proprio questa divisione generata dalla riflessione critica, implicante l’amor proprio e, dunque, la volontà di primeggiare sugli altri fa sì che la società moderna sia il regno dell’odio reciproco, della diffidenza, della dissimulazione e dell’insincerità, opportunamente nascoste sotto la vernice delle buone maniere. Si tratta allora di una società da cui è bandita la felicità e in cui tutti temono tutti e in cui nessuno è se stesso, giacché si ritrova ad indossare maschere per meglio abbindolare gli altri. L’errore fatale dell’Illuminismo sta dunque nell’aver preso per rimedio dei mali quella che invece ne era la causa scatenante: l’amor proprio, fortificato dalla ragione calcolatrice. Ma l’uomo – rileva Rousseau – non è soltanto ragione calcolatrice e amor proprio; è anche e soprattutto un duplice sentimento: amor di sé e pietà. L’amor di sé di cui parla positivamente Rousseau non dev’essere però confuso con l’amor proprio che egli aborre e che gli Illuministi avevano portato alle stelle: se l’amor di sé è al di qua di ogni riflessione, l’amor proprio è invece il figlio legittimo della riflessione. Da ciò si evince come l’amor di sé, proprio perché a monte della ragione calcolatrice, non instauri paragoni e, in forza di ciò, non entri in conflitto con gli altri e possa pacificamente convivere con la pietà per gli altri: da esso traggono origine tutte le più grandi virtù, la clemenza, la generosità, ecc. Sicché, quando Rousseau invita a tornare alla natura, egli esorta a tornare a questa dimensione situata a monte della ragione calcolatrice e dominata dall’amor di sé e dalla pietà. Basta che l’uomo si apparti anche solo per un attimo dal rumore assordante prodotto dalla ragione e dalla teorie filosofiche che da essa proliferano, e subito ritrova l’immediata certezza del proprio intimo ed immediato sentire (ovvero dell’amor di sé e della pietà): a parlare è allora la voce della coscienza, il nostro profondo sentire rimasto incorrotto nonostante il proliferare del calcolo razionale. Ciò di cui Rousseau sta qui parlando è la naturale bontà dell’uomo: egli rivendica un intervento correttivo che guerreggi contro una ragione che pretende di essere la sola guida dell’uomo. E il grande progetto che sta al cuore del romanzo La nuova Eloisa si risolve per l’appunto in un tentativo, ambizioso e talvolta lacunoso, di coniugare tra loro il sentimento e la ragione, in misura tale che non si prevarichino a vicenda. Accanto a Rousseau, anche Kant costituisce una delle grandi fonti a cui si abbeverano i Romantici: anch’egli protesta vibratamente contro l’utilitarismo e l’eudemonismo illuministico, rifiutandone la concezione dell’uomo come mera sensibilità e amor proprio. Sugli imperativi ipotetici proposti dalla ragione calcolatrice non si può costruire una morale, giacché essi non mirano che all’utile e alla felicità, limitandosi ad indicarci per quali vie incamminarci per conseguirli. Ma, oltre ai suggerimenti della ragione calcolatrice, l’uomo avverte in sé la voce della ragion pura pratica, dell’imperativo categorico che mira unicamente a improntare il comportamento umano ad un agire universale e disinteressato, nonché puramente razionale. Le affinità col discorso di Rousseau sono fin troppo evidenti: il filosofo ginevrino espleta in ambito di ragion pratica la stessa funzione espletata da Hume in ambito di ragion pura, destando Kant dal sonno dogmatico in cui era sprofondato. Nello sforzo di conformare l’agire all’imperativo categorico, vincendo la resistenza opposta dalla sensibilità, l’uomo esercita la propria libertà, essendo libero di non lasciarsi determinare dai sensi, dalle pulsioni, dalle volizioni e dalle inclinazioni sensibili. Tanto Kant quanto Fichte sottolineano il valore umano dello sforzo morale come manifestazione della libertà umana: la coscienza finita dell’uomo è coscienza essenzialmente morale, è sforzo verso un ideale di pura razionalità che, essendo irraggiungibile, mantiene in perenne tensione la coscienza umana. Questo punto di vista è ottimamente compendiato nelle Lettere sul dogmatismo e sul criticismo (1795) di Schelling, che qui ancora si muove in una prospettiva lato sensu fichteana, a tal punto da sostituire la felicità con la libertà della ragion pratica, la quale esclude ogni forma di eudemonismo: “quanto più diventiamo liberi, tanto meno necessitiamo della felicità, che dobbiamo alla sorte […]. Nella misura in cui avanza sulla via della moralità, l’uomo libero si vede innalzato al di sopra dell’ideale sensibile di felicità”, poiché la ragion pratica si sforza per giungere all’assoluta identità con se stessa, cercando cioè di diventare pura e illimitata libertà. E questa è anche la beatitudine, l’attingimento dell’illimitata libertà razionale che permette di approdare alla poesia della vita libera, innalzandosi al di sopra della vita prosaica fatta di appetiti sensibili. Quello di Kant è dunque il punto di vista di una coscienza finita che riflette sul proprio conoscere, mettendone in luce i limiti oltreché le potenzialità. Il filosofo si domanda anche il perché del nostro conoscere e, a tal domanda, risponde che ciò avviene in forza del fatto che la ragion pura connette, ad esempio, in maniera causale certi fenomeni situati nel tempo e nello spazio. Come i bambini rompono i giocattoli per vederne le parti e per poter così capire come essi funzionino, similmente Kant scompone le parti del nostro conoscere (il materiale sensibile e la nostra struttura a priori); la sintesi di queste parti dà appunto quella che chiamiamo conoscenza. Sicché conosciamo il mondo perché il nostro conoscere è fatto di dati sensibili riorganizzati dalla struttura a priori. La prospettiva cambia radicalmente nella Critica della ragion pratica, giacché non è possibile dedurre la ragion pratica in quanto essa è un fatto nella cui presenza ci troviamo e che dobbiamo necessariamente accettare come tale. E pertanto Kant non risponde a domande del tipo “perché sentiamo in noi la voce dell’imperativo categorico?”: si limita a notare com’esso sia un dato di fatto che non consente alcuna deduzione. E allora, nella Critica della ragion pratica, il filosofo tedesco riflette sulla praticità della ragion pratica, illustrandone le conseguenze: se agiamo moralmente, allora ne consegue che siamo liberi, che esiste Dio e che la nostra anima è immortale. In altri termini, la ragion pratica, che esiste come fatto, postula la libertà, l’esistenza di Dio e l’immortalità dell’anima. Ma ciò non toglie che anche qui, al pari della Critica della ragion pura, si resti in un punto di vista finito. Anche il pensiero di Fichte è un faro costante per i Romantici: al centro della sua riflessione morale è, come in Kant, la nozione di Streben, ossia dello “sforzo” a cui è chiamato l’uomo per vincere la sensibilità. La sua è una filosofia “trascendentale”, in quella duplice valenza del termine fissata da Kant nella Critica della ragion pura: “chiamo trascendentale ogni conoscenza che si occupa non degli oggetti, ma del nostro modo di conoscerli”. In questa prima accezione, trascendentale è la conoscenza delle possibilità di conoscenza, ossia la riflessione critica sulla natura del conoscere. È detta “trascendentale” perché trascende il mero conoscere ignaro di sé, ma anche perché è pur sempre un conoscere che non trascende la conoscenza umana in quanto tale (ché altrimenti sarebbe non già trascendentale, ma trascendente): resta cioè un punto di vista finito. In secondo luogo, trascendentale è anche la struttura a priori del nostro conoscere, cioè quel qualcosa che antecede la conoscenza rendendola possibile (le intuizioni sensibili dello spazio e del tempo, le forme a priori delle dodici categorie, l’Io penso). In una terza possibile accezione, trascendentale è quella componente del nostro conoscere che trascende il singolo soggetto empirico, poiché è presente, in forma uguale, in tutti gli uomini. La Dottrina della scienza di Fichte muove direttamente dal Kant della Critica della ragion pratica e, pur mantenendosi nel punto di vista della coscienza finita, riesce a dedurre ciò che Kant non era riuscito a dedurre: la praticità della coscienza finita, il suo essere moralità. Ciò costituisce l’essenza della coscienza umana: ne segue allora che l’uomo è soprattutto moralità e che il rigorismo etico kantiano diventa ossessivo. Il conoscere stesso è, agli occhi di Fichte, funzione ed espressione dell’essere ragion pratica dell’uomo. Ma che cosa fa sì che la coscienza umana sia eminentemente moralità? Naturalmente – puntualizza Fichte – non tutti gli uomini sono in pari grado moralità, e anzi gli eroi morali sono rare eccezioni in un mondo di briganti e truffatori; ma ciò non di meno l’imperativo categorico è istanza incancellabile nell’uomo, in ogni uomo. E la riflessione di Fichte procede come quella kantiana: se Kant aveva rotto il giocattolo della conoscenza nelle sue parti, Fichte si propone di rompere la coscienza morale per poterla spiegare. In particolare, egli analizza la coscienza pratica, la scompone e ne mostra le relazioni. L’Io finito è coscienza pratica perché è sforzo teso ad attuare l’imperativo categorico, vincendo la resistenza della sensibilità: ma che cos’è che rende possibile ciò? Anche la coscienza pratica è sintesi di due opposti, di una tesi e di un’antitesi: è cioè composizione di un’opposizione. In questo caso, tesi e antitesi sono le condizioni preconsce che solo la riflessione trascendentale riesce a cogliere, mettendole in luce mediante astrazione: la riflessione trascendentale è allora un retrocedere nell’anticamera incoscia della coscienza. Così lo sforzo pratico è sforzo incessante di essere la ragion pura pratica, senza sensibilità: siamo qui in presenza di un’attività finita? Oppure infinita? Se fosse finita, agirebbe mossa solo da imperativi ipotetici, cosicché in presenza di un oggetto piacevole direbbe solamente come agire per ottenerlo e, ottenutolo, si acquieterebbe. Ma un tale agire è tutto fuorché morale, giacché è interamente votato al soddisfacimento di bisogni sensibili. L’azione morale è invece un qualcosa di incessante e ha per fine la ragione stessa e, dunque, non è indotta dall’esterno: è piuttosto innata e radicale, tale da non potersi mai acquietare. Il fine (la pura razionalità) non è mai raggiungibile, ma comunque lo sforzo della ragion pratica mai si tacita, ma anzi sempre e di nuovo rinasce in noi. Un tale sforzo è frutto di un’attività infinita: non si esaurisce conseguendo uno scopo, ma sempre e di nuovo rinasce, anche se lo scopo mai è raggiunto. Il nostro sforzo è allora quello di un’attività infinita che, se ostacolata, si sforza di tornare alla sua illimitatezza, rimuovendo il limite: “la praticità dello spirito finito è la sua destinazione eterna, la sua infinità; è ciò per cui lo spirito è infinito”. E dunque “lo sforzo è attività infinita che, limitata, non rinuncia alla propria infinità […]. Lo sforzo è precisamente la sintesi fra attività pura e limite, e cioè è attività limitata ma che ancora contiene lo slancio della sua infinità”. Questo è il risultato cui perviene la riflessione trascendentale, componendo la coscienza pratica e scoprendo che essa è attività infinita limitata sempre e di nuovo da un limite. E attività infinita e limite costituiscono per l’appunto la tesi e l’antitesi di cui prima dicevamo, delle quali la coscienza è sintesi. In termini fichteani, la tesi è “l’Io pone se stesso”, l’antitesi “l’Io oppone a sé un non-Io”. La sintesi risultante sono le coscienze finite umane di fronte al mondo entro cui agiscono moralmente: questo punto, espresso in termini fichteani, recita che “l’Io oppone nell’Io all’Io divisibile un non-Io divisibile”. La tesi è l’attività infinita dell’Io, è la ragion pura pratica in quanto inesauribile e illimitata attività identica a se stessa. Quest’attività infinita compone la nostra coscienza in quanto, in presenza del limite, essa tende a superarlo cercando con sforzo di recuperare la propria identità di attività infinita che sarebbe se non fosse limitata. Ma che cos’è che la limita? È la sensazione, o meglio il nostro sistema delle sensazioni: questa è l’antitesi contro cui urta l’attività infinita della ragion pura pratica, costretta alla condizione di sforzo per superare le sensazioni che le si oppongono. In quanto coscienze finite, siamo composte dall’attività infinita della ragion pratica che, in presenza di un limite che la ostacola, diventa lo sforzo sempre reiterato di recuperarsi alla sua condizione di infinità. Le sensazioni sono precisamente l’ostacolo contro cui cozza la coscienza: esse provengono dall’Io stesso, cui è congenito l’autolimitarsi, cosicché da sempre l’Io sussiste come sforzo perché da sempre esso si limita diventando la totalità delle sensazioni. Sicché le coscienze che siamo sono frutto di uno sforzo di essere se stesse superando l’ostacolo che si sono poste. È questa la preistoria inconscia della coscienza a cui perviene la riflessione trascendentale. L’attività infinita dell’Io è già sempre l’intero sistema delle sensazioni contro cui essa urta. In realtà, a sussistere sono sempre le singole coscienze finite, composte dallo sforzo infinito volto a superare l’ostacolo che esse si pongono. Diventando attività conoscitiva, l’Io trasforma l’urto in un ostacolo superabile, mutando la molteplicità delle sensazioni nella rappresentazione del mondo. L’Io infinito tende a limitarsi e, per ciò stesso, diventa la molteplicità delle sensazioni; ma, essendo infinito, reagisce all’ostacolo, non ne è annientato: la reazione all’ostacolo si sviluppa in due momenti, uno conoscitivo e l’altro morale. Nel primo momento, la massa delle sensazioni è trasformata in rappresentazione spazio/temporale del mondo e ciò avviene perché l’Io si è fatto coscienza teoretica (cioè immaginazione produttiva). Avendo reso l’urto superabile, in veste teoretica, l’Io diventa attività morale: la ragion teoretica trapassa in ragion pratica, poiché è solo così che può realmente superare quell’ostacolo reso superabile dalla ragion teoretica. Ed è per questo motivo – ossia per il fatto che solo la ragion pratica può trionfare sul limite – che Fichte mai si stanca di ribadire la superiorità della ragion pratica su quella teoretica: l’essere anche ragion teoretica è funzionale alla ragion pratica, giacché solamente se costruiamo un mondo attraverso l’attività teoretica possiamo poi agire in esso moralmente. In quest’ottica, le sensazioni si riducono ad autoaffezioni dell’Io: se rimanesse soltanto un magma di sensazioni, l’Io non potrebbe essere sforzo morale. Esso invece reagisce in due battute, facendosi dapprima coscienza teoretica (e dunque rendendo le sensazioni rappresentazioni spazio/temporali) e poi, costruitosi un mondo di rappresentazioni, facendosi coscienza pratica. La sensazione interrompe l’attività pura dell’Io, la quale diventa sforzo di recuperarsi alla propria situazione facendosi teoresi e poi attività pratica. L’Io riflette su di sé fino a scoprire in tutto ciò che lo circonda una propria autolimitazione: il mondo non è che il limite che l’Io si autopone; se il mondo è posto inconsapevolmente dall’immaginazione produttiva (che trasforma le sensazioni in rappresentazioni), allora l’intera conoscenza si risolve in aspetti e gradi diversi della stessa immaginazione produttiva, che proietta le sensazioni in oggetti che noi dapprima crediamo esterni all’Io. Scrive Fichte: “poiché all’Io non appartiene nulla ch’esso non ponga, bisogna che questa limitazione la ponga lui. Porre tale limitazione è ciò che si chiama sentire”. L’Io, da sempre, si modifica in sensazione e lo fa inconsciamente: “attraverso l’immaginazione, il sentimento passa nella vita conoscitiva facendosi intuizione spazio/temporale”. Quel che Fichte non fa è dedurre il finito da un infinito che lo precede: riflettendo sulle condizioni del finito, vi individua un’attività infinita come una delle sue condizioni. Tale attività infinita esiste da sempre come reazione al limite: siamo attività infinita autolimitatasi e reagente a tale limitazione prima come conoscenza, poi come sforzo pratico. L’immaginazione produttiva racchiude la conoscenza trascendentale di cui parlava Kant e l’attività dell’Io è insieme attività e freno a quest’attività: “la coscienza dello spirito è l’attività della ragione che si cerca”. Siamo e conoscenza e praticità, e il nostro essere le due cose è lo sforzo della ragione ostacolata di autoritrovarsi. Quando l’Io non sussiste mai come Io puro, è sempre un Io finito, che reagisce al proprio limite ed è perciò in perenne ricerca di se stesso: a sussistere è solo l’identità in cerca di se stessa, non l’identità pura. Pertanto non c’è un infinito reale fuori e prima del finito: l’infinito esiste solo nel finito, come sforzo d’essere infinito, cosicché l’agire del finito è l’attività stessa dell’infinito, attività che esiste sempre e solo come ostacolata e in cerca di sé. L’unico infinito reale è l’infinito tendere del finito. La tesi e l’antitesi sono condizioni reali di ciascuno di noi che la riflessione filosofica, astraendo, proietta in una preistoria puramente filosofica: se l’Io è sforzo morale, allora in lui vi saranno l’attività infinita e la sua autolimitazione. Cerchiamo di tirare le fila su quanto finora detto circa Fichte: alla domanda “di che cosa siamo fatti, noi singole coscienze morali e, per ciò stesso, libere?”, egli risponde che a costituirci è un’infinita (cioè inesauribile e illimitata) attività della ragion pura pratica, cioè l’infinito autoaffermarsi dell’Io in quanto attività morale e il suo simultaneo autolimitarsi diventando la molteplicità delle sensazioni. Da sempre l’infinita attività morale così si limita: siamo fatti di un’infinita attività morale e dalle sensazioni, diventando le quali essa si è limitata. Proprio perché siamo siffatti, siamo quel che siamo (finite coscienze morali libere), ovvero siamo lo sforzo etico che siamo: più precisamente lo sforzo pratico (teoretico/pratico) dell’Io di recuperarsi oltre il limite, vale a dire lo sforzo d’essere ciò che virtualmente sarebbe (pura auto-identità) se da sempre e per sempre non si limitasse. Ci rappresentiamo il mondo trasformando l’oscuro sentire in un mondo fatto di oggetti situati spazio/temporalmente: così facendo, il limite è trasformato in ostacolo superabile, in mondo di oggetti nel quale progettare e attuare i propri fini. Già essendo coscienza teoretica, la coscienza umana finita è sforzo pratico dell’Io di autorecuperarsi, ma tale sforzo inizia come coscienza teoretica. Avvertiamo la voce dell’imperativo categorico e lottiamo contro i sensi nel tentativo sempre reiterato di affermare la razionalità pura dell’Io. Ciò vuol dire che siamo fatti di una cosa sola, ossia dell’infinita attività morale dell’Io, che è il principio primo dell’intera realtà. Tale infinita attività è il principio che però non sussiste di per sé separato e anteriore, ma solo nelle sue modificazioni, come sforzo teoretico/pratico. Dei tre principi che Fichte enuncia, i primi due sono astrazioni operate dalla riflessione: l’Io e il non-Io non sussistono mai come tali, esiste sempre il terzo principio, cioè la molteplicità delle coscienze finite e la molteplicità degli oggetti finiti che esse si rappresentano come sintesi di tesi e antitesi. Fichte per un verso ha dedotto le coscienze finite umane pratiche, per un altro è pervenuto ad una concezione in cui il finito si trova assolutizzato: Kant aveva postulato la libertà senza dedurla, mentre Fichte si sente in grado di dimostrarla; al contrario, ogni prospettiva realistica che parli di un mondo reale slegato dalla coscienza non può che avere un esito deterministico e negatore di ogni libertà. Sicché la più coerente esposizione del materialismo è quella del sensismo francese, in cui l’uomo è inteso come zimbello delle sue passioni e della sensibilità. Fichte dimostra che è la libertà dell’Io a fondare il non-Io, limitandosi liberamente: l’Io resta indipendente dalla sua limitazione, che ha lui stesso posto con un atto libero. La libertà è allora tale precisamente per il fatto che è essa stessa a porre il mondo esterno: lungi dall’essere passiva, la ragione è attività pura. Nulla può l’antitesi contro la tesi: può sì limitarla, ma mai sopprimerla. Così l’idealismo spiega la libertà pratica, mentre il realismo sortisce esiti deterministici. La prospettiva fichteana si chiude con una assolutizzazione del finito: la coscienza finita è tutta la realtà, cioè l’assoluto non esiste se non come infinito tendere a se stesso. L’unico modo di essere dell’identità è l’identità in cerca di sé. L’Io assoluto, allora, non esiste prima e fuori del finito delle coscienze, ma esiste unicamente nel finito e come finito, ovvero come sforzo pratico/teoretico. Il discorso di Fichte sull’Io assoluto non riguarda un Io assoluto che crea il mondo precedendolo ontologicamente: l’assoluto resta ideale e solo infinito è reale, mentre il finito resta coscienza finita di un singolo essere riflettente su di sé. Dire che solo il finito è reale equivale a dire che l’assoluto è reale solo nel finito, come attività del finito stesso: lo spirito finito è tutto, ma non è l’assoluto compiuto; l’assoluto è allora un ideale verso cui il finito tende senza tregua. Fichte afferma l’indeducibilità della molteplicità concreta delle cose: sia la molteplicità delle cose sia quella delle coscienze rientra nella categoria del fatto e dell’accidentale, ragion per cui non v’è risposta a domande del tipo “perché questo mondo?”, o “perché questi individui?” o ancora “perché ci rappresentiamo questo nostro mondo?”. Il contenuto concreto delle coscienze individuali resta, nella sua contingenza e concretezza, insondabile per la riflessione trascendentale, la quale riesce però a dedurre i tratti e la struttura generale della coscienza finita, ma non il suo contenuto. Perciò tutte le domande relative ai contenuti empirici (ad esempio “perché questo corpo?”, “perché questo mondo?”, e così via) sono domande impertinenti, alle quali Fichte non risponde, in quanto esulanti dalla riflessione trascendentale. In un celebre frammento, Schlegel nota che Fichte, la Rivoluzione Francese e il Guglielmo Meister di Goethe sono i vanti dell’epoca e, in un altro frammento, fa cenno all’accusa di ateismo intentata a Fichte: “Fichte avrebbe dunque attaccato la religione? Se l’essenza della religione è interesse per il soprasensibile, allora tutta la sua dottrina è religione in forma di filosofia”. Da ciò si evince l’influsso che Fichte esercitò sui giovani Romantici: l’uomo di cui egli parla è in costante tensione verso l’infinito, ripudia gli scopi sensibili e finiti di cui fa vanto l’Illuminismo.
IL PENSIERO DI SCHLEGEL
Lo svilupparsi del razionalismo moderno avviene attraverso un’aspra e lunga polemica anti-aristotelica. Sia la scienza moderna sia il razionalismo crescono polemizzando senza sosta non già contro lo spirito dell’aristotelismo, bensì contro la sua lettera. E del resto lo spirito aristotelico era profondamente razionalistico e naturalistico (cioè empirico) e, pertanto, affine a quello dei moderni. L’accusa che questi ultimi muovono ad Aristotele non è pertanto quella di essere naturalista e razionalista, ma piuttosto quella di essere inconseguente tanto nel suo naturalismo quanto nel suo razionalismo. È incoerente nel naturalismo perché muove dai sensi, senza far ricorso all’anamnesi platonica, ma finisce poi per smarrire il naturalismo quando, pervenuto alla definizione (attraverso l’astrazione e la deduzione), il suo pensiero diventa deduttivo, prescindendo dall’esperienza e lavorando di soli sillogismi. Altrettanto inconseguente è Aristotele nel suo razionalismo, giacché la sua celebrazione della ragione finisce per rovesciarsi in condanna della medesima: alla sua ragione manca infatti quella criticità tipicamente moderna, la consapevolezza non solo di ciò che essa può fare ma anche di ciò che non può fare. Ecco perché poi tale ragione acritica e inconsapevole di sé sortisce quello pseudo-sapere metafisico che i moderni rigettano come chimerico. La ragione dei moderni, consapevole dei propri limiti intrinseci, non si avvita su inutili speculazioni metafisiche, ma ciò non di meno è in grado come non mai di civilizzare la terra: in particolare, con l’Illuminismo a trionfare è la ragione calcolatrice, il cui trionfo è quello dell’intelletto riflettente (Hegel) e della prosa, nel senso del trionfo del genere letterario prosastico. Se la ragione ha da vincere, allora deve trionfare la prosa piana e chiara in cui tale ragione meglio si esprime e che nell’uomo costituisce il linguaggio più alto, di fronte al quale altre forme (la poesia, la musica, ecc) hanno funzione esornativa o di intrattenimento. In questo panorama, si spiega come Bach e Mozart, due dei grandi geni musicali dell’epoca, siano del tutto assenti dalla vita culturale del Settecento: lo stesso Mozart era costretto a pranzare coi servi, a sancire la funzione servile della musica. Ancora nella Critica del Giudizio, e dunque sul tramontare del secolo XVIII, Kant sostiene che la musica ci parla per mere sensazioni, senza lasciare alcunché alla riflessione: proprio in forza di ciò, essa “è piuttosto godimento che cultura”, è l’infima fra le arti e le spetta la sola funzione di titillamento dei sensi. Questa situazione è il portato di una ragione eminentemente prosastica, cosicché l’Illuminismo si configura come trionfo della prosa sul piano stilistico e una tale forma letteraria dà il meglio di sé nella miriade di trattati, tutti aventi per oggetto la felicità, che fioriscono nell’età dei Lumi. Oltre a ridurre a prosa ogni arte, l’Illuminismo abbassa a prosa l’intera vita dell’uomo, rinchiudendolo nel finito: e il trionfo di quest’ultimo esclude ogni sforzo volto a trascendere la finitezza, cosicché si è in presenza di un finito rinchiuso entro e su se stesso. “Ut pictura poesis”, diceva Orazio nell’Ars poetica: gli Illuministi, rovesciando il motto oraziano, sostengono che è la pittura a dover essere come la poesia e, in particolare, deve narrare gli accadimenti storici, rendendo il più possibile manifesta la ragione. Quella da loro operata è allora un’autentica riduzione della vita a prosa, cosicché – nota Schlegel – “gli uomini comuni venerano tutto ciò che è ordinario e mediocre e considerano diabolico lo straordinario”. Gli uomini in comune di cui qui si parla sono quelli che “restano incollati alla terra”, come precisa Schlegel utilizzando un’espressione che inciderà profondamente su Hegel (il quale, com’è noto, definisce la modernità come “conversione dal cielo alla terra”). In questo senso, gli uomini comuni sono meri ingranaggi della macchina produttiva, sono numeri di una funzione politica: conducono un’esistenza umbratile, di contro a quanti vivono in maniera autentica (tematica che tornerà con insistenza nell’esistenzialismo). Scrive Schlegel: “Dapprima l’uomo borghese viene non certo senza sforzo lavorato e tornito fino a farne una macchina; avrà poi fatto la sua felicità? Allorché sarà diventato anche un numero nella somma politica e si potrà dire di lui che è perfetto sotto ogni punto di vista quando finalmente sarà diventato un fantoccio. E come i singoli, così è anche la massa: si nutrono, si sposano, generano figli e invecchiano e lasciano dietro di sé figli che vivono allo stesso modo”. Ma perché una tale massificazione? Perché – risponde Schlegel – “sono pochi gli uomini che siano degli individui” e la maggior parte degli uomini, come i “mondi possibili” di Leibniz, sono dei pretendenti all’esistenza, di contro ai pochi che esistono veramente. In un tono alquanto simile, scrive Novalis: “costoro vivono solo la vita di ogni giorno, tutto ciò che fanno lo fanno solo in vista della vita terrena; a questa loro vita mescolano quel poco di poesia che sembra loro necessaria […]”, interrompendo di tanto in tanto la vita ordinaria e concedendosi brevi spazi di vita “poetica”: “di norma, questa interruzione avviene ogni sette giorni e la si potrebbe definire una poetica febbre settanica. La domenica il lavoro cessa, vivono un po’ meglio del solito e questa ebbrezza domenicale si conclude con un sonno un po’ più profondo […]. Il massimo grado di esistenza poetica costoro lo vivono in occasione di un viaggio, di un battesimo, di un matrimonio […]. Ma un rozzo interesse egoistico è il risultato di una grezza limitatezza”. Quella che i più si trovano a condurre è allora un’esistenza ordinata solo ad una fitta trama di scopi finiti e, proprio per ciò, essa appare tanto a Schlegel quanto a Novalis come il frutto di un’aberrazione: “avere degli scopi, agire secondo scopi e collegare artificialmente uno scopo all’altro in vista di sempre nuovi scopi è aberrazione profondamente radicata nella stolta natura dell’uomo” (Schlegel), prodotta dal trionfo dell’empiria e dell’economia, le quali costringono l’uomo alla finitezza. Proprio in ciò riposa la ragione dell’inautenticità di una tale esistenza, poiché “ciò che è solo qualcosa esiste solo in senso improprio” (Schlegel). Ecco perché la logica dell’utile e della produttività è aberrante: essa esige un attivismo frenetico che però immobilizza nella condizione di esseri finiti, un attivismo frenetico in virtù del quale ci si muove molto senza andare da nessuna parte (un po’ come capita nei cartoni animati, in cui spesso i personaggi muovono con incredibile rapidità le gambe su se stessi, senza però spostarsi). E tale costrizione alla limitatezza trova espressione nelle convenzioni borghesi, ossia in quelle mortificanti costrizioni ad un’esistenza impropria e tale da farle detestare da Schelgel. Quest’ultimo arriva a sostenere che “ogni utilità e attività è infernale e demoniaca”, giacché impedisce all’uomo di evadere dalle angustie del “solo qualcosa” che di volta in volta egli è. Per queste ragioni, Schlegel si sente legittimato a stendere un elogio dell’ozio, ovvero di quella che egli definisce come “divina arte” e a cui dedica un intero capitolo della Lucinde: al giorno d’oggi, l’ozio è condannato senza mezzi termini e ciò perché la borghesia è salita al potere, introducendo la sua concezione della vita come frenetica attività lavorativa incompatibile con l’oziare. Nell’antichità però ad essere condannato era non l’ozio, bensì il lavoro, che Virgilio nelle Georgiche etichetta come improbus labor. In sintonia con questa condanna, è quanto dice Senofonte: “il lavoro requisisce tutto il tempo e non lascia perciò tempo alcuno per la politica e per gli amici”. Da ciò si evince come la condizione d’eccellenza fosse per i Greci quella della scolh, per i Latini quella dell’otium (contrapposto al negotium), ovvero di quello che noi chiamiamo “ozio” e che ai loro tempi era reso possibile demandando il lavoro ad altri, soprattutto agli schiavi. Un ozio però non fine a se stesso, ma concepito come tempo libero da dedicare agli studi e alla cultura. Ancora Aristotele, quando tratteggia la divinità, la immagina come un filosofo a tempo pieno, ossia come oziosa e non impegnata dal lavoro, ma anzi tale da poter filosofare senza intermittenze. Questo quadro resta pressoché immutato dall’avvento del cristianesimo: la classe sacerdotale è infatti una classe di oziosi, ossia di gente che non è tenuta a lavorare. E la riforma benedettina, che pure introduce una rivalutazione del lavoro, resta un episodio marginale, com’è del resto provato dal fatto che nei monasteri il lavoro sussista in forma di penitenza e di castigo. Su questa scia, nel suo Commento alla Politica Tommaso definisce “viles artifices” i lavoratori. Anche la nobiltà feudale è consacrata all’ozio e non è eccessivo affermare che la cultura medievale ignori la concezione – tipicamente moderna – del lavoro come realizzazione dell’uomo. La valutazione positiva del lavoro coincide con l’avvento dell’Illuminismo ed è connessa all’utilitarismo: in questa nuova cornice culturale, oziose risultano quelle attività meramente contemplative (la religione e la metafisica) che sono incapaci di agire praticamente. Un caso sui generis sono le arti, le quali non vengono liquidate come inutili giacché esse ristorano il lavoratore e migliorano la qualità dell’esistenza abbellendola. Alla demonizzazione dell’ozio come padre di tutti i vizi, corrisponde dunque la moderna valutazione positiva del lavoro, che ben si inquadra nella polemica borghese diretta contro l’aristocrazia parassitaria: agli occhi dei borghesi, l’ozio aristocratico incarna tutti i vizi possibili. La valorizzazione del lavoro incontra la sua prima forma di elogio in Saint Simon (1760-1820), che negli anni 10-20 dell’Ottocento tematizza la concezione dell’uomo produttore e statuisce una dicotomia tra “produttori” (lavoratori attivi, creatori di sé e del collettivo benessere) – categoria in cui rientrano tanto i lavoratori salariati quanto gli industriali, i commercianti, gli scienziati, i contadini e gli artisti – e “fannulloni”, ossia gli oziosi, i nobili feudali, il monarca e la sua corte, i metafisici, il clero: tutti questi, che sono membri della classe dei fannulloni, appartengono secondo Saint Simon ad un ceto storicamente superato, poiché oggigiorno – dopo essere passati per lo stadio teologico e per quello metafisico – siamo giunti a quello positivo, in cui trionfa l’autoregolazione dell’industria e sono abolite la religione, la metafisica e perfino la politica. Sicché lo stadio positivo segna la transizione dallo Stato parassitario anti-industriale alla società produttiva e manageriale che si autoregolamenta in forza delle utili relazioni che si stringono fra le sue varie componenti. Nel 1819, Saint Simon attacca i fannulloni attraverso una favola sull’ozio: in essa, egli si domanda che cosa accadrebbe se la Francia perdesse all’improvviso i suoi cinquanta migliori chimici, ingegneri, banchieri e fisici. La risposta che egli fornisce è che, se ciò accadesse, il Paese diverrebbe immediatamente un corpo senz’anima e retrocederebbe rispetto alle altre nazioni concorrenti. Dopo di che, Saint Simon si domanda che cosa accadrebbe invece se la Francia perdesse all’improvviso la corte, il clero, i metafisici: la risposta è che ciò non avrebbe incidenza alcuna sulla vita politica e sociale del Paese. Da quest’arguta favola, che costò un processo a Saint Simon, affiora una nuova immagine dell’uomo, produttore frenetico e nemico dell’ozio e di chi lo pratica, ovvero di chi consuma senza produrre: “i vigliacchi del futuro sono gli oziosi”, arriva a dire Sant Simon. Si tratta di un mutamento epocale che ci mostra come il Romanticismo, che è elogio dell’ozio in polemica anti-illuministica, risulti alla fine perdente e sia superato da quella concezione borghese del mondo che ancor oggi è rimasta in piedi. Che la condanna dell’ozio sia ancor oggi viva più che mai è testimoniato da una ricca serie di detti comuni del tipo “è un gran lavoratore”, “è tutto casa e lavoro”, “una vita consacrata al lavoro”, “chi non lavora non mangia”. L’ozio che Schlegel predica è tale rispetto alle attività nelle quali i borghesi dissipano il loro io e il loro tempo: stornando da sé le lusinghe dell’economia e dell’utile che intrappolano l’uomo nelle ragnatele della borghesia, Schlegel esorta all’ozio, poiché oziando si riposa dal finito e ciò subito si traduce in nostalgia dell’infinito: “il riposo è solo indisturbata nostalgia” e “solo nello struggimento troviamo riposo”. Infatti, il disimpegno dal mondo produttivo implica tensione verso l’infinito: e tale tensione, possibile solo riposandosi e congedandosi dagli scopi finiti, è l’unico autentico progresso di cui l’uomo sia capace, poiché quel relativo progresso che lo sposta da questo a quello degli scopi finiti è solo apparente, in quanto perpetua la sua stagnazione all’interno del finito. Il finto progresso messo in moto dalla borghesia è un grande agitarsi senza che nulla muti. Il solo progresso reale è allora quello che, distogliendo dal finito, indirizza verso l’infinito: “assoluta progressività = tensione verso l’infinito”. Si riaffaccia qui il tema della nostalgia e dello struggimento, di quello che in tedesco si chiama Sehnsucht (termine composto da suchen, “cercare”, e da sehnen, “sforzarsi verso”), inteso come una tendenza permanente alla pari dell’eros platonico. L’uomo progredisce, e dunque evade dal finito muovendo verso l’infinito, nella misura in cui si universalizza, ovvero nella misura in cui “attraverso uno sviluppo infinito, uno sviluppo uniforme in tutte le direzioni”, acquista una cultura infinita la quale, configurandosi come “la più profonda, incessante e quasi ingorda partecipazione di ogni forma di vita”, “amplia ogni particolare sentire a sentire universale, infinito e si palesa come una manifestazione di una prodiga pienezza”. Questa è allora una cultura progressiva, il cui spirito è l’universalità ed è tale perché non è se non il dispiegarsi nell’uomo della “infinita pienezza di vita che l’infinito stesso è e che nell’uomo colto prende progressivamente a svilupparsi”. Ecco allora che il ristretto orizzonte dell’io finito è rotto e l’io, coltivandosi, da mediocre pretendente all’esistenza è trasformato in uno di quegli “individui che contengono in sé interi sistemi di individui” e il cui intimo è “un mondo di mondi”, vale a dire quell’io che si coltiva e che è in via di progressiva infinitizzazione. Il termine con cui i Romantici designano la cultura è Bildung, il cui etimo è Bild, che – al pari dell’eidoV greco – significa tanto “immagine” quanto “forma”: pertanto Bilden, al riflessivo, vorrà dire “coltivarsi” e “darsi forma”, e Bildungsroman è appunto il “romanzo di formazione”, nel quale si narrano le vicende attraverso le quali il protagonista si forma. Tale è l’uomo di cui parla Schlegel, il quale allude a una cultura infinita e manifestante una prodiga pienezza di vita, ossia di Dio. Sicché l’uomo colto contiene in sé interi sistemi di individui, è mondo di mondi, non è mai solo se stesso: la sua formazione tende alla onniformità e, per ciò, egli si sforza costantemente di diventare quell’infinita pienezza di vita che è l’io stesso. Proprio in ciò risiede il “panteismo dinamico” di cui alcuni studiosi hanno parlato in riferimento a Schlegel: panteismo, nel senso che tutto è Dio e che Dio si risolve nella totalità dell’esistente; ma è un panteismo “dinamico”, nel senso che il Dio di cui parla Schlegel, l’infinito, è infinita pienezza di vita, ossia è inteso alla maniera platonica e neoplatonica come infinita pienezza d’essere, come omnitudo realitatis. Come si ricorderà, l’Uno plotiniano e procliano includeva in sé ogni forma e modo d’essere e – per dirla con Cusano – complicava in sé ogni possibile essere: era dunque la totalità attualizzante d’ogni perfezione d’essere (ens perfectissimum). Questa infinita sovrabbondanza d’essere esiste come tale al di qua di ogni ente finito di cui è il principio in forza della propria sovrabbondanza d’essere: è così ricco d’essere che può parteciparlo diventando il molteplice mondo finito. Questa concezione, anche se accusata d’esserlo, non è panteistica, poiché la molteplicità degli esseri è sì la causa che li è diventati, ma quest’ultima resta anche quel che è al di qua del suo parteciparsi, cosicché permane la distinzione tra finito e infinito, tra mondo e Uno. Schlegel mutua dai Neoplatonici il concetto di infinito come infinita pienezza di vita, ma si distanzia da Plotino e da Proco nella misura in cui lo concepisce solo in potenza: l’infinito, come infinita pienezza d’essere, è allora tale solo e sempre a livello potenziale, giacché da sempre gli è congenito il limitarsi divenendo la molteplicità degli enti finiti del nostro mondo. Lungi dall’essere attualissima perfezione, esso si risolve in potenziale perfezione d’ogni modo e forma d’essere. Mentre nella prospettiva neoplatonica esiste un “prima” solo logico che separa l’Uno e il suo parteciparsi, per Schelegel invece l’Uno produce temporalmente prima d’essere quella attualissima perfezione: è tale perfezione solo in potenza, giacché è già sempre tradotto nella molteplicità dei suoi prodotti, è cioè un’infinita pienezza di vita in divenire. Il suo incessante produrre è il suo tradurre in atto la sua potenzialità. Mentre i Neoplatonici distinguono tra l’Uno e il mondo che ne deriva e dicono “l’Uno e il suo produrre”, in Schlegel viene a cadere tale distinzione ed egli può dire “l’Uno è il suo produrre”, è l’infinita pienezza di vita tutta coincidente col suo produrre. In quest’ottica, Dio non è, ma diventa. E il suo produrre è il suo essere, che è un diventare: sicché l’intero mondo non è se non Dio in cerca di se stesso. Ben si capisce, a partire da quest’incessante ricerca che Dio fa di se stesso, come quello schlegeliano sia un panteismo “dinamico” e, per così dire, irrequieto, in cui l’infinito coincide senza residui col suo produrre: è dinamico perché è in cerca di sé e mai si trova in alcuna delle sue produzioni. Superandole le une dopo le altre, esso è sforzo sempre reiterato di diventare se stesso attraverso le sue produzioni. In siffatta prospettiva, viene meno la trascendenza della causa e quello di Schlegel, se raffrontato all’Uno dei Neoplatonici risolventesi in infinita pienezza d’essere, è un Dio diminuito e in fieri. “Deus est in se, fit in creaturis”, dicono i Neoplatonici: in Schlegel, resta valida solo la seconda parte della frase – “Deus fit in creaturis” -, poiché Dio è, a suo avviso, soltanto nelle e attraverso le creature. Con questo scenario immanentista, perdiamo la trascendenza, ma – come nota Hegel stesso – riusciamo a dare un senso alla creazione: infatti, una prospettiva squisitamente trascendente non riesce a render ragione del perché, un ente perfettissimo quale è Dio, debba creare un doppione così impreciso e fallace come il nostro mondo. L’inevitabile rischio che si produce dal modello trascendente è quello di privare di senso il nostro mondo, concepito come copia pallida e scadente del mondo originario: la creazione stessa finisce per risolversi in una caduta dalla perfezione all’imperfezione. Tutto cambia con la prospettiva immanentistica fatta valere da Schlegel: se infatti il mondo – e più precisamente questo mondo – è la sede del divenire di Dio, allora la sofferenza di quaggiù è la sofferenza di un parto, nella fattispecie del parto di Dio; ne segue che questo mondo, anziché essere svalutato, riceve un senso profondo. Nonostante la viva ammirazione per Fichte, Schlegel propugna un punto di vista filosofico che non è quello della filosofia trascendentale, concependo il mondo come il prodotto di un principio e non dell’immaginazione trascendentale/produttiva fichteana. L’uomo colto – il poeta – è quello in cui l’infinita pienezza potenziale prende coscienza di sé: è cioè quello in cui Dio diventa cosciente di sé ed è a questo proposito che Schlegel, pur avendo fatto proprio un punto di vista non trascendentale, recupera alcuni spunti fichteani. La coscienza dell’uomo colto – egli dice – è caratterizzata da infinita pienezza di vita che, sempre e di nuovo limitandosi, si sforza senza tregua di sorpassare quei limiti e di dispiegare la propria infinita coscienza. L’infinita pienezza di vita crea le cose, le quali però restano quel che sono: nell’uomo colto, invece, accade che possa verificarsi un passaggio dall’essere mero pretendente all’esistenza ad individuo che racchiude in sé altri individui e altri mondi. La sua cultura deve essere sforzo di proteiformità, assumendo in sé, diventandoli, una pluralità di io. Questo sforzo è quella tensione all’infinito che caratterizza l’uomo colto che si sforza di vivere una pluralità di vite: in lui si squaderna l’infinita pienezza del divino, che diventa consapevole di sé. La coscienza dell’uomo colto è, per sua definizione, una coscienza nostalgica e ironica: e proprio questo è lo sforzo che non solo la caratterizza, ma la costituisce. Si capisce allora perché, nel lessico schlegeliano, termini come “cultura”, “infinito”, “Dio” e “umanità” finiscano per essere sinonimi, cosicché Schlegel può affermare “non dissipare fede e amore nel mondo della politica, ma specifica ciò che c’è di più intimo nella sacra ignea corrente della cultura eterna”. La “sacra ignea corrente” non è che la vita divina di chi ozia e non si dedica alla politica, ma sacrifica di volta in volta le vite che vive. La cultura così intesa è il sommo bene ed è, per ciò, altresì l’unico dovere dell’uomo: “sommo bene e solo utile è la cultura [Bildung]”. E a tal proposito, egli parla di un “puro e superiore egoismo”, quello dell’ozio che, disprezzando ogni altra utilità, attende solo, come vocazione suprema, all’educazione e allo sviluppo di se stesso. “Suprema virtù è praticare la propria individualità come fine ultimo”, scrive Schlegel: il puro e superiore egoismo è allora quello di Dio diveniente nell’uomo che si coltiva con la cultura e che con essa si sacrifica per gli altri. Gli uomini hanno dunque il diritto ad essere egoisti, ma a condizione che conoscano il loro vero io: il che è possibile solo a patto di averne uno. Bisogna cioè essere non una semplice cosa, bensì vita infinitamente piena in divenire: tale è per l’appunto Dio. Chi ha un tale io e lo riconosce, ha il sacro diritto di essere egoista, poiché il suo egoismo è divino, nel senso che è al servizio di Dio. E hanno un io – nota Schlegel – quanti sono dotati di una coscienza poetica e ad essa danno seguito: “trasferirsi arbitrariamente ora in questa ora in quella sfera come in un altro mondo non solo con la ragione o con l’intelletto, ma con tutta l’anima […]. Uno spirito che contenga in sé come una pluralità di spiriti […], nel cui intimo l’universo […] si è dispiegato ed è pervenuto alla sua maturità”. Nella prospettiva schlegeliana, essere qualcuno significa pertanto essere un io divino, il contrario di ogni chiusura in se stessi: si tratta anzi di un’apertura all’infinito, di una trasformazione del proprio io in universo intero. Si annuncia in questi termini una nuova forma di cosmopolitismo, differente rispetto a quella predicata dagli Illuministi: “il desiderio rivoluzionario di realizzare il regno di Dio è il punto elastico della cultura progressiva e il principio della storia moderna. Ciò che in essa non ha relazione col regno di Dio ha un valore secondario”. Il desiderio rivoluzionario (e qui il riferimento è anche alla Rivoluzione Francese) di realizzare il regno di Dio è proprio dell’uomo colto, che fa propria una “insurrezione permanente” contro ogni limite. Schlegel arriverà a descrivere la cultura occidentale come caratterizzata dal progressivo avvento del regno di Dio, coincidente con la piena umanità, alla luce dell’assunto che “se tu pensi un finito sollevato all’infinito, tu pensi un uomo”. Sicché l’uomo è tale nella misura in cui è sulla via di quell’infinitizzazione che coincide con l’avvento del regno di Dio. “Spirito finito senza spirito infinito è nulla. Ma lo spirito infinito non è affatto semplicemente dato. Dio è un compito degli spiriti. Essi devono farlo. Dio non è, bensì diventa nel mondo”, scrive Schlegel e parla di “desiderio rivoluzionario di realizzare il regno di Dio” per indicare la nostalgia dell’infinito. La natura rivoluzionaria del desiderio è tale perché è rivoluzionaria rispetto alle tendenze dell’epoca e anche in riferimento all’esistenza del singolo: il regno di Dio si realizzerà compiutamente soltanto quando si avrà un’ininterrotta catena di rivoluzioni che si susseguono senza sosta. Ma come si configura l’esperienza che l’io fa del divino? O, in altri termini, come fa l’infinito a divenire nel finito? Tale progressione dall’infinito al finito – spiega Schlegel – si manifesta come onnivora e proliferante crescita culturale in tutte le direzioni, come il proliferare e l’intrecciarsi di nuovi scorci e punti di vista, nessi e relazioni insospettate che, spostando sempre più in avanti l’orizzonte dell’io, lo rendono sterminato: si tratta di un “prodigioso baccanare spirituale” che si prospetta come “partecipazione a tutte le forme di vita, massiccio offrirsi di tutte le forze ancora sopite”. Di questa esperienza vertiginosa ed entusiastica, una pallida immagine può forse offrircela “l’onnipotenza delle forze latenti di un adolescente”, ossia quell’esplosione incontenibile di vita che caratterizza l’età dell’adolescenza e che è, per alcuni versi, anche simile a un grande albero la cui vita si espande dalle radici sino a creare una corona fittamente intrecciata. È esperienza estatica e vertiginosa, tale per cui chi la esperisce si sente sottratto a se stesso, rapito alla propria finitezza in un divenire che, inglobandolo, lo trascende. In questi termini, lo spirito dell’uomo è il Proteo di se stesso: è una sorta di vortice che tutto afferra e al cui centro sta l’infinita pienezza della libertà creatrice. Per chiarire questi concetti, Schlegel adotta un linguaggio profetico e chiliastico: egli non nasconde e anzi segnala sempre più marcatamente che l’infinitizzazione in fieri dell’uomo corrisponde a un suo divinizzarsi; è Dio che diventa Dio mediante la cultura dell’uomo: “diventare Dio, essere uomo, coltivarsi, sono espressioni equivalenti”. “In questa grande persona dell’umanità, Dio si è fatto uomo”: così intesa, l’umanità è la sede del farsi di Dio nell’umanità stessa. Siamo cioè dinanzi a un Dio che solo progressivamente realizza, esplicandola, la propria infinitezza e lo fa prendendo possesso dell’uomo come sede più alta per il suo manifestarsi. Ciò accade in virtù del fatto che “ogni individuo infinito è Dio”. Quello che Schlegel chiama “l’uomo totale”, in via di infinitizzazione, è l’uomo abitato da un demone o da un genio, giacché è in lui che Dio si esperisce e si sa come tale. Si tratterà allora di un’esperienza che è al contempo estatica (nel senso letterale dello “star fuori di sé”) perché pone fuori dalla normale quotidianità, in una fuga dal finito verso l’infinito, ed entusiastica, cioè tale per cui il divino è presente e si manifesta. Gli uomini potenziati sono tali in virtù del divino entusiasmo da cui sono mossi.
LA POESIA IN SCHLEGEL
È su queste basi che Schlegel introduce il suo concetto di poesia: dove l’infinito irrompe e si espande nello spirito e nell’esperienza umana, diventando il motore dell’agire umano che permette il passaggio dalla grettezza del finito e del mondano a puro e disinteressato tendere all’infinito, attraverso il dedicarsi a quell’ozio che è l’occuparsi della propria Bildung, lì troviamo la poesia nel senso lato del termine: “il mite riflesso della divinità nell’uomo è la vera anima, la scintilla che accende ogni poesia”. In un altro passo, così si esprime Schlegel: “l’unico principio della poesia è l’entusiasmo”, in cui si attua l’unione fra l’umano e il divino. Altrove questa poesia lato sensu è precisata in riferimento alla prosa: “la poesia vuole solo tendere verso l’infinito e disprezza utilità e cultura profane”. Sicché c’è poesia ovunque sia rinvenibile l’impronta dell’infinito e dunque ovunque si viva per e dell’infinito. La poesia, così intesa, è la dimensione divina presente nel finito: essa – che è assoluto, alto, divino – è opposta alla prosa – che è finito, limitato, basso, pedestre, gretto -, in una lotta dell’infinito contro il finito, del divino contro il solo umano. L’uomo potenziato trova in sé l’Assoluto: e tale esperienza si configura dapprima come desiderio, nostalgia, aspirazione, e l’eterna nostalgia è l’inizio del manifestarsi della presenza dell’infinito. La poesia vuole solo tendere all’infinito e, per ciò, disprezza la cultura profana, la quale è l’opposto della vera religione. Ma questo sentimento della nostalgia va inteso nella valenza pascaliana e rousseauiana, come superiore forma di conoscenza (Rousseau parlava di amor di sé e di pietà, Pascal del cuore). Il sentimento dell’infinito è allora il secondo manifestarsi della coscienza dell’infinito stesso, un primo sentirlo e saperlo come scopo del proprio agire. Così delineato, il sentimento non ha nulla a che vedere col sentimentalismo, ovvero con una superficiale emotività piattamente commuovente e lacrimosa: se il sentimentalismo è “pieno di quei familiari generosi sentimenti nei quali uomini senza carattere si sentono così felici e grati”, il sentimento è al contrario la primigenia coscienza dell’infinito nell’uomo. Il sentire non è che infinita pienezza in potenza non ancora dispiegata e, proprio per ciò, è ancora soltanto desiderio di sé: e poiché il dispiegarsi è sempre relativo, il desiderio non verrà mai meno e sarà anzi il pungolo che stimolerà sempre e di nuovo l’uomo a formarsi. In particolare, quel desiderio dell’uomo è il desiderarsi di Dio nell’uomo e, pertanto, anche il trovarsi di Dio nell’uomo. Il sentimentale di cui parla Schlegel è amore che si mostra come desiderio e silenziosa malinconia: amore è Dio che si dà e si offre, cosicché “per il vero poeta, tutto questo, per quanto la sua anima lo possa cordialmente abbracciare, è solo accenno a ciò che è più alto e infinito, geroglifico dell’unico eterno amore e della sacra pienezza di vita della natura creatrice” (Dialogo sulla poesia). Ogni poeta e le sue realizzazioni, oltre che sede del venire di Dio, sono segno e allusione al più ampio e incessante divenire di Dio di cui quel poeta è, per così dire, solo un aspetto, un accenno, un geroglifico. L’infinita pienezza si manifesta nell’uomo come caos – “regno di Dio = caos = poesia” – e, a rigor di termini, il regno stesso di Dio è poesia, e viceversa. L’infinitizazzione è allora il caos al posto dell’ordine, lo smisurato al posto del misurato, l’infinito al posto del finito. E poetica sarà quell’esistenza che, traendo ispirazione dall’infinito e mirando ad esso, “fa valere il suo indiscutibile diritto alla confusione, vale a dire ripudia ogni restrittivo ordine costituito”. Pertanto opporre il caos all’ordine equivale a opporre la poesia alla non-poesia e, dunque, il Romanticismo sta alla base di certo anarchismo nascente nell’Ottocento: la poesia di una vita esaltata all’infinito è opposta alla trivialità di un’esistenza ridotta al finito e alla prosa, rispetto alla quale deve porsi in maniera critica e rivoluzionaria. “Questo è infatti il principio d’ogni poesia: annullare il corso e le leggi della ragione ragionante e trasferirsi di nuovo nel caos originario della natura umana”, quel caos che Dio stesso è. Si capisce allora perché “nessuno scopo è più alto dell’annientare, distanziandosene, ciò che chiamiamo ordine e del rivendicare il proprio diritto a una stimolante confusione”: secondo Schlegel, infatti, la confusione così intesa stimola per il fatto stesso che è in divenire, trasporta chi ad essa si abbandona, non è mai quiete riposante. Da qui nasce il disprezzo per quell’ordine che irreggimenta l’esistenza al servizio di un’utilità soltanto empirica e che ne svilisce ogni slancio ultraterreno. È l’ideale di una vita trasformata in poesia dalla dirompente e caotizzante presenza dell’infinito: questa rivoluzione contro l’ordine deve diventare, nella prospettiva schlegeliana, una “insurrezione permanente”, giacché la divinizzazione e la formazione dell’individuo in spirito che abbia in sé una pluralità di spiriti è tale nella misura in cui non si limita a nessuno dei tanti spiriti che via via diventa, ma tutti li abbraccia progredendo incessantemente dall’uno all’altro. Ogni aspetto, ogni parte dell’infinita pienezza è limitata e finita e, per ciò, deve di volta in volta essere riconosciuta come tale e dunque superata, foss’anche ciò che maggiormente amiamo, al fine di evitare che l’indugiare in essa arresti la nostra progressione all’infinito: “dobbiamo sollevarci anche al di sopra di ciò che amiamo ed essere in grado di annientare nel pensiero ciò che adoriamo, altrimenti ci manca il senso dell’universo”, ovvero non sentiamo l’irruzione dell’universo in noi. È qui enunciato come indispensabile un esercizio critico che si configura come sacrificio del finito a vantaggio dell’infinito: è quello che Schlegel definisce come una continua “autoparodia”, che è la pratica di sistematica auto-ironia condotta dal poeta e volta a evidenziare i limiti del poeta stesso, la parzialità dei diversi modi d’essere che, nel suo formarsi, egli va via via assumendo. “Il senso segreto del sacrificio è l’annientamento del finito perché è finito”: con ciò, Schlegel intende dire che bisogna evitare che ciò che è solo qualcosa venga indebitamente assolutizzato e dunque vissuto dogmaticamente come un alcunché di ultimo e di definitivo. “Ironia è quello stato d’animo che sovrasta a tutto e che si solleva infinitamente su tutto ciò che è limitato: perfino sulla propria arte, virtù o genialità”: così tratteggiata, l’ironia si presenta come un esercizio di scetticismo nei propri stessi confronti e un tale assiduo intervento dell’ironia restituisce al suo ruolo di mero momento all’interno di una più ampia totalità ogni pretesa ma infondata assolutezza. Da ciò segue che l’ironia è la più libera di tutte le licenze, poiché con essa ci si pone al di sopra e oltre se stessi. Ma al tempo stesso è anche la più legittima licenza, perché incondizionatamente necessaria e indispensabile affinché la progressione all’infinito non si interrompa. “Così intesa, l’ironia è un’autentica prassi rivoluzionaria che produce una serie continua di rivoluzioni interiori”: si tratta di un contraddittorio permanente in forza del quale ogni nuovo spirito viene puntualmente confutato nella sua pretesa assolutezza e ridimensionato nella sua limitatezza, cosicché, anziché arrestare la progressione, è spunto affinché essa proceda. “Chi ha una predilezione per l’Assoluto e non può farne a meno, non ha altra via d’uscita che quella di contraddirsi continuamente e di connettere gli estremi opposti”, rileva Schlegel, cosicché la cultura è “sintesi antitetica sino all’ironia”. Un uomo la cui cultura sia universale e formata, ha un’interiorità configurantesi come continua concatenazione delle più straordinarie rivoluzioni, a rendere possibili le quali è la presenza incessante dell’ironia. “Ironia è chiara coscienza dell’eterna agilità del caos infinitamente pieno”: la coscienza poetica è – fichteanamente – sintesi di una tesi e di un’antitesi: la sintesi è la coscienza metafisico/ironica (desiderio dell’infinito e critica del limite), ossia è tensione all’infinito; la tesi è l’infinita pienezza divina, il caos pieno. Da ultimo, l’antitesi è data dalle forme di vita e di cultura di volta in volta limitate che la tesi assume e in cui si limita: in altri termini, è l’entusiasmo che produce questo o quello spirito in cui la pienezza divina va sempre limitandosi. L’ironia è allora superamento e annientamento del limite, dove a costituire il limite sono le forme che l’uomo via via assume, giacché egli è di volta in volta un sacrificio e un annientamento di sé ma funzionale al realizzarsi della vita divina (è dunque un annientamento apparente, perché ripristina la vita divina). “L’apparenza dell’autoannientamento è manifestazione della libertà incondizionata, dell’autocreazione”: l’autoannientamento è l’ironia, ma è apparente perché manifesta l’autocreazione (il divenire di Dio): sicché l’ironia è lo strumento di cui Dio, nell’uomo, si avvale per far riemergere sempre e di nuovo la sua vita dal limite in cui apparentemente s’era sopita. L’infinita pienezza diventa qualcosa ma con l’autoironia sorpassa il limite e riprende la sua corsa all’infinito: siamo allora in presenza di un nichilismo relativo, che nega sì la vita bassa e prosaica, ma lo fa in vista del liberarsi di una nuova e più alta forma di vita poetica; è, per usare le parole di Schlegel, una “continua alternanza di autocreazione e di autoannientamento” e ciò comporta risvolti liberal-democratici nel pensiero del giovane romantico: l’ironista è infatti tutto fuorché un assolutista, è anzi un essere aperto in tutte le direzioni. Cercheremo ora di fare il punto sul concetto di ironia, effettuando una vera e propria ricognizione storica: da un lato, v’è l’ironia come tecnica oratoria (così ce la presentano Cicerone e Quintiliano) consistente nel dire una cosa lasciandone intendere un’altra. In questo senso, l’oratore simula di sostenere una cosa che crede falsa, mentre in realtà ne dice un’altra che crede vera. Così, se in una stanza orribile e decadente un tale dicesse “questa stanza è elegante e confortevole”, egli simulerebbe di dire il falso e in realtà starebbe dicendo il vero. Dall’altro lato, con Socrate invale un nuovo significato del termine “ironia”: il filosofo simula l’ignoranza dell’opinione per portare alla luce nei suoi interlocutori la verità del sapere. Queste due forme di ironia, che abbiamo succintamente delineato, hanno in comune l’abbandono del vero al suo contrario e ciò in funzione dell’affermazione di quel vero che momentaneamente è stato abbandonato. In comune hanno cioè il partire da un punto di vista superiore, muovendo dal quale (e abbandonandolo temporaneamente) criticano il punto di vista inferiore: così intesa, l’ironia è sempre critica del falso e tale da implicare però il possesso del vero. In altri termini, essa è possibile a partire da un punto di vista superiore rispetto a quello sul quale si ironizza. Il secondo punto in comune tra queste due concezioni è il momento faceto: l’ironia è infatti una critica che mette in luce l’aspetto comico di ciò su cui si ironizza. Ad essere criticata è infatti l’indebita serietà del punto di vista inferiore, il quale si presenta indebitamente come vero: allora l’ironia smaschera la pretesa serietà come mera seriosità di chi crede d’essere dove in realtà non è. Da queste due concezioni Schlegel mutua sia il momento critico sia quello faceto: se ne distingue però nella misura in cui l’ironia come egli la intende non è rivolta a terzi che debbono essere convinti dell’errore delle loro posizioni. Al contrario, l’ironia di cui parla Schlegel è sempre autoironia di chi da un punto di vista superiore si rende consapevole dei propri limiti, di chi dunque non coincide mai in toto con ciò che di volta in volta è, ma è anzi in grado sempre e di nuovo di prendere le distanze da ciò che via via diventa, esibendone a se stesso il limite e la pretesa di assolutezza. Ciò accade perché un tal soggetto, che fa autoironia, è dotato di un punto di vista superiore: l’infinita pienezza in divenire. Il soggetto ironizzante, infatti, è l’infinita pienezza in divenire che di volta in volta, limitandosi, diventa qualcosa di cui subito avverte e critica la limitatezza. Sicché la coscienza di un tale soggetto è caratterizzata da un continuo autotrascendimento, un perenne andare oltre se stesso: ecco perché la coscienza dell’uomo romantico, nel suo sforzo continuato, è nostalgico/ironico e, dunque, lucidamente critica e trascendentale (nel senso di riflettente sulle proprie stesse condizioni d’essere). Pertanto il Romantico non può mai prendersi troppo sul serio, non è mai serioso, né mai coincide del tutto con se stesso: egli segnalerà sempre, e lo farà con un sorriso e con un motto di spirito, di non essere mai soltanto quel che sembra essere. In quest’accezione, il sorriso dell’ironista romantico è tanto di commiserazione quanto di superiorità: di commiserazione, giacché dal punto di vista superiore egli commisera la propria attuale e fattuale limitatezza; di superiorità, poiché egli divina profeticamente l’infinita pienezza d’essere di cui egli è il progressivo divenire. L’atteggiamento del romantico è allora disincantato e disinteressato, ma mai nichilista nel senso forte e negativo del termine: infatti il distacco che lo contraddistingue concerne solo quel che via via si è nella propria limitatezza e non l’infinita pienezza d’essere. Significativamente, in un frammento Schlegel mette in evidenza la superiorità del punto di vista proprio di chi ironizza: “ironia è lo stato d’animo che sovrintende a tutto (“sovrintendere” in tedesco è Übersehen, ovvero “vedere dall’alto”) e che si solleva infinitamente al di sopra di tutto ciò che è condizionato”. Del resto, Schlegel rileva anche come se non sappiamo praticare l’ironia, ciò accade perché ci manca il “senso del cosmo”, ossia il senso della totalità al di là del suo limitarsi. Il limite di cui egli parla, lungi dal togliere di mezzo l’infinito, lo blocca soltanto per un istante, fino a che l’ironia non abbia provveduto a superare l’ostacolo. Come sacrificio, essa richiede la rinuncia alla pretesa della definitività: sua caratteristica sarà allora il sortire una specie di fluidificazione dello spirito romantico, un progressivo incremento della sua agilità. Essendo lo spirito romantico eminentemente sforzo volto a superare il limite, il ricorso all’ironia finisce per tradursi in una sempre più radicale critica dei limiti futuri, nel senso che un limite non fa in tempo a porsi che subito lo spirito è ironicamente al di là di esso. In questa prospettiva, l’ironia diventa una critica di ogni possibile limite e, dunque, non fa che accelerare, fluidificandolo, il processo di Bildung del Romantico: tale esperienza si velocizza sempre più e, in forza di ciò, l’infinitizzazione del soggetto finito diventa quasi visibile. Questo punto è espresso da Schlegel in riferimento alla categoria dell’arguzia: lo spirito romantico, nel suo esercizio d’ironia, si presenta infatti come spirito altamente arguto. Il termine schlegeliano è Witz, che corrisponde allo spagnolo agudeza e all’italiano arguzia: su questo concetto avevano soffermato l’attenzione soprattutto i teorici dell’ars combinatoria – in particolare Raimondo Lullo – e, memore di ciò, Schlegel, in una lettera del febbraio 1796, definisce l’arguzia come capacità combinatoria tale da saper cogliere fulmineamente le connessioni tra le idee: “acume, arguzia, ars combinatoria, critica, arte inventiva: sono tutt’uno”. Ciò detto, egli nota che “l’intelletto riflettente è spirito meccanico; l’arguzia è spirito chimico”: vuol dire che mentre l’intelletto risale dagli effetti alle cause e lo fa in modo meccanico, l’arguzia è intuizione chimica, sintetizza e combina, è “divinazione profetica”, è un colpo d’occhio che vede tutt’insieme ciò che l’intelletto ricompone progressivamente e a fatica. “L’arguzia combinatoria è veramente profetica”, conclude Schlegel: in quanto tale, essa riesce a vedere lontano e “la cosa principale è il presentimento della totalità cui conduce l’arguzia”. Altrove, egli parla dell’arguzia come elasticità ed elettricità: essa è dunque l’esito cui perviene lo spirito romantico praticando l’ironia; ed è qui in nuce lo spunto di quella critica di dilettantismo che Hegel e Kierkegaard muoveranno ai Romantici. Certo è che il reiterato esercizio dell’ironia, acutizzando la coscienza del Romantico, la infinitizza sempre più, rendendo facilmente rimuovibile il limite. Quel che avviene in un individuo siffatto è una vera e propria teogonia, un divenire di Dio, che peraltro è destinato a rimanere soltanto ideale: l’ironia è “limpido caos in agilità”, vale a dire l’incontenibile divenire di Dio nell’uomo. Nell’atto stesso con cui dà vita alle sue manifestazioni, l’uomo romantico non si arresta in nessuna di esse, ma tutte le supera librandosi al di sopra. Sicché da un lato stanno le invenzioni dell’entusiasmo, che inventa nuovi modi d’essere e in essi si limita; dall’altro, sta l’ironia, che riafferma la libertà dell’infinita pienezza di contro ad ogni limite. Ma proprio il suo essere tale fa sì che l’infinito sia sempre solo in divenire, mai attuato: non è cioè mai infinita pienezza in atto, è piuttosto perenne autolimitazione. Sull’onda di ciò Schlegel afferma che “Dio è un compito degli spiriti” e che diventa nel mondo solo mediante essi: può cioè solo essere creato e non è che l’individuo nella sua massima potenza. L’umanità è dunque il processo che manifesta Dio e che dunque permette all’uomo di emanciparsi dal finito; “libero è l’uomo allorché produce e rende visibile Dio e, in tal modo, diventa immortale”: questa è un’autentica rivendicazione di libertà dalla tirannia del limite, ossia è una progressiva conquista di libertà dal possibile predominio dispotico di una parte sul tutto. La costituzione di un tale uomo può allora dirsi pienamente repubblicana: così dicendo, Schlegel si sta facendo promotore di un liberalismo repubblicano, per cui “liberale è chi da tutti i lati e in tutte le direzioni è di per sé libero e opera in tutta la sua umanità, chi partecipa ad ogni forma di vita senza lasciarsi traviare da ristrettezze di vedute all’odio e al disprezzo” (l’unico disprezzo consentito è quello verso il finito). Da tutto ciò si capisce meglio come Schlegel prometta sì l’immortalità, ma non quella individuale, bensì quella dell’infinito in fieri di cui siamo costituiti. In quanto individui, ci è garantita l’eterna giovinezza: l’esistenza che sia progressione assoluta è un coltivarsi all’eterna giovinezza e lo è per la sua stessa natura di divenire incessante (non può mai fossilizzarsi nel “questo” o “quello” che progressivamente diventa), un perenne andare oltre. L’umanità, che diventa repubblicana e liberale, mantiene sempre intatta la sua giovinezza: nessuno dei suoi membri è, per così dire, un sopravissuto di epoche precedenti. Lo spirito di una tale coscienza è infatti mobilissimo, è sempre in sintonia con quello che Hegel definiva come “Spirito del tempo”: la sua esperienza “resta eternamente nuova”, rinnovandosi perpetuamente proprio perché è poetica. In tale ottica, non v’è il rischio d’essere superati dai tempi. Il progressismo di Schlegel ha tra i suoi seguaci i Futuristi, ma da essi si distingue perchè mantiene la riflessione critica propria dell’ironia, senza mai cadere, ad esempio, nell’esaltazione della velocità.
IL ROMANZO SECONDO SCHLEGEL
Parlando della teoria schlegeliana del romanzo, slitteremo dal piano dell’etica a quello dell’estetica. Schlegel definisce la poesia, nel suo significato artistico, come il “superiore linguaggio della vita nobile”: essa è dunque la traduzione di una vita poetica in un’opera letteraria, la quale si presenta come un vero e proprio compendio enciclopedico “dell’intera vita spirituale di un individuo geniale” e ciò perché il poeta è uno di quegli uomini superiori abitati dall’infinito, ispirati da Dio e tali da avere un’intuizione originale dell’infinito stesso e da abbracciare in sé l’intero universo della poesia. Così tratteggiato, il poeta è un autentico portavoce di Dio ed è questa la conditio sine qua non affinché si possano comporre poesie. Ora, la poesia di un tale poeta è “universale e progressiva”: questa è precisamente la poesia romantica. In particolare, essa dovrà essere progressiva e universale come è lo spirito dell’autore che la esprime: ed è romantica perché il romanzo è – o, meglio, deve essere – la “forma letteraria” che meglio di ogni altra riesce ad incarnarla. In effetti, come nota Schlegel, l’infinita pienezza di vita che il poeta reca in sé può manifestarsi solo in un’opera che sia essa stessa infinitamente piena e caotica: tale è il romanzo come Schlegel lo intende. La sua essenza è la mescolanza di tutti i generi poetici: nel romanzo tutti i diversi generi poetici (lirica,epoV , dramma, commedia, ecc) si intrecciano e si intersecano senza soluzione di continuità, sortendo quella forma caotica che fa del romanzo la sede più appropriata per la rivelazione dell’infinito in divenire. Nella misura in cui riunisce e mescola in sé tutti i generi, il romanzo diventa un “sistema di opere reciprocamente integrantisi”, corrispondendo al “sistema di individui” che è il poeta. Ne nasce una “poesia progressiva” che ha agio di esprimere la progressività infinita dell’autore stesso: Schlegel sa bene come questa sua teoria del romanzo rivoluzioni l’intera poesia, gettando lo scompiglio nella distinzione dei generi romantici che contraddistingueva l’estetica all’epoca in auge. Così, un unico genere poetico – il romanzo – si trova a riunire in sé tutti gli altri, ragion per cui “compito imprescindibile del romanzo è la commistione e l’intreccio di parti quanto mai eterogenee fra loro”. Il termine tedesco per esprimere l’italiano “romantico” è Romantisch, mentre Romanisch significa “romanzo” nel senso di “proprio delle lingue romanze”: romanzi e romanze erano tutte le opere scritte non già in metri classici, bensì in queste lingue romanze (ad esempio, il romanzo di Re Artù). Per Schlegel, “romantico” significa anzitutto “peculiare del romanzo”, ovvero della produzione poetico/letteraria romanza (e quindi non latina): in primis i poemi cavallereschi medievali. Ma, accanto ai poemi cavallereschi, Schlegel ha in mente Dante, Petrarca e Ariosto: sicché “poesia romantica” significa in primis “poesia non latina”, cui tuttavia Schlegel ascrive anche i drammi che si sottraggono alla precettistica espressa nella Poetica di Aristotele: Calderon de la Barca e Shakespeare, quest’ultimo ancora considerato da Voltaire come un barbaro. La caratteristica di questi autori – da Dante a Shakespeare – è la mescolanza di prosa e poesia, di filosofia e poesia, di generi, di alto e basso, di volgare e di nobile: la loro è una produzione letteraria che esula dai canoni della classicità. E tale mescolanza torna a riproporsi anche in opere più recenti, come il Don Chisciotte di Cervantes, Jacques le fataliste di Diderot e le Confessioni di Rousseau. In senso meta-storico, romanzo è la forma ideale della poesia romantica, della progressione dello spirito romantico, ossia di uno spirito che non nasce con Schlegel ma che è da sempre presente e che già si è manifestato in questi Romantici ante litteram che sono Dante, Shakespeare, Petrarca, ecc. Ancor prima di entrare in medias res per quel che riguarda la teoria del romanzo, dobbiamo spendere qualche parola sulla poesia in senso strettamente artistico: a tale trattazione Schlegel dedica il Dialogo sulla poesia, in cui esordisce dicendo che “romantico è ciò che ci rappresenta una materia sentimentale in una forma fantastica”. Nella fattispecie, la “materia sentimentale” è l’oggetto della nostalgia del poeta, mentre la “forma fantastica” è tale nel senso che è attiva la fantasia inventiva dell’entusiasmo che, sul piano della produzione poetica, si esprime in sempre nuove invenzioni poetiche. L’altra definizione della poesia romantica che fornisce Schlegel è quella secondo cui essa sarebbe “universale e progressiva”: così dicendo, egli capovolge l’estetica classica, rigettandone i canoni. Infatti, l’estetica di Aristotele, dei Rinascimentali e dei Classicisti è universale, giacché il suo oggetto è non già un particolare, bensì l’universale stesso, di contro alla storia, la quale descrive le peripezie dei singoli individui: l’estetica classica, infatti, riguarda non la particolarità di questa o quella cosa, ma il suo essere nell’universalità, ossia l’essere che la cosa è (e che la accomuna alle altre di quella specie) nella sua perfezione universale, nella sua idealità. Una tal concezione universalistica dell’arte configura la poesia come un qualcosa di volta in volta in sé conchiuso: così, quando l’arte raffigura l’uomo, non fa che guardare all’essenza dell’esser uomo nella sua piena attuazione; ad esempio, rappresentando la virtù di Odisseo, essa rappresenta l’uomo stesso nella sua archetipicità. Ma questa è, com’è naturale, una raffigurazione che inizia e che si conclude: ha cioè un inizio e una fine che fanno sì che essa sia un’opera compiuta. E infatti le peripezie cui va incontro Odisseo sono un qualcosa in sé conchiuso, nonostante la frammentarietà indefinita degli episodi che costellano quel qualcosa. Sicché dire che la poesia è universale equivale a dire che il poeta dà vita a opere in sé conchiuse; in ciò concordando con l’estetica classica, anche Schlegel sostiene che la poesia è universale, ma poi aggiunge un aggettivo fatale: – “progressivo” – che sgretola l’estetica classica. Condividendo la concezione dell’arte come rappresentazione dell’universale, Schlegel concepisce poi l’universale in modo diverso rispetto all’estetica classica: tale universale, infatti, non è a suo avviso riconducibile né all’essenza di cui parlava Aristotele né all’idea di cui diceva Platone. È, piuttosto, un principio di tutto ciò che è e, dunque, è un universale sempre in divenire, cosicché l’arte deve raffigurarlo nella sua costante progressione, nel suo divenire incessante. Come l’universale non è ma diviene, così la poesia che cerca di raffigurarlo non è mai conchiusa ma è essa stessa in progressione: di conseguenza, l’artista, che coglie intuitivamente l’universale nel suo essere altro rispetto al molteplice sensibile, fissa mediante astrazione l’essenza costitutiva delle cose (ad esempio, la razionalità come essenza dell’uomo). L’universale diveniente è – come sarà quello hegeliano – concreto, nel senso che concresce diventando via via i suoi prodotti. E tale universale è ad un tempo soggetto e oggetto della poesia romantica: soggetto, perché la fantasia del poeta, dilagante in sempre nuove invenzioni, è la pienezza del Dio diveniente nel poeta stesso; oggetto, perché il poeta cerca di fissarlo in un’opera che resta sempre aperta, che mai potrà dirsi conchiusa e che si presenta come un perenne work in progress. Una tale poesia non solo unisce in sé tutti i generi letterari, ma ancor prima tende ad unire filosofia e poesia, giacché è universale, progressiva e dunque tale da essere abitata dalla riflessione ironica. E del resto la poesia riesce ad essere universale e progressiva solo se c’è la riflessione ironica, cioè filosofica: deve dunque mescolare sapientemente poesia e prosa, cioè infinito e finito, ma anche versi e discorsività. Deve poi unire genialità e critica, cioè entusiasmo inventivo e ironia. Come l’uomo romantico non è solo un sentimentale, ma un lucido e lungimirante critico, così l’artista romantico è sempre anche dotato della riflessione critico/filosofica, poiché solo il poeta che sia in grado di riflettere sulla propria opera è poi in grado di trascenderla e di produrre una poesia progressiva e universale. Pertanto tra l’invenzione e l’opera si libra sempre e di nuovo la riflessione ironica: quando l’estetica classica parlava della poesia come raffigurazione dell’universale statico, concepiva l’arte come mera imitazione della natura, ancorché quest’ultima fosse contemplata nella sua idealità (le idee platoniche o le forme aristoteliche); era sì celebrata l’inventiva dell’artista, ma sempre concependo l’universale come il solo orizzonte entro cui l’artista poteva muoversi (l’idea platonica e l’essenza aristotelica devono essere solo riconosciute ed imitate). Al contrario, per Schlegel la libertà del poeta non ha limiti: egli è creatore assoluto, in quanto è l’infinita pienezza che in lui si manifesta, a tal punto che possiamo dire di essere in presenza di una demiurgicità dell’artista sconosciuta all’arte classica. Fatte queste precisazioni sulla poesia, possiamo ora tornare alla teoria schlegeliana del romanzo, partendo da quanto dice Schlegel stesso: “in un certo senso, tutte le opere di poesia sono romanzi, rientrano nella progressione della poesia. Ogni poesia dev’essere prosa e ogni prosa dev’essere poesia. Tutte le produzioni dello spirito devono romantizzare, cioè approssimarsi il più possibile al romanzo”. Così, ad avviso di Schlegel, il Guglielmo Meister di Goethe è, dopo quello di Cervantes, il romanzo moderno che più si avvicina alla sua concezione del romanzo, poiché in esso lirica e prosa si alternano, è forte la parte dialogata e dunque v’è fusione tra etica, lirica, dramma. Inoltre, in esso è altamente presente la riflessione critico/filosofica: ma, nonostante questi aspetti che lo rendono assai vicino al romanzo schlegelianamente inteso, esso non è ancora perfetto, perché per essere tale dovrebbe essere “più moderno, più antico, più filosofico e etico e poetico, più politico, più liberale, più universale, più socievole” (curioso è il riferimento alla socievolezza, con la quale qui si allude al fatto che la poesia romantica deve mescolare tutti i generi). Tra i romanzi più romantici vi sono anche il Don Chisciotte di Cervantes e i drammi di Shakespeare, i quali costituiscono – nota Schlegel – un unico romanzo e il “nucleo della fantasia romantica”: nella loro totalità, tali drammi costituiscono un solo romanzo che racchiude in sé tutti i generi e tutte le loro possibili declinazioni. E se l’estetica fa questione della bellezza, qui no, si fa questione di progressività e si celebrano autori che, per i canoni del Classicismo, grandi autori non erano. Come l’esistenza del poeta è sforzo di infinitizzazione, così la poesia è sforzo di raffigurare quello sforzo di infinitizzazione e il romanzo è traduzione in un’opera di tale sforzo, come emerge bene dall’affermazione di Schlegel secondo cui i drammi shakespeareani sono un romanzo. La stessa Commedia di Dante è un romanzo, ossia un insieme di generi, di alto e basso, di nobile e volgare: del resto, in essa l’individuo Dante si forma fino a diventare, con la salita in Paradiso, un sistema di individui, nella misura in cui egli compartecipa della vita dei personaggi che si raffigura. Le stesse poesie di Petrarca sono i frammenti di un romanzo e, del resto, il Canzoniere narra la formazione dell’autore, il suo progredire incessante attraverso un percorso spirituale e materiale: cosa c’è di più romantico dell’itinerario erotico di Petrarca che tende a Laura come all’infinito? Nella visione schlegeliana, il romanzo coincide con la poesia stessa, della quale è la forma tendenziale: cessando di essere un genere, esso li racchiude tutti. Certo è che, prima ancora di scriverlo, il romanzo è vissuto dal poeta: è questa la prima formulazione di quella che è successivamente diventata una forma popolare, compendiata in frasi del tipo “la vita di quell’uomo è un romanzo”. In questo senso, romanzo è unione di due assoluti: dell’assoluta individualità (del soggetto) e dell’assoluta originalità (dell’infinita pienezza che fa della vita del soggetto un romanzo). Le molteplici opere d’arte di un artista formano allora un solo romanzo che rappresenta il divenire di Dio: ecco allora balenare a Schlegel l’idea di una commedia teologica che sia autobiografia del soggetto assoluto, a sottolineare che l’intera produzione poetica dell’umanità è l’autobiografia di Dio. “Vi sono poesie antiche e moderne che respirano di continuo nel tutto e in ogni parte il divino soffio dell’ironia. Vive in esse una buffoneria davvero trascendentale: nell’intimo, lo stato d’animo che coglie tutto con un colpo d’occhio dall’alto e che si solleva infinitamente su tutto ciò che è condizionato, perfino sulla propria arte, virtù, genialità. Nell’esterno, esecuzione e maniera mimica di un comune buon buffone italiano”: l’invenzione del poeta romantico è lungimirante e ha di mira la totalità, che cerca di raffigurare e per ciò si solleva su tutto ciò che è condizionato (cioè sulle sue singole invenzioni); il poeta è dunque critico di sé e della propria opera e, nell’esterno (cioè nella concreta realizzazione dell’opera d’arte) egli è come un buffone italiano, è ironico quanto critico e, per ciò, il suo agire si traduce in facezia, in sorriso, in parodia del proprio limite riconosciuto come tale. A tal proposito, Schlegel parlerà di “poesia della poesia”, per suggerire l’idea di come nella poesia romantica sia sempre presente la riflessione dell’autore su e in essa. Ciò è da Schlegel esemplificato attraverso il modo in cui Goethe è sempre presente nel suo Guglielmo Meister sorridendo e guardando al proprio capolavoro. L’autore, alto sulla propria opera e già oltre essa, ne sorride benevolmente e in maniera autocritica. Ciò segnala la non coincidenza di quel che di volta in volta l’autore è con la sua opera, che egli trascende: in questo senso, ogni opera è il momento di una più ampia opera che l’autore si sforza via via di produrre. Stesso discorso potrebbe valere, ad esempio, per i Promessi sposi di Manzoni. Ludovico Tieck pubblica nel 1799 una versione drammaturgica de Il gatto con gli stivali, la famosa opera in cui il gatto aiuta il mugnaio a diventare conte e a sposare la figlia del re: Tieck ne fa una farsa satirica contro la letteratura illuministica e contro i suoi testi edificanti. È, in fin dei conti, un’esasperata espressione della teoria schlegeliana dell’ironia nel romanzo: l’azione è sempre interrotta e così l’atmosfera teatrale è impedita. Come ebbe a notare Augusto Schlegel riguardo all’opera di Tieck, “il poeta si interrompe sempre e di nuovo distruggendo di continuo la propria opera”. E Tieck ottiene un tale esito facendo comparire in scena perfino il pubblico e l’autore, il quale commenta e spiega l’azione agli spettatori, i quali interagiscono e interloquiscono con l’azione stessa. Nel terzo atto è addirittura introdotta una disputa tra uno scemo del villaggio con un dotto circa la bontà dell’opera stessa. Il poeta è tanto oltre la propria opera che le impedisce di compiersi in un tutto: così facendo, egli si mostra svincolato da essa. Abbiamo così esaminato un esempio di ironia romantica sulla scena teatrale. In realtà, Schlegel man mano che passano gli anni tende a retrocedere nella propria riflessione sull’ironia: è vero che egli la riscontra in alcuni testi quasi contemporanei, però poi finisce per rinvenirla anche nella letteratura antica, anche se noi non possiamo qui affrontare come egli risolva il problematico rapporto tra arte classica e arte romantica. Ci limiteremo a constatare come la soluzione a tale problema consisterà non già in una opposizione tra le due, ma in una continuità tale da rendere configurabile, come già notavamo, l’intera letteratura mondiale come sede della più alta autorivelazione di Dio. Abbiamo prima ricordato Manzoni, ma potremmo a ragion veduta ricordare anche Leopardi e la sua lirica Il sabato del villaggio: questa costituisce un eccellente esempio di ironia romantica, giacchè se nella sua prima parte v’è rappresentazione, nella seconda domina invece la riflessione e l’intervenire costante dell’autore; ciò ben segnala come anche chi (come Leopardi) è slegato dal Romanticismo finisca poi per esserne coinvolto, quasi come se trionfasse l’hegeliano “Spirito del tempo”. Schlegel nota come nell’arte l’ironia sia già presente anche in opere a lui molto vicine, come Tristam Shandy di Lawrence Stern. Quest’opera è perennemente inframmezzata da pagine bianche, da capitoli perduti e reintrodotti più avanti, da continui interventi diretti dell’autore: sicché Schlegel, più che inventare qualcosa di nuovo, dà un nome a qualcosa che è già sempre esistito ma che, fino ad allora, era rimasto privo di quella consapevolezza teorica che ora Schlegel stesso apporta. Tra gli antecedenti più significativi del romanzo spicca il Don Chisciotte, nella cui seconda parte il ricorso all’ironia è assai forte: Cervantes si rivolge direttamente ai suoi lettori e già nel prologo chiede al pubblico se si debba ornare la narrazione con l’aggiunta di poesie. Nel cap.V della seconda parte, accade addirittura che Sancho si metta a parlare in stile alto e che Cervantes, di fronte a tale fatto inusuale, si giustifichi con la logica del relata refero, dicendo che si sta limitando a trascrivere un manoscritto arabo. Dopo di che, Sancho narra anche che è stato pubblicato un libro su di lui contenente notizie di cui solo lui è a conoscenza: in questa maniera, Cervantes riesce a far muovere l’opera in una duplice dimensione, reale e letteraria. I suoi personaggi, infatti, sono tanto reali quanto letterari, e ciò è avvalorato dal fatto che nel cap.59 egli alluda a un suo plagiatore che, prima che uscisse la seconda parte dell’opera, aveva scritto la continuazione del Don Chisciotte: così troviamo Sancho e Don Chisciotte che sentono parlare due gentiluomini di questa seconda parte apocrifa dell’opera e i due eroi si rivolgono ad essi dicendo che è una continuazione falsa e mal riuscita. Per questa via, Cervantes costruisce una fuga prospettica che è senza fine e che racchiude in nuce l’ironia romantica. Oltre che sul Don Chisciotte, Schlegel sofferma la sua attenzione sui Racconti di Canterbury di Chaucer: essi sono narrati da un oste e, mentre egli ne sta narrando uno, ecco che vede tra gli avventori della sua osteria uno sconosciuto che si qualifica come Chaucer e che si mette a raccontare egli stesso un racconto. Possiamo volgere lo sguardo anche alla letteratura antica: l’Asino d’oro di Apuleio si apre coinvolgendo direttamente il lettore; l’autore stesso parla di “arguzia alessandrina”, a segnalare la presenza della critica e della filosofia nella sua narrazione. In tutti questi casi, l’autore fa valere – rispetto alla fissità dell’opera – la propria mobilità e dunque la propria ulteriorità rispetto all’opera stessa, della quale critica la fissità e così segnala di essere libero da essa pur essendone il produttore. Mentre per l’estetica classica la raffigurazione artistica è compiuta e in essa l’autore trova la propria soddisfazione, qui invece egli non è mai pienamente soddisfatto della propria opera e per ciò non può mai scomparire in essa: è invece sempre indotto a disturbare con la propria presenza la pretesa di compiutezza avanzata dall’opera stessa; egli si adopra dunque affinché essa resti aperta e lo fa con la sua coscienza sempre vigile e critica. Un ulteriore exemplum antico di ironia è ravvisato da Schlegel nella parabasiV (la “sortita”) della commedia antica: essa consiste nell’interruzione dell’azione scenica da parte del coro, il quale avanza fino al limite estremo del proscenio e si rivolge al pubblico, scambiando con esso una serie di battute. La parabasi – osserva Schlegel – segnala la sortita dell’artista dalla sua opera, con la quale cessa di coincidere senza residui: in questo scenario, “l’ironia è una parabasi permanente”, a segnalare questo costante tornare sui propri passi e il rivolgersi dell’ironia contro l’entusiasmo e le sue realizzazioni che tendono a concretizzarsi di volta in volta in una data opera. Questa scoperta di Schlegel dellironia già nell’arte classica risale al suo periodo pre-romantico e filo-elleno, in particolare al Trattato sul valore estetico della commedia greca (1794): in quest’opera, egli configura una reazione distruttiva al raptus creativo, all’ispirazione, all’entusiasmo. “Questa ferita non è frutto di imperizia, ma del lucido ardimento d’una traboccante pienezza di vita”, egli afferma: il lucido ardimento è precisamente lo sforzo dell’infinita pienezza che reagisce alla propria autolimitazione “e il suo effetto non è affatto negativo, ed è anzi di potenziamento” poiché, a ben vedere, la creazione artistica non può mai essere annientata. Quella reazione, allora, “ferisce per stimolare senza distruggere”, per mantenere aperta l’opera e per stimolarne la progressività: è in questo senso che Schlegel parla del romantico come di un uomo “coltivato fino all’ironia”, tale cioè che la sua cultura includa l’autocritica e sia costante oltrepassamento di ogni propria configurazione. Una tale cultura è sofisticata, nel senso positivo – e connesso all’antica Sofistica – di critica: autocriticandosi, anticipa ogni possibile obiezione che le possa essere mossa. Già nel saggio del 1794 Schlegel vede nella produzione artistica due elementi interagenti in maniera dialettica: da un lato, il movimento entusiastico della creazione/limitazione; dall’altro, quello scettico della critica e del superamento della limitazione. Ciò è così sintetizzato: “per lo spirito è parimenti mortale avere un sistema e non averne nessuno. Dovrà per ciò decidersi a coniugare entrambi”. Nella prospettiva schlegeliana, avere un sistema equivale a far uso della riflessione, mentre non averlo significa darsi all’ispirazione e all’entusiasmo. Ed è dall’interazione dei due aspetti – riflessione e ispirazione – che nasce la poesia romantica come “poesia della poesia” o “poesia trascendentale” (tale cioè da riflettere su se stessa): “in tutto quello che rappresenta, dovrebbe rappresentare anche se stessa ed essere insieme poesia e poesia della poesia”. Questa poesia universale e progressiva “può librarsi sulle ali della riflessione poetica fra l’oggetto della rappresentazione e il soggetto rappresentante, tornare sempre a potenziare questa riflessione e moltiplicarla come in una serie interminabile di specchi”. La poesia romantica dà pertanto vita ad un’arte la cui forma Schlegel ritiene di poter definire come “arabesco”, che è indice dell’infinita pienezza. “Indice” è qui da intendersi nel duplice senso che indica tale infinita pienezza e che ne è manifestazione. Dire ciò equivale a segnalarne la struttura di arabesco: quest’ultimo è un’ornamentazione pittorica fatta di forme vegetali, più o meno stilizzate, usato dagli Arabi, ai quali il Corano vieta di raffigurare uomini e animali. Simili agli arabeschi sono le grottesche, ossia quelle decorazioni murarie presenti a Pompei e che i moderni hanno ripetuto nelle logge vaticane di Raffaello. Sono decorazioni murarie fatte da una serie di figure vegetali e animali interrotte da figure bizzarre e chimeriche sì da costituire una decorazione che finisce per coprire tutte le pareti e i soffitti, senza inizio e senza fine, a segnalare un massimo di inventività tendenzialmente infinita. Di esse, Schlegel dice: “quelle argute pitture che chiamiamo arabeschi […] la più antica e originaria forma della fantasia”. L’arabesco è simbolo dello spirito poetico che sempre germoglia e si trapassa, manifestando il gioco ironico con le forme e riuscendo in una raffigurazione che vuole essere allusiva dell’infinita pienezza di Dio. Ecco allora che il romanzo è un ininterrotto arabesco alludente all’infinito e alla sua ineffabilità (non può essere detto proprio perché infinitamente inesauribile): in forza di ciò, Apollo stesso – dice Schlegel – è munito di lira e di arco, il che allude ai due momenti fondamentali della poesia: l’ispirazione (simboleggiata dalla lira) e la critica (simboleggiata dall’arco e dalle sue pungenti frecce). Il richiamo ad Apollo ci porta a richiamare l’opinione che Schlegel ha della mitologia antica: essa è un esempio di arguzia del tutto naturale, cioè spontanea e irriflessa; infatti, in essa il momento ironico agisce inconsapevolmente, dando così ali ad una fantasia che supera sempre e di nuovo le proprie limitazioni. I tanti dei dell’Olimpo sono i singoli aspetti dell’infinita pienezza divina, ma ognuno di essi è solo un aspetto di essa: già i Neoplatonici rilevavano che se l’Uno complica in sé il mondo delle idee, dal canto suo l’Olimpo è la sua rappresentazione poetica e gli dei rappresentano le tante idee. In questa maniera, la fantasia antica dà vita, nella mitologia, ad una totalità progrediente.
LETTERA E SPIRITO IN SCHLEGEL
La concezione della totalità progrediente, dapprima prospettata nei termini mitici dell’antico Olimpo, è da Schlegel approfondita mutuando dalla teologia la distinzione tra la “lettera” e lo “spirito”. La parola letterale è il veicolo dello spirito e tuttavia quest’ultimo è irriducibile ad essa: proprio perché infinito, esso trascende sempre la lettera finita in cui parzialmente di volta in volta si incarna. Sicché “la lettera uccide lo spirito” (Paolo di Tarso) solo se ci si arresta ad essa, fermandosi dunque al significato letterale. Il significato della parola è tale che essa mai riesce ad esprimerlo tutto ed esaurientemente: e tuttavia essa – che è sì parola umana, ma è divinamente ispirata – non dice solo qualcosa di quel significato, non lo riduce solo al proprio significato letterale. Ciò vuol dire che, nell’atto con cui la parola scritturale ne dice qualche cosa, al contempo adombra una molteplicità di ulteriori significati che trascendono quello letterale e che però in esso sono virtualmente contenuti. A differenza della prosa, la poesia include nel detto una pluralità di significati non detti che sta poi alla critica portare in superficie: tanto più una parola è poetica quanto più è pregna di significati. Tale struttura della parola poetica vale a maggior ragione nel caso della parola scritturale: ed è qui che poggia la distinzione tra significato letterale e significato spirituale delle Scritture. La parola dice infatti qualcosa di non riducibile al significato letterale, ma suscettibile di una pluralità di significati che la parola scritturale non riesce a esprimere tutti, può solo alludere ad essi. Come quella del poeta, la parola della Scrittura è rinforzata, allude a una miriade di significati, è – come dice Agostino – un mare immenso e insondabile, un’infinita “sensuum silva” che si configura come “mira profunditas eloquiorum”. Del resto, la teologia medievale distingue tra significato letterale e significato spirituale, suddividendo quest’ultimo in morale, allegorico e anagogico, secondo la nota espressione “littera gesta docet, quid credas allegoria,moralis quid agas, quo tendas anagogia”. E la distinzione tra lettera e spirito è sintomatica del rapporto intercorrente tra significante (la parola) e significato (Dio): il significato è infinito, mentre il significante è tale che pur nella sua finitezza di parola umana riesce, in virtù dell’ispirazione divina, a tener conto dell’infinità del significato, di ciò che si sforza di significare, dicendo sempre anche altro oltre il proprio significato letterale. A tal proposito, Schlegel afferma: “la lettera è spirito fissato. Ogni lettera deve, di necessità, restare sempre incompiuta”, giacché una lettera che si pretendesse compiuta sarebbe la lettera che uccide lo spirito di cui diceva Paolo di Tarso. Sicché “la lettera è la vera bacchetta magica”, perché per un verso fissa lo spirito, per un altro, restando incompiuta, gli permette sempre e di nuovo di sprigionarsi dalla lettera. “La lettera è finita e vuole diventare infinita; lo spirito è infinito e vuole diventare finito”: questo aforisma mette in luce come allo spirito sia congenito il limitarsi in singole opere, le quali sono la “lettera” e aspirano a diventare infinite. Ciò significa che esse sono consapevoli della loro missione, ossia che, pur nella loro finitezza, significano un contenuto infinito: quelle in questione, sono parole che, a differenza della prosa comune, pur vincolate alla finitezza, sono potenti e in grado di trascendersi. È questa la parola poetica in quanto allusiva, il cui significato mai si riduce a quello letterale: pur nella sua finitezza, essa si sforza di essere infinita e, di conseguenza, “ogni opera riuscita sa più di quanto non dica e vuole più di quanto non sappia”. Essa vuole di più e in ciò sta la sforzo che le inerisce in quanto autolimitazione dell’infinita pienezza. Ciò segnala nell’opera la pienezza di quell’ironia che consente all’opera stessa di trascendersi, di alludere ad altro, di andare oltre: “senza lettera, niente spirito. La lettera è vincibile solo nella misura in cui viene fluidificata”. Lo spirito sussiste solo nella lettera, cioè autolimitandosi, ma la fluidificazione della lettera è la necessaria conseguenza dell’infinita pienezza dello spirito che, pur limitandosi, è sempre e di nuovo trascendimento di quel limite in virtù dell’agilità che gli viene dall’ironia: onde l’arguzia propria dell’ironia romantica. La fluidità è il contrario dell’irrigidimento: sicché la lettera suscita lo sprigionamento dello spirito, lo fissa e lo evoca per poi non imprigionarlo, bensì sprigionarlo; e lo fa proprio perché le inerisce tale fluidità che è frutto dell’ironia. Questa è la “magia della lettera”. Ecco perché la filologia è sempre filosofia, che lo sappia o no: la filologia infatti è tale allorché si limita a espertizzare la lettera, ma trapassa in filosofia quando diventa riflessione sul nesso lettera/spirito, capovolgendosi in indagine filosofica circa la natura e le condizioni della creazione artistica, del rapporto vigente tra finito e infinito. Con tali affermazioni, Schlegel sta prospettando una particolare relazione tra l’opera, l’autore e il lettore: quest’ultimo deve essere anche filosofo, cioè in grado di far funzionare la lettera facendole sprigionare lo spirito. In altri termini, il lettore deve saper cogliere l’ironia presente nell’opera e deve dunque saper leggere l’opera stessa, ovvero l’ulteriorità di significato cui essa allude. Il rapporto autore/lettore è allora simpatetico, nel senso che essi devono rapportarsi sulla stessa lunghezza d’onda: nel lettore deve vivere la stessa tensione all’infinito presente nell’artista e nell’opera da lui prodotta e che sta a segnalare la loro (dell’artista e dell’opera) tensione all’infinito. Solamente se si instaura una siffatta relazione l’opera sortisce i giusti effetti: sicché quel che Schlegel chiede ex parte lectoris è di essere congeniale all’opera, di essere fruitore attivo della medesima, deve cioè consentirle di agire come deve, ovvero non come lettera morta che mortifica lo spirito, bensì come lettera che lo sprigiona rimandando dunque ad altro. Per questa ragione, l’opera d’arte è e resta sempre aperta. Da una tale concezione deriva inoltre il fatto che non esiste una rivelazione sola o definitiva dello spirito che si sia consegnato una volta per tutte a uno o a più testi canonici. La rivelazione è, dunque, poliforme e continua, procede ininterrottamente di romanzo in romanzo, dando vita ad un unico libro universale in infinito divenire. Il poeta è allora profeta dell’umanità, giacché, essendo il suo il punto di vista dell’infinito, ne profetizza le ulteriori rivelazioni e ad esse rimanda. In questa prospettiva, la Bibbia diventa metafora di un libro perfetto perché infinitamente diveniente, mera concatenazione di libri trascendentisi gli uni agli altri e ardita commistione di più generi letterari. Da ciò deriva che ogni libro autentico è Bibbia, cioè rivelazione continua in cui la lettera è costantemente dissigillata: “in un siffatto libro eternamente in divenire, verrà rivelato il Vangelo dell’umanità e della cultura”. A dimostrazione di come l’arguzia del discorso di Schlegel sia programmatica ed effettiva, possiamo dire in linguaggio politico quanto abbiamo finora detto in termini religiosi: “la poesia è un discorso repubblicano in cui tutte le parti sono liberi cittadini e hanno il diritto di voto”. Ciò significa che nella poesia tutti i punti di vista hanno cittadinanza e dignità, essendo ciascuno di essi una manifestazione dell’infinito, con la conseguenza che nella repubblica della poesia ogni minoranza è tutelata dalla natura repubblicana (cioè universale e progressiva). Il poeta ha dunque il diritto di vivere ogni forma di vita, facendo tutte le esperienze possibili, di contro a quello spirito borghese che è lettera che uccide lo spirito costringendolo entro la finitezza della propria vita prosaica. In questi termini, l’autore romantico è sempre insoddisfatto della propria opera, sentita come finita: significativamente, nella Lucinde v’è un luogo in cui si dice che “queste parole esprimono solo un lato, un frammento dell’insieme, del tutto che vorrei alludere in tutta la sua pienezza e armonia”. L’ironia è il tramite per cui si realizza la “lotta continua per rappresentare l’irrappresentabile”, cosicché “ogni romanzo vuol essere un libro assoluto e va considerato come libro progressivo”. Il poeta sente l’esigenza di essere più di quel che è: ecco perché la poesia romantica può divenire, ma non può mai essere in senso pieno: il poeta è profeta ma anche mediatore dell’infinito in virtù della sua capacità di sacrificare se stesso e la propria opera all’infinito. A tal proposito, scrive Schlegel: “mediatore è chi avverte il divino in sé e annientandosi si sacrifica per annunciare questo divino a tutti gli uomini col costume, con l’azione, con le parole e con le opere”. In quanto mediatore, il poeta è anche sacerdote dell’infinito: e allora la dottrina schlegeliana del romanzo e del Romanticismo, prima d’essere una teoria artistico-letteraria, è etico-esistenziale, giacché fa riferimento ad un’etica che può essere riassunta nell’imperativo della romanticizzazione. Il romanzo che l’uomo colto è chiamato a produrre è innanzitutto il romanzo che egli è chiamato a vivere, poiché “ogni uomo reca nel proprio intimo un necessario romanzo a priori, il quale altro non è che l’esposizione più compiuta di tutto quanto il suo esistere”. Sta a noi vivere quel romanzo virtualmente contenuto nel nostro intimo, nella nostalgia e nel desiderio, oppure dar seguito alla vita finita che ci suggerisce l’Illuminismo: “ogni uomo che sia colto e si coltivi, reca in sé un romanzo: che poi lo esponga e lo scriva non è necessario”. Si tratta evidentemente di un imperativo etico, che può essere così formulato: “vivere una vita che sia romantica o – il che è lo stesso – poetica”, che sia cioè sede del dispiegarsi dell’infinito. La relazione tra arte e vita non è allora da intendersi come unilaterale riduzione della vita ad arte, ma piuttosto come costante relazione reciproca per cui la vita esprime essa stessa una vita romanzesca e con essa interagisce senza tregua. Se coltivarsi equivale a fare albergare entro sé un sistema di spiriti, allora la relazione con gli altri e con le loro opere assume un’importanza eccezionale in quanto momento imprescindibile nel processo di accrescimento dell’io in una molteplicità. E nessuno quanto i Romantici ha posto l’accento sulla straordinarietà dell’artista: proprio in ciò sta la svolta epocale con cui muta radicalmente il suo status e diventa, da prestatore di opere come tanti altri e dotato di un prestigio non intrinseco all’essere artista, un mediatore, un sacerdote, un profeta, un vate. In questa concezione, i Romantici risentono profondamente della loro formazione protestante e, soprattutto, pietistica: l’artista è sacerdote e questi è non già un funzionario che, all’interno della gerarchia ecclesiastica, espleta determinate funzioni, bensì la persona autenticamente religiosa e abitata dallo spirito divino. Artisti sono allora quanti hanno un autentico rapporto con l’infinito, che in essi preme per giungere all’autoconsapevolezza e per esprimersi nelle loro opere d’arte. Essi eccellono – dice Schlegel per tre motivi: in primo luogo, per la loro separatezza dal finito e dal volgare; poi per via “dell’opera che divinamente va oltre ogni intenzione”, un’opera che è sia finita sia infinita, sia umana sia divina, e “la cui intenzione nessuno intenderà fino in fondo”, essendo essa infinita. Infine, l’eccezionalità dell’artista sta nel fatto che egli può animare i suoi compagni nella loro attività e poi quel che essi creano torna a suo vantaggio. “A tutti gli artisti appartiene ogni dottrina dell’eterno Oriente”: in questa frase, che a tutta prima potrà sembrare enigmatica, è presente quel riferimento all’Oriente che troviamo già nell’antichità (ex Oriente lux) e nel cristianesimo (Cristo come sol iustitiae), ma che trova nella massoneria il suo vertice. La massoneria del Settecento è divisa al suo interno in due correnti che, come qualcuno ha notato, prefigurano la distinzione degli schieramenti politici in Destra e Sinistra: c’è infatti una massoneria illuministica, razionalistica, laica, anticlericale e progressista; ma ce n’è un’altra che, al contrario, è mistica, esoterica, religiosa, neoplatonica. E i riferimenti dei Romantici sono soprattutto rivolti al secondo tipo di massoneria, che soprattutto in Novalis assume le connotazioni del neoplatonismo, mentre in Schlegel quelle del panteismo dinamico. Quello degli artisti è “l’unico, vero gran mondo”, il contrario di quello borghese e volgare rinchiuso nella finitezza: “l’unico gran mondo è quello degli artisti. Essi vivono una più alta vita”, in opposizione a quella borghese. L’artista così celebrato, reso edotto dal suo superiore status di uomo ai margini della società, si distingue anche nei tratti esteriori ed è qui che emerge il tipo dell’artista nella sua alterità rispetto alla gente comune (possiamo scorgere in ciò i prodromi del dandysmo ottocentesco). Gli artisti sono “brahamini, nobili non per nascita ma per libera autoconsacrazione” all’infinito: ecco allora che Schlegel concepisce, in tale prospettiva, una libera associazione – una “lega” – di artisti aventi per scopo alcunché che sia finito: al contrario, loro unico scopo è l’infinito. L’artista si è consacrato al divino di cui ha avvertito in sé l’empito dell’ispirazione e il desiderio e ad essi si è sacrificato. In tale capacità di sacrificio consiste non solo ciò che permette all’artista di essere tale, ma anche ciò che fonda in lui il particolare tipo di relazioni interpersonali che egli è in grado di intrattenere, in primis con gli artisti stessi. Una tale forma di relazione tra artisti dev’essere assunta a modello di ogni relazione umana: è qui che nasce il concetto, squisitamente romantico, di sun-filosofia e di sun-poesia (dal greco sun, nel senso di “con”), ad indicare una forma di cooperazione fra singoli individui accomunati dal perseguimento dello stesso infinito, verso il quale sono in progressione. Dunque ciò li riguarda come uomini prima che come artisti: tale forma di cooperazione implica, da parte di ognuno, la capacità e la disponibilità a sacrificarsi, giacché solo grazie al sacrificio la cooperazione può risolversi in un arricchimento reciproco e ben riuscito per ciascuno nel suo sforzo di universalizzazione. Posso arricchire gli altri e trarre arricchimento da essi esclusivamente se rinuncio di imporre ad essi il mio punto di vista, in primo luogo per il fatto che, in forza dell’ironia, non mi identifico con nessun punto di vista definitivo, in secondo luogo perché non agisco in maniera tirannica ma apro sempre il mio io ad altre suggestioni che lo arricchiscano. Il dialogo reciproco è possibile in virtù di un costante morire dei dialoganti che fonda la vitalità del dialogo stesso: sacrifichiamo il nostro io e poi ci apriamo alle prospettive altrui introiettandole. Ci apriamo dunque all’infinito (in termini religiosi), ma anche agli altri (in termini etico-politici) e all’arte (in termini estetici): in questa maniera, il nostro io diventa repubblicano, vincendo il proprio io particolare e aprendosi ad un’esistenza liberale. Lungi dall’essere un egoista e soggettivista quale Hegel ce lo presenta, il Romantico scorge nella relazione con l’altro (inteso sia come individuo sia come opera d’arte) un momento fondamentale nella sua formazione, per cui una vita senza amicizia e senza amore è un romanzo mancato, non è vita romantica. L’aspirazione all’infinito da cui il poeta è pervaso urta contro i limiti dell’individualità dell’io e si sforza di superarli: proprio per questo motivo, una tal tensione all’infinito è congenitamente apertura all’altro, giacché la socievolezza inerisce al desiderio di infinito. L’apertura all’altro è allora uno dei momenti nei quali si attua il superamento del limite e che dà origine a una relazione non già di unilaterale dipendenza dell’uno dell’altro, bensì di interdipendenza reciproca.
AMICIZIA E AMORE IN SCHLEGEL
“Non c’è nulla di più alto di due amici che vedano riflesso chiaro e perfetto nell’anima dell’altro ciò che hanno di migliore”, scrive Schlegel e, con queste parole, mette in luce come due amici vedano riflesso l’uno nell’altro le loro peculiarità, avvertano i loro limiti e, per ciò stesso, li superino, completandosi reciprocamente. In questo senso, l’amicizia è a un tempo percezione e superamento del limite, per cui in essa v’è critica ironica e anelito all’infinito. Proprio nel confronto con l’altro, tale anelito urta coi limiti, ma nella misura in cui v’è apertura verso l’amico, ecco allora che il segnalamento del limite ne è già anche il superamento, ossia il reciproco completarsi dei due. L’aspirazione all’infinito che caratterizza il poeta è dunque congenitamente socievole: del resto, il Dio del “panteismo dinamico” schlegeliano è spirito concreto, nel senso proto-hegeliano di un crescere insieme integrandosi vicendevolmente attraverso un con-filosofare, un con-poetare e, più genericamente, un con-vivere che potenzia l’universalizzazione di ciascuno. Concrescendo, si introiettano i punti di vista e le personalità altrui: in una tale ottica, non stupisce che i Romantici – e soprattutto Novalis – parlino di “antropofagismo spirituale”, a segnalare come, quanto più la relazione tra due o più individui è forte, tanto più ciascuno di essi tenderà, per così dire, a divorare gli altri e le loro visioni del mondo. Sicché la nostalgia romantica sarà innanzitutto fortissima percezione della propria individualità, ma anche slancio oltre se stessi e apertura ai consenzienti, ossia a coloro che sentono come noi. “Forse potrebbe iniziare una nuova epoca della scienza e delle arti se la sun-filosofia e la sun-poesia diventassero così universali e così individuali da non far più apparire strano e raro che diverse personalità di differente natura ma capaci di completarsi vicendevolmente costruissero opere comuni”: tale pratica, qui teorizzata da Schlegel, si è concretamente realizzata nella rivista Ateneum, scritta unitamente dai Romantici. Ciò illustra il rapporto intercorrente tra poeta e lettore: il poeta è già sempre critico e, in quanto tale, è critico dell’opera propria e aperto a quella altrui, che fa propria; similmente, il lettore s’arricchisce delle opere che legge e che incamera senza restare prigioniero di nessuna di esse, ma anzi, criticandole, le attraversa tutte. È in questo scenario che si innesta la distinzione schlegeliana tra “scrittori analitici” e “scrittori sintetici”: riprendendo la nota distinzione kantiana tra “giudizi analitici a priori” (che sono mere esplicitazioni di ciò che è già contenuto nel soggetto) e “giudizi sintetici a posteriori” (nei quali il predicato aggiunge qualcosa che non è implicito nel soggetto e, così facendo, lo arricchisce), Schlegel etichetta come “analitico” quello scrittore che osserva il lettore quale è, poi fa il suo calcolo e infine appresta le sue macchine per avere su di lui l’effetto voluto. In questo senso, lo scrittore analitico non fa che esplicitare ciò che è già presente nel lettore, scrivendo cioè quel che questi vuole leggere. In questo caso, l’opera si limita a dare al lettore quel che egli già è e già sa (rientra in questa casistica la letteratura di consumo, quella dei best sellers). Trovandosi confermato nel proprio essere, il lettore non può non apprezzare l’opera degli scrittori analitici. Del tutto diverso è il modus operandi dello scrittore sintetico, il quale mira ad arricchire e a coltivare il lettore, cooperando alla sua formazione e aggiungendovi nuovi punti di vista: “lo scrittore sintetico si costituisce e si crea un lettore come deve essere, non se lo pensa morto e passivo, ma vivo e reattivo. Ciò che ha trovato fa sì che si svolga gradualmente dinanzi agli occhi del suo autore o addirittura spinge il lettore a trovare egli stesso quell’invenzione. Lo scritto sintetico non vuole esercitare un effetto determinato, ma entra con lui nella sacra relazione della più intima sun-filosofia o sun-poesia”. Ritornando all’amicizia, essa mira al completamento reciproco e al sostegno dell’individualità: negli anni in cui – grazie soprattutto a Volta e a Renouvier – si stava scoprendo l’elettricità, Schlegel definisce l’arguzia come fenomeno elettrico e sostiene che l’amicizia stessa ha funzione elettrizzante. Così intesa, essa è una relazione che elettrizza i contraenti mediante la “frizione della libera socievolezza”: “elettrizzare l’immaginazione reciproca mediante la frizione della libera socievolezza cosicché la reazione provocata dal più breve contatto, positivo o negativo, possa trarne sfolgoranti scintille, raggi luminosi o colpi detonanti”, questo è l’effetto sortito dall’amicizia. Una persona che viva questo tipo di relazione è contagiosa come lo stato febbrile, che è uno stato di particolare brillantezza e che acuisce l’ingegno. Ecco dove affonda le sue radici l’interesse che i Romantici nutrono per la condizione di malattia: essa è una situazione straordinaria nel senso che è fuori dall’ordinario; perciò, ossia in quanto non normale e sfuggente dalla prosa della quotidianità, essa è poetica e produce un’acuita sensibilità e creatività. Nella Lucinde, così scrive Schlegel a proposito della malattia: “sentivo che la vita della malattia è ricca di misteri e più piena e più profonda della comune salute dei sognanti nottambuli intorno a me”. Il poeta romantico è, agli occhi del borghese, un malato e non uno che pratichi una sortita dall’ordinario. Novalis, recuperando la concezione schlegeliana dell’amicizia, parla diffusamente di assimilazione spirituale e sottolinea come un vero club (termine che rimanda ai club della Rivoluzione Francese) abbia un fine indeterminato: “l’umanità in generale”, ossia il diventare più umani. Proprio questo umanizzarsi costituisce il fine indeterminato dell’amicizia come la intende Novalis, il quale così si esprime: “la società non è che vita comune, un’indivisibile persona pensante e senziente”. Una siffatta descrizione si attaglia perfettamente al Dio perennemente diveniente di cui parla Schlegel e, del resto, ogni uomo è una società in piccolo. E questo contagio spirituale ha effettivamente caratterizzato i nostri autori ai tempi dell’Ateneum, quando la loro attività era un germinare costante di idee che ricorda quello dei dialoghi socratici. Non è un caso che Schlegel fosse solito dire d’essere “una bestia infinitamente socievole e insaziabile d’amicizia” e che “filosofare significa cercare insieme l’onniscienza” propria di Dio. Se questa è l’amicizia, che cos’è l’amore? L’amicizia è – come abbiamo appena visto – integrazione reciproca di due o più individui che concrescono restando però distinti, mentre l’amore va molto più in là nell’integrazione reciproca e si configura anche come una vera e propria – in senso non soltanto metaforico – compenetrazione. A tal proposito, Schlegel accentua la religiosità del suo discorso sottolineando la dimensione mistico/estatica del rapporto amoroso, che viene a configurarsi addirittura come superamento dell’individualità e, anche se solo momentaneamente, del principium individuationis. “L’amicizia è un matrimonio parziale, l’amore è amicizia da tutti i lati e in tutte le direzioni: amicizia universale. La coscienza dei limiti necessari costituisce ciò che di più indispensabile e raro v’è nell’amicizia”: così intesa, l’amicizia è superamento solo relativo dei limiti, giacchè sopravvive una zona franca – potremmo dire un hic sunt leones – nella quale nessuno degli amici osa avventurarsi. Essa viene però meno nel rapporto amoroso, dove cade la riservatezza e subentra una perlustrazione completa dei reciproci territori. Per meglio capire la concezione schlegeliana dell’amore, faremo riferimento alla Lucinde, a questo romanzo autobiografico che Schlegel, una volta divenuto iper-cattolico, ripudierà. Tra amicizia e amore non v’è soluzione di continuità, giacché il secondo è approfondimento della prima: nella Lucinde, si dice significativamente che il protagonista “non amava più solo l’amicizia nei suoi amici, ma gli amici stessi. […] Cercava di far crescere tutti gli splendidi presentimenti e le allusioni presenti nella sua anima. Così il suo spirito veniva arricchito in molteplici rapporti. […] Trovava la piena armonia solo nell’anima di Lucinde”. La relazione che intercorre tra i due rievoca quella di Pigmalione con la statua da lui creata e di cui si innamora a tal punto che gli dei, impietositi, le donano la vita: nel rapporto amoroso, infatti, ciascuno crea il suo partner formandolo. E Schlegel, nel suo romanzo, si spinge oltre, facendo riflessioni sul matrimonio: quasi tutti i matrimoni – egli dice – sono fallimentari e l’essenza di quelli veri sta nel fatto che più persone ne diventino una sola. E Schlegel polemizza aspramente contro il matrimonio combinato, tipico della borghesia, e contro l’impossibilità di divorziare: nella sua critica, egli lascia anche trasparire la possibilità di un matrimonio tra quattro persone. Perché mai ci si dovrebbe opporre a ciò? Se il Romantico è una “persona del desiderio”, allora in quanto tale è già sempre virtualmente aperto ad amare, cosicché l’amore si presenta, rispetto all’amicizia, come ulteriorità più radicale, poiché è – almeno nella prospettiva schlegeliana – un rapporto tra persone di sesso opposto e tale perciò da esprimere l’esigenza di ciascuno dei partners di diventare perfino il sesso opposto, facendo valere il desiderio di totalità. Quanto più la persona con cui si intrattiene il rapporto amoroso è ricca (ontologicamente), tanto più la si desidera, giacché essa appare in grado di estinguere la sete di totalità lasciando vivere il proprio io a quanti sono disposti a sacrificarle il loro. In una tale prospettiva, la monogamia dovrebbe sembrare limitativa a Schlegel, di contro a quello che potremmo definire un “repubblicanesimo erotico” che coinvolge al contempo ben quattro persone. In realtà le cose non stanno in questi termini: quanto più è ricco l’io altrui, tanto più esso impegna e trattiene nella relazione amorosa, cosicché anche la relazione con una sola persona è già una relazione coi molteplici individui che in essa (in quanto sistema di spiriti) vivono. Sicché, quanto più sono geniali gli io che si amano, tanto più sono fedeli l’uno all’altro: l’infedeltà allora è indice della limitatezza di almeno uno dei due contraenti. La relazione amorosa riduce poi la limitatezza dell’individualità empirica, giacché le mie sensazioni scompaiono e cedono il passo ad un massimo di infinita pienezza proprio in virtù del fatto che tra i due di sesso opposto v’è un massimo di differenza (si legge qui, in filigrana, la dottrina platonica dell’androgino): e così gli amanti attraversano insieme i sensi e lo spirito, la distinzione tra maschile e femminile, facendo la più completa delle esperienze. Rigettando l’annientamento della sensibilità prospettato da Kant e da Fichte, Schlegel rivaluta i sensi, concependoli come momento del progressivo squadernarsi dell’infinita pienezza di vita e attestando ancora una volta come il Romantico non si neghi ad alcun tipo di esperienza. La sua è anzi un’inesauribile esplorazione di sensi e di spiriti, con la conseguenza che la ragione e i sensi, anziché escludersi, devono corroborarsi a vicenda, acquisendo ogni forma di vita e passando attraverso la conoscenza di tutte le possibili pieghe dell’io. In quest’ottica, ben si capisce come l’amore sia intrinsecamente connesso alla morte (prendendo ad amare l’altro, il soggetto muore a se stesso per rinascere nell’amato) e come esso comporti sempre nuovi dissensi, poiché l’io oppone una naturale resistenza dalla quale rampolla la rivoluzionarietà del rapporto amoroso. Se infatti l’amore vuole tutto l’altro, ecco che per ciò stesso suscita resistenze nell’io proprio e in quello altrui: per questo motivo, si può dire che gli screzi tra amanti nascano dall’insaziabilità dell’amare, senza la quale non sussiste vero amore. Quest’ultimo è anche una relazione che sostituisce l’un l’altro i due protagonisti alla loro totalità, facendo sì che ciascuno di essi conosca e accetti tutto l’altro. In questa maniera, ci è restituita tutta la nostra varietà raccolta in unità e diventiamo un io autentico. Nel corso della relazione, i due protagonisti cessano di essere quel che erano all’inizio – disiecta membra poetae – e si raccolgono in unità articolata: l’originaria dispersività dell’io è raccolta dai due partners, i quali vedono dall’esterno quella totalità in divenire che altrimenti non riuscirebbero a cogliere. Pertanto i due si consegnano l’un l’altro nella loro pienezza: essi sono l’uno il Pigmalione dell’altro e si soffiano a vicenda la vita. Essere amati è allora essere raccolti, ossia composti: “non l’odio, ma l’amore […] divide gli esseri e plasma il mondo, e solo nella sua luce si può trovare e contemplare, solo nella risposta del suo ‘tu’ con ogni ‘io’ può sentire interamente la sua infinita unità”. Schlegel ribadisce in questi termini il carattere ideale della destinazione cui l’uomo è indirizzato: “nessun singolo uomo può raggiungere la destinazione dell’uomo: quella destinazione si estende all’intera stirpe umana nell’eternità del tempo”. In questa maniera, il panteismo dinamico si traduce in filosofia della storia, tant’è che la storia stessa si configura come progressiva attuazione dell’infinita pienezza di vita, cosicché “un uomo non può mai essere più che un uomo”: essendo irraggiungibile la piena coincidenza dell’esser uomo con l’infinita pienezza, ecco allora che si attua non un’eliminazione, bensì un graduale superamento dei limiti. E dunque l’intera cultura umana è la sede di questa teogonia in fieri.
IL PENSIERO DI NOVALIS
A differenza di Schlegel, il quale intraprende in questo periodo un percorso sostanzialmente unitario, il pensiero di Novalis presenta un’evoluzione rapidissima in due diverse fasi, alle quali corrispondono due diverse visioni del mondo: la prima fase (che si estende dal 1797 al 1798) è quella nota col nome di “idealismo magico”, ad indicare quella dottrina formulata da Novalis in una nutrita serie di frammenti – raccolti sotto il titolo Polline – e nel romanzo incompiuto I discepoli di Sais (1798). La seconda fase (che si ha tra il 1799 e il 1801, anno della scomparsa di Novalis) esprime un mutato punto di vista ed è definibile con l’etichetta di “neoplatonismo cristiano”: a produrre questo cambiamento di percorso è l’incontro col pensiero di Plotino, di Spinoza e della tradizione mistica tedesca. Le opere che vedono la luce in questa seconda fase sono una nuova serie di frammenti, il romanzo Enrico di Ofterdingen, gli Inni alla notte e il saggio Cristianità o Europa. Passiamo all’esame più dettagliato della prima fase, quella dell’idealismo magico: si tratta di un periodo marcatamente influenzato dal pensiero di Fichte (è da lui che Novalis desume la componente di idealismo cui allude l’etichetta “idealismo magico”) e, per entrare in medias res, possiamo muovere da due frammenti novalisiani. “Il metodo di Fichte e di Kant non è stato esposto ancora del tutto e con sufficiente precisione: entrambi non sanno ancora sperimentare con sufficiente facilità” e col giusto punto di vista trascendentale. Il secondo frammento dice invece: “è probabile che esistano e che esisteranno uomini capaci di fichteggiare molto meglio di Fichte”. Dalla lettura dei due frammenti, è facile capire come Novalis subisca il fascino dell’idealismo fichteano, che egli avverte coem sollecitatore di congetture e come stimolante ad ulteriori riflessioni che egli va presentando in forma di ipotesi e di domanda: ciò significa che non si tratta di elaborare sistematicamente il punto di vista di Fichte (e anzi Novalis è profondamente anti-sistematico), ma piuttosto di congetturare a partire da esso, sviluppando – nella forma del frammento – le virtualità e le potenzialità (anche artistiche) di un tale pensiero, che Novalis presenta – con terminologia alchemica – come una serie di “fermenta cognitionis”. Proprio muovendo da queste considerazioni, egli perviene ad un impiego poetico e fantastico della riflessione di Fichte: questi è visto come colui ceh accende la fantasia di chi sa “fichteggiare” meglio di lui stesso, attivando tutte le possibili congetture virtualmente racchiuse nel suo pensiero. E, nella fattispecie, il punto di partenza che Novalis mutua da Fichte è l’idea che il mondo sia il prodotto inconsapevole della struttura trascendentale di tutti i soggetti umani. In particolare, a colpirlo è la nozione di “immaginazione produttiva”: operando inconsciamente in ogni soggetto, essa si prolunga – nota Novalis – nell’immaginazione produttiva dell’artista. Si è spesso sostenuto che i Romantici fraintendono Fichte nella misura in cui confondono l’Io infinito con l’Io empirico: ma, se riferita a Schelling e a Novalis, tale tesi è erronea, giacché nessuno dei due autori cede ad un tale travisamento di bassa lega. Quel che i Romantici fanno è, piuttosto, una “legittima” (almeno dal loro punto di vista) accentuazione dell’Assoluto nel finito: e, del resto, non era forse Fichte stesso ad insegnare che l’Assoluto vive soltanto nel finito, come sua condizione? Si tratta di render consapevole l’inconsapevole, volontario l’involontario, ossia di muoversi nella direzione di un impadronimento cosciente dell’attività assoluta inconsciamente operante nella coscienza di ogni singolo individuo. Fichte notava che il non-Io (cioè il mondo esterno) è, in ultima analisi, l’Io stesso: sulla sua scia, Novalis, alla domanda “che cos’è la natura?”, risponde che essa è “un indice sistematico, enciclopedico dello spirito, un piano dello spirito”. Con ciò, egli intende dire che essa è inconsapevole limitazione dell’Io stesso. In questo senso, per Novalis la natura è spirito solidificato, attività pratica rappresa, “il passato dell’Io”, ovvero ciò che l’Io cessa sempre e di nuovo di essere in virtù del suo essere attività pratica. Dall’identità di natura e spirito, segue che conoscere il mondo equivale a conoscere se stessi, cosicché “capiremo il mondo quando capiremo noi stessi”: e la comprensione del mondo non può che avvenire congetturalmente, attraverso la conoscenza di ciò che inconsapevolmente siamo (dal canto suo, la scienza conosce solo la superficie fenomenica del mondo, mai l’in sé della natura). Un tal punto di vista mette in luce come, per conoscere l’universo, si debba viaggiare non nell’universo stesso, ma in se stessi: “verso l’interno si volge la via misteriosa” e, a tal proposito, l’immagine che meglio esprime questa concezione è quella del minatore che si cala nelle profondità dell’Io (la psicanalisi di Freud affonda qui le proprie radici). “L’universo non è forse in noi?”, si domanda Novalis: il mondo esterno – come abbiamo detto – non è che Io pietrificato, inerzia, libertà passata, “è la somma delle cose passate e staccate da noi”: il criterio di conoscenza diventa allora quello dell’analogia, che schiude la natura metafisica del mondo. Grazie ad essa, applicando al mondo la conoscenza che abbiamo di noi stessi, possiamo estendere sempre più il nostro sapere. Proprio in questa prospettiva, alla mania congetturale di Novalis si affiancano le divagazioni poetico/fantastiche nelle quali egli non si perita di considerare la natura in analogia con l’uomo, con la conseguenza che essa va incontro ad una progressiva antropomorfizzazione, diventando una persona cara in quanto nota (giacchè la natura siamo noi stessi o, meglio, eravamo noi stessi). Allora familiarizzare con la natura significa familiarizzare con noi stessi, il che spiega perché i poeti abbiano l’innata tendenza a personificare le cose e a parlarne come se esse fossero persone viventi: “noi dobbiamo considerare natura e mondo esterno come un essere umano che possiamo e dobbiamo comprendere come comprendiamo le persone care”. Si affaccia qui una relazione dell’uomo con la natura che è di tutt’altro genere rispetto a quella di mero sfruttamento fatta valere dalla borghesia illuministica dell’età della “rivoluzione industriale”. Resta però da chiarire perché l’idealismo di Novalis venga definito “magico”: esso è così detto perché evidenzia il carattere prodigioso della creazione della natura da parte dell’Io; esso la crea senza saperlo e ne resta incantato – qui sta l’elemento magico -, credendo che essa sussista indipendentemente. Il mondo è una creazione dell’Io, ma gli appare come “altro”: a tal punto l’incantesimo è stato forte. L’Io, preda del proprio stesso incantesimo, è l’Io del punto di vista realistico, per il quale il mondo esterno ha una sua realtà: rispetto a questo punto di vista, l’idealismo di Fichte è una rivoluzione sconvolgente, perché – nell’ottica novalisiana – il mondo è al contempo soggettivo (perché prodotto dall’Io) e oggettivo (perché non riconosciuto dall’Io come sua produzione): “il più gran mago – scrive Novalis – sarebbe chi sapesse incantare se stesso fino al punto che le sue stesse magie gli apparissero fenomeni estranei, e questo non potrebbe essere il caso nostro”. Ma si tratta di un idealismo “magico” anche per un secondo motivo: l’uomo è infatti dotato di una potenza magica, per lo più ancora inutilizzata, che può essere attiva se si ridesta la creatività di cui egli è inconsapevolmente capace, diventandone consapevole e usandola coscientemente e volontariamente. Ciò può essere il frutto di un esercizio di vigilanza e di attenzione tali da trasformare l’inconsapevole in consapevole e da sviluppare le facoltà dell’uomo, incrementandone l’attività. In questo senso, quanto più diventiamo attivi (diminuendo la nostra inerzia), tanto più il mondo esterno perde potere su di noi, essendo esso null’altro che la nostra inerzia (spirito addormentato). Sicché vincere l’inerzia significa vincere la resistenza del mondo nei nostri confronti, recuperare le forze latenti, estendere il dominio della volontà. V’è poi un’altra possibilità: ricreare il mondo. Anzitutto, affinché ciò si attui, occorre rivolgersi al proprio corpo, trasformandolo nella nostra stessa volontà e, pertanto, vincendo le funzioni involontarie. Si tratta pertanto di acquisire una totale padronanza del proprio corpo e di tutti i suoi movimenti involontari, con la conseguenza che, quando ciò sarà avvenuto, ognuno sarà medico di se stesso, potrà togliersi la vita secondo la propria volontà e potrà addirittura modificare la rappresentazione del corpo che vorrà. Del resto, abbiamo già concreti esempi di relativo dominio dei sensi ad opera della fantasia: in particolare, dobbiamo pensare al pittore che nelle sue opere fa vedere cose che gli occhi comuni non vedono, cose che in natura non hanno cittadinanza. Sicché l’arte migliora la natura, raffigurandola nella sua perfezione ideale. Questa magia positiva si applica non solo al corpo, ma all’intera natura, cosicché il mondo dev’essere come voglio io. Il tema della ricreazione del mondo va dunque nella direzione di una sua moralizzazione: in effetti, se esso è una mia rappresentazione, allora dipende da me come me lo rappresento; in tale ottica, non stupisce che lo stesso luogo possa apparirci diverso a seconda degli stati d’animo che abbiamo quando lo osserviamo (se siamo depressi, ci apparirà uggioso; ma se siamo euforici, ecco allora che ci sembrerà allegro). Ciò vuol dire che “noi abbiamo creato la natura come materiale del nostro dovere morale, possiamo ricrearla associandola alla nostra stessa moralità”. Com’è noto, in Fichte la natura è fatta per essere vinta dallo spirito e dissolta nella pura identità della ragion pura pratica con se stessa: ora, Novalis apporta una variante introducendo la legge morale nella natura stessa. Ciò significa che cade l’antagonismo tra inclinazioni sensibili e imperativo categorico, nel senso che l’istanza razionale è estesa alle stesse inclinazioni sensibili. Quella che abbiamo di fronte è dunque una natura sognata dal poeta, moralizzata e pertanto tale da essere dominata non dalla legge del più forte, bensì da una convivenza armoniosa tra gli uomini, nella quale il rispetto dell’uomo come fine è esteso a tutte le creature viventi in natura (troviamo qui i prodromi del contemporaneo ecologismo). Si tratta quindi di una natura edenica, bonificata e pacificata: ciò non toglie che a dircelo siano sempre congetture e scenari onirici e fiabeschi, in un panorama di utopia e di forte opposizione all’immagine sensistica della natura offerta dall’Illuminismo.
SPIRITO, NATURA, FIABA IN NOVALIS
I discepoli di Sais è un’opera incompiuta e suddivisa in due frammenti (Il discepolo e La natura), ai quali si aggiunge una ricca appendice di abbozzi e frammenti. La storia narrata nello scritto è quella di un giovane che, volendo afferrare il mistero dell’universo, si mette in viaggio verso il tempio di Sais, un luogo venerando e misterioso che tramanda una sapienza antica. In esso si venera l’immagine di una dea – Iside – coperta da un velo: chi arrivi a sollevarlo, avrà la rivelazione del mistero dell’universo. Quest’opera, che è la più fichteana tra quelle di Novalis, presenta un clima vivamente sognante, con una natura non descritta ma interiorizzata e ridotta a sogno. I punti cardinali che affiorano dalla lettura di questo scritto – che si presenta come un romanzo di formazione e di viaggio – sono essenzialmente tre: in primis, in un abbozzo dell’appendice, Novalis dice che il viaggio termina con l’arrivo a casa propria dalla sposa. In secundis, in un altro punto del romanzo, si narra in maniera più diffusa la stessa vicenda ma sotto forma di favola. È la favola di Giacinto e di Fior di Rosa: i due vivono nell’amore reciproco, fino a che non arriva uno straniero che reca con sé un libro (che dona a Giacinto) e che con la sua parola suadente ammalia Fior di Rosa. Giacinto, depresso per l’amore perduto, si mette in cammino per arrivare – attraverso peripezie innumerevoli – alla dea Iside. Giuntovi, le solleva il velo e Fior di Rosa torna a gettarsi tra le sue braccia. Solo il sogno (che è congettura trascendentale del poeta che sogna qualcosa di inesistente nel reale e che è contrapposto alla coscienza desta dell’Illuminismo) riesce a condurre Giacinto alla meta: egli, quando all’inizio vive tranquillo e senza preoccupazioni la realtà, rappresenta il borghese illuminista; il vecchio straniero che gli fa dono del libro è Fichte stesso, che semina il dubbio e rende il mondo non più visibile negli antichi termini, sollecitando Giacinto ad una nostalgia che lo porterà a congedarsi da tale mondo e ad arrivare alla sua amata. In tertis, v’è un distico nell’appendice che così recita: “arrise ad uno di sollevare il velo della dea di Sais. Ebbene, che vide? Vide – meraviglia delle meraviglie – se stesso”. Egli trova cioè quel che già inconsapevolmente aveva ma che ora diventa consapevole e volontario. Il lungo e travagliato viaggio nella natura ha per fine il punto di partenza (l’Io), scoperto come principio della natura: è la scoperta del punto di vista trascendentale. In un altro abbozzo, Novalis passa in rassegna cinque diverse interpretazioni della natura: 1) quella economica, tipica della scienza, secondo cui la natura è “fucina e dispensa”; 2) quella religiosa, per cui la natura è intesa come tempio; 3) quella dell’educazione artistica (o incivilimento), per cui la natura è raffigurata dall’artista come idealmente perfetta; 4) quella orrifica, secondo cui la natura è una forza bruta, un “mulino di morte” tale da suscitare il terrore d’esserne sopraffatti; 5) quella liberatoria, per cui l’uomo, resosi consapevole della propria capacità di domare e di vincere la natura, non la teme più (è questa la prospettiva di Fichte). Non solo siamo liberi rispetto alla natura, ma – aggiunge Novalis – la terribilità stessa della natura è opera nostra, in quanto siamo noi a partorirla con la nostra immaginazione. Si può dunque rimuovere la terribilità della natura: il discepolo resta smarrito e interdetto fino a che non comprende che tali letture della natura non sono tra loro autoesclusive, ma costituiscono piuttosto le tappe successive verso la finale visione poetica della natura stessa, cioè verso la sua umanizzazione. Infatti, personificando la natura, il poeta ne sottolinea la familiarità e il suo continuo rimandare all’uomo stesso. Presto però il punto di vista fichteano è abbandonato ad Novalis, in quanto ritenuto inadeguato. Di fronte ad esso, il congetturare novalisiano si presenta spesso come un fantasticare soggettivistico e incurante della validità dell’argomentare. Come Schlegel approda ad un prospettivismo repubblicano e liberale, così in Novalis il fantasticare fa poi valere istanze filosoficamente pregevoli, prima fra tutte la rivalutazione della natura. Questa è prodotto inconsapevole dell’immaginazione produttiva e, pertanto, ha un’essenza spirituale, ancorché si tratti di spirito pietrificato: è proprio qui che appare insostenibile la posizione di Fichte, la quale svaluta la natura liquidandola come mero ostacolo al libero espandersi dello spirito (a tal punto che, se non vi fosse la natura, lo spirito potrebbe realmente essere tale, illimitato e perfetto). Proprio queste considerazioni inducono Novalis a congedarsi da Fichte e ad addivenire ad una concezione della natura rispetto alla quale la prospettiva fichteana appare inconciliabile: la natura non può in alcun caso essere ridotta a mero strumento dell’attività dello spirito, giacchè entrambi (natura e spirito) rimandano ad un principio superiore di cui sono il prodotto. Proprio qui sta il passaggio novalisiano dall’idealismo magico al neoplatonismo cristiano, che si configura eminentemente come avvicinamento a Plotino e a Spinoza (la cui metafisica è di impianto direttamente plotiniano). E Novalis fa valere in forma interrogativa i suoi dubbi circa la dottrina di Fichte: “Fichte non ha forse messo arbitrariamente tutto nell’Io? E con quale diritto? L’atto per cui l’Io si pone come Io deve essere congiunto con l’antitesi di un non-Io indipendente e col riferimento ad una sfera che li racchiuda: questa sfera la si può chiamare Dio”. La natura allora non è più rappresentazione inconsapevole dell’Io, ma anzi sussiste indipendentemente da esso ed è anch’essa il prodotto dell’unico principio – Dio – che è infinita pienezza di tutte le possibili forme d’essere. In un frammento che a tutta prima può sembrare di esclusiva pertinenza psicologica, scrive Novalis: “stati d’animo e sensazioni indeterminate, e non invece sensazioni e sentimenti determinati, rendono felici. Ci si sente bene allorquando non si osserva in sé alcuno stimolo particolare, alcuna serie determinata di pensieri e di sensazioni. Della coscienza più perfetta si può dire che è coscienza di tutto e di nulla”. È un elogio all’indeterminatezza, da Novalis (come da Schlegel) opposta all’ordine – borghese e illuministico – che regola l’esistenza di quanti si assoggettano alle leggi dell’utile e della produzione. Al contrario, l’indeterminatezza è esperita come piacevole perché interrompe la monotonia di quell’ordine e vi introduce un elemento di novità, un che di insolito. E il nuovo e l’insolito piacciono perché, rispetto alla prosaicità dell’ordinarietà, hanno un effetto poetico, esercitano un’azione liberatrice dalla soffocante angustia dell’ordinario e della routine. “Tutto ciò che è nuovo sortisce, in quanto estraneo, un effetto poetico. Tutto ciò che è antico [“antico” qui nel senso di “passato”] sortisce parimenti, in quanto interiore, un effetto romantico. Entrambi in contrasto con l’ordinario. La vita ordinaria è prosaica, è discorso e non canto. La quantità di ciò che è ordinario serve solo a rafforzare l’ordinarietà, onde l’impressione opprimente che fa il mondo se contemplato dal punto di vista utilitaristico, ordinario, prosaico”. Come in Schlegel, anche in Novalis c’è contrapposizione tra la poesia e la prosa: il regno dell’utile e del finito è opposto al romantico e al poetico, identificati da Novalis con l’eterogeneo, l’indeterminato, l’insolito. Sicché poetico è l’accidentale, l’imprevisto, tutto ciò che sfugge alla prosa rozza e volgare del quotidiano. In questa prospettiva, la poesia è allora irruzione di “altro” nel quotidiano e “ogni poesia interrompe lo stato abituale, la vita comune per rinnovare”. Malattie, incidenti, nuove conoscenze, imprevisti sortiscono allora un effetto che poetizza la vita, giacché ne interrompono la regolarità. Resta da chiedersi in che senso e perché l’esotico e l’insolito siano romantici: a questa domanda, Novalis risponde che essi sono romantici in virtù del fatto che la poesia è, lato sensu, l’altro mondo, quello più alto, soprasensibile e sovraterreno; in una sola parola, “poesia è l’Uno-Tutto”, cioè l’infinito stesso. Il principio della poesia è allora tutt’altro rispetto a questo mondo: esso si configura anzi come principio cosmico, il che era già vero ai tempi dell’idealismo magico, quando il principio cosmico della poesia era ricondotto all’Io assoluto (essendovi, all’origine della realtà, l’inconsapevole poetare dell’Io). Come si ricorderà, l’immaginazione produttiva è l’unica fonte di poesia che produce il mondo (inconsapevolmente) e la poesia che lo canta (consapevolmente), ma questa seconda può modificare il primo, in direzione di un’umanizzazione della natura. Il poeta può dunque rifare in meglio il mondo rispetto a come l’ha creato l’immaginazione produttiva, la quale – in quanto inconsapevole – può essere smodata e arrivare a produrre il già ricordato “orrido in natura”. Abbandonato l’idealismo magico, nella fase neoplatonico/cristiana la poesia come principio cosmico coincide con l’Uno-Tutto, ossia con Dio, che dobbiamo intendere come un infinito reale e sussistente prima rispetto ai suoi effetti, di cui è principio e complicazione (li include in sé virtualmente). E questo Uno-Tutto non ha nulla a che vedere col panteismo dinamico di Schlegel: secondo Novalis, infatti, l’infinito non sussiste divenendo (come credeva Schlegel), ma è anzi reale e attuale (ancor prima del suo produrre). La poesia originaria è questo Uno-Tutto di cui il poeta, con la sua opera, dà rivelazione: e la vera interazione che vige tra l’infinito e il molteplice finito, ossia tra il mondo soprasensibile e quello sensibile, è platonicamente intesa come partecipazione, nel senso che le tante cose di questo mondo sono sospese all’altro mondo, del cui essere partecipano, da cui cioè ottengono di essere ciò che sono e di esistere come tali. Scrive Novalis: “il visibile è sospeso all’invisibile, l’udibile all’inudibile, il percettibile all’impercettibile, e così forse il pensabile all’impensabile”. Il termine “partecipazione” deriva dal latino partem capere, ma è una parola equivoca perché fa sembrare che la relazione sia tra due soggetti preesistenti al loro rapporto di partecipazione: ma così non è, in quanto uno dei due è prodotto dal parteciparsi del principio. Prima che ciò avvenga, non v’è nulla che partecipi dell’essere del principio. Si tratta del parteciparsi del principio che “crea”: sicché la partecipazione è il principio stesso che diventa i suoi effetti, modificandosi in essi. È, allora, un’autocontrazione del principio, che si limita nei suoi prodotti ma senza per ciò cessare di esser principio. Simultaneamente, l’Uno sussiste come infinita pienezza che resta tale e come modificazione nei suoi prodotti. Esso si partecipa, contraendosi, nei suoi effetti (spinozianamente: nei suoi “modi”) e lo fa per una traboccanza d’essere, il che è ben sintetizzato dall’afermazione di Platone secondo cui la divinità non è invidiosa. Sicché l’Uno è, al contempo, immanente e trascendente, è “ubique et nusquam”: è ovunque, perché è in tutte le cose; ma è anche da nessuna parte, poiché non si esaurisce in nessuna delle cose che è. E la produzione del mondo nulla aggiunge all’Uno e nulla gli toglie. Per chiarire questo punto, Plotino ricorre all’immagine della sorgente, la quale diventa fiume senza però cessare di essere sorgente, e all’immagine della radice, che produce l’albero restando però radice. Ciò spiega anche come l’Uno sia al contempo onninominabile e ininnominabile e, di conseguenza, come siano possibili tanto una teologia catafatica quanto una apofatica: è onninominabile perché tutte le cose sono sue modificazioni, e dunque il nome di ogni cosa già allude all’Uno; ma è anche ininnominabile perché nessun nome esaurisce la sua essenza (e neanche la somma di tutti i nomi può farlo, giacché esso è anche trascendenza). Modificandosi, allorché li produce, l’Uno è mal ridotto nei suoi enti, poiché la partecipazione può avvenire solo “discensive” (Tommaso), ossia procedendo dall’infinito al finito, cosicché nella partecipazione viene meno l’infinita pienezza d’essere. E il cosiddetto “male metafisico” di cui parla Leibniz è appunto la finitezza del finito, il fatto che ogni cosa sia soltanto se stessa. Tale finitezza è però un male solo se considerata dal punto di vista dell’infinitezza di Dio: ciò non di meno, in presenza del male metafisico, può insorgere il “male morale”, dal momento che la finitezza implica necessariamente contrapposizione, discordia, antagonismo, lotta, dissidio, egoismo. Infatti, tutto ciò che è soltanto se stesso si trova immediatamente opposto a quel che esso non è. È questo il principio prosaico virtualmente presente nel finito, di contro alla poesia dell’infinito, il quale è concordia e amore. Dove la finitezza si pretende autonoma, là entra nella prospettiva utilitaristica ed eudemonistica che con l’Illuminismo celebra i suoi trionfi. Facendo essere le cose quelle che sono attraverso la partecipazione, l’infinito – nota Novalis – è presente in tutte le cose, senza tuttavia ridursi ad alcuna di esse. Ecco perché Novalis riprende invariato lo slogan neoplatonico dell’ubique et nusquam (pantacou kai oudamou, in greco): “il mondo patrio è ovunque e in nessun luogo”; con questo linguaggio accentuatamente neoplatonico, egli sottolinea come la patria non sia questo mondo, col quale tuttavia è intimamente intrecciata, a tal punto che “il mondo superiore ci è più vicino di quanto comunemente non crediamo”. Ecco che ci avviciniamo al redde rationem: ogni cosa sensibile è vestigio del suo principio soprasensibile; “vestigio” nel senso forte di “immagine”, di riproduzione, ad evidenziare come ogni cosa visibile non sia che un’immagine e un riflesso del mondo invisibile. Se dunque a questo mondo inerisce lo statuto di immagine e – spinozianamente – di “modo” dell’infinito, allora esso è poetico: infatti, se l’infinito è poesia (e abbiamo visto che lo è), allora anche questo mondo – che ne è simulacro – è poetico, ossia aperto all’altro mondo, che attraverso esso filtra e traspare. Proprio perché questo mondo dipende in toto dall’altro, ipso facto è rimando al suo principio. La sua inconsistenza ontologica è già sempre un rinvio al principio stesso e proprio in ciò risiede la natura teofanica del nostro mondo, della quale l’Illuminismo s’è scordato. Così inteso, il mondo è un libro scritto da Dio, come sostiene una lunga tradizione di matrice medievale, cosicché il libro scritturale è affiancato dal liber naturae, da quello che spesso è stato definito il “gran teatro del mondo”, nel quale Dio nasconde e, insieme, manifesta se stesso. Egli si manifesta, poiché – platonicamente – l’effetto non può che somigliare alla causa (e dunque il mondo è un costante rinvio a Dio), ma al contempo si cela, giacché la causa è sempre qualcosa di più del suo effetto, che ne è una restrizione. Proprio in questa prospettiva si inserisce la riflessione di Novalis, il quale recupera – come Schlegel – la distinzione tra spirito e lettera: sicché ogni cosa del mondo è un nome predicabile di Dio, da cui tutto dipende. L’errore sta nel ritenere che le cose di questo mondo siano autonome e tali da rimandare solo a se stesse: è questo il nefasto atteggiamento della scienza moderna, che vede nelle cose soltanto la loro finitezza. In questo senso, il mondo è “una rivelazione dello spirito, ma è trascorso il tempo in cui lo spirito di Dio era comprensibile”. Pertanto “il significato del mondo è andato perduto”, siamo rimasti fermi alla lettera o – come dice Novalis – “è rimasta la manifestazione, ma abbiamo perso ciò che vi si manifesta”. Da trasparente che era, il mondo s’è fatto opaco e tale intervenuta opacità, la quale non è che il prosaicizzarsi del mondo stesso, è frutto dell’assolutizzazione della sua finitezza: esso è ridotto a “monotona ripetitività d’una macchina autosufficiente e in sé conchiusa”, con l’esclusione di ogni riferimento ad un fondamento che lo trascenda. In questa prospettiva, il mondo ha il solo significato letterale decriptato dalla scienza, la quale non ne ammette altri: “un tempo, tutto era apparizione di spirito; ora vediamo solo una morta ripetizione che non comprendiamo”. In altri termini, manca il senso del geroglifico: come è noto, lo stesso Plotino fu un grande estimatore del geroglifico, inteso come simbolo equivoco plurisignificante e, dunque, adatto ad esprimere l’insondabile infinitezza dell’Uno, giacché è l’esempio lampante di una lettera che racchiude in sé infiniti significati. Ogni cosa, proprio perché una, è un rimando all’Uno stesso: ognuna di esse risulta dall’unione di una pluralità di fattori uniti in modo non caotico, ma ordinato e tale da manifestare il loro essere effetti di un’unità superiore che, mediante essi, si manifesta. Sicché ogni molteplicità partecipa già sempre dell’Uno, come rileva Proclo: ecco la ragione per cui ognuna di esse è una (è se stessa e non le altre) e per cui il mondo stesso non si risolve in una congerie di schegge disordinate, ma in un quid di unitario e disciplinato che si configura come teofania. Del resto, in un mondo opacizzato e senza poesia, ogni cosa non può che svilupparsi all’insegna dell’utile, del basso e dell’ordinario: ma ciononostante, sebbene soffocata dallo scientismo imperante, l’intrinseca natura spirituale del mondo è solamente stata obliata e occultata, non abolita. Ne segue che colui il quale è infelice in questo mondo e non vi trova ciò che cerca, conserva intatta la possibilità di una ripoetizzazione del mondo stesso, una sua romanticizzazione (riaffiora qui, invariato, il tema romantico della nostalgia). Perché si possa riscoprire la sua dimensione teofanico/poetica, occorre anzitutto smettere di guardare le cose troppo da vicino e con l’ausilio di un “rischiaramento” (Aufklärung in tedesco, termine che designa l’Illuminismo) artificiale che, facendo troppo risaltare le cose nella loro finitezza, ne enfatizza la consistenza ontologica facendola sembrare maggiore di quanto non sia. Questo guardar troppo da vicino finisce infatti per attribuire ad esse un’autosufficienza di cui in realtà sono prive, poiché dipendenti dall’Assoluto. E pertanto, se si vuole ripoetizzare questo mondo, bisogna in primis rigettare la volontà di dominio – fatta valere dall’Illuminismo – su di esso, guardando le cose con distacco: così facendo, esse torneranno a mostrarsi per quelle che sono, nella loro reale natura poetica ed allusiva. È un po’ come quando contempliamo le cose da distante e nella luce incerta del crepuscolo, in cui perdono i loro contorni ben definiti e la loro marcata delimitatezza, cosicché ogni cosa si dissolve e sfuma, smarrendo la sua apparente consistenza e facendo tornare trasparente ciò di cui è immagine. A tal proposito, Novalis afferma che “nella lontananza, tutto diventa poesia” e, di conseguenza, tutto diventa romantico e affiora la nostra natura originariamente poetica. Nell’Enrico di Ofterdingen, il Medioevo in cui è ambientato il romanzo è significativamente concepito come epoca romantica perché caratterizzata dal contrasto tra chiaro e scuro: quella medievale è dunque un’epoca crepuscolare, contrapposta ai tempi moderni che offrono l’immagine di un giorno generalizzato (ciò è dovuto all’eccesso di luce prodotto dall’Illuminismo). La ripoetizzazione del mondo, che dev’essere la stella polare dell’agire del Romantico, fa riemergere la dimensione teofanica e poetica del mondo, ed è opera del poeta romantico, il quale, alla prosa illuministica, sostituisce la propria poesia e, così facendo, riscopre il mondo come poema di Dio. In ciò, egli riesce nella misura in cui è in grado di rappresentare un mondo dai contorni sfumati – quale era quello medievale -, con dissolvenze e lontananze, con brume e crepuscoli. Per meglio comprendere questa poetica del non-finito, possiamo fare riferimento a Michelangelo che, campione artistico del non-finito, segue quella poetica platonica secondo la quale lo sfumato e l’incompiuto tendono a negarsi e, per ciò stesso, alludono ad altro. Infatti – nota Novalis – un’immagine sfocata è allusiva, vince la rigidità dei contorni fatta valere dalla scienza: ne emerge un mondo fluttuante e disancorato quale effettivamente è, non avendo in sé la propria radice (a mettere sulla tela i precetti novalisiani saranno Friedrick e Turner). Dunque la poetizazzione rende al mondo il suo significato originario, restituendo all’ordinario la funzione di veicolo dello straordinario. In questi termini, romanticizzare è potenziare qualitativamente, in quanto si conferisce “all’ordinario un altro significato, all’abituale un aspetto misterioso, al noto la dignità dell’ignoto, al finito un’apparenza infinita”. Questa teoria è così sintetizzata da Novalis: “il senso per la poesia ha molto in comune col senso per il misticismo: è il senso dell’originario, del personale, dell’ignoto, dell’arcano, di ciò che deve essere rivelato. Rappresenta l’irrappresentabile, vede l’invisibile, percepisce l’impercettibile. La sensibilità poetica è molto affine alla sensibilità profetica e, in generale, a quella religiosa e divinatrice”. E questo mondo ci è dal poeta presentato come meraviglioso: infatti, in un mondo veramente poetico, tutto è naturale ma meraviglioso, si crede che nulla potrebbe essere diversamente ed è come se si fosse fino ad ora dormito. Il mondo ci appare tutt’altro ed è così che la poesia sana le ferite procurate dall’intelletto, giacché essa riscopre il meraviglioso del mondo stesso e lo libera dalla soggezione al finito. La meraviglia dev’essere però distinta dallo stupore: quest’ultimo è uno stato di coscienza attonito e, per così dire, stupido ed ignorante, in quanto ci si stupisce di ciò che si ignora. È pertanto uno stato d’animo prodotto da qualcosa che ancora non si sa. Sull’altro versante, la meraviglia presenta l’etimo del latino mirari e mirabilis: a suscitarla è qualcosa di miracoloso, e non è un caso che tanto Platone quanto Aristotele pongano il qaumazein (che è meraviglia, non stupore) come initium philosophiae, riferendosi non solo all’inizio in senso cronologico, ma anche come principio animatore e permanente dell’indagine filosofica e del sapere, che mai può essere interamente dissolto da ciò che via via è saputo. Su questa scia, Novalis sostiene che, a partire dalla conoscenza di questo mondo finito, si può risalire al sapere infinito: le cose sono meravigliose nel senso che destano meraviglia in quanto specchi riflettenti l’infinitezza divina, con la conseguenza che ammirare il mondo è già sempre ammirare il principio divino cui esso rinvia. Un tal sapere mirante all’infinito culmina, da ultimo, in un non sapere o, per dirla con Cusano, in una “dotta ignoranza”. E una creazione poetica che sia apparizione e rivelazione del meraviglioso, è per sua stessa natura fiaba: “il fiabesco è il trasparire del sovraterreno, il mirabile riflesso del mondo superiore; tutte le fiabe sono solo segni di quel mondo patrio che è ovunque e in nessun luogo”. Quanto più è poetica l’opera del poeta, tanto più essa è fiabesca: e la fiaba non è che “il canone della poesia”, con la conseguenza che tutto quel che è poetico deve essere fiabesco. E Novalis attribuisce alla poesia lo statuto di fiaba perché quest’ultima implica una visione onirica delle cose che capovolge quella scientifica, la esorcizza, la supera e restituisce al mondo il suo significato originario. “La fiaba è propriamente come un’immagine onirica: senza nesso, un insieme di cose e di accadimenti meravigliosi”, cosicché, in luogo della visione scientifica di un ordine regolato dal principio di causalità (il quale riduce il mondo a macchina il cui solo significato è il prestarsi all’uso umano), la visione fiabesca instaura disordine e anarchia che regnano tra le cose, là dove esse siano legate tra loro da un’associazione poetica intenzionalmente arbitraria. “Non v’è nulla di più contrario allo spirito d’una fiaba che una connessione che abbia rigore di legge”: nelle fiabe regna infatti un’autentica anarchia naturale, un “mondo astratto, mondo di sogno”. Aggiunge Novalis: “il poeta adopera le cose e le parole come tasti e tutta la poesia si fonda su di un’attiva associazione di idee, su di un’autonoma intenzionale produzione di casualità (fortuita, libera associazione)”. Poetici – egli rileva – sono allora l’antro di un mago, il laboratorio di un fisico, una stanza per bambini, un ripostiglio, una dispensa, insomma tutti i luoghi in cui regna il caos, poiché la disposizione casuale degli oggetti recupera il loro autentico significato. Nella fiaba, poi, i due mondi (quello finito e quello infinito) tornano ad apparire intrecciati: “in un’autentica fiaba, tutto deve essere meraviglioso, misterioso, incoerente: l’età dell’anarchia universale, la condizione ex lege, la libertà”. In quanto fiaba, la poesia orienta di nuovo verso il meraviglioso l’uomo moderno che l’ha perso di vista. Il poeta scompagina l’ordinario contesto entro cui le cose sono costrette, rendendole straordinarie e poetiche: ed è allora che esse diventano piacevoli. Riaffiora a questo punto il tema dell’esotico e dell’insolito: grazie al disordine in cui vengono presentate, le cose tornano ad essere occasioni di poesia, la quale è foriera del meraviglioso. Così la missione del poeta romantico si configura come produzione di quell’effetto di piacevole straniamento che da sempre ha suscitato l’attenzione di Novalis, in forza della sua portata poetica: “l’arte di estraniare in maniera piacevole, di rendere un oggetto estraneo e tuttavia noto e accattivante: questa è la poetica romantica”.
MEDIOEVO, NOTTE, VIAGGIO IN NOVALIS
L’Enrico di Ofterdingen risale al 1800 ed è un romanzo naturalmente rimasto incompiuto, secondo la consuetudine romantica: esso presenta una prima parte giunta a compimento e una seconda in forma frammentaria. Si tratta di un romanzo di formazione in cui a formarsi è un poeta che, come meta di un lungo e tortuoso percorso, perviene ad un’esistenza realmente autentica. La formazione ch’egli consegue, stante la prospettiva platonico/cristiana fatta valere da Novalis, è duplice: è, infatti, formazione in terra dell’artista e, insieme, sua trasfigurazione in cielo. Il protagonista dell’opera – Enrico – inizia la propria formazione con l’incontro di uno straniero (a significare l’alterità che fa irruzione nella vita ordinaria) che gli parla del “fiore azzurro”, metafora di ogni metafora. Di fronte a ciò, la reazione di Enrico è di irrequietezza e di presentimento: nascono in lui il desiderio e, a poco a poco, lo stato poetico. Questa nascita raggiunge il culmine nel sogno che Enrico fa del fiore azzurro, il quale cela un viso femminile. Il padre del giovane Enrico ritiene di doverlo mettere in guardia dai sogni, che sono soltanto menzogne: il padre simboleggia l’Illuminismo che, nelle vesti del razionalismo, conduce la sua interminabile battaglia contro ogni forma di sogno. Secondo la definizione hegeliana, la coscienza illuministica è per sua natura desta e vigile, e ciò già a partire da Cartesio. Questi si era premurato di distinguere lo stato di veglia da quello del sonno, sostenendo che v’è conoscenza dove regnano la chiarezza e la distinzione delle idee. Chi ci garantisce che la vita che conduciamo non sia un continuo sognare? A tale domanda, Cartesio risponde additando Dio come garante della certezza della conoscenza. E la lotta cartesiana contro il sogno è raccolta dai suoi successori ed è intesa come battaglia della ragione vigile e desta contro i sogni dei metafisici e dei visionari. Sicché il rigorismo illuministico finisce per esercitare un’egemonia indiscussa sulla vita dell’uomo, liberandolo dai sogni, dai miti, dalle fantasticherie e dalle visioni. In polemica frontale con questa prospettiva, Novalis estrae dal suo cilindro la fiaba e il sogno come dimensioni veritative; e all’affermazione del padre che liquida i sogni come menzogne, Enrico risponde significativamente che il sogno è un dono divino, una “difesa contro la regolarità e la mediocrità della vita”, un’irruzione dello straordinario nella vita di tutti i giorni. Il sogno del fiore azzurro fatto da Enrico si rivela profetico: esso profetizza al giovane l’imminente innamoramento e la nascita della poesia in lui (e tanto nell’amore quanto nella poesia si manifesta la nostalgia della “patria”). Il racconto prosegue ed Enrico giunge ad Augusta, la città della Baviera ricchissima di tradizione medievale: egli si reca in casa del nonno, ove è in corso una festa. Qui incontra un famoso poeta e la sua bella figlia, Matilde. Il tema del viaggio, del Medioevo, della festa come avvenimento inconsueto, sono tutti elementi squisitamente romantici che preparano il terreno per l’imminente incontro di Enrico con l’amore e con la poesia. Si realizza in questo modo una dimensione di amor platonico, cortese e cavalleresco che rende protagonista il poeta. Ben emerge l’identità tra poesia e amore: la poesia non è che l’Uno-Tutto che, in quanto tale, è anche amore. Amare Matilde significa allora amare la poesia e, con essa, Dio. Ella appare anzitutto come Musa ispiratrice di Enrico, giacché suscita in lui l’entusiasmo inventivo proprio del poeta. Il padre di Matilde gli tiene poi una breve quanto profonda conferenza sull’essenza del poeta, la quale non fa che confermare come per Novalis la dimensione del poetico non si risolva solo nell’entusiasmo, ma comprenda anche il momento della criticità: “nulla al poeta è più indispensabile che la penetrazione nella natura d’ogni cosa […]. Entusiasmo senza comprensione è inutile e nocivo, e il poeta potrà fare pochi miracoli se egli stesso si meraviglia del miracolo”, se cioè non instaura una giusta distanza che permetta lo sviluppo della riflessione critica. “Il calore fresco e vivificante di un’anima poetica è esattamente il contrario di un selvaggio ardore di un cuore malaticcio, che è povero e passeggero”: così dicendo, Novalis sta già negando la degenerazione cui il Romanticismo andrà incontro quando si capovolgerà in culto dell’immediatezza rapsodica e frammentaria dell’ispirazione. Freddezza e cautela sono due componenti del poeta, il quale è “puro acciaio”, sensibile e duro al tempo stesso: “la poesia richiede esercizio; l’arte deve aggiungersi al talento”, il che equivale a dire che il poeta deve osservare e arricchire la conoscenza, senza limitarsi alle mere sensazioni che prova. Sicché all’entusiasmo (che è il dono dell’amore provato per Matilde) deve accompagnarsi quella freddezza, quel discernimento e quella riflessione che permettano di organizzare l’ispirazione e l’entusiasmo. Non si può infatti creare alcunché di duraturo con la sola ispirazione. Sull’onda di queste considerazioni, Novalis fa una diffida al ritenersi poeti perché capaci di sensazioni acute: il poeta – egli sostiene – è rivelatore di verità, non di epidermiche sensazioni soggettive e narcisistiche. Egli deve essere sempre anche filosofo, ossia poeta doctus, ché altrimenti resta prigioniero della propria soggettività e riduce la propria arte ad autobiografismo. Il fatto che al poeta inerisca la distanza critica apre la possibilità del con-poetare e del con-filosofare: ma, perché ciò si verifichi, ai due momenti precedentemente individuati (l’entusiasmo e la riflessione critica) deve aggiungersene un terzo, quello dell’amore/morte. L’altro (aspirato e saputo) è ora esperito in un contatto diretto che si produce tramite l’esperienza della morte dell’amata (Matilde nel romanzo, Sofia nella vita di Novalis) e che lascia trasparire la contrapposizione della notte al giorno. Dopo la morte di Matilde, Enrico continua a vivere nel giorno, ma con una costante nostalgia della notte e con la consapevolezza che il giorno non è il vero mondo e che perciò esso mai può appagare il desiderio del poeta. “Si è già fatta sera intorno a me, e presto sarà notte”, scrive Novalis in una lettera: si acuisce in lui il desiderio dell’altro mondo e, correlativi a ciò, il disgusto per questo mondo e il taedium vitae, cosicché “la tomba di Sofia è anche la mia; tutta la mia gioia, i miei progetti sono qui sepolti”. Ciò vuol dire che questo mondo, senza Sofia, appare per quello che realmente è: manchevole, insufficiente, deficitario. A ciò s’accompagna l’esperienza della costante presenza immanente dell’amata defunta, che consolida la convinzione novalisiana dell’intreccio dell’altro mondo con il nostro. L’amore prosegue, ma l’amata lo chiama via da questo mondo e, per ciò, si fa sempre più forte il ricordo dell’altro mondo, con la conseguenza che si muore a quello terreno. È questo, in linea generale, il contenuto degli Inni alla notte. Essi nascono dall’esperienza della morte, la quale palesa la natura platonico/cortese della relazione amorosa, poiché nell’atto in cui l’amata scompare, ecco che l’amore non cessa ma anzi disvela la propria vera natura, scoprendo che la persona amata era solo un tramite per l’amore provato per la patria divina. Nel primo inno (che così si apre: “quale vivente, dotato di sensi, non ama tra tutte le meravigliose parvenze dello spazio che ampiamente lo circonda, la più gioiosa, la luce”) v’è una contrapposizione tra gli individui normali, che apprezzano il sole, e la solitudine del poeta, che si rivolge “alla sacra e ineffabile notte”, la quale “reca balsamo alle ferite del desiderio”, giacché apre in noi occhi infiniti e, per ciò, è annunciatrice di sacri mondi e sede della rivelazione. Già i Neoplatonici asserivano che l’Uno è tenebra (in virtù della sua insondabilità e della sua ineffabilità) ma non per difetto, bensì per sovrabbondanza dell’essere e di una luce che è così forte da apparire come tenebra. Nel secondo inno, la conversione dal giorno alla notte ritorna in forma di disgusto per le attività del giorno e prosegue con l’invocazione del sacro sonno affinché non sia parco di doni con chi si è consacrato alla notte. Il sonno in questione non è quello della gente comune, ma piuttosto quello che veicola messaggi infiniti. Il terzo inno è il resoconto di un sogno: l’esistenza, dopo la morte, dell’amata appare come un vicolo cieco perché chiuso da una collina che nasconde la vista ed opprime, finchè dal cielo non si affaccia un nuovo mondo senza fondo ed abissale. La collina si dissolve in una nuvola e il poeta vi scorge i tratti dell’amata. È qui che si palesa come l’amore era in questo mondo nostalgia per l’altro mondo, presente nelle vesti dell’amata, la quale è – con la sua bellezza – il tramite per cui l’Uno ci chiama a sé liberandoci dai limiti dell’egoità. È questa la dimensione metafisico/religiosa dell’amore: amando una persona, si ama l’altro, cosicché gli amanti assurgono a reciproco veicolo del divino. È però solo con la morte di uno dei due che ciò si palesa radicalmente, come ci insegnano Dante con Beatrice e Petrarca con Laura: morta la donna amata, si scopre che quel che si amava non era quella persona finita e transitoria, e proprio perché essa, post mortem, appare insostituibile, ci si accorge che questo mondo non basta più. Ciò significa che si amava non un che di finito e limitato, ma l’infinito stesso. Tale teoria dell’amore cortese trova la propria espressione più efficace nel quinto dialogo dell’opera De gli eroici furori di Giordano Bruno, ove una delle due interlocutrici riconosce la propria funzione di esca dell’infinito e così si esprime: “or io, se per grazia del cielo ottenni d’esser bella, maggior grazia e favor credo che mi sia gionto; perché qualunque fusse la mia beltade, è stata in qualche maniera principio per far discuoprir quell’unica e divina. Ringrazio gli dei, perché in quel tempo che io fui sì verde, che le amorose fiamme non si posseano accendere nel petto mio, mediante la mia tanto restia quanto semplice ed innocente crudeltade, han preso mezzo per concedere incomparabilmente grazie maggiori a’ miei amanti, che altrimente avessero possute ottenere per quantunque grande mia benignitade”. La tenera età dell’esca divina (Beatrice, Laura, Sofia) è, del resto, segno del rinvio ad altro e della costante tensione dell’eros. Il quarto inno descrive la duplice ed ambigua esistenza di chi, avendo contemplato la vera patria (“dove eterna regna la luce”), torna al mondo comune ma restando fedele all’altro e percependo vieppiù la lontananza del giorno dalla nostra patria e dell’antico “magnifico cielo”. È interessante rilevare come il primo Kierkegaard sarà influenzato sia da Hegel sia dai Romantici: il “cavaliere della fede” di cui egli parla è il religioso che, pur continuando a vivere in questo mondo, in realtà intrattiene una relazione privilegiata con Dio, vivendo la vita normale e ordinaria ma ciò non di meno essendo votato al divino e all’infinito. Nel quinto degli Inni alla notte, il poeta palesa al massimo la propria dimensione critica, facendo un abbozzo di filosofia della storia. Novalis propone una visione generale del mondo, badando non alla soteriologia privata (come aveva fatto finora), ma a quella pubblica. La storia umana, com’egli la concepisce, si articola in tre fasi distinte. Dapprima v’è il mondo antico e della luce: essa, infinitamente diversa da quella dell’Illuminismo, segnala la presenza degli dei e – winckelmannianamente – l’inconsapevole e felice fanciullezza di un’umanità paga di sé e in una primavera perenne. Tuttavia, in ciò divergendo da Winckelmann, Novalis aggiunge l’elemento della precarietà a quest’era: è un’epoca precaria perché insidiata dal tarlo della morte, il cui pensiero – nota Novalis – s’aggira tremendo tra i commensali dei banchetti. Alla morte, neppure gli dei sanno dare una risposta. Essa interrompe la festa: gli antichi hanno provato a rimuoverla con l’idea edulcorante di un dolce sonno, ma solo in parte vi sono riusciti. Il che ha comportato la fine del mondo antico, inficiato da tale menomazione congenita: “irrisolta rimase l’eterna notte, il severo segno d’una potenza lontana”. Dal mondo antico si passa allora a quello moderno, caratterizzato (illuministicamente) dal lavoro e dalla categoria dell’utilità, visti ora da Novalis come fuga dalla morte (giacché, per dirla con Pascal, essi costituiscono una sorta di divertissement). Contro questo mondo, Novalis polemizzerà accesamente nel testo Cristianità o Europa, etichettandolo come mondo in cui “numero e misura incatenano la natura” e spariscono la fede e la fantasia. Ma, nel frattempo, è accaduto qualcosa che può aprire nuovi spiragli: si è verificata, ad opera di Cristo, la vittoria sulla morte, la quale diventa ora una porta che apre sull’infinito. Il nuovo Dio rivelato è allora il Dio della notte, non quello del giorno: alla metafora del sol salutis, Novalis contrappone ora quella del sol noctis, del quale il poeta è annunciatore. Del resto, la bella antichità è – nota Novalis – preceduta dall’assoggettamento dei Titani, ossia di quelle forze gigantesche e minacciose che sono sì legate, ma non eliminate in via definitiva e che possono riesplodere da un momento all’altro. La notte in cui il poeta scende e a cui si vota è anche la notte del sentimento, di contro alla luce abbagliante della ragione. Recuperando il suo antico interesse per l’attività del minatore come immagine della ricerca filosofica, Novalis esprime il ritrovamento della pietra filosofale in un sol termine: VITRIOL (Visita Interiora Terrae Rectificando Invenes Occultum Lapidem). Ciò significa, per dirla con Proclo, che “l’Uno è in noi”, ovvero che l’interiorità è la notte in noi presente. Calandosi nel fondo, si troverà il sol noctis che il minatore, gli elfi e il poeta trovano in loro. Questa è la notte della favola e della poesia, di contro alla superficialità della chiarezza prosastica. L’imprendibilità dell’amata rende possibile il distacco dal mondo, facendolo apparire come limitato e, per ciò stesso, da abbandonare. Il VI inno si intitola Nostalgia della morte e in esso Novalis afferma plotinianamente che “svanito è il desiderio dell’andar lontano, vogliamo tornare a casa del padre”. “In questa temporalità, l’eterna sete resta sempre insoddisfatta”: così dicendo, Novalis sta facendo – come lo chiama egli stesso – un “annichilimento del qui ed ora”, contrapponendo il tempo all’eternità. In questa contrapposizione riecheggiano temi squisitamente neoplatonici, per cui il tempo non è che deficiente imitazione dell’eternità. L’Uno stesso è eterno, in quanto infinita pienezza d’essere cui nulla manca e a cui nulla può essere aggiunto: essendo infinita pienezza d’essere, l’Uno è, per ciò stesso, già sempre e per sempre. E il tempo si trova in rapporto con l’eternità come il finito con l’infinito: per un verso, in forza dell’onninominabilità, il finito rivela l’infinito; ma, per un altro verso, non fa che metterlo in ombra. Similmente, il tempo rincorre l’eternità e ad essa allude, ma al contempo è radicalmente altra cosa rispetto ad essa. In questa maniera, Novalis vede il tempo non già come via all’eternità, bensì come fuga da essa. Se l’eternità è infatti l’eterno presente d’una infinita pienezza d’essere, allora il tempo in cui viviamo manca di presente ed è l’imprendibile attimo fuggente di cui diceva Goethe. Una momentanea sospensione del tempo è data dall’esperienza amorosa e dall’opera d’arte: quando si ama e quando si fruisce di un’opera, ecco che si perde la nozione del tempo, il che segnala come siamo tenuti a trascendere il più possibile la temporalità. Anche per Enrico, come per Novalis, l’esperienza della morte è una tappa decisiva per l’acquisizione della poesia: infatti, dopo la festa interviene un sogno premonitore in cui egli assiste alla morte di Matilde nelle acque azzurre d’un fiume. Egli cerca invano di salvarla, ma, persi i sensi, si risveglia sulla spiaggia di un luogo fantastico: al suo fianco egli ritrova Matilde e, quando domanda dove si trovino, gli è risposto che sono nel paese dei genitori, nella terra paterna. Se in Schlegel v’è una visione laica ed emancipatrice del rapporto amoroso, per cui la donna vale quanto l’uomo, in Novalis prevale invece una concezione religiosa tale per cui a morire è sempre la donna. La seconda parte dell’opera resta incompiuta: dopo la morte di Matilde, Enrico diventa un pellegrino errante, essendosi ormai liberato dal finito. Ciò gli permette di diventare poeta e di guardare al mondo superiore. Il mondo stesso in cui egli vive non è più limitato, ma è riscoperto come segno di quello superiore e per ciò è caro al “cittadino della notte”. Il mondo così poeticizzato diventa esso stesso fiaba: il sogno diventa mondo, e il mondo diventa sogno. Se la prima parte del romanzo descrive la formazione del poeta, la seconda dovrebbe raffigurare la rivelazione della poesia da parte del poeta così costituitosi. E se in Schlegel il romanzo si presenta come eterno divenire, in Novalis esso è fiaba: quel che accomuna le due concezioni è l’incessante polemica anti-illuministica e il netto rifiuto della prosa. Entrambi i poeti convengono nell’identificare la poesia con l’infinito, concependo però quest’ultimo in termini diversi: esso è panteismo dinamico per Schlegel, partecipazione neoplatonica per Novalis. Divenuto viandante, Enrico va errando per il mondo senza una precisa meta mondana, a segnalare che la sua vita è un iter dal finito verso l’infinito. E dunque questo vagabondo è assai simile al viator della tradizione platonico/cristiana e alla sua tradizione della “teologia dei viandanti”. L’esistenza è, in questa prospettiva, un vagabondare con una meta oltremondana, con la conseguenza che scarso spazio è concesso al viaggiare in questo mondo: infatti, sia il monaco sia l’eremita, che di ciò sono emblemi, non viaggiano affatto e il loro stare al mondo è già uno starne fuori. Del resto, se guardiamo al Medioevo, il viaggiatore (tanto il pellegrino quanto il crociato) è sempre in viaggio non verso mete mondane, ma verso la salvezza eterna. Al contrario, il viaggio nel mondo mosso dall’esclusivo interesse per il mondo stesso nasce con la modernità e si sviluppa con lo svilupparsi della modernità stessa. Principalmente quattro sono i modi in cui essa sperimenta il viaggio: 1) come viaggio di conquista, 2) di affari, 3) di scoperta, 4) di istruzione. I primi due tipi segnalano un atteggiamento ormai saldamente mondano e gli altri due sono decisivi per lo sviluppo della modernità e della rilegittimata curiosità per il mondo. Ciò giunge all’apice nel Settecento, con quella grande serie di viaggi motivati da interessi scientifici, botanici, cartografici: grazie ad essi, il mondo è ora reso accessibile e messo a disposizione dell’uomo. Altrettanto decisivo è il viaggio d’istruzione, che serve alla riappropriazione di un io allestito per poter operare efficacemente in questo mondo in vista del proprio vantaggio. Significativamente, Montaigne nei suoi Saggi esalta il viaggio perché, mettendoci a confronto con l’alterità, propizia l’esercizio della ragione critica, vince il conformismo della tradizione e delle opinioni ricevute, risvegliando il pensiero e il relativismo. Il viaggio ci induce a mettere in forse tutte le certezze di cui viviamo. Lo stesso itinerario di Cartesio si configura come un allontanamento dalla selva delle opinioni e della tradizione grazie alla bussola del metodo critico. Viaggiando, si apprende tutto ciò che torna utile per vivere meglio a casa: così Bacone e Locke sostengono che il viaggio completa il gentleman insegnandogli a stare al mondo. In ques’ottica si può capire il significato del Gran Tour che i gentlemen inglesi facevano in Italia ai fini della propria formazione. Tutti questi viaggi segnalano un atteggiamento radicalmente mondano: così la società borghese/illuministica afferma la sua volontà di vivere al meglio nel migliore dei mondi possibili e il viaggio diventa strumento di felicità. Diversissimo (e assai più vicino a quello dei Cristiani) è il viaggio come lo intendono i Romantici: nell’Illuminismo, il viandante quanto il residente sono soddisfatti appieno del mondo finito in cui si trovano; al contrario, il viandante romantico non trova posto in questo mondo e si dà per ciò al vagabondaggio, muovendosi non verso un obiettivo prefisso, ma in fuga da questo mondo, verso il quale esprime disagio, dissenso, protesta. Il vagabondo radicale di cui dice Novalis è sempre in fuga; quello meno radicale (di cui parla Schlegel) rifiuta sì la società borghese e la sua finitezza, ma non questo mondo, che può essere infinitizzato. Nell’Orlando furioso, i vari paladini sono costantemente all’inseguimento di Angelica, la cui bellezza che sempre sfugge alla presa non è che l’eros platonico che distoglie i paladini stessi da ogni altro impegno: sicchè, se letto in chiave romantica, l’intero Orlando furioso non è che la narrazione delle alterne vicende di un’unica esistenza di un unico io nella sua infinitizzazione. Lo stesso si può dire del Don Chisciotte: egli brama d’essere un cavaliere antico e si trova a vagabondare per il mondo ordinario, fatto di sopraffazione, di violenza e di inganni.
MODERNITA’ E BARBARIE: AUSCHWITZ

PERCHE’ OCCUPARSI DI AUSCHWITZ?
Perché, a più di cinquant’anni di distanza, ci occupiamo ancora di Auschwitz? In una celebre lettera del 27/1/1904 indirizzata a Oskar Pollak, scriveva Kafka:
| “ma é bene se la coscienza riceve larghe ferite perché in tal modo diventa più sensibile a ogni morso. Bisognerebbe leggere, credo, soltanto libri che mordono e pungono. Se il libro che leggiamo non ci sveglia con un pugno sul cranio, a che serve leggerlo? Affinché ci renda felici, come scrivi tu? Dio mio, felici saremmo anche se non avessimo libri, e i libri che ci rendono felici potremmo eventualmente scriverli noi. Ma abbiamo bisogno di libri che agiscano su di noi come una disgrazia che ci fa molto male, come la morte di uno che ci era più caro di noi stessi, come se fossimo respinti nei boschi, via da tutti gli uomini, come un suicidio, un libro dev’essere la scure per il mare gelato dentro di noi”. |
Ed è proprio per questa ragione – ossia per far ricevere grandi ferite alla nostra coscienza – che, nonostante il tempo trascorso, dobbiamo ancora occuparci di Auschwitz, ossia di un tema che, affrontato, non può non ferire come un’ascia la nostra coscienza, mordendola e facendola sanguinare dal profondo. Molti autori hanno scritto nel Novecento opere intitolate La condizione del nostro tempo: ma oggi quale è, realmente, tale condizione? Che cos’è che meglio caratterizza l’epoca che stiamo vivendo? Si può certamente rispondere che il tratto caratterizzante dei giorni nostri è la freddezza, il torpore, il ghiaccio: assistiamo al proliferare di una curiosità perversa e morbosa, che ci porta a voler sapere tutto di tutti (donde l’interminabile stuolo di programmi televisivi che mettono a nudo la vita di tutti), e, al contempo, viviamo in un’indifferenza paralizzante verso ogni cosa, quasi come se quell’iperinformazione non desiderata e a cui non ci possiamo sottrarre (e che ci porta a sapere che cosa accade tanto in Uganda quanto nella casa dei personaggi di successo) venisse enigmaticamente compensata da un’ignoranza ambita e anelita. Vige insomma un insopportabile stato di distrazione o, per dirla con Pascal, di divertissement, tale per cui chiunque cerchi di penetrare quella insostenibile cortina di indifferenza viene zittito come guastafeste, al pari del vecchio marinaio della famosa ballata di Coleridge, che uccide senza ragione un albatro ed è costretto a scontare per questo gesto la maledizione che si abbatte sulla sua nave e, alla fine delle disavventure, morti tutti i suoi compagni, è condannato a spostarsi incessantemente di luogo in luogo per insegnare col suo esempio l’amore e il rispetto per tutte le creature di Dio. Come il marinaio, che narra a chi si dirige verso la festa il tragico episodio della sua esistenza, la tragica perdita di tutti i suoi compagni, rendendo tutti più tristi e più saggi, così fa chiunque parli di cose sgradite a chi è immerso nell’indifferenza. Al giorno d’oggi si verifica del resto un inquietante avvenimento: scansiamo non solo i guastafeste che pretendono di ferirci la coscienza raccontandoci le loro esperienze, ma anche coloro che a noi si avvicinano per farci del bene e per salvarci, come capita allorché il testimone di Geova suona il campanello delle nostre porte e noi, infastiditi, non gli apriamo o lo invitiamo a recarsi altrove. Rompere il ghiaccio dell’indifferenza non è cosa da poco: un’immagine che può ben esprimere la situazione in cui versiamo è quella del Titanic che sta per affondare e su cui, ciononostante, tutti continuano a danzare, indifferenti a quanto stia per accadere. Fino agli anni ’70 del Novecento aleggiava la diffusa idea che, dietro alla “verità di comodo”, se ne nasconde un’altra (realmente vera), abilmente mascherata con mille vernici: sicché, se a quei tempi il problema che ci si poneva era “come faccio a sapere?”, oggi, in un’età in cui siamo sommersi dalle informazioni (a cui non possiamo in alcun modo sfuggire), il problema da porsi è un altro: “che farne di ciò che sappiamo?”. Ed è a tal proposito, dinanzi a questo cumulo di sapere indistinto, che nascono il distacco, il cinismo, l’indifferenza, il lanciare lo sguardo sul mondo senza lasciarsi minimamente coinvolgere: chi guarda il mondo senza farsi toccare da esso è come un Dio, diceva Nietzsche riprendendo un topoV stoico e, in tal modo, valorizzando appieno quell’indifferenza contro la quale i Romantici avevano speso le loro energie. Ma è possibile, al giorno d’oggi, rompere quel refrattario strato di ghiaccio che ci impedisce di sentire per davvero le cose e di farci coinvolgere da esse? Oggi, nell’età in cui le grandi religioni hanno rivelato la loro impotenza consustanziale, i grandi sogni comunisti si sono risolti in terribili incubi, è ancora possibile una saggezza, una sensibilità? Il sociologo tedesco Beck sostiene, a tal proposito, che si devono “risolvere per via biografica le difficoltà sistemiche“: con ciò egli intende dire che, dopo il fallimento delle grandi organizzazioni (delle grandi chiese e dei grandi partiti), grava sui singoli individui la risoluzione di quei problemi rimasti insoluti. Per gli antichi Stoici, per gli Scettici, per Nietzsche il distacco dal mondo e dalle sue vicissitudini babeliche è una virtù dal cui adempimento dipende la felicità: ma, al giorno d’oggi, possiamo ancora essere felici perché siamo indifferenti? Non sentiamo, piuttosto, il dovere di perforare il muro dell’indifferenza? Adorno dice che Nietzsche fu un vero filosofo solamente in un’occasione: quando, in preda alla follia, abbracciò a Torino il cavallo frustato: ciò a significare che – secondo Adorno – saremo davvero umani quando abbracceremo chi soffre, spezzando il gelo del distacco. Ma – domandiamoci – che cosa accade a chi si impegna a vincere l’indifferenza? Riprendendo la bella immagine della ballata di Coleridge, chi compisse un tale salto, si troverebbe immediatamente nella duplice condizione di vecchio marinaio e di invitato alla festa, trovandosi così ad oscillare tra una situazione in cui cerca di sensibilizzare gli altri su ciò che a lui pare intollerabile (e ciò può essere tanto la fame nel mondo quanto la mancanza di parcheggi sotto casa) e una situazione in cui viene ad essere sensibilizzato da altri “vecchi marinai” su altrettanti problemi che probabilmente egli non avverte come tali. Del resto, perché mai occuparsi del problema della fame nel mondo anziché di quello del cancro o dei parcheggi o dei treni perennemente in ritardo? Vige, in questo senso, una forma di “idiotismo del bene”, per cui ciascuno parla una lingua che è comprensibile a lui soltanto: manca, in altri termini, una koinh con cui capirsi, con cui decidere che cosa realmente sia un problema. La risposta forse più coerente a questo interrogativo sta nel fatto che ciascuno di noi, in fondo, crede ancora in qualcosa a cui gli altri restano indifferenti; Gramsci condanna aspramente chi vive da indifferente, senza lasciarsi coinvolgere:
|
“Odio gli indifferenti. L’indifferenza è il peso morto della storia. E’ la palla di piombo per il novato, è la materia inerte in cui affogano spesso gli entusiasmi più splendidi, è palude che recinge la vecchia città e la difende meglio delle mura più salde, meglio dei petti dei suoi guerrieri, perché inghiottisce nei suoi gorghi limosi gli assalitori, e li decima e li scora e qualche volta la fa desistere dall’impresa eroica”. |
INTRODUZIONE
Siamo dell’idea che non si possa considerare Auschwitz semplicemente come un evento catastrofico tra i tanti che hanno punteggiato il corso della storia, uno tra i tanti che, dopo essersi drammaticamente verificati, sono stati – rapidamente o meno – digeriti: ciò che intendiamo sostenere è l’unicità di Auschwitz, concependolo come un fatto assolutamente unico in duemila anni di storia. Ma dobbiamo allora domandarci che cos’è che giustifica tale unicità e, per rispondere a tale quesito, ci rivolgeremo ai teologi, agli scrittori, agli storici e, da ultimo, ai filosofi. E’ evidente che per i teologi la presenza di un male così radicale come Auschwitz è assai ingombrante e imbarazzante; le domande che immediatamente, una dopo l’altra, si sollevano sono: dov’era Dio quando è accaduto quel male? Esso si è verificato come punizione inflitta da Dio stesso? O, piuttosto, quel male si giustifica all’interno del bene complessivo che impera nel mondo? Ma la teologia non è il solo ambito investito da un numero incredibile di domande arrovellanti: anzi, si può facilmente notare come, da qualsiasi angolatura (teologica, storica, filosofica) si guardi ad Auschwitz, subito nasca una serie interminabile di quesiti. Ad esempio, perché mai un popolo colto e raffinato quale era quello tedesco negli anni ’30 del Novecento (un popolo che, in quanto a prestazioni culturali, non temeva rivali in tutto il mondo), decide di sterminare una minoranza ben integrata quale erano gli ebrei? Perché pressoché nessuno seppe opporsi con fermezza? Non appena solleviamo tali interrogativi, subito ci troviamo in quella che Wittgenstein era la condizione propria del filosofo, il quale non si raccapezza dinanzi al problema, come la mosca che, chiusa in una bottiglia, continua a sbattere contro le pareti di vetro senza trovare quella via di uscita che sta alla filosofia indicare. Di fronte ad un evento come Auschwitz non si può essere soltanto “spettatori”, privi di emozioni e di coinvolgimento, tant’è che chi cerca di spiegarlo come mero effetto determinato da una sequenza causale è subito etichettato come empio; in questa prospettiva, si può parlare di Auschwitz come di un “tabù laico”. Del resto Giorgio Agamben, nel suo scritto su Quel che resta di Auschwitz, nota come gli stessi superstiti dei campi di concentramento non sono che “falsi testimoni”, giacché “veri” sono quelli morti in loco. Ciò non toglie che vi sia anche stato chi ha tentato di trattare Auschwitz come “cosa normale”, come evento fra i tanti: così Martin Walser, in maniera fortemente provocatoria, asserisce che “è ora di finirla di usare Auschwitz come una clava morale contro i Tedeschi“, a sottolineare quanto sia assurdo, dal suo punto di vista, eternizzare la loro colpa; e Walser non si ferma qui: egli si spinge fino a sostenere che le altre nazioni strumentalizzerebbero Auscwitz per fini politici diretti contro la Germania, quasi come se, ogni qual volta lo stato tedesco osasse prendere qualche iniziativa, subito venisse ad esso rinfacciata la colpa. Così ad esempio pare essere accaduto quando, nel ’98, si parlava a gran voce di Euro come moneta valida per tutta l’Europa e la Germania, già di per sé fortissima col Marco, non poteva che non avere interessi alla questione, ma ha dovuto piegarsi sotto le minacce della “clava morale” di Auschwitz. Su posizioni ben più radicali di quelle di cui è alfiere Walser sono i “negazionisti” come Robert Faurisson (ossia coloro che sostengono che la shoà sia un’invenzione degli ebrei) e anche i “revisionisti”, cioè coloro che – come Ernst Nolte – negano l’unicità della shoà, mettendo in luce come non meno terribile sia stato lo stalinismo e arrivando a sottolineare come il nazismo sia esistito semplicemente come reazione al comunismo dilagante (come a dire: se il comunismo non ci fosse mai stato, non ci sarebbe mai stato neppure il nazismo). Foriero di posizioni altrettanto “forti” è Norman Finkelstein, autore di un testo significativamente intitolato L’industria dell’olocausto: qui egli nota (in veste di ebreo coi genitori scampati per miracolo ad Auschwitz) che per l’intero corso della “Guerra fredda” di shoà non si parla mai, fino a quando – nel ’67 -, all’esplodere del conflitto di Israele, la shoà diventa un eccellente strumento a vantaggio di Israele e degli USA: creando una vera e propria “industria dell’olocausto”, Israele entrerebbe nella sala dei bottoni a Washington; sicchè la shoà non è se non una colossale menzogna finalizzata a minimizzare l’altrui sofferenza e a ingigantire quella ebraica. Gli ebrei – prosegue Finkelstein – desiderano ottenere denaro e potere, e, per far ciò, gonfiano clamorosamente i numeri dei deportati nei lager per poter così rimpossessarsi dei loro presunti beni confiscati dai nazisti. Il problema sollevato da Walser ruotava intorno alla domanda: “fino a quando graverà sui Tedeschi la colpa?”; la domanda che invece agita l’indagine di Finkelstein è di segno opposto: “quanto a lungo potrà durare l’impunità di Israele?”. Se in Germania la questione di Auscwitz è affrontata da uno scrittore come Walser e in America da un ebreo fortemente critico come Finkelstein, in Italia è presa in esame in maniera pagliaccesca da Roberto Benigni e dal suo film La vita è bella, vincitore del premio Oscar. Per la prima volta nella storia, con Benigni Auschwitz è presentato come luogo di cui ridere, come un luogo di divertimento per bambini (che, nella realtà, erano spesso uccisi sui treni dagli stessi genitori affinché non vivessero le atrocità dei lager). Cercando di rendere tollerabile l’intollerabile, egli infrange il “tabù laico”: forse se Adorno e Horkheimer avessero potuto vedere La vita è bella l’avrebbero qualificata come grandioso prodotto dell’industria culturale.
L’INTERPRETAZIONE DEGLI STORICI
Per capire l’unicità di Auschwitz, ci rivolgeremo ora direttamente agli storici. Nella misura in cui parlo di “unicità”, mi riferisco evidentemente ad una scala di misura tale che mi permetta di dire che quell’evento è unico rispetto agli altri: ma, nel caso di Auschwitz, in che cosa consiste siffatta scala? Nei morti? Se così fosse, ne conseguirebbe che Auschwitz è un evento unico perché, tra tutte le catastrofi, è quella che ha causato il maggior numero di morti: eppure, ragionando in questi termini, i conti non tornerebbero, poiché è l’AIDS – e non la shoà – a detenere tale triste primato. Dovremo allora riferirci alla qualità dei morti? Ma, allora, si dovrà riconoscere che esistono morti che pesano più di altri? I cadaveri ebrei “valgono” di più rispetto a quelli dei Gulag o di Hiroshima? Tanto più che, all’interno dei lager, non vi erano solo gli ebrei, ma anche i comunisti, i pazzi, gli handicappati, gli omosessuali, i prigionieri. Come mai, allora, tutti parlano dei caduti ad Auschwitz e in pochi ricordano quelli della città di Dresda, distrutta dagli anglo-americani per pura vendetta, o quelli di Hiroshima o del Vietnam? Una prima risposta, che però non soddisfa pienamente, è che a scrivere la storia sono i vincitori e non i vinti. Se, come nota Michel Serres, il potere non è che un modo di dare la morte ai sudditi, allora Hiroshima – e non Auschwitz – segna il vero punto di rottura con il passato, in quanto per la prima volta nella storia la morte di massa è data con il semplice gesto con cui si preme un pulsante che sgancia una bomba; quanto dice Serres pare del resto avvalorato dal fatto che, per tutta la “Guerra fredda”, la grande minaccia è quella della bomba atomica e non quella dei campi di sterminio. La drammatica vicenda di Hiroshima ci insegna poi che non solo le dittature (siano esse di stampo comunista o di stampo fascista) fanno massacri: anche la democrazia può vantare tale macabro privilegio. Ma c’è anche chi sostiene posizioni diverse da quelle di Serres: nel 1999 Fennell scrive un’opera dal titolo La condizione postoccidentale, in cui sostiene che con Auschwitz siamo entrati nel postoccidentale; l’epoca occidentale – dai Greci a Hiroshima – è segnata dal tabù di non uccidere gli innocenti, ma con Auschwitz esso viene violato, cosicché – nota Fennell – dopo Auschwitz si impone l’imperativo di non architettare mai più campi di sterminio (il che però legittima pienamente i bombardamenti). Un’altra teoria che ha goduto e gode tuttora di una certa popolarità presso gli storici è quella dei “totalitarismi gemelli”, stando alla quale non vi sarebbe differenza alcuna tra il nazismo e il comunismo, totalitarismi gemelli in quanto parimenti portatori di disgrazie e di morte. Già Primo Levi, però, si opponeva con fermezza a questa teoria, mettendo in luce come un nazismo senza i lager sia inconcepibile, mentre un comunismo senza i gulag è possibile. Come del resto nota con acutezza Norberto Bobbio, i fini stessi per cui comunismo e nazismo sono sorti sono diversissimi: nato per eliminare quell’ingiustizia sociale per cui v’è chi ha tutto e chi invece muore di fame, il comunismo mira a raggiungere la felicità dell’umanità; viceversa, l’obiettivo che fin dalla nascita il nazismo si pone è la distruzione del diverso, l’annientamento dell’umanità allo scopo di far vivere solamente chi è degno di tale privilegio. Sul piano della fisica dei poteri, poi, pare evidente che il solo fine dei lager fosse quello di procurare morte: ciò in realtà non è del tutto vero, giacché nei lager si utilizzavano i detenuti come manodopera coatta per produrre manufatti, quasi come se ci trovassimo dinanzi a delle macchine capitalistiche con cui sfruttare il lavoro dei soggetti umani fino alla loro morte. Ben diversa è la situazione per quel che concerne i gulag, dove la morte dei reclusi non era l’obiettivo primario: il vero scopo che permeava tali terrificanti luoghi di sofferenza era il lavoro disumano (come quando si trattava di costruire una ferrovia in pochi giorni) e, accanto ad esso, la rieducazione dei “nemici di classe”. La storia del genere umano ha conosciuto fin dalla sua nascita i massacri di Stato: tali sono stati, ad esempio, quelli compiuti con tanta efferatezza dai Romani o quelli prodotti con un impareggiabile spirito di intolleranza dai Crociati; eppure v’è qualcosa che distingue nettamente Auschwitz da ogni altro massacro realizzatosi nella storia, a partire dai Romani per giungere fino ai gulag: gli storici paiono concordi nel rispondere che la vera unicità della shoà risieda nel fatto che, per la prima volta nella storia, lo sterminio su vasta scala di un popolo è avvenuto non già in vista del conseguimento di qualche obiettivo (come la conquista di determinati territori per i Romani o la rieducazione dei nemici di classe per i Sovietici), bensì è stato fine a se stesso. Detto in altre parole, Auschwitz non era il mezzo per conseguire un dato fine, ma era esso stesso il fine da aggiungere e in ciò sta la sua assoluta unicità. “Non serviva a nulla”, dice Hannah Arendt, rilevando in ciò il carattere profondamente “antiutilitaristico” della shoà. Ad Auschwitz si decide chi deve vivere e chi invece è condannato a morire: la progettualità che si cela dietro a questo terribile evento è l’utopica creazione di un mondo migliore, cosicché – benché a tutta prima possa parere assurdo – i nazisti agivano, in cuor loro, a fin di bene, al pari di quei Crociati che, massacrando gli infedeli, ritenevano di agire in nome di Dio; da ciò si può evincere come il male indossi sempre la maschera del bene. Quella che si è verificata ad Auschwitz è – per dirla con l’efficace immagine che Zygmunt Bauman usa in Modernità e Olocausto – la fantasia del giardiniere, che progetta un giardino meraviglioso e che, per realizzarlo, si sbarazza delle erbacce che qua e là lo infestano e che sono di impaccio.
FILOSOFIA E TEOLOGIA DI FRONTE AL MALE
Come si è posta la filosofia dinanzi alla shoà e, in generale, di fronte al male? E’ significativo il fatto che Nicola Abbagnano, nel suo Dizionario di filosofia, inserisca la voce “Auschwitz” e la definisca come “apice della sofferenza e della barbarie“: assistiamo in questo caso ad un evento che si trasforma in un lemma del dizionario, con una sineddoche (pars pro toto) in forza della quale Auschwitz assurge a simbolo stesso del male. Ancora una volta, tuttavia, dobbiamo chiederci perché proprio Auschwitz e non un’altra delle tante tragedie che hanno investito l’umanità: e, ponendoci tale domanda, ci spostiamo dalla sfera dei fatti a quella delle interpretazioni. Il fatto che Auschwitz venga universalmente concepito come quintessenza del male è già una spia che segnala la presenza di un’ermeneutica del male. Infatti, si è sempre riusciti, in qualche maniera, a render conto del male e a darne un’interpretazione (ermeneutica del male), ma ciò con Auschwitz non è più possibile, il modello implode su se stesso, cosicché è necessario rivedere gli strumenti concettuali con cui siamo stati abituati ad operare. “Lo stupore perché le cose che viviamo sono ancora possibili non è filosofico“, dice Walter Benjamin, a sottolineare che il modo in cui abbiamo finora concepito la storia non è affatto corretto, e Auschwitz ne è la prova più lampante. Dobbiamo però tener presente che, accanto a quelle della storia, esistono anche le catastrofi della natura, come ad esempio quel terribile terremoto che si verificò a Lisbona a metà del XVIII secolo e su cui Voltaire spese tanta energia filosofica. Scrive a tal proposito Adorno: “il terremoto di Lisbona bastò a guarire Voltaire dalla teodicea“. L’inquietante domanda che il filosofo come il teologo non possono non porsi è la seguente: dov’era Dio mentre il terremoto di Lisbona uccise miseramente i fedeli che Lo pregavano? La catastrofe di Lisbona simboleggia i disastri che la natura compie ai danni dell’uomo: ma, secondo Adorno, si tratta di una catastrofe di minima entità se accostata ad Auschwitz, che “prepara l’inferno reale” sulla terra. Quel che asseriva Leibniz nella Teodicea, ossia che il nostro sarebbe il migliore fra tutti gli altri infiniti mondi possibili, è oggetto di una feroce derisione da parte di Voltaire, il cui Candido non è se non un’indiavolata confutazione volta a dimostrare come in realtà il nostro sia il peggiore fra i mondi: la figura di Pangloss incarna il leibniziano integralista che giustifica ogni cosa, anche i mali più gratuiti, con il principio di ragion sufficiente. “Lisbona è affondata e a Parigi si balla“, nota con pungente sarcasmo il philosophe Voltaire: col suo Candido, per la prima volta nella storia, si inceppa il meccanismo leibniziano della teodicea e si affaccia la prospettiva che a compiere disastri irreparabili non sia solo la natura, ma anche l’uomo: la conclusione cui egli addiviene è che “le guerre uccidono più dei terremoti“. Sarebbe però erroneo credere che il problema del male acquisisca dignità filosofica solo a partire da Leibniz: esso è, anzi, un tema che ha sempre ossessionato la cultura occidentale, la quale ha di volta in volta cercato di liquidarlo attraverso spiegazioni filosofiche architettate a regola d’arte. Sotto questo profilo, la religione cristiana ha fornito al problema del male risposte fortissime, tanto da rimanere valide, per quel che riguarda il male prodotto dalla natura, fino al terremoto di Lisbona, e, per quel che concerne il male compiuto dall’uomo, fino ad Auschwitz. I due grandi modelli schierati dai cristiani sono quello della nemesi divina (incentrato sull’idea che il male è causato come vendetta da un Dio che punisce l’uomo per il male che ha compiuto) e quello della teodicea (secondo cui il male, anche il più gratuito, ha un senso compiuto se inserito nell’economia del tutto: il tutto è bene, e il male perde la sua valenza di male se inserito in tale contesto). L’idea comune a questi due modelli è che vi siano bilancio e compensazione tali per cui è garantito ab aeterno che alla fine il budget sarà in pareggio: in altri termini, sia per il primo sia per il secondo dei modelli la cassa della felicità non resta mai vuota. E lo stesso Giudizio universale, pilastro della fede cristiana, altro non è se non un’esemplificazione di ciò: alla fine dei tempi i malvagi saranno castigati e i buoni godranno di premi eterni. Il problema che comunque tende a rimanere insoluto presso il mondo cristiano è quello del libero arbitrio: di ciò era perfettamente consapevole Karl Barth, che ha a tal proposito parlato di questo problema come della “croce a cui il cristianesimo resterà filosoficamente inchiodato“. Il male che l’uomo compie e che – secondo il modello della nemesi – chiama altro male o – secondo il modello della teodicea – ha senso nell’economia del tutto, è compiuto con un libero atto di scelta o, piuttosto, è qualcosa di necessitato e dunque di non liberamente compiuto? Nel caso della nemesi, pare risaltare il libero arbitrio, giacchè Dio punisce l’uomo per il male che questi ha deliberatamente compiuto: stando la questione in questi termini, per i sostenitori di questo modello la shoà non è che la giusta pena inflitta da Dio agli ebrei per delle colpe da loro commesse. Diverso è invece il caso della teodicea, dove il male, più che essere commesso, è patito supinamente, quasi come se si fosse passivi ricettacoli del male, bersagli su cui sfogarsi a piacimento: e dinanzi a questo male patito Dio interverrebbe a correggere siffatta insensatezza innestando il bene. Resta comunque vero che, in entrambi i modelli, il male ha un senso compiuto: nel caso della nemesi, lo si subisce perché lo si è meritato; nel caso della teodicea, chi lo subisce avrà un indennizzo da parte di Dio stesso. L’idea di fondo che pervade i due modelli è che il male sia redimibile. La stessa filosofia della storia di Voltaire, così nemico del modello leibniziano, presenta evidenti, in chiave secolarizzata, i pilastri dell’ermeneutica del male di radice religiosa: se da Agostino a Bossuet si parla di “teologia della storia” come di un tentativo di decifrare il senso della storia (che senso ha ciò che accade? In che direzione tende?) con chiavi interpretative teologiche (la tipica risposta provvidenzialistica: il senso della storia risiede nella Provvidenza divina), con Voltaire il modello teologico e provvidenzialistico crolla su se stesso e cede il passo alla nuova idea secondo la quale la nostra storia la scriviamo noi. Si attua in senso pieno con Voltaire la secolarizzazione, ovvero il passaggio dal cielo alla terra: per dirla con Feuerbach, accade che l’uomo si riprenda in cielo ciò che gli spetta (e che si trovava in cielo perché egli stesso colà l’ha posto); per gli uomini “religiosi” ciò è un vero e proprio attacco sacrilego condotto contro il Cielo e da cui derivano, quasi come se si fosse aperto il vaso di Pandora, ogni genere di male (il nichilismo, la morte di Dio, l’arroganza, ecc). Ad avviso di costoro, la pretesa di riprendersi dal cielo la vita perfetta per traghettarla sulla terra non porta che incubi in scongiurabili, quali i gulag e i lager, tutti nati in forza dell’arroganza dell’uomo che si è sostituito a Dio. La fondazione della filosofia della storia a partire da Voltaire poggia su una dicotomia fondamentale: da un lato, v’è il mondo della natura, che, nella sua datiti, non può mai essere del tutto imbrigliato e tenuto sotto controllo; dall’altro, v’è il mondo della storia, che è la dimensione peculiare del nostro essere (tutto ciò che accade, accade nel tempo) e contiene il senso delle nostre azioni: come notava Vico, i veri responsabili della storia siamo noi (verum ipsum factum). Certamente esistono culture che non operano tale distinzione tra storia e natura (ad esempio, per i Giapponesi bomba atomica e maremoto sono la stessa cosa; sono sventure che accadono e, di fronte alle quali, non si può che restare impassibili): dal canto loro, gli antichi Greci ritenevano che occuparsi filosoficamente della storia fosse una follia, giacché la filosofia, per sua natura, si occupa di ciò che è eterno e non di ciò che è transeunte ed effimero come le nostre pragmata, radicate nel particolare e non nell’universale. Il senso profondo della natura – possiamo dire – sta nel non avere un senso: a meno che qualcuno non ci spieghi in maniera realmente persuasiva quali siano il fine e il senso di un fiore. Così Max Weber rilevava che nella catena dei fatti di natura tutto pare avere un senso compiuto (per via della pioggia cresce il raccolto, grazie al quale l’uomo si nutre, ecc), ma, non appena sganciamo un singolo anello dalla catena, ha ancora un senso? La pioggia in quanto tale o il fiore hanno un senso? Nelle vicende umane, poi, regnano il caso, l’insensatezza e il disordine: ciò che tutt’al più della storia poteva attirare i filosofi era una “dinamica della storia” o quella che Vico chiamava “eterogenesi dei fini” (così compendiabile: la risultante delle singole azioni da ciascuno compiute – ognuna delle quali è dotata di senso – produce un senso diverso da quello originariamente intenzionato). Ciò che pare ancor più interessante è che i filosofi non si limitino a prendere atto del caotico e spaesante guazzabuglio degli eventi storici, ma cerchino anche di venirne a capo: ci prova Adam Smith con la “mano invisibile”, ci prova Hegel con “l’astuzia della ragione”. Ciò che i filosofi si ingegnano a fare è di dar conto dell’eterogenesi dei fini trovando un modo in cui la storia funzioni. Sicchè essi distinguono tra un disciplinato e regolare mondo della natura, procedente per leggi e retto da Dio, e uno caoticamente insensato prodotto dagli uomini stessi: tale è il mondo della storia. Il primo mondo direttamente in mano a Dio ed è dotato di senso compiuto; di esso l’uomo non può né deve curarsi (al massimo può sfruttarlo, come dice Bacone). L’altro mondo, quello della storia, è governato dall’uomo e, in virtù di ciò, è il regno del caos più totale: e, a ben pensarci, l’intero sforzo di Marx può essere ricondotto al suo tentativo di rendere coscienti gli uomini di ciò che fanno, riprendendo il motto vangelico “non lo sanno, ma lo fanno” (in particolare, Marx si propone di renderli coscienti affinché non tornino ad essere servi del capitalismo, che domina fino a che lo si considera come natura e non come prodotto storico). La problematica alla quale la filosofia della storia è chiamata a rispondere è allora la seguente: come si può costruire una filosofia della storia, se la filosofia vuol essere ordine e precisione e, dal canto suo, la storia è un magmatico groviglio di accadimenti caotici? Il problema, a questo punto, diventa un altro: come espungere il caso dalla trama delle vicende umane?
ROUSSEAU, KANT, HEGEL
Stiamo affrontando il problema della shoà come “anomalia paradigmatica”: come è noto, Kuhn scrive un’opera – destinata a godere di grande fortuna – dal titolo La struttura delle rivoluzioni scientifiche, in cui dice che le singole scoperte che di volta in volta sono fatte non sono atti che si succedono puntualmente, ma, piuttosto, costituiscono un quadro interpretativo che viene poi rimpiazzato da un altro maggiormente euristico. Ora, con Auschwitz pare che il bagaglio concettuale con cui storicamente si è interpretato il male imploda su stesso e si configuri come totalmente inadeguato, come se, con una rivoluzione, cambiasse il paradigma interpretativo: la macchina ermeneutica si inceppa e, con essa, saltano tutte le modalità con cui la nostra cultura si è confrontata con il male. Fino ad Auschwitz i filosofi si erano affaticati per eliminare il caso dalla storia, consapevoli di come esso costituisse un rompicapo enigmatico oltre che un insormontabile ostacolo alla costruzione di una filosofia della storia. Così per Rousseau il caso è uno “scandalo sociale”: a suo dire, l’autentico peccato originale dell’uomo sta nell’essere entrato in società abbandonando il primitivo e innocente stato di natura, ove regnava il sentimento e non era ancora prevalsa l’istanza razionale. In una società funzionante con le regole dell’ingiustizia (e non della natura), in forza delle quali vi è chi ha tutto e chi non dispone di nulla, tali regole vengono a coincidere col caso: nascere ricchi anziché poveri, in America anziché in Uganda è un qualcosa di meramente casuale, che ben può essere inquadrato con l’etichetta esistenzialista della “gettatezza”: con un’espressione alquanto efficace, Heidegger sostiene che “non siamo padroni delle nostre origini“. Non è un caso che, sui presupposti fissati da Rousseau, prenda il via l’indagine filosofica di Marx, il cui ambizioso obiettivo si risolve nell’annullamento dell’ingiustizia e, dunque, del caso. Se per Rousseau il caso è uno scandalo sociale, esso si configura invece agli occhi di Kant come “scandalo antropologico”: nella sua Idea di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico il male è riconosciuto e addomesticato mediante una teodicea di sapore leibniziano tale per cui, alla fine, esso finisce per essere inteso come involontario fattore di progresso. Gli uomini sono esseri anfibi tra il divino e l’animale, proprio perché dotati di ragione ma, al contempo, equipaggiati di impulsi animaleschi (non sono né “santi” né “api o castori“, dice Kant); situati in questa condizione mediana, essi vengono colti da un profondo senso di smarrimento allorché scorgono nel mondo “infantile malvagità” e “infantile stoltezza“: al filosofo, pertanto, non resta aperta altra via all’infuori del cercare di scoprire se, nel contraddittorio flusso delle azioni umane, v’è un progetto della natura, quasi come se esistesse un più alto livello tale da conferire un senso compiuto laddove, a tutta prima, non ve n’è uno. Inutile dire che Kant è alla ricerca di questo livello perché non può accettare che possa dominare il “caso sconfortante“. Da qui nasce la sua celebre dottrina della “insocievole socievolezza“, secondo la quale il male non è che concime finalizzato al proliferare del bene (è in certo senso una ripresa della tematica di Mandeville dei vizi privati che diventano pubbliche virtù). Tuttavia, per poter vedere le cose di questo mondo in maniera tale che essi risultino dotate di un senso devo situarmi alla fine della storia, giacchè è solo a giochi fatti che si potrà dire se anche il male era funzionale al trionfo del bene: in questa prospettiva, pare vera la bella immagine di Hegel della nottola di Minerva che spicca il suo volo sul fare della sera. Sicché – nota Kant – se si riesce a posteriori a ravvisare un senso nella storia, si può avere una “visione confortante dell’avvenire“, di contro allo sconforto del presente. Anche in Kant, non meno che in Voltaire, si trovano in forma secolarizzata quei pilastri che abbiamo visto esser tipici della tradizione cristiana: ciò non toglie, tuttavia, che per Kant sussista quello scandalo antropologico per cui l’uomo, creato da Dio a Sua immagine e somiglianza, è a tal punto imperfetto che Kant arriva ad asserire che “da un legno storto come l’uomo non si creerà mai nulla di buono“. Anche per Kant resta vera la concezione dicotomica per cui, accanto ad una natura procedente in maniera regolare, vi è una storia – agita dagli uomini – nella quale regna il caos più totale: di fronte a questo spaesamento, si deve per Kant assumere un punto di vista particolare con cui leggere la storia in modo tale da poterle conferire un senso; per far ciò – egli nota – si deve necessariamente intendere il male alla stregua di un imprevisto occasionale ma indispensabile per il progresso del bene (è il modello leibniziano della teodicea che ritorna). Più complesso è, forse, il caso di Hegel, il quale di fatto non ha praticamente mai scritto nulla di filosofia della storia, benché sull’argomento abbia tenuto ben cinque corsi (poi pubblicati dai suoi allievi). Anche il suo pensiero è costantemente percorso dall’esigenza – quasi un’ossessione – di espungere il caso dalla storia: laddove gli occhi umani registrano il caso, quelli più fini del filosofo scorgono coscienza e libertà. A differenza degli storici, i cui interessi storici orbitano esclusivamente intorno al presente (giacché essi leggono la storia solo in funzione di esso), il filosofo della storia ha obiettivi di altro genere: egli “non ha altro intento se non l’eliminazione dell’accidentale“. Ciò in virtù del fatto che: a) egli “mira a farsi una ragione del male nel mondo” e b) “assicura che il male non riuscirà ad imporsi alla fine“. Ma, prima di descrivere la realtà storica quale appare all’occhiuta ragione del filosofo della storia, Hegel tratteggia lo scenario che si presenta agli occhi umani, un “panorama di peccato e di dolore“, come un “banco del macellaio” su cui, prima o poi, passano tanto i grandi imperi quanto le eccelse personalità individuali: che senso può avere che tutti – chi prima e chi dopo – vengano a cadere miseramente? Dalla constatazione di questa triste sorte a tutti riservata, nascono una profonda tristezza e un intenso senso di sconforto morale. Ma – si domanda Hegel – esiste un antidoto, un modo con cui porsi al riparo? Una prima soluzione (Hegel la scarta subito dopo averla presentata) è quella di Goethe, il quale, mentre passeggiava su quell’autentico regno della morte che era il campo di battaglia dopo lo scontro di Jena, pensava che era destino che le cose andassero così e che, pertanto, non avesse senso volersi ribellare. Hegel rigetta duramente siffatta posizione assunta da Goethe ma, a sua volta, frutto di una lunga tradizione che può essere fatta risalire a Lucrezio e alla sua metafora (De rerum natura, II) dello spettatore che assiste da riva all’altrui naufragio e trae godimento dall’essere immune da quel male. E’ dunque interessante come, da Hegel fino ad Auschwitz, la posizione lucreziana e goethiana dello spettatore che assiste al naufragio diventi impossibile: il teatro, dove si assiste allo spettacolo come meri spettatori, non più una posizione che possa essere assunta, perché non v’è nessuno che si trovi realmente sulla terra ferma, al riparo dai perigliosi flutti del mare. Scrive a tal proposito Burkhardt: “conosceremmo volentieri le onde che ci portano sul mare della vita; ma queste onde siamo noi stessi“. Oltre alla posizione del naufragio con spettatore, Hegel ripudia anche quella – tipicamente romantica – della lamentazione per il mancato concretarsi degli ideali: in merito, egli dice che “la filosofia deve condurci a capire che il mondo reale è come deve essere […]. Sparisce l’idea che il mondo è un susseguirsi di fatti assurdi e irrazionali“; e, ancora, egli insiste sul fatto che “non si deve essere migliori della propria epoca, ma si deve essere la propria epoca nel modo migliore“. Rigettata tanto la posizione di Goethe quanto quella degli odiati Romantici, Hegel ne propone una sua: egli non si rassegna dinanzi alla “noia” e alla “litania“, convinto che il pensiero debba di necessità chiedersi quale sia il fine cui mira la storia. La risposta che egli propone è, ancora una volta, una ripresa in forma secolarizzata dell’antico motivo religioso della teodicea: “dobbiamo farci una ragione del male nel mondo” – egli dice – e, per far ciò, dobbiamo conferire un senso al male dilagante, concependolo come momento necessario all’interno di un processo nel quale, alla fine, trionfa il bene: nell’economia di tale processo, quello che inteso come a sé stante era il male, viene a configurarsi come una tappa necessaria (e quindi positiva) per la realizzazione del bene.
MODERNITA’ O BARBARIE
Il pensiero di Hegel è una grande summa della filosofia moderna, una sorta di punto di forza dell’Occidente. Dobbiamo però ora chiarire che cosa effettivamente si debba intendere per “modernità” e, una volta compiuta tale operazione, passare a definire la “barbarie”, che è quella particolare forma di male che la modernità produce. Tre sono i modi fondamentali di intendere la modernità: a) come epoca; b) come atteggiamento; c) come processo.
- Il moderno come atteggiamento ha nella critica della tradizione il suo assunto fondamentale: l’atteggiamento peculiare della modernità sta infatti nel rifiuto di ogni dogmatismo in nome di un criticismo corrosivo di ogni pretesa verità dogmatica, nella puntuale messa in discussione di tutti i capisaldi su cui la tradizione poggiava. Secondo questa concezione, il moderno non ha più una precisa periodizzazione, ma è piuttosto un atteggiamento affiorato in ogni epoca storica, sebbene con diverse intensità: sicché vi sarebbero stati “moderni” (nel senso sopra delineato) già al tempo dei Greci, poi in età cristiana, e infine in età contemporanea. Ogni qual volta si è presentata nella storia un’istanza critica, là vi è stata la modernità. Servendosi di questa nozione, Foucault rilegge i testi di Kant e tiene una serie di lezioni su Discorso e verità nella Grecia antica, lezioni al cuore delle quali sta quello che per Foucault è l’uomo moderno per eccellenza: il “parresiasta” (parrhsia in greco è la “libertà d’espressione” tipica dei Cinici), ossia l’antidogmatico per eccellenza, colui che non dice la verità: la sbotta, giacché non riesce a trattenerla. E nello sbottarla, egli non si cura minimamente delle conseguenze derivanti da ciò: il tratto portante del suo agire è il coraggio, il saper vivere senza temere guai, in perfetta armonia tra ciò che pensa e ciò che fa. Se ai moderni interessa la verità degli enunciati, nel caso del parresiasta è la stessa sua armonia tra il pensato e l’agito a garantire la verità di ciò che egli va asserendo: “fondamentale non è dire cose vere, ma che ci sia chi dice cose vere“, asserisce Foucault.
Comune a tutti e tre questi diversi modi di concepire la modernità è l’antropocentrismo di fondo. Tuttavia, se per alcuni la modernità deve essere intesa come un processo infinito (giacché ci saranno sempre ancora delle porzioni del reale da razionalizzare) e propulsivo, per altri l’esito di tale processualità è il nichilismo, come se – antropizzando ogni problema – si soggettivasse tutto. Ma a tutte e tre le letture del moderno è anche comune – e qui sta l’aspetto più interessante – il modo di concepire il rapporto tra la modernità e la barbarie: l’idea che permea tutti e tre i modelli è che, all’avanzare del moderno, arretra la barbarie, in base al presupposto diffuso secondo cui, man mano che si modernizza, l’uomo diventa sempre più umano. In questo senso, “barbaro” diventa l’aggettivo tipico per definire chi non è toccato dalla modernizzazione sempre crescente o ad essa si ribella. Se per gli antichi Greci barbaroV era chi parlava una qualsivoglia lingua non greca e, dunque, chi viveva oltre i confini del mondo ellenico, oggi, per noi, il termine ha assunto significati diversi, ma non del tutto sganciati da quelli attribuiti dai Greci. Barbaro è chi non è progredito sul piano sociale e culturale, chi risulta essere crudele e disumano: è senz’altro più che una coincidenza il fatto che tutti i dizionari, sotto il lemma “barbarie”, adducano come esempio esplicativo la barbarie nazista. Barbari eravamo noi nel nostro passato, quando ancora non eravamo stati coinvolti dalla modernizzazione, e barbare sono da noi usualmente ritenute quelle culture con usanze e riti non solo diversi, ma anche incivili e disumani. Sicché si può a ragion veduta affermare che la modernizzazione, qui intesa come processo di razionalizzazione crescente, di incivilimento e, pertanto di umanizzazione, ad altro non mira se non alla debarbarizzazione. I primi a ragionare esplicitamente in questi termini furono, nel Settecento, i membri della cosiddetta “Scuola scozzese”. Tra questi, spicca la figura di Adam Ferguson (autore di un Saggio sulla storia della società civile), il quale riteneva che lo sviluppo della civiltà fosse così scandito: in un primo tempo, quando gli uomini erano selvaggi, sul piano conoscitivo, dominava la magia, su quello sociale regnava la comunità non strutturata; secondariamente, quando gli uomini divennero barbari, si passò dalla magia al mito e dalla comunità non strutturata alla comunità con la proprietà ma ancora senza leggi; infine, gli uomini divennero civilizzati, sul piano conoscitivo trionfò finalmente la scienza e, su quello sociale, si instaurò la comunità armonica disciplinata dalle leggi. Stando al modello proposto da Ferguson, l’umanità diventa più civile nella misura in cui si addomestica e si ammansisce, espellendo e sublimando i residui ferini che ancora permangono in essa. In ciò risiede propriamente l’incivilimento, che, a livello di morale, trova la propria compiuta espressione nel trionfo dell’etica kantiana (introiettiva e basata sull’imperativo categorico) sull’arcaica legge del taglione. Rispetto alla posizione degli Scozzesi” è forse più interessante quella sostenuta dai loro avversari, ossia da quanti scorgono nell’incivilimento non già un positivo successo conquistato, bensì un avvilente processo di scadenza dell’uomo; corifeo di tale posizione è, in primis, Nietzsche, il quale così si esprime in Genealogia della morale: “posto che sia vero, il processo di incivilimento è il processo con cui si disciplina la bestia da preda uomo per farne un animale educato […]”, ma questo non è altro che “l’immeschinirsi e il livellarsi dell’uomo“. L’addomesticamento in cui la civiltà si risolve è da Nietzsche letto come un fatale rimpicciolimento della razza umana: sicché ciò che per gli “Scozzesi”, cultori della civiltà, era un progresso, diventa per Nietzsche una turpe putrefazione. L’immagine che meglio esprime la concezione che il filosofo tedesco ha dell’Occidente, di questo mondo dove la civiltà si afferma con sempre maggior vigore, è quella delle stelle di cui, benché siano morte, continuiamo a scorgere il fulgore. Diametralmente opposta è la posizione di Condorcet, espressa soprattutto nei suoi Schizzi di un quadro storico dei progressi del genere umano, del 1793. In netta opposizione alla tesi vichiana dei corsi e dei ricorsi storici, Condorcet afferma a gran voce che “il genere umano non potrà più ricadere nella barbarie“, poiché il progresso è irreversibile: l’idea, traboccante di ottimismo, è che l’umanità vivrà come in una serra, nella quale non vi saranno più infiltrazioni di cattivi giardinieri e le tenebre non potranno mai più avere il sopravvento. Quella di Condorcet è la posizione di fede nella modernità forse più estremistica e, se vogliamo, più ingenua e se solo egli avesse vissuto gli orrori che hanno costellato il Novecento si sarebbe certo ricreduto. Ciò non toglie, tuttavia, che anche i più forti critici della modernità finiscano tutti, chi più e chi meno, per nutrire la convinzione che, alla fine, la barbarie sarà sconfitta. Le tanto diffuse espressioni “socialismo o barbarie”, “capitalismo o barbarie”, “modernità o barbarie” sono tutte fra loro accomunate dalla disgiunzione, da quell’aut-aut grazie al quale è scongiurato il pericolo che la barbarie possa trionfare (a patto naturalmente che si affermino il socialismo o il capitalismo o la modernità). Eppure così scriveva Hitler nel suo Mein Kempf: “noi siamo barbari, e ne siamo fieri“. E’ interessante il fatto che se Rosa Luxemburg, ancora convinta che la storia puntasse verso un preciso teloV, poneva l’aut-aut “socialismo o barbarie”, a partire dal 1989, dopo la disfatta del modello socialistico attuato con esiti catastrofici nell’ex Unione Sovietica, si è parlato di “capitalismo come destino”; ma quel che forse è ancora più interessante è che, dopo l’11 settembre 2001, si è di nuovo tornati al modello dell’aut-aut: capitalismo o barbarie? Ovvero: USA o Al-Qaida? Ciò che tenteremo ora di fare sarà di mettere in luce come, con Auschwitz, il modello dell’aut-aut, per cui modernità e barbarie sono due realtà elidentisi mutuamente, imploda su stesso: dopo Auschwitz non si deve più parlare di “modernità o barbarie”, ma si deve piuttosto far ricorso all’espressione “modernità e barbarie”; metteremo pertanto in evidenza come la modernità non sia l’antidoto alla barbarie, ma, piuttosto, il fertile terreno su cui essa prolifera.
MODERNITA’ E BARBARIE
Abbiamo visto come storicamente sia invalsa la convinzione che, quanto più si affermasse la modernità, tanto più arretrasse la barbarie, quasi come se le due cose si escludessero a vicenda e la storia tendesse ad un progressivo azzeramento della barbarie: ma – chiediamoci – può un tale modello rimanere valido dopo Auschwitz? Non possiamo che rispondere negativamente: la shoà ci ha rivelato come modernità e barbarie possano convivere senza escludersi a vicenda. A tal proposito, due sono i grandi filoni interpretativi: una prima posizione è quella sostenuta da quanti credono che la barbarie sia, per così dire, un’ombra che pedina incessantemente la modernità, quasi come se fosse il suo cuore di tenebra mai del tutto eliminabile. Questo modello può poi declinarsi in due diversi modi: il primo è quello dell’intreccio “modernità e barbarie”, col quale si mette in luce come i due aspetti convivano; il secondo è quello che possiamo definire del “ritorno del rimosso”. Come i bambini nascondono ciò che ritengono fastidioso alla vista, così noi tutti tendiamo ad occultare ciò che ci turba e in ciò risiede la rimozione, il nascondimento di ciò che, se non occultato, genera fastidio: così, di fronte ad una barbarie mai del tutto debellata, la nostra cultura volge altrove lo sguardo, fingendo che l’incivilimento l’abbia espunta, quando in realtà essa ritorna di volta in volta in scena. Vi sono poi autori (tra cui Adorno e Horkheimer) che si sono addirittura spinti al di là, arrivando a leggere il moderno come prosecuzione stessa della barbarie. Una terza posizione, non riducibile a quelle testé elencate, è quella che individua nella barbarie un potenziale di disumanità di cui il moderno diventa sempre più consapevole e, in base a ciò, può autocorreggersi, quasi come se sussistesse un’incessante autocritica della modernità che fa i conti con se stessa: è questa la posizione assunta da Hannah Arendt e, secondo modalità differenti, da Habermas. Se per i sostenitori della prima posizione (quella del “cuore di tenebra”), la shoà non è che il vero volto della modernità, viceversa per questi ultimi (Arendt e Habermas) la shoà viene a configurarsi come uno slittamento, potremmo dire una “sbandata” del moderno, una battuta d’arresto che – paradossalmente – può essere istruttiva. Quel che è incontrovertibilmente certo è che con Auschwitz tutte le vecchie categorie impiegate nel passato per rendere conto del male paiono totalmente inadeguate, degli autentici “ferri vecchi” di cui ci si deve sbarazzare: l’idea religiosa, anche nella sua forma secolarizzata, del male redimibile sembra del tutto insostenibile, anche in forza del fatto che esso nasceva dal fatto squisitamente umano che tendiamo sempre ad anteporre la speranza alla realtà e, per tale via, ci autoinganniamo badando più a quel che l’uomo avrebbe dovuto essere rispetto a quel che effettivamente egli è. Le prime falle della tradizionale ermeneutica del male si registrano in occasione della prima Guerra Mondiale e dei suoi massacri di trincea, dove a morire erano decine di migliaia di uomini in simultanea. Ferita gravemente, l’ermeneutica classica del male trovò la sua morte con la shoà, quando si trovò a dover render conto della morte “antiutilitaristica” (Arendt) di milioni di individui massacrati soltanto perché ebrei: da quel momento parve evidente, in tutta la sua portata, la fine di una fede cieca nelle risorse culturali del genere umano. Ma quale fu l’aspetto della shoà che più colpì gli uomini del tempo? Leggendo le opere scritte in quegli anni, cosa emerge in primo piano? Sicuramente a colpire in maniera più profonda le coscienze degli uomini dell’epoca fu das Unheinliche, il “carattere perturbante”, lo spaesamento, il non sentirsi più a casa: si tratta di una sorta di ritorno del rimosso, ma a presentarsi come rimosso è qualcosa che ci è familiare, anche se non lo sentiamo più come nostro perché trasfigurato. Secondo Freud, “lo spaesamento che risale a ciò che ci è familiare, ma che c’è stato reso trasfigurato per rimozione” è il massimo spaesamento che possa esservi: di questo genere è lo spaesamento che prova il bambino di fronte alla madre malvagia, e tale è anche quello che provarono gli uomini di quegli anni quando si accorsero che, il tradizionale aut-aut “cultura o barbarie” (rinviante a quello “modernità o barbarie”) dopo Auschwitz non aveva più senso, e si era anzi capovolto in uno sconcertante “cultura e barbarie”. I lager mettono in chiaro come le due dimensioni (quella della cultura e quella della barbarie) possano essere fra loro connesse a) da indifferenza, b) da complicità. In altri termini, ci si accorse che la cultura non era l’antidoto per il male, ma anzi poteva agevolarne il trionfo, cosicché si può ora comprendere la sensazione tremendamente spaesante che si provò. Crolla definitivamente l’idea che, se si è colti, non si può commettere il male: “Weimar, città dei Classici, con forno crematorio“, dice a tal proposito un noto poeta tedesco, a sottolineare la complicità di cultura e barbarie. Come è noto, Weimar fu la città in cui operarono Goethe e Schiller, e cionondimeno fu sede di un campo di sterminio nazista, che fu poi (il che è forse meno noto) trasformato in lager comunista. Nel bellissimo testo di Steiner – Nel castello di Barbablù – molte pagine sono dedicate al tema della fragilità della cultura. Ciò che più contribuì a generare lo spaesamento fu la constatazione che non era una ragione assonnata a generare mostri (come invece credeva Goya), ma anzi era una ragione iperattiva che aveva creato i lager, sintesi perversa di alcuni elementi della cultura moderna: i carnefici non erano mostri disumani, erano piuttosto uomini coltissimi, che conoscevano i testi dei grandi filosofi tedeschi, apprezzavano la musica di Mozart e prima di andare a sterminare gli ebrei accarezzavano affettuosamente i loro figli. Insomma, non vi fu un solo ambito della modernità a rimanere escluso dalla shoà. E, del resto, se si volesse a tutti i costi applicare ancora il modello dell’aut-aut, per cui la cultura esclude la barbarie, come si potrebbe spiegare il caso di Heidegger, che fu forse il più grande pensatore del XX secolo e che aderì al nazismo? Allo stesso modo, molti nazisti furono kantiani e non è certo un caso che, nella Dialettica dell’illuminismo, Adorno e Horkheimer, mettano accanto Kant e Sade. L’idea della possibilità di vincere sul male non è che la “menzogna vitale” (Pierpaolo Portinaro) – ossia la menzogna indispensabile per continuare a vivere: ciò non toglie, naturalmente, che essa sia e resti una menzogna. Auschwitz si configura strutturalmente come un “corpo nero” che assorbe tutta la modernità, nella sua ridente solarità (quale era apparsa con Condorcet) e non la riverbera, la trattiene e la offusca: da quel momento in poi convive il binomio “modernità e barbarie”, senza però che per ciò diventi vero quel daltonismo dell’amarezza, troppo spesso evidenziato, per cui “modernità uguale barbarie”. Significativamente Bauman asserisce che la shoà è come un quadro o come una finestra: ma, chiediamoci, come mai la sociologia – di cui Bauman è insigne esponente – non si occupa della shoà e, in fin dei conti, la considera alla stregua di un quadro appeso ad una parete bianca, quasi una sorta di tumore proliferante in un corpo di per sé sano? Una risposta definitiva non c’è, ma possiamo comunque notare come Auschwitz debba essere inteso, più che come un tumore su un corpo sano, come una ferita che appartiene strutturalmente (e non accidentalmente) al paesaggio, quasi una sorta di prodotto dell’organismo stesso, benché non si tratti di un prodotto “necessario”, tale da non potere non realizzarsi. A ragion veduta, Bauman rileva che “Auschwitz dice di più sulla sociologia di quanto la sociologia dica su Auschwitz“: con ciò egli intende mostrare l’opportunità di abbandonare una volta per tutte il mito – di cui la sociologia stessa si sostanzia – di un’umanità che, entrata nella modernità, si è definitivamente lasciata alle spalle la barbarie; ma non per questo bisogna credere che la shoà fosse un evento necessario, che doveva per forza prodursi: ciò benché “le capacità necessarie per dominare il mondo non siano qualitativamente diverse da quelle che permisero di realizzare la ‘soluzione finale’“. Ne segue, pertanto, che la modernità è condizione necessaria ma non sufficiente per il realizzarsi di Auschwitz e dell’esplosione della barbarie: sicché ha ragione Bauman quando dice che “in qualsiasi altra cultura la shoà sarebbe stata impensabile in questa forma“. Egli aggiunge che “non è la shoà che è impossibile da comprendere, ma è la nostra civiltà – alla luce della shoà – impossibile da capire“: per questa via, viene ancora una volta sottolineata l’affinità elettiva per cui, senza modernità, Auschwitz non sarebbe mai potuto venire ad essere. Ma – chiediamoci – una filosofia resasi consapevole di ciò, che cosa può e deve fare? Essenzialmente, essa deve giustificare il fatto di poter ancora esistere, ossia di sopravvivere alla diagnosi della propria morte: ciò significa che se la filosofia non fa finta di niente (processo di rimozione), allora dovrà porsi con insistenza il problema della propria legittimità dopo Auschwitz. Non è un caso che, dopo la shoà, si verifichino una sfilza di epitaffi della cultura: dopo Auschwitz, essa è “spazzatura” (Adorno) ed “è impossibile parlare di Dio” (Hans Jonas) o scrivere ancora romanzi. In altri termini, dopo la catastrofe del Novecento, la cultura emana sentenze di morte su se stessa, si condanna ad un silenzio che ben rispecchia la situazione di ineffabilità di quel che è accaduto e di cui essa stessa è stata in buona parte responsabile: in maniera netta e decisa, Adorno – in Educazione dopo Auschwitz – sostiene che, per chi fa ancora cultura, uno solo è l’imperativo: “che Auschwitz non si ripeta!“. Eppure tale imperativo, senz’ombra di dubbio altisonante, si trova forzatamente costretto a convivere con l’amara constatazione che “compresa la critica della cultura, […] tutta la cultura, dopo Auschwitz, è spazzatura” (Adorno, Dialettica negativa). La situazione è, dunque, di stallo: v’è una cultura che si trova a dover pensare contro se stessa e in ciò risiede, per Adorno, la “dialettica negativa”:
| “chi parla per la conservazione della cultura radicalmente colpevole e miserevole, diventa un collaborazionista. Mentre chi si nega alla cultura, favorisce immediatamente la barbarie, quale si è rivelata essere la cultura. Neppure il silenzio fa uscire da questo circolo vizioso: esso razionalizza soltanto la propria incapacità soggettiva con lo stato di verità oggettiva, e così la degrada ancora una volta a menzogna“. |
Dal passo testé riportato della Dialettica negativa emerge bene come i criteri stessi con cui fissiamo i contorni dell’orrore sono essi stessi barbari: è, questa, la situazione di stallo che si verifica nel gioco degli scacchi, quando qualunque mossa si faccia si va incontro alla disfatta, o che si registra nelle opere di Beckett, come in Aspettando Godot. L’unica posizione è quella “negativa”, ossia rimanere nello stallo senza uscirne, poiché ciò comporterebbe una nuova disfatta: sia la difesa dell’aut-aut “cultura o barbarie”, sia la negazione della cultura, sia il silenzio sono da Adorno ripudiati, giacché, chi si nega alla cultura, accetta per ciò stesso la barbarie; ma, al contempo, chi favorisce la cultura, in forza di ciò appoggia la barbarie, che è sorta dalla cultura stessa; infine, anche chi tace si macchia di complicità. Da quanto detto, si evince come la posizione di Adorno non sia rinunciataria, bensì “aporetica”, nel senso greco di “privo di vie d’uscita” (aporia): è, come abbiamo evidenziato, una posizione di stallo, ma non di sconfitta, ed è per questo l’approdo filosoficamente più estremo e più consapevole della problematicità degli strumenti stessi con cui si affrontano i problemi, poiché – nota Adorno – i concetti stessi sono parte del problema o, forse, sono addirittura il problema stesso. Ciò porterà Adorno, congiuntamente con Horheimer, alla tesi – contenuta soprattutto in Dialettica dell’illumisnimo – secondo cui è l’illuminismo stesso a generare la shoà.
PRIMO LEVI E HANNAH ARENDT
Quella di Adorno, secondo cui Auschwitz è l’unico vero orizzonte della filosofia, è la posizione estrema, a tal punto che egli arriva a chiedersi “se dopo Auschwitz si possa ancora vivere“. Ma questa non è l’unica posizione sostenibile: diametralmente opposta è, a tal proposito, quella che potremmo definire la “strategia in due tempi”, così detta perché, subito dopo Auschwitz, si occupa del problema shoà in maniera “radicale”, e, in un secondo tempo, lo esamina invece in maniera “banale”. Vessilliferi di questa posizione sono Primo Levi e, soprattutto, Hannah Arendt. In un primo tempo, ci si chiede come possa la cultura farsi carico del disastro rappresentato dalla shoà; e, secondariamente, ammessa l’intrinseca fragilità della cultura e il suo ineliminabile nesso con la barbarie, si finisce per riconoscere che la barbarie stessa ha – per quanto ciò possa sembrare assurdo – una sua normalità o, per dirla con Arendt, una sua “banalità”. Ciò ben emerge in due scritti di Primo Levi – Se questo è un uomo e I sommersi e i salvati -, risalenti il primo al periodo immediatamente successivo ad Auschwitz, il secondo a diversi anni dopo. In Se questo è un uomo impera la radicalità del male: l’autore, appena giunto nel lager, chiede a tutti con insistenza disperata “Warum?” (Perché?) e un compagno gli risponde “Hier ist kein Warum” (qui non c’è alcun perché). Da ciò affiora la tematica portante dell’opera: forse quanto avvenuto nei lager non si può comprendere, poiché comprendere è giudicare e mettersi al posto dell’autore che ha vissuto sulla propria pelle la catastrofe, ma ciò è assolutamente impossibile. Il male, così inteso, è radicale e colui che lo compie è un essere disumano, un mostro il cui agire non può essere in alcun caso compreso, perché, per comprenderlo, occorrerebbe entrare nella sua personalità. A distanza di vent’anni da Se questo è un uomo, Levi affronta il problema del male in una mutata prospettiva, secondo quella che potremmo definire la “zona grigia” e che possiamo facilmente comprendere leggendo alcuni passaggi de I sommersi e i salvati in cui parla dei carnefici: “erano infatti della nostra stessa stoffa […], erano esseri umani medi […] non erano mostri […] avevano un viso come il nostro“. Chi compie il male non è più inteso come un mostro, come una persona assolutamente diversa da chi lo subisce; viceversa, è un essere umano come gli altri e, proprio in ciò, sta la banalità del male, il fatto che chiunque altro avrebbe potuto compierlo. A tal proposito, Levi adduce l’esempio dei “comandi speciali” con cui era affidato agli ebrei stessi l’ingrato compito di uccidere gli altri ebrei per ottenere in cambio qualche mese di “non morte”: questo è, secondo Levi, il crimine più spaventoso che si possa commettere, poiché si fanno diventare colpevoli le vittime stesse. Centrale nell’opera è la scena della partita di calcio disputata tra i prigionieri del lager e i guardiani: per un momento è come se si tornasse alla normalità, benché si tratti di una partita disputata “davanti alle porte dell’inferno“. Con la prospettiva della “zona grigia” subentra un elemento di inquietudine che, fino ad ora, non avevamo incontrato: nel nostro itinerario, infatti, abbiamo preso in considerazione la drammatica possibilità di finire noi stessi vittime di un lager e, oltre a questa, quella di diventare spettatori indifferenti del male; ora si aggiunge l’altrettanto tragica possibilità di diventare noi stessi i carnefici, e ciò in base alla teoria della banalità del male, secondo la quale a compiere il male sono persone “normali” e non mostri. Hannah Arendt stessa si colloca su posizioni di questo tipo: ella rilascia nel 1965 un’importante intervista in cui confessa di non sentirsi più una filosofa ormai da diversi decenni; ella si sente, piuttosto, una “scienziata politica”, con lo sguardo sgombro da quell’impaccio che è la filosofia; verso di essa Arendt nutre grande sfiducia soprattutto da quando – nel ’33 – ha constatato che pressoché tutti i filosofi si allineavano al regime (Heidegger in primis) e ciò non benché fossero filosofi, ma per il fatto stesso che lo erano. Decisivo fu poi, nel suo itinerario, Auschwitz, un “vero trauma” con il quale si spalancò un abisso sotto i suoi piedi: di fronte a ciò, ella si sforza in ogni modo di addivenire ad una comprensione: “io voglio comprendere e provo appagamento se altri comprendono come me“. Ma, nel caso di Arendt, comprendere non equivale né a dimenticare né, tanto meno, a perdonare, bensì a portarsi consapevolmente sulle spalle il fardello del nostro tempo. Da ciò nasce la sempre rinnovatesi esigenza di spazzare il campo dai pregiudizi, in maniera tale da poter affrontare la realtà nella maniera più obiettiva e per venire a capo della realtà del male, del perché lo compiamo. Tre sono i tre grandi momenti della riflessione arendtiana sul male: a) normalità e incommensurabilità del male; b) radicalità del male; c) banalità del male. Sono tre modi di concepirlo in base a tre questioni: 1) qual è la natura del male?; b) qual è il suo rapporto con la modernità?; c) come può la filosofia resistere ad esso? Nell’immediato dopoguerra tende a prevalere la concezione della radicalità del male: Heidegger, che di Arendt fu l’amante, si sbarazza di lei e la invia a Heidelberg da Karl Jaspers, a cui ben presto – a causa del suo dichiarato antinazismo e a causa del fatto che sua moglie era ebrea – sono tolte la cattedra e la possibilità di pubblicare, cosicché egli finisce per vivere una sorta di esilio interno alla Germania. Nel dopoguerra – esattamente nel 1945 – egli torna in cattedra e tiene un corso sulla Schuldfrage, ossia sulla “domanda inerente la colpa”: di che colpa si sono macchiati i Tedeschi? Per rispondere a questa domanda, Jaspers elabora una casistica con quattro tipi di colpa: 1) colpa criminale è la trasgressione della legge; 2) colpa politica è quella che riguarda diversamente i cittadini a seconda della loro posizione (sudditi, capi, ecc), benché resti vero che chi obbedisce e non si oppone è comunque corresponsabile; 3) colpa morale è quella che si commette quando si violano le leggi prescritte dalla propria coscienza (come nel caso in cui si uccide una persona benché la coscienza ci inviti a non farlo); 4) colpa metafisica è quella per cui, in quanto uomini, siamo tutti corresponsabili di ogni torto perpetrato nel mondo, cosicché Jaspers può affermare che “il fatto di essere ancora vivi [dopo Auschwitz] è una colpa“. Arendt, attenta lettrice e grande amica di Jaspers, intende la sua nozione di “colpa metafisica” equivalente a quella di “colpa collettiva” e obietta al filosofo tedesco che dire che tutti sono colpevoli è, in fin dei conti, come dire che nessuno lo è, quasi come se, dalla colpevolezza generalizzata, risultasse una altrettanto generalizzata assoluzione. Si tratta invece – prosegue Arendt – di accertare i singoli gradi di responsabilità nei singoli casi. Sulla base di questi presupposti, esaminiamo ora le tre maniere – corrispondenti a tre momenti della sua vita – in cui Arendt concepisce il male. La prima maniera – quella della normalità e dell’incommensurabilità del male – si afferma specialmente nel carteggio che la filosofa tiene con Jaspers nel 1946 sul problema della colpa: alla tesi jasperiana della colpevolezza collettiva, ella contrappone la nozione di “colpa organizzata”. Come è noto, nel processo di Norimberga, i nazisti cercavano di discolparsi presentandosi come meri ingranaggi della macchina dello sterminio, cioè come semplici esecutori degli ordini che di volta in volta erano loro impartiti: pertanto Arendt – alla stregua di Levi – ne evince che i capi erano dei mostri, mentre gli esecutori erano uomini come noi, ingranaggi in quelle “fabbriche della morte” che erano i lager. Questi ultimi – nota Arendt – sono caratterizzati da tre elementi essenziali: a) l’impersonalità tipica delle grandi burocrazie; b) la parcellizzazione tayloristica, quasi come se si trattasse di una catena di montaggio finalizzata a dare la morte; c) la gerarchicità più totale, come in un esercito. Il lager – nota Arendt – applica tutti i tratti fondamentali delle istituzionalità della modernità e, in particolare, quello che Weber definiva l’agire razionale rispetto allo scopo, intendo – con tale espressione – un agire mirante esclusivamente al fine (lo sterminio degli ebrei) e incurante dei valori e delle conseguenze. Non appena a quegli “onesti padri di famiglia” era dato agire con quello sgravio di impunità morale, il gioco era fatto: diventavano carnefici a tutti gli effetti. La grande modernità di Auschwitz sta allora, secondo Arendt, nel fatto che, oltre a poggiare sulle istituzionalità tipiche del moderno, il male è compiuto da persone come le altre, da “onesti padri di famiglia“, gentili ed educati con i propri figli e con le proprie mogli. Dal canto suo, Jaspers propone come terapia ad Auschwitz un ritorno generale all’umanesimo di Goethe e si spinge anche più in là della Arendt, forse in virtù del fatto che egli era psicologo ancor prima che filosofo: “la colpa […] assume un connotato di satanica grandezza“; egli avverte tuttavia il rischio che, parlando come fa Arendt di male incommensurabile, si finisca per farne una velata esaltazione, quasi come se ella trasformasse “l’orrore in mito“, cosicché – egli conclude – “mi pare che si debbano ricondurre le cose alla loro banalità“: per spiegare questo punto scivoloso, egli ricorre all’immagine dei batteri che, pur così piccoli e insignificanti, sono in grado di produrre mali immensi; tale è ciò che è accaduto coi nazisti. Ma Arendt rifiuta risolutamente la proposta di Jaspers e lo fa in nome del paqoV: “ad Auschwitz non si è commesso un male superficiale, si è tentato di estirpare dal mondo il concetto stesso di uomo“. Quale strategia di resistenza propone allora la Arendt, di contro al ritorno (forse anacronistico) a Goethe prospettato da Jaspers? Ella propone semplicemente una strategia tanto classica quanto inefficace: un’etica della responsabilità che muti il male in un fardello di cui l’umanità è chiamata a farsi carico, una sorta di vergogna che ciascuno deve provare all’idea di far parte di quell’umanità che ha commesso quel male. E’ una proposta che sicuramente suona bene e, a livello teorico, pare davvero potente; tuttavia, se tradotta in pratica, fa acqua da tutte le parti. Con la stesura de Le origini del totalitarismo, del 1951, si volta pagina: Arendt passa dall’incommensurabilità alla radicalità del male, identificando Auschwitz col male assoluto, icasticamente tratteggiato in questi termini:
| “il male assoluto, impunibile e imperdonabile, che non poteva più essere compreso e spiegato, coi malvagi motivi dell’interesse egoistico, dell’avidità, dell’invidia, del risentimento e che quindi la collera non poteva vendicare, la carità sopportare, l’amicizia perdonare, la legge punire“. |
Da ciò si evince come l’eziologia e la terapia siano messe entrambe fuori gioco: con la shoà il filo della tradizione è stato per sempre reciso e si è concretato quello che già Kant – in La religione entro i limiti della sola ragione – definiva il “male radicale“. Tuttavia Arendt non indica quale sia la reale natura di tale male, ma si limita a indicarne i luoghi in cui esso è nato: i lager. Ella è altresì convinta che, per capire il totalitarismo (e questo è l’obiettivo della sua opera del ’51), si debbano innanzitutto capire i lager, ossia quei luoghi in cui la logia del male radicale si è sviluppata appieno. Ma usare i lager per capire il totalitarismo equivale, naturalmente, a chiedersi quale fosse la funzione dei lager: a tal proposito, Arendt esclude in blocco tutte le possibili risposte utilitaristiche, secondo le quali i lager sarebbero serviti a qualcosa; al contrario – ella nota – essi non sono fabbriche finalizzate alla produzione di qualche cosa, né volte a creare cadaveri. Certo, quella che nei lager si compiva era una forma di annichilimento dell’uomo, giacché egli era in primo luogo annullato come individuo non appena, nel lager, gli erano negate una nazione e una giuridicità, e, in secondo luogo, era azzerato sul piano morale, nella misura in cui – nel lager – i classici problemi morali perdevano ogni significato (tale è il caso in cui alla madre è chiesto quale dei suoi figli preferisce che muoia per primo). Sicchè Arendt addiviene in fine alla conclusione che il vero scopo dei lager era la trasformazione della natura umana, la quale, così com’è, si oppone per sua natura al totalitarismo: il lager plasma un’umanità perversamente nuova e diversa, e questo è il sogno di tutti i pensatori moderni (dal Faust di Goethe fino a Marx). Nei lager quel sogno si è capovolto in incubo, l’utopia si è fatta distopia (è l’immagine del “giardiniere” in altre forme): dopo poche settimane di reclusione, persone tra loro diversissime sotto ogni profilo diventano una sola persona che non ha più umanità né diritti, ma a cui restano esclusivamente le funzioni primarie. Il passo successivo compiuto dalla Arendt è di chiedersi quale sia il ruolo svolto dalla cultura nei lager intesi come laboratori per cambiare la natura umana. A tal proposito, ella confessa a Jaspers: “ho il sospetto che la filosofia non sia monda e priva di macchia in tutto ciò“. Come disciplina, la filosofia ha innanzitutto responsabilità di tipo politico/dirette: è questo il caso in cui essa si mette al servizio di una certa linea politica, con un coinvolgimento diretto (è il caso di Gentile e il fascismo italiano); ma c’è anche una responsabilità di tipo intellettuale/indiretta, quando – come nel caso di Nietzsche e del nazismo – si precorrono filosoficamente posizioni che altri percorreranno fraintendendole. Abbiamo qui succintamente delineato le possibili responsabilità della filosofia in generale, ma dobbiamo ora chiederci quando si debba parlare di responsabilità riferita ai singoli filosofi: quand’è che un filosofo può essere qualificato come nazista? Sicuramente quando egli teorizza la superiorità della presunta razza ariana e quando assegna ad un dato popolo una missione particolare. Tre sono le possibili interpretazioni della responsabilità individuale: 1) si può essere nazisti a prescindere dalla propria filosofia (è il caso di chi aderì al nazismo benché fosse kantiano); 2) si può essere nazisti perché la propria filosofia non presenta elementi di opposizione a ciò (compromissione debole); 3) si può essere nazisti perché la propria filosofia spinge in quella direzione (compromissione forte). Nel caso di Arendt, si preferisce comunemente parlare di “responsabilità indiretta”: quando ella scrive a Jaspers circa la complicità della filosofia col male estremo, pensa ad una prospettiva in cui ciò che accade all’interno dei lager – e che a tutta prima pare del tutto assurdo e ineccepibile – diventa di una chiarezza imbarazzante se visto attraverso le lenti dell’ideologia, le quali finiscono per dare fin “troppo senso” al male. Il termine chiave a cui far riferimento per capire a questo punto il pensiero della Arendt diventa allora quello di ideologia: che cosa intende ella con esso? L’ideologia per Marx era una forma di “falsa coscienza” poggiante su quegli interessi di classe che spingono a pensare in una maniera involontariamente favorevole alla propria classe sociale (tale è il caso della borghesia che finisce col considerare il capitalismo come eterno anziché come frutto di un determinato momento storico); spetta ai critici dell’ideologia smascherare tale falsa coscienza, mettendone in luce la falsità. Con Arendt il termine “ideologia” si colora di significati nuovi e diversi: esso si riferisce ad una corrispondenza totale quanto impossibile tra teoria e prassi; è, in altri termini, la pretesa di far diventare in tutto e per tutto reale la teoria, senza accorgersi che le due sfere – quella reale e quella teorica – fanno a pugni. Lo slogan degli “ideologi” è, in questo senso, il seguente: “ciò che vale per la teoria, deve necessariamente valere anche per la prassi“; o anche quello latino: “fiat veritas ac pereat mundus“. E’ esattamente questo che si è verificato ad Auschwitz, dove i nazisti hanno tentato di concretare la loro perversa teoria: per mettere in evidenza ciò, Arendt si sente in dovere di dimostrare come l’orrore nazista si sia realizzato in virtù del fatto che il mondo è svanito, ossia è caduta quella pluralità che garantiva resistenza, giacché l’ideologia, per funzionare, non ha bisogno dell’io e del mondo: essa è, piuttosto, un parto della mente, un monologo paranoico, un’evasione dal reale. E tale rimozione della pluralità in tutte le sue sfaccettatura – rimozione su cui, come abbiamo detto, trova il suo terreno più fertile l’ideologia – affetta sempre più la filosofia, che tende sempre più a capovolgersi essa stessa in ideologia e a diventare preda di un folle pensare l’unità, riducendo l’umanità ad un solo uomo (nei lager, come abbiamo precedentemente rilevato, le pluralità e le differenze erano azzerate: si era una sorta di unico uomo ridotto alle funzioni primarie). Tuttavia Arendt si accorge ben presto che questo modello, se applicato al nazismo, funziona poco: e, per salvarlo, decide di estenderne l’applicabilità anche allo stalinismo, consapevole di come sia stato, più di ogni altro, Marx (che, nella lettura della Arendt, dello stalinismo è, in certo senso, l’antesignano) a tentare di far diventare prassi la teoria (rendere “filosofico” il mondo, com’egli amava dire), teorizzando la priorità della vita activa su quella contemplativa. Con Marx la filosofia diventa supporto politico del totalitarismo, anche se – come Arendt stessa rileva – “il filo che lega Marx ad Aristotele è assai più robusto di quello che lega Marx a Stalin“. Mostrata la validità della sua tesi per cui si procede sempre più in direzione di un’ideologia, cosicché si perde la pluralità in nome dell’unità, Arendt estende il modello – risultato valido nell’analisi dello stalinismo – anche al nazismo: la teoria della razza è diventata prassi nei lager (questa è l’ideologia). Come antidoto a questa inquietante marcia verso l’ideologia, ella propone di distinguere, all’interno della storia, una “tradizione principale“, che rimuove la pluralità e le differenze, e – ad essa contrapposta – una “tradizione alternativa” che, viceversa, valorizza ed esalta il pluralismo in ogni ambito, lottando contro ogni totalitarismo: appuntare l’attenzione su questa tradizione minoritaria è il compito che Arendt si assume a partire dal suo scritto Vita activa. Si tratta dunque di ripensare l’intera tradizione storica e filosofica tentando di valorizzare quegli elementi pluralizzanti che la “tradizione principale” ha eliminato o, nel migliore dei casi, messo a tacere: siamo pertanto di fronte a quello che potremmo definire un “contravveleno anti-ideologico”. Tra la fine degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’60 il pensiero di Arendt subisce una nuova svolta in concomitanza con l’arresto di Eichmann, uno dei pezzi grossi della milizia nazista, fuggito in Argentina – con l’appoggio del Vaticano – dopo la disfatta tedesca: si cattura e si processa quello che, nell’immaginario collettivo, è il mostro per antonomasia. Israele, diventato Stato, vuole mostrare al mondo che, da quel momento in poi, chi oserà attaccarlo non si salverà; e il fatto stesso che lo Stato vada a prelevare Eichmann in Argentina è una prova lampante di ciò. Subito sorge un problema non da poco: chi ha il diritto di processare Eichmann? Per la prima volta si parla di crimini contro l’umanità: in tale occasione, Jaspers sostiene che tutto il mondo deve processare Eichmann (e Arendt condivide tale posizione), ma Israele si rivela sordo e decide di processarlo a Gerusalemme, anche quando molti (fra cui Arendt stessa) fanno notare che i lager non hanno riguardato esclusivamente gli ebrei, ma anche i comunisti, gli omosessuali, i minorati mentali e, in fin dei conti, l’intera umanità. A questo punto, Arendt decide di seguire di persona il processo a Gerusalemme e di vedere “in carne e ossa” quello che a quei tempi ancora definiva “il male radicale”: sicché si fa mandare da un giornale americano come inviata speciale e da quest’esperienza esce un libro – La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme – attraversato da cima a fondo da un costante senso di spaesamento che traspare fin da quando Arendt scende dall’aereo. Con la pubblicazione di quel libro, inoltre, ella perderà tutti i suoi più cari amici (tra cui Hans Jonas) e sarà ripetutamente accusata di “insensibilità”. Ciò può essere facilmente compreso fin dalle prime pagine, dove ella scrive che, alla vigilia del processo, Israele si stava organizzando come la Germania nazista: espressione, questa, che suonò assai sgradita alle orecchie di molti. Le prime domande che si sollevarono furono le seguenti: perché Eichmann non è processato da una corte universale? Perché non in Germania, dove compì i suoi crimini? La risposta – destinata a suscitare grande scalpore – che Arendt, sconcertata, forniva era che Israele aveva bisogno di legittimarsi e il processo ad Eichmann era un’eccellente occasione. Ancora più sconcertata ella fu allorché vide in persona Eichmann in tribunale; appena due giorni dopo, essa riferì a suo marito dell’incontro e così descrisse icasticamente Eichmann: “è un uomo grigio, piccolo, un coglione“. Ma ciò che più la colpì fu l’assoluta normalità di Eichmann: quello che, nell’immaginario collettivo, era un mostro efferato, si presentava ora come una persona qualunque, del tutto sana, che non uccise mai nessuno con le sue mani e che addirittura svenne alla vista del sangue; egli era, in altri termini, semplicemente un “funzionario delle fabbriche della morte” e, di fronte a lui, la teoria del “male radicale” girava a vuoto. A questo punto, Arendt comincia a mutare prospettiva e ad elaborare una teoria simile a quella della “zona grigia” di Levi. L’avvenuto mutamento di prospettiva è da Arendt comunicato a Scholem (che, fino a quel momento, fu suo amico) in una lettera del 1963:
| “ho cambiato idea e non parlo più di “male radicale”. […] Quel che ora penso veramente è che il male non è mai “radicale”, ma soltanto estremo, e che non possegga né profondità né una dimensione demoniaca. Esso può invadere e devastare il mondo intero, perché si espande sulla sua superficie come un fungo. Esso “sfida” […] il pensiero, perché il pensiero cerca di raggiungere la profondità, di andare alle radici, e, nel momento in cui cerca il male, è frustrato perché non trova nulla. Questa è la sua “banalità”. Solo il bene è profondo e può essere radicale“. |
La spaesante conclusione cui ella perviene è che Eichmann non è un mostro orripilante, un essere “non umano” che uccide per il gusto di uccidere: al contrario, egli né uccide né odia gli ebrei, bensì si limita ad organizzare il trasporto ferroviario degli ebrei nei campi di sterminio, ossia si preoccupa solamente che i treni arrivino in orario, senza curarsi minimamente del loro carico. Addirittura, si scopre che il suo progetto era di invadere il Madagascar e di mandare lì in esilio tutti gli ebrei: il loro sterminio esulava del tutto dalla sua volontà. Ne emerge, allora, la figura di un Ponzio Pilato che non giudica mai e che è sconvolto quando i nazisti optano per la “soluzione finale”: da tutto ciò, Arendt sostiene che “Eichmann non pensa” ed è perciò un uomo malvagio, quasi l’incarnazione del totalitarismo e dell’ideologia, pensa e agisce in modo meccanico, è “obbediente come un cadavere“. Chiamato a difendersi, egli arriva a dire di aver agito “kantianamente” e di aver seguito la volontà di Hitler: non sa ergersi a giudicare quel che fa, si limita ad obbedire ai comandi che gli sono impartiti; così rileva Arendt e, di seguito, si domanda se quello di Eichmann fosse un comportamento obbligato. A questa domanda risponde negativamente: non è assolutamente vero che in ogni uomo si nasconde e latita un potenziale mostro come Eichmann; al contrario, basta saper pensare ed essere giudici del proprio agire perché ciò non si verifichi. Per chiarire questo punto, Arendt adduce l’esempio della Danimarca, l’unico Paese che si era fermamente opposto all’invasione della Germania e delle sue idee aberranti. In fin dei conti, Arendt rileva che Eichmann ha compiuto un male immenso e incommensurabile ma credendo di fare del bene (in ciò risiede quella che ella chiama la “banalità del male“), non ha saputo opporsi poiché non è stato in grado di pensare e giudicare: perciò deve essere punito dalle leggi. Sicché la pena che gli fu inflitta a Gerusalemme (l’impiccagione) fu giusta secondo Arendt, benché ella non condividesse affatto la sentenza per cui Eichmann era un criminale contro gli ebrei: in realtà – ella nota – Eichmann fu un criminale contro l’umanità e perciò deve morire. Il concetto di obbedienza va bene solo quando si ha a che fare coi bambini o coi credenti, ma mai in politica, dove obbedire equivale ad appoggiare. Certo, non tutti possono essere eroi e intraprendere una resistenza attiva, poiché – come giustamente notava don Abbondio – il coraggio non ce lo possiamo auto-infondere, e tuttavia, ciò non di meno, tutti possono rifiutarsi di obbedire, intraprendendo per questa via una resistenza passiva.
DIALETTICA DELL’ILLUMINISMO
Una lunga tradizione costituente il cuore della cultura occidentale riteneva che il male fosse sempre redimibile e che, alla fine, esso sarebbe stato schiacciato dal bene; dal canto suo, Hannah Arendt metteva in luce come, lungi dall’escludersi mutuamente, la barbarie e l’avanzare della modernità potessero convivere e come l’unico antidoto fosse una progressiva autocorrezione intrapresa dalla modernità stessa. Agli antipodi è la posizione di Adorno e Horkheimer, secondo i quali la barbarie è come un’ombra che pedina sempre la modernità e che mai può essere scacciata. In ciò, molti (tra cui Habermas) hanno visto un pessimismo radicale, quasi una disperazione assoluta: in realtà, leggendo in trasparenza il testo principale di Adorno e Horkheimer (Dialettica dell’Illuminismo), si può notare come esso sia percorso non già da disperazione, bensì da sconsolazione e sconforto, il che non esclude in toto che la modernità possa redimersi. Ad avvalorare quanto detto, citiamo un passaggio dell’opera: “senza speranza, non è la realtà, ma il sapere che – nel simbolo fantastico o matematico – si appropria la realtà come schema e così la perpetua“. Da ciò si evince come la lettura data da Habermas e da quanti scorgono nei Francofortesi un pessimismo insanabile sia erronea. L’intera Dialettica dell’Illuminismo è percorsa dalla speranza che, qualora l’Illuminismo riesca a capirsi meglio, esso possa parzialmente sottrarsi a quella domanda martellante che compare fin dalle prime pagine dell’opera: “perché l’umanità, invece di entrare in uno stato veramente umano, sprofonda in un nuovo genere di barbarie?“. In realtà, Adorno e Horkheimer notano che quel genere di barbarie (Auschwitz) non è del tutto nuovo, è anzi un qualcosa di vecchio come il mondo: tuttavia, è come se lì, ad Auschwitz, esplodesse un trend inscritto nella cultura occidentale, dove la filosofia ha una sua responsabilità, cosicchè il pensiero è chiamato a riflettere sulle proprie colpe. In questo senso, l’opera si presenta come una “preistoria filosofica dell’antisemitismo“, secondo la calzante espressione adoperata dai due autori di quella che è passata alla storia come “Scuola di Francoforte”. Tale “Scuola” ha una vicenda assai bizzarra, poiché, anche se fondata nel 1923, di essa si parla soprattutto negli anni che vanno dal ’49 al ’52, quando i suoi esponenti rientrano dall’esilio a cui erano stati costretti dall’avvento del nazismo. Sono un gruppo molto variegato di intellettuali che, grazie ad una cospicua eredità, fondano un “Istituto per le ricerche sociali” e Horkheimer, che della Scuola fu il padre fondatore, decide di mettere insieme un team che lavori ad una “teoria critica della società” al fine di aggiornare il marxismo e – per dirla con Gramsci – renderlo “all’altezza dei tempi“, anche alla luce della recente scoperta dei Manoscritti economico-filosofici del 1844, fino ad allora rimasti sconosciuti: dalla lettura dei Manoscritti affiora un Marx diverso da quello a cui si era generalmente abituati (il Marx ispiratore del partito e critico di economia, il Marx de Il Capitale), in particolare emerge la figura di un attento lettore di Hegel e critico di Feuerbach e della religione. E’ in quest’epoca che nasce il cosiddetto “marxismo occidentale”, una pianta su cui si innestano nuove discipline, tra le quali la psicanalisi (Fromm, Reich, ecc). Quest’ultima è chiamata a rispondere ad una domanda che colpiva al cuore il marxismo: perché la rivoluzione – che secondo Marx era necessaria non meno della caduta di un grave gettato da un’altura – non è arrivata? Ci si trova costretti a riconoscere o che Marx ha sbagliato nelle sue previsioni o che nelle anime dei soggetti rivoluzionari è accaduto qualcosa per cui essi hanno rimosso la rivoluzione, quasi come se il sistema avesse trovato il modo per drogare e ottundere lo spirito rivoluzionario (spiegazione psicologica). In quegli anni si credeva di poter leggere la società alla luce delle categorie della psicanalisi, come se la patologia del singolo potesse essere il frutto di una società malata, con la conseguenza che la malattia psichica che affligge l’individuo diventa una risposta sana ad una società malata nel profondo. Se fino al ’35 circa ci si chiedeva perché non si fosse realizzata la rivoluzione, all’inizio degli anni Quaranta ci si comincia a chiedere perché sia venuta meno la civiltà e si sia improvvisamente sprofondati nella barbarie. I Francofortesi – e qui alludiamo ad Adorno e a Horkheimer – ritengono in un primo momento che nazismo, socialismo e capitalismo possano essere interpretati con una sola teoria, convinti che fra i tre “regimi” non vi siano differenze qualitative di rilievo: la conseguenza è che si può spiegare Auschwitz non diversamente da come si spiega Hollywood o Stalin, poiché il meccanismo di dominio è il medesimo. Dopo aver compattato il loro modello esplicativo in uno solo, Adorno e Horkheimer lo estendono all’intero corso della civiltà, dall’antichissimo passaggio di Ulisse di fronte alle sirene fino alla “soap opera” che Adorno ha visto la sera prima di metter mano all’opera. Al pari della “Scuola di Francoforte”, la Dialettica dell’illuminismo ha una storia alquanto travagliata: uscita dattiloscritta nel ’44 (nel ’47 ad Amsterdam), fino agli anni ’60 resta pressoché sconosciuta; nel frattempo, i Francofortesi rientrano in Germania, Horkheimer diventa rettore di università e, con il loro coinvolgimento nelle cariche accademiche, viene meno l’istinto critico rivelato in precedenza. Nel ’68 la fortuna sorride all’opera, che gode improvvisamente di grandissima fama presso gli studenti insorti: essi chiedono ad Adorno stesso perché non li aiuta, lui che un tempo scrisse quell’opera tanto rivoluzionaria, ed egli risponde di essere un uomo teoretico, aggiungendo che è impossibile agire nella prassi, poiché, non appena si prova, subito si è inghiottiti dall’industria culturale. E per la verità la Dialettica un testo assai difficile, che oppone resistenza a chi voglia penetrarlo e il motivo del suo grande successo nel ’68 va senz’altro ascritto al fatto che pare assai adatto a supportare il “gran Rifiuto” (Marcuse) in blocco di Auschwitz, degli USA e dello stalinismo e, inoltre, a fare una grande cesura con le generazioni passate. L’idea di scrivere tale testo balenò ad Horkheimer, il quale aveva pensato dapprima a Marcuse come proprio partner, ma ben presto aveva spostato le sue attenzioni sul musicologo Adorno, per via del suo “sguardo reso più acuto dall’odio” verso il capitalismo. All’inizio i due pensavano di comporre un trattato volto alla distruzione delle altrui teorie; poi cambiano idea e decidono di scrivere un testo significativamente intitolato Concetto di illuminismo, in cui troviamo il nucleo di quella che sarà la Dialettica. Il primo excursus che propongono è quello su Ulisse e le sirene, il secondo è su Nietzsche e Sade intesi come i veri illuministi; segue quindi un saggio sull’industria culturale, in cui il modello è esteso agli USA (un illuminismo per le masse) e dove trionfa la tesi per cui fra realtà e televisione non v’è più differenza alcuna. L’ultimo saggio, infine, è sulle Tesi sull’antisemitismo, costituente il teloV recondito dell’opera: la ragione è qui intesa alla stregua di un segugio che va in cerca di residui di diversità per stanarli e che, nel ‘900, si incarna nella follia nazista che annienta gli ebrei. Si affianca anche la tesi secondo cui anche in filosofia la forma non è un mero orpello esteriore (a dircelo è un musicologo), ma è anzi parte integrante del contenuto, poiché, qualunque tesi formuliamo, subito l’industria culturale se ne appropria e se ne serve per i propri fini: ne segue allora che occorre formulare messaggi alternativi in forme alternative, tali da non essere ingerite dall’industria culturale, cosicché sarà opportuno scrivere testi che non provochino piacere o divertimento (più che piacere, l’arte è ascesi); infatti, tra il modo in cui pensiamo e il modo in cui procede la società v’è una forte analogia, e se i filosofi tendono a scrivere trattati sistematici e gerarchici, ciò avviene in forza del fatto che la società stessa è un sistema gerarchico. Ben si inquadra, in questo contesto, lo stile della Dialettica dell’illuminismo, che a tutta prima può sembrare incomprensibile: anziché di un sistema, si tratta di costellazioni, di ragnatele, di frammenti e, in certo senso, di campi di forze, testi in cui manca del tutto la rilassatezza del periodare, la chiarezza e la distinzione. A tal proposito, è opportuno tenere a mente che Adorno, ancor prima che filosofo, era musicologo e che forse la Dialettica è stata scritta come si scrive la musica, dove ogni “tesi” presenta già in sé il proprio contrario. Il registro, l’epoca trattata e la disciplina cambiano di riga in riga e ciò contribuisce a far apparire il testo come alchimia: l’unica sostanza che permane invariata è il dominio, che di periodo in periodo si declina in mille versioni, senza che però vi siano norme regolanti le trasformazioni che si succedono. Dal feticismo di Marx si passa a quello di Freud, presupponendo che il lettore abbia ben chiaro nella sua mente di cosa si sta trattando. Molti, del resto, sono gli antecedenti a cui Adorno e Horkheimer si rifanno e altrettante sono le posizioni di volta in volta richiamate nell’opera: in primis, una teoria standard dell’illuminismo, quale era stata formulata da Kant stesso nella sua Risposta alla domanda: che cos’è l’Illuminismo?, dove il filosofo tedesco rispondeva che esso “è l’uscita dell’uomo da uno stato di minorità che egli deve imputare a se stesso.[…] Sapere aude! Osa servirti della tua intelligenza!“. Così inteso, l’illuminismo si configura come coraggio di vincere l’inerzia e la minorità con la sola forza della propria ragione, giacché è troppo comodo lasciare che siano gli altri a pensare per noi. Non è affatto vero, allora, per Kant (come invece era per Condorcet) che l’uomo tenda per sua natura ad emanciparsi: perché ciò avvenga, egli deve anzi vincere l’inerzia. E Kant distingue tra un “uso privato” della ragione – uso che ciascuno fa all’interno della propria funzione sociale, dove è parte di un meccanismo e deve obbedire senza usare la ragione (il prete deve limitarsi a celebrare la funzione religiosa e non gli è dato disquisire in Chiesa sui dogmi) – e un “uso pubblico”, che si fa quando si sono dismessi i panni del proprio ruolo sociale, allorché ciascuno può liberamente fruire della propria ragione, fermo restando l’imperativo: “ragionate quanto volete, ma obbedite!”. Ben si capisce come una ragione così concepita sia foriera di emancipazione; ma tale teoria è, nella Dialettica dell’illuminismo, completamente ribaltata, poiché Adorno e Horkheimer sostengono che l’esito dialettico dell’illuminismo è non già l’emancipazione, bensì il totalitarismo: “sotto i gelidi lumi della ragione, nasce la messe di una nuova barbarie“. La ragione, infatti, non è che sottomissione della natura e degli altri; come già rilevava Schopenhauer, essa è – al pari delle zanne per la tigre – lo strumento con cui ci teniamo in vita. Ne segue, allora, che il vero illuminismo deve essere cercato in Sade e nel suo pensiero, non in Kant, benché questi avesse perfettamente capito come una ragione non consapevole dei propri limiti producesse inevitabilmente un’eterogenesi dei fini a tal punto da distruggere addirittura il soggetto che essa doveva conservare. Un altro grande referente del pensiero di Adorno e Horkheimer è Hegel, per via della sua concretezza: tre sono in linea di massima gli aspetti della sua filosofia che riecheggiano nella Dialettica. In primis, è sicuramente un retaggio dell’hegelismo – e in particolare della Fenomenologia dello Spirito – il fatto che Adorno e Horkheimer analizzino non già i lager, bensì la storia della ragione, con l’idea che sussista un forte rapporto tra il sapere che l’umanità ha di sé e la storia che l’umanità compie. Ad ogni epoca corrisponde una forma di sapere e la storia non si svolge nei cieli astratti bensì nell’immanenza terrestre, a tal punto che, se storicamente termina la schiavitù, è perché pensiamo in un dato modo. Tanto per Hegel quanto per Adorno e Horkheimer l’indiscussa protagonista della storia è la ragione: il passaggio da un’epoca all’altra avviene in virtù di un processo dialettico in cui ogni forma di sapere percepisce la propria contraddizione e si capovolge nel suo opposto. L’idea della dialettica come processo triadico di posizione, negazione e superamento era balenata a Hegel in gioventù, quando rifletteva sull’amore, alla luce della lettura di Romeo e Giulietta di Shakespeare: quando non amo – egli notava – sono “in me”, ma quando poi amo esco da me ed entro nella persona amata e, nell’amore riuscito, torno in me arricchito dell’esperienza vissuta nell’altro. Quella che, in questo modo, si realizza è – dice Hegel – un’autentica “Odissea dello spirito“, giacchè, come Ulisse fa ritorno ad Itaca arricchito dalle mille traversie vissute lungo il cammino, così lo spirito torna in sé infinitamente accresciuto. Nel procedimento dialettico nulla va perduto: dapprima si pone, poi si nega e, infine, si innalza conservando ad un superiore livello, proprio come nel fiore è contenuta tutta la verità del seme che, tuttavia, per diventare fiore, ha dovuto negarsi come seme. A catturare l’attenzione dei Francofortesi (e, a suo tempo, quella di Marx) è la figura dialettica del servo/signore, esposta nella Fenomenologia dello Spirito: con l’autocoscienza, si è consapevoli di sé come soggetti percipienti, sicchè il sapere comincia ad avere se stesso come oggetto; si verifica poi la “duplicazione dell’autocoscienza”, per cui due soggetti si incontrano ed entrano in conflitto fra loro in una “lotta mortale” dove la posta in palio è il riconoscimento (ciascuna delle due autocoscienze ambisce ad essere riconosciuta, secondo la bell’espressione di Sartre “sorge l’altro, ruba il mio mondo“). La lotta può finire con la morte delle due autocoscienze, oppure può accadere che una si arrenda per amore della vita e accetti di diventare serva dell’altra, che in questa maniera – non avendo temuto la morte – diventa la padrona: l’una è nulla, l’altra è tutto. Tuttavia si innesta poi la dialettica per cui la sconfitta diventa vincitrice: infatti, il servo lavora e muta la natura a vantaggio del padrone; lavorando, l’autocoscienza serva compie l’attività più umanizzante e diventa la vera padrona, mentre il signore diviene servo del servo. Qualcosa di analogo avviene anche per Ulisse: egli è il signore, i rematori sono i servi, le sirene sono la natura. I rematori, a cui son state tappate le orecchie con la cera, non sentono la voce della natura, non fanno altro che lavorare a vantaggio del padrone. Ulisse la ode, ma, fattosi incatenare, non può seguirla: sicchè la dialettica servo/padrone implode, non nasce alcun superamento e gli schiavi, anziché diventar padroni, restano schiavi abbruttiti dal lavoro disumano, mentre il signore Ulisse si arricchisce sulle loro spalle. Altra figura della Fenomenologia a cui i Francofortesi rivolgono particolare attenzione è quella della “dialettica dell’illuminismo” (da cui mutuano perfino il titolo per la loro opera): Hegel notava che l’illuminismo, con un tipico capovolgimento dialettico, finiva per risolversi non già in un’emancipazione universale, bensì nel suo opposto, tant’è che lo sbocco fu il Terrore giacobino; ciò che non è ragione viene ghigliottinato e distrutto, quasi come se la ragione, là dove non scorge tracce di sé, annienta ogni cosa come forma di inganno da cui gli uomini debbono liberarsi, prima fra tutte la fede, la quale – nota Hegel -, nel momento in cui deve giustificarsi dinanzi alla ragione, “è perduta“. Pertanto quel terrore e quella superstizione da cui l’illuminismo doveva liberare sono stati da esso rinforzati all’ennesima potenza. Il binomio che merita di essere evidenziato è quello illuminismo/potere: il processo che vuol liberare dal dominio, non fa che rinsaldarlo. I Francofortesi riprendono questo modello hegeliano e lo estendono alla storia nel suo complesso, cosicché, per loro, illuminismo non è solo il Settecento (come era invece per Hegel), è piuttosto un qualche cosa che investe l’intera umanità in ogni epoca, da Odisseo fino ad Auschwitz. Un altro autore di importanza fondamentale a cui Adorno e Horkheimer costantemente fanno riferimento è Marx: termini come feticismo, sfruttamento, alienazione, struttura, ecc, che così spesso ricorrono nella Dialettica, ne segnalano la ponderosa presenza. Attento lettore di Hegel, Marx riprende la figura del servo/signore, convinto anch’egli che l’uomo, modificando la natura, diventi sempre più uomo, giacchè a realizzare l’umanità in senso pieno è il lavoro. Tuttavia, nella fabbrica capitalistica capita che il lavoratore si ponga nell’oggetto e che questo gli venga strappato dalle mani: in questa maniera, esso si rivolta contro al lavoratore, che è sottomesso dall’oggetto del suo lavoro come da un mostro (in ciò risiede il feticismo delle merci). Ciò si riverbera nelle “forze produttive”, giacché i lavoratori, che potrebbero cambiare il mondo, lavorano nell’interesse di pochi e non dell’umanità. In Il Capitale, si tratta ampiamente del feticismo e del suo arcano: quanto più l’operaio produce merci, tanto più egli si inginocchia di fronte ad esse, quasi come se acquistassero autonomia e lo dominassero, con la conseguenza che i rapporti tra uomini assumono la parvenza di rapporti tra merci: “la società assume la forma di un rapporto tra cose […]. Anziché averne il dominio, l’uomo ne è dominato“. Diventa allora necessario lottare per far cadere tale illusione e per far sì che a dominare siano non già le merci, bensì gli uomini: ciò significa fine del feticismo e, con esso, fine della religione come dipendenza da un ipotetico mondo soprannaturale. Tuttavia l’analisi che Marx conduce col piglio critico di uno scienziato è viziata da tre errori o, forse è meglio dire, da tre miti: primo fra tutti quello secondo cui il lavoro rappresenti una forma di conservazione e di realizzazione di sé (come rilevano i Francofortesi, esso costituisce piuttosto una forma di dominio); in secondo luogo, il fatto che la scienza e la tecnica siano neutre, quasi come se esse potessero del tutto porre fine alla miseria e allo sfruttamento, se solo non vi fosse il capitalismo: al contrario – e di ciò sono ben consapevoli i Francofortesi – esse sono ideologiche al massimo. Infine, l’ultimo mito di cui Marx è succube è che i rapporti siano così nitidi che si possa pianificare di abolire la proprietà e, sulla base di tale pianificazione, abolirla realmente. Il feticismo delle merci è dai Francofortesi esteso ad ogni rapporto, perfino a quello intercorrente tra i soggetti, a tal punto che la stessa produzione di opere d’arte, la stessa visione di un film o lo stesso esercizio del pensiero ne sono il frutto: infatti, è perché pensiamo in un dato modo che produciamo gli oggetti in una certa maniera. Altra fonte cui Adorno e Horkheimer si ispirano sono Nietzsche e Freud: sulla loro scia, infatti, Adorno e Horkheimer si domandano quale sia il prezzo che la nostra natura interna deve pagare per l’ingresso nella civiltà. Se Nietzsche, a tal proposito, parlava di una morale dei servi e, ad essa opposta, di una dei signori, dal canto loro Adorno e Horkheimer prendono apertamente posizione a favore della morale dei signori. Nell’opera Principio di piacere e principio di realtà, Freud asseriva che l’ingresso nella civiltà impone la rinuncia alla realizzazione dell’eros, aggiungendo però che si tratta di un prezzo che deve assolutamente essere pagato, poiché, altrimenti, torna a scaturire la barbarie e, con essa, la guerra. Il prezzo pagato per l’ingresso nella civiltà è, nella Dialettica dell’illuminismo, rappresentato da Ulisse, che può solo udire (e non rispondere) il richiamo dell’eros incarnato dall’ammaliante canto delle sirene. Infine, l’ultimo autore a cui i Francofortesi fanno riferimento è Max Weber: questi sosteneva che un processo sempre più intenso di dominio razionale del mondo finiva poi per capovolgersi nel suo contrario; in forza di ciò, nel moderno è come se fossero risorti gli antichi dei greci e, in questo senso, Weber parla di “gabbia d’acciaio”. Con la volontà di opporsi a Marx, Weber guarda alle cose dal punto di vista delle sovrastrutture e si domanda di qual genere di uomo (e non – come ci si aspetterebbe da Marx – di qual genere di strutture) ci fosse bisogno affinché potesse nascere il capitalismo. Egli risponde prendendo in esame i protestanti e il loro grande accumulo di ricchezze a partire al Cinquecento. Il termine chiave per capire questo accumulo è – dice Weber – il termine tedesco Beruf, che significa tanto “vocazione” quanto “lavoro”, quasi come se sussistesse un’identità di professione di fede e professione lavorativa. Per i protestanti la salvezza è decretata da Dio ab aeterno (giustificazione per fede) e non la si ottiene in virtù delle proprie opere: un indizio per capire se si sarà o meno salvati è il successo professionale che si ha nel corso della vita, quasi come se, dal successo nel lavoro, si potesse avvertire il proprio essere graditi a Dio. Sicché quella che il protestante compie è un’autentica “ascesi intramondana“, per cui egli è strumento di Dio nel mondo: chi lavora con dedizione per tutta la propria vita e riscuote grande successo accumulando ingenti ricchezze (e non per fini edonistici: accumula senza consumare, perché ciò è proibito dalla religione), può ritenersi salvato da Dio. Da ciò nasce secondo Weber il capitalismo: non già da particolari condizioni materiali, storiche ed economiche (come credeva Marx), bensì da idee, da sovrastrutture. I Francofortesi cercano di coniugare Marx e Weber: quest’ultimo, per chiarire quanto accade nel mondo protestante, ricorre all’esempio del mantello che, dapprima usato per riscaldare, finisce poi per imprigionare come una “gabbia d’acciaio“; infatti, l’accumulo di ricchezza effettuato dai protestanti finisce a lungo andare per diventare fine a se stesso e non più funzionale alla religione, ossia finisce per trasformare il mantello della religione in una gabbia che la annienta. La “razionalità rispetto al valore” si smarrisce lungo la strada e viene rimpiazzata dalla “razionalità rispetto allo scopo“. La vita spesa nel lavoro diventa priva di senso e fine a se stessa: ne segue la perdita della libertà, l’accumulo domina l’uomo e lo rende superfluo. Del discorso di Weber, in Adorno resta che la “ragione strumentale” (la “razionalità rispetto allo scopo” di Weber) è monca e diventa una gabbia d’acciaio: tale è la ragione dell’astuto Ulisse che passa dinanzi alle sirene legato all’albero della nave. In Sociologia delle religioni, Weber ci propone poi uno sconcertante elenco di conquiste dell’Occidente e ci chiede se siano effettivamente universali, degne di essere esportate in quanto umane e superiori; tali conquiste sono, ad esempio, la scienza e “la forza più fatale” (il capitalismo). Agli occhi di Weber, la modernità viene a configurarsi come un processo che tutto razionalizza (l’insegnamento, la politica, ecc) ma che poi, per ironia della sorte, tende a capovolgersi e a far risorgere gli antichi dei della Grecia: ciascuna delle realizzazioni della modernità, infatti, risponde solamente a sé, cosicché ciò che è buono non per questo è anche vero, ciò che è bello non per questo è anche buono, ecc. Si attua cioè un autentico frazionamento dei valori o, come lo chiama Weber, un “politeismo dei valori” di fronte al quale l’individuo può chinare il capo ad uno dei tanti dei trascurando gli altri: può così scegliere il valore della religione (conducendo una vita religiosa), oppure quello della scienza (conducendo una vita dedita alla ricerca), e così via. Ma tra i molteplici valori non v’è contatto né comunicazione: pertanto il moderno si prospetta come tragico smarrimento del senso e della libertà, come fredda “gabbia d’acciaio“. Se in Marx e in Hegel vi era il “superamento” dialettico, in Weber regna invece l’accettazione, cosicché il suo si presenta come un “individualismo eroico” che accetta come destino il frazionamento dei valori. Di fronte ad una razionalità che tutto promette senza nulla mantenere, si deve parlare di una ragione sana o, piuttosto, di una ragione malata e autofagocitante? E’ una situazione del tutto analoga a quella che si ha coi miti: e l’idea stessa che la ragione si capovolga nel suo opposto (negli dei olimpici di cui parla Weber) pare suggerire l’idea che la ragione si accompagni sempre e comunque al mito, dove tutto accade perché deve accadere e dove l’uomo può soccombere o combattere commettendo ubriV. Affiora qui la tesi secondo cui la ragione moderna ha una segreta complicità col mito: Hans Blumenberg non scorge alcun elemento di scandalo nel legame tra logoV emuqoV , anzi, egli sostiene (in Elaborazione del mito) che il mito serve a compensare l’intrinseca impotenza umana di fronte alla realtà che è “ontologicamente nemica dell’uomo“; col mito, infatti, si creano immagini che conferiscono un senso alla realtà, l’uomo cerca di indebolirla e di distanziarla per poterla rendere più vivibile; in ciò risiede “il lavoro del mito“. Subito dopo averlo definito, Blumenberg asserisce che il mito funziona come depotenziatore della realtà non già in una precisa epoca storica, ma lungo tutto il corso della storia, perpetuandosi di continuo come se sempre e di nuovo addomesticassimo coi miti creati in ogni epoca una realtà di per sé invivibile. Ben si capisce allora come, nella prospettiva fatta valere da Blumenberg, mito e ragione non contrastino, ma anzi si aiutino reciprocamente, poiché la loro funzione è la stessa: “il logos del mito diventa il logos tout court“. La distinzione generalmente ammessa tra mito e ragione è dunque meramente fittizia. Diametralmente opposta è la posizione dei Francofortesi nella Dialettica, dove l’intreccio fra ragione e mito è letto come testimonianza del fatto che la ragione, quale si è affermata nella nostra società, è malata: civettando con Marx, sostengono che “la ragione è sempre esistita, ma non sempre in forma ragionevole“. Sicché essi approdano da ultimo ad una teoria della civiltà mancata, poggiante su una serrata critica della ragione avviata da Horkheimer nel suo saggio – dedicato a Benjamin – Ragione e autoconservazione (1940), a partire dalla seguente tesi: “il nuovo ordine fascista è la ragione, nella quale la ragione si disvela come non ragione“. Ma – chiediamoci – che la ragione si faccia oppressiva è una tappa inevitabile del suo cammino? Fino agli anni ’30, i Francofortesi rispondono sostenendo che la ragione è oppressiva perché oppressiva è la società in cui essa si trova ad operare: e, dalla lettura della Dialettica, appare chiaro come essi non facciano riferimento ad una particolare classe sociale capace di trasformare la società, cosicché il loro è un messaggio nella bottiglia indirizzato ai posteri. Ciò che occorre però chiarire è se la ragione sia intrinsecamente nociva o se sia tale solo nell’ambito di una determinata situazione storica. In Eclissi della ragione – che della Dialettica è una versione ad usum delphini per gli studenti americani, ritenuti non in grado di leggere la Dialettica -, Horkheimer lascia trasparire la tesi secondo cui, se volessimo parlare di una malattia della ragione, allora tale malattia andrebbe intesa non come un male verificatosi in un dato momento storico, bensì come un qualcosa di inseparabile dalla natura della ragione nella civiltà quale si è sviluppata fino ad oggi. In particolare, la malattia da cui la ragione è affetta consiste nel fatto che essa è nata dall’esigenza umana di dominare la natura e di piegarla al suo volere, cosicché, per rendere possibile la guarigione, occorrerà comprendere la natura del male alle sue origini e sarà invece insufficiente curarne gli ultimi sintomi. Ne segue, allora, che una vera critica della ragione porterà di necessità alla luce gli strati più profondi della civiltà e ne esplorerà la storia più antica. Così scrive Horkheimer in Eclissi della ragione:
| “Dal momento in cui la ragione divenne lo strumento del dominio esercitato dall’uomo sulla natura umana ed extraumana – il che equivale a dire: nel momento in cui nacque -, essa fu frustrata nell’intenzione di scoprire la verità. Ciò è dovuto al fatto che essa ridusse la natura alla condizione di semplice oggetto e non seppe distinguere la traccia di se stessa in tale oggettivazione. […] Si potrebbe dire che la follia collettiva imperversante oggi, dai campi di concentramento alle manifestazioni apparentemente più innocue della cultura di massa, era già presente in germe nell’oggettivazione primitiva, nello sguardo con cui il primo uomo vide il mondo come una preda “. |
Esiste pertanto una malattia della ragione che oggi si manifesta più che mai: lo si vede nei lager e nella cultura di massa, ma in realtà è sempre esistita poiché è presente nelle radici stesse della ragione il voler dominare la natura. Dovrebbe ricercare la libertà e la verità, invece agisce come strumento di autoconservazione (al pari delle zanne per la tigre). Ne sue che la cura dovrà essere radicale quanto la malattia: in articolare, la terapia consisterà in un’archeologia della ragione, ossia in un andare a ritroso nel tempo per riportare alla luce lo strato più arcaico della ragione e, a quel punto, tentare di risanarla. Si tratterà, in altri termini, di compiere un’indagine storico/genetica di una ragione votata al dominio della natura: nata come strumento di conservazione di sé, la ragione finisce poi per distruggere la civiltà e, dunque, per sortire esiti opposti a quelli iniziali (è un capovolgimento dialettico di marca hegeliana). E, a tal proposito, le prima quaranta pagine circa della Dialettica dell’illuminismo prendono in esame il rapporto ragione/mito, chiarendo come la ragione fallisca sia nel liberare l’uomo dall’asservimento sia nell’autoconservazione. La tesi portante che qui emerge è che il mito è già illuminismo e che, a sua volta, l’illuminismo si ribalta in mito. Al pari dell’illuminismo, il mito è una prestazione che attribuiamo alla ragione, la quale cerca con esso di controllare una realtà babelica; in questo senso, il mito è astrazione, riconduzione all’unità di ciò che è molteplice. Nel nome del concetto si uniscono le molteplicità (le Idee di Platone), si mette al bando la magia. Il mago si rapportava mimeticamente alla natura, senza fratture, senza oggettivazione e senza reductio ad unum. Dal canto suo, il mito opera già come autoconservazione, nella misura in cui dà nomi (gli dei), individua responsabili degli eventi e, in fin dei conti, rende ragione di ogni singolo accadimento, al pari dell’illuminismo. In secondo luogo, il mito è perdita di sé: Ulisse di fronte alle sirene rappresenta esattamente questo, la formazione e la perdita dell’individuo borghese di fronte alla natura non reificata (le sirene), il cui canto deduttivo è particolarmente insidioso perché il borghese ne sente ancora il forte richiamo e, di fronte ad essa, smarrisce in toto la propria identità: Ulisse è Nessuno, come egli stesso dice al Ciclope che gli domanda il nome. Non riesce a non passare dalle Sirene, si abbandona al richiamo come chi si sa già in catene: è il borghese che rinuncia alla natura ma che, ciò non di meno, continua a sentirla, di contro ai proletari (i rematori le cui orecchie sono state tappate) che nemmeno possono sentirla, poiché ciò è stato loro precluso dal borghese stesso. Riprendendo l’immagine, Kafka immagine mute le sirene, cosicché il canto che i rematori non sentono in realtà non esiste. “Il mito è già illuminismo e l’illuminismo torna a convertirsi in mito“: da questa constatazione, centrale nell’opera, nasce una teoria del dominio della natura interna (ossia del patrimonio pulsionale) e di quella esterna (la realtà); dal punto di vista della realtà, la narrazione mitica si configura come distacco dalla magia (dove il soggetto non conosce la distinzione tra sé e la natura: lo stregone si immedesima nel fuoco, nel tuono e negli altri fenomeni naturali) cosicché il soggetto distanzia da sé la realtà stessa per meglio dominarla (il “sapere è potere” di Bacone): se la magia, dinanzi al timore di una realtà onnipotente e capace di schiacciare l’uomo, si immedesima in essa, il mito, viceversa, crea dei, depura la realtà dalla sua ricchezza qualitativa, tant’è che tutto è ridotto a uno e a quantità. A questo punto, l’uomo si concepisce come separato dalla natura, di cui è dominatore e, successivamente, distruttore. E per poter acquisire un’identità (ossia per poter dire: “io”), l’uomo soffre: nell’immagine di Ulisse, le sirene non sono che il richiamo che la natura rivolge all’uomo affinché egli torni ad essa e l’astuzia di Ulisse, l’uomo dalle mille risorse (polutropoV), sta nell’escogitare un inganno per poter udire il richiamo senza però poter cedere ad esso (e, in ciò, sta la sua regressione). Come già notavamo, i rematori non possono nemmeno udire tale richiamo: essi sublimano nella rabbia quel richiamo che non riescono ad udire. Il lavoro dei rematori (che per Hegel e per Marx era potenzialmente positivo) per i Francofortesi è completamente negativo, giacché i rematori diventano sempre meno uomini e non hanno possibilità di riscattarsi. E’ così che l’illuminismo ripiomba nel mito: la concezione scientistica di Bacone, di Newton, di Galileo e di Cartesio trova nel ‘900 la sua realizzazione in forma di incubo, poiché, come mai prima d’allora, scienza e tecnologia, lungi dall’essere neutre (come le riteneva Marx), si sostanziano di ideologia e non hanno alcuna valenza emancipativi, sono anzi per loro stessa natura repressive: in ciò sta la morte della filosofia. In quest’ottica, i Francofortesi scagliano i loro dardi avvelenati contro il neo-positivismo (negli anni ’60 vi sarà un importante dibattito tra Adorno e Popper su questa problematica) e contro la sua pretesa aderenza ai fatti e alla grande importanza concordata al linguaggio, per cui i problemi filosofici altro non sarebbero che problemi linguistici (sicchè i problemi che la tradizione si è posta sono rimasti irrisolti perché mal posti linguisticamente): nel neo-positivismo muore la filosofia come messa in discussione della realtà, giacché per i neo-positivisti diventa apologia della realtà quale essa è. Ciò si verifica soprattutto in quella che Adorno e Horkheimer chiamano industria culturale, anch’essa frutto della dialettica della razionalità: il sogno illuministico di portare la cultura al pubblico si capovolge in incubo, diventa un inganno, il mito diventa mito di massa: la cultura, infatti, raggiunge attraverso lo schermo del televisore o attraverso la radio le masse ma non già per liberarle, bensì per assoggettarle. L’arte – che da sempre è stata anfibia tra la merce e la liberazione – con la riproducibilità tecnica non è più che una merce priva di ogni potenzialità emancipativa; nella “perdita dell’aura” causata dalla riproducibilità tecnica, Benjamin scorge invece – suggestionato da Brecht – una potenziale emancipazione generale. Al contrario per i Francofortesi l’industria culturale inculca l’idea di una realtà che eternamente si riproduce e di fronte alla quale ci si dovrebbe rassegnare: sicché, anziché liberare, la cultura – in ogni sia forma – non fa che rafforzare la sudditanza, sicchè si tratta di una finta evasione dalla realtà. Per esempio, se prendiamo il caso dei cartoni animati, Paperino che prende un sacco di bastonate ma, ciò non di meno, continua a vivere non è forse l’inculcamento – da parte dell’industria culturale – che, di fronte alle ingiustizie, ci si deve rassegnare? La stessa messa in scena della violenza nei film d’azione è profetica. Tuttavia, Adorno e Horkheimer non prendono minimamente in esame la possibile emancipazione apportata dalla cultura, non ipotizzano cioè per neanche un istante che i mass media possano essere impiegati non già per assoggettare, bensì per liberare. E tuttavia Adorno, invitato a conferenze e interrogato su come educare la gioventù dopo Auschwitz, fornisce risposte e avanza proposte che stridono con quanto da lui sostenuto nella Dialettica: egli asserisce che nelle campagne, per via dell’ignoranza diffusa, v’è più predisposizione a compiere nefandezze e, per ovviare a ciò, occorrono programmi televisivi che indirizzino la gente ad agire diversamente. Siamo evidentemente dinanzi ad una contraddizione: se nella Dialettica egli bollava i mass media come necessariamente assoggettanti, ora egli li addita come strumenti di educazione! Negli Elementi di una teoria dell’antisemitismo, l’antisemitismo è letto come una proiezione della paranoia causata dalla frattura tra soggetto e natura; gli ebrei sono visti come tutto ciò che il Sé ha dovuto sacrificare: essi sono come pezzi di natura che circolano impunemente per il mondo e che, in quanto tali, debbono essere prima ridotti all’uno (l’essere ebreo), poi al nulla (cioè eliminati). Il nazismo è dunque un meccanismo aggressivo e difensivo al tempo stesso e la vittima può essere di volta in volta incarnata in diversi gruppi, a seconda del momento storico. In Adorno e Horkheimer v’è un’ossessione per il negativo, per la critica totale della ragione: ma quale orizzonte alternativo resta se “il tutto è falso” (Minima moralia)? Leggendo la Dialettica dell’illuminismo, si incontreranno, sparse qua e là, frasi che aprono tenui spiragli di speranza. Tuttavia – chiediamoci -, se dico che la ragione è malata (e così dicono Adorno e Horkheimer), su cosa poggia il mio giudizio? Non poggia forse anch’esso su tale ragione malata? Adorno e Horkheimer, in realtà, mai si pongono il problema, che invece è centrale in Habermas; si limitano a dire che siamo immersi nella falsità, ma la disperazione di cui parlano non è la realtà (come invece legge Habermas), ma la ragione che la interpreta. L’imperativo in positivo che aleggia nell’opera è, senz’ombra di dubbio, il seguente: non lasciamo ai neo-positivisti la critica! Resta comunque il problema di come si possa dire il vero se tutto è falso: a tal proposito, Adorno dice che “al pensatore odierno si chiede […] di essere nelle cose e fuori dalle cose. […] E’ il barone di Münchausen che si solleva per il codino” (Minima Moralia, 46); e aggiunge che “la filosofia […] è il tentativo di considerare le cose quali si presenterebbero dal punto di vista della redenzione“. Pertanto da un lato c’è il gesto di chi (come il barone di Münchausen) si solleva da sé, dall’altro ci vuole il punto di vista messianico di fine del mondo: quest’ultima prospettiva è presente anche in Benjamin, il quale ipotizza un robot che batte a scacchi tutti i rivali; tale robot è il marxismo e vince perché pilotato dall’interno da un nano orribile: la teologia. Pare emergere la tesi secondo cui la cultura che è immondizia non è tutta la cultura, ma solo quella che c’è stata fino ad allora: sicché è possibile immaginare una nuova cultura. E nella parte della Dialettica in cui “due giovani conversano fra loro”, uno dei due è Adorno che parla di se stesso: dice di non detestare in sé la ragione, ma solo quella che v’è stata fino ad allora; c’è bisogno di una forza messianica per non guarire. E in tal prospettiva, Adorno abbozza una pedagogia affinché Auschwitz non si ripeta: la linea fondamentale che percorre tale pedagogia è che non abbiamo più potere sulla realtà e sulle strutture di dominio che ci sovrastano, cosicché possiamo solo lavorare su noi stessi. Perciò egli elabora una “pedagogia della resistenza”, incentrata su tre punti cardinali: a) riconoscere che è la freddezza la condizione che fa nascere Auschwitz; b) “non diventiamo gli assassini di noi stessi!“, egli dice; c) non stancarsi mai di aprire gli occhi alla gente sull’orrore che c’è stato e c’è ancora: è, ancora una volta, l’atteggiamento del vecchio marinaio della ballata di Coleridge.
Corso tenuto nell’inverno 2003 dal prof. Enrico Donaggio presso l’Università di Torino. Appunti scritti e presi da Diego Fusaro.