ESTETICA
“Bisogna avere la forza della critica totale, del rifiuto, della denuncia disperata e inutile” (P.P. Pasolini)
INTRODUZIONE ALL’ESTETICA
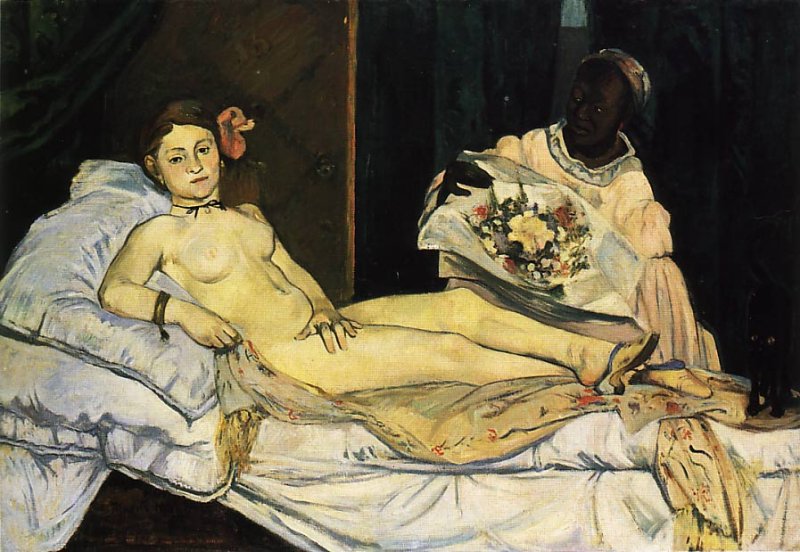
La nave è ormai in mano al cuoco di bordo e ciò che trasmette il megafono del comandante non è più la rotta ma ciò che mangeremo domani. (S. Kierkegaard)
A cura di Roberta Musolesi
Manet: Olympia
L’estetica come disciplina filosofica specifica nasce alla fine del Settecento e si configura pertanto come un fenomeno essenzialmente moderno; essa nasce come tentativo di fornire una legittimazione universale ad un ambito che, malgrado la molteplicità di tesi e precetti, non era ancora divenuto oggetto di riflessione sistematica. Questo ambito è caratterizzato dall’emergere in primo piano della soggettività con le sue manifestazioni, in particolare il sentimento individuale: questo particolare stato affettivo, che inizia ad essere concepito sul piano filosofico come la fonte delle emozioni, era sconosciuto nell’antichità, dove invece prevaleva la nozione di passione, ancora ampiamente utilizzata fino a tutto il Seicento. A partire dal Settecento, il sentimento va invece ad indicare il riflesso soggettivo che accompagna ogni nostra esperienza e si configura come terzo ambito fondamentale della nostra vita spirituale, accanto ad intelletto e volontà; tale nozione non appare caratterizzata da connotazioni di ordine psicologico e trova il suo terreno di applicazione unicamente in ambito estetico e morale.
L’estetica come disciplina filosofica nasce quindi come tentativo di fondare in modo critico un settore che appare, per le tematiche affrontate, votato fin dall’inizio all’accidente e all’irrazionalità e mira a dettare le condizioni di universalità e di necessità per un tipo di esperienza che, ad una prima analisi, ne è priva. L’estetica, come fenomeno moderno, si sviluppa in un’area culturale, quella di lingua tedesca, che alla fine del Settecento offre alla cultura contributi decisivi nel campo della letteratura (Goethe, Novalis, Schiller, Hölderlin, ecc..) e della musica (Mozart, Beethoven, Schubert) e si radica in un tessuto sociale in cui si qualifica in modo molto chiaro e preciso l’esperienza sociale dell’arte. Il momento in cui infatti nasce l’estetica filosofica è anche quello in cui si delinea in modo definitivo e stabile la figura dell’artista come soggetto in grado di produrre le opere d’arte, quel particolare tipo di oggetti cioè che vengono concepiti sotto la comune categoria della qualità estetica. Tale processo ha inizio a partire dal Rinascimento, mentre precedentemente, nel mondo greco, romano e medievale, l’attività artistica è sempre rimasta, sul piano teorico e sul piano pratico, al di sotto di quel livello di unificazione e specificazione oltre il quale poteva divenire oggetto di una specifica teoria estetica. Ciò tuttavia non significa che le epoche e le civiltà precedenti il Rinascimento non siano state in grado di produrre opere d’arte valide come quelle realizzate negli ultimi quattro secoli; tuttavia la categoria di arte come noi la conosciamo e la pratichiamo oggi era sconosciuta ai greci, ai romani e alla civiltà medievale. Ciò peraltro non rappresenta necessariamente un limite negativo di queste culture: l’estetica più recente si è chiesta infatti se l’arte come attività distinta dalle altre attività dell’uomo non sia il frutto di una specifica forma di “alienazione”, una conseguenza cioè di quel processo di divisione del lavoro che viene visto come motivo di lacerazione dell’integrità dell’esperienza, sia sul piano individuale che su quello sociale.
Accanto al delinearsi in modo chiaro della figura dell’artista, un altro filo conduttore che consente di comprendere le condizioni che rendono possibile l’origine dell’estetica moderna è la nascita del museo: ciò che distingue questa istituzione da tutte quelle create precedentemente per raccogliere le opere d’arte (si vedano, ad esempio, le raccolte principesche) è il fatto che esso opera in base a criteri di scelta che non riflettono più il gusto di un singolo individuo o di un singolo gruppo, ma pretende di operare sulla base di qualità estetiche generalmente riconosciute.
Temi e dualismi dell’estetica
Lo studio dell’estetica, secondo l’analisi compiuta da W. Tatarkiewicz nella sua Storia dell’estetica[1], si sviluppa lungo molteplici direttrici e delinea diverse forme di contrapposizione e di dualismo che sono così schematizzabili:
a) Studio del bello e studio dell’arte
L’estetica è stata tradizionalmente definita come lo studio del bello, ma alcuni estetologi, poiché la nozione di bello appare troppo vaga e indeterminata per poter essere adeguatamente studiata, si sono rivolti all’analisi delle arti, giungendo alla definizione dell’estetica come studio dell’arte. Ognuno di questi due concetti, bello e arte, appartiene ad una sfera diversa. Il bello infatti non è limitato all’arte e l’arte non è in linea assoluta la ricerca del bello; in alcuni momenti storici, come ad esempio nell’antichità, il rapporto fra arte e bello apparve infatti tenue o addirittura inesistente e, sebbene venisse ugualmente approfondito lo studio sia dell’uno che dell’altro aspetto, questi furono trattati separatamente in quanto non appariva alcuna motivazione logica valida per associarli. Lo studioso moderno invece fatica a dissociare il bello dall’arte e ciò perché troppe idee intorno al bello si sono sviluppate dallo studio dell’arte e numerose idee intorno all’arte derivano dallo studio del bello.
Si tratta quindi di due sfere che tendono a convergere e tale tendenza, che rappresenta il primo dualismo evidente nella storia dell’estetica, è caratteristica della storia di questa disciplina: lo studioso potrà pertanto attribuire maggior rilievo al bello o all’arte, ma l’estetica, in quanto disciplina, evidenzia un duplice campo di ricerca in quanto comprende sia lo studio del bello sia quello dell’arte.
b) Estetica oggettivistica e soggettivistica
L’estetica può essere definita come lo studio degli oggetti estetici, ma include anche lo studio delle esperienze estetiche soggettive. Questi due aspetti sono fra loro profondamente interconnessi in quanto l’indagine sul bello oggettivo e sulle opere d’arte conduce inevitabilmente ad affrontare questioni che hanno a che fare con la soggettività: non esiste nulla che non sia stato ritenuto bello da qualcuno e tutto, a seconda dell’atteggiamento estetico che si assume nei confronti delle cose, può essere bello; quindi molti studiosi sono giunti alla conclusione che l’oggetto specifico dell’estetica come disciplina filosofica non sia da individuare nel bello o nell’arte, ma nell’esperienza estetica e nell’atteggiamento estetico assunto nei confronti delle cose.
Appare evidente quindi che lo studio dell’estetica si muove lungo due diverse direttrici e propone quindi un nuovo dualismo: l’uomo ha a che fare con l’estetica in modi diversi, in quanto crea, partecipando come artista, la bellezza e l’opera d’arte, e vive, valuta e critica l’arte stessa, partecipando come fruitore.
c) Estetica psicologica e sociologica
Poiché la partecipazione dell’uomo all’arte avviene sia a livello individuale sia a livello collettivo, l’estetica sarà necessariamente analisi delle reazioni del soggetto di fronte al bello e all’arte, quindi estetica psicologica, e analisi dell’atteggiamento che gruppi più o meno ampi di persone assumono di fronte all’arte, quindi estetica sociologica.
d) Estetica descrittiva e normativa
In molte opere di estetica si trovano descritte le proprietà degli oggetti che consideriamo belli e le reazioni che essi suscitano nel fruitore, in altre invece vengono riportati suggerimenti e indicazioni finalizzati a creare opere d’arte valide e di autentica bellezza. L’estetica quindi può essere descrittiva o normativa: l’estetica francese del Seicento, ad esempio, era prevalentemente normativa, quella inglese del Settecento invece era principalmente descrittiva; le norme e i precetti possono inoltre derivare da analisi descrittive e quindi avere un’origine empirica, ma possono anche derivare da presupposti aprioristici e modelli astratti di gusto prevalenti in un determinato periodo storico.
e) Teoria estetica e prassi estetica
Questo dualismo, che trova il suo corrispondente nella contrapposizione fra teoria e prassi, vede contrapposti da un lato l’enunciazione di principi, funzionali e parte integrante di ogni teoria dell’arte, e dall’altro la definizione di precetti, che servono invece alla prassi concreta dell’arte stessa. La teoria dell’arte si propone quindi di fornire una visione universale dell’arte e del bello, mentre nella prassi artistica concreta l’artista propone o persegue una delle tante possibili concezioni dell’arte.
f) Fatti estetici e spiegazione estetica
L’estetica, come tutte le discipline, cerca di definire le proprietà degli oggetti che studia e si configura quindi come ricerca delle proprietà del bello e dell’arte. Essa cerca inoltre di spiegare queste proprietà, di chiarire cioè le ragioni per cui il bello agisce in un determinato modo e per cui l’arte ha adottato alcune forme invece di altre, e le spiegazioni cui perviene possono essere molto diverse: l’estetica può infatti spiegare l’azione del bello su un piano psicologico o fisiologico oppure spiegare le varie forme artistiche da un punto di vista storico o sociologico.
g) Estetica filosofica ed estetica delle singole arti
Le più famose ed importanti teorie estetiche sono state create da filosofi, come Platone e Aristotele, Hume e Burke, Kant e Hegel, Croce e Dewey, ma numerose sono anche le teorie elaborate da artisti, come Leonardo, o da studiosi di architettura, come Vitruvio. Come si è già visto in precedenza, l’estetica, sia che derivi dalla riflessione di un filosofo sia che nasca dalle considerazioni di un artista, può essere aprioristica o empirica; secondo Tatarkiewicz, nell’estetica filosofica appare una tendenza più netta verso l’apriorismo e, a tale proposito, riporta le considerazioni di Fechner, che contrapponeva l’estetica filosofica, come processo che si sviluppa “dall’alto”, a quella empirica, che procede invece “dal basso”.
h) Estetica delle arti ed estetica della letteratura
L’estetica analizza e studia materiali che provengono da diverse arti, ciascuna delle quali possiede una propria specificità; esiste, a giudizio di Tatarkiewicz, una contrapposizione fra belle arti, che si rivolgono direttamente ai sensi del fruitore, e la poesia, che opera invece mediante segni linguistici; è naturale quindi, che queste pervengano a concezioni estetiche diverse e per certi versi contrapposte, visto che e prime mettono in evidenza le immagini sensibili e le seconde propongono invece simboli intelligibili.
[1] W. Tatarkiewicz, Storia dell’estetica, vol. I, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 1979.
ESTETICA ANTICA

Ciò che è bello, sia un animale sia ogni altra cosa costituita di parti, deve avere non soltanto queste parti ordinate al loro posto, ma anche una grandezza che non sia casuale; il bello infatti sta nella grandezza e nell’ordinata disposizione delle parti (Aristotele, Poetica).
A cura di Roberta Musolesi
Nike di Samotracia
È possibile parlare di estetica antica?
In linea di principio, parlare di estetica antica rappresenta una contraddizione perché l’estetica, come disciplina filosofica, nasce alla fine del Settecento. La disciplina cui, a metà del XVIII secolo, Baumgarten impose il nome di estetica, intendendo con essa la dottrina della conoscenza sensibile e della sua perfetta realizzazione nella bellezza, non ebbe infatti nell’antichità un suo proprio territorio teorico, ma tale mancata autonomia non autorizza comunque ad ignorare gli apporti del pensiero greco e romano alla storia dell’estetica occidentale. E’ quindi corretto affermare che l’indagine estetica ha certamente avuto inizio in Europa oltre 2000 anni prima che fosse trovato per essa un termine specifico e si costituisse un campo di studi autonomo.
Secondo Gianni Carchia[1] inoltre non solo è possibile parlare di estetica antica come riflessione sulla sensibilità, sul bello e sull’arte, ma l’aver isolato un ambito specifico, dal Settecento in poi, non è stato sicuramente un bene. Dal suo punto di vista parlare di estetica antica significa pertanto cercare di comprendere cosa hanno detto sulla sensibilità, sull’arte e sulla bellezza Pitagora, Democrito e Platone, mentre parlare di estetica moderna significa, nella maggior parte dei casi, occuparsi di figure minori o di spazi marginali che le maggiori personalità filosofiche hanno dedicato, per lo più per esigenze di sistema, alle suddette tematiche. Secondo Carchia inoltre le riflessioni estetiche degli antichi non si limitano, come comunemente si pensa, esclusivamente alla poesia, ma coinvolgono l’essere, la fenomenologia e la psicologia.
Dello stesso parere è Giovanni Lombardo[2], anche se con opportune precisazioni. Se è vero infatti che l’antichità classica, che non giunse a sviluppare compiutamente un’idea di autocoscienza, non attinse quasi mai alla dimensione soggettivistica dell’esperienza estetica, è vero anche che su un piano più generale è oggi possibile interpretare alcuni personaggi, ad esempio, del dramma antico come anticipatori della consapevolezza propria del mondo moderno e analogamente alcune teorizzazioni ed acquisizioni del pensiero antico (si vedano, ad esempio, la concezione platonica del bello o quella aristotelica dell’opera letteraria) sembrano precorrere sensibilità sicuramente molto vicine al nostro tempo. Fra estetica antica e moderna esistono tuttavia, dal punto di vista dell’autore, alcune importanti e fondamentali distinzioni e differenze: l’estetica moderna è abituata a cercare la bellezza soprattutto nell’opera d’arte, che viene ammirata in quanto rappresentazione di un significato indipendente da qualsiasi vincolo utilitaristico o morale, l’estetica antica inserisce invece l’arte fra le competenze tecniche ed artigianali, i cui prodotti sono destinati ad una fruizione prevalentemente pubblica entro spazi istituzionali come feste, simposi e riti religiosi.
Di opinione contraria a quella di Carchia e Lombardo è invece Sergio Givone, secondo il quale parlare di estetica riferendosi alla riflessione classica, e greca in particolare, sul bello e sull’arte appare problematico non solo perché per i Greci l’arte aveva a che fare con l’intelletto e non con la sensibilità, cui invece il termine moderno di estetica rimanda, ma anche perchè gli stessi concetti di arte e di bello che noi impieghiamo non sono semanticamente equivalenti ai corrispondenti termini della lingua greca.
Arte e bellezza
Anche se quanto appena esposto, come vedremo in seguito, corrisponde a verità, è comunque possibile affermare con certezza che, già nel periodo cosiddetto arcaico, che va da VI secolo a. C. all’inizio del V secolo, i Greci, che già possedevano una grande arte, avevano sviluppato anche una loro concezione precisa del bello e dell’arte stessa, che non misero per iscritto, ma che può essere ricostruita a partire dalla prassi artistica concreta.
I Greci, come iniziatori di questa inedita forma di riflessione, dovettero pertanto inventare un linguaggio per poter parlare dell’arte da loro stessi inventata e definire dei concetti che anche noi oggi utilizziamo, anche se con un significato diverso.
Il bello
Il primo di questi concetti fondamentali è appunto il concetto di bello.
La parola kalón, che noi traduciamo con “bello”, aveva in realtà un significato più ampio rispetto a quello attuale: comprendeva non solo ciò che risultava gradito all’occhio e all’orecchio, ma anche qualità del carattere e della mente umana. Gli antichi mantengono inoltre separate la sfera del bello e la sfera dell’arte e conferiscono alla bellezza un fondamento ontologico, per ricercarne conseguentemente le manifestazioni nella natura e, in particolare, nel corpo dell’uomo, il più nobile e alto fra gli esseri naturali. Proprio per questo primato, l’uomo è in grado di esprimere la sua bellezza, oltre che nella proporzione delle forme fisiche, anche nella dignità dei comportamenti pratici: da qui deriva il forte legame fra bello e buono, che nella Grecia classica trova la sua espressione suprema nell’ideale formativo della kalokagathía, la condizione propria cioè di chi sa di potersi dimostrare, nello stesso tempo, bello e buono. Buono, agathós, rappresenta l’aspetto morale, unito alle sfumature sociale e mondana che provengono dalle origini, bello, kalós, è la bellezza fisica, con l’inevitabile aura erotica e sensuale che l’accompagna. Già da solo, tuttavia, l’aggettivo kalós è in grado di qualificare, insieme alla bellezza fisica, anche quella morale, così come nell’aggettivo latino bellus, da cui deriva l’italiano bello, si rileva un diminutivo di bonus (dwenos → dwenolos → benlos)
Quello di “bello” era quindi un concetto dal significato molto complesso e ricco, cui i Greci ricondussero schematicamente:
1. l’armonia, rilevabile nell’equilibrio cosmico;
2. la simmetria, cioè misura appropriata;
3. l’euritmia, cioè ritmo esatto e dalle corrette proporzioni.
Tutto ciò è riassumibile nel concetto di kósmos, che si riferisce alla bellezza di un oggetto dovuta alla perfezione della sua struttura in ragione della proporzione della sue parti. Fin dall’età arcaica l’opera d’arte viene infatti concepita come un insieme composito di elementi che rappresentano la copia e la riproduzione di un ordine esterno all’opera stessa e che, in virtù del loro trattamento rappresentativo, generano piacere e ammirazione. Nel campo delle arti verbali, come riferisce lo stesso Omero, il concetto di kósmos si collega all’armonia e alla coerenza: di un cantore si può dire che esegua un canto secondo i canoni della bellezza se procede katá kósmon, secondo un bell’ordine, riproponendo cioè in una coerente struttura verbale la successione reale degli eventi. Nella lirica arcaica il testo poetico viene inteso come un kósmos epéōn, cioè un bell’ordine di parole.
Il processo compositivo del kósmos è attivato, a sua volta, dall’impulso a riprodurre che, secondo Aristotele, caratterizza l’uomo in quanto essere rivolto e orientato verso la conoscenza. Tale impulso riproduttivo viene definito dallo Stagirita come mímēsis, il processo imitativo cioè che può riferirsi non solo ai procedimenti della poesia, delle arti figurative e della musica, ma anche della voce e della recitazione, fino ad arrivare ad accezioni più filosofiche, come l’assunzione di comportamenti ritenuti esemplari, il legame fra i nomi e le cose, il rapporto fra l’essere e il divenire fino ad arrivare addirittura alla contemplazione delle forme ideali. Il concetto di mímēsis apparve assai presto e persistette a lungo nella cultura e nell’arte della Grecia classica; prima di assumere il succitato significato di riproduzione della realtà con le sue molteplici sfumature, si riferiva originariamente alla danza e aveva un significato del tutto diverso, in quanto stava ad indicare l’espressione dei sentimenti e la manifestazione dell’esperienza attraverso il movimento, il suono e le parole. Tale concetto comparve per la prima volta in connessione con il culto di Dioniso e le danze rituali dei sacerdoti; in Pindaro, infatti, la parola mímēsis sta a significare una danza nel senso antico del termine, intesa cioè come danza non imitativa, ma espressiva, tesa cioè ad esprimere sentimenti piuttosto che a imitarli.
L’arte
Per quanto concerne l’altro concetto fondamentale, quello di arte, i Greci si riferivano ad essa mediante il termine téchnē, in cui veniva fatto rientrare ogni prodotto dell’abilità tecnica, dal lavoro manuale dei tessitori, dei calzolai (l’arte di fare le scarpe) e dei tessitori a quello degli architetti. Rappresentare la realtà significa, anche ai livelli più elementari e soprattutto alle origini dell’antichità classica, filtrarla attraverso un meccanismo selettivo tale da estrapolare gli elementi maggiormente significativi per ricomporli in un nuovo ordine; l’artista, in definitiva, secondo la prospettiva classica, opera alla stregua di un fabbricatore, di un poiētēs, che mediante una tecnica ed una particolare abilità riproduttiva, mette assieme un kósmos artificiale analogo e per certi versi simile al kósmos reale. Come affermava anche Democrito, il kósmos artistico presuppone l’atto del costruire, del tektáinesthai, espressione verbale che è vicina, con la radice tek-, congiungere, al termine greco téchnē. La costruzione di un kósmos riesce inoltre tanto più bella ed attraente quanto più in essa ciò che è stato imitato risplende agli occhi con la luce che gli è propria. L’artista infatti ottiene successo anche in funzione della sua capacità di trasformare i propri mezzi espressivi rendendoli adeguati alla situazione che essi devono rappresentare e alle circostanze cui essi, davanti all’opera finita, vengono recepiti; in definitiva la sua attività, sia nel momento della produzione che in quello della fruizione, è connessa e si innesta sempre in un preciso kairós, cioè in una giusta occasione: ciò che l’artista riesce a ritagliare dalla realtà deve poi essere opportunamente innestato ed adattato nelle reazioni dei fruitori, che devono cogliere il piacere estetico dato dall’identità fra l’opera e la realtà in essa rappresentata.
Il termine téchnē fa quindi riferimento:
1. all’attività umana in quanto opposta alla spontaneità della natura;
2. all’aspetto della produzione manuale, visto in alternativa a quello dell’attività conoscitiva;
3. alla relazione con l’abilità e non con l’ispirazione;
4. alla presenza di norme operative generali e non di semplice abitudine ed ammaestramento meccanico.
L’aspetto dell’abilità era ritenuto essenziale, ragione per cui l’arte era considerata un’attività dell’ingegno, e fondamentali erano considerate anche le conoscenze che l’esercizio dell’arte stessa richiedeva. Per i Greci, inoltre, quelle che più tardi coincisero con le “belle arti” non erano distinte dalle arti manuali e qualunque artigiano, dēmiourgós, a qualunque arte si dedicasse, poteva raggiungere la perfezione e diventare un maestro, architéktōn.
L’atteggiamento dei Greci verso coloro che esercitavano le arti era inoltre caratterizzato da una marcata ambivalenza: da un lato essi erano stimati per le conoscenze che possedevano, ma dall’altro erano disprezzati per il fatto di esercitare un’attività manuale dalla quale ricavavano i mezzi per il loro sostentamento. Anche la divisione delle arti risentiva, in un certo senso, di questa visione preconcetta. Ad un livello superiore, infatti, erano collocate le arti libere, quelle cioè che non richiedevano fatica e sforzo fisico, dall’altro stavano le arti servili, che richiedevano, al contrario, impegno fisico ed attività manuale; tanto per fare un esempio, la musica era considerata arte libera, mentre la scultura e anche la pittura erano considerate arti servili. La separazione fra arti libere e arti servili rifletteva quindi una cultura per la quale il lavoro manuale aveva in sé qualcosa di poco nobile. La stessa condizione degli artisti, non solo di quelli che praticavano le arti servili, ma anche dei musici, degli attori e dei ballerini, rifletteva chiaramente questo pregiudizio, cui nei fatti se ne aggiungevano altri: gli attori, che pure non praticavano un’arte servile, sono stati oggetto, da allora fino all’età moderna, di duri giudizi di condanna per lo stile di vita fuori dai canoni della normalità che a causa della loro professione conducevano.
La poesia
I Greci non classificavano la poesia fra le arti: l’arte era un’attività che, in virtù di specifiche abilità e seguendo precise regole, portava alla produzione di oggetti materiali, mentre la poesia era considerata frutto dell’ispirazione. In definitiva, nell’arte, l’intervento dell’abilità tecnica impediva di avvertire il coinvolgimento dell’ispirazione, mentre nella poesia accadeva esattamente il contrario e per questo non si vedeva alcun possibile rapporto fra le due. La poesia pertanto, per queste ragioni, venne accostata alla divinazione e i poeti furono classificati come indovini, in quanto si riteneva che potessero portare a termine la loro opera solo grazie all’ispirazione concessa dalle potenze celesti. Ciò contribuì a confermare la forza seduttiva della poesia e la circondò di un alone magico. Se non fu possibile infatti per i Greci cogliere il legame fra poesia e arte, fu invece immediata la connessione fra poesia, musica e canto, che fu a tal punto accentuata da giungere a ritenerle unite ed appartenenti alla stessa sfera creativa. Tale affinità era motivata in primo luogo dal fatto che la poesia veniva normalmente recitata insieme ad un accompagnamento musicale, ed era quindi percepita acusticamente come musica, e secondariamente perché entrambe erano in grado di produrre nel fruitore uno stato di esaltazione. Il canto nelle epoche più antiche era interpretato come un dono soprannaturale in grado di generare l’entousiasmos, in grado cioè di dilettare e affascinare gli ascoltatori. Lo stesso termine estetica, che prende le sue origini dal termine greco áisthēsis, fa riferimento non solo alla percezione sensoriale nel suo complesso, ma anche, in particolare, alla percezione per mezzo dell’orecchio, implicita nel verbo aiō: l’ascolto dell’esecuzione di un aedo si riteneva potesse comportare l’attivazione di un’esperienza estetica portata avanti in virtù dell’ispirazione del poeta, in grado di rafforzare i poteri visualizzanti della sua arte, poteri che, sul piano tecnico, si esplicavano attraverso i procedimenti dell’enárgeia e coinvolgevano immediatamente l’uditorio negli eventi evocati dal canto. Pertanto, proprio nel momento in cui gli spettatori potevano cogliere l’affinità fra il corso delle parole e il corso delle cose, provavano le medesime emozioni che avrebbero provato se gli avvenimenti presentati dal canto si fossero svolti davanti a loro.
Importante e significativo è inoltre il legame esistente fra poesia e filosofia. Prima di scendere nel dettaglio delle riflessioni filosofiche sull’arte sviluppate dai singoli artisti o dai vari pensatori, è possibile anticipare che è Omero, con la distinzione fra poetica della verità, esemplificata da Demodoco, e poetica della finzione, esemplificata dalle sirene, a dare l’avvio alla contrapposizione fra pensiero filosofico e poesia che segnerà tutto il dibattito letterario fra il VII e IV secolo a.C. In seguito Esiodo, polemico nei confronti dei racconti di finzione e delle favole dell’epos, si proclama depositario di un messaggio di verità che presenta come trasmesso direttamente dalle Muse; Parmenide, invece, operando una distinzione fra l’ambito della verità e quello del non essere e dell’opinione e individuando nei discorsi propri della doxa, cioè dell’opinione, un ordine ingannevole, giunge a denunciare la fallacia di ogni rappresentazione costruita per mezzo della poesia e, a suo avviso, il “bell’ordine delle parole”, tramite espressivo della doxa, è portatore di un messaggio inaffidabile. Platone, erede della metafisica parmenidea e difensore strenuo del primato della componente razionale dell’anima protesa verso l’apprensione delle idee, porta alle estreme conseguenze la separazione fra poesia e filosofia. L’arte in generale, e la poesia in particolare, si riferiscono infatti, dal suo punto di vista, al mondo delle apparenze e delle sensazioni e sono per questo molto lontane dall’eterno splendore del mondo delle idee; queste quindi, in quanto riproducono l’intricata e contorta molteplicità del divenire, restano limitate al gradino più basso della scala verso la verità e, poichè sollecitano emozioni, sono ritenute da Platone attività che offuscano lo sviluppo e l’ascesa della ragione. Aristotele rovescia invece la prospettiva platonica affermando che la poesia, in quanto mímēsis práxeōs, cioè rispecchiamento di un’azione reale o possibile, svolge una fondamentale funzione conoscitiva. Poichè infatti può riprodurre ciò che accade ed anticipare, secondo le regole della verosimiglianza o del principio causa-effetto, ciò che potrebbe accadere, la poesia risulta più vicina alla filosofia di quanto, ad esempio, non possa essere la storia: la poesia, ponendo ordine nel caos dell’esperienza e nel tumulto delle passioni, che vengono così organizzati in una sintesi coerente, è in grado di rendere comprensibili gli eventi spesso confusi e contraddittori della vita reale. I fatti, che rimangono comunque imprevedibili, con la poesia verrebbero quindi proposti, secondo lo Stagirita, secondo un preciso ordine formale ed essa si presenta pertanto certamente come un inganno, ma solo apparente, un inganno cioè che viene comunque sostenuto e convalidato dalla precisione e dalla coerenza della rappresentazione. Secondo Aristotele la poesia appare così come un “ordine disordinato”, un ordine cioè che riespone, senza cancellarlo od annullarlo, l’inestricabile disordine delle passioni.
Le strade tracciate da Platone e da Aristotele si perpetueranno in seguito nella contrapposizione fra due possibili funzioni della poesia, quella moralistica del prodesse e quella edonistica del delectare, ma la ricerca aristotelica sulla conoscenza mediante la mímēsis sarà all’origine, in età ellenistica, di una nuova sensibilità nei confronti del testo, sia dal punto di vista filologico sia sul piano dello stile.
Gli Stoici, che riprenderanno, in chiave puramente individualistica, le idee platoniche ed aristoteliche relative ai processi psicologici legati alla visualizzazione mentale, svilupperanno un’idea della creatività estremamente moderna, in quanto ritenuta frutto dell’espressione dell’immaginazione personale dell’artista. Questa idea si ritroverà anche in Cicerone e verrà elaborata poi da Plotino in un senso che la spingerà oltre il mondo classico. Dalla concezione plotiniana del bello come traguardo del viaggio spirituale verso l’assoluto discenderà infatti, per mezzo di Agostino, l’estetica cristiana del Medioevo.
[1] Gianni Carchia, L’estetica antica, Laterza, Roma-Bari, 1999.
[2] Giovanni Lombardo, L’estetica antica, Il Mulino, Bologna, 2002.
ESTETICA IN OMERO

Un dio donò il canto a darci diletto. (Omero)
A cura di Roberta Musolesi
Omero
I poeti antichi svilupparono le loro riflessioni teoriche all’interno delle loro opere di poesia. Essi infatti, scrivendo e parlando delle cose più svariate, parlarono spesso di arte in generale e di poesia in particolare, ponendo interrogativi che poi sarebbero divenuti essenziali per l’estetica delle epoche successive:
– quali sono le origini della poesia?
– quali sono i suoi fini?
– in che modo essa agisce sull’uomo?
– qual è il suo oggetto?
– è vero ciò che essa dice?
Estetica e filosofia nelle opere di Omero
Introduzione
Risalire agli albori del pensiero greco significa riscoprire tutti quegli aspetti, anche avvolti di mistero, che precedettero la fase, ormai storica, in cui le domande e gli interrogativi iniziarono ad assumere una valenza chiaramente filosofica. La linea di separazione fra questa tradizione e la filosofia è rappresentata anche dalla creazione di generi letterari nuovi ed alternativi, che solo occasionalmente faranno uso del linguaggio poetico e con fini del tutto differenti rispetto al retroterra culturale della grecità più remota. Il testo filosofico, come genere letterario a sé, si darà infatti prevalentemente obiettivi di carattere conoscitivo, nel tentativo di esplorare il problema dell’origine della realtà che tanto appassionò i primi filosofi.
Già però con l’epos greco e con Omero quale presunto (e forse mai esistito) autore dell’Iliade e dell’Odissea, è presente una rilevante anticipazione di contenuti definibili a vario titolo come filosofici, come, ad esempio, il ruolo didattico del dialogo interpersonale e della dialettica, che è ravvisabile nella stessa struttura del discorso narrativo omerico e che sarà proprio del pensiero greco più maturo.
La filosofia, quindi, che volle muovere i primi passi verso il superamento della tradizione precedente legata al mito, trovò un punto di riferimento “forte” proprio nell’epos omerico: i poemi omerici, che presentavano modelli di vita e pensiero paradigmatici, sebbene immersi nell’aura della tensione fantastica, svolsero un ruolo di fondamentale importanza nel dare le coordinate concettuali propedeutiche alla nascita della filosofia. Queste idee, che si mostreranno produttive, in particolare, nell’ambito della metafisica, sia di quella dei filosofi della Ionia, più “debole” per contenuti, sia di quella più complessa ed articolata di Platone ed Aristotele, trovano la loro origine, da un punto di vista prefilosofico, nella volontà di Omero di ricercare ed offrire una giustificazione valida alla molteplicità di eventi che si sviluppano nel corso della narrazione e quindi nella ricerca delle cause recondite che rendono possibile e spiegano una determinata situazione. Le vicissitudini e le storie che Iliade e Odissea rappresentano appaiono sempre governate da un meccanismo razionale, malgrado l’apparente inattendibilità e a volte l’incoerenza dell’intreccio narrativo; i vari accadimenti presentati nei testi omerici non sono mai pertanto casuali, ma emerge, al contrario, una sorta di superiore regia che guida gli eventi e che garantisce uno sviluppo coerente della storia e dei vari temi-guida. Per queste ragioni, la poesia omerica consente di parlare, oltre che di filosofia implicita, anche di ermeneutica delle origini. Questo termine, a sua volta collegato al nome del messaggero degli Dei dell’Olimpo, Hermes, deriva da “hermeneia” cioè “espressione, interpretazione”, e si presenta come un tipo di pensiero importantissimo, soprattutto per via della tradizione ad esso collegata e dei suoi futuri sviluppi.
Nell’Inno ad Hermes, attribuito tradizionalmente all’autore dell’Iliade e dell’Odissea, si celebra appunto questa divinità dell’intermediazione, protettrice dei poeti e messaggero dell’Olimpo, rappresentata iconograficamente come un dio-fanciullo, dalla mente sottile e ispiratore di sogni, guardiano delle porte e suonatore della lira, tutti caratteri che, insieme alla vocazione per il furto (Hermes rubò le vacche di Apollo già il primo giorno di vita) saranno tipici di questo dio eternamente giovane, custode dei segreti del linguaggio e della verità.
L’Inno ad Hermes di Omero segna pertanto la nascita della filosofia e, in particolare, di quella branca, l’ermeneutica, che diverrà uno strumento indispensabile per decriptare e comprendere scritti e discorsi.
· Alcune considerazioni sui canali di trasmissione e diffusione del sapere nella Grecia arcaica: oralità e scrittura
La cultura greca arcaica si trasmetteva essenzialmente attraverso due principali canali di comunicazione: la pratica della scrittura e la tradizione orale.
La scrittura fu una tecnica utilizzata in origine per scopi pratici, come la registrazione di liste di cariche ufficiali, la conservazione delle leggi, testamenti, commemorazioni di eventi politici o sociali, messaggi e dediche.
La scrittura, tuttavia, non costituiva il mezzo più adatto per trasmettere il sapere tradizionale e ciò principalmente a causa della difficile reperibilità e dei notevoli costi del materiale scrittorio. La società greca inoltre considerava l’immutabilità delle azioni, dei riti religiosi e dei costumi etici l’elemento fondante della sua stessa identità e tale immutabilità era garantita dal rito e dal mito, che prevedevano forme di comunicazione orale: il rito consisteva in una sequenza di atti fissati da canoni tramandati di generazione in generazione e compiuti in tempi e luoghi stabiliti, il mito era il racconto che rintracciava e fissava le origini della società in una prospettiva magica, soprannaturale, religiosa. Questi due elementi del patrimonio culturale greco erano trasmessi e diffusi da indovini e poeti, da coloro cioè che avevano ricevuto dalle Muse il dono della memoria.
I poeti trasmettevano l’insieme delle conoscenze ancestrali del popolo greco adeguandole alle esigenze culturali del loro tempo e la loro abilità consisteva anche nel non rendere troppo manifeste al pubblico le inevitabili innovazioni ideologiche e stilistiche che essi dovevano necessariamente introdurre. Da tale contesto deriva così uno degli aspetti fondamentali dell’estetica e della poetica della Grecia delle origini, il ripetere rinnovando e innovando. La scrittura invece tendeva già a fissare i testi in una forma definitiva e non sembrava in grado di garantire alcuna possibilità di innovazione ed evoluzione del testo poetico, che subiva invece frequenti modificazioni nel corso della presentazione e della declamazione al pubblico, in virtù della capacità dei singoli poeti di trarre spunto da modelli lirici noti per creare delle variazioni.
Il patrimonio della lirica greca arcaica cominciò ad essere messo per iscritto in modo sistematico solo nell’epoca ellenistica, quando si avvertì il rischio di perdere le opere più importanti, e solo in quel momento nacquero l’editoria e il mercato librario.
Rispetto alla questione dell’oralità dei poemi omerici appaiono necessarie alcune precisazioni. E’ infatti importante tentare di comprendere come essi venissero effettivamente composti, se cioè per mezzo di un procedimento che comunque implicava anche la scrittura o se invece mediante processi che prescindevano dalla scrittura stessa; secondariamente è essenziale chiarire un equivoco di fondo e cioè che l’idea di una composizione orale non deve essere associata, come normalmente avviene, all’idea di una composizione molto rapida, con coincidenza cioè fra tempo della composizione e tempo dell’esecuzione e della produzione; tale modo di pensare appare in effetti poco produttivo poiché conduce a considerare i poemi omerici come qualcosa di diverso da un’opera letteraria.
Per l’interpretazione e l’analisi critica dell’oralità esistono vari modelli, molti dei quali tuttavia non appaiono applicabili ai poemi omerici. Uno di questi modelli, quello elaborato da R. Finnegan in Oral Composition and Oral Literature in the Pacific, è stato elaborato per le pratiche poetiche del Pacifico, dove si praticano canti in funzione della danza, dove la composizione può essere collettiva e dove nell’elaborazione possono intervenire degli assistenti ai quali può toccare il compito della memorizzazione, tutti elementi che non appartengono alla natura dei poemi omerici. L’estensione inoltre delle due opere omeriche è tale da non rendere plausibile l’ipotesi che ciascuna di queste fosse associabile ad una sola ed unica performance e ciò sarebbe dimostrato dai numerosi collegamenti e dalle molteplici rispondenze evidenti in vari punti di ogni poema, che proverebbero invece l’ipotesi di performance relative anche a singole parti.
Altra prospettiva interpretativa è quella di B. Gentili, che in Poesia e pubblico nella Grecia antica confronta la pratica aedica arcaica con l’esperienza dei poeti improvvisatori italiani attivi nel XVIII secolo. La forte emotività che caratterizza queste recitazioni estemporanee e che si esprime, ad esempio, con il volto assorto e distaccato, lo sguardo rivolto verso l’alto, gli occhi che si accendono, lo sguardo torvo, i capelli arruffati, non trova tuttavia alcun riscontro negli atteggiamenti propri degli aedi dell’Odissea, in cui non appare alcun accenno a forme di agitazione emotiva durante l’esecuzione dei canti. Il tipo di performance proprio degli improvvisatori italiani, che appare assimilabile in tutto e per tutto alla mania, non ha pertanto nulla a che vedere con la poesia omerica. Altro aspetto messo in luce da Gentili è la possibilità che frammenti del repertorio epico, utilizzati dagli aedi per ricordare meglio gli elementi principali del racconto o per dare inizio o fine al libro, potessero essere affidati alla scrittura, ma nega in seguito che i poemi omerici potessero essere scritti per intero e ciò sulla base della difficoltà nel reperimento del materiale scrittorio, rappresentato prevalentemente da pezzi di cuoio. Malgrado il supporto materiale fosse poco adatto alla scrittura e di difficile reperibilità, ciò non rappresenta tuttavia un motivo per ritenere con certezza che le parti scritte fossero limitate a brevi frammenti, poiché nulla vieta di pensare che gli stessi supporti potessero essere utilizzati per frammenti più grandi.
Altro dato evidenziato da Gentili è la constatazione, all’interno dei poemi omerici, di parti intercambiabili e spostabili a piacimento, quindi utilizzate presumibilmente in modo meccanico, cui però si contrappone la constatazione della profonda coerenza strutturale che caratterizza i testi omerici, attestata, ad esempio, da un uso altamente consapevole della tecnica delle corrispondenze. L’ipotesi però della creazione ad opera di un aedo geniale è in contrasto con l’ipotesi della ripetizione meccanica di parti, così come appare poco compatibile l’ipotesi della intercambiabilità di frammenti a fronte della comprovata coerenza testuale.
L. E. Rossi, sulla scia di Havelock, nel suo I poemi omerici come testimonianza di poesia orale, prende in esame alcuni indizi che, a suo avviso, attesterebbero l’origine prevalentemente orale dei poemi omerici.
Il primo indizio che l’autore individua è l’anacronismo, la presenza cioè nel singolo poema di elementi culturali relativi a differenti momenti cronologici; questo aspetto tuttavia appare più la conseguenza del particolare modo di porsi del poeta di fronte alla tradizione piuttosto che del mezzo, oralità o scrittura, impiegato per produrre le opere.
Altro indizio presentato da Rossi a favore dell’oralità è la presenza nei poemi di incongruenze narrative, più frequenti e probabili, a suo avviso, quando si compone oralmente. Un esempio è individuato nel personaggio di Pulaimenes, che nel V libro viene ucciso e nel XIII libro viene invece dato come vivo. Tali incongruenze, definite da Rossi come “scandali analitici”, possono in effetti verificarsi nel caso di poemi molto lunghi e ciò indipendentemente dal processo e dai mezzi coinvolti nella creazione; anche nell’Orlando Furioso, malgrado Ariosto facesse sicuramente uso della scrittura, il personaggio di Agricalte prima viene ucciso ed poi in seguito risulta essere vivo.
· Iliade ed Odissea: i contenuti filosofici
In tutto Omero compare una costante ricerca intorno alla natura umana e alle leggi eterne che governano il corso del mondo.
Nel mondo omerico regna una perfetta armonia della natura e della vita umana; ovunque appare un flusso di vita guidato e regolato da un ritmo unificatore, non compare mai caos né Omero si abbandona mai all’esperienza caotica della vita. Omero conosce e coglie le passioni umane e ne rappresenta magistralmente l’impeto, ma mostra anche che, quando tale corrente tende a straripare, è sempre possibile trattenerla entro solidi argini.
I limiti etici sono per Omero e per tutti i Greci supreme leggi dell’essere e non semplici convenzioni; la coscienza dell’obbligo della legge morale, che rappresenta l’aspetto soggettivo della moralità, è il riflesso dell’eticità del reale, che viene messa in luce non solo dall’epica, ma anche dalla riflessione filosofica più tarda (si vedano, ad esempio, il concetto di dike in Solone e nella filosofia naturale di Anassimandro, la morale dei sofisti e la sua relazione con la legge della natura e l’armonia di Sofocle). A tutto ciò si ricollega il gusto di Omero per la ricerca della motivazione: egli non propone mai una semplice narrazione di fatti, ma solo sviluppo, secondo la legge causa-effetto, dell’azione di fase in fase e svolgimento della drammaticità del racconto in modo perfettamente coerente. L’azione quindi non si distende con una fiacca e banale successione temporale, ma in ogni istante viene fatto valere il principio di ragion sufficiente ed ogni evento appare organicamente legato agli altri.
Omero tuttavia non è un autore moderno, per cui possa valere cioè solo lo svolgimento interiore dei fatti, e nel mondo in cui egli vive nulla può accadere senza l’intervento di una potenza divina. Omero quindi non parla dei moti interiori dei suoi personaggi dal punto di vista di chi può averli provati direttamente, ma individua, coglie ed esprime costantemente i nessi fra umano e divino. E’ vero che l’intervento del divino costituisce per il poeta anche un artificio poetico, ma non appare mai esclusivamente strumentale. Dall’analisi delle modalità con cui viene descritto l’intervento degli dei nelle epopee omeriche, si avverte infatti in modo molto chiaro che non si tratta di un intervento puramente esteriore, come poteva essere quello del più antico stile epico, ma di un vero e proprio potere di indirizzo della vita delle singole persone da parte del divino. E’ vero che, in modo analogo a quanto appare evidente nel pensiero religioso e politico dell’antico Oriente, anche per i Greci gli dei si contrappongono e puntano ciascuno a perseguire il proprio interesse personale, ma nell’Iliade e nell’Odissea appaiono tratti e caratteri più moderni, come la volontà di salvaguardare, al di sopra delle discordie, la lealtà che esiste fra le varie divinità, l’unità del loro operare e la stabilità del loro regno divino. Accanto al rilievo dato al divino, viene valorizzata, nella considerazione e nella valutazione degli eventi, anche la prospettiva psicologica. Appare chiaro al lettore che le vicende umane sono determinate necessariamente da imperscrutabili leggi sovrumane, ma emerge anche che tali leggi divine si intrecciano inevitabilmente con le azioni e le sofferenze dell’uomo, intreccio che costringe il poeta a vedere l’azione dell’uomo non nella sua particolarità e contingenza, ma nel suo valore assoluto e ad inquadrarla nell’ambito della concatenazione universale degli eventi.
L’epos omerico presenta quindi, come elemento di grande novità rispetto alla cosmologia teomorfa dell’Oriente, un chiaro atteggiamento antropocentrico, che appare però meno evidente nell’Iliade rispetto all’Odissea, opera questa prodotta in un momento storico in cui il pensiero mostrava già un elevato grado di sistematicità e di ordine razionale. Diverso è fra le due opere l’atteggiamento stesso delle divinità: nell’Iliade, sebbene compaiano già i segni di un pensiero morale orientato a conciliare l’azione reciproca delle varie divinità ed una visione del mondo di carattere essenzialmente razionale, appaiono tuttavia ancora scene molto tumultuose, in cui gli dei rischiano spesso di venire alle mani e in cui emerge l’immagine di uno Zeus che impone la sua sovranità con le minacce, nell’Odissea invece appare una maggiore coerenza e finalità nell’azione delle divinità e lo Zeus che presiede il consiglio degli dei si configura come coscienza universale filosoficamente purificata. L’immagine che nell’Odissea si ha quindi di Zeus è quella di una potenza onnisciente, superiore ad ogni pensiero e ad ogni azione dei mortali ed è nella sua essenza spirito e pensiero.
· Iliade ed Odissea: alcune considerazioni etiche, sociologiche e pedagogiche
Iliade ed Odissea rappresentano, come già sottolineato, fonti storiche di primaria importanza per la conoscenza della cultura greca arcaica. Queste opere vengono normalmente riferite ad Omero, ma è importante precisare che, malgrado questa comune paternità, esse non possono essere considerate con assoluta certezza come un’unità né come se fossero invenzione di un unico poeta.
Delle due opere, l’Iliade appare, per struttura e temi affrontati, come il poema più antico, mentre l’Odissea riflette sicuramente uno stadio più recente della civiltà, ma sebbene la prima dia l’impressione di una maggiore antichità rispetto alla seconda, non è detto che la sua produzione concreta sia da collocarsi molto lontano da quella dell’Odissea.
L’Iliade mostra l’assoluta prevalenza dello stato di guerra, quale doveva essere la condizione delle genti greche nell’età delle migrazioni, ed in essa si fondono l’immagine, tramandata dal canto, degli antichi eroi leggendari e le tradizioni dell’aristocrazia. Il valoroso, nell’Iliade, è sempre l’aristocratico, l’uomo di classe sociale elevata, e combattimento e vittoria rappresentano elementi di suprema distinzione e costituiscono la vera sostanza della sua vita. I temi dell’Iliade mostrano quindi l’aspetto guerriero dell’esistenza e gli eroi, pur nel loro contegno aristocratico, hanno come loro luogo naturale il campo di battaglia e solo raramente vengono raffigurati o descritti nelle pause fra un conflitto e l’altro.
Nell’Odissea la scena cambia completamente. Il motivo del ritorno degli eroi, infatti, crea le condizioni per la rappresentazione e la descrizione della loro esistenza in tempo di pace. L’Odissea, che propone immagini estremamente realistiche degli ambienti, rappresenta pertanto la fonte principale per conoscere lo stile di vita dell’antica aristocrazia. L’aristocrazia dell’Odissea è una classe sociale che appare fortemente consapevole del proprio privilegio, della propria maggior finezza di costumi e di stile di vita; le sue condizioni di vita sono caratterizzate dalla sedentarietà, elemento questo che rende possibile la trasmissione dello stile di vita dagli anziani ai fanciulli e l’organizzazione di una scuola: elementi peculiari della cultura aristocratica, così come viene rappresentata dall’Odissea, sono il saper provvedere alla formazione della personalità umana, mediante continui ammaestramenti, e la trasformazione dell’educazione in formazione sistematica della personalità secondo un modello definito.
A differenza quindi dell’Iliade, in cui vengono rappresentate figure caratterizzate da grandi passioni e da destini tragici, nel poema più recente compaiono personaggi dalle connotazioni più umane. La misura del pregio di ogni personalità è certamente ancora il valore guerriero, ma ad esso si aggiunge tuttavia anche l’apprezzamento dei meriti intellettuali e sociali: l’eroe è colui che non è mai privo di buoni consigli, che in ogni circostanza sa trovare le parole giuste e che, oltre alle virtù guerriere, mostra astuzia, capacità inventiva e spirito pratico, grazie a cui finisce per trionfare sempre sui nemici potenti e su pericoli insidiosi.
Le opere di Omero pertanto, come ebbe modo di affermare anche lo stesso Platone, non venivano lette solo per il piacere artistico che erano in grado di provocare, ma anche gli esempi di vita che presentavano. Nel pensiero greco dell’età arcaica l’elemento estetico non è infatti ancora separato da quello etico e tale fusione non è puramente accidentale, ma, al contrario, il contenuto normativo e la forma artistica dell’opera d’arte stanno in una relazione di reciprocità e hanno in comune la loro intima radice. La poesia della Grecia classica non fornisce quindi solamente la rappresentazione di frammenti e scorci della realtà, ma sceglie accuratamente questi aspetti, cerca di renderli nella forma artistica migliore e più efficace e li pone poi in relazione ad un determinato ideale o modello da trasmettere. Le innumerevoli scene di combattimento, ad esempio, collegate fra loro in forma unitaria, non hanno solo lo scopo di presentare quadri particolari di avvenimenti noti, ma anche quello di mettere in risalto la virtù morale degli eroi famosi, fra i quali spicca Achille, monumento immortale di esperienza umana e di dolorosa grandezza. Con il termine aristia si indica proprio la descrizione delle gesta e del valore di un eroe, di cui vengono celebrati i tratti quasi sovrumani e comunque ritenuti eccellenti da un punto di vista etico. Le soluzioni stilistiche e narrative adottate per raggiungere questi obiettivi sono le seguenti:
a) “ritardare” o escludere l’intervento delle divinità, di Zeus in particolare, nelle vicende della guerra, in modo tale da creare lo spazio per il libero dispiegamento delle possibilità dei singoli guerrieri, quindi di uomini;
b) inventare episodi e creare circostanze, come l’episodio della seduzione di Zeus da parte di Hera, che consentano di lasciare campo libero all’intervento dell’uomo;
c) introdurre gli exploits di singoli guerrieri, quindi proporre delle aristie “minori”, per interrompere ed intercalare le sequenze vittoriose delle aristie principali, quella di Ettore e di Achille, e per proporre nello stesso tempo diversi modelli umani.
Accanto poi alla presentazione di modelli etici, fin dalle battute iniziali dei due poemi appare evidente il rilievo che l’autore intende dare ad un dato ideologico fondamentale, e cioè che, al di là della guerra, che rappresenta la struttura portante dell’opera, l’elemento che accomuna il genere umano nel suo complesso è l’ineludibilità della morte. Le “forti anime di eroi” sono quelle dei Greci e dei Troiani, che appaiono legati da un comune destino di paura architettato e progettato da Zeus, e in molti passi dell’opera molti di loro, sempre Greci e Troiani, si trovano coinvolti in gravi lutti.
Omero scrive un poema che racconta la guerra, realizzato con pieno gusto del narrare e con uno straordinario senso del fatto, ma nello stesso tempo svela una realtà profonda, che va al di là della guerra e che la svuota completamente di significato. Mentre infatti la sua poesia prende corpo, inizia a farsi strada, mediante l’impiego di mirati e studiati paragoni (ad esempio gli uomini paragonati alle foglie), l’idea della fragilità e della debolezza del genere umano: gli uomini, che nel corso della narrazione divengono progressivamente sempre meno guerrieri e sempre più uomini, in alcune circostanze manifestano certamente la loro forza, ma in altre soccombono e periscono.
Il discorso relativo al ruolo che i modelli etici giocano nell’Iliade e nell’Odissea deve tuttavia spingersi ancora più in profondità. L’aspetto della responsabilità personale, articolata in due forme, responsabilità oggettiva, che va al di là della volontarietà di chi ha commesso il fatto (es.: Patroclo da ragazzo ha dovuto abbandonare la sua terra per aver commesso un delitto involontario), e complementarietà dell’agire dell’uomo con quello della divinità, cioè quel concetto di atē come idea che implicitamente evoca l’intervento di una forza esterna al soggetto, riveste nei poemi omerici un ruolo centrale. Un singolo individuo, potenzialmente all’origine di un evento o di una catena di eventi di valenza negativa, viene giudicato con modalità che hanno un chiaro riferimento ai procedimenti ufficiali di amministrazione della giustizia; Zeus inoltre viene presentato come difensore ultimo e quale garanzia dalla possibilità di sentenze ingiuste: nel XVI libro la rovinosa tempesta provocata da Zeus è presentata dal poeta come espressione dell’ira del capo degli a causa di una pratica scorretta dell’attività giudiziaria.
Nella parte conclusiva del poema si assiste tuttavia, in questo senso, ad una svolta. Zeus viene infatti presentato non più solo come garante ultimo della giustizia, ma anche e soprattutto come l’entità all’origine del ciclo di sofferenze e di mali che colpiscono l’uomo; nel XXIV libro, infatti, Achille si rivolge a Priamo enunciando il principio secondo cui all’uomo tocca vivere nell’infelicità, concezione questa che non è incompatibile con l’immagine di Zeus garante della giustizia, ma che fa riferimento ad un atteggiamento etico di ordine diverso.
Date queste premesse, è necessario analizzare come il concetto di responsabilità personale prenda effettivamente corpo attraverso le vicende di alcuni personaggi dell’Iliade:
Paride
Viene presentato come responsabile dell’infrazione della norma dell’ospitalità per aver condotto via Elena e molte delle sue ricchezze da Sparta e per questo è ritenuto all’origine della guerra. Il comportamento di Paride e di Elena viene inoltre stigmatizzato come lussurioso e lo stesso Paride viene presentato come uomo che agisce in quanto accecato dal desiderio. A parte però questo duro giudizio di condanna, non si ravvisa nel poema una linea narrativa che faccia pensare che a tale colpa debba necessariamente seguire una punizione: l’Iliade si conclude senza che Paride venga ucciso e il poema inoltre termina con la morte di Ettore, il personaggio che più di ogni altro ha espresso atteggiamenti di rimprovero nei confronti di Paride. In linea di massima quindi, nel corso dell’opera, il problema della responsabilità di Paride tende ad essere mitigato: nella parte iniziale viene frequentemente citato il gesto del rapimento di Elena, oggetto di dura condanna da parte dei Greci, ma in seguito viene mostrato un Paride che riesce a riscattarsi grazie alle sue qualità di guerriero.
Elena
Il dato costante è quello dell’autocondanna di Elena, che definisce se stessa, per ben due volte nel discorso rivolto ad Ettore, come cagna. L’autocondanna è confermata dall’auspicio, espresso dalla stessa Elena, di poter morire per aver compiuto il gesto di seguire Paride e dall’augurio di poter essere trascinata via da una rovinosa tempesta.
Relativamente alla volontarietà o meno del gesto compiuto da Elena, i fatti vengono presentati nel poema in modo molto articolato. Di fronte a Priamo infatti Elena pone l’accento sull’aspetto della volontarietà, mentre nel corso del lamento funebre per Ettore si pone maggiormente in luce l’iniziativa di Paride, presentato come colui che l’ha condotta con la forza a Troia. Molto diversa è la presentazione del punto di vista dei Greci. A loro avviso l’essenziale era infatti vendicare “gli strappi e i gemiti di Elena”, con chiaro riferimento quindi ad un atto di costrizione esercitato da Paride ai danni di Elena stessa, e questo punto di vista rappresentava una premessa necessaria perché la guerra mossa contro Troia non apparisse priva di giustificazione.
Il narratore, dal canto suo, non presenta Elena semplicemente come colei che ha subito un atto di costrizione, ma propone tre diversi punti di vista sottesi a questo evento: l’intervento di Paride, l’intervento di una dea, Afrodite, ma soprattutto il consenso di Elena, cui fa da contraltare l’autocondanna.
Appare chiaro quindi che Omero esprime nei confronti di Elena un giudizio di aperta condanna, ma è nello stesso tempo refrattario a suggerire una evoluzione degli eventi che abbia come sbocco la punizione della donna.
Agamennone
Agamennone viene presentato, da parte di Achille nel I libro, come colpevole di violenza per il fatto di avergli tolto Briseide, ma nel corso del poema appare pentirsi del suo comportamento, fino a che nell’assemblea che viene descritta nel XIX libro fa pubblica ammenda. Achille, in questa circostanza, non chiede nessuna riparazione ad Agamennone e convoca un’assemblea della riconciliazione per annunciare la volontà di abbandonare atteggiamenti improntati all’ira e alla rabbia e per chiedere ad Agamennone di guidare l’esercito nella battaglia alla quale lui stesso prenderà parte. La causa di questo mutamento di orientamento è da individuare essenzialmente nella morte di Patroclo, di fronte alla quale l’ira perde di significato, e in occasione dell’assemblea per la riconciliazione la questione del contrasto fra Achille ed Agamennone appare già superata, anche se un atto di riparazione da parte di Agamennone stesso, sebbene svuotato di significato reale, dovrà esserci.
A differenza di quanto accade nell’Iliade, nell’Odissea colpa e punizione si caricano invece di una valenza molto forte. Il poeta esprime infatti frequenti giudizi di esplicita condanna, ad esempio nei confronti dei Proci, vengono impiegati spesso termini valutativi ed emerge molto chiaramente un esplicito intento didattico, espresso, ad esempio, già nel proemio nell’anticipazione del destino di morte cui i compagni di Ulisse sono destinati a causa del loro comportamento colpevole. Tale messaggio didattico, pur intersecandosi con altri temi importanti, come la nostalgia, il ritorno, gli affetti familiari e anche, e soprattutto, il piacere della narrazione, spinto fino al limite del fiabesco, appare nell’Odissea molto evidente, mentre nell’Iliade risulta essere molto più nascosto.
· Iliade ed Odissea: le scelte stilistiche in funzione delle esigenze narrative
Concentrando l’analisi e l’attenzione in primo luogo sull’Iliade, uno dei dati che balza agli occhi per primo è che una parte considerevole del testo è costituita da discorsi diretti, che rappresentano il 45% degli oltre 15600 versi che costituiscono l’opera. Tale alternanza di parti narrative e parti in cui il narratore lascia spazio al personaggio per una autonoma formulazione del discorso si trova già in composizioni letterarie anteriori all’Iliade, come, ad esempio, nel poema di Gilgamesh. Questo aspetto tuttavia, al di là del dato apparente, presenta nell’Iliade varie sfaccettature.
In primo luogo il discorso di ogni singolo personaggio, espressione di un particolare punto di vista, può essere motivato da fattori di ordine puramente espositivo, miranti cioè a rendere possibile l’esposizione da parte del parlante di cose o fatti che un altro parlante non conosce, o di ordine tendenzioso, di esposizione cioè da parte del parlante di cose che in un particolare momento appaiono molto vicine ai suoi interessi e alle sue intenzioni. Il discorso formulato da ciascun personaggio conserva inoltre sempre un carattere di contestualità rispetto alla dimensione narrativa complessiva e ciò in virtù dell’abilità del poeta che riesce sempre, mediante una serie di procedimenti molto sofisticati, a concedere uno spazio autonomo al suo personaggio, ma, nello stesso tempo, a creare connessioni fra tale spazio autonomo e il resto della narrazione.
Centrale è inoltre il rapporto fra il punto di vista del narratore e la posizione espressa dal personaggio, figure queste che si alternano per tutto il corso dell’opera e che si contendono il ruolo di primo piano. Sul rapporto fra queste due figure sono necessari alcuni approfondimenti.
· Il rapporto fra narratore e personaggio
Relativamente al rapporto fra il narratore e il personaggio, si possono individuare diverse strategie:
a) il narratore fa da spalla al personaggio: il narratore crea le condizioni affinché il personaggio possa esprimere il suo punto di vista. Tale meccanismo è evidente in molti passi dell’Iliade, come, ad esempio, nella parte iniziale del libro XXI, in cui viene narrato l’episodio patetico di Licaone. In questa circostanza vengono prodotte da parte di Achille delle frequenti ripetizioni di forme verbali, già proposte precedentemente dal narratore, che in questo caso sostiene e fa da spalla ad Achille;
b) il narratore gioca con il personaggio: ciò si può cogliere chiaramente nel libro XIV, in cui Omero gioca addirittura con Zeus nel corso dell’episodio della seduzione che Zeus stesso subisce da parte di Hera. In questa circostanza il capo degli dei fa riferimento con estrema tranquillità e con un atteggiamento un po’ spavaldo ad un suo desiderio che, nel passato, lo ha condotto ad avere come oggetto sia donne mortali che dee e, a riprova di ciò, produce un lungo elenco di donne che ha amato. Proprio però nel momento in cui egli mette in mostra le sue doti di amatore, viene ingannato da Hera, che riesce a farlo cadere in un sonno profondo e a sedurlo; il narratore mostra quindi di giocare con il personaggio, facendo in modo che egli si scopra proprio nel momento meno opportuno e coprendolo in un certo senso di ridicolo;
c) il narratore prende le distanze dal personaggio: nel VI libro si parla dello scambio di armi fra Diomede e Glauco su proposta di Diomede e il narratore afferma, facendo ricorso ad un’espressione molto forte, che Zeus ha tolto il senno a Glauco. Tale giudizio negativo nasce dal fatto che l’accordo fra i due, che si impegnano a non combattersi più nemmeno in futuro, appare al narratore troppo in anticipo rispetto ai tempi e per questo sente la necessità di introdurre una nota di commento tale da impedire all’ascoltatore di immedesimarsi nella vicenda e nelle sorti del personaggio e che provoca pertanto l’effetto contrario, un impulso cioè verso un atteggiamento di dissociazione. In definitiva, in questo episodio il personaggio si sarebbe spinto, a giudizio del narratore, troppo oltre e per questo il narratore stesso sente la necessità di frenarlo.
Relativamente invece a come viene delineato e presentato il personaggio, non solo nella sua esteriorità, ma anche nella sua dimensione interiore e motivazionale, si individuano nell’Iliade vari procedimenti:
a) il personaggio viene presentato dal narratore nell’atto di agire senza che vi sia consapevolezza da parte sua della motivazione che lo spinge all’azione: in questa circostanza è il narratore che garantisce per il personaggio e la sequenza delle vicende è interamente organizzata e regolata dal narratore stesso, che segue lo sviluppo delle cose e di volta in volta fornisce informazioni all’ascoltatore;
b) il personaggio agisce in concomitanza con una circostanza accessoria che viene correlata al suo personale punto di vista: in questo caso il nesso tra personaggio e le sequenza delle vicende non è immediato, ma si ha un elemento intermedio, caratterizzato peraltro da una precisa struttura grammaticale e sintattica (participio, preposizione temporale-causale e proposizione finale) che aiuta a far prevalere il punto di vista del personaggio stesso e la sua autonoma capacità di valutazione;
c) il narratore riferisce dell’incertezza del personaggio fra due alternative e informa in seguito quale delle due è stata scelta: si tratta in questo caso di un salto qualitativo rispetto ai precedenti procedimenti espressivi utilizzati poiché il narratore concede al personaggio un suo spazio autonomo, anche se è sempre lui a regolare e a circoscrivere questo spazio; l’incertezza viene espressa mediante l’uso dei verbi meditare, riflettere ed esitare e con la struttura o…. o….. e a volte la titubanza del personaggio si conclude con l’intervento esterno di un’altra entità, rappresentata nella maggior parte dei casi da una divinità;
d) in un monologo il personaggio riflette fra sé e sé fino a decidere come agire: il personaggio in questo caso perviene ad una decisione attraverso un discorso rivolto a se stesso e rompe il legame che lo lega al narratore, evidenziando una sua autonoma capacità di argomentazione.
Relativamente ai monologhi questi appaiono differentemente articolati a seconda degli scopi che, per mezzo di essi, il personaggio si prefigge:
1) il monologo può svilupparsi mediante l’enunciazione da parte del personaggio della decisione presa dopo aver esposto due alternative che si elidono a vicenda, caso in cui il monologo appare maggiormente formalizzato anche nella struttura (introduzione con un verso formulare esterno – inizio con una interiezione che contiene al suo interno il verso modulare “ma perché a me il mio animo ha detto queste cose”);
2) il monologo può presentare il personaggio che perviene ad una decisione senza aver enunciato alternative; in questo caso si tratta di monologhi brevi che al poeta dovevano apparire più adatti a rendere il senso dell’immediata percezione di ciò che si presenta di fronte al personaggio; nel caso di Ettore la prospettiva che gli si pone davanti è la sua morte, circostanza questa in cui il poeta mette in atto una creazione poetica di altissimo livello espressivo mediante la quale propone il modello dell’eroe che affronta consapevolmente e senza incertezze il suo destino. Il margine di scelta che resta all’eroe riguarda il modo di morire, in considerazione del ricordo che del suo gesto resterà alla generazioni future: nel gesto esemplare cui si sta preparando, l’eroe trova il suo riscatto o, osservando le cose da un diverso punto di vista, il poeta concede al suo personaggio il modo per riscattarsi di fronte ad una situazione irrevocabile e senza alternative nella quale egli lo ha stretto. Il monologo si carica pertanto in questo caso di un inevitabile carattere drammatico e tragico;
3) nel monologo il personaggio non perviene ad alcuna decisione e non si pone nemmeno il problema di decidere.
In tutta l’opera compaiono quattro monologhi nei libri XI, XVII, XXI e XXII, la cui estensione cresce progressivamente e dei quali l’ultimo, quello di Ettore, rappresenta il culmine di una sequenza in progressione non solo sul piano ritmico, ma anche dal punto di vista dell’espressione poetica.
· Il diverso ambito di conoscenza del narratore e del personaggio
Altro aspetto da segnalare è relativo all’ambito di conoscenza proprio del narratore rispetto a quello del personaggio. Nell’Iliade, così come nell’Odissea, appare, ad esempio, in modo costante la seguente struttura espressiva: “Così disse (dissero) pregando”, seguita poi da “…e lo/li ascoltò” seguita dal nome della divinità che prestava ascolto. Tale formula espressiva riflette pertanto una situazione tipica, quella dell’uomo che prega e della divinità che, venendo incontro ad un desiderio elementare dell’uomo, presta ascolto. Nell’Iliade tuttavia, differentemente da ciò che accade nell’Odissea, compaiono due casi atipici. Il primo caso è quello in cui alla formula: “Così disse pregando” segue un verso da cui appare evidente il rifiuto della divinità a prestare ascolto alla preghiera. In questo modo si delinea uno scarto fra l’ambito di conoscenza del personaggio e quello del narratore, che mostra di conoscere di più, sulle intenzioni della divinità, del personaggio stesso. Nel secondo caso, invece, la formulazione del verso appare regolare sul piano della forma, ma la risposta della divinità si carica di una risonanza sinistra. Ciò avviene, ad esempio, nel XVI libro, quando Achille chiede a Zeus di garantire il successo di Patroclo e di farlo tornare sano e salvo; in questo caso il narratore, anticipando gli eventi, rivela che la preghiera di Achille non verrà esaudita interamente e che soprattutto non verrà esaudita nel punto che per Achille è di importanza essenziale. Anche in questo caso il narratore circoscrive il personaggio in un ambito ristretto di conoscenza e mette in atto nei suoi confronti un gioco nel complesso piuttosto crudele: in un primo momento tutto appare andare nella direzione voluta dal personaggio e la divinità sembra esaudire tutte le sue preghiere, dopo invece il discorso si arricchisce di un elemento che preannuncia al personaggio un evento negativo. Il rifiuto della divinità di intervenire per esaudire la preghiera che il personaggio gli ha rivolto emerge inoltre anche quando la richiesta viene formulata con eccessiva superbia, ad esempio con la formula: “Così disse vantandosi”, caso in cui segue anche la dissociazione del narratore nei confronti dell’atteggiamento del personaggio.
Il narratore, inoltre, proprio per sottolineare la ristrettezza dell’ambito di conoscenza proprio del personaggio, utilizza talvolta il termine nepios, che letteralmente significa “bambino”, ma che appare più spesso impiegato nell’accezione di “inconsapevole”. Fermo restando il significato di base, questo termine acquista sfumature che necessitano di un chiarimento.
Quando è usato nel discorso diretto ed è riferito all’interlocutore che il personaggio che parla ha davanti a sé, il termine di nepios diviene allora uno strumento di aggressione verbale, molto simile al nostro “stolto”. Più ampia è invece la gamma dei significati quando il termine è impiegato dal narratore; a volte infatti l’uso del termine rivela un intento polemico nei confronti del personaggio, ma a volte viene introdotto per evidenziare il suo ristretto ambito di conoscenza, senza tuttavia far trasparire nei suoi confronti un intento polemico particolare. Tale accezione di significato viene usata, ad esempio, nei confronti di Patroclo ed ha la funzione, oltre che di sottolinearne la scarsa consapevolezza, di prendere da esso le distanze e di valutare la possibilità di comportamenti diversi e più cauti. Ultima accezione, infine, del termine nepios è quella impiegata nei confronti di Andromaca in relazione alla morte del marito. In questi passi il termine, che si carica di un chiaro significato patetico e delinea l’attesa vana di Andromaca, mette in evidenzia ancora una volta la dissociazione del narratore nei confronti del comportamento del personaggio, ma senza che emerga tuttavia un tono di riprovazione. Il fatto che il narratore sappia di più del personaggio fa scattare, nel caso di Andromaca, un processo di partecipazione alla sua sofferenza, che viene valorizzata nella sua profonda umanità.
Il termine nepios viene infine impiegato nell’Iliade per due volte in relazione al rapporto uomo/dio. In un passo in particolare, nel libro XX, il narratore, riferendosi ad Achille che temeva che la lancia scagliata da Enea potesse perforare il suo scudo fabbricato da Efesto, usa il termine “stolto” per sottolineare l’errata valutazione di Achille stesso di un dato, appunto la solidità dello scudo.
· L’uso della seconda persona
Altra particolarità che si rende evidente nell’Iliade è l’uso, da parte del narratore, della seconda persona per rivolgersi direttamente alle Muse, all’ascoltatore o al personaggio. Le invocazioni alle Muse rientrano nell’ambito del rapporto che legava il poeta all’attività che la musa stessa presiedeva e ad una specifica tradizione, caratterizzata da un proprio sistema di regole e norme. Il rivolgersi all’ascoltatore aveva invece la funzione di trasmettere le informazioni ad un destinatario, con il quale il poeta sentiva il bisogno di stabilire un collegamento, in particolare nella fase iniziale del suo racconto. Il rivolgersi ad uno dei suoi personaggi è infine uno strumento privilegiato di cui il narratore si serve per interrompere il flusso della narrazione nella sua apparente oggettività. Tale procedimento, detto “apostrofe”, mentre nell’Odissea è attestato solo per il personaggio di Eumeo, nell’Iliade è impiegato nei confronti di vari personaggi, come Menelao, Apollo, Patroclo ed Achille. Nell’Iliade inoltre l’apostrofe ricorre frequentemente dopo un paragone, che rappresenta una temporanea lacerazione della compattezza del testo in conseguenza di un intervento più diretto del narratore, ed è inoltre impiegata frequentemente in concomitanza con la morte o il pericolo di morte di un personaggio e quindi di fronte a circostanze cariche di grande intensità emotiva. Esiste pertanto una perfetta corrispondenza biunivoca fra apostrofe ed emotività ed è evidente che l’apostrofe veniva percepita dal poeta come uno strumento da impiegare in occasione di una forte spinta di carattere emozionale, e ciò spiega anche perché il personaggio per il quale tale procedimento narrativo viene maggiormente impiegato è Patroclo. Patroclo è un personaggio tutto costruito in chiave patetica e le apostrofi sottolineano i momenti più rilevanti della sua vicenda, che si conclude con la morte. Il personaggio, dopo Patroclo, per il quale vengono impiegate più apostrofi è Menelao e, in particolare, in circostanze che presentano un pericolo di morte a suo carico.
· La formulazione di richieste e il resoconto di fatti
Altro procedimento messo in atto nell’Iliade è l’enunciazione da parte del personaggio, attraverso il discorso diretto, di una richiesta di cui poi il narratore riferisce l’esito. Il rapporto che sussiste fra richiesta del personaggio e resoconto del narratore non è di semplice ripetizione, ma si rendono evidenti dei cambiamenti classificabili in:
– variazioni dovute allo sviluppo della vicenda nel tempo: un esempio lo possiamo individuare nel litigio fra Achille ed Agamennone, in cui il narratore, in seguito alla rottura fra i due, vuole evitare che le capacità decisionali ed operative di Agamennone possano risultare compromesse dopo la rottura con Achille;
– espressione, da parte del narratore, di un punto di vista diverso da chi ha formulato la richiesta: nel XIX libro Zeus ordina ad Athena di instillare nel petto di Achille nettare ed ambrosia perché non fosse raggiunto dalla fame e la dea, come racconta il narratore, agì eseguendo le richieste di Zeus affinché la fame non raggiungesse Achille “alle ginocchia”. Appare evidente che la frase di Zeus viene dilatata ed amplificata e viene evidenziato l’aspetto sgradevole della fame;
– ampliamento con l’aggiunta di particolari dovuto al gusto di raccontare proprio del narratore: il narratore, nell’obbedire a sue particolari esigenze espressive, è portato a raccontare i fatti con una ricchezza di particolari che non trova sempre riscontro nel precedente discorso del personaggio. Il discorso del personaggio può venire infatti arricchito con l’inserimento di nuovi dettagli, come accade, ad esempio, nel libro VI in relazione alle istruzioni date da Elena ad Ettore e ripetute da questo alla madre e il resoconto della messa in atto di queste istruzioni realizzato dal narratore, resoconto che presenta sensibili variazioni. Non è infatti Ecuba che aduna le donne troiane, come dovrebbe avvenire secondo le istruzioni, ma tale operazione viene messa in atto dalle serve per incarico della stessa Ecuba, sulla quale poi il narratore si sofferma per descrivere con accuratezza sia l’operazione di donazione alla dea di un peplo, sia le caratteristiche dello stesso peplo prodotto dalle donne che Paride aveva portato a Troia, ritornando insieme ad Elena da Sparta. Anche il personaggio, dal canto suo, ripropone fatti esposti dal narratore non sotto forma di semplice ripetizione, bensì con l’introduzione di numerose variazioni dovute al suo particolare punto di vista. Non si tratta solamente di esposizione di particolari diversi, legati semplicemente ad una diversa prospettiva nel valutare i fatti, ma anche di consapevole manipolazione degli eventi da parte del personaggio, manipolazione che si spinge a volte al limite della tendenziosità e del falso. Un esempio di tale strategia narrativa è individuabile nel discorso che Licaone rivolge ad Achille nel libro XXI. Delle vicende che riguardano Licaone compaiono infatti, a breve distanza, due diverse versioni, una propria del narratore ed una seconda dello stesso Licaone. Il narratore riporta infatti che Achille aveva condotto via Licaone per venderlo, in seguito, al figlio di Giasone, che pagò il prezzo dovuto. In questo racconto si mette in evidenza la figura di Achille che risulta essere per Licaone l’origine di una sciagura inattesa. Licaone racconta invece di essersi posto davanti ad Achille in posizione supplichevole ed appare quindi molto evidente il suo atteggiamento umile con il quale cerca di indurre in Achille pietà. La diversità di punti di vista emerge anche quando sono coinvolti due personaggi diversi, che parlano in momenti diversi dello stesso evento. Un esempio di ciò è individuabile nella preghiera che Theti, nella parte iniziale del poema, rivolge a Zeus sull’Olimpo. Hera riferisce che la stessa Theti si sarebbe seduta di buon mattino presso Zeus e gli avrebbe preso le ginocchia, resoconto che presenta punti di contatto con la formulazione data dal narratore, Athena invece, parlando dello stesso episodio, riferisce che Theti baciò le ginocchia di Zeus, esagerando nella descrizione, in modo perfettamente coerente con il suo stile animoso e polemico. Lo scarto fra i diversi punti di vista dei due personaggi può essere ancora più rilevante quando fa riferimento ad eventi estranei al poema. Può verificarsi cioè che si diano versioni completamente differenti di uno stesso evento senza che l’ascoltatore sia in grado di accertare o verificare quale versione sia vera. Nelle intenzioni di Omero l’ascoltatore non doveva pensare che il personaggio inventasse cose non accadute e le diverse versioni sono proposte come tutte vere, anche se non congruenti fra loro; ciò che conta per il poeta è la salvaguardia della verità del segmento narrativo che egli di volta in volta costruisce e di fronte a ciò qualche incongruenza appare nel complesso secondaria.
· L’uso di strutture simmetriche
Nell’Iliade, così come nell’Odissea, compaiono versi perfettamente simmetrici, cioè con una parte di distico riservata ad un personaggio o ad una categoria di persone e l’altra parte di distico riservata ad un secondo personaggio o ad un’altra categoria di persone. Si presenta quindi, in alcune circostanze, una struttura ritmicamente equilibrata analoga alla danza, mediante la quale Omero cerca di creare delle corrispondenze fra i personaggi di volta in volta coinvolti. Tali strutture ritmiche parallele coinvolgono anche il rapporto fra personaggi e narratore. Nel XVI libro, dove viene presentato il contrasto fra Ettore e Patroclo intorno al cadavere di Febrione, prima viene descritto il balzo compiuto da Ettore e subito dopo viene descritto il balzo compiuto da Patroclo, mediante una ricerca di corrispondenza fonica fra i versi ottenuta mediante una sorta di rima. Compaiono strutture diadiche anche quando il contrasto coinvolge due interi eserciti: nel XV libro vengono utilizzate espressioni diadiche che hanno la funzione di mettere in evidenza le corrispondenze che sussistono fra le due parti in causa e che hanno alla fine lo scopo di accomunare i due schieramenti in lotta in quanto condividono lo stesso destino; il sangue che alla fine scorre sulla nera terra è sangue di Greci e di Troiani. Anche nella parte finale del poema, dove viene descritto l’incontro fra Achille e Priamo, il narratore impiega corrispondenze simmetriche: i due piangono insieme e, grazie al sapiente impiego di rime e parallelismi, viene resa al meglio la consonanza affettiva tra vinto e vincitore.
· La formularità e la ripetizione
Relativamente alla questione dell’uso delle formule e della tecnica della ripetizione è necessario premettere che il pubblico di cui erano destinate Iliade ed Odissea era sicuramente molto sensibile alla comunicazione orale e poteva da questa essere facilmente raggiunto. Di ciò il poeta avrà sicuramente tenuto conto al momento della composizione dell’opera ed avrà quindi fatto probabilmente ricorso, come tutti coloro che a quel tempo si occupavano di poesia, ad un vasto patrimonio di formule trasmesso oralmente e all’utilizzo della ripetizione, perché convinto dell’efficacia delle formule ripetitive sul suo uditorio. Tutto ciò tuttavia, che è sicuramente molto probabile, deve però essere tenuto distinto da quanto concerne la scelta e l’impiego dei registri espressivi da parte dell’autore; formularità e ripetizione devono pertanto essere analizzate in funzione dei procedimenti inventivi frutto delle sue scelte creative o in rapporto alle specifiche esigenze espressive delle varie parti del testo.
L’arte dei richiami e dell’uso delle formule ripetitive appare quindi nell’Iliade e nell’Odissea un elemento degno di considerazione, malgrado non sia, contrariamente a ciò che si potrebbe pensare, così tanto impiegato. Quasi ogni segmento delle opere omeriche è infatti un caso particolare ed unico nell’ambito dell’epica arcaica pervenuta fino a noi ed appare evidente che determinate espressioni sono state coniate autonomamente da Omero e da lui elevate a livello letterario; tanto per fare un esempio, l’appellativo di “villoso” attribuito al petto di Achille non viene usato per nessun altro personaggio dell’epica classica e deve essere inventato dall’autore in funzione di una particolare esigenza espressiva.
Relativamente all’impiego di formule, è necessario distinguere fra una formularità esterna, l’utilizzo cioè multiplo di formule preesistenti ed appartenenti al patrimonio comune dei poeti, e formularità interna, ripetizione cioè di espressioni già usate da Omero in precedenza e probabilmente originali. Nell’Iliade si possono trovare non solo espressioni per le quali è legittimo parlare di patrimonio tradizionale di formule, quindi di formularità esterna, ma anche, e per una parte rilevante del testo, ripetizioni che possono essere riferite solo alla formularità interna.
L’utilizzo inoltre di formule esterne non inoltre costituiva un ostacolo o una limitazione alla capacità inventiva del poeta poiché queste venivano comunque sottoposte ad un procedimento di variazione, mediante:
– parziale sostituzione: la formula tradizionale “dirò, e tu presta attenzione e ascoltami” diviene nel I libro “dirò e tu presta attenzione e giurami”, in una circostanza in cui, data la necessità da parte del personaggio coinvolto di prendere un impegno preciso, non era sufficiente dire che egli ascoltasse, ma era necessario che intervenisse prestando giuramento;
– ampliamento: la formula “il padre e la veneranda madre” diviene “il caro padre e la veneranda madre”, in cui l’aggettivo “caro” sottolinea il tipo di rapporto padre/figlio che Omero ha creato in questo episodio;
– rovesciamento di funzione: l’espressione “pari a un dio” viene impiegata sia con connotazione positiva, per sottolineare cioè le particolari qualità di un personaggio, ma anche con connotazione negativa, per ammonire un personaggio per la sua eccessiva superbia;
– discussione di una formula: una formula, impiegata per porre in rilievo particolari qualità di una persona, viene citata con un intento espressivo tale da metterla in discussione e negare di conseguenza le qualità che con essa potevano essere attestate.
Tali meccanismi di variazione, impiegati molto di frequente, erano pertanto uno strumento privilegiato che il poeta aveva a disposizione per creare, a partire da modalità espressive già fissate dalla tradizione, delle espressioni nuove.
· Gli epiteti
Interessante è anche l’analisi di quanto e come venivano impiegati gli epiteti, particolari o generici, nei poemi omerici. Analizzando in particolare la figura di Ettore, è possibile registrare l’uso dell’appellativo di illustre, impiegato anche per Aiace Telamonio e quindi non in modo specializzato, e quello di forte, che viene invece impiegato esclusivamente per Ettore, segno questo di una accentuata specializzazione. Altri epiteti specializzati utilizzati però non solo per Ettore, ma anche per Aiace sono “scuotitore d’elmo”, “simile alla fiamma per valore” e “pari ad Ares distruttore di uomini”, espressione quest’ultima considerata probabilmente dal poeta come particolarmente forte ed utilizzata in poche occasioni. In generale, relativamente all’uso degli epiteti, si osserva una specializzazione che coinvolge e riguarda i grandi protagonisti del poema.
Numerosi sono però anche i casi in cui il nome di un eroe non è legato o accompagnato da alcun epiteto, né specifico né generico. L’alternanza fra presenza e assenza di epiteti costituisce, nell’Iliade e nell’Odissea, uno strumento espressivo di vitale importanza: si ha la presenza costante di epiteti quando l’attenzione dell’autore si concentra su un determinato particolare, che viene messo dall’epiteto in primo piano, si ha l’impiego di epiteti di carattere per lo più di carattere elogiativo quando il poeta vuole metterne in evidenza l’eroismo e dare l’idea di un mondo eroico lontano nel tempo, si ha infine l’alternanza di epiteti generici e di epiteti specializzati quando si vuole far emergere il valore di una singola personalità.
Un aspetto però che è necessario prendere nella giusta considerazione è il rapporto fra l’epiteto e il contesto. Se un epiteto è impiegato molto frequentemente appare evidente che il rapporto con il contesto sarà labile; l’uso dell’appellativo “divino” per Ettore è impiegato in molti momenti e quindi non ha senso chiedersi se la constatazione della sua divinità dipenda dal particolare contesto in cui viene attestata; se invece l’epiteto viene impiegato con minore frequenza, allora il rapporto con il contesto appare più stretto; sempre in relazione ad Ettore, l’appellativo “forte” è usato solo nelle circostanze in cui è necessario porne in rilievo la forza, così come l’appellativo “audace” viene impiegato solo nei momenti in cui Ettore, pur avendo ricevuto consigli assennati, si appresta a seguire una linea di condotta spericolata.
· I paragoni
L’uso dei paragoni nell’Iliade e nell’Odissea non avviene in modo indiscriminato, ma si inquadra invece all’interno di un preciso disegno compositivo, realizzato ed ottenuto mediante i collegamenti fra un paragone e l’altro. A volte determinati paragoni si sviluppano a distanza realizzando, al di là del racconto vero e proprio, una seconda linea compositiva che il poeta sviluppa parallelamente alla trama principale. Nel libro XVI, ad esempio, il paragone con cui Patroclo ed Ettore, che si contendevano il corpo di Cebrione, vengono identificati con due leoni affamati che si contendono una cerva uccisa, corrisponde, sempre nello stesso libro, al paragone con cui Ettore viene assimilato ad un leone che uccide un cinghiale. Un collegamento a distanza tra due paragoni può essere realizzato anche attraverso ben isolabili procedimenti di ampliamento e accorciamento; una breve similitudine può venir ripresa in un passo successivo o, al contrario, può accadere che in un secondo passo una similitudine più articolata venga ridotta ad una breve similitudine. Quando poi si ha una sequenza di tre paragoni collegati fra loro, quello centrale viene ad assolvere una funzione di cerniera. Nei libri V, XI e XIII viene proposta l’immagine di un fiume dalla corrente invernale e impetuosa in riferimento a Diomede, Aiace ed Ettore. In questa circostanza Omero propone, nel primo paragone, uno spunto linguistico che viene poi sviluppato in seguito. Il primo fiume travolge argini e recinzioni, nell’XI libro l’azione del fiume è invece molto più rovinosa e trascina con sé molti alberi e molto fango, nel terzo paragone, quello del XIII libro, Omero sviluppa una potenzialità già presente nel secondo, ma non nel primo: in questa circostanza un macigno viene spinto a valle, così come nell’XI libro venivano spinti a valle querce e pini, e alla fine del paragone compare il riferimento ad Ettore, così come nell’XI libro appare il riferimento ad Aiace.
Nell’Iliade inoltre vi sono cinque casi in cui un paragone viene ripetuto. Tali ripetizioni, percentualmente scarse rispetto al numero complessivo di paragoni del poema, vengono peraltro accompagnate da procedimenti che compensano la ripetizione stessa, come, ad esempio, processi di intensificazione, che consistono nell’introduzione, in una catena di paragoni, di un paragone nuovo per accentuare determinati caratteri di un personaggio o per metterne in rilievo le azioni. Anche quando i paragoni vengono ripetuti senza apparenti modifiche esteriori, ad uno sguardo più approfondito appare evidente che non si tratta mai di pura e semplice copia, ma, al contrario, la ripetizione acquista una particolare significatività. Uno dei paragoni più efficaci è quello del leone, che presenta uno sviluppo per tutto il corso dell’opera con una svolta particolare nella parte conclusiva del poema. Il paragone inizia infatti con la classica immagine del leone sanguinario che uccide un toro nel XVI libro e prosegue, nel XVII libro, con l’immagine di un leone, cui viene paragonato Aiace che si pone accanto al cadavere di Patroclo, che, insieme ai suoi piccoli, incontra un cacciatore nella foresta ed ostenta la sua forza aggrottando le sopracciglia. Qui l’aggressività diviene marginale e il leone si caratterizza per il suo atteggiamento di difesa del gruppo familiare, che lo conduce a proteggere i suoi piccoli che sente minacciati dai cacciatori. Il paragone del leone prosegue nel XVII e XX dove ricompare il particolare della foresta, che appare infittita, e i piccoli, precedentemente solo minacciati, ora sono stati rapiti; il leone, preso dal dolore e dall’ira, si aggira fra i monti senza tuttavia trovare il rapitore, ma si tratta di un leone che non ha più i caratteri dell’incondizionata aggressività. L’elemento di novità dei vari passi citati è rappresentato quindi dalla peculiarità dei moduli espressivi impiegati, creati allo scopo di produrre un’immagine del leone non caratterizzata unicamente e specificamente da una sanguinaria aggressività.
· Considerazioni conclusive
Volendo quindi accettare l’ipotesi dell’esistenza storica di Omero quale autore di Iliade ed Odissea, è necessario ritornare agli interrogativi iniziali e verificare le risposte, più o meno evidenti e chiare, che Omero ha fornito ad essi attraverso le sue opere:
– da dove viene la poesia? A questa domanda Omero risponde semplicemente che essa proviene dalle Muse o, con un termine più chiaro e generale, dagli dei. Nell’Odissea infatti un aedo afferma che fu un dio ad ispirare tutti i canti nel suo cuore, precisando però di aver appreso da solo l’arte della poesia;
– qual è il fine della poesia? Anche in questo caso Omero risponde molto semplicemente: il fine della poesia è procurare diletto (“Un dio donò il canto a darci diletto”). Omero aveva una visione piuttosto pragmatica del diletto che la poesia procura agli uomini: attribuisce ad esso una grande considerazione, ma non ritiene che debba collocarsi al di sopra di quello che proviene dalle bevande o dal cibo. Egli ritiene inoltre che il vero fine della poesia, secondo un modo di pensare diffuso al suo tempo, risieda nell’essere ornamento alle feste: afferma infatti che, in tali occasioni, nulla risulta più gradevole di quando i convitati, seduti in fila, stanno assorti ad ascoltare il cantore;
– quale effetto produce la poesia sugli uomini? Omero ritiene che la poesia, oltre a procurare diletto, sia anche in grado di affascinare gli animi; parla infatti di incanto quando parla del canto delle sirene e da lui prende appunto origine l’idea della poesia come strumento in grado di incantare chi la ascolta, concetto questo che avrebbe svolto una funzione importantissima nell’estetica delle epoche successive;
– quale deve essere l’argomento della poesia? La poesia, secondo Omero, deve trattare di fatti memorabili e, dicendo ciò, aveva in mente ovviamente le gesta degli eroi dell’epica classica;
– in che cosa consiste il valore della poesia? Il valore della poesia, secondo Omero, risiede nel fatto che essa è la voce degli dei che parlano per bocca dei poeti, ma anche nel fatto che procura agli uomini diletto, tramandando, nello stesso tempo, il ricordo di antiche imprese.
In tutta l’opera di Omero non emergono affermazioni che facciano pensare alla poesia come arte autonoma, anche se il valore che egli attribuisce a questo dono degli dei e all’aedo che, ispirato da essi, lo esercita, è altissimo: tra gli uomini utili al paese, accanto all’indovino, al medico e all’artigiano, l’aedo viene posto fra coloro che, per la funzione esercitata, sono “cercati fra gli uomini sulla terra infinita”. Dal suo punto di vista, inoltre, l’abilità del poeta, che oltrepassava le reali capacità espressive dell’uomo comune, doveva essere ritenuta un dono degli dei: se anche il poeta avesse avuto dieci bocche e dieci lingue, una voce instancabile e un petto di bronzo, senza l’aiuto degli dei, non avrebbe comunque mai potuto realizzare la sua opera. Omero conclude infine la questione con un’affermazione ad effetto: pur di perseverare nella poesia, val la pena di sopportare le peggiori sventure, che gli dei impongono agli uomini proprio perché possano divenire materia di canto per i futuri poeti;
– la poesia è veritiera oppure inventa? Omero ritiene che la poesia dica il vero e ne apprezza la piena aderenza alla realtà, così come apprezza lo scultore che riesce a realizzare un oggetto che, pur essendo di un materiale diverso dall’originale, assomiglia in tutto e per tutto al modello. Omero tuttavia era perfettamente consapevole del fatto che la poesia richiede libertà: quando Penelope chiede all’aedo di cantare nel modo convenuto, il figlio intercede presso di lei affinché egli possa cantare seconda la sua ispirazione.
Questi, in generale, sono i problemi estetici più importanti affrontati da Omero; altri vengono appena toccati, ma in molti casi sono analizzati con molta precisione ed acutezza, come accade, ad esempio, quando considera la funzione e l’effetto determinato dal “nuovo”: nell’Odissea si legge che, di tutti i canti, il più gradito e maggiormente lodato è quello che risulta più nuovo alle orecchie dell’ascoltatore.
Bibliografia di riferimento
Opere di Omero
Iliade, introduzione di Giuseppe Zanetto ; traduzione di Giovanni Cerri ; commento di Antonietta Gostoli. – Milano, Radici BUR, 2006;
Odissea, introduzione di Aldo Tagliaferri ; traduzione a cura di Emilio Villa, Milano, Feltrinelli, 1994;
Manuali di storia della filosofia
N. Abbagnano, La filosofia antica : dalle origini al Neoplatonismo, Milano, TEA, 1995;
G. Cambiano, Storia della filosofia antica, Roma/Bar, Laterza, 2004
L. Geymonat, Storia del pensiero filosofico e scientifico. L’antichità, il Medioevo, Milano, Garzanti, 1970;
G. Reale, D. Antiseri, Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi : corso di filosofia per i licei classici e scientifici, Brescia, La scuola;
F. Restaino, Storia della filosofia. La filosofia antica: India, Cina, Grecia, Torino, UTET, 1999
Monografie
V. Di Benedetto, Nel laboratorio di Omero, Torino, Piccola biblioteca Einaudi, 1998;
B. Gentili, Poesia e pubblico nella Grecia antica : da Omero al 5. secolo, Roma, Laterza, 1995;
W. Jaeger, Paideia: la formazione dell’uomo greco, introduzione di Giovanni Reale, traduzione di Luigi Emery e Alessandro Setti, Milano, Bompiani, 2003
W. Tatarkiewicz, Storia dell’estetica a cura di Giampiero Cavaglia, vol. I, Torino, Einaudi.
L’ESTETICA DI PLATONE
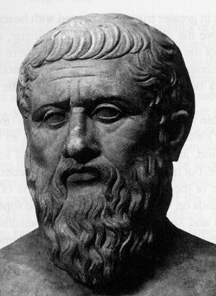
La potenza del Bene si è rifugiata nella natura del Bello. (Platone, Filebo, 65 a)
A cura di Claudia Bianco
Platone
La Repubblica di Platone, la cui data di composizione rappresenta per molti studiosi un problema insolubile, a causa dell’insostenibilità della tesi secondo cui un’opera antica è databile in un determinato anno e, questo, non soltanto per l’ampiezza e la complessità del testo, ma anche perché nulla sappiamo circa le sue modalità di diffusione e circolazione, è probabilmente il più importante fra i dialoghi del filosofo greco. Per cercare di stabilire con una certa sicurezza un termine cronologico, sono state percorse più strade tra cui il confronto dei dialoghi, la ricerca all’interno di essi di caratteristiche stilistiche comuni e le testimonianze del dibattito intellettuale della fine del V secolo, pervenuteci dalle commedie di Aristofane (450-388 a.C. circa). Nonostante la difficoltà posta dalla «data drammatica»[1], si tende ad indicare, approssimativamente, come periodo di composizione, gli anni tra il 386 e il 370 a.C., e a considerare, conseguentemente, La Repubblica come uno dei dialoghi della maturità insieme a testi come il Gorgia, il Menone, il Cratilo, il Fedone, il Simposio e il Fedro.
La natura profonda di quest’opera, ossia la sua intenzione dominante e il suo senso principale, è stata oggetto di numerose interpretazioni. Vi sono tendenze che hanno definito la Repubblica come un testo meramente politico; altre, come quella di Leo Strauss e della sua scuola, l’hanno, invece, concepita come una vera e propria «utopia autoconfutatoria», tale da mostrare i terribili danni che verrebbero provocati dai tentativi di applicare l’idealismo filosofico in campo storico-politico; altre ancora hanno individuato i problemi di etica individuale (qual è il rapporto fra felicità e virtù), a loro volta connessi con una teoria dell’anima, come il nucleo vivo dell’opera.
Il conflitto delle interpretazioni è, quindi, sufficiente a far comprendere come non sia possibile proporre una lettura della Repubblica che si pretenda «oggettiva» o neutrale: essa si presenta, infatti, come un complesso affresco in cui la teoria dello Stato viene edificata a partire da una serie di tesi riguardanti la natura dell’anima umana, della conoscenza, della virtù, dell’educazione. Rimettendo in discussione i princìpi fondanti della cultura del suo tempo, Platone presenta un modello di come potrebbe strutturarsi una giusta convivenza sociale in una società guidata dalla filosofia. Ed è proprio la questione inerente a che cosa sia la giustizia a porre l’inizio del dialogo, il quale presenta, oltretutto, la caratteristica di disegnare una sorta di enciclopedia, di sistema filosofico complesso al fine di rispondere a tale interrogativo. Per rispondere alla domanda «che cos’è la giustizia?», Platone sviluppa, quindi, temi di metafisica, di psicologia filosofica e avanza una teoria della conoscenza all’interno di un quadro di filosofia politica.
Se focalizziamo la nostra attenzione sulla filosofia estetica che può essere colta tra le righe della Repubblica, notiamo che la domanda della metafisica (che cosa esiste?), la domanda della psicologia (com’è fatto l’uomo?) e la domanda della filosofia della conoscenza (in che modo noi conosciamo le cose?) vengono utilizzate da Platone per sviluppare la tesi circa il ruolo degli imitatori all’interno di uno stato ideale. In effetti, a Platone non soltanto risulterebbe impossibile parlare di «artisti» e in particolare di «arte» come viene intesa da noi oggi, data la comparsa piuttosto recente del termine (soprattutto nella nozione filosofica, esso nasce verso la fine del ‘700 e l’inizio dell’800), ma non gli interessa nemmeno affrontare di per sé il problema di chi siano, che cosa facciano e in che modo debbano essere valutati gli imitatori se non all’interno di un contesto politico, in cui il singolo viene considerato non solo in quanto tale ma anche, e soprattutto, in quanto cittadino e membro di una comunità. Ciò è ulteriormente dimostrato dalla prima apparizione della critica negativa agli imitatori, la quale si verifica nel II-III libro della Repubblica quando viene affrontato il problema dell’educazione dei guardiani, ossia all’interno di un contesto politico dove lo scopo prefissato è la realizzazione di uno stato ideale.
Ma chi sono gli imitatori? Platone, proprio nel II libro, li definisce come coloro che «si occupano di figure e di colori o di musica, poeti con i loro valletti, rapsodi, attori, coreuti, impresari, fabbricanti di ogni sorta di suppellettili oggetti per diversi usi, soprattutto per la moda femminile»[2]. Gli imitatori, così come vengono concepiti da Platone, sono, quindi, una specie particolare di artigiani; essi fanno conseguentemente parte di una di quelle tre classi (artigiani, guerrieri, governanti-filosofi) di cui una città, proprio in quanto ideale, deve comporsi.. Il ruolo degli artigiani è fondamentale per il fatto che essi sono incaricati di produrre i beni di consumo di prima necessità ed è proprio in quanto «produttori» che essi esercitano una teknè. Teknè, termine greco avente come equivalente successivo latino ars, è un’attività che ha come scopo quello di introdurre dei cambiamenti all’interno del mondo naturale, ovvero produrre oggetti che non si trovano in natura. Dopo aver affrontato questo problema, il nostro autore segnala due presupposti di senso comune: in primo luogo il pittore, lo scultore e il poeta non producono alcun oggetto utilitario: in secondo luogo, propone di procedere cercando ciò che accomuna queste attività; il comune denominatore da lui individuato è che il pittore, lo scultore, il poeta non conoscono direttamente gli oggetti, ma li imitano, ossia producono copie di oggetti veri. Il problema centrale del II-III libro della Repubblica consiste, quindi, nel capire se una simile attività vada ammessa all’interno dello Stato ideale, e la risposta a cui giunge Platone va ricondotta all’influenza pedagogica esercitata dal prodotto degli imitatori. Il punto di partenza risulta, inevitabilmente, essere la formazione dei cittadini, e ciò avviene in quanto l’edificazione di una città non può prescindere dall’individuazione delle condizioni che permettono di attingere una retta conoscenza e un retto sapere. Di qui la necessità di prendere in considerazione il problema dell’educazione (paideia) dei cittadini, ossia il modo in cui ciascun individuo e ciascun gruppo di individui viene avviato verso il perfetto svolgimento del proprio ruolo all’interno della società. Platone, per bocca di Socrate, arriva quindi a dire che sarà necessario affidare ad un individuo «un compito solo, quello per cui aveva naturale disposizione e che poteva svolgere bene, attendendovi libero da altre preoccupazioni e svolgendolo per tutta la vita senza lasciarsi sfuggire le occasioni opportune»[3].
Come viene ribadito più volte all’interno della Repubblica, colui che dovrà difendere la città ideale sarà il guardiano, ossia un individuo che dovrà essere «per natura filosofo, animoso, veloce e vigoroso»[4], e per fare in modo che diventi tale sarà necessario educarlo, come detto precedentemente. «Ma come si alleveranno e si educheranno questi nostri uomini? E questo nostro esame non potrà tornarci di qualche utilità per scorgere la meta di tutte le nostre indagini, in che modo nascono in uno stato la giustizia e l’ingiustizia»[5]. Questo passo permette di fare due considerazioni: innanzitutto, è una delle testimonianze testuali in cui viene affermato il fatto, già esposto sopra, che le teorie enunciate nella Repubblica (teorie metafisiche, psicologiche e gnoseologiche) sono inserite all’interno di un quadro politico, in vista di finalità politiche; in secondo luogo, mette in luce che è proprio a partire dalla necessità di una buona educazione che Platone pone l’inizio della questione circa l’utilità o nocività dell’opera degli imitatori.
Tramite la figura di Socrate, Platone sostiene sia l’efficacia prodotta dall’opera degli imitatori, in quanto legata alla loro propria capacità di persuasione, sia la dannosità di cui essi sono portatori. Le nutrici che raccontano le storie di Omero ai fanciulli hanno un ruolo pedagogico notevole, ma poiché «il giovane non è in grado di giudicare ciò che è allegoria e ciò che non lo è»[6] e poiché «tutte le impressioni che riceve a tale età divengono in genere incancellabili e immutabili»[7], ecco che diventa «assai importante che le prime cose udite dai giovani siano favole narrate nel miglior modo possibile con l’intento di incitare alla virtù»[8]. Socrate dichiara se stesso e il suo interlocutore Adimanto «fondatori di uno stato»[9], ed è proprio ai fondatori che «s’addice conoscere i modelli ai quali si debbono adeguare i poeti nella narrazione delle favole loro; e se i poeti non vi si attengono nella loro invenzione, non devono lasciarli fare»[10]. Raccontare i vizi degli Dei o le debolezze degli eroi può avere un effetto negativo sull’educazione dei guerrieri: infatti, prima di tutto «c’è pericolo che facciano sorgere nei nostri giovani grande facilità a commettere male»[11], data la tendenza a giustificare le proprie colpe facendo appello alla convinzione che anche gli dèi le commettono; c’è poi il rischio che i guerrieri diventino timorosi ed emotivi. Tutto ciò vale anche per le rappresentazioni teatrali e per le «armonie languide»[12] in virtù del loro considerevole condizionamento. Dunque deve essere esercitato un controllo di tipo censorio rispetto all’attività degli imitatori; essi possono essere, infatti, accettati soltanto nella misura in cui non disturbano il processo di educazione ideale soprattutto delle classi guerriere e dei governatori, ossia di quelle classi che hanno il fondamentale compito di difendere e legiferare.
Apparentemente, sembra che Platone abbia detto tutto ciò che poteva dire circa il ruolo delle pseudo-arti dal punto di vista filosofico-politico, ma in realtà nel X libro della Repubblica avanza la tesi secondo cui nello Stato ideale gli imitatori devono essere espulsi anche nel caso di un possibile controllo censorio su ciò che essi trasmettono ai cittadini. La condanna delle arti imitative, in particolare della pittura e della poesia, svolta nel X libro, non si fonda su ragioni di tipo politico-pedagogico come nel II-III libro, ma viene valutata sulla base di argomenti di metafisica, psicologia e teoria della conoscenza. Se nel II libro la poesia viene condannata in relazione all’educazione dei guerrieri o custodi della città ideale, in quanto contenente raffigurazioni errate e moralmente fuorvianti, nel X libro essa, insieme alla pittura, viene segnata da una profonda svalutazione metafisico-gnoseologica. In questo testo Platone comincia con l’interrogarsi sul senso dell’imitazione (mimesis), e lo fa a partire da un celebre esempio in cui prende in considerazione un oggetto banale e ordinario, un «letto». Se ci chiediamo quanti tipi di letti possano esistere, siamo condotti a riconoscere che è possibile parlare di tre tipi diversi: l’idea di letto, che deve essere considerata come ciò che è più propriamente il letto; il letto che viene fabbricato da un artigiano sul modello dell’idea; il letto dipinto da un pittore che si dedica alla rappresentazione della realtà sensibile. Questo accade per il fatto che, come viene ampiamente spiegato dalla teoria delle idee, agli oggetti fisici, cioè agli enti sensibili esistenti nella realtà, corrispondono delle entità ideali nell’Iperuranio, cioè «oggetti» definiti dalle loro caratteristiche essenziali. Platone ipotizza che queste entità ideali sono state prodotte da un Demiurgo, cioè un Dio, un’entità divina che le produce così come gli artigiani producono gli oggetti fisici che vengono da noi utilizzati. Riprendendo la tripartizione dei «letti», secondo Platone, ad essi corrispondono tre artefici: l’idea del letto è creata da un dio che crea le idee secondo natura (Demiurgo); il letto «fabbricato» è prodotto da un artefice (artigiano) che rivolge il proprio sguardo all’idea soprasensibile; quello «dipinto» è creato da un pittore che non si rivolge all’idea, bensì al letto sensibile fabbricato dall’artigiano, e quindi non può essere definito propriamente un artefice bensì soltanto un «imitatore» (mimetes).
Il pittore non imita dunque la realtà e la verità delle idee, ma l’apparenza delle cose sensibili, che a loro volta non sono che imitazioni delle idee: la sua è perciò «copia di una copia», imitazione di un’imitazione, ed per questo che si può affermare che egli produce «apparenze, non cose reali»[13] e che può essere definito «imitatore dell’oggetto di cui gli altri sono artigiani»[14]. In questo senso, in quanto lontano dall’idea, il pittore sarà il «terzo a partire dal re e dalla verità»[15], e lo stesso avverrà per il poeta. Pittori e poeti distano, secondo Platone, tre volte dalla vera realtà e le loro produzioni danno vita a pure parvenze e non a enti reali; per questo motivo, essi non sono altro che creatori di eidola, ossia di «immagini ingannevoli» perché non conformi all’idea. Quindi, se volessimo fare una sorta di equivalenza, potremmo dire che l’imitatore sta all’artigiano esattamente come l’artigiano sta all’imitatore e che, conseguentemente, il prodotto dell’imitatore sta al prodotto dell’artigiano come il prodotto dell’artigiano sta a quello del Demiurgo. Un letto dipinto o un letto descritto da un poeta somigliano semplicemente al letto fisico, non a quello ideale; infatti, in questo caso il rapporto di imitazione è radicalmente difettivo. Dal punto di vista della teoria della metafisica, la copia del letto che viene prodotta da un pittore non solo non è «vera» ma corrisponde a un «non-letto»; in sostanza, quest’imitazione è talmente imperfetta da fare di questo un «non-ente», una cosa inconsistente. Platone, per precisare meglio la sua argomentazione, dimostra che quando siamo di fronte a un letto dipinto, noi non vediamo le stesse cose che potremmo vedere dinanzi a un letto reale: cambia la forma, non è possibile toccarlo, non è possibile utilizzarlo. Ciò significa che le uniche proprietà che vengono ad essere condivise tra la copia del prodotto di imitazione e l’oggetto che viene imitato sono le «proprietà sensibili», ossia il mero aspetto sensibile: il colore, la forma e via discorrendo. Per Platone «l’arredo metafisico» dell’universo è quindi dato dalle entità ideali, dalle entità logico-matematiche, dagli «eidola». Il letto dipinto e qualsiasi altro prodotto dell’imitatore ricade nella classe delle entità metafisiche non reali, non consistenti; entità che possono, però, essere anche naturali, non prodotte dall’essere umano e conseguenti di per sé stesse in natura (riflessi, ombre…).
Riassumendo quanto finora detto, possiamo affermare che nel X libro è presente un doppio livello, ossia uno ontologico ed uno gnoseologico. Il livello ontologico è quello che è stato appena trattato, ossia quello relativo alle cose «quali sono»; in sostanza, esso prevede l’esistenza di tre entità: ideali, le cose che cadono sotto i nostri sensi (oggetti fisici) e le immagini. Per quanto riguarda, invece, il piano gnoseologico bisogna considerare i tre tipi di «soggetti» (artefici) capaci di conoscere i tre tipi di entità. Sia il Demiurgo sia gli artigiani possiedono un certo tipo di sapere: quello del Demiurgo è un sapere perfetto, in quanto egli è la causa stessa e origine delle idee; il sapere dell’artigiano, pur essendo un sapere imperfetto, è comunque classificabile come sapere; chi produce immagini, ossia copia gli oggetti fisici, non possiede una conoscenza degna di questo nome. Da questa premessa si sviluppano, poi, due tesi: innanzitutto le immagini non sono oggetti genuini; in secondo luogo, sia i soggetti che producono sia gli oggetti che vengono prodotti ingannano necessariamente e, questo, non poiché i «produttori di immagini» sono animati da cattiva volontà, ma è in virtù dell’«ontologia» degli oggetti da essi realizzati che ciò avviene. Il motivo di ciò va ricercato all’interno della teoria della conoscenza e della psicologia esposte sia nella Repubblica sia in altri dialoghi; il punto centrale risiede nel fatto che l’attività dell’imitare si basa unicamente sulla capacità di accedere mediante i sensi alle immagini presenti in natura. Nella Repubblica l’«argomento gnoseologico» su cui viene sviluppata la condanna alle arti imitative è esposto alla fine del VI libro, dove Platone inferisce la cosiddetta «teoria della linea», che a sua volta introduce il «mito della caverna», ossia la condizione dell’uomo raccontata attraverso il mùthos. Socrate chiede al suo interlocutore di paragonare la natura umana a ciò che avviene «dentro una dimora sotterranea a forma di caverna, con l’entrata aperta alla luce e ampia quanto tutta la larghezza della caverna»[16]; gli chiede inoltre di «vedere degli uomini che vi stiano dentro fin da fanciulli, incatenati gambe e collo, sì da dover stare fermi e da poter vedere soltanto avanti, incapaci, a causa della catena di volgere attorno il capo»[17]. Dietro questi uomini, che hanno lo sguardo rivolto alla parete della caverna, arde un fuoco, e tra essi e il fuoco scorre un muro, dietro il quale passano altri uomini che «portano lungo il muricciolo oggetti di ogni sorta sporgenti dal margine, e statue e altre figura di pietra e legno in qualunque modo lavorate»[18]. Essendo legati e costretti a guardare verso la parete, l’unica forma di conoscenza a loro possibile è quella che ha per oggetto immagini sbiadite, ossia «le ombre proiettate dal fuoco sulla parete della caverna»[19]. Se però fosse loro consentito liberarsi, alzarsi e uscire dalla caverna potrebbero vedere dapprima gli oggetti che proiettano le ombre al di là del «muricciolo» e poi, via via, la luce del sole, gli oggetti da esso resi visibili ed infine il sole stesso. Il mito platonico qui riportato può essere definito come una vera e propria metafora della vita umana e, in particolare, come l’immagine dell’ascesa dell’anima al mondo intelligibile. Infatti Platone imposta la sua teoria soffermandosi sull’esistenza di una piena corrispondenza tra grado e perfezione di essere degli oggetti conoscibili e grado o perfezione della conoscenza che li riguarda: è, in altri termini, la corrispondenza tra ontologia e gnoseologia. Platone innanzitutto distingue due grandi classi: gli oggetti sensibili e gli oggetti afferrabili soltanto con l’intelletto. Il primo dominio è suddivisibile in altre due sezioni: quella delle ombre o delle immagini generate dalla proiezioni su superfici riflettenti di oggetti sensibili (acqua, specchi…); e quella degli oggetti sensibili veri e propri (pietre, piante, animali…). Seguendo la corrispondenza gnoseologica, a questi due ambiti corrispondono due gradi inferiori di conoscenza, ossia rispettivamente, l’eikasia (percezione delle immagini) e la pistis (la credenza, che coglie gli oggetti che a tali immagini danno luogo). Sempre sul piano gnoseologico, questi due tipi di conoscenza costituiscono il dominio dell’opinione (doxa), la quale è instabile e fluttuante come i suoi oggetti. La seconda classe, ossia quella degli oggetti che si possono cogliere solo attraverso l’uso dell’intelletto, è anch’essa suddivisibile in due sezioni: le entità matematiche e le idee. Di nuovo, sul piano gnoseologico, le prime vengono colte dalla dianoia (conoscenza che procede mediante ragionamenti), le seconde dalle noesis (conoscenza intellettuale vera e propria delle idee). In questo caso, diversamente dalle cose sensibili, i due gradi della conoscenza degli oggetti intelligibili costituiscono l’episteme, ossia la conoscenza, il cui accesso è reso possibile dalla filosofia. Il punto essenziale di questa argomentazione è che se delle entità ideali e degli oggetti fisici possiamo avere un certo tipo di conoscenza, per quanto concerne le immagini si può asserire che non possiamo averne alcuna. La ragione di ciò va ricercata nelle concezione platonica dell’aistesis (sensazione) che Platone distingue dalla doxa (opinione); Platone dimostra la veridicità della sua tesi confutando quella secondo cui la conoscenza consiste nel percepire le cose come sono con le loro caratteristiche. Egli, infatti, sostiene che se avere conoscenza significasse avere semplice «percezione» (aistesis), allora una medesima cosa apparirebbe diversa a seconda dal soggetto conoscente o a seconda delle possibili alterazioni degli organi di senso. Avere sensazione non significa né conoscere in modo perfetto né conoscere male; essa non è né giusta né sbagliata e, per tutti questi motivi, non può essere considerata conoscenza.
Cosa ben diversa è, per Platone, la formulazione di giudizi. Innanzitutto, per il filosofo greco, ci sono delle caratteristiche del mondo che sono proprie degli oggetti fisici, e tra queste caratteristiche rientra la somiglianza. Essere simile è qualcosa che noi non percepiamo mai, poiché la somiglianza di per sé stessa non cade sotto i nostri sensi. Sicché noi diciamo che due cose sono simili anche quando esse sono visibilmente diverse; ciò è possibile attraverso l’utilizzo di un’ulteriore «facoltà», il giudizio. Il giudicare, secondo Platone, è un criterio minimo di conoscenza e dove vi è traccia di giudizio non è possibile parlare di conoscenza bensì di opinione. Nel Teeteto, Platone prosegue elencando due ulteriori caratteristiche dell’opinione: in primo luogo, le opinioni esprimono qualcosa che può essere suscettibile di verità e falsità ma, per poter essere considerate conoscenza, devono poter esprimere unicamente qualcosa di vero; in secondo luogo, un’opinione deve essere anche giustificata. Tale concezione è inoltre rintracciabile nello Ione, in cui la condanna delle arti imitative trova il suo fondamento proprio; in questo dialogo, Platone, nel confrontarsi con la poesia, si misura con il prestigio che la tradizione poetica aveva acquisito nella società a lui contemporanea e con il primato ad essa attribuito dalla sofistica. Protagora di Abdera, Gorgia da Lentini, Prodico di Ceo o Ippia di Elide, attivi già prima della nascita di Platone, si presentavano in veste di educatori e di maestri di sapienza, quest’ultima attinta dalla tradizione culturale di Omero. Al mondo della poesia e della tradizione, alla cultura orale formatasi grazie all’insegnamento e alla recitazione dei rapsodi, Platone oppone invece una nuova forma di sapere, la dialettica, che è la vera e propria essenza della ricerca filosofica. La dialettica impone l’obiettivo di condurre chi vi partecipa al di là del mondo sensibile in direzione del mondo delle idee, attraverso due momenti: innanzitutto attraverso la riconduzione del molteplice sensibile all’unità dell’idea (synagoghe); poi, attraverso la divisione dell’idea stessa nelle sue articolazioni interne (diairesis). Secondo Platone, la forma letteraria che più si addice alla filosofia è quella dialogica, in quanto essa rispecchia nel miglior modo possibile tale procedimento. Come è stato detto precedentemente, la concezione dell’opinione trova all’interno dello Ione una ulteriore legittimazione. Socrate, infatti, interroga il rapsodo (Ione) circa il fondamento delle sue conoscenze, ed egli si appella all’ispirazione divina, all’estasi, all’invasamento. Da questa risposta, Socrate elabora la sua condanna, sostenendo quanto segue:
«tutti i bravi poeti epici non per capacità artistica ma in quanto ispirati e posseduti compongono tutti questi bei poemi, e la cosa vale anche per i bravi poeti melici; come i coribanti danzano solo quando sono fuori di senno, così anche i poeti melici compongono queste belle poesie solo quando sono fuori di senno. Ma una volta che siano entrati nella sfera dell’armonia e del ritmo, cadono in preda a furore bacchico e a invasamento, così come le baccanti che attingono miele e latte dai fiumi quando sono possedute, ma quando sono in sé non lo fanno; e l’anima dei poeti melici si comporta allo stesso modo,come appunto essi dicono. Infatti i poeti certo ci raccontano che, attingendo i loro versi da fontane di miele, da giardini e dalle valli boscose delle Muse, li portano a noi come le api, volando anche loro come esse, e dicono la verità, poiché il poeta è un essere etereo, alato e sacro e non è capace di comporre prima di essere ispirato e fuori di sé e prima che non vi sia più in lui il senno».[20]
Il concetto di «ispirazione» poetica proveniente da dio ritorna nel Fedro, in cui Platone tenta di delineare un quadro sistematico delle forme di divina ispirazione, fra cui rientra anche la poesia. Si possono dunque trovare, all’interno di questo dialogo, quattro forme di «mania che proviene dagli dèi»[21], ossia quella profetica, quella rituale-telestica, quella erotica e quella poetica. La poetica, in particolare, viene descritta come un tipo di «invasamento e di mania proveniente dalle Muse. Questa mania, dopo essersi impossessata di un’ anima sensibile e pura, la risveglia suscitando in essa ispirazione bacchica per i canti e per gli altri generi di poesia e, attraverso la celebrazione di innumerevoli imprese degli antichi, educa i posteri. Invece, chiunque si presenti alle porte della poesia senza essere ispirato dalla mania delle Muse, convinto che gli basterà la tecnica per essere un bravo poeta, sarà un poeta mancato, perché la poesia di chi é in sé viene oscurata da quella di coloro che sono in preda a mania»[22].
Finora, ancorandoci a diverse fonti, abbiamo fatto prevalere la figura di un Platone che condanna e rifiuta nettamente e senza riserve l’opera degli imitatori, non cogliendo le proposte alternative alle forme di mimesis. All’interno del Sofista, Platone presenta la distinzione tra una mimesis icastica, che produce un’immagine fedele al proprio modello, e una mimesis dell’apparenza, che invece produce un tipo di immagine che si allontana al modello di riferimento. In questo caso, Platone ammette l’imitazione, ma solo nel momento in cui essa rimanga fedele al primato dell’idea. In un altro dialogo dell’ultima fase, il Timeo, Platone ammette un tipo di imitazione che rispetta il primato del modello intelligibile. In quest’opera, Platone si occupa della creazione dell’uomo da parte di un Demiurgo, il quale dà vita al mondo sensibile tenendo lo sguardo rivolto al mondo delle idee in modo tale da creare il cosmo a immagine fedele dell’archetipo ideale. In questo caso, l’imitazione può assumere un duplice ruolo a seconda che rispetti o meno il primato dell’idea: da un lato, l’imitazione dà vita a un’immagine fedele ed è testimonianza del rapporto di partecipazione che lega il mondo delle idee a quello sensibile; dall’altro lato, l’imitazione produce un’immagine ingannevole che tralascia il riferimento all’idea, finendo per essere copia di una copia.
Nonostante la presenza di alcuni passi in cui la condanna appare meno «aggressiva», in generale l’arte risulta essere la vittima,o meglio, il nemico contro cui Platone combatte al fine di estirpare dalla società tutti i possibili mali, proprio come, per riprendere la metafora della medicina più volta presente all’interno della Repubblica, un medico cerca di eliminare il morbo dal corpo malsano; l’obiettivo di Platone è quindi quello di realizzare uno Stato ideale in cui ogni singola parte segua l’ordine della filosofia e in cui gli individui vengano spogliati dal velo oscuro dell’illusione creato dalle arti imitative.
[1] M. Vegetti, Guida alla lettura della Repubblica di Platone, Laterza, Roma–Bari 2004, p. 5.
[2] Platone, Repubblica, 373 c; tr. it. a cura di M. Vegetti, Laterza, Roma–Bari 2005, p. 81.
[3] Ivi, p. 82.
[4] Ivi, p. 84.
[5] Ivi, pp. 84-85.
[6] Ivi, p. 87.
[7] Ibidem.
[8] Ibidem.
[9] Ibidem.
[10]Ibidem.
[11] Ivi, p. 102.
[12] Ivi, p. 110.
[13] Ivi, p. 319.
[14] Ivi, p. 318.
[15] Ibidem.
[16] Ivi, p. 229.
[17] Ibidem.
[18] Ibidem.
[19] Ibidem.
[20] Platone, Ione, 533 d ss.; tr. it. in Platone. Tutti gli scritti, Bompiani, Milano 2000, a cura di G. Reale, p. 1027.
[21] Platone, Fedro, 245 b; tr. it. in Platone. Tutti gli scritti, cit., p. 554.
[22] Ibidem.
L’ESTETICA DI ARISTOTELE

L’esperienza è conoscenza dei particolari, mentre l’arte è conoscenza degli universali. (Aristotele, Metafisica)
A cura di Claudia Bianco
ARISTOTELE
Platone e Aristotele: tra Repubblica e Etica Nicomachea
Aristotele non critica e non affronta direttamente la condanna delle arti imitative avanzata da Platone nel X libro della Repubblica, piuttosto espone, in modo molto più dettagliato e sistematico, una concezione alternativa di teknè; su questa base, egli rigetta il presupposto platonico, secondo cui imitare significa produrre delle copie degli oggetti da noi percepiti tramite i sensi, e propone una nozione di mimesis (imitazione) non fondata semplicemente sull’aistesis (sensazione), ma implicata in una serie di meccanismi molto più complessi. Aristotele, inoltre, sviluppa, in sede psicologica, una teoria sulla facoltà di desiderare e appetire che va diametralmente contro la tesi platonica secondo la quale sono presenti nell’anima delle facoltà indipendenti, suddivise in razionali e irrazionali, il cui rapporto costituisce il fondamento di un’anima «giusta», ossia di un’anima in cui le facoltà razionali esercitano una coercizione volta alla sottomissione di quelle irrazionali.
Per comprendere la nozione aristotelica di tecnica e per riuscire a cogliere la distanza che la separa da quella platonica, è necessario fare un passo indietro e riprendere le parole di Platone stesso. In primo luogo, nel X libro, egli definisce il prodotto dell’imitatore come «una realizzazione frequente e veloce, anzi velocissima»[1] che consiste in «prendere uno specchio e girarlo in ogni direzione»[2] creando in tal modo «il sole e i corpi celesti, la terra, gli altri esseri viventi, gli oggetti, le piante»[3]; in secondo luogo, distingue l’arte di chi sa usare gli strumenti e gli utensili, l’arte di chi sa produrre questi strumenti e utensili e, infine, la pseudo-arte che li imita. Distinti questi tre tipi di arte («quella che ne farà uso, quella che lo realizzerà, quella che lo imiterà»[4]), Platone, per bocca di Socrate, domanda al suo interlocutore se concorda sul fatto che la virtù, la bellezza, la perfezione di ogni singolo oggetto, essere vivente e azione riguardino soltanto l’uso per il quale ciascuno di essi è fabbricato o esiste in natura e, dopo aver ricevuto esito positivo al suo interrogativo, sostiene che «chi adopera ogni singolo oggetto deve per forza averne la maggiore esperienza e riferire al fabbricante i pregi e i difetti che si rivelano all’uso; ad esempio un flautista dà spiegazioni al costruttore di flauti sugli strumenti che gli servono nel suo mestiere e gli ordinerà come deve fabbricarli, e quello obbedirà»[5]. Da ciò deduce, innanzitutto, che «il fabbricante avrà delle idee giuste sulla perfezione e l’imperfezione dello stesso oggetto, perché frequenta l’esperto ed è costretto ad ascoltarlo»[6]; in secondo luogo, che «solo chi lo utilizza ne avrà la scienza»; in terzo luogo, che l’imitatore, non potendo sapere dall’uso se ciò che ha dipinto possa essere giudicato positivamente e non potendo ricavare una corretta opinione dal suo necessario contatto con l’esperto[7], «non possiederà né la conoscenza né la retta opinione sui pregi e i difetti di ciò che imita»[8].
L’elemento centrale dell’argomentazione di Platone è la distinzione tra il sapere di chi sa usare un oggetto e di chi lo produce. Colui che conosce, in qualche misura, l’idea degli oggetti prodotti è colui che sa usarli, mentre chi li produce ne ha conoscenza per semplice opinione. Dunque a questo livello vanno distinti due tipi di artigiano: uno che conosce l’idea, usando lo strumento; l’altro che ne riceve l’opinione, producendolo. Per Platone, infatti, conoscere lo scopo per cui è realizzato un oggetto significa conoscerne una caratteristica ideale essenziale, cioè la perfezione. Ogni gruppo di oggetti, quindi, avrà, tra le tante caratteristiche, quella della perfezione, che consiste, nel caso degli utensili, allo scopo per il quale essi vengono realizzati; la conseguenza a cui giunge Platone, attraverso l’esempio del flautista sopra citato, è che tale conoscenza ideale non potrà mai essere propria degli artigiani-produttori, in quanto questi ultimi risulteranno essere possessori di un tipo di sapere volto ad altre caratteristiche dell’oggetto in questione. Dunque vi sarà un artigiano che ha scienza (episteme), e uno che ne avrà mera doxà (opinione); naturalmente, l’imitatore non possiederà nulla di tutto ciò. Nasce, in tal modo, la figura di un «scienziato-artigiano», il quale non necessariamente produce oggetti, ma utilizza quelli creati da altri per raggiungere i suoi obiettivi, in quanto conoscitore dello scopo vero per cui tali oggetti vengono prodotti.
Uno dei motivi centrali, per il quale è stato necessario riprendere la concezione platonica della tecnica e del sapere ad essa inerente, è la possibilità di leggere, attraverso una prospettiva più esterna, la filosofia aristotelica, la quale si posiziona su un versante opposto rispetto a quella platonica. Aristotele nel I libro della Metafisica, prima ancora di pronunciare l’interessante critica alla teoria delle idee di Platone, attacca la concezione del rapporto tra scienza, sapere degli artigiani e sapere degli imitatori, di cui si è appena trattato. In particolare, da un lato Aristotele spezza questa continuità tra buon artigiano e scienziato (per Aristotele, uno scienziato vero non è un artigiano di livello superiore, ma ha qualcosa in più); per un altro verso, dimostra che anche colui che imita possiede un certo tipo di sapere. L’argomento, che si scontra con la teoria platonica, è rintracciabile nelle prime pagine della Metafisica di Aristotele, ma, prima di entrare nel merito della questione, è di nuovo necessario fare riferimento a un altro testo aristotelico per poter comprendere più facilmente la tesi sviluppata dallo Stagirita. L’Etica Nicomachea presenta il carattere distintivo di utilizzare una terminologia specifica, introdotta da Aristotele stesso, per parlare di coloro che Platone denominava artigiani. Qui, Aristotele traspone la nozione di «prassi», che rappresenta il fulcro argomentativo dell’opera, su un piano assolutamente astratto. La Praxis, secondo Aristotele, viene condivisa dagli uomini e da qualsiasi altra entità naturale, in quanto essa è propriamente azione, attività in generale (ad esempio anche il semplice movimento) ed è quindi una caratteristica comune a più esseri viventi. Aristotele afferma, poi, che esistono due tipologie di attività pratiche che non possono essere attribuite agli altri soggetti presenti in natura (piante e animali) e che, conseguentemente, sono proprie dell’individuo, ossia l’azione umana e la produzione (poesis); esse si distinguono per il fatto che l’azione ha il proprio fine in se stessa, ossia nel compimento dell’azione stessa, mentre la produzione ha il suo fine fuori di sé, ossia nell’oggetto che essa produce. Utilizzando esempi efficaci per chiarificare e confermare le sue posizioni, Aristotele ammette quindi che:
«ogni tecnica praticata metodicamente, e, ugualmente, ogni azione realizzata in base a una scelta, mirino ad un bene: perciò a ragione si è affermato che il bene è “ciò cui ogni cosa tende”1. Ma tra i fini c’è un’evidente differenza: alcuni infatti sono attività, altri sono opere che da esse derivano. [5] Quando ci sono dei fini al di là delle azioni, le opere sono per natura di maggior valore delle attività. E poiché molte sono le azioni, le arti e le scienze, molti sono anche i fini: infatti, mentre della medicina il fine è la salute, dell’arte di costruire navi il fine è la nave, della strategia la vittoria, dell’economia la ricchezza. [10] Tutte le attività di questo tipo sono subordinate ad un’unica, determinata capacità: come la fabbricazione delle briglie e di tutti gli altri strumenti che servono per i cavalli è subordinata all’equitazione, e quest’ultima e ogni azione militare sono subordinate alla strategia, così allo stesso modo, altre attività sono subordinate ad attività diverse. In tutte, però, i fini delle attività architettoniche [15] sono da anteporsi a quelli delle subordinate: i beni di queste ultime infatti sono perseguiti in vista di quei primi. E non c’è alcuna differenza se i fini delle azioni sono le attività in sé, oppure qualche altra cosa al di là di esse, come nel caso delle scienze suddette.»[9]
«Produrre» significa, quindi, provocare cambiamenti che non si verificherebbero se non intervenisse un’attività specificatamente umana. Ora, è necessario indirizzare l’attenzione su due punti fondamentali: in primo luogo, sarà possibile parlare di teknè solo se le attività umane produrranno oggetti e cambiamenti non presenti in natura; in secondo luogo, non si potrà parlare di tecnica, ma piuttosto di saggezza e di scienza, per quei saperi che, secondo Aristotele, reggono le attività teoretiche. Circa questa seconda tesi le parole del filosofo sono le seguenti:
«Ammettiamo, dunque, che le disposizioni per cui l’anima coglie il vero con un’affermazione o con una negazione siano cinque di numero: e queste sono l’arte, la scienza, la saggezza, la sapienza, l’intelletto; il giudizio e l’opinione no, perché ad essi è possibile ingannarsi. Che cosa è, dunque, la scienza, se dobbiamo parlare con rigore e non tener dietro a similitudini, risulta chiaro da quanto segue. [20] Tutti ammettiamo che ciò di cui abbiamo scienza non può essere diversamente da quello che è: ciò, invece, che può essere anche diverso, quando è fuori dal campo della nostra osservazione, non si sa più se esiste o no. In conclusione, l’oggetto della scienza esiste di necessità. Quindi è eterno: gli enti, infatti, che esistono di necessità assoluta sono tutti eterni, e gli enti eterni sono ingenerati e incorruttibili. [25] Inoltre, si ritiene che ogni scienza sia insegnabile e che ciò che è oggetto di scienza può essere appreso. Ogni insegnamento, poi, procede da conoscenze precedenti, come diciamo anche negli Analitici149: procede, infatti, o mediante l’induzione o mediante il sillogismo. Ora, l’induzione è principio di conoscenza anche dell’universale, mentre il sillogismo procede dagli universali. Ci sono, [30] dunque, dei principi da cui il sillogismo procede, ma dei quali non è possibile sillogismo: dunque, si ottengono per induzione. In conclusione, la scienza è una disposizione alla dimostrazione, insieme con tutti gli altri caratteri che abbiamo definito negli Analitici 150, giacché quando si è giunti ad una determinata convinzione e quando i principi ci sono noti, si ha scienza. Infatti, se i principi non sono più noti della conclusione, [35] si avrà scienza solo per accidente. Si consideri conclusa in questo modo la definizione di scienza.»[10]
Tutto questo presupposto, ampiamente argomentato nell’Etica Nicomechea, è il fondamento dell’affermazione pronunciata da Aristotele nel I libro della Metafisica.
La Metafisica e la gerarchia delle conoscenze
«Tutti gli uomini per natura tendono al sapere. Segno ne è l’amore per le sensazioni: infatti, essi amano le sensazioni per se stesse, anche indipendentemente dalla loro utilità, e, più di tutte amano la sensazione della vista: in effetti, non solo ai fini dell’azione, ma anche senza avere alcuna intenzione di agire, noi preferiamo il vedere, in certo senso, a tutte le altre sensazioni. E il motivo sta nel fatto che la vista ci fa conoscere più di tutte le altre sensazioni e ci rende manifeste numerose differenze fra le cose.»[11]
Si possono svolgere alcune considerazioni circa il passo sopra riportato: innanzitutto, la riabilitazione, sviluppata anche in altre opere, delle sensazioni, a cui viene attribuita la capacità di fornire un certo tipo di conoscenza; in secondo luogo, è possibile rilevare l’importanza della distinzione tra scienza/sapere e utilità pratica, che implica una naturale tendenza degli uomini al perseguimento del sapere fine a sé stesso, indipendentemente dalla sua capacità di reggere attività pratiche rivolte a qualche scopo. Terzo elemento, è la rivalutazione della capacità irrazionale e naturale di provare piacere e dispiacere: secondo Aristotele, diversamente da Platone, il piacere sensibile non deve essere ascritto ad una facoltà dell’anima del tutto irrazionale, soggetta ad un controllo coercitivo esercitato dalla facoltà razionale, ma può essere posto sotto l’influenza della riconciliazione tra il piacere del sapere fine a se stesso e il piacere conseguibile nell’esercizio della conoscenza. Accennati questi versi che allontano Aristotele da Platone, si sviluppa un discorso la cui finalità sarà quella, in Poetica e Retorica, di assegnare alle arti mimetiche e alle arti della parola la qualifica di tecniche. Aristotele, asserisce poi
«che gli animali sono naturalmente forniti di sensazione; ma, in alcuni, dalla sensazione non nasce la memoria, in altri, invece, nasce. Per tale motivo questi ultimi sono più intelligenti e più atti ad imparare rispetto a quelli che non hanno capacità di ricordare. Sono intelligenti. Ma senza capacità di imparare, tutti gli animali che non hanno facoltà di udire i suoni (per esempio l’ape e ogni altro animale di questo tipo); imparano, invece, tutti quelli che, oltre la memoria, posseggono anche il senso dell’udito.»[12]
Lo Stagirita incomincia, qui, a trattare le capacità psicologiche che ricadono sotto il gruppo delle facoltà riconducibili all’aistesis; infatti, Aristotele annovera, tra le facoltà strettamente legate alla sensazione, la memoria. La base dell’argomento è la constatazione che anche alcuni animali, e dunque non solo gli esseri umani, sono in grado di apprendere. Gli animali non possiedono la ragione, non hanno la capacità di riflessione, ma va ammesso che sono provvisti di qualcosa di analogo alla ragione; «analogo» in quanto permette loro di mutare comportamento in modo vantaggioso in funzione dell’acquisizione di esperienza, pur diversificandosi dagli uomini nella loro incapacità di apprendere gli intelligibili. Gli animali, similmente agli esseri umani, apprendono in quanto non possiedono solamente capacità percettive immediate e momentanee, ma possiedono anche la memoria delle sensazioni; conseguentemente, grazie all’accumulo di conoscenze minime date dalle sensazioni, modificano i loro atteggiamenti. Prosegue Aristotele:
«Orbene, mentre gli animali vivono con immagini sensibili e con ricordi, e poco partecipano dell’esperienza, il genere umano vive, invece, anche d’arte e di ragionamenti. Negli uomini, l’esperienza deriva dalla memoria: infatti, molto ricordi dello stesso oggetto giungono a costituire un’esperienza unica. L’esperienza, poi, sembra essere alquanto simile alla scienza e all’arte: in effetti, gli uomini acquistano scienza e arte attraverso l’esperienza. L’esperienza, infatti, come dice Polo, produce l’arte, mentre l’inesperienza produce il puro caso. L’arte si genera quando, da molte osservazioni di esperienza, si forma un giudizio generale ed unico riferibile a tutti i casi simili. Per esempio, il giudicare che a Callia, sofferente di una determinata malattia, ha giovato un certo rimedio, e che questo ha giovato anche a Socrate e a molti altri individui, è proprio dell’esperienza; invece il giudicare che a tutti questi individui, ridotti ad unità secondo la specie, sofferenti di una certa malattia, ha giovato un certo rimedio (per esempio ai flemmatici o ai biliosi o ai febbricitanti) è proprio dell’arte. Orbene, ai fini dell’attività pratica, l’esperienza non sembra differire in nulla dall’arte; anzi, gli empirici riescono anche meglio di coloro che posseggono la teoria senza la pratica. E la ragione sta in questo: l’esperienza è conoscenza dei particolari, mentre l’arte è conoscenza degli universali; ora, tutte le azioni e le produzioni riguardano il particolare: infatti il medico non guarisce l’uomo se non per accidente, ma guarisce Callia o Socrate o qualche altro individuo che porta un nome di questi, al quale, appunto, accade di essere uomo. Dunque, se uno possiede la teoria senza l’esperienza e conosce l’universale ma non conosce il particolare che vi è contenuto, più volte sbaglierà la cura. Perché ciò a cui è diretta la cura è, appunto, l’individuo particolare.»[13]
Aristotele utilizza più volte alcuni termini particolari come pratica, tecnica, arte, prassi, scienza, e affianca ad essi l’elemento essenziale dell’esperienza; in sostanza, riportando casi empirici di medicina e basandosi sulla capacità naturale di acquisire conoscenza, afferma che il primo livello del sapere è l’esperienza acquisibile attraverso le facoltà legate alla sensazione e alla memoria. Vi è, poi, un secondo livello di sapere, in cui le facoltà, specificatamente umane, garantiscono la formulazione di ragionamenti a carattere generale, i quali conducono all’osservazione di casi singolari, permettendo l’elaborazione di giudizi. Per Aristotele vale la distinzione tra il sapere dell’arte e quello della scienza; distinzione che si verifica non dal punto di vista delle qualità del sapere ma da quello dell’efficacia pratica.
«E, tuttavia, noi riteniamo che il sapere e l’intendere siano propri più all’arte che all’esperienza, e giudichiamo coloro che posseggono l’arte più sapienti di coloro che posseggono la sola esperienza, in quanto siamo convinti che la sapienza, in ciascuno degli uomini, corrisponda al loro grado di conoscere. E, questo, perché i primi sanno la causa, mentre gli altri non la sanno. Gli empirici sanno il puro dato di fatto, ma non il perché di esso; invece gli altri conoscono il perché e la causa. Perciò noi riteniamo che coloro che hanno la direzione nelle singole arti siano più degni di onore e posseggano maggiore conoscenza e siano più sapienti dei manovali, in quanto conoscono le cause delle cose che vengon fatte; invece i manovali agiscono, ma senza sapere ciò che fanno così come agiscono alcuni degli esseri inanimati, per esempio, così come il fuoco brucia: ciascuno di questi esseri inanimati agisce per un certo impulso naturale, mentre i manovali agiscono per abitudine. Perciò consideriamo i primi più sapienti, non perché capaci di fare, ma perché in possesso di un sapere concettuale e perché conoscono le cause.»[14]
Aristotele svolge qui un altro argomento: pone la differenza tra semplice esperienza e arte. Precedentemente, Aristotele distingueva tra il sapere dell’artista e quello dello scienziato, sostenendo che il sapere dello scienziato mira alla conoscenza dell’universale, mentre quello del tecnico punta a una conoscenza di casi particolari. Dunque, giunge all’introduzione di un ulteriore caratteristica della conoscenza, ossia la conognizione delle cause. Definire la scienza come conoscenza del «che» e non del «perché» le cose vadano in un certo modo, serve ad introdurre la distinzione tra esperienza e arte. Infatti l’avere semplicemente esperienza non è sufficiente per avere arte; noi distinguiamo il capo mastro dal semplice manovale su questa base. Il semplice manovale agisce come un essere inanimato sulla base delle semplici conoscenze che possono essere attribuite anche ad una animale; mentre, agiscono per arte coloro che conoscono il perché bisogna agire in un certo modo.
La Retorica e la Poetica . Verso la riabilitazione etica dell’arte
La concezione di tecnica e del sapere inerente alle arti è rintracciabile tra le righe della Retorica, opera che non solo non ammette la condanna degli imitatori mossa da Platone, ma difende a pieno titolo l’attività svolta dai retori. Per Platone era necessario espellerli dallo stato ideale essenzialmente per due motivi: innanzitutto in quanto si proclamavano detentori di una tecnica di cui non erano realmente in possesso, in secondo luogo, poiché si appellavano a facoltà irrazionali che, in quanto tali, non dovevano essere stimolate. Aristotele, contrariamente a Platone, sostiene, all’inizio della sua opera, che la retorica oltre ad essere una tecnica, non richiama facoltà irrazionali, ma bensì razionali. La retorica viene definita da Aristotele come la capacità di trattare tecnicamente ciò che è persuasivo riguardo a ciascun argomento; ciò significa che, di per sé stessa, non si assume il compito di persuadere direttamente, ma quello di indagare e di esplicare quali siano le «cose persuasive» in qualsiasi campo:
«Definiamo dunque la retorica come la facoltà di scoprire in ogni argomento ciò che è in grado di persuadere. Questa infatti non è la funzione di nessun’altra arte; ciascuna delle arti mira all’insegnamento e alla persuasione intorno al proprio oggetto: così la medicina intorno ai casi di salute e di malattia, la geometria intorno alle variazioni che avvengono nelle grandezze, l’aritmetica intorno ai numeri, e parimenti le altre arti e scienze. La retorica, invece, sembra poter scoprire ciò che persuade, per così dire, intorno a qualsiasi argomento dato; perciò affermiamo che essa non costituisce una tecnica intorno a un genere proprio e determinato.»[15]
I mezzi di persuasione che vengono utilizzati dalla retorica possono riferirsi al carattere morale di chi parla o alla disposizione di chi ascolta, in tal caso sono studiati dall’etica e dalla politica, oppure al valore intrinseco del discorso stesso, in quanto esso riesce a dimostrare o ad avere l’apparenza di dimostrare, e in questo secondo caso sono di stretta competenza della dialettica. Infatti, Aristotele afferma vi sono tre specie di argomentazioni procurate dal discorso, ossia «le une risiedono nel carattere dell’oratore, le altre nel disporre l’ascoltatore in una data maniera, le altre infine nello stesso discorso, attraverso la dimostrazione o l’apparenza di dimostrazione»[16]. Se le cose stanno così, significa che la retorica è il punto di incontro tra etica, politica e dialettica, dato che il suo oggetto di studio non contempla solo il modo di suscitare le passioni negli ascoltatori, ma anche l’individuazione delle regole secondo cui bisogna costruire le argomentazioni, indipendentemente dalla loro verità o falsità. Ciò che distingue la retorica dalla dialettica è il fatto che essa non si occupa di tutti i tipi di problemi in generale, bensì di quelle argomentazioni che vertono su quanto è oggetto di deliberazione, di scelta, e che si rivolgono ad ascoltatori qualsiasi e non ha professionisti dell’argomentazione, scegliendo forme abbreviate di dimostrazione, meno rigorose dei veri e propri sillogismi dimostrativi, ma più persuasive e efficaci nel contesto della discussione pubblica. L’«arte del discorso», ossia la retorica, viene considerata tecnica non solo per la non condannabilità dei suoi scopi, ma anche per il sapere empirico su cui è fondata che, essendo appunto esperibile, permette il miglioramento attraverso il ricorso alla cognizione delle cause e dei moventi che hanno reso le azioni meno efficaci.
In generale, la riabilitazione dell’arte poetica trova le sue radici da un lato nella teoria aristotelica dell’arte, dall’altro in una serie di concezioni relative alla psicologia e alla fisica, le quali sono soltanto accennate nella Poetica; ciò significa che per comprendere alcuni passaggi nodali della Poetica bisognerà fare riferimento al De Anima, dove la concezione di aistesis viene messa in connessione con una facoltà trascurata da Platone, la fantasia. Partendo dall’analisi della Poetica, i luoghi centrali su cui essa erge il suo complesso teorico sono essenzialmente due: innanzitutto il paragrafo d’apertura, in cui Aristotele sembra voler ripercorre i passi compiuti da Platone nella Repubblica, ammettendo l’esistenza di una serie di arti imitative, intese però, ed è qui che si innesta la differenza con il maestro, non come tecniche che producono strumenti o beni di utilizzo immediato, ma come semplici riproduzioni di oggetti che esisterebbero anche senza codesta tecnica. Nell’incipit della sua opera, Aristotele fissa il fulcro della suo studio:
«Trattiamo dunque di poetica in sé e delle sue forme, quale potenzialità ciascuna possegga e come debbano comporsi i racconti perché la poesia riesca ben fatta, e inoltre di quante e quali parti consista, e anche, in modo simile, di tutti gli altri argomenti che pervengono alla medesima disciplina, incominciando secondo natura dapprincipio dai principi. L’epica, così come la poesia tragica, nonché la commedia, la composizione di ditirambi e la maggior parte dell’auletica e della citaristica nel complesso sono tutte imitazioni, ma si distinguono l’una dall’altra sotto tre aspetti: nell’imitare o con mezzo diversi, o oggetti diversi, o diversamente e nello stesso tempo. Come alcuni imitano riproducendo molti oggetti con colori e figure (chi per arte, chi per pratica) e altri usando la voce, così tutte le dette arti compiono l’imitazione con il ritmo, la parola e la musica, separatamente oppure in combinazione.»[17]
In sostanza, dapprima afferma che l’opera tratterà della poetica in quanto arte imitativa, delineando una suddivisione delle sottospecie dell’arte poetica (l’epica, la poesia tragica, la commedia, la composizione di ditirambi, l’auletica e la citaristica), successivamente traccia un parallelo tra arte poetica e arte imitativa del pittore: infatti, come i colori e le forme sono il mezzo di cui dispone un pittore, così il ritmo, la parola e la musica sono gli strumenti di cui dispone il poeta per imitare. Se nella Repubblica Platone poneva l’esistenza delle arti imitative assumendo come paradigma l’arte del pittore e sostenendo, una volta definita quest’ultima, che l’arte del poeta è ad essa uguale, Aristotele, procedendo in modo diverso, prepara la soluzione secondo cui imitare non è produrre semplice copie, ma è un qualcosa di più complesso. In poche parole, Platone riduce tutto ai minimi termini, individuando un rapporto di uguaglianza tra poesia e pittura; Aristotele, invece, osserva come tra poesia e pittura si instauri un rapporto analogico, in cui l’arte poetica risulta essere solo analoga alla pittura. Si apre, in tal modo, la diatriba che ruota intorno alla corretta decodificazione del frammento oraziano, «ut pictura et poesis» tra due linee interpretative: da una parte la posizione platonica secondo la quale la traduzione letterale della formula consisterebbe in «così come la pittura così come la poesia»; dall’altra, coloro che assumono per intero la formula «ut pictura et poesis erit» (la pittura sarà come la poesia/la pittura deve essere come la poesia) e che dunque seguono le indicazioni aristoteliche di una mimesis ricalcata sul modello della poesia, a cui il pittore deve adeguarsi senza essere un mero imitatore di copie fedeli agli originali.
Il secondo luogo centrale si incontra nel quarto paragrafo dove lo Stagirita avanza più di un argomento in antitesi con il maestro Platone:
«Due cause appaiono in generale aver dato vita all’arte poetica, entrambe naturali: da una parte il fatto che l’imitare è connaturato agli uomini fin dalla puerizia (e in ciò l’uomo differenzia dagli altri animali, nell’essere il più portato ad imitare e nel procurarsi per mezzo delle imitazione le nozioni fondamentali), dall’altra il fatto che tutti traggono piacere dalle imitazioni. Ne è segno quel che avviene nei fatti: le immagini particolarmente esatte di quello che in sé ci dà fastidio vedere, come per esempio le figure degli animali più spregevoli e dei cadaveri, ci procurano piacere allo sguardo. Il motivo di ciò è che l’imparare è molto piacevole non solo ai filosofi ma anche ugualmente a tutti gli altri, soltanto che questi ne partecipano per breve tempo.»[18]
L’impostazione di stampo naturalistico rintracciabile in queste righe sarà il medesimo che troveremo nella psicologia e che abbiamo già incontrato nelle prime pagine della metafisica. Aristotele cioè imposta le sue considerazioni su una visione complessiva dell’universo e, conseguentemente, su una caratteristica comune e presente in tutti gli uomini, che risulta essere la giustificazione dell’arte imitativa, oltre che la prima riflessione naturalistica riscontrabile; secondo Aristotele, infatti, l’arte imitativa è equiparabile all’istinto naturale, e proprio in quanto tale non ha senso volerla eliminare. Sempre a questo proposito Aristotele, come già sosteneva nella Metafisica, ritiene quindi che se tutti gli uomini sono dotati di medesime caratteristiche, allora saranno tutti dotati, sin dalla fanciullezza, dell’istinto a imitare. La seconda considerazione naturalistica risiede nell’affermazione aristotelica circa lo scopo dell’imitazione, il quale è analogo a quello dell’acquisizione di esperienza: imitando si impara, si conosce, si apprendono dei comportamenti che è possibile perfezionare proprio sulla base delle esperienze. Il terzo motivo, sempre di base naturalistica, consiste nella connessione tra imitare per apprendere e provare piacere, già presente nella Metafisica; Aristotele, infatti, dicendo che è naturale provare piacere ogni qualvolta noi apprendiamo, tende non solo a giustificare il piacere in quanto tale poiché volto alla conoscenza e per questo non irrazionale, ma pone anche un problema scaturito da una constatazione empirica: noi proviamo piacere nell’osservare cose che, qualora fossero imitazioni, ci desterebbero disgusto. A ragione di questo, se osserviamo il cadavere di un animale spregevole siamo soggetti al disgusto, se invece ne abbiamo conoscenza mediante rappresentazione, proviamo piacere; ciò può avvenire solo in virtù del medium imitativo, il quale trasforma l’oggetto spregevole in un oggetto di conoscenza che dunque suscita piacere. Nonostante la centralità che il problema inerente al rapporto tra il piacere e l’imitazione ha rivestito, per lungo tempo, nei dibattiti tra critici e psicologi, è certo che esso permette allo Stagirita di rafforzare la sua tesi circa l’istanza conoscitiva dell’imitazione e di contrastare la mimesis platonica concepita come mera capacità di avere sensazioni:
«Da ciò che si è detto è chiaro che il compito del poeta non è di dire le cose avvenute, ma quali possono avvenire, cioè quelle possibili secondo versomiglianza o necessità. Lo storico e il poeta non si distinguono nel dire in versi o senza versi (si potrebbero mettere in versi gli scritti di Erodono e nondimeno sarebbe sempre una storia, con versi o senza versi); si distinguono invece in questo: l’uno dice le cose avvenute, l’altro quali possono avvenire. Perciò la poesia è cosa di maggiore fondamento teorico e più importante della storia perché la poesia dice piuttosto gli universali, la storia i particolari. E’ universale il fatto che a una persona di una certa qualità capiti di dire o di fare cose di una certa qualità, secondo verosimiglianza o necessità, il che persegue la poesia, imponendo poi i nomi. Il particolare invece è che cosa fece o subì Alcibiade.»[19]
Non solo Aristotele sostiene l’istanza conoscitiva dell’imitazione ma la legittima attraverso il confronto tra poeta e storico, laddove la differenza non risiede nella veridicità di ciò che il poeta rappresenta ma nella sua capacità ad occuparsi degli universali: infatti mentre il poeta può inventare delle storie e raccontare eventi che non sono accaduti ma che sono suscettibili di accadere, lo storico si limita ad elencare gli eventi secondo cronologia. A tal proposito il criterio a cui deve aderire l’imitatore è quello della verosimiglianza, secondo il quale noi abbiamo la possibilità di imparare da una storia solo se verosimile e attinente alle leggi della possibilità. In questo modo ciò che noi apprendiamo è vicino alla conoscenza scientifica; infatti, se noi siamo a conoscenza delle leggi tali che le cose siano suscettibili di accadimento, significa che abbiamo anche cognizione di qualcosa di universale. Dunque, un buon pittore non si pone come scopo la riproduzione illusoria di un ente al fine di ingannarci, ma ha semmai l’obiettivo di illustrarci le leggi di tipo generale, ed è questo, in definitiva, il vero motivo che garantisce l’ammissione delle arti poetiche. Se volessimo realizzare un confronto tra l’arte della poetica e quella della retorica, vedremo come entrambe si prefiggano uno scopo ben definito: da una parte abbiamo la retorica che mira a cambiare il mondo, influire sulle valutazioni della vita pubblica e sulle deliberazioni dei tribunali; dall’altra abbiamo la poetica che vuole fornire la conoscenza universale, divenendo in virtù di ciò un’arte genuina.
Non deve però cadere nell’oblio il fatto che il valore conoscitivo dell’arte poetica è inserito entro una cornice trattatistica il cui scopo è quello di fornire indicazioni per la realizzazione di tragedie efficaci, in quanto solo il genere tragico è in grado di mostrarci le leggi del possibile che hanno portata etica; la tragedia ha il compito di farci conoscere dei modelli di uomo, di farci divenire consapevoli delle conseguenze dell’agire umano e di farci apprendere i problemi etici e religiosi. Resta esclusa da queste pagine la spiegazione del perché noi imitando giungiamo alla cognizione dell’universale, che verrà invece esposta in altre due opere aristoteliche, ossia nella Fisica e nel De Anima.
Fisica e De anima: scienza e tecnica per il perfezionamento della natura
Se nella Poetica Aristotele si limita ad indicare le regole a cui un poeta deve attenersi per raggiungere la massima efficacia dei suoi prodotti, nella Fisica la nozione di tecnica non solo viene più ampliamente sviluppata ma acquista anche la capacità di perfezionare l’opera della natura; nuovamente, mentre la caratterizzazione della tecnica come azione volta al miglioramento della natura in un quadro platonico è un qualcosa di impensabile, in Aristotele trova la sua collocazione nel II Libro della Fisica. All’inizio del II libro, lo Stagirita pone una distinzione cruciale per la sua concezione di tecnica in quanto mimesis:
«Degli enti alcuni sono per natura, altri per altre cause. Sono per natura gli animali e le loro parti e le piante e i corpi semplici, come terra, fuoco, aria e acqua (queste e le altre cose di tal genere noi diciamo che sono per natura), tutte cose che appaiono diverse da quelle che non esistono per natura. Infatti, tutte queste cose mostrano di avere in se stesse il principio del movimento e della quiete, alcune rispetto al luogo, altre rispetto all’accrescimento e alla diminuzione, altre rispetto all’alterazione. Invece il letto o il mantello o altra cosa di tal genere, in quanto hanno ciascuno un nome appropriato e una determinazione particolare dovuta all’arte, non hanno alcuna innata tendenza al mangiamento, ma l’hanno solo in quanto, per accidente, tali cose sono o di pietra o di legno una mescolanza di ciò.»[20]
La distinzione posta da Aristotele tra enti naturali e enti artificiali permette di cogliere in che senso la tecnica, l’arte e tutto ciò ad essa inerente si configuri come mimesis, come imitazione della natura: allo stesso modo in cui gli enti naturali sono tali in virtù del principio di movimento e cangiamento insito in loro, «similmente avviene per ciascuno degli oggetti prodotti artificialmente: nessuno di essi, infatti, ha in se stesso il principio della produzione, ma alcuni lo hanno in altre cose e dall’esterno, come la casa e ogni altro prodotto manuale; altri in se stessi, ma non per propria essenza, bensì in quanto accidentalmente potrebbero diventar causa a se stessi»[21].
Dalla diretta osservazione dei corpi, sia naturali sia artificiali, è possibile quindi notare come essi siano il risultato della convergenza di quattro cause: sono dotati di materia, sono prodotti da qualcuno, sono tali sia in quanto aventi una forma propria sia in quanto possiedono un scopo per il quale sono stati creati. Nonostante in più punti Aristotele affermi che «la natura è forma»[22], non bisogna dimenticare l’esistenza di una materia che la condiziona, a tal punto da divenire da essa inscindibile. Se quindi ogni cosa è dotata di materia per poter raggiungere un fine, e se la forma è ciò che è in quanto organizzata in vista di tale fine, allora la natura è «fine e causa finale (infatti, poiché il movimento è continuo e vi è un fine del movimento stesso, questo fine è l’estremo e la causa finale; perciò anche il poeta, se pur in modo goffo, fu spinto a dire: ‘ Ha quella fine per la quale nacque’, giacché non un estremo qualsiasi, ma soltanto il migliore ha la pretesa di essere il fine)»[23]. Il «fisico» dovrà conoscere tutte e quattro le cause degli enti naturali, i quali hanno in sé il principio del loro movimento e della loro quiete, il «matematico» dovrà studiare ciò che è sotto l’aspetto della quantità, mentre chi si occuperà di «filosofia prima» studierà l’essere in quanto essere; in definitiva, per Aristotele, la fisica, la matematica e la metafisica costituiscono la classe delle cosiddette scienze teoretiche il cui fine ultimo è la verità. Ecco, allora che si innesta l’analogia ed il parallelismo tra entità naturali e artigianali da un lato e scienza e tecnica dall’altro:
«Poiché anche le arti si costruiscono la materia, alcune in senso assoluto, altre solo per l’attuazione dell’opera, e noi ce ne serviamo come se tutto esistesse per nostro scopo (siamo, in verità, in un certo senso anche noi il fine, giacché la causa finale si intende in due significati; e ciò è stato discusso negli scritti Sulla filosofia) E sono due le arti che comandano sulla materia e la conoscono: l’una è quella che ne fa uso pratico, l’altra fa parte delle attività costruttive ed è l’architettonica. Perciò anche l’arte che ne fa uso pratico è, in un certo senso, architettonica; ma la differenza è nel fatto che l’architettonica ha la competenza della forma, mentre l’altra, in quanto attività costruttiva ha competenza della materia. Il nocchiero, ad esempio, conosce quale sia la forma del timone e la controlla; il costruttore, invece, sa da quale legno e da quali movimenti il timone potrà venir fuori. Nelle cose artificiali, dunque, siamo noia trar fuori la materia per raggiungere il fine dell’opera; nelle cose naturali, invece, la materia già esiste.»[24]
In primis, qui Aristotele sostiene la distinzione tra tecnica, la cui azione ha fine fuori di sé, ossia nell’oggetto che essa produce, e scienza, il cui oggetto è il necessario, ossia ciò che non può essere o avvenire diversamente da come è o avviene. In secondo luogo individua una differenziazione interna alla stessa tecnica tra chi sa usare un oggetto, in virtù della conoscenza della forma (nocchiero), e chi, invece, conosce ciò che produce relativamente alla materia (costruttore).
La legittimazione della fisica come disciplina scientifica, la distinzione tra enti naturali ed enti artificiali, la caratterizzazione della scienza e della tecnica, sono gli argomenti maggiormente sviluppati nei primi due paragrafi del II libro e costituiscono il fondamento teorico per i restanti sette, in cui il filosofo dipingerà, all’interno del suo maestoso affresco gnoseologico, la relazione mimetica intercorrente tra arte e natura. Ci sono infatti delle leggi che possono essere osservate nei due ambiti: sia l’arte sia la natura producono cambiamenti rivolti a degli scopi, ed entrambe sono fallibili e suscettibili di errore.
In primo luogo, è deducibile che non è la natura ad imitare l’arte ma, viceversa, è l’arte ad imitare la natura, almeno per quanto concerne il fine di raggiungere uno scopo; dunque il tecnico sarà colui che dovrà adempiere al ruolo di imitatore sia quando produce cose non esistenti in natura e sia quando ne imita i suoi meccanismi interni (ad esempio, come la natura nel caso delle piante produce foglie, allo stesso modo l’uomo realizza le abitazioni per proteggersi e ripararsi). Dunque, quella che si viene a configurare, è una concezione teleologica della natura poiché le
«cose sembrano generarsi o per fortuita coincidenza o in virtù di una causa finale, se non è possibile che esse avvengano né per fortuita coincidenza né per caso, allora avverranno in vista di un fine. Ma tutte le cose di tal genere sono sempre conformi a natura, come ammettono i meccanicisti. Dunque, nelle cose che in natura sono generate ed esistono c’è una causa finale. Inoltre, in tutte le cose che hanno un fine, in virtù di questo si fanno alcune cose prima altre dopo. Quindi, come una cosa è fatta, così essa è disposta per natura e, per converso, come è disposta per natura, così è fatta, purché non vi sia qualche impaccio. Ma essa è fatta per un fine; dunque per natura è disposta ad un tale fine»[25].
Il nesso logico, basilare per cogliere il concetto di mimesis, viene enunciato poco più avanti attraverso un esempio, infatti:
«Se la casa facesse parte dei prodotti naturali, sarebbe generata con le stesse caratteristiche con le quali è ora prodotta dall’arte; e se le cose naturali fossero generate non solo per natura, ma anche per arte, esse sarebbero prodotte allo stesso modo di come lo sono in natura. Ché l’una cosa ha come fine l’altra. Insomma: alcune cose che la natura è capace di effettuare l’arte; altre le imita. E se, dunque, le cose artificiali hanno una causa finale, è chiaro che è così anche per le cose naturali: infatti il prima e il poi si trovano in rapporto reciproco alla stessa guisa tanto nelle cose artificiali quanto in quelle naturali.»[26]
In secondo luogo, il parallelismo natura/arte si svela sotto le sembianze dell’errore, della fallibilità; infatti, così come si riscontrano errori nei prodotti dell’arte (ad esempio, il grammatico scrive in modo scorretto e il medico sbaglia la dose del farmaco), parimenti essi si verificano anche nei prodotti naturali (ad esempio, nei parti mostruosi e nella nascite di esseri malformi). La spiegazione di tali fenomeni risiede nel fatto che essendo la natura duplice, cioè materia e forma[27], può avvenire che la materia, opponendo resistenza, non si lasci dominare dalla forma: infatti, come specifica lo Stagirita, «se vi sono, dunque, cose artificiali in cui ciò che è esatto, è tale in virtù della causa finale, mentre nelle parti sbagliate pur si è mirato ad un fine, ma non si è riusciti a conseguirlo, la medesima cosa avverrà anche nei prodotti naturali, e i mostri risultano sbagli di quella determinata causa finale.»[28]
Nonostante l’uomo sia un essere per sua natura fallibile ha la possibilità di riscontrare gli errori che si verificano negli enti naturali e di rimediare ad essi, attraverso un opera di correzione e di perfezionamento dell’operato della natura. Ciò è vero tanto per lo scienziato quanto per l’artista/tecnico: infatti il medico, grazie alle sue pozioni e ai suo farmaci, può curare laddove la natura ha commesso delle sviste; l’artista, invece, imita la natura non per realizzare delle mere copie, ma per poterla trasfigurare giungendo ad una sorte di idealizzazione di una natura priva di errori (ad esempio nei ritratti e nelle sculture).
Ricapitolando i fini del discorso aristotelico in sede psicologica risulta che, in primo luogo, imitando si conosce; in secondo luogo, che è possibile acquisire esperienza sulla sola base delle sensazioni senza la necessità di un ricorso all’intelletto; infine, che vi è una stretta connessione con il sentimento di piacere, su cui oltretutto Aristotele si sofferma per elaborare una sua personale teoria. Tutte queste argomentazioni trovano adito nel trattato di psicologia di Aristotele, il De Anima, che consiste in una ricerca sull’anima, la cui conoscenza contribuisce «grandemente alla verità in tutti i campi, e specialmente alla ricerca sulla natura, giacché l’anima è come il principio degli animali»[29]; il traguardo che Aristotele vuole vittoriosamente varcare è la conoscenza della natura ed essenza dell’anima e di tutte le caratteristiche che le competono, di cui «alcune sembrano affezioni proprie dell’anima, mentre altre pare che in virtù sua appartengano agli animali»[30].
Secondo il filosofo, ciò che rende un essere vivente tale è la presenza in esso di qualcosa che lo animi, dove per anima si intende un «entelechia (atto perfetto) di un corpo che ha vita in potenza»[31]; la concezione aristotelica dell’anima, diversamente da quella platonica, costituisce un insieme unitario con il corpo organico di cui essa è principio vitale, non potendo in tal modo esistere separatamente e indipendentemente da esso. Ancora in antitesi con il suo maestro, Aristotele dimostra come l’anima non sia divisa in più parti, bensì sia un insieme di funzioni, a loro volta distinguibili in tre livelli: funzione nutritiva e riproduttiva (propria delle piante, oltre che di tutti gli animali, uomo compreso), funzione sensitiva (propria di animali e uomini) e la funzione intellettiva (specificatamente umana). Volgendo la nostra attenzione in particolar modo sulla sensazione, lo Stagirita sostiene che:
«il senso è ciò che è atto ad assumere le forma sensibili senza la materia, come la cera riceve l’impronta dell’anello senza il ferro o l’oro: riceve bensì l’impronta dell’oro o del bronzo, ma non in quanto è oro o bronzo. Analogamente il senso, rispetto a ciascun sensibile, subisce l’azione di ciò che ha colore o sapore o suono, ma non in quanto si tratti di ciascuno di questi oggetti, bensì in quanto l’oggetto possiede una determinata qualità e secondo la forma.»[32]
Il senso, dunque, riceve la forma, non la materia; e il paragone offerto da Aristotele è piuttosto appropriato: facendo riferimento ad una metafora già utilizzata da Platone nel Teeteto, in cui l’anima viene accostata ad una tavoletta di cera e le impressioni alle forme che si imprimono su di essa, Aristotele tematizza come anche nel processo percettivo ciò che i sensi ricevono non è il materiale, ma più che altro la forma degli oggetti. Inoltre, la sensazione provata lascia una sorta di residuo della forma che permane anche quando gli oggetti percepiti non sono più presenti; ma tali residui costituiscono le immagini, che sono l’oggetto della fantasia o immaginazione, la quale può essere sia vera sia falsa e ha l’importante funzione di essere stimolo dell’azione e alla base degli atti di locomozione: infatti tanto il desiderio quanto gli atti di appetizione presuppongono l’immaginazione. A questo aggiungiamo un ulteriore caratterizzazione della immaginazione: essa è alla base della memoria, che si costituisce mediante immagini mentali; su di esse poi, in quanto prive del loro supporto sensibile, opera anche l’intelletto per poter ricavare le forme intelligibili, gli universali, i concetti, le definizioni. L’insieme di tutti questi processi permettono ad Aristotele non solo di spiegare l’esistenza di capacità inventive nell’uomo, ma anche di ricondurre le abilità d’invenzione tipicamente umane alla facoltà della memoria; chi, dunque, possiede la capacità di sentire è, conseguentemente in grado, di ricordare e di immaginare e perciò di conoscere per esperienza. Per evitare di incappare in errori di comprensione, Aristotele specifica che non tutti gli esseri viventi sono dotati degli stessi sensi e delle medesime capacità di apprendimento per esperienza: l’ostrica, come riporta Aristotele, possiede unicamente il tatto, ma come gli uomini quando percepisce riceve una forma immateriale che può memorizzare, facendo quindi esperienza di piacere e di dolore. Nel III libro del De Anima non solo viene preso in esame l’intelletto in quanto facoltà propriamente umana, ma viene messa in luce anche la sua diretta interrelazione con la fantasia e la sensazione:
«E’ poi manifesto che la sensazione e l’intelligenza non sono la stessa cosa, giacché di quella partecipano tutti gli animali, e di questa pochi. Quanto al pensiero (che include quello retto e quello non retto; quello retto è saggezza, scienza, e opinione vera, quello non retto i contrari di questi), neppure esso è la stessa cosa che la sensazione. In effetti la percezione dei sensibili propri è sempre vera ed appartiene a tutti gli animali, mentre si può pensare anche falsamente, ed il pensiero non si trova se non in chi è fornito di ragione.»[33]
Aristotele quindi sostiene che l’errore non si manifesta attraverso le sensazioni, le quali sono sempre vere, ma piuttosto nel momento in cui intervengono dei giudizi che non sono relativi al fatto che si sta provando una determinata sensazione. Circa la terza facoltà, ossia l’immaginazione, Aristotele prosegue dicendo che è «diversa sia dalla sensazione sia dal pensiero, però non esiste senza sensazione, e senza di essa non c’è apprensione intellettiva»[34]; dal un lato dunque dipende da noi – «quando lo vogliamo (è possibile infatti raffigurarsi qualcosa davanti agli occhi, come fanno coloro che dispongono le cose nei luoghi mnemonici e si costruiscono delle immagini)»[35]– ; dall’altro – quando sogniamo – non è in nostro potere e dunque ci diviene impossibile controllarla. Ma la facoltà dell’immaginazione è vera? A questa domanda Aristotele risponde sostenendo che è falsa nel momento in cui noi ci confrontiamo con la realtà (ad esempio l’ircocervo creato nella nostra mente non possiede un referente nel mondo), ma è vera in relazione alle leggi della verosimiglianza, le quali ci garantiscono la conoscenza dell’universale, ossia la conoscenza della totalità dei fenomeni che non sono ancora avvenuti ma che sono suscettibili di accadimento (i cosiddetti mondi possibili): in tal modo il filosofo ha dimostrato che la capacità di imitare equivale alla capacità di acquisire conoscenza.
Un altro aspetto da non sottovalutare, ai fini di una ricostruzione dell’estetica nella filosofia di Aristotele, è la teoria dell’immaginazione come movimento, infatti «è possibile che, quando una data cosa è mossa, un’altra sia mossa da essa»[36] e che l’immaginazione «non si produca senza sensazione, ma soltanto negli esseri forniti di sensazione»[37]; queste ultime affermazioni permettono di chiarire come sono possibili il piacere e il desiderio. Mentre nel II libro il filosofo si era limitato ad una distinzione generale delle funzioni dell’anima (vegetativa, sensitiva, intellettiva), attribuendole in una sorta di gerarchia crescente che parte dalle piante sino ad arrivare agli esseri umani, ora compie un ulteriore passo in avanti, osservando come alcuni esseri viventi – le ostriche – possiedano sia la facoltà sensitiva che quella immaginativa, mentre altri i – vermi – sono dotati solo di capacità percettive e non di immaginazione: questo permette ad Aristotele di spiegare come la capacità locomotiva volta al raggiungimento di un fine si differisca negli esseri, divenendo automatica in alcuni (vermi), mentre mossa da motivazioni più profonde in altri (ostriche, ragni…). Per quanto riguarda l’essere umano la situazione appare più complessa; nell’uomo, infatti, la facoltà locomotoria, a cui è legata l’immaginazione, si pone in rapporto con quelle passibili di produrre la conoscenza: la facoltà di desiderare e di provare piacere e dispiacere è quindi il risultato del gioco tra la facoltà motrice e la facoltà di produrre conoscenza. Così dicendo la teoria del piacere in Aristotele trova il suo fondamento: gli esseri dotati di immaginazione e di aisteisis possono essere mossi o unicamente in base alla oghexis, la quale è una facoltà passiva, oppure, attraverso la valutazione delle circostanze sulla base delle conoscenze acquisite (facoltà attiva), decidere se o no muoversi per il perseguimento del fine.
Alla luce della teoria del piacere di Aristotele, si possono formulare alcune considerazioni: in primo luogo, a differenza di Platone, per il quale il desiderio è percezione di un’assenza, Aristotele sostiene che il desiderio si generi dalla creazione di un’immagine volontaria; in secondo luogo, la sua teoria può spiegare quei fenomeni, oggi definiti come «bilancio delle motivazioni», che sono alla base del conflitto tra i desideri opposti. Circa quest’ultima osservazione, si può ricorrere all’esempio dell’alcolizzato, in cui al desiderio di bere si oppone quello di voler smettere, e questo conferisce una valenza positiva alla sua teoria del desiderio e dell’imitazione, permettendo ad entrambe di entrare nel novero delle teorie etiche.
Se, dunque, questo è il nostro modo di desiderare che motivo c’è di voler allontanare dalla società coloro che alimentano i nostri desideri? La chiave di volta risiede solo nella capacità di operare giudizi migliori.
[1] Platone, Repubblica; tr. it. a cura di M. Vegetti, Laterza, Roma–Bari 2005, p. 316.
[2]Ibidem.
[3]Ibidem.
[4] Ivi, p. 323.
[5] Ibidem.
[6] Ibidem.
[7] Ibidem.
[8] Ibidem.
[9] Aristotele, Etica nicomachea, 1094 a; tr. it. a cura di C. Mazzarelli, Bompiani, Milano 2000, p. 51.
[10] Ivi, 1139 b 15 e ss., p. 233.
[11]Aristotele, Metafisica, 980 a; tr. it. a cura di Giovanni Reale, Bompiani, Milano 2000, p. 3.
[12] Ibidem.
[13] Ivi, p. 59.
[14] Ivi, p .6.
[15] Aristotele, Retorica; tr. it. a cura di Armando Plebe, Laterza, Roma–Bari 1961, p. 6.
[16] Ivi, p. 7.
[17] Aristotele, Poetica; tr. it. a cura di Diego Lanza, Bur, Milano 1987, p. 117.
[18] Ivi, p. 125.
[19] Ivi, p. 147.
[20] Aristotele, Fisica, in Opere; tr. it. a cura di Antonio Russo, Laterza, Roma-Bari 1973, p. 27.
[21] Ibidem.
[22] Ivi, p. 30.
[23] Ivi, p. 32.
[24] Ivi, p. 32.
[25] Ivi, p. 45.
[26] Ivi, p. 45.
[27] Ivi, p. 46.
[28] Ivi, p. 46.
[29]Aristotele, L’anima; tr. it. a cura di Giancarlo Movia, Bompiani, Milano 2001, p. 55.
[30] Ibidem.
[31] Ivi, p. 115.
[32] Ivi, p. 183.
[33] Ivi, p. 205.
[34] Ibidem.
[35] Ibidem.
[36] Ivi, p. 209.
[37] Ibidem.
PSEUDO-LONGINO, PLOTINO, LEONARDO, VICOELE
A cura di Claudia Bianco
Gli undici manoscritti che ci hanno tramandato il trattato intitolato Sul sublime (Peri hypsous) non forniscono alcuna indicazione sicura circa l’identità del suo autore, che è stato oggetto, sin dall’inizio dell’Ottocento, di una complessa disputa filologica rimasta tuttora irrisolta. Sebbene un’attribuzione certa non sia stata ancora stabilita, tanto che all’autore anonimo si assegna ormai per comodità il nome di Pseudo-Longino, oggi prevale l’opinione secondo cui lo scritto dovrebbe essere collocato cronologicamente nell’età augustea e comunque non oltre la prima metà del I secolo d.C. Sullo sfondo del trattato si collocano le grandi polemiche che attraversavano la retorica tardo-ellenistica , come l’opposizione tra gli stili atticista e asiano, ossia tra uno stile semplice chiaro e ordinato, modellato sulla prosa attica del IV secolo a.C., e uno irregolare, basato su frasi brevi e spezzate, ricco di figure retoriche e di ricercati effetti ritmici e fonetici. La contrapposizione fra atticismo e asianesimo si ripropone, tra la seconda metà del I secolo a.C e la prima metà del I secolo d.C., nella polemica tra apollodorei e teodorei, due tendenze che prendevano il nome dai rispettivi capiscuola: Apollodoro di Pergamo (maestro di Augusto e sostenitore dell’ideale di un’oratoria scientifica) e Teodoro di Gadara (maestro di Tiberio che difese l’opposto ideale di un’oratoria poetica). Punti di riferimento delle due tendenze erano Aristotele e Platone: dal primo discendevano il razionalismo e la vocazione sistematica degli apollodorei, dal secondo invece l’irrazionalismo e la libertà espressiva dei teodorei. Oltre a collocarsi nel quadro delle distinzioni stilistiche allora vigenti, l’autore del trattato Sul sublime riprende alcune riflessioni stoiche sulla bellezza, sottolineando, in particolare, l’importanza delle motivazioni morali ed esistenziali nella genesi della grandezza di un testo letterario.
Lo Pseudo-Longino eredita dalla tradizione retorica il concetto di “sublime” (hypsos) come categoria esclusivamente formale e indicante uno stile oratorio elevato e magniloquente. Già da tempo si era consolidata, negli studi di retorica, la distinzione fra tre stili dell’oratoria, i cosiddetti tria genera dicendi che Cicerone, riprendendo la terminologia della Retorica ad Herennium, aveva classificato nell’Orator con i nomi di grave, medium e tenue. Nello Pseudo-Longino la categoria del sublime, proveniente dalle riflessioni sullo stile grave, viene reinterpretata e se ne sottolinea la dimensione non solo stilistica, ma morale: “ il sublime è l’eco di una grande anima”, e deve essere concepito come segno di un’intensa vita interiore e di una tensione emotiva che, per essere comprese, richiedono dal lettore o dall’uditore un atteggiamento ricettivo altrettanto magnanimo e intenso.
Il sublime, inoltre, non deve essere semplicemente descritto, bensì riconosciuto e praticato, valorizzando un ingenium innato che deve essere presente nell’animo dell’oratore e che occorre sviluppare attraverso un uso consapevole dell’ars retorica. La necessità di una conciliazione di ars e ingenium, di tecnica oratoria e pathos, è una delle tesi fortemente sostenute dal trattato, nel quale la concezione platonica della poesia, fondata sul carattere divino e irrazionale dell’ispirazione (mania), convive con il rispetto della tradizione e l’emulazione degli antichi, da cui devono provenire gli strumenti capaci di forgiare l’espressione dei pensieri e delle emozioni sublimi. Nel trattato lo Pseudo-Longino elenca nell’ottavo capitolo le cinque fonti del “vero” sublime. Due sono innate (“lo slancio esuberante dei pensieri” e il “pathos trascinante e ispirato”), mentre le altre tre devono essere acquisite con la tecnica e consistono:
§ nell’uso sapiente e dissimulato del linguaggio figurato e delle forme argomentative;
§ nella personalità stilistica che si manifesta in particolare nella scelta lessicale;
§ e infine nella composizione (synthesis) delle parti del discorso.
Nel corso del trattato, il sublime si delinea come uno stile oratorio caratterizzato dall’altezza del discorso e dalla ricerca di effetti di meraviglia, stupore e sbigottimento capaci di produrre nell’ascoltatore uno stato di annichilimento e immedesimazione che va ben al di là della semplice persuasione: “Il sublime non porta gli ascoltatori alla persuasione ma all’esaltazione”.
Con accenti che avranno una grande risonanza nell’estetica settecentesca, quando si assiste a un’importante ripresa del tema del sublime, lo Pseudo-Longino esalta la naturale tendenza dell’uomo verso tutto ciò che è grande e potente: “ la natura non ha giudicato l’uomo una creatura ignobile e di poco conto, ma, introducendoci nella grande e festosa adunanza della vita e dell’ordine cosmico affinché, allo spettacolo dei suoi cimenti, potessimo ambire e competervi, ha subito infuso nelle nostre anime il desiderio irresistibile di ciò che è sempre grande e che ci sovrasta con la sua divinità. Perciò agli slanci dell’osservazione e del pensiero umano l’universo intero è insufficiente, perché anzi la nostra mente spesso eccede i limiti del creato”. La fortuna delle tesi dello Pseudo-Longino è tutta moderna: né dall’Antichità classica né dalla tradizione medioevale ci pervengono riferimenti al trattato. A partire dalla traduzione inglese di John Hall (1652) e da quella francese di Nicolas Boileau (1674), la fama dello Pseudo–Longino si diffonde nella cultura dell’Europa moderna, e il concetto di sublime si impone come tema centrale della riflessione estetologica, superando l’ordinaria connotazione stilistica e retorica e presentandosi come fulcro di una riflessione sulla varietà delle forme del bello e del piacere. Se Boileau vede lo Pseudo-Longino come un paladino dei classici, nel Settecento inglese l’autore è visto come teorico delle motivazioni irrazionali ed emotive dell’arte e le sue idee diventano il punto di partenza per una più ampia riflessione filosofica (Burke e Kant).
PLOTINO
Il bello intelligibile
Gli scritti di Plotino (205-270 ca.d.C.) furono sistemati in sei gruppi di nove trattati con il titolo complessivo di Enneadi dall’allievo Porfirio, autore anche di una Vita di Plotino alla quale dobbiamo tutte le informazioni in nostro possesso sulla vita del filosofo. All’interno dei 54 trattati componenti le Enneadi si trovano scritti di argomento diverso, disposti secondo un ordine tematico che non riflette la sequenza cronologica in cui furono redatti e nei quali compaiono integrazioni e cesure introdotte probabilmente dallo stesso Porfirio. Due sono i testi espressamente dedicati alla tematica del bello:
il trattato Sul hello ( Peri tou kalou), considerato come uno dei primi scritti su Plotino;
e quello intitolato Sul bello intelligibile , appartenente a una fase successiva della speculazione plotiniana.
L’innovazione sostanziale della speculazione plotiniana rispetto alla tradizione filosofica del platonismo, risiede nella concezione di un’unità suprema e ineffabile, l’Uno, posta alla fonte stessa dell’essere, ma di cui l’essere non può essere predicato. L’Uno può infatti essere menzionato solo in termini negativi: al di sopra dell’essere e della conoscenza, esso è infinito, illimitato, informe ( in quanto al di là di ogni forma e figura), assolutamente trascendente rispetto a ogni molteplicità e misura. Nello sviluppare la propria concezione dell’Uno, Plotino riprende sia l’ipotesi di un’unità del tutto separata rispetto al molteplice, avanzata da Platone nel Parmenide, che la concezione dell’idea del Bene come fonte trascendente della realtà e dell’intelligibilità delle idee, esposta nella Repubblica. In questi secondo dialogo, inaugurando una metafisica della luce poi ampiamente ripresa da Plotino, Platone sosteneva che l’idea del Bene è per gli oggetti della conoscenza (le idee) e per il conoscere stesso ciò che il sole è per gli oggetti visibili e per la vista: così come il sole produce i colori che noi vediamo e fornisce nello stesso tempo all’occhio la facoltà di vedere (l’occhio è infatti a sua volta fonte di luce), alla stessa maniera il Bene dà agli oggetti della conoscenza dialettica il loro essere (ousia) e li rende conoscibili pur distanziandosi da essi. Infatti, come il sole non è né i colori che vediamo né l’occhio che li vede, così il Bene è qualcosa di ancora più alto dell’essere delle idee: la sua “irresistibile bellezza” si colloca al di là dell’essere stesso, “dall’altra parte dell’essere” (epekeina tes ousias).
Riprendendo questi temi platonici, Plotino concepisce l’Uno come identico al Bene e come infinita fonte di luce che si irradia sulla realtà che da esso procede per emanazione. Esso è al tempo stesso al di là dell’essere e “sorgente dell’essere”, e in quanto tale fonte inesauribile di vita, potenza attiva che trabocca spontaneamente al di fuori di sé dando luogo alla processione gerarchica discendente degli esseri. La generazione della realtà da parte dell’Uno è descritta da Plotino come un processo di sovrabbondanza e donazione che dà luogo progressivamente all’Intelligenza, alle idee in cui essa si articola – modelli intelligibili e archetipi eterni della realtà sensibile – e infine all’anima, che come “Anima del mondo” pervade il cosmo ed esplica la propria attività demiurgica dando vita alla materia e imprimendovi le forme intelligibili. All’estremo opposto dell’Uno-Bene, all’altro capo della gerarchia ontologica emanativa, si colloca la materia (hyle), concepita come negatività pura, “privazione”, massa informe, ossia ciò che rimane del reale una volta sottratta da esso ogni forma. Trascinato verso il basso dalle passioni corporee e verso l’alto da un’anima che tende a ricongiungersi alla dimensione intelligibile e immateriale da cui proviene, l’uomo deve fuggire il male insito nella corporeità e nel sensibile e cercare di favorire il ritorno dell’anima verso il bene e la luce.
Compito della filosofia è quindi di condurre l’uomo a rientrare nella propria interiorità, purificarsi e ascendere gradualmente verso l’intelligibile in modo da avvicinarsi progressivamente a quella forma suprema di conoscenza che è l’estasi, “uscita da sé, pensiero al di là del pensiero, caratterizzato da un’unione assoluta con il proprio oggetto e da un assoluto appagamento.
A partire da questo complesso quadro ontologico, la speculazione plotiniana sulla bellezza e sull’arte assume un’irriducibile valenza etica e metafisica. Nel trattato Sul bello Plotino comincia con il rifiutare la tradizionale concezione della bellezza come armonia e proporzione, sostenendo che questa sembra riferirsi esclusivamente a oggetti composti in cui possa esservi simmetria tra le parti: al contrario, la bellezza risiede innanzitutto negli oggetti e nelle qualità semplici, in quanto ogni allontanamento dall’unità verso la molteplicità equivale a una perdita di perfezione. Causa della bellezza è l’imprimersi di una forma nella materia, che fa sì che questa partecipi dell’intelligibilità dell’idea e sia pervasa da una luce spirituale e soprasensibile. In questo primo trattato Plotino riprende poi il tema della funzione anagogica della bellezza esposto da Platone nel Simposio e nel Fedro, dove il progressivo ritorno dell’anima verso la sfera delle idee avveniva tramite la contemplazione e l’amore rivolto a forme di bellezza via via più spirituali e immateriali. Al culmine del celebre discorso di Diotima nel Simposio di Platone si situa infatti la contemplazione di un “bello in sé”, “divino e uniforme”, rispetto al quale ogni altra forma di bellezza non è che un mero riflesso. Anche nel trattato Sul Bello di Plotino (Enneadi, I,6) la visione della bellezza sensibile è un momento fondamentale del cammino di ascesi e purificazione che deve ricondurla all’Uno: «L’anima purificata diventa dunque una forma, una ragione, si fa tutta incorporea, intellettuale ed appartiene interamente al divino, ov’è la fonte della bellezza e donde ci vengono tutte le cose dello steso genere (…) il bene e la bellezza dell’anima consistono nel rassomigliare a dio, poiché da lui derivano il bello e la natura essenziale degli esseri. (…) ». Compito dell’anima è perciò quello di distogliere gradualmente la propria visione da quei corpi che non sono altro che “immagini e tracce e ombre” della vera fonte della bellezza, e, rientrando in sé, risalire verso quell’Uno concepito come coincidente con il Bene e circondato da ogni parte dal Bello, un «Bello che dispensa la bellezza a tutte le cose e la dà rimanendo in sé senza ricevere nulla in sé».
Nel successivo trattato Sul bello intelligibile (Enneadi V,8) troviamo un’importante riformulazione della posizione platonica riguardo al tema della mimesis. Nella Repubblica Platone non aveva condannato in blocco l’arte mimetica (mimetike techne) , ma solo quella che si esplica come imitazione del sensibile e non del modello intelligibile, l’idea. Riprendendo una tesi già sostenuta da Cicerone nell’Orator e gravida di conseguenze per il futuro della riflessione sullo statuto dell’arte, Plotino sostiene che l’attività artistica si sviluppa a partire da un’idea presente nella mente dell’artefice, il quale è capace di imprimerne la forma nella materia.
In questo modo l’artista non è più concepito come vano imitatore dell’ingannevole mondo delle apparenze sensibili, né come rigidamente subordinato alla contemplazione di un’essenza metafisica e sovraindividuale, bensì come colui che reca nel suo spirito un’dea di bellezza ed è in grado di trasferirla nella materia, partecipando così nella stessa attività di imitazione demiurgica che pervade l’intera natura: una tesi, quella di Plotino, destinata ad aprire la strada verso una radicale rivalutazione dello statuto dell’artista e delle arti mimetiche che sarà sviluppata nelle poetiche del neoplatonismo rinascimentale.
LEONARDO da VINCI
Arte e interpretazione della natura
Gli scritti di teoria dell’arte di Leonardo da Vinci (1452-1519) – note, aforismi, osservazioni su temi diversi, dalla teoria della prospettiva e della rappresentazione di luci e ombre a indicazioni dettagliate sulla pratica quotidiana del dipingere – non furono pubblicati durante la sua vita.
Il Trattato della pittura, che è la fonte principale per conoscere le sue idee sull’arte, non fu redatto di suo pugno ma è una compilazione dovuto ai suoi allievi. Scritto probabilmente a partire dalla fine del Quattrocento, la prima edizione parziale apparve nel 1651 a Parigi, mentre l’edizione integrale, che si basa sul manoscritto 1270 di Urbino, uscì soltanto nel 1817 a cura di G. Manzi.
Il Trattato appartiene a pieno titolo a un insieme di tesi di teoria dell’arte scritti da artisti, architetti e umanisti che hanno segnato profondamente la cultura rinascimentale: tra questi possiamo menzionare i tre trattati di Leon Battista Alberti intitolati rispettivamente De pictura, De re aedificatoria e De statua, i Commentarii di Lorenzo Ghiberti, il De prospectiva pingendi di Piero della Francesca e il De divina proporzione di Luca Pacioli per quanto riguarda la teoria della prospettiva, i trattati di architettura del Filerete e di Francesco di Giorgio Martini o ancora, l’affascinante Hypnerotomachia Poliphili del domenicano Francesco Colonna. Attraverso la riflessione teorica sui principi delle arti visive e della rappresentazione, gli artisti rinascimentali aspiravano al riconoscimento delle loro attività come arti liberali e non più come mere arti meccaniche. Riprendendo categorie concettuali tratte dalla filosofia e dalla retorica, ed elaborando paradigmi storiografici miranti a esaltare il proprio ruolo di artisti, come quello presentato dal Vasari nelle Vite de’ più eccellenti architetti, scultori e pittori, sostenevano la necessità di attribuire alle arti visive uno statuto pari se non superiore a quello della poesia, di cui da tempo era stata riconosciuta la dimensione intellettuale.
Leon Battista Alberti è il primo umanista a sviluppare una teoria complessiva dell’arte nei tre trattati da lui dedicati alla pittura, all’architettura e alla scultura. Il De pictura, in particolare, costituisce un importante precedente e termine di confronto per la comprensione del Trattato di Leonardo. Qui l’Alberti comincia con la tesi secondo cui la pittura ha come oggetto solo ed esclusivamente il visibile (“Delle cose quali non possiano vedere, neuno nega nulla apartenersene al pittore. Solo studia il pittore fingere quello che si vede”) e prosegue sostenendo che la rappresentazione pittorica deve essere concepita come “intersezione della piramide visiva”, ossia come “finestra” aperta e delimitata all’interno del campo visivo.
Tale spazio della rappresentazione deve poi essere costruito seguendo rigorosamente le leggi della rappresentazione prospettica, elaborate di recente dal Brunelleschi, che si pensava riflettessero esattamente le leggi della visione. Sulla base di questa analogia tra visione empirica e rappresentazione pittorica si fondava, secondo l’Alberti, la “forza divina” della pittura, capace, “come l’amicizia”, di “far gli uomini assenti essere presenti, (e) i morti dopo molti secoli essere quasi vivi”. Dopo aver richiamato alcuni temi ripresi dalla Naturalis Historia di Plinio il Vecchio (23-79 d.C.), secondo il quale all’origine della pittura ci sarebbe stato il fascino di Narciso per la propria immagine riflessa e il tratto con cui furono delineati la prima volta i contorni dell’ombra di un volto amato, l’Alberti riprende l’argomentazione sistematica e suddivide la pittura in tre parti o momenti:
1. la circoscrizione dello spazio della rappresentazione;
2. la composizione degli elementi rappresentati;
3. la ricezione delle luci e delle ombre.
Nel suo insieme, la riflessione dell’Alberti sulle arti si caratterizza come un complesso tentativo di rifondare la pratica pittoria, architettonica e scultorea su basi razionali che avessero al tempo stesso precisi riferimenti nell’Antichità e una solida impostazione scientifica. Nel De re aedificatoria, la razionalità delle arti si fonda sul fatto che esse traggono origine dal disegno, inteso come “preordinazione concepita dall’anima” e come “prodotto dell’ingegno “ prima ancora che come tracciato materiale di linee e di angoli. Il riferiemento all’Antichità classica veniva individuato da un lato nella ripresa di termini tratti dalla teoria della retorica (inventio, compositio ecc.), e dall’altro nella formulazione della teoria del bello come concinnitas, un termine che riprendeva il tema ormai tradizionale della simmetria e della proporzione caricandolo di specifiche valenze morali. La scientificità dell’arte, infine, risiedeva nel riferimento alla teoria della prospettiva, argomento che durante il Rinascimento avrebbe occupato non soltanto artisti con spiccati interessi scientifici (Piero della Francesca, Lenardo), ma anche matematici (Luca Pacioli), architetti (Brunelleschi, Bramante), scultori (Ghibertim, Donatello). Fondare la teoria della rappresentazione pittorica sulla teoria della costruzione prospettica significava, come abbiamo visto da un lato conferire un fondamento “naturale” alla pittura rendendola analoga alla visione, e dall’altro trovare un metodo il più possibile univoco e stabile per la rappresentazione sul piano dello spazio tridimensionale e per la misurazione del decrescere delle grandezze rappresentata con l’aumentare della distanza.
Nel Trattato della pittura di Leonardo ritroviamo gran parte di questi temi, con alcune importanti differenze. Insieme al rapporto tra pittura e visione e alla costruzione prospettica della rappresentazione, troviamo infatti una grande varietà di osservazioni su temi diversi – la formazione del pittore, la vita quotidiana nello studio, i piaceri della pittura – oltre a indicazioni precise sulla rappresentazione del corpo umano, del paesaggio, dei corpi trasparenti o opachi, delle emozioni, delle storie. La problematica della luce e dell’ombra ricorre come parte essenziale di un approccio che, al culto della classicità che pervade gli scritti dell’Alberti, sostituisce un tentativo di legittimazione dello statuto scientifico della pittura a partire da un’incessante attività di ricerca e di sperimentazione sul mondo delle forme naturali. Lo statuto scientifico della pittura deriva, secondo Leonardo, dalla superiorità della vista rispetto a tutti gli altri sensi quale strumento di investigazione della natura. «L’occhio, che si dice finestra dell’anima, è la principale via donde il comune senso può più copiosamente e magnificamente considerare le infinite opere di natura». La pittura, “partorita dalla stessa natura” e intesa come capacità di riprodurre le realtà visibile, “evidenti”, sulla superficie piana, ha uno statuto propriamente filosofico: «la pittura è filosofia (…) sola imitatrice di tutte le opere evidenti di natura (…) è una sottile invenzione la quale con filosofica e sottile speculazione considera tutte le qualità delle forme: mare, siti, piante, animali, erbe, fiori, le quali sono cinte di ombra e di lume». Oggetto di conoscenza della pittura è dunque il visibile , la superficie visibile delle cose, che essa imita in modo che l’imitazione non si riduce a mera riproduzione ma costituisce un vero e proprio processo euristico, sperimentale, osservativo. L’atteggiamento di Leonardo nei confronti della natura è empirico e razionale al tempo stesso. Come ogni scienza degna di tale nome, la pittura deve avvalersi di “matematiche dimostrazioni” e di “esperienza”: essa “è prima nella mente del suo speculatore, e non può pervenire alla sua perfezione senza la manuale operazione”. Delle dieci qualità del visibile (“ luce, tenebre, colore, corpo, figura, sito, remozione, propinquità, moto e quiete”) la pittura è in grado di coglierne sette, in quanto non riesce a rappresentare l’interno dei corpi al di là della loro superficie opaca, né il moto e la quiete. Lo studio della natura è dunque filtrato dalla pittura come capacità rappresentativa che tratta la disposizione delle luci e delle ombre come un fenomeno naturale e la costruzione prospettica come una struttura geometrica che conferisce scientificità alla rappresentazione. La prospettiva, infine è studiata da Leonardo non solo come prospettiva lineare, che costruisce geometricamente il decrescere della grandezza degli oggetti con l’aumentare della distanza, ma anche come “prospettiva aerea” in cui la distanza stessa viene resa attraverso il colore e lo sfumato.
Da questa analisi della pittura quale strumento privilegiato di indagine del visibile deriva nel Trattato l’esaltazione del ruolo del pittore, “padrone di tutte le cose che possono cadere in pensiero all’uomo”, e la celebre tesi della superiorità della pittura rispetto alla poesia, una ripresa da parte di Leonardo del tema ormai tradizionale del paragone fra le arti. Il primato della pittura, secondo lui, deriva:
§ da un lato dalla superiorità della vista rispetto all’udito e dell’immagine rispetto alla parola (che sta all’immagine come l’ombra al corpo vero e proprio);
§ dall’altro dalla capacità dell’immagine di rappresentare simultaneamente il proprio contenuto, anziché successivamente come è costretta a fare la poesia, composta di parole che si susseguono l’un l’altra.
Una distinzione, questa, tra simultaneità della rappresentazione pittorica e sequenzialità del discorso poetico, che sarà ripresa e approfondita nel Settecento dal Laocoonte di Gotthold Ephraim Lesing (1729-1781).
GIAMBATTISTA VICO
La logica poetica
Nel capitolo della sezione storica dell’Estetica dedicato a Vico, Benedetto Croce scrive: «Il rivoluzionario, che, mettendo da parte il concetto del verisimile e intendendo in modo muovo la fantasia, penetrò la vera natura della poesia e dell’arte, e scoperse, per così dire, la scienza estetica, fu l’italiano Gianbattista Vico», e lo fece «dieci anni innanzi che si pubblicasse in Germania il primo opuscolo del Baumgarten» con la Scienza nuova prima del 1725. Le due sezioni presenti nella Scienza nuova seconda del 1730, intitolate rispettivamente “Della sapienza poetica” e “ Della discoperta del vero Omero”, avrebbero poi, secondo Croce, dato ulteriore fondamento al primato di Vico quale vero e proprio iniziatore dell’estetica, in anticipo rispetto ad Alexander Gottlieb Baumgarten, pubblica la Meditationes philosophicae de nonnullis ad poema pertinentibus nel 1735 e l’Aesthetica nel 1750. Nell’interpretazione di Croce, l’originalità e il valore fondativi del pensiero di Vico consisterebbero nell’aver ricondotto la poesia a “un periodo della storia dell’umanità” che deve essere inteso più in generale come “un momento della storia ideale dello spirito, una forma della coscienza”. Nella concezione vichiana della storia, la fantasia all’origine dell’espressione poetica è dotata di una sua autonomia espressiva e conoscitiva, tanto che si può dire che “il grado fantastico è affatto indipendente e autonomo rispetto a quello intellettivo, che non solo non gli può aggiungere alcuna perfezione, ma riesce solamente a distruggerlo”. Arte e scienza, fondate rispettivamente su fantasia e intelletto, sarebbero dunque attività contrapposte e inconfondibili, e merito di Vico sarebbe l’aver chiarito il ruolo e l’autonomia della “fantasia creatrice” nello sviluppo storico delle istituzioni e delle forme di conoscenza, del linguaggio, della mitologia, delle figurazioni simboliche, sicché, a ben vedere, “la vera Scienza nuova del Vico è l’Estetica”. Al tempo stesso, però, la lettura di Croce coglie alcuni aspetti cruciali dell’importanza del pensiero di Vico per la storia dell’estetica: il ruolo centrale, espressivo e conoscitivo attribuito alla fantasia, la produttività dell’immaginazione, il radicamento sensibile e sentimentale delle forme espressive.
Il tema della rivendicazione dello statuto di verità del poetico e dell’autonomia della poesia rispetto ad altre forme conoscitive e ad altre regioni della cultura era già stato al centro della riflessione ai autori del primo Settecento italiano come Gian Vincenzo Gravina (Della ragion poetica, 1708) e Ludovico Muratori (Della perfetta poesia italiana, 1706; Riflessioni sopra il buon gusto nelle scienze e nelle arti, 1708) e le loro opere costituiscono il contesto entro cui si sviluppa il pensiero vichiano. Nel nuovo approccio alla storia presentato da Vico nelle tre edizioni della Scienza nuova (1725,1730,1744), l’evoluzione delle istituzioni sociali dell’umanità dopo il diluvio procede in parallelo con lo sviluppo delle forme della conoscenza e del linguaggio. In un celebre passo della Scienza nuova seconda Vico scrive: “Gli uomini prima sentono senz’avvertire, dappoi avvertiscono con animo perturbato e commosso, finalmente riflettono con mente pura”. Allo sviluppo delle forme di conoscenza dalla sensazione al sentimento, alla fantasia e alla ragione corrisponde la suddivisione della storia in tre età e in tre forme linguistiche: «Ci sono pur giunti due gran rottami dell’egiziache antichità, che si sono sopra osservati. De’ quali uno è che gli egizi riducevano tutto il tempo del mondo scorso loro dinanzi a tre età, che furono: età degli dei, età degli eroi ed età degli uomini. L’altro, che per tutte queste tre età si fussero parlate tre lingue, nell’ordine corrispondenti a dette tre età, che furono: la lingua geroglifica, ovvero sagra, la lingua simbolica o per somiglianze, qual è l’eroica, e la pistolare o sia volgare degli uomini, per segni convenuti da comunicare le volgari bisogne della lor vita».
1. Età degli dei (ossia dei miti religiosi primitivi);
2. l’età degli eroi ( o del dominio signorile, così come è descritto nei poemi omerici);
3. l’età degli uomini (caratterizzata dalla comparsa del pensiero filosofico e delle codificazioni legislative).
Le forme espressive delle prime due età, la “lingua geroglifica” e la “lingua simbolica o per somiglianze”, devono, secondo Vico, essere ricondotte alle forme conoscitive che le hanno generate: sono espressione di una fantasia spontaneamente animistica e antropomorfica, ma manifestano una “sapienza poetica” che deve essere compresa filologicamente, evitando due forme opposte di pregiudizio quali il disprezzo razionalistico nei confronti delle superstizioni arcaiche – come se queste fossero prive di senso – e l’atteggiamento esoterico che vede in esse forme di sapere occulto. I miti non sono dunque né invenzioni arbitrarie né travestimenti allegorici di verità filosofiche, bensì narrazioni in cui trova espressione la natura mitico-fantastica dell’umanità primitiva, l’immaginazione collettiva dei popoli. Il mito è poesia, è l’esplicitarsi di una “sapienza poetica” che caratterizza le fasi iniziali dell’umanità, quando dominano facoltà come il senso, la fantasia, la memoria, che “mettono le loro radici nel corpo e prendono vigore dal corpo”. Nelle lingue geroglifiche e simboliche Vico rintraccia i “caratteri poetici” e gli “universali fantastici” di lingue che si sono formate a partire dai gesti e dal canto sulla base dell’esigenza di rapportarsi mimeticamente alla natura e di esprimere con vivacità le passioni. Le prime lingue articolate, che erano lingue “poetiche”, ricorrevano infatti a immagini, somiglianze, comparazioni, metafore. Figure retoriche come la metafora e la sineddoche non erano mere decorazioni esteriori che si aggiungevano a un linguaggio già organizzato, bensì forme espressive che riflettevano forme di conoscenza proprie di quell’”infanzia” dell’umanità nella quale la comprensione del mondo esterno avviene cogliendo somiglianze e analogie tra cose animate e cose inanimate. La “ragion poetica” che caratterizza la mentalità dei popoli nelle prime fasi del loro sviluppo è dunque pervasa dalla tendenza a comprendere il mondo secondo categorie mitiche, riconducibili a determinati “caratteri poetici” che devono essere intesi come forme embrionali di concetti nei quali la somiglianza metaforica supplisce alla mancanza di astrazione.
La riflessione di Vico sulla “sapienza poetica” e sul ruolo conoscitivo ed espressivo della fantasia si colloca pertanto nel quadro di un progetto di ricerca sull’origine dei miti, del linguaggio, dell’evoluzione delle società primitive. Il mondo storico studiato da Vico non è costituito di oggetti materiali ed esterni (come il mondo naturale), né di enti fittizi (come quello della matematica), bensì è un universo composto da motivi, propositi, azioni, passioni, speranze, linguaggi, miti, leggi, istituzioni civili che l’uomo può conoscere in quanto ne è il protagonista.
La “scienza nuova” delineata da Vico deve essere al tempo stesso storia filologia e filosofia, dove lo studio dei fatti si fonde con quello dell’evoluzione delle forme linguistiche e conoscitive. In aperta polemica con il razionalismo e il metodo deduttivo sviluppato dai cartesiani, caratterizzato dalla ricerca di un’evidenza razionale che respingeva qualsiasi contaminazione emotiva e da un ideale di austerità e sobrietà scientifica dello stile, Vico ribadisce l’importanza storica e gnoseologica dell’eloquenza che sa muovere gli affetti, della retorica, della poesia, della fantasia, dell’ingegno quale facoltà produttrice di metafore. Il “vero” che è oggetto della scienza non risiede tanto in rappresentazioni chiare e distinte che si offrono a una coscienza autonoma rispetto alla storia, bensì nei fatti e nelle concrezioni linguistico-espressive che la storia stessa ci propone; come scrive Vico, il vero coincide con ciò che è stato fatto , “verum ipsum factum”.
Radicata nello sviluppo storico dell’umanità, la fantasia possiede un potenziale espressivo diverso e autonomo rispetto alla ragione, quasi opposto ad essa: “La fantasia tanto è più robusta quanto è più debole il raziocinio”. Sottolineando un’opposizione tra conoscenza razionale e conoscenza poetica presente anche in Baumgarten, Vico sostiene che se le “sentenze filosofiche, che si formano dalla riflessione con raziocinii(…) più s’appressano al vero quanto più s’innalzano agli universali”, le “sentenze poetiche”, espressione di affetti e passioni , sono tanto più vere quanto più danno a conoscere il particolare. A fronte di questa opposizione al razionalismo cartesiano, Vico sviluppa delle tesi – come quella della radicale storicità del linguaggio che non deve essere inteso come una creazione arbitraria e convenzionale ma come un’istituzione radicata antropologicamente nell’evoluzione delle forme di vita e di conoscenza dei popoli – che rimarranno al centro della riflessione settecentesca sul linguaggio, in particolare in autori come Etienne Condillac (1715-1780), Pierre-Louis Maupertuis (1698-1759), Jean-Jacques Rousseau(1712-1778) e Johann Gottfried Herder (1744-1803).
ALEXANDER GOTTLIEB BAUMGARTEN
L’estetica (teoria delle arti liberali, gnoseologia inferiore, arte del pensare in modo bello, arte dell’analogo della ragione) è la scienza della conoscenza sensibile.
A cura di Claudia Bianco
Con le Riflessioni sul testo poetico (Meditationes philosophicae de nonnullis ad poema pertinentibus, 1735) e l’Estetica (Aesthetica, 1750) di Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-1762) l’estetica si costituisce come disciplina autonoma e specificatamente filosofica, dotata di una precisa collocazione nell’ambito del sapere e dell’insegnamento accademico, di un proprio oggetto e di un proprio fine. Coniando il neologismo di derivazione greca aesthetica, che conferisce valore di sostantivo all’aggettivo aisthetike (sensibile), Baumgarten attribuisce un nome comune a un complesso di temi che per la prima volta si trovano riuniti in uno stesso ambito disciplinare: teoria della conoscenza, psicologia e antropologia empiriche, poetica e retorica. Se è senz’altro legittimo attribuire a Baumgarten il ruolo di “fondatore” dell’estetica filosofica, bisogna però ricordare che la sua estetica non si propone in primo luogo come una scienza dell’arte, né come una filosofia del bello artistico, bensì trae origine dal tentativo di condurre una riflessione metodica, a partire da una serie di distinzioni relative alla teoria della conoscenza, su ambiti del sapere, come la poetica e la retorica, fino ad allora considerati extrafilosofici.
>Sullo sfondo della riflessione baumgarteniana si colloca la teoria leibniziana della conoscenza e la sistematizzazione che ne era stata data, a inizio Settecento, da Christian Wolff (1679-1754) , la cui produzione filosofica configura quello spazio enciclopedico nel quale l’estetica viene a collocarsi come disciplina autonoma nell’ambito della teoria della conoscenza. In diversi scritti – tra cui le Meditazioni sulla conoscenza, la verità e le idee, il Discorso di metafisica e i Nuovi saggi sull’intelletto umano – Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) propone una classificazione delle percezioni o conoscenze secondo la loro maggiore o minore chiarezza e distinzione, e questa classificazione costituisce un motivo di sostanziale distanziamento da Cartesio, che considerava chiarezza e distinzione nozioni equivalenti e designanti l’evidenza con cui le idee vere si presentano alla mente. Leibniz ,invece, distingue nettamente tra chiarezza e distinzione, all’interno di una classificazione delle conoscenze che, pur mantenendo un rigoroso continuiamo e gradualismo che esclude ogni soluzione di continuità , le suddivide in oscure e chiare, le chiare in confuse e distinte, le distinte in adeguate e inadeguate, e, infine,tutte le conoscenze in generale in simboliche e intuitive.
Nella classificazione leibniziana, oscure sono le conoscenze che non rendono possibile nemmeno l’identificazione del contenuto percepito, mentre chiare sono quelle che la rendono possibile. Le conoscenze chiare, a loro volta, possono essere confuse, quando del contenuto percepito non siamo in grado di isolare le singole componenti, o distinte quando possiamo individuarne un certo numero. Se l’individuazione delle componenti del contenuto percepito è esaustiva ed enumera tutte quelle semplici non ulteriormente scomponibili, abbiamo una conoscenza adeguata, se invece questo processo di analisi non arriva agli elementi primi, abbiamo una conoscenza chiara e distinta ma inadeguata. Infine, una conoscenza è simbolica se mediata da simboli o segni, intuitiva se il suo contenuto è colto direttamente senza mediazioni. La conoscenza perfetta, che è propria solo di Dio e costituisce l’ideale verso cui deve orientarsi la conoscenza umana sempre perfettibile, è, secondo Leibniz, quella al contempo chiara, distinta, adeguata e intuitiva. La conoscenza umana, invece, solo raramente è intuitiva e adeguata: per lo più è invece simbolica e inadeguata, nel senso che non può fare a meno della mediazione offerta da caratteri e immagini, e di rado riesce a cogliere, in una rappresentazione, in un’idea o in un concetto, tutte le unità concettuali semplici non ulteriormente scomponibili. La conoscenza chiara e confusa, infine – che Baumgarten considererà dominio specifico dell’estetica – è una conoscenza fondata su percezioni che, come sostiene Leibniz nelle Meditazioni sulla conoscenza, la verità e le idee, non ci permettono di “enumerare separatamente delle caratteristiche sufficienti a distinguere quella cosa dalle altre, sebbene la cosa possieda veramente tali caratteristiche e requisiti, nei quali si possa risolvere la sua nozione”.
Se in Leibniz la classificazione delle conoscenze rimanda comunque a un gradualismo conoscitivo privo di soluzioni di continuità, il problema che occuperà tutta la gnoseologia successiva, e in particolare Wolff e Baumgarten, sarà quello dei limiti delle varie forme di conoscenza, o, meglio, del suddividersi del continuum della conoscenza umana in ambiti differenti e diversamente caratterizzati quanto alla loro perfezione e perfettibilità. In particolare, quella che viene progressivamente delineandosi è una divisione tra conoscenza sensibile, fatta di rappresentazioni chiare e distinte. La distinzione, stabilita da Wolff nei paragrafi 54 e 55 della sua Psychologia empirica, tra “parte inferiore” e “parte superiore della facoltà di conoscere”, aventi per oggetto rispettivamente “idee e nozioni oscure e confuse” e “idee e nozioni distinte”, è ripresa da Baumgarten, che nella Metaphysica considera come pertinente alla psicologia empirica lo studio delle facoltà conoscitive superiori (intellectus, ratio) e inferiori (tra cui sensus, phantasia, memoria, facultas fingendi).
Al centro della riflessione che conduce Baumgarten a definire l’estetica come disciplina autonoma nel complesso enciclopedico del sapere c’è dunque un problema di tipo prettamente gnoseologico: distinguere con esattezza le diverse facoltà conoscitive, i vari livelli della conoscenza e le specifiche forme di perfezione che ciascun livello può attingere. A questo orizzonte di problemi si somma poi il tentativo di elevare a uno statuto filosofico la riflessione sulla poetica e la retorica , che opponeva, negli stessi anni in cui scrive Baumgarten, il classicismo razionale e prescrittivo di Johann Christoph Gottsched (1700-1766) e le tesi di Johann Jakob Bodmer (1698-1783) e Johann Jakob Breitinger (1701-1776), volte a esaltare la parola poetica come capacità di comunicare immagini fantastiche e muovere l’animo, rendendo visibile l’invisibile e reale il possibile.
Nella prima opera pubblicata da Baumgarten, le Riflessioni sul testo poetico, i contenuti della poetica e della retorica classiche sono reinterpretati a partire dal vocabolario teoretico della dottrina della conoscenza wolffiana: “le rappresentazioni procurate dalla parte inferiore della facoltà conoscitiva sono sensitive”, un’orazione composta da parole che significano rappresentazioni sensitive è un ‘”orazione sensitiva”, e “un’orazione sensitiva perfetta è quella le cui varie parti tendono alla conoscenza di rappresentazioni sensitive”. Tale “orazione sensitiva perfetta” è, secondo Baumgarten, il “poema”, il cui studio deve essere condotto da parte di una disciplina filosoficamente fondata, la “poetica”, capace di difendere l’autonomia e la poeticità della conoscenza sensibile rispetto alla conoscenza intellettuale, fatta di rappresentazioni chiare e distinte. In quello che è a tutti gli effetti un tentativo di ridefinire l’antico problema dei rapporti tra poesia, retorica e filosofia, riformulando all’interno della teoria della conoscenza leibniziana il tema dell’emancipazione creativo-poetica dell’immaginazione, Baumgarten sostiene l’autonomia della conoscenza sensibile e la legittimità filosofica della disciplina che ne studia il possibile perfezionamento. Il sensibile, che nella tradizione leibniziana era il territorio dell’oscuro e del confuso, non deve essere condannato bensì indagato nella sua specificità per coglierne le potenzialità conoscitive, come già aveva fatto lo stesso Leibniz considerando il piacere alla stregua di un sentimento con cui viene conosciuta, sebbene in modo oscuro e confuso, una certa qual forma di perfezione. Occorre ridefinire i rapporti tra sensibile e intelligibile, l’ambito delle rappresentazioni chiare e confuse non deve essere considerato meramente propedeutico rispetto alla conoscenza chiara e distinta, e la disciplina che lo studia deve trarre dalla psicologia i propri principi e il proprio statuto filosofico: “Filosofia poetica è la scienza che dirige verso la perfezione l’orazione sensitiva” ; essa deve occuparsi “ di quegli artifizi grazie ai quali le facoltà inferiori del conoscere potrebbero essere affinate, acuite, più felicemente impiegate a vantaggio del genere umano. Poiché la psicologia conferisce saldi principi, non dubitiamo affatto che si possa dare una scienza la quale diriga la facoltà conoscitiva inferiore: o scienza del conoscere sensitivo”.
La definizione dell’estetica quale scientia sensitive quid cognoscendi si ritrova nel primo paragrafo dell’introduzione all’Estetica, un breve testi che contiene in nuce tutto il programma baumgarteniano: “L’estetica ( teoria delle arti liberali, gnoseologia inferiore, arte del pensare in modo bello, arte dell’analogo della ragione) è la scienza della conoscenza sensibile”. In questo passo l’estetica è presentata come teoria delle arti liberali e come poetica, entrambe riconducibili a una forma di gnoseologia autonoma rispetto alla logica, anche se ad essa analoga , in quanto dotata di una propria specifica perfezione. Tale perfezione consiste non tanto nell’elaborazione di rappresentazioni chiare e distinte come quelle della logica, quanto nel perseguimento di una “chiarezza estensiva”, intesa come capacità di abbracciare la varietà e la diversità con uno sguardo complessivo e con rappresentazioni vivaci e concrete. L’orizzonte conoscitivo studiato dall’estetica si colloca al di sopra delle rappresentazioni oscure e indistinguibili, ma al di sotto della distinzione peculiare delle rappresentazioni colte dalle facoltà conoscitive superiori: si tratta di un orizzonte fatto non di astrazione ma di concretezza, varietà, individualità, un dominio dotato di una propria verità estetica conosciuta con i sensi e l’immaginazione e di una propria bellezza, che consiste appunto nella “perfezione della conoscenza sensibile”. Una verità estetica e una bellezza che vengono perse nel momento in cui la chiarezza e la confusione sono oltrepassate in direzione della chiarezza e della distinzione.
EDMUND BURKE

Il bello e il sublime
A cura di Claudia Bianco
Nicolas Boileau (1636-1711) nella Prefazione alla sua traduzione del trattato longiniano e nelle Réflexions critiques sur quelques passages du rhéteur Longin (pubblicate postume nel 1713), aveva distinto tra stile sublime ed effetto sublime: mentre il primo non è altro che uno dei generi dell’oratoria individuati dalla retorica antica, uno stile magniloquente e appropriato ad argomenti eroici, il secondo consiste nello “straordinario” e nel “meraviglioso” che ci colpiscono nel discorso.
Riprendendo e ponendosi in continuità con la riflessione longiniana, Boileau ne ripropone il dualismo e l’ambivalenza; il sublime si presentava come un fatto al tempo stesso stilistico-psicologico, ossia come una precisa strategia retorica mirante alla produzione di un effetto di ammirazione, sorpresa e rapimento nel lettore o nell’ascoltatore.
L’intento di Boileau che risultò poi invano, consisteva nel ricondurre il sublime all’interno di una poetica classicistica, attraverso un elogio della semplicità e della mitezza; invano poiché, a causa del suo continuo insistere sulla tematica degli effetti del sublime, finì per spingere il dibattito settecentesco in una direzione nettamente anticlassicistica, portando alla luce una concezione della poesia intesa come esaltazione, rapimento, pathòs. Oltretutto, siamo qui immersi in un clima culturale attraversato dall’ammirazione per poeti come Pindaro e Dante, Shakespeare e Milton, i cui scritti costituiscono il contesto a cui si riferisce l’Inchiesta sul Bello e il Sublime ( A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and the Beautiful, 1756) di Edmund Burke .
Anche solo osservando il titolo del trattato di Burke si comprende quali siano le linee guida del suo approccio al tema del sublime: quella che egli propone non è infatti un’analisi stilistica, poetica e retorica dei luoghi del sublime nella letteratura, bensì una ricerca filosofica sull’idea del sublime, condotta a partire da una psicologia empirica delle passioni e da una teoria empirica della conoscenza di stampo lockiano, secondo cui le idee e i sentimenti traggono origine dalle sensazioni. Il sublime, per Burke, è perciò un’idea che deve essere nettamente distinta dall’idea del bello e di cui da un lato bisogna cercare l’origine in determinate qualità sensibili o dinamiche esperenziali, e dall’altro scovarne gli effetti in determinate passioni e determinati sentimenti provati dal soggetto. Il trattato si apre con un’introduzione intitolata Sul gusto nella quale Burke, – intervenendo su un tema assai dibattuto nell’estetica di lingua inglese del Settecento, per esempio in La regola del gusto di Hume – si pronuncia a favore dell’esistenza di una regolarità e di una uniformità del giudizio di gusto in virtù del suo radicamento empirico-fisiologico, che è necessariamente intersoggettivo in quanto relativo alla natura umana in generale. Del gusto – ossia del giudizio relativo alle “opere dell’immaginazione e delle belle arti” – , così come della facoltà razionale di giudicare del vero e del falso, deve esistere una certa regolarità, altrimenti verrebbe minata la stessa natura sociale della vita umana. Secondo Burke, infatti è probabile che la regola sia della ragione sia del gusto abbia in tutte le creature umane le stesse caratteristiche; poiché, se non vi fossero principi del giudizio, così come di sentimento, comuni a tutti gli uomini, non si potrebbe fare nessun affidamento sulla loro ragione o sulle loro passioni, tale da permettere l’ordinario rapporto di vista. L’analisi delle idee del bello e del sublime condotta da Burke deve dunque partire da un attento esame delle passioni umane, della loro origine e delle loro trasformazioni all’interno della dinamica conoscitiva della mente, in cui operano facoltà come l’ingegno (wit) e il giudizio (judgement)che, rispettivamente, colgono somiglianze e dissomiglianze tra i contenuti sensibili derivanti dalla sensazione.
Per arrivare a definire lo statuto dell’idea del sublime Burke comincia affermando che esistono due specie di piaceri e di dolori:in primo luogo, piaceri e dolori di una natura positiva e indipendente; in secondo luogo quelli che nascono dalla cessazione della sensazione a loro opposta. In particolare, oltre al piacere positivo (pleasure), esiste un piacere negativo detto diletto (delight), che è appunto negativo o relativo in quanto scaturisce dalla scomparsa di un dolore o di un pericolo e consiste in una specie di tranquillità oscurata dall’orrore e ad una specie di passione mista di terrore e stupore. Il tema del terrore, quale componente ineliminabile del piacere prodotto dall’idea del sublime, assente dal trattato dello Pseudo-Longino e dagli scritti di Boileau, diventa un elemento centrale nella concezione burkiana del sublime, secondo la quale tutto ciò che può destare idee di dolore e di pericolo, ossia tutto ciò che è in certo senso terribile, o che riguarda oggetti terribili, o che agisce in modo analogo al terrore, è una fonte del sublime, il quale produce la più forte emozione che l’animo sia capace di sentire. Ma quindi cos’è il sublime? Per Burke è un’idea capace di provocare una sensazione di diletto e sentimenti come lo stupore, l’ammirazione, la riverenza e il rispetto ed il presupposto perché si possa parlare di sublime è la distanza interocorrente tra il soggetto che prova tali sentimenti ed il pericolo, distanza che deve perciò essere tale da non mettere a repentaglio la sua incolumità. Perché possa essere considerato tale, il sublime deve quindi essere contemplato come uno spettacolo da un soggetto posto a una certa distanza ma capace di lasciarsi coinvolgere empaticamente nello spettacolo osservato: come osserva Burke, noi proviamo un certo diletto, e non piccolo, nelle reali disgrazie e nei dolori degli altri.
In opposizione e in antitesi con il sublime è l’idea del “bello”, che secondo Burke non può essere definito, classicamente, come proporzione e armonia: l’ordine e la convenienza tra le parti sono infatti qualità colte dall’intelletto, là dove l’effetto della bellezza è molto più immediato e sensibile. La contemplazione di una proporzionalità armonica e funzionale suscita un’approvazione ben diversa dal piacere positivo provocato dalla visione della bellezza, la quale ha dunque un’origine sensibile; se le passioni suscitate dal sublime erano il terrore, lo stupore e il rispetto- passioni relative alla tendenza di ogni individuo alla propria autopreservazione, quella suscitata dalla bellezza è invece l’amore, una passione eminentemente sociale, intersoggettiva che nelle sue forme più intense diventa lussuria e ha per fine la procreazione, ma che può anche essere rivolta alla bellezza in generale.
La scelta di un approccio empiristico allo studio delle idee del bello e del sublime conduce Burke, da un lato, a tentare di individuare con precisione tutte le qualità sensibili capaci di determinarle, e dall’altro a descrivere le modificazioni fisiologiche e fisionomiche che esse determinano nel soggetto che le esperisce. All’origine dell’idea del sublime ci sarebbero quindi la contemplazione di spazi di ampie dimensioni (montagne, distese oceaniche, vaste pianure) e di una potenza tale da far perdere la nostra immaginazione, il sentimento dell’infinito, la privazione nelle sue diverse forme (il vuoto, l’oscurità, la solitudine, il silenzio), il grandioso e l’eccessivo, così come determinati colori, sapori e suoni; la concezione burkiana del sublime non è infatti caratterizzata da un primato della visione, bensì, al contrario, nasce dalla visione di cose piccole e delicate, e dal contatto con tutto ciò che è liscio, levigato, sinuoso. Nel delineare i tratti fisionomici che si accompagnano alle idee del bello e del sublime, infine, Burke si riferisce a tutta una tradizione che alla riflessione psicologica sull’origine e sulla natura delle passioni, aveva accostato osservazioni di carattere fisiologico e fisionomico; l’esempio più noto è il trattato di Charles Le Brun (1619-1690), in cui l’autore In questo testo Le Brun riprendeva la classificazione delle passioni esposta da Cartesio nel trattato Le passioni dell’anima per dare vita a una vera e propria tassonomia espressiva delle passioni così come esse si manifestano alterando il volto umano. Ricollegandosi a questa tradizione, Burke parla a sua volta delle manifestazioni somatiche che si accompagnano alle esperienze del sublime e del bello: un uomo che soffre di un violento dolore fisico ha i denti stretti, le sopracciglia fortemente contratte, la fronte corrugata, gli occhi incavati e roteanti affannosamente, i capelli irti; la voce è emessa a fatica in brevi grida e gemiti, tutto l’organismo è scosso. La paura o il terrore, che è un’apprensione del dolore o della morte, produce esattamente gli stessi effetti, che per violenza si avvicinano a quelli sopra menzionati, in proporzione alla vicinanza della causa e alla debolezza del soggetto. Quando abbiamo dinnanzi oggetti capaci di suscitare amore e diletto, il corpo è impressionato: il capo si piega un po’ di lato, le palpebre sono più socchiuse del solito, e gli occhi si muovono languidamente volgendosi all’oggetto; la bocca è semiaperta e il respiro è lento, inframmezzato di quando in quando da un profondo sospiro; tutto il corpo è rilassato, e le mani scendono inerti lungo i fianchi. Il tutto è accompagnato da un intimo senso di intenerimento e languore.
IMMANUEL KANT
La critica del giudizio estetico
La bellezza è simbolo della moralità.
A cura di Claudia Bianco
La stesura della Critica della facoltà di giudizio (Kritik der Urteilskraft, 1790) corona un intenso decennio di attività speculativa in cui Immanuel Kant (1724-1804) pubblica le due edizioni della Critica della ragion pura (1781 e 1787), i Prolegomeni a ogni futura metafisica che si presenterà come scienza (1783), i Primi principi metafisici della scienza della natura (1786) e, sul terreno della filosofia pratica, la Fondazione della metafisica dei costumi (1785) e la Critica della ragion pratica (1788). Come vedremo, per diverse ragioni la Critica della facoltà del giudizio non deve essere considerata soltanto come la terza critica kantiana – che viene dopo le prime due e ne porta a compimento il sistema – bensì come una riformulazione, un approfondimento dell’intera filosofia critica e trascendentale, a partire da un asse teorico che lega il sentimento di piacere e dispiacere con la facoltà del giudizio e con il principio a priori della finalità.
Con quest’opera Kant solo si confronta con tematiche, come quelle del bello e dell’arte, assenti nelle due critiche precedenti, ma giunge a formulare tesi decisive circa la struttura trascendentale del soggetto e il conciliarsi, nell’uomo, di tensione conoscitiva e destinazione morale. A partire da una riflessione trascendentale sulla natura del giudizio e del sentimento in quell’esperienza particolare che è l’esperienza estetica, Kant approfondisce la propria concezione dell’esperienza in generale, ossia del rapporto tra le facoltà dell’animo umano e gli oggetti cui esse si applicano.
Nella Critica della ragion pura Kant impiega il termine “estetica trascendentale” per definire la “scienza di tutti i principi a priori della sensibilità”. In quest’opera – che ha come obiettivo l’esposizione delle forme a priori della conoscenza al fine di legittimare l’edificazione di un sapere necessario e universalmente valido giudicando così le ambizioni della metafisica a presentarsi come scienza – , l’estetica trascendentale, che tratta dello spazio e del tempo in quanto forme a priori della sensibilità, viene completata dalla “logica trascendentale”, scienza delle leggi dell’intelletto in generale. Estetica e logica sono dunque due momenti complementari e interdipendenti nella ricostruzione della struttura trascendentale, a priori, della conoscenza. Le forme da esse analizzate – le forme a priori della sensibilità e i concetti puri dell’intelletto – non possono infatti prescindere le une dalle altre: “I pensieri senza contenuto sono vuoti, le intuizioni senza concetti sono cieche”.
In una celebre nota dell’Estetica trascendentale, Kant critica Baumgarten per aver usato il termine “estetica” per quella che in realtà non sarebbe altro che una “critica del gusto”, manifestando così la speranza infondata di “ ridurre a principi razionali il giudizio critico del bello, e elevarne le regole a scienza”. Secondo il Kant della Critica della ragion pura, infatti, “le regole e i criteri del gusto sono per le loro principali fonti empirici”, e una critica del gusto può essere sviluppata solo su basi psicologiche e non secondo principi a priori. L’errore di Baumgarten, quindi, sarebbe stato quello di considerare l’estetica come gnoseologia inferiore, ossia come una scienza avente per oggetto la sensibilità intesa come forma di conoscenza autonoma ma analoga, sebbene oscura e confusa, alla conoscenza intellettuale, mentre la filosofia trascendentale kantiana mostra, al contrario, che la conoscenza è possibile solo a partire dall’attività congiunta e interdipendente di sensibilità e intelletto intese come funzioni conoscitive radicalmente diverse. La differenza tra sensibilità e intelletto, in altre parole, non risiede secondo Kant nella minore o maggiore chiarezza delle rispettive rappresentazioni, ma nella loro diversa funzione trascendentale nell’edificazione della conoscenza.
La tesi esposta nella Critica della ragion pura della netta distinzione tra estetica trascendentale e critica del gusto, là dove si sostiene che quest’ultima non può avere che un fondamento empirico e psicologico, sembra essere ribaltata da Kant nella Critica della facoltà di giudizio, dove troviamo una vera e propria critica del giudizio estetico, cioè del gusto, che ne individua i presupposti trascendentali a priori. In realtà, ciò che cambia non è l’approccio critico-trascendentale all’estetica, ma la concezione della sua funzione nell’ambito del sapere: all’estetica quale analisi della correlazione trascendentale tra giudizio di gusto e sentimenti di piacere e dispiacere di fronte a prodotti dell’arte o a fenomeni naturali giudicati belli o sublimi. In entrambi i casi, rimane invariato il carattere critico-trascendentale dell’analisi kantiana, che ha per oggetto le strutture a priori, universali e necessarie della soggettività nel tentativo di comprendere il costituirsi dell’esperienza: criticismo significa infatti riflessione sulle condizioni a priori e sulla legittimità e comunicabilità del conoscere e del sentire, mentre trascendentale – come spiega Kant nell’Introduzione alla Critica della ragion pura – è ogni indagine “che si occupa non di oggetti, ma del nostro modo di conoscenza degli oggetti in quanto questa deve essere possibile a priori”.
Le tesi esposte nella Prefazione e nell’introduzione alla Critica delle facoltà di giudizio costituiscono un presupposto necessario per intendere il disegno complessivo dell’opera. Qui Kant presenta la critica del giudizio come completamento del disegno speculativo avviato con la Critica della ragion pura e la Critica della ragion pratica. L’indagine critica condotta da Kant in queste due opere aveva infatti finito per isolare e contrapporre due ordini di realtà: il mondo della natura da un lato, e il mondo della libertà dall’altro. Compito dell’introduzione alla Critica della facoltà di giudizio è chiarire in che modo possa essere raggiunta una mediazione tra questi due ordini, ossia tra il determinismo riscontrabile nel mondo naturale, fenomenico, spiegabile mediante rigorose leggi scientifiche, e la libertà che sta a fondamento delle azioni umane, compreso lo stesso pensare; in altre parole, tra la dimensione del conoscere e quella dell’agire. In questo complesso tentativo di ridefinire la struttura della propria filosofia critico-trascendentale, Kant attribuisce un ruolo di mediazione al sentimento di piacere e dispiacere, alla facoltà di giudizio e al principio di finalità: l’indagine condotta nella Critica della facoltà di giudizio consisterà allora nell’esame di quei sentimenti che si accompagnano al ritrovamento di un armonizzarsi finalistico delle leggi naturali e alla manifestazione di una corrispondenza finalistica tra le facoltà conoscitive del soggetto e gli oggetti cui esso si rivolge, che di quei sentimenti in cui emerge la superiore destinazione morale dell’uomo attraverso l’idea di libertà. Al termine di questo percorso, i diversi momenti della conoscenza e dell’agire, della scienza e della moralità, dovrebbero trovare un momento di mediazione proprio nel sentimento e nel giudizio.
La facoltà di giudicare, intesa genericamente come capacità di unificare un soggetto e un predicato, era già stata al centro dell’analisi della Critica della ragion pura, nella quale Kant aveva distinto tra
giudizi analitici e giudizi sintetici (a seconda che il predicato sia contenuto nel soggetto o no);
e giudizi a posteriori e a priori (a seconda che dipendano dall’esperienza o no).
Il compito della Critica della ragion pura era stato individuato nel tentativo di chiarire la legittimità dei giudizi sintetici a priori, tramite cui la conoscenza avrebbe potuto assumere un carattere necessario e universalmente valido, e dalla classificazione logica dei giudizi Kant aveva derivato la tavola delle categorie, i “concetti puri dell’intelletto” che operano a priori la sintesi delle intuizioni sensibili. Nella Critica della facoltà di giudizio, dopo aver definito il giudizio come facoltà di ricondurre un particolare sotto un universale, Kant introduce una nuova distinzione, quella tra giudizi determinanti e giudizi riflettenti:
nel primo caso il particolare e l’universale (la regola, il principio, la legge) sono dati, e compiti del giudizio è semplicemente ricondurre il particolare sotto l’universale;
mentre nel secondo è dato solo il particolare, e compito del giudizio è trovare un universale sotto il quale sussumerlo.
Determinanti sono sia i giudizi delle scienze esatte sia i giudizi pratici, i quali riconducono l’azione singola sotto l’universalità della legge morale. I giudizi riflettenti, invece, non hanno una funzione conoscitiva, né servono a individuare direttive dell’agire o principi di valutazione morale di un’azione compiuta: in essi la rappresentazione del particolare è riferita riflessivamente alle facoltà del soggetto e al sentimento da esso provato.
Il giudizio riflettente, secondo Kant, si esercita sui prodotti dell’arte e su quegli aspetti in cui la natura mostra la presenza di una finalità: aspetti che non sono sussumibili sotto le leggi necessarie dell’intelletto ma nei quali si rivela un accordo finalistico tra le facoltà soggettive capace di venerare un sentimento di piacere. In questo insistere sulla natura riflettente del giudizio estetico emerge con chiarezza il fatto che l’esperienza estetica in Kant non è un’esperienza conoscitiva né presuppone una concezione dell’arte e della bellezza quale manifestazione del vero, come avverrà in Schelling e Hegel, bensì ha un senso eminentemente riflessivo: in essa il soggetto trascendentale perviene a una forma di autoaffezione, di sentimenti di sé con cui viene esperita l’attività delle facoltà trascendentali dell’animo umano.
Le due parti in cui si suddivide la Critica della facoltà di giudizio – “Critica del giudizio estetico” e “ Critica del giudizio teleologico” – contengono l’analisi di due forme diverse del giudizio riflettente:
nel giudizio estetico la facoltà di giudizio è chiamata a esprimersi su ciò che è definito “bello” o “sublime”;
mentre nel giudizio teleologico essa si esplica in relazione a quegli aspetti del mondo naturale e umano che possono avere una spiegazione finalistica.
Il giudizio estetico è poi detto riflettente in quanto in esso il soggetto riflette sulla “semplice apprensione della forma di un oggetto nell’intuizione”, indipendentemente dal prodursi di una conoscenza. La sua analisi è condotta da Kant in due sezioni, l’”Analitica del bello” e l”Analitica del sublime”, a cui segue la “Deduzione dei giudizi estetici puri”.
Del giudizio sul bello Kant propone un’analisi che si fonda sulla stessa suddivisione logica dei giudizi utilizzata nella Critica della ragion pura, secondo la qualità, la quantità, la relazione e la modalità. In base alle argomentazioni sviluppate in questi quattro momenti dell’Analitica del bello, le tesi cui giunte Kant sono, in ordine, le seguenti: bello è ciò che è oggetto di un piacere disinteressato, che “piace universalmente senza concetto”, che esprime una finalità “percepita senza la rappresentazione di uno scopo”, e che suscita un piacere “necessario” . Con la prima tesi circa il carattere disinteressato del piacere suscitato dal giudizio sul bello, Kant intende distinguere nettamente tra bello, buono e piacevole: i predicati del buono e del piacevole sono infatti legati all’interesse per l’esistenza di ciò che è giudicato tale, mentre nel caso del bello siamo in presenza di un giudizio puramente “contemplativo”, caratterizzato dall’assenza di interesse per l’esistenza dell’oggetto bello.
La seconda e la quarta tesi, che asseriscono il carattere universale e necessario del piacere provato in concomitanza con il giudizio sul bello, contengono una delle affermazioni più importanti della Critica della facoltà di giudizio: i giudizi di gusto – sempre logicamente singolari, in quanto formulati secondo lo schema “ x è bello” – devono poter ambire a una validità universale, ossia devono poter essere condivisi intersoggettivamente pur senza essere fondati su concetti. La ragione di questa pretesa è trascendentale, e risiede nella natura del piacere provato in concomitanza con il giudizio estetico, un piacere derivante da quello che Kant chiama “libero gioco” delle facoltà conoscitive coinvolte nel giudizio sul bello: l’immaginazione e l’intelletto. Questo armonico accordarsi delle facoltà soggettive produce infatti uno stato d’animo soggettivo, non vincolato ad alcun concetto o regola e tuttavia condivisibile intersoggettivamente, una sorta di senso comune fondato sul sentimento che Kant chiama sensus communis aestheticus. Dal luogo del variare soggettivo e imprevedibile delle sensazioni, il giudizio di gusto diventa dunque in Kant il fondamento trascendentale della possibilità di condividere intersoggettivamente il sentimento, luogo in cui l’esperienza del gusto può essere comunicata e assumere una valenza sociale.
Il terzo momento dell’analitica del bello, infine, asserisce che bello è ciò che piace “senza la rappresentazione di uno scopo”, distinguendo in tal modo
una bellezza “libera” (pulchritudo vaga), indipendente da qualsiasi rappresentazione di un fine determinato,
da una bellezza “aderente” (pulchritudo adhaerens), subordinata al concetto di ciò che l’oggetto deve essere.
In questo modo Kant distingue nettamente tra bellezza e perfezione, criticando la concezione baumgarteniana della bellezza come perfezione della conoscenza sensitiva.
Nell’Analitica del sublime il nesso tra bellezza e moralità – già evidente nell’insistenza da parte di Kant sul tema della libertà in rapporto al bello, fonte di un piacere libero e disinteressato, fondato sul libero gioco di immaginazione e intelletto – diventa ancora più stringente. Tale nesso emerge proprio a partire dall’individuazione delle differenze tra bello e sublime; se il bello è connesso alle idee di limitazione e di forma, il sublime rimanda alle idee di illimitatezza e informe; se il sentimento di piacere che si accompagna al giudizio sul bello è tale da suscitare un’intensificazione delle forze vitali del soggetto, il giudizio sul sublime genera un’emozione in cui l’animo “è alternativamente attratto e respinto” e preda di un “piacere negativo” accompagnato non da gioia ma da meraviglia (Bewunderung) e rispetto (Achtung). L’esperienza del sublime nelle sue due forme – sublime “dinamico” e sublime “matematico” – è per Kant l’esperienza di una sproporzione tra le facoltà conoscitive del soggetto e l’infinita grandezza o infinita potenza che esso si trova dinanzi. Ciò si traduce da un lato nella consapevolezza del soggetto della sua insufficienza e limitatezza; dall’altro, però, per il solo fatto di poter pensare questa grandezza o infinita potenza che esso si trova dinanzi. Ciò si traduce da un lato nella consapevolezza del soggetto della sua insufficienza e limitatezza; dall’altro, però, per il solo fatto di poter pensare questa infinita grandezza e infinita potenza nella sua totalità, il sublime finisce per attestare l’esistenza di una facoltà dall’animo superiore a ogni misura dei sensi: la ragione, intesa come facoltà dell’incondizionato e sede dell’idea di libertà.
Al libero gioco tra immaginazione e intelletto che caratterizzava il giudizio sul bello subentra dunque, con il sublime, un confronto-scontro immaginazione e ragione, nel quale la prima, nella sua inadeguatezza, apre dialetticamente all’avvento della seconda, rivelando la superiore e soprasensibile destinazione morale dell’uomo attraverso quel sentimento di rispetto che , nella Critica della ragion pratica, era stato presentato come sentimento avente per oggetto la legge morale nella sua assoluta universalità, formalità e incondizionatezza. Il sublime descritto da Kant nella Critica della facoltà di giudizio si rivela quindi profondamente diverso da quello descritto da Burke e da Kant stesso nelle Osservazioni sul bello e sul sublime scritte nel 1764. Alla prospettiva empirico-psicologica di Burke – che presenta un’indagine empirica sulle qualità sensibili capaci di suscitare le idee del bello e del sublime e pertanto di generare i sentimenti e le passioni a esse corrispondenti- subentra ora una prospettiva rigorosamente trascendentale con l’obiettivo di esibire un peculiare rapporto tra le facoltà soggettive: il sublime non è un’idea suscitata da qualità sensibili e accompagnata da un piacere misto a terrore ( il diletto, delight) , bensì è il correlarsi trascendentale di un giudizio e di un sentimento che finisce per rivelare l’esistenza di una facoltà dell’animo superiore a ogni misura dei sensi, la ragione.
La “Deduzione dei giudizi estetici puri”, oltre a riprendere i temi della pretesa dei giudizi estetici alla validità universale e del gusto come senso comune estetico, affronta un serie di argomenti: la natura dell’arte, la spontaneità e la produttività del genio, la classificazione delle belle arti.
Nella definizione di arte come “produzione mediante libertà, cioè mediante un arbitrio che ponga la ragione a fondamento delle sue azioni “risuona l’eco della definizione di techne esposta da Aristotele nell’Etica nicomachea, secondo cui la techne è una produzione secondo ragione, mentre la classificazione delle belle arti in arti della parola, arti figurative e arti del gioco delle sensazioni visive o uditive a partire dal concetto di espressione riprende direttamente le argomentazioni esposte da Batteux nel trattato Le Belle Arti ridotte ad un unico principio. Il tema dell’espressione ritorna poi nella definizione kantiana del genio come “quel felice rapporto , che nessuna scienza può insegnare e nessuna diligenza può far imparare, nel rinvenire idee per un concetto dato e per altro verso nell’indovinare per esse l’espressione mediante la quale la disposizione dell’animo così provocata, quale accompagnamento di un concetto, possa essere comunicata ad altri”. Il genio artistico, nella sua esemplarità che non può essere imitata ma solo presa come modello, è descritto da Kant come capacità di esprimere idee estetiche, rappresentazioni che “danno molto da pensare” ed estendono e vivificano le facoltà conoscitive senza essere riconducibili ad alcun concetto. Speculari alle idee della ragione (concetti soprasensibili dei quali non può mai essere fornita un’intuizione corrispettiva), le idee estetiche sono rappresentazioni dell’immaginazione rispetto alle quali nessun concetto è adeguato. La produttività dell’immaginazione, che nella Critica della ragion pura esplicava la propria funzione sintetica e conoscitiva generando gli schemi e quindi mediando tra intelletto e sensibilità, si esplica qui come creatività capace di pensare e comunicare l’inesprimibile.
Nella sezione finale della critica del giudizio estetico Kant conclude la propria riflessione sul giudizio estetico quale ponte tra dominio conoscitivo e dominio morale, affermando la tesi secondo cui “la bellezza è simbolo della moralità”. Preceduta da un’analisi sul ruolo del pensiero simbolico come capacità di “esibire” le idee della ragione tramite intuizioni sensibili ad esse analoghe, l’argomentazione di questa tesi sottolinea analogie e differenze tra bello e bene: al carattere immediato e disinteressato del piacere riferito al bello si oppone il carattere mediato e interessato del giudizio morale, fondato su concetti della ragione che stabiliscono imperativamente un dover essere; all’universalità solo soggettiva del giudizio estetico si contrappone l’universalità oggettiva, conoscibile mediante concetti, della moralità. Nonostante queste differenze, l’insistenza di Kant sulla dimensione di libertà presente nel giudizio estetico sul bello e sull’emergere dialettico della superiorità della ragione nel giudizio sul sublime mostrano come, in generale, il gusto possa avere una funzione propedeutica rispetto al rivelarsi della vera destinazione morale del soggetto.
CHARLES BATTEUX

Le belle arti: imitazione ed espressione
L’arte non crea le espressioni né le distrugge: le regola solamente, le fortifica e le raffina.
A cura di Claudia Bianco
Con il trattato Le Belle Arti ricondotte ad un unico principio (Les Beaux –Arts réduits à un méme principe, 1746) Charles Batteux (1713-1780) propone un’ipotesi di sistemazione del campo delle arti e delle facoltà soggettive a esse connesse, il genio e il gusto, destinato ad avere notevoli ripercussioni sull’estetica settecentesca. Sebbene il testo di Batteaux costituisca uno dei primi tentativi di delineare un vero e proprio “sistema delle arti”, il problema della definizione di ciò che è “arte” e della classificazione delle diverse arti in base ai loro principi e ai loro mezzi specifici non nasce nel Settecento. Nell’Antichità con i termini techne e ars si designava un’abilità produttiva, una capacità tecnica riconducibile a regole dettate dallo studio e dall’esperienza, in modo tale che l’insieme delle arti comprendeva una sfera assai ampia di attività poetico-imitative, di cui facevano parte la pittura e la scultura ma anche le diverse forme della produzione artigianale. La distinzione tra “arti meccaniche” e “arti liberali” si afferma solo successivamente: nel De nuptiis Philologiae et Mercurii, Marziano Capella (V sec. d.C.) individua sette arti liberali, che saranno in seguito suddivise nei due gruppi del trivium (grammatica, retorica, dialettica) e del quadrivium (aritmetica, geometria, astronomia e musica). Durante il Rinascimento, i frequenti scritti sul tema del paragone delle arti – nei quali, come nel Trattato della pittura di Leonardo, vengono messe a confronto pittura, poesia e scultura – sono l’indice del tentativo di elevare arti ritenuti prevalentemente manuali, come pittura e scultura, al rango di arti intellettuali come la poesia. Solo con l’estetica settecentesca, però, si afferma la distinzione netta fra arti pratiche e “belle arti”, e la riflessione su queste ultime si sviluppa all’interno di un campo teorico in cui confluiscono i temi della bellezza e del piacere, della sensibilità e dell’immaginazione, del genio e del gusto.
Il punto d’avvio della riflessione di Batteux è la constatazione della necessità di una semplificazione e di una sistematizzazione del discorso relativo alle belle arti, al fine di comprenderne più chiaramente la posizione autonoma e il valore conoscitivo all’interno del complesso della cultura. Le arti, secondo Batteux, possono essere suddivise in arti meccaniche, che hanno per oggetto “i bisogni dell’uomo” , arti belle, che hanno per oggetto “il piacere” e sono nate “in seno alla gioia e ai sentimenti che producono l’abbondanza e la tranquillità”, e infine arti “che hanno per oggetto l’utilità e la piacevolezza insieme”; al primo gruppo appartengono tutte le attività meccaniche e artigianali, al secondo, quello delle belle arti, appartengono musica, poesia, pittura, scultura e danza, mentre al terzo gruppo appartengono l’eloquenza e l’architettura. Il principio a cui può essere ricondotto l’insieme delle belle arti è quello dell’imitazione, intesa aristotelicamente come produzione di verosimiglianza, anche se poi nel testo di Batteaux il concetto di imitazione viene via via assumendo un significato originale.
Inizialmente Batteaux sostiene che l’arte è imitazione nel senso di copia di un modello: “Imitare è copiare un modello. Questo termine contiene due idee. 1) Il prototipo che porta i tratti che si vogliono imitare. 2) La copia che li rappresenta”. Ciò che deve essere imitato non è però solo ciò che in effetti è , ma anche ciò che “noi concepiamo agevolmente come possibile”, in modo tale che le arti “non sono che imitazioni, rassomiglianze che non sono la natura ma che sembrano esserlo; e così la materia delle belle arti non è il vero, ma soltanto il verosimile”. L’imitazione della natura operata dall’arte deve dunque essere un’imitazione selettiva e idealizzata tale che ciò che viene rappresentato è “la natura non come essa è in se stessa, ma quale potrebbe essere concepita mediante lo spirito”, così come fece il pittore antico Zeusi il quale, dopo aver radunato “i tratti separati di molte bellezze esistenti, si formò nello spirito un’idea artificiale che risultava da tutti quei tratti riuniti: e questa idea fu il prototipo o il modello del suo quadro, che fu verosimile e poetico nella sua totalità e non fu vero e storico che nelle sue parti prese separatamente”. L’imitazione proposta da Batteux come principio unificante del campo delle belle arti non deve dunque essere intesa come copia statica e passiva di un modello, bensì come invenzione verosimile di una natura ideale. Essa è “imitazione della “ bella natura” , la quale “ non è il vero che è, ma il vero che potrebbe essere, il bel vero, che è rappresentato come se esistesse realmente e con tutte le perfezioni che può ricevere”.
Nel trattato di Batteux il concetto “imitazione della bella natura” si precisa gradualmente attraverso un altro termine che assumerà un’importanza centrale nell’estetica settecentesca: il concetto di espressione. Dopo aver distinto i diversi mezzi impiegati dalle varie arti per imitare la natura Batteux fa un passo indietro ed elenca i tre mezzi di cui gli uomini dispongono “per esprimere le loro idee e i loro sentimenti: la parola, il tono della voce, il gesto”, forme espressive di cui la natura ha dotato l’uomo e di cui l’arte deve avvalersi plasmandole e indirizzandole verso i propri fini: “Le espressioni, in generale, non sono in se stesse né naturali, né artificiali: non sono che dei segni. Che le impieghi l’arte o la natura, che siano legate alla realtà o alla finzione, alla verità o alla menzogna, esse cambiano di qualità, ma senza cambiare di natura né di stato. Le parole sono le stesse nella conversazione e nella poesia, i tratti e i colori negli oggetti naturali e nei quadri: di conseguenza i toni e i gesti devono essere gli stessi nelle passioni, sia reali, sia favolose. L’arte non crea le espressioni né le distrugge: le regola solamente, le fortifica e le raffina. E come non può uscire dalla natura per creare le cose, non può maggiormente uscirne per esprimerle”.
Nel corso della storia della riflessione sulle arti, il concetto di “imitazione” ha subito diverse interpretazioni: da riproduzione irriflessa della natura a rappresentazione del possibile e dell’universale, da imitazione di modelli antichi a composizione idealizzante di elementi scelti, sottolineandone di volta in volta le potenzialità veritative o illusorie. In questo contesto, il concetto di imitazione della bella natura proposto da Batteux quale principio unificatore delle belle arti deve essere inteso come espressione di passioni e sentimenti da parte di un soggetto la cui attività è riconducibile a due facoltà correlate: il genio, inteso come capacità di creare plasmando le espressioni naturali e conoscendone le specificità linguistico-espressive, e il gusto, facoltà di giudicare i prodotti del genio. L’esercizio del gusto, “facilità di sentire il buono, il cattivo, il mediocre, e di distinguerli con certezza”, si fonda su basi naturali: si tratta infatti di un “sentimento” capace di cogliere quella “proporzione naturale” che vige tra la nostra anima e gli oggetti in cui si manifestano bellezza e bontà. Inizialmente destinato a giudicare delle cose naturali in rapporto ai nostri piaceri e ai nostri bisogni, il gusto è poi diventato giudice di quel “secondo ordine di bisogni” che sono il diletto e il piacere suscitati dalle arti imitative. Così come il genio, esso è “una facoltà naturale che non può avere per soggetto legittimo che la natura stessa o ciò che le assomiglia”.
L’originalità del trattato di Batteux risiede, da un lato, nell’aver ordinato in un unico quadro teoricamente autonomo arti diverse quali musica, poesia, pittura, scultura e danza; e dall’altro, nell’aver individuato nell’espressione la funzione dell’arte in quanto capacità del soggetto di oggettivare in opere sentimenti e passioni, secondo i dettami naturali del gusto e del genio.
Un’analoga concezione del potere espressivo dell’arte si ritrova in Denis Diderot (1713-1784), che nella Lettura sui sordomuti paragona i prodotti di arti come poesia, musica e pittura a “geroglifici” espressivi con cui il genio dà forma alla propria capacità sintetica di penetrare nella dimensione dinamica e organica della natura. In entrambi gli autori l’imitazione è dunque espressione e interpretazione, e non mera riproduzione del dato naturale. L’obiettivo di Diderot – individuare i “geroglifici particolari” di “ogni arte d’imitazione” – sarà poi ripreso da Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) nel Laocconte (1766), dove si contesta apertamente il tentativo di Batteux di ricondurre tutte le belle arti a un solo principio. Secondo Lessing, anziché sottolineare l’unità delle arti riconfermando così l’antica tesi dell’analogia tra pittura e poesia (l’oraziano ut pictura poesis), è necessario distinguere nettamente le diverse modalità espressive e i diversi oggetti a cui le arti si riferiscono. Nel caso della pittura e della poesia questa distinzione assume la forma di una vera e propria opposizione : come scrive Lessing, “oggetti che esistono l’uno accanto all’altro, o le cui parti esistono l’una accanto all’altra, si chiamano corpi. Di conseguenza, sono i corpi, con le loro qualità visibili, i vari oggetti della pittura. Oggetti che si susseguono l’un l’altro, o le cui parti si susseguono, si chiamano in generale azioni. Di conseguenza le azioni sono i veri oggetti della poesia”. Al di sotto del comune riferimento al principio dell’espressione, si delinea così in Lessino una separazione tra arti spaziali e arti temporali, arti della simultaneità e arti della sequenzialità, che avrà una lunga risonanza nella successiva storia dell’estetica.
GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL
L’arte e l’apparire sensibile dell’idea
L’arte, dal lato della sua suprema destinazione, è e rimane per noi un passato.
A cura di Claudia Bianco
Il testo conosciuto con il titolo di Estetica non è un’opera pubblicata da Hegel (1770-1831) – come la Fenomenologia dello spirito (1807) , la Scienza della logica (1812-1816) o l’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio (1817,1827) – bensì nasce dalla rielaborazione e dall’integrazione, da parte del discepolo Heinrich Gustav Hotho (1802-1873) , di una congerie di materiali diversi , la cui ossatura portante è costituita dagli appunti presi da numerosi uditori dei corsi universitari sull’estetica tenuti da Hegel prima a Heidelberg (nel1818) e poi a Berlino (1820-21,1823,1826,1828-29) .
All’inizio dell’Introduzione Hegel sostiene che l’estetica non deve essere intesa né come “scienza del sentire”, seguendo le tesi avanzate da Baumgarten, né come una disciplina che prende in considerazione i sentimenti suscitati dalle opere d’arte, bensì come “filosofia dell’arte” avente per oggetto il “bello artistico” , superiore, nella sua spiritualità, rispetto al bello naturale, Se in Kant la trattazione del bello riguardava tanto il bello artistico quanto il bello naturale, e il sublime era considerato esclusivamente come sublime naturale, nell’estetica di Hegel, in virtù del principio secondo cui “tutto quel che è spirituale è superiore a ogni prodotto naturale”, l’essenza della bellezza risiede nell’arte in quanto prodotto dello spirito: “l’opera d’arte è tale solo in quanto, originata dallo spirito, appartiene al campo dello spirito, ha ricevuto il battesimo di spirituale e manifesta solo ciò che è formato secondo la risonanza dello spirito”. Di qui deriva la legittimazione dello statuto filosofico e scientifico dell’estetica: essendo lo spirito pensiero in divenire e l’arte manifestazione dello spirito, nel pensare l’arte lo spirito pensa se stesso in una delle proprie forme, e questo pensarsi dello spirito è proprio ciò che definisce la filosofia.
Il fine dell’arte, secondo Hegel, non è né l’imitazione della natura né il tentativo di suscitare sentimenti e purificare le passioni, né l’ammaestramento o il perfezionamento morale: il vero scopo dell’arte è “rivelare la verità sotto forma di configurazione artistica sensibile”. Nel bello artistico si ha la manifestazione sensibile della verità, la rivelazione concreta e individuale dell’universalità dello spirito , “l’apparire sensibile dell’idea”. In questo senso l’arte è essenzialmente mediazione e conciliazione tra spirito e materia, universale e particolare, infinito e finito, pensiero e sensibilità: essa è un prodotto dello spirito con il quale questo dà vita a una prima forma di “conciliazione tra ciò che è semplicemente esterno, sensibile e transeunte , ed il puro pensiero, tra la natura e la realtà finita e l’infinita libertà del pensiero concettuale”. L’opera d’arte è dunque al tempo stesso sensibile e spirituale, si offre alla nostra apprensione sensibile e al contempo rivela attraverso di essa il proprio contenuto spirituale: “Perciò il sensibile nell’opera d’arte, in confronto con l’esistenza immediata della cosa naturale, è elevato a semplice parvenza, e l’opera d’arte sta nel mezzo tra la sensibilità immediata e il pensiero ideale. L’opera d’arte non è ancora puro pensiero, ma, nonostante la sua sensibilità, non è più semplice esistenza materiale, come le pietre, le piante, la vita organica”. A differenza delle pur varie forme del bello naturale, l’opera d’arte reca in sé un momento della vita dello spirito e fa appello a un pensiero capace di comprenderla nella sua essenza: essa “è essenzialmente una domanda, un’apostrofe , rivolta ad un cuore che vi risponde, un appello indirizzato all’animo e allo spirito”.
In quanto manifestazione, mediazione e conciliazione, l’opera d’arte costituisce una delle forme del percorso lungo il quale lo spirito si libera dall’esteriorità della natura per ritornare alla piena comprensione di sé. Come è noto, il sistema hegeliano esposto nell’Enciclopedia parte dalla logica (dell’essere, dell’essenza e del concetto) per trattare della filosofia della natura (nei suoi momenti meccanici , fisici e organici) e concludere poi, passando attraverso i gradi della filosofia dello spirito soggettivo e oggettivo, con il Sapere assoluto inteso come piena e trasparente autocomprensione dello spirito. In questo percorso teleologicamente orientato, la posizione storico-epocale dell’arte come manifestazione sensibile della verità precede quelle della religione e della filosofia. Mentre la religione esprime l’assolutezza dello spirito nell’interiorità della rappresentazione e del sentimento, e la filosofia nella pura concettualità del pensiero, l’arte, in quanto fondata su un fare e un produrre, pone lo spirito in opera , lo istituisce come ente finito e sensibile.
Con queste tesi Hegel si distanzia nettamente da tutta l’estetica settecentesca da quella kantiana, accusando la prima di essersi fermata all’analisi psicologica, empirica e soggettiva delle passioni e dei sentimenti suscitati dalle opere, e rimproverando alla seconda di non essere giunta alla perfetta conciliazione, nel bello, di quegli opposti (universale e particolare, ragione e sentimento, soggetto e natura) che pure aveva individuato con chiarezza. Il sentimento, secondo Hegel, non può costituire il perno della riflessione sul bello e sull’arte: esso è “una forma del tutto vuota dell’affezione soggettiva”, e “la riflessione sul sentimento si accontenta di osservare l’affezione soggettiva e la sua particolarità, invece di immergersi profondamente nella cosa, nell’opera d’arte, e lasciare perciò andare la semplice soggettività e i suoi stati”. La concezione hegeliana dell’arte è quindi segnata da un abbandono della centralità che avevano in Kant i temi del sentimento e del giudizio e il loro ruolo nel ridefinire la comprensione trascendentale dell’esperienza. Ciò non significa, però, che l’arte sia considerata come altra rispetto al sensibile: al contrario, il carattere sensibile dell’opera d’arte viene ribadito, ma è reinterpretato alla luce della concezione dell’arte come manifestazione della verità e presentazione dell’assoluto. Il problema della verità dell’arte si pone infatti, in Hegel, solo nell’ambito della concezione dell’apparire: “La parvenza stessa è essenziale all’essenza; la verità non sarebbe, se non paresse ed apparisse, se non fosse per qualcosa, per se stessa tanto quanto per lo spirito in generale. (…).
Lungi dall’essere semplice parvenza, ai fenomeni dell’arte è da attribuire, di contro all’effettualità abituale, realtà più alta ed esistenza più vera”. La natura sensibile dell’opera d’arte non è dunque mera parvenza bensì manifestazione e fenomeno della verità. Essa è il luogo in cui si conciliano un sensibile spiritualizzato e uno spirituale sensibilizzato.
L’Estetica , nell’edizione redatta da Hotho, si suddivide in tre grandi sezioni, dedicate rispettivamente all’”idea del bello artistico o l’ideale”, allo “sviluppo dell’ideale nelle forme particolari del bello artistico” e al “sistema delle singole arti”. Per quanto riguarda la prima sezione, Hegel sostiene che l’ideale non è l’idea come tale, quale cioè una logica metafisica deve concepirla come l’assoluto, ma l’idea in quanto si è foggiata a realtà ed è entrata con questa realtà in unità immediatamente corrispondente”. L’ideale che si manifesta nel bello artistico è la perfetta conciliazione di idea e forma concreta, la loro configurazione sensibile e figurativa, che è possibile solo là dove il contenuto rappresentato dall’arte non è irraggiungibile nella sua astrattezza ma suscettibile di essere concretizzato in un’opera.
La descrizione delle diverse modalità in cui si realizza la conciliazione di idea e forma, spirito e materia, pensiero e intuizione, costituisce la base a partire dalla quale Hegel distingue le varie forme in cui il nello artistico si è manifestato nel corso del cammino dialettico e teleologicamente orientato dello spirito: arte simbolica , arte classica e arte romantica.. In questo scheda triadico, in cui ogni momento deve essere compreso secondo la verità che vi si manifesta, l’arte classica ha una posizione e funzione centrale rispetto a quella simbolica , ancora incerta, disorientata, immersa in un’esteriorità che non è in grado di padroneggiare, e un’arte (quella romantica) ormai spinta dall’avvento di una nuova tendenza dello spirito a ritrarsi nella soggettività e nell’interiorità, avviandosi però in tal modo inesorabilmente alla propria dissoluzione e alla consumazione di qualsiasi possibilità di esprimere l’assoluto come tale. Se nell’arte simbolica “l’idea non ha ancora trovato in se stessa la forma, vi aspira soltanto, si sforza ad essa “, in quella classica si ha “la libera impressione adeguata dell’idea nella forma peculiarmente appropriata, secondo il suo concetto, all’idea stessa, con cui essa può quindi giungere a una libera, completa concordanza. Con ciò , soltanto la forma classica dà la produzione e l’intuizione dell’ideale compiuto e lo pone come realizzato”. L’equilibrio raggiunto dall’arte classica, che trova la sua più compiuta espressione nella rappresentazione della figura umana, viene perso con l’arte romantica, il cui oggetto è costituito dalla “libera spiritualità concreta” e nella quale predominano l’interiorità, l’intimità soggettiva, il sentimento individuale.
Nella terza e ultima parte il discorso sulle forme d’arte generali (simbolica, classica, romantica) e sul rapporto in esse tra idea e forma è riportato ai diversi generi artistici individuati in architettura, scultura, pittura, musica e poesia, Se l’architettura , nella sua elaborazione materiale della natura inorganica, appare come un genere artistico fondamentalmente legato alla forma d’arte simbolica, la scultura è invece il genere in cui si esprime con maggiore perfezione l’ideale della forma d’arte classica: “in essa l’interno spirituale, a cui l’architettura è solo in grado di accennare, si installa nella forma sensibile e nel suo materiale esterno, ed i due lati si plasmano l’un l’altro in modo tale che nessuno dei due prevalga. (…) ad opera della scultura lo spirito deve restare in immediata unità, quieto e sereno, nella sua forma corporea, e la forma deve essere animata dal contenuto di un’individualità spirituale”. Con pittura, musica e poesia prosegue la graduale liberazione dello spirito dalla materia e il distacco rispetto all’accordo armonico con la materia che caratterizzava la scultura come momento emblematico dell’arte classica. La pittura , avendo per oggetto “ il render visibile come tale”, è maggiormente spirituale della scultura, ancora legata alla pesantezza della materia, mentre nella musica è l’intera dimensione della spazialità ad essere oltrepassata dialetticamente in direzione di una “idealità temporale” con cui “ il suono scioglie l’ideale, per così’ dire, dal suo incatenamento materiale”. La poesia , infine, rappresenta la manifestazione più spirituale della forma d’arte romantica: in essa “il suono, estremo materiale esterno della poesia, non è più il sentimento che risuona, ma un segno per sé privo di significato”.
Con la poesia l’arte perviene al culmine della propria capacità di liberazione dello spirito dalla materia e dalla sensibilità. L’idea ora non ha più bisogno di concretizzarsi in un materiale esterno sensibile, ma “si effonde solo nello spazio interno e nel tempo interno delle rappresentazioni e dei sentimenti”. E’ questo il momento in cui l’arte “va oltre se stessa”, giunge al compimento del proprio ruolo di forma dello spirito assoluto, e trapassa nella religione e nella filosofia, Già nella Fenomenologia dello spirito era presente il tema di una morte o fine dell’arte, ossia del superamento e dell’inveramento dell’arte nella religione e nel sapere assoluto. Se l’arte intuisce l’assoluto e lo manifesta nel sensibile, tocca però alla religione rappresentarlo e alla filosofia portarlo alla compiuta autocoscienza, e questo impianto sistematico, impostato nella Fenomenologia, è ripresentato nelle due edizioni dell’Enciclopedia (1817 e 1827) e fa da sfondo alle Lezioni di estetica.
Parlare di fine dell’arte significa quindi ricordare che l’arte rappresenta solo una forma limitata e finita di manifestazione dell’assoluto, in cui può venire alla luce solo un certo grado di verità, quella passibile di essere rappresentata nel sensibile. Come ogni determinazione finita, anche l’opera d’arte è parte di un movimento dialettico e trova la propria verità nel tempo e nel divenire, nell’”inquietudine “ che spinge ogni finito oltre se stesso. Ogni determinazione finita è in se stessa contradditoria, e implica la spinta inesorabile verso il proprio tramonto. Lo spirito procede attraverso le sue figure e i suoi momenti secondo il ritmo della Aufhebung , quel movimento secondo cui ogni contenuto determinato è tolto dialetticamente per essere inverato ed elevato a uno stadio successivo. Lungo questo cammino, compito della filosofia è conoscere l’idea nelle sue manifestazioni e nei suoi successivi modi di comprendersi. A questi appartiene l’arte, che ha il suo prima nella natura e il suo poi , il suo superamento, nella religione, dove la verità si dà nella fede e nell’interiorità, e nella filosofia, dove la verità si dà finalmente nella forma propria, quella del concetto, al di là di ogni estraniazione. A differenza di Schelling (1775-1854) , che nelle pagine finali del Sistema dell’idealismo trascendentale (1800) presentava l’intuizione artistica come forma più alta di intuizione dell’assoluto, per Hegel l’arte non è il modo supremo di rivelarsi della verità. Avendo perso il suo intrinseco legame con il divino e, in quanto forma superata di manifestazione dello spirito, “l’arte, dal lato della sua suprema destinazione, è e rimane per noi un passato”.
FRIEDRICH SCHLEGEL
La poesia e il romantico
La nuova mitologia deve essere creata, tratta dalle profondità più remote dello spirito, e ciò deve essere la più artificiale delle opere d’arte, perché deve comprendere in sé tutte le altre.
A cura di Claudia Bianco
Nei diversi frammenti critici e nel Dialogo sulla poesia pubblicati da F. Schlegel (1772-1829) sulla rivista Athenaeum, da lui fondata nel 1798 insieme al fratello August Wilhelm Schlegel (1767-1845) , troviamo un’esposizione emblematica dell’estetica del primo romanticismo tedesco, in tutto il suo sperimentalismo e la sua frammentarietà. La rivista, pubblicata per soli due anni dal 1798 al 1800, raccoglieva i contributi di una ristretta cerchia di intellettuali che si era riunita a Jena intorno ai fratelli Schlegel . Di tale cerchia facevano parte, tra gli altri, il teologo e filosofo Friedrich Schleiermacher (1768-1834) , lo scrittore Johann Ludwig Tieck (1773-1853) , il poeta Friedrich von Hardenberg, più noto con lo pseudonimo di Novalis (1772-1801) , e il filosofo Friedrich Schelling (1775-1854) , che a partire dal 1798 cominciò a insegnare proprio a Jena. Il gruppo, i cui membri pubblicavano in forma anonima i propri contributi su Athenaeum , era unito dal progetto di intervenire sulla scena letteraria e filosofica al fine di operare una trasformazione radicale del modo di pensare e giudicare la poesia e la letteratura. La dimensione collettiva della riflessione elaborata dal circolo di Jena fu esplicitamente teorizzata da Schlegel con i termini di “sinfilosofia” e “simpoesia” indicanti lo spirito di partecipazione intellettuale ed emotiva che animava i membri del gruppo, i quali intendevano presentarsi come una sorta di Autore multiplo , capace di sintetizzare in sé “diverse nature complementari” volte a “creare opere comuni”, e al tempo stesso di veicolare all’esterno, attraverso un linguaggio spesso volutamente esoterico e frammentario, il messaggio di una rivoluzione da attuarsi nel campo della critica letteraria e della poesia. In questo senso il gruppo di Jena può essere considerato il primo movimento estetico letterario in senso moderno, consapevole della propria natura di élite intellettuale e intenzionato a far leva sulla dimensione collettiva della propria riflessione per aumentare la forza delle proprie idee.
Parlando di estetica romantica in riferimento agli scritti comparsi su Athenaeum e, in particolare, alla produzione teorica di F. Schlegel , sorge subito la necessità di chiarire il senso del termine “romantico” che, a differenza di altri termini appartenenti al vocabolario e alla storia dell’estetica, è diventato d’uso comune nel linguaggio correnti e sta a indicare determinati stati d’animo legati al sentimento, all’amore, alla passione, Da questa accezione di “romantico” come categoria psicologia è però ne3cessario prescindere, se si vuole comprendere il significato dei termini “romantico” e “romanticismo” nell’estetica e nella storia della letteratura, dove si sono gradualmente imposti come categorie stilistiche e storiografiche. Innanzitutto, è importante sottolineare che il circolo di Jena, pur avendo una netta consapevolezza della propria specificità e della propria collocazione storica, non si è mai autodenominato “romantico”. Negli scritti comparsi su Athenaeum , il termine è impiegato non per autodefinirsi come scuola, bensì per caratterizzare una forma di poesia che da un lato affonda le sue origini nel passato, nella poesia cristiana medioevale e rinascimentale, e dall’altro è l’autentica poesia ancora a venire, l’ideale di letteratura verso cui si orientano le aspirazioni estetiche utopiche del gruppo senese. Nel frammento 116 di Athenaeum leggiamo infatti che, a differenza di altri generi poetici che hanno esaurito la propria vitalità e possono essere analizzati nella loro totalità compiuta, “ il genere poetico romantico è ancora in divenire; anzi, questa è la sua essenza peculiare, che può soltanto eternamente divenire e mai essere compiuto. Esso non può esser esaurito da alcuna teoria, e solo una critica divinatoria potrà osare di voler caratterizzare il suo ideale.. Esso è solo infinito, così come esso è libero e riconosce come sua prima legge che l’arbitrio del poeta non tollera alcuna legge. Il genere poetico romantico è l’unico essere più di un genere e, per così dire, a essere la poesia stessa: poiché in un certo senso tutta la poesia è o deve essere romantica”.
Il termine “romantico” non era stato inventato né da Schlegel né dagli altri collaboratori della rivista: presente verso la metà del XVII secolo in Inghilterra – dove romantick significa “ al modo dei vecchi romanzi”, ossia di quelle forme di letteratura fantastica e l’argomenti per lo più cavalleresco delle romance – , ricompare nel Settecento in riferimento a paesaggi o edifici (castelli, rovine, foreste) con il significato di “pittoresco”. Nella Germania della seconda metà del Settecento assume un’altra accezione, che risulterà decisiva per comprendere l’uso fattone da Schlegel : “romantico” indica ora tutto ciò che si riferisce alle lingue e alle letterature neolatine, che anche noi oggi chiamiamo “romanze”. “Romantiche” sono quindi sia le forme tipiche di quelle letterature, come il poema cavalleresco o il romanzo vero e proprio, sia il contenuto di tali opere, spesso meraviglioso, fantastico, “romanzesco” . I termini “romantico” e “romanticismo” si sono poi imposti come categorie storiografiche indicanti sia il gruppo dei “romantici” jenesi, sia alcuni gruppi di intellettuali e scrittori attivi negli anni successivi, come per esempio quello della città di Heidelberg- caratterizzato da un profondo interesse per la mitologia e la storia delle lingue e delle tradizioni popolari -, che comprendeva il filologo Friedrich Creuzer (1771-1858) e gli scrittori Joseph Gorres (1776-1848) , i fratelli Jacob (1785-1863) e Wilhem Grimm (1786-1859) , Clemens Brentano (1778-1842) e Achim von Arnim (1781-1831) – o quello attivo a Berlino che ruota, a partire dal 1808, attorno alle figure di Adam Muller (1779-1829) e Heinrich von Kleist (1777-1811).
Dopo che per lungo tempo, seguendo il giudizio formulato da Hegel, la produzione critica e letteraria dei romantici è stata accusata di essere concettualmente fragile e filosoficamente inconsistente, a causa della propria frammentarietà e rapsodicità , negli ultimi decenni si è affermata la tendenza a riconoscere la statura propriamente filosofica degli scritti di autori come F. Schlegel , Novalis o Friedrich Holderlin (1770-1843), che pure rimase autonomo rispetto al gruppo di Jena, rinvenendo comuni radici “romantiche”nel pensiero dei tre grandi rappresentanti dell’idealismo: Johann Gottlieb Fiche (1762-1814)., Schelling e lo stesso Hegel (1770-.1831).
Il carattere propriamente filosofico dell’estetica romantica può essere colto in modo emblematico nella consapevolezza, ampiamente teorizzata da Schlegel dell’indiscindibilità di poesia e critica, arte e discorso sull’arte, letteratura e teoria (e, come vedremo, storia) della letteratura, La poesia romantica, secondo Schlegel , deve contenere sempre un momento di riflessione su se stessa. Nel frammento 238, pubblicato su Athenaeun, Schlegel , riferendosi alla poesia, romantica, parla di “poesia trascendentale” , ossia di una poesia intrinsecamente accompagnata dalla consapevolezza teorica del proprio significato e del proprio farsi, così come una filosofia è trascendentale se non si occupa tanto degli oggetti della conoscenza ma del modo in cui essi sono conosciuti.
Questa inscindibilità di poesia e critica ha un duplice significato, in quanto implica al tempo stesso che la poesia deve avere in sé una dimensione riflessiva, di autorispecchiamento, e che la critica deve farsi essa stessa poetica: nel Discorso sulla poesia Schlegel afferma che “ solo in poesia si può propriamente parlare di poesia”, e ciò spiega la forma stessa di questo scritto, che si presenta come un dialogo contenente al suo interno quattro brevi trattati, intitolati rispettivamente “Epoche della poesia”, “Discorso sulla mitologia”, “Lettere sul romanzo”, “Saggio sulla diversità dello stile nelle opere giovanili e nelle opere tarde di Goethe”.
Il primo breve trattato, “Epoche della poesia”,contiene una sorta di storia della letteratura in nuce che espone in modo molto sintetico alcune tesi fondamentali del primo romanticismo. Il percorso delineato va dalla letteratura della Grecia antica (i poemi omerici, le varie forme di poesia giambica, elegiaca, melica, ditirambica, la tragedia e la commedia) a Goethe – attraversando, in poche dense pagine, la letteratura della Roma antica, il Medioevo cavalleresco, Dante, Petrarca e Boccaccia, definiti “i tre capostipiti dello stile antico dell’arte moderna”, il poema cavalleresco rinascimentale del Boiardo e di Ariosto, e poi Cervantes e Shakespeare- e si conclude con un appello rivolto al futuro: “i tedeschi non hanno che da continuare a usare questi mezzi, seguire l’esempio dato da Goethe, esplorare le forme dell’arte fino alla sorgente, per dar loro nuova vita e nuove combinazioni tornare alle origini della propria lingua e letteratura, liberare l’’antica forza, il nobile spirito che ancora riposa, ignorato da tutti , nei documenti del passato e della nazione”. L’idea che l’individuazione dei tratti salienti della poesia del futuro debba prendere le mosse dalla considerazione del passato, esplorando “fino alla sorgente” la lingua, la letteratura e la civiltà del passato di una nazione, mostra bene uno degli aspetti insieme più importanti e influenti dell’intera estetica romantica: la radicale storicizzazione della riflessione sull’arte. Comprendere l’arte significa infatti, secondo i romantici, comprenderne la storia, l’evoluzione delle forme e degli stili da essa assunti. Compito dell’estetica, dunque, non è più fissare canoni, regole e modelli per la produzione artistica, né trattare temi quali il nello e il sublime in un’ottica gnoseologica o psicologica che prescinde dalla loro variabilità storica (cosa che avviene, per esempio, in autori settecenteschi come Baumgarten o Burke). L’estetica si propone ora come una filosofia dell’arte che prende le mosse proprio dall’intrinseca storicità delle opere e delle forme artistiche, ossia dalla loro irriducibile individualità e determinatezza, e questa esigenza di comprensione storica viene fatta valere dai romantici non solo in relazione all’arte ma anche al linguaggio, al diritto, alla religione.
La consapevolezza della determinatezza storica di ogni forma artistica agisce sul modo stesso di comprendersi e di presentarsi da parte dell’estetica romantica, là dove ricorrono frequentemente coppie di termini opposti come “antico” e “moderno” o “classico” e “romantico” . Si tratta di opposizioni che possono facilmente essere fraintese se non ricondotte al complesso della riflessione teorica da cui emergono in autori come Schlegel , Friedrich Schiller (1759-1805) , Hegel o Schelling. Nello Studio della poesia greca (1797) , Schlegelelabora un ampio paragone tra letteratura antica e letteratura moderna, nel quale la letteratura antica è presentata come il dominio dell’armonia , della perfezione, dell’equilibrio, mentre quella moderna appare caratterizzata dai valori opposti dell’anarchia, del caos, del disordine, dell’eccesso e del dissidio. Il senso complessivo del discorso schlegeliano mira a contrapporre il carattere naturale della cultura antica a quello artificiale della poesia moderna: da un lato la religione e la mitologia naturali della Grecia antica, dall’altro il carattere riflesso, artificiale, frammentario, ibrido della letteratura moderna, che affonda le proprie radici in una religione, il cristianesimo, con cui si spezza quell’unità armonica tra uomo e natura che caratterizzava le religioni antiche, A differenza del noto dibattito con cui,nella querelle degli Antichi e dei Moderni di fine Seicento, si confrontavano i sostenitori del primato della poesia natica e i fautori del primato dei moderni, in Schlegel la venerazione nei confronti dell’arte classica è accompagnata dalla consapevolezza che essa non può più porsi come modello da imitare. Tra arte antica e arte moderna ci sono differenze incolmabili, e l’universo di valori del moderno non può accogliere al suo interno un ordine ideale ormai perduto, se non vuole ricadere nella fredda precettistica del classicismo. L’equilibrio e la perfezione dell’arte, che riposavano sulla consonanza dello spirito creatore con il suo mondo e il suo destino, sono andati per sempre perduti, ma questa perdita e questa decadenza devono essere il punto di partenza per il raggiungimento di una nuova perfezione, attraverso una rigenerazione dell’arte a cui si rivolgono gli sforzi del circolo jenese.
La contrapposizione di antichi e moderni e quella, non equivalente, di classici e romantici, erano presenti in diversi scritti dell’epoca, anche di autori che non appartenevano al movimento romantico, col quale spesso entrarono in polemica . Poco prima che uscisse il testo di Schlegel Sullo studio della poesia greca, Friedrich Schiller, nel dicembre del 1795, aveva pubblicato sulla rivista Die Horen un saggio intitolato Sulla poesia ingenua e sentimentale, dove contrapponeva la poesia ingenua degli antichi – fatta di equilibrio, armonia e immediata comunione con la natura – alla poesia sentimentale dei moderni, nella quale dominano la scissione, la distanza della riflessione, la ricerca dell’infinito e la tendenza alla rappresentazione di un ideale che contrappone l’arte alla realtà. La diede classico-romantico ritorna poi nell’Estetica di Hegel , dove l’arte classica (preceduta da quella simbolica) è l’arte in cui l’idea si manifesta in modo perfetto ed equilibrato nel sensibile, mentre nell’arte romantica, che è poi l’arte cristiana, si annuncia già quel prevalere dell’interiorità spirituale che porterà al superamento dialettico dell’arte stessa da parte della religione della filosofia, Tra Schlegel , Schiller e Hegel vi sono tuttavia importanti differenze: in Schlegel la distinzione tra “antico” e “moderno” è una distinzione storica, a cui si aggiunge poi quella tra “classico” e “romantico” ; in Schiller, “ingenuo” e “sentimentale” sono categorie tipologiche , che individuano non due epoche della poesia, ma due ,modi o generi poetici; in Hegel,infine, l’arte “classica” e l’arte “romantica” sono due delle tre figure con cui si compie il cammino teleologico dell’arte come forma di autorealizzazione dello Spirito in direzione del suo superamento da parte della religione della filosofia.
Come abbiamo visto, l’approccio storico alla natura dell’arte esemplificato dal breve trattato “Epoche della poesia” è parte integrante del modo in cui i romantici definiscono e presentano la propria collocazione storica e la propria missione estetica. Una volta stabilita l’irrimediabile separazione tra antico e moderno, l’arte romantica si presenta come quell’arte che non si orienta verso una passiva riproduzione del modello classico bensì cerca nella tradizione della letteratura cristiana i cicli della letteratura cavalleresca medioevale, Dante, Petrarca, Boccaccio, Ariosto, Cervantes, Shakespeare) le radici di una rinascita della poesia. In Schlegel “moderno” non coincide quindi necessariamente con “romantico”: è infatti moderna ma non romantica tutta l’arte che si rivolge all’antico come a un ideale da imitare con regole e precetti, per esempio il classicismo francese, costante bersaglio polemico dei romantici. In questo senso , il romanticismo appare segnato da un netto discrimine rispetto alle teorie estetiche precedenti, ossia dall’abbandono definitivo del principio di imitazione inteso come statica riproduzione di un modello esterno, individuabile di volta in volta nell’antico, o nella natura, o in entrambi. Secondo i romantici, nella sua produttività e creatività l’arte non deve essere imitazione passiva della natura bensì continuazione della sua forza attiva e generatrice: un’idea comune ai fratelli Schlegel e allo Schelling del saggio Sul rapporto tra le arti figurative e la natura (1807) che era stata ripresa dagli scritti di Karl Philipp Moritz (1756-1793) , il quale per primo aveva avanzato l’idea di un’imitazione che non partisse dagli oggetti naturali ma si sforzasse di emulare la capacità creatrice della natura stessa. Nel Dialogo sulla poesia l’appartenenza della creazione poetica al flusso organico e metamorfico della natura è presentata con accenti che mostrano bene il carattere al tempo stesso critico e letterario di questo testo : “Smisurato ed inesauribile è il mondo della poesia, come smisurata ed inesauribile è la ricchezza,m profusa dalla natura vivificatrice, di piante, animali ed organismi di ogni specie, forma e colore, Neppure lo spirito più grande potrà facilmente abbracciare tutte quelle opere dell’arte o quei prodotti della natura che hanno forma e nome di poesia, E che cosa sono essi di fronte a quella poesia priva di forma e di coscienza che si muove nella pianta , risplende nella luce, sorride nel bambino, balena nel fiorire della giovinezza, arte nel petto innamorato delle donne?
Questa è la poesia prima e originaria, senza la quale certamente non esisterebbe poesia delle parole, E noi uomini non abbiamo, da sempre e per l’eternità, altro oggetto ed altro materiale di attività e gioia se non l’unico poema della divinità, di cui anche noi siano parte e fioritura: la terra. Se siamo in grado di percepire la musica del meccanismo infinito e di comprendere la bellezza di quel poema, è perché una parte del poeta, una scintilla del suo spirito creatore vive in noi e mai cessa di ardere con segreta violenza sotto la cenere dell’irragione da noi stessi prodotta”.
Il progetto di ricondurre la poesia alla vastità di quel “poema della divinità” che è la natura stessa, sta poi alla base del “Discorso sulla mitologia”, il secondo dei quattro saggi contenuti nel Dialogo sulla poesia. Schlegel vi sostiene la necessità di dar vita a una “nuova mitologia” , attraverso la quale conferire forza e vita alla nuova poesia romantica. L’idea di un ritorno alla mitologia era presente anche in un celebre manoscritto del 1796 intitolato Più antico programma sistematico dell’idealismo tedesco, che è stato attribuito, in modo non definitivo, ad Holderlin, Schelling o Hegel. Il breve testo costituisce un programma non solo dell’idealismo, ma anche del nascente romanticismo, e molte delle idee in esso contenuto riecheggiano temi affini in Schlegel o Schelling. La parte finale del Programma afferma la necessità di produrre una “nuova mitologia” che si ponga “ al servizio delle idee” , una mitologia della ragione capace di dare veste sensibile e forza immaginativo-poetica a contenuti razionali, in modo da renderli accessibili anche al di fuori di una ristretta cerchia di intellettuali: “Esporrò ora un’idea che, a quanto mi risulta, non è ancora divenuta cosciente in nessun uomo- è necessario possedere una nuova mitologia, ma essa deve porsi al servizio delle idee, deve divenire una mitologia della ragione. Se non daremo alle idee una forma estetica , cioè mitologica, esse non avranno interesse per il popolo, e viceversa: se la mitologia non è razionale , il filosofo ne deve provare vergogna, E così alla fine coloro che sono illuminati e coloro che non lo sono, si uniranno: la mitologia deve divenire filosofica, così da rendere il popolo razionale, e la filosofia deve divenire mitologica, così da rendere sensibili i filosofi. Allora regnerà tra gli uomini un’eterna unità!”.
Nel Dialogo sulla poesia Schlegel riprende il tema della “nuova mitologia” esposta nel Programma, sottolineando non tanto la necessità di un’estetizzazione della ragione o la possibile funzione sociale del mito in relazione alle attese utopiche del movimento romantico (temi, peraltro, che egli tratta in altri scritti), ma bensì concentrando la propria attenzione sul ruolo della mitologia in relazione alla poesia. Secondo Schlegel , la differenza fondamentale tra poesia antica e poesia moderna risiede proprio nel fatto che mentre quella antica aveva nella mitologia un centro e un terreno comune, quella moderna manca di questo fondamento:” Alla nostra poesia (…) manca un centro, quale è stata la mitologia per gli Antichi. La sostanza di tutto ciò per cui la letteratura moderna è inferiore all’antica si può racchiudere nelle parole; noi non abbiamo mitologia. Però, aggiungo, siamo prossimi ad averne una o almeno è giunto il momento di contribuire seriamente a produrla. Perchè essa verrà a noi per una via opposta rispetto alla mitologia di un tempo. Quella aderiva con semplicità e immediatezza a tutto ciò che di più naturale e vivo le offriva il mondo sensibile, e ad esso si formava. Al contrario, la nuova mitologia deve essere creata, tratta dalle profondità più remote dello spirito, e ciò deve essere la più artificiale delle opere d’arte, perché deve comprendere in sé tutte le altre; deve essere il nuovo letto e il nuovo vaso in cui scorra l’antica, immortale fonte primigenia della poesia; deve essere il poema infinito che racchiuda in sé i germi di ogni altro poema”. La nuova mitologia ricercata dai romantici, dunque, come è inevitabile nel quadro dell’artificialità della cultura moderna, deve essere creata, prodotta, rivolgendosi alle mitologie antiche e orientali, al cui studio Schlegel si dedicherà negli anni successivi al periodo senese. Se la poesia moderna vuole uscire dalla decadenza che la minaccia e ritrovare il centro vitale che le manca, deve riavvicinarsi a quell’intimo legame con il caos metaforico della natura così ben espresso dalla mitologia antica, utilizzando, per accostarsi all’incredibile, gli strumenti dell’ironia, dell’arguzia (Witz) , dell’allegoria: come scrive Schlegel nel Dialogo sulla poesia, ogni bellezza “è allegoria, e le cose supreme, proprio perché inesprimibili, possono essere espresse solo allegoricamente”.
ARTHUR SCHOPENHAUER
L’arte e la volontà
La musica […] non esprime il fenomeno, ma soltanto l’intima essenza, l’in sé di ogni fenomeno, la volontà stessa.
A cura di Claudia Bianco
Il pensiero di Arthur Schopenhauer (1788-1860) si sviluppa a partire dalla rielaborazione di alcuni temi kantiani e da una netta presa di posizione contro la filosofia hegeliana , e sfocia in una complessa visione metafisica della realtà che costituisce il presupposto imprescindibile per comprendere la sua concezione dell’arte. Alla visione hegeliana della storia come progressiva rivelazione comprensione di sé dello spirito attraverso il superamento dialettico dell’esteriorità, Schopenhauer contrappone quella di un mondo interamente mosso e dominato da un principio irrazionale, la volontà . Nella sua opera principale, Il mondo come volontà e rappresentazione (1819) , egli riprende e reinterpreta la distinzione kantiana tra fenomeno e noumeno ossia tra ciò che si manifesta all’interno delle forme trascendentali del soggetto conoscente si costituisce progressivamente come oggetto, e la cosa in sé, insesperibile e quindi in conoscibile. In Schopenhauer la distinzione kantiana è radicalizzata e accostata a quella platonica tra mondo sovrasensibile delle idee e mondo sensibile del divenire: alla dimensione del fenomeno, inteso come pura apparenza e rappresentazione , si contrappone la dimensione soggiacente della volontà, che per Schopenhauer è la vera e propria “cosa in sé” , il sostrato metafisico dell’esistente. In quest’ottica Platone e Kant sarebbero accomunati dall’aver entrambi giudicato “il mondo sensibile come un’apparenza che non ha in sé alcun valore, che possiede un significato e una realtà derivata solo in virtù di ciò che vi si esprime (la cosa in sé per Kant, l’idea per Platone)”.
Il dominio della rappresentazione è quello della conoscenza concepita come rapporto tra soggetto e oggetto vincolato alle forme dello spazio e del tempo e al principio di causalità., vero e proprio principio di ragion sufficiente per la comprensione del mondo fenomenico. I modi in cui il soggetto comprende i rapporti causali tra gli oggetti inscritti nel mondo della rappresentazione sono quattro, e Schopenhauer li espone in dettaglio nella dissertazione del 1813 intitolata Sulla quadruplice radice del principio di ragion sufficiente: a) il principium rationis sufficientis fiendi, cioè del divenire, che manifesta la causalità fisica nelle cose naturali; b) il principiom rationis sufficientis cognoscendi, cioè del conoscere, che regola la relazione logica tra le conclusioni e le premesse; c) il principium rationis sufficientis essendi, cioè dell’essere, che, presiedendo ai rapporti tra le parti dello spazio e del tempo, regola la concatenazione degli enti aritmetici e geometricim fondando la necessità delle conoscenze matematiche; d) il principium rationis sufficientis agenti, cioè dell’azione, che è la causalità naturale vista non dalla parte dell’oggetto ma da quella del soggetto, e che regola i rapporti tra le azioni facendole dipendere da motivi, stimoli, eccitazioni, presiedendo così alla necessità morale.
Al di sotto del mondo della rappresentazione – concepito da Schopenhauer quale mondo del fenomeno inteso come apparenza e inganno – sta la volontà, che è il fondamento della rappresentazione stessa. La via d’accesso al mondo come volontà è, per il soggetto , il corpo , e il corpo proprio, costante,ente attraversato da una volontà di vivere che si traduce in azione. Un corpo, quindi, che rivela, al di sotto della pluralità distinta dei fenomeni conosciuti secondo i principi di causalità e di individuazione, l’esistenza di una volontà intesa come principio unico e fondamentalmente irrazionale , un “impulso cieco” capace però di un “oggettivarsi” nel mondo della rappresentazione. “unica e identica in tutti gli esseri, (la volontà) vuole sempre e dappertutto la stessa cosa, e cioè oggettivarsi nella vita, nell’esistenza, in una varietà infinita di esseri e di forme, la quale non è altro che tutta una serie di adattamenti alle varie condizioni esterne, paragonabile alle molteplici variazioni di uno stesso tema” . I diversi modi con cui la volontà si oggettiva nel mondo sono chiamati da Schopenhauer “idee nel senso platonico”, e devono essere intesi come modelli eterni capaci di concretizzarsi e individualizzarsi in una molteplicità di fenomeni. Tali diverse forme di oggettivazione della volontà si dispongono per gradi di complessità crescente; al grado più basso si trovano le forze generali della natura (come la forza di gravità o il magnetismo9; seguono, quindi, in un processo ascendente, le forze che governano la vita delle piante e degli animali; infine , nell’uomo, la volontà diviene ragione, agisce secondo motivi determinati e al tempio stesso produce lotta, conflitto, aggressività volta all’autoaffermazione.
Di fronte a questo quadro metafisico dominato dall’irrazionalità della volontà e dalla lotta perenne che ha luogo all’interno delle sue diverse forme di oggettivazione (tensione verso la vita, istinti animali, egoismi individuali), all’uomo affidato il compito etico- conoscitivo di sottrarsi alla volontà di vivere che lacera il mondo della rappresentazione, e le vie di questa liberazione sono descritte nel terzo e quarto libro del Mondo, che costituiscono rispettivamente l’estetica e l’etica del pensiero di Schopenhauer. Il compito dell’arte è condurre il soggetto conoscente a liberarsi della propria individualità e del proprio asservimento alla volontà per cogliere le idee nella loro purezza, La conoscenza rappresentativa, fondata sul principio di ragion sufficiente e avente per oggetto la pluralità dei fenomeni individuali e delle loro relazioni, deve essere superata in direzione di una conoscenza che contempla l’oggetto singolo per cogliervi l’idea, al di fuori di ogni correlazione con altri oggetto. Una volta attinto questo livello di conoscenza, “il soggetto cessa di essere puramente individuale, e diviene soggetto conoscente puro e libero dalla volontà”, “limpido specchio dell’oggetto” capace di essere “di là dal dolore, di là dalla volontà, di là dal tempo”. L’arte è dunque “ la specie di conoscenza in ci è contemplata la vera essenza del mondo, nel suo sussistente all’infuori e indipendentemente da ogni relazione (…), specie di conoscenza in cui sono contemplate le idee, che sono l’oggettività immediata e adeguata della cosa in sé, della volontà”.
L’arte è opera del genio e ha per fine quello di cogliere le idee eterne per poi riprodurle e comunicarle all’interno di diverse forme espressive, come l’architettura, la scultura, la pittura, la poesia: “la sua origine unica è la conoscenza delle idee; il suo unico fine, la comunicazione di tale conoscenza”. Il genio, “dono innato”, è la capacità di portare al grado supremo la possibilità insita in ogni uomo, di astrarre dalle cose particolari e dalle loro relazioni per divenire “soggetto puro della conoscenza!, un soggetto che finisce per perdersi nell’intuizione, dimenticando la propria individualità. Il tema kantiano del disinteresse della contemplazione estetica assume qui la valenza metafisica di una vera e propria liberazione della coscienza dalla propria sottomissione alla volontà.
A partire da questa concezione dell’arte si chiarisce il significato della bellezza e la distinzione tra bello e sublime. Bello è ciò che è oggetto di una contemplazione estetica , ossia ciò che nella sua individualità lascia trasparire l’assolutezza dell’idea e conduce il soggetto contemplante a divenire puro soggetto conoscente, libero da ogni volontà. Tale contemplazione estetica, però, può essere attinta in diversi modi, ed è qui che viene in luce la differenza tra bello e sublime : “Finché questo atteggiamento della natura d’offrire se stessa, finché il significato e l’evidenza delle sue forme, esprimenti le idee che vi s’individualizzano sono le solo condizioni che ci elevano dalla conoscenza delle semplici relazioni (conoscenza che è al servizio della volontà) alla contemplazione estetica e alla dignità di soggetto di conoscenza libero da ogni volere, fino allora ciò che agisce in noi non è che il bello, e non altro che sentimento del bello quello che vibra in noi. Ma supponiamo che quegli oggetti, le cui forme significative c’invitano alla loro contemplazione, siano in relazione d’ostilità con la volontà umana in generale, quale si oggettiva nel corpo umano; supponiamo che tali oggetti le siano funesti, che la minaccino con una strapotenza vittoriosa di ogni opposizione, o che la riducano al nulla con la loro smisurata grandezza; se, nonostante tutto ciò lo spettatore non pone attenzione a questa relazione ostile con la sua volontà; (…) se, in qualità di soggetto conoscente puro e libero da ogni volontà, limitandosi a concepirne le idee, estranee a ogni relazione; se lo spettatore si trattiene quindi con piacere in tale contemplazione e se, infine, in conseguenza di tale atteggiamento, si eleva al di sopra di se stesso, della sua persona, della sua volontà, al di sopra di ogni volontà, allora davvero il sentimento che lo riempie sarà il sentimento del sublime”.
Una volta chiarite la natura e la funzione dell’arte e del piacere estetico che è all’origine sia dell’attività poetica del genio sia della fruizione delle sue opere, Schopenhauer presenta una descrizione della specificità estetica-conoscitiva dei generi artistici, secondo una vera e propria gradazione che va dal grado più basso di oggettivazione della volontà a quello più alto.
Il grado più basso è quello dell’architettura: considerata come arte bella e prescindendo dalla sua destinazione ai fini pratici, “nel qual caso essa è al servizio della volontà, e non della conoscenza pura”, essa favorisce l’intuizione di alcune idee relative ai gradi inferiori di oggettivazione della volontà, come “il peso, la coesione, la rigidità, la durezza”. Ogni edificio, contemplato come opera, esibisce la lotta tra il peso che lo trascinerebbe verso il basso rendendolo una massa informe, e la rigidità che gli conferisce forma e verticalità. Altri generi artistici – come l’arte del giardinaggio, la pittura di un paesaggio, la pittura e scultura che riproducono forme animali, la raffigurazione scultorea del corpo umano o la pittura storica – consentono di cogliere idee che esibiscono forme gradualmente pi- complesse di oggettivazione della volontà. Al vertice di questa scala ascendente troviamo la poesia, che si differenzia dalla storia per la sua capacità di rappresentare la natura umana nella varietà delle sue aspirazioni e delle sue motivazioni, e in particolare la tragedia, nella quale viene in luce “la lotta spaventosa della volontà con se stessa” nel grande quadro delle sofferenze umane: “ sia di quelle provenienti dal caso e dall’errore che governano il mondo sotto la forma di un destino fatale, con una perfidia che cha quasi l’apparenza di una persecuzione intenzionale, sia di quelle che hanno sorgente nella stessa natura umana, cioè, o nell’incrocio degli sforzi e delle volizioni degli individui, o nella malvagità e nella stoltezza della maggioranza degli uomini “.
Con la tragedia l’arte accede al grado supremo della sua capacità di condurre al di là della conoscenza vincolata alle forme della rappresentazione, Ciò che subentra è la “perfetta conoscenza dell’essere del mondo; conoscenza che, agendo come quietivo della volontà, produce la rassegnazione, la rinunzia, non soltanto alla vita, ma alla stessa volontà di vivere”. Al di là della tragedia rimane solo una forma d’arte, che appare come totalmente isolata dalle altre; si tratta della musica , che per natura non è una copia o una “ripetizione di qualche idea degli esseri di questo mondo” bensì , come le idee , una vera e propria forma di oggettivazione della volontà: “ la musica, infatti, non esprime il fenomeno, ma soltanto l’intima essenza, l’in sé di ogni fenomeno, la volontà stessa”. In essa la melodia ci racconta gli impulsi, gli slanci, i movimenti della volontà nel suo dipanarsi del mondo come rappresentazione, e l’uomo accede alla conoscenza di quella che è la verità metafisica fondamentale: “Soltanto la volontà esiste; la volontà, cosa in sé, e sorgente di tutti i fenomeni. La coscienza che la volontà prende di sé, l’autoaffermazione o l’autonegazione che si decide a trarne, ecco il solo avvenimento in sé”. Di fronte a tale verità il piacere estetico assume la forma di una consolazione , di uno spettacolo grandioso capace di liberarci dal dolore e dalla sofferenza e di condurci più in là , anche se in forma momentanea e transitoria, sulla via della rassegnazione e della negazione della volontà di vivere.
CHARLES BAUDELAIRE
La bellezza nella modernità
Perché ogni modernità acquisti il diritto di diventare antichità, occorre che ne sia stata tratta fuori la bellezza misteriosa che vi immette, inconsapevole, la vita umana.
A cura di Claudia Bianco
Pubblicata su Le Figaro nel 1863 , la raccolta di brevi saggi intitolata Il pittore della vita moderna (Le peintre de la vie moderne) testimonia dell’intensa attività di critico e saggista che Charles Baudelaire (1821-1867) affiancò , lungo tutto l’arco della sua vita, alla scrittura poetica. Nel 1845, in concomitanza con l’uscita della rivista L’artiste della prima poesia pubblicata Baudelaire con la sua firma – “A une dame créole”, che poi entrerà a far parte della celebre raccolta I fiori del male -, esce anche il primo articolo sui Salons di pittura , in cui si esalta la pittura di Eugène Delacroix (1798-1863) , definito “il pittore più originale dei tempi antichi e moderni”. I Salons erano ampie esposizioni d’arte che venivano organizzate ogni anno sin dal Settecento, inizialmente sotto gli auspici dell’Accademia e poi sotto il controllo dei professori dell’E’cole des Beaux Arts, che formavano la giuria delegata a decidere insindacabilmente quali artisti dovessero essere ammessi e quali no. Il controllo dei Salons da parte dell’ufficialità accademica fu in seguito contestato con episodi clamorosi da parte dei pittori rifiutati dalla giuria, come Gustave Courbet (1819-1877) , che nel 1855 creò un suo padiglione del “realismo”, o il gruppo degli impressionisti, che diedero vita nel 1863 al Salon des Refusés. Le mostre autonome degli impressionisti (1874-1886) e la fondazione, da parte di Georges Seurat (1859-1891) e Paul Signac (1863-1935) , del Salon des Indépendants, misero definitivamente in crisi la tradizionale istituzione, che perse gradualmente la sua importanza.
Nutrita da un costante interesse per la letteratura, la musica e la pittura a lui contemporanee, la produzione critica di Baudelaire comprende non solo gli articoli relativi ai Salons del 1845, 1846 e 1859 – con cui egli si inseriva in una tradizione avviata nel Settecento da Diderot – ma anche, tra gli altri, i saggi su Edgar Allan Poe (1809-1849) , Gustave Flaubert (1821-1880) , Victor Hugo (1802-1885), Théophile Gautier (1811-1872), Richard Wagner (1813-1883) e Delacroix. Nei brevi saggi che compongono Il pittore della vita moderna , l’attenzione si concentra sull’opera del pittore Costantin Guys (menzionato solo con le iniziali C.G. , per sua stessa volontà), che si rivela ben presto essere una sorta di alter ego dello stesso Baudelaire: con il pretesto di commentare l’opera e la personalità di Guys , Baudelaire finisce infatti per parlare di sé, esibendo i diversi punti di vista da cui si esercita il suo sguardo al tempo stesso affascinato e disincantato sulla modernità. L’io narrante che si rivela nei saggi è un critico che si presenta di volta in volta come osservatore distaccato, filosofo, moralista appassionato, dandy, girovago (flàneur). Già in un saggio appartenente alla raccolta dedicata al Salon del 1846 , intitolato “ A che serve la critica?”, Baudelaire sosteneva che la vera critica “deve essere parziale, appassionata, politica, vale a dire condotta da un punto di vista esclusivo, ma tale da aprire il più ampio degli orizzonti”. Ne Il pittore della vita moderna ritroviamo questo sguardo irriducibilmente soggettivo e parziale, e attraverso il commento all’opera di C.G. scaturiscono delle réveries morales aventi per oggetto, di volta in volta, la figura dell’artista, la bellezza, l’immaginazione, le donne, la moda, alla ricerca continua del significato che questi temi possono avere nel rivelarci l’essenza della modernità.
Parlando della figura dell’artista, Baudelaire descrive le diverse prospettive assunte nel suo ruolo di critico e poeta, capace di esercitare uno sguardo libero e spregiudicato, contraddittorio e paradossale nei confronti del mondo. L’artista descritto da Baudelaire è un “uomo del mondo intero, che comprende il mondo e le ragioni misteriose e legittime di tutte le sue usanze”, un “cittadino spirituale dell’universo” per il quale la curiosità costituisce “il punto di partenza del suo genio”. E’ un eterno convalescente , per il quale “la convalescenza è come un ritorno all’infanzia” e al continuo fascino della novità che la pervade: “ Il convalescente possiede in sommo grado, come il fanciullo, la facoltà di interessarsi vivamente alle cose, anche a quelle in apparenza più banali. Proviamo a risalire, se è possibile, con uno sforzo retrospettivo della fantasia, verso le nostre impressioni più giovani e più aurorali, e vedremo allora che esse avevano una singolare affinità con quelle impressioni, dai colori così vivi, che più tardi abbiamo ricevuto in seguito a una malattia fisica , purché la malattia abbia lasciato pure e intatte le nostre facoltà spirituali. Il fanciullo vede tutto in una forma di novità, è sempre ebbro. Nulla somiglia tanto a quella che chiamo ispirazione, quanto la gioia con cui il fanciullo assorbe la forma e il colore. Ma io vorrei andare ancora oltre: dico che l’ispirazione ha un qualche rapporto con la congestione, e che a ogni pensiero sublime si accompagna una scossa nervosa, più o meno intensa, che si ripercuote sin nel cervelletto”.
L’artista descritto da Baudelaire non è però solo convalescente e fanciullo, bensì anche un dandy , ossia colui che partecipa del mondo conoscendone i più intimi meccanismi ma al tempo stesso ostentando distacco e superiorità. Come un “animale depravato” che però ha saputo mantenere “il dono della facoltà di vedere”, insieme alla “potenza di esprimere”, il dandy vive in una dimensione di puro dispendio, di completa inutilità , ammirando “la bellezza eterna e la stupenda armonia della vita nelle capitali”. Il suo sguardo, al tempo stesso cinico e affascinato, “!gioisce della vita universale”, del variare delle mode e dell’anonimato di una folla sempre mutevole: “Sposarsi alla folla è la sua passione e la sua professione. Per il perfetto perdigiorno (flàneur) , per l’osservatore appassionato, è una gioia senza limiti prendere dimora nel numero, nell’ondeggiante, nel movimento, nel fuggitivo e nell’infinito. Essere fuori di casa, e ciò nondimeno sentirsi ovunque nel proprio domicilio; vedere il mondo, esserne al centro e restagli nascosto (…). Così l’innamorato della vita universale entra nella folla come in un’immensa centrale di elettricità. Lo si può magari paragonare a uno specchio immenso quanto la folla; a un caleidoscopio provvisto di coscienza, che, ad ogni suo movimento, raffigura la vita molteplice e la grazia mutevole di tutti gli elementi della vita, E’un io insaziabile del non-io , il quale, ad ogni istante, lo rende e lo esprime in immagini più vive della vita stessa, sempre instabile e fuggitiva”. Nella sua continua ricerca di “distinzione” , l’atteggiamento del dandy “confina con lo spiritualismo e con lo stoicismo”; come “un sole al tramonto”, emana un “ultimo bagliore di eroismo nei tempi della decadenza”.
Descrivendo lo sguardo del dandy, Baudelaire non fa altro che descrivere la natura del proprio sguardo critico e poetico nei confronti di una realtà che deve essere colta in ciò che ha di assolutamente unico e irriducibile, la propria modernità. Abbiamo già visto che il problema dell’individuazione di ciò che è moderno , e dunque il tentativo di un’autofondazione da parte della modernità stessa, si è spesso posto all’interno della riflessione estetica, per esempio negli scritti di Schlegel, nei quali attraverso l’opposizione tra “antico” e “moderno” viene in luce la vera natura di ciò che è “romantico” , ossia della poesia a venire e delle sue radici storiche.
In Baudelaire la comprensione dell’essenza della modernità non avviene all’interno di una filosofia della storia segnata dal primato della civiltà e dell’arte antica, bensì alla luce di uno sguardo che cerca ciò che di eterno e duratura si nasconde nel presente e nell’effimero: in un celebre passo del saggio intitolato, per l’appunto, “La modernità” , Baudelaire scrive che “ la modernità è al transitorio, il fuggitivo, il contingente, la metà dell’arte, di cui l’altra metà è l’eterno e l’immutabile (…) perché ogni modernità acquisti il diritto di diventare antichità, occorre che ne sia stata tratta fuori la bellezza misteriosa che vi immette, inconsapevole, la vita umana”. Il compito dello sguardo del critico viene quindi a confondersi con quello del poeta, nel tentativo di “cercare e illustrare la bellezza della modernità”. In questo modo il presente non acquisisce la consapevolezza di sé opponendosi a un’epoca ripudiata e oltrepassata, oppure a un passato mitizzato e idealizzato: l’attualità si costituisce invece come punto di incrocio fra istantaneità ed eternità, nel momento in cui il transitorio viene fissato poeticamente e trasfigurato nell’eterno. Di qui la “teoria razionale e storica del bello” che Baudelaire ci presenta nel saggio “Il bello, la moda e la felicità”: “Il bello è fatto di un elemento eterno, invariabile, la cui quantità è oltremodo difficile da determinare, e di un elemento relativo, occasionale, che sarà, se si preferisce, volta a volta o contemporaneamente, l’epoca, la moda, la morale, la passione. Senza questo secondo elemento, che è come l’involucro dilettoso, pruriginoso, stimolante del dolce divino, il primo elemento sarebbe indigeribile, non degustabile, inadatto e improprio alla natura umana. Sfido chiunque a scovarmi un esemplare qualsiasi di bellezza dove non siano contenuti i due elementi”.
Nella costante ricerca del bello all’interno della dimensione poliedrica e contraddittoria della vita moderna, lo sguardo del poeta deve orientarsi verso il sublime e il meraviglioso che si nasconde nella quotidianità : “ La vita parigina è fertile di soggetti poetici e meravigliosi. Il meraviglioso ci avvolge e ci bagna come l’atmosfera; ma non lo vediamo”. Fine del poeta e del critico non deve essere imitare passivamente la realtà, bensì liberare i poteri dell’immaginazione, facoltà dell’analisi e della sintesi, dell’analogia e della metafora, del verosimile e del possibile, “concretamente congiunta con l’infinito”. In questo modo diventa possibile cogliere quelle correspondances che danno il titolo a uno delle più celebri poesie de I fiori del male “foreste di simboli dagli occhi familiari” che rivelano come tutto l’universo visibile non sia altro che “un deposito di immagini e di segni ai quali l’immaginazione deve attribuire un posto e un valore relativo”.
La tendenza “realista” e “positivista” presente nell’arte a lui contemporanea, il dominante gusto per il Vero, sarebbe all’origine secondo Baudelaire del diffuso fascino per la recente invenzione della fotografia , un fascino costituito dalla sorpresa di fronte a un’immagine che si presenta come replica esatta e impassibile del vero. Nel successo della fotografia Baudelaire denuncia una forma di fanatismo e di attaccamento idolatrino al “vero” naturale dietro cui si nasconderebbe un “amore dell’osceno” e un irrimediabile “impoverimento del genio artistico”. La fotografia non deve proporsi come forma artistica alternativa, se non addirittura “superiore” , alla pittura, bensì come tecnica finalizzata alla documentazione e alla conservazione. Esaltare i poteri dell’immaginazione4 significa, secondo Baudelaire, difendere le prerogative della pittura di fronte alle insidie di un’arte, la fotografia, che curiosamente sembrerebbe proprio avere a che fare con quella ricerca dell’immutabile nell’istante in cui risiede l’essenza della bellezza,
In questa condanna dell’”amore osceno” che si nasconde dietro il successo della fotografia, la posizione di Baudelaire potrebbe sembrare senza dubbio contraddittoria, trattandosi di un autore che ha fatto della contraddizione, della paradossalità , della fusione di alto e basso, sublime e grottesco, il tratto distintivo della propria poetica. In Baudelaire prosegue infatti quella deriva anticlassicistica – annunciata dalle riflessioni romantiche sul “caratteristico” e l’”interessante” e testimoniata dal tentativo delle estetiche posthegeliane di fare i conti con il tema del brutto, per esempio nell’Estetica del brutto (1853) di Karl Rosenkranz (1805-1879) – che ha il suo massimo esponente in Victor Hugo nella sua tematizzazione del grottesco. Se in Rosenkranz la trattazione del brutto era ancora subordinata al primato della bellezza e dell’armonia, tanto che il disarmonico e il negativo erano considerati momenti destinati a essere superati e ricomposti nella potenza conciliante del bello, in Hugo il brutto e il grottesco si presentano come una dimensione esuberante e irriducibile: “Il bello non ha che un tipo: il brutto ne ha mille”. L’arte non si limita più ad accogliere nel proprio ambito la bellezza, bensì si apre alle innumerevoli forme della sua decadenza e della sua perversione, rivolgendosi ai nuovi territori della deformazione e dell’informe, della contraddizione e della disarmonia. Tutto l’accostamento di temi e stili “sublimi” con improvvise cadute nella depravazione e nel grottesco, in una tensione polare costantemente irrisolta.
Nei saggi de Il pittore della vita moderna, la ricerca della dimensione sublime ed eterna in ciò che è “basso” e ordinario assume però una veste inaspettata, e si concretizza nella celebre rivalutazione della moda e del trucco.
Riscattata dalla sua condanna ad opera della morale dominante, che vi vede l’ambigua esaltazione dell’artificio contro il legittimo primato della naturalità, la moda si presenta come emblema della modernità proprio in quanto congiunzione dell’eterno e dell’effimero. Obbedendo al continuo imperativo della novità , essa mostra la capacità del presente di assumere valore simbolico, facendosi rappresentazione e quindi proponendosi come eterno: la donna truccata perde infatti ogni “piatta” naturalezza e svela il suo volto quasi totemico, per farsi adorare come un idolo : “ essere terribile e incomunicabile al pari di Dio ( con la sola differenza che l’infinito non si comunica in quanto accecherebbe e schiaccerebbe il finito, mentre l’essere di cui si parla è forse incomprensibile solo perché non ha niente da comunicare), (la donna) è piuttosto una divinità, un astro (…) una luce, uno sguardo, un invito alla felicità , e talvolta il suono di una parola; ma soprattutto è un’armonia generale , non solo nel gesto e nel movimento delle membra, ma anche nelle mussole, nei veli, negli ampi e cangianti nembi di stoffe in cui si avvolge, che sono come gli attributi e il fondamento della sua divinità”. La moda, in altre parole, è “uno dei segni della nobiltà primitiva dell’anima umana”, “un sintomo del gusto dell’ideale”, un modo con cui la donna si eleva a una dimensione magica e soprannaturale, si pone come idolo e statua di fronte a uno sguardo adorante: “Il rosso e il nero rappresentano la vita, vita soprannaturale e smisurata; il bordo nero fa lo sguardo più profondo e singolare, dono all’occhio un’apparenza più risoluta di finestra aperta sull’infinito; il rosso che infiamma i pomelli, accresce vieppiù la luminosità della pupilla e insinua in un bel volto femminile la misteriosa passione della sacerdotessa”.
BENEDETTO CROCE

Arte, intuizione, espressione
La storia artistica e letteraria è, perciò, un’opera d’arte storica, sorta sopra una o più opere d’arte.
A cura di Claudia Bianco
Nella primavera del 1900 Benedetto Croce (1866-1952) legge nell’Accademia Pontaniana di Napoli le Tesi fondamentali di un’estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale. Accompagnate da un’ampia parte storica e profondamente rimaneggiate, le Tesi diventeranno due anni dopo l’Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale. Teoria e Storia (1902) , a cui faranno seguito il Breviario di Estetica (1912) , l’Aesthetica in nuce (1928) e diversi scritti di critica e storia letteraria, tra cui i saggi sulla letteratura italiana dall’Unità ai primi del secolo raccolti nei quattro volumi della Letteratura della Nuova Italia (1914-15) , e testi come La riforma della storia artistica e letteraria (1917) , Poesia e non poesia (1923), i Nuovi saggi sulla letteratura italiana del Seicento (1931), Poesia popolare e poesia d’arte (1933), La Poesia (1936). Nell’arco di questa produzione teorica che si misura di volta in volta con i principi fondanti dell’estetica o con l’analisi di singole opere, Croce viene articolando la propria tesi fondamentale, che concepisce l’arte come intuizione ed espressione ,e, come abbiamo visto (vedere Vico) , si richiama alla figura di Giambattista Vico, che per primo avrebbe avuto il merito di proporre una “Logica poetica”, distinta da quella intellettuale, capace di considerare la poesia una forma di conoscenza autonoma rispetto alla filosofia e avente come principio la fantasia.
La genesi della riflessione crociata sull’estetica risale alla memoria del 1893 intitolata La storia ridotta sotto il concetto generale dell’arte. In questo testo arte e storia sono definite entrambe “rappresentazione della realtà”, salvo poi differenziarsi in conoscenza di ciò che è meramente possibile (l’arte) e di ciò che è veramente accaduto (la storia). La concezione dell’arte come forma specifica e autonoma di conoscenza e l’intenzione di riconnettere i fatti estetici e artistici alla totalità della vita dello spirito ritornano nelle Tesi e nell’Estetica del 1902 , dove l’arte è identificata con la conoscenza intuitiva , distinta da quella concettuale o logica: “La conoscenza ha due forme: è o conoscenza intuitiva o conoscenza logica; conoscenza per la fantasia o conoscenza per l’intelletto; conoscenza dell’individuale o conoscenza dell’universale; delle cose singole ovvero delle loro relazioni; è insomma, o produttrice di immagini o produttrice di concetti”. Il dominio dell’arte è dunque quello dell’intuizione dell’individuale e dell’immagine fantastica, un dominio profondamente diverso da quello della logica o della scienza, che procedono per elaborazione di concetti, costruzione di classi, astrazioni, ordinamento di fatti. Conoscenza intuitiva e conoscenza concettuale, studiate rispettivamente dall’Estetica e dalla Logica, si oppongono quindi come momenti distinti, anche se in parte complementari, della sfera teoretica. Analogamente, nell’ambito pratico Croce distingue tra un primo grado (l’attività meramente utile o economica, e un secondo grado (quello dell’attività morale), finendo così per delineare l’impianto generale della Filosofia dello Spirito, sviluppato in seguito, oltre che nell’Estetica , nei Lineamenti di Logica (1905) , nella Logica (1909) e nella Filosofia della Pratica.Economia ed etica (1908).
Affermando la tesi secondo cui l’arte è conoscenza intuitiva, Croce si riallaccia al senso originario del termine estetica come autonoma “scienza della sensibilità” introdotto a metà del Settecento da Baumgarten e, contemporaneamente, si ricollega alla concezione kantiana dell’Estetica trascendentale esposta nella Critica della ragion pura. Come in Kant, così anche in Croce l’estetica si differenzia dalla logica, e l’intuizione dal concetto; se però nella Critica della ragion pura intuizioni e concetti si integrano a vicenda per dar luogo alla sintesi conoscitiva, nell’elaborazione crociata la sfera estetica rimane autonoma rispetto alla logica: vi sono infatti intuizioni “pure” a cui non si mescolano concetti o volizioni, mentre non si può dire il contrario, in quanto non c’è pensiero logico o azione morale che possa prescindere da intuizioni e sentimenti. In quest’ottica, essendo l’intuizione un grado necessario e imprescindibile della vita dello spirito, non ha alcun senso parlare di morte o eliminazione dell’arte: “domandare se l’arte sia eliminabile sarebbe né più né meno come domandare se siano eliminabili la sensazione o l’intelligenza”.
Ma cosa significa, per Croce, intuizione? L’intuizione è apprensione immediata di un contenuto sensibile, opposta all’elaborazione immediata di un contenuto sensibile, opposta all’elaborazione discorsiva prodotta dall’intelletto. E’ presenza di un contenuto ai nostri sensi (un’immagine, un colore, un suono) prima dell’intervento di qualsiasi organizzazione concettuale. L’intuizione si differenzia però sia dalla percezione , in quanto non distingue tra la realtà e l’irrealtà dei propri contenuti, sia dalla sensazione, ossia dalla semplice affezione passiva e meccanica procurataci da qualcosa di esterno. L’intuizione “pura” – ossia scevra di ogni elemento concettuale – plasma e dà forma alle sensazioni, le fissa in immagini senza pronunciarsi sulla loro verità o falsità, le esprime.
Momento fondamentale dell’attività dello spirito, l’intuizione è dunque espressione, forma e sintesi: “Ogni vera intuizione o rappresentazione è, insieme, espressione. Ciò che non si oggettiva in una espressione non è intuizione o rappresentazione, ma sensazione e naturalità. Lo spirito non intuisce se non facendo, formando, esprimendo. Chi separa intuizione da espressione, non riesce mai più a congiungerle”. Come scrive Croce, “ l’atto estetico è forma, e nient’altro che forma”, e proprio nella sua capacità di dar forma al sentimento risiede la funzione catartica dell’arte : “Elaborando le impressioni, l’uomo si libera da esse. Oggettivandole, le distacca da sé e si fa loro superiore. La funzione liberatrice e purificatrice dell’arte è un altro aspetto e un’altra formula del suo carattere di attività. L’attività è liberatrice appunto perché scaccia la passività”. Dalla tesi dell’identità di intuizione ed espressione discende quindi la tesi dell’identità di Estetica e Linguistica generale, contenuta nei titoli delle Tesi e dell’Estetica del 1902: ogni forma espressiva è linguaggio, anche le espressioni figurative o la musica, e il linguaggio è essenzialmente libera creazione . Le categorie grammaticali, le leggi fonetiche, le stesse lingue storico-naturali studiate dalla linguistica, secondo Croce, sono soltanto costruzioni secondarie, che si elevano sul tessuto liberamente creativo dell’attività espressiva di un linguaggio concepito come attività, dinamicità, “creazione spirituale”.
L’arte è dunque essenzialmente intuizione ed espressione. Essa differisce profondamente dalla filosofia, in quanto “filosofia è pensamento logico delle categorie universali dell’essere, e l’arte è intuizione irriflessa dell’essere; e perciò , laddove la prima oltrepassa e risolve l’immagine, l’arte vive nella cerchia di questa come in un suo regno”. Dalla tesi che afferma il carattere intuitivo- espressivo dell’arte e il suo essere parte integrante della vita spirituale, deriva poi una serie di importanti conseguenze per quanto riguarda lo statuto dell’artista, dell’opera d’arte e del bello naturale. Innanzitutto Croce afferma che l’arte differisce quantitativamente, e non qualitativamente, dalle comuni intuizioni. Tutte le intuizioni, potenzialmente, sono arte, e la differenza tra le intuizioni dell’uomo comune e quelle del genio artistico non è di natura, genere, qualità, ma di grado, quantità, estensione. Compito dell’Estetica deve essere, secondo Croce, ricondurre l’arte al complesso della vita spirituale e dell’attività teoretica, rimettendo in discussione ogni gerarchia precostituita e ogni canone tradizionale: “Un epigramma appartiene all’arte: perché no una semplice parola? Una novella appartiene all’arte: perché no una nota cronaca giornalistica? Un paesaggio appartiene all’arte: perché no uno schizzo topografico?”. A questa provocatoria apertura nei confronti delle più diverse forme di espressione, corrisponde però in Croce la tesi della non artisticità della dimensione tecnica e materiale del fare artistico, ossia di ogni processo di fissazione materiale, fisica, delle espressioni. Una volta raggiunta l’espressione adeguata a una data intuizione, l’iscrizione mediante segni o la fissazione su di un supporto non è altro che un’attività estrinseca, che può avere sicuramente chiari fini pratici – legati alla comunicazione, alla conservazione, alla diffusione sociale dell’arte- ma è priva di valore estetico. Le opere d’arte, per Croce, sono sostanzialmente immagini interiori , esistono solo “ nelle anime che le creano o le ricreano”. Alla tecnica artistica e alla componente materiale dell’opera viene così negato ogni senso artistico, in quanto si tratta di qualcosa di estrinseco, di derivato: “Il fatto estetico si esaurisce tutto nell’elaborazione espressiva delle impressioni. Quando abbiamo conquistato la parola interna, concepita netta e viva una figura o una statua, trovato un motivo musicale, l’espressione è nata ed è completa : non ha bisogno d’altro (…) l’opera d’arte (l’opera estetica) è sempre interna; e quella che si chiama esterna non è più opera d’arte”.
Alla svalutazione della tecnica artistica fa seguito una netta svalutazione di tutta una serie di temi tradizionali dell’estetica, come la distinzione tra generi letterari e tra stili, o la riflessione sul bello naturale. Lo studio dei generi letterari, delle figure retoriche, di categorie estetiche quali sublime, tragico, comico ecc.., è condannato da Croce in quanto estrinseco rispetto all’unicità del principio secondo cui l’arte è intuizione. L’estetica crociata riconduce all’unità e all’universalità di questo principio la varietà irriducibile delle forme espressive, che devono essere colte nella loro individualità, prescindere da rigide classificazioni che hanno una validità puramente pratica e empirica. Concetti come tragico, sublime., romanzo, novella, servono semplicemente a ordinare e catalogare le opere letterarie, e diventano fonte d’errore se trasformati in strumenti per la critica e il giudizio estetico. Di fronte all’arte bisogna chiedersi unicamente se essa sia espressiva e che cosa esprima, e nona quale genere appartenga. Il bello naturale, invece, per Croce, è privo di quei caratteri di attività e spiritualità che costituiscono l’essenza dell’atto intuitivo ed espressivo dell’arte, che nella sua purezza si distingue tanto dalle sensazioni da cui prende le mosse quanto dai sentimenti di piacere che è capace di suscitare, Non ha dunque senso parlare di bellezza naturale, in quanto la bellezza non è altro che “l’adeguatezza dell’espressione”. Tutto ciò che è espresso adeguatamente è bello, mentre è brutto ciò che è antiestetico o inespressivo, e che perciò si pone di fatto al di fuori dei confini dell’arte.
Al principio dell’intuizione Croce riconduce sia il momento della creazione artistica sia quello della ricezione, del giudizio, del gusto. Come leggiamo nell’Estetica , “l’attività giudicatrice, che critica e riconosce il bello, s’identifica con quella che lo produce. La differenza consiste soltanto nella diversità delle circostanze, perché una volta si tratta di produzione e l’altra di riproduzione estetica., L’attività che giudica si dice gusto; l’attività produttrice, genio: genio e gusto sono, dunque, sostanzialmente identici”. Il giudizio di gusto nasce dunque da un atto con cui l’intuizione estetica in cui consiste l’opera d’arte viene ri-prodotta. Su questa possibilità di rivivere la genesi di un’intuizione si fondano, secondo Croce, non soltanto la fruizione dell’arte e l’attività del critico, ma la stessa continuità della nostra vita di coscienza , in cui ci rapportiamo costantemente al nostro passato rivivendolo, e la possibilità di una vita sociale fatta di “comunione coi nostri simili” e di “comunicazione con gli altri uomini, del presente e del passato”. Per diventare storici della letteratura e dell’arte, però, non è sufficje3nte saper riprodurre le intuizioni contenute nelle opere, ma bisogna che a questa riproduzione faccia seguito la capacità di giungere a nuove intuizioni ed espressioni con cui un’opera viene rappresentata storicamente. Di qui l’alto compito assegnato da Croce alla critica e alla storia dell’arte e della letteratura: “la storia artistica e letteraria è, perciò, un’opera d’arte storica, sorta sopra una o più opere d’arte”.
MARTIN HEIDEGGER

Opera d’arte e verità dell’essere
Ciò che è in opera nell’opera è l’apertura dell’ente nel suo essere, il farsi evento della verità.
A cura di Claudia Bianco
Per comprendere la riflessione sull’arte condotta da Martin Heidegger (1889-1976) nel saggio L’origine dell’opera d’arte (Der Ursprung des Kunstwerkes, 1935) , è necessario collocare questo testo nel quadro del percorso speculativo intrapreso dall’autore negli anni successivi alla pubblicazione di Essere e tempo (1927) , quando emerge la necessità di abbandonare il progetto di un’analitica dell’esistenza in favore dell’elaborazione di un nuovo pensiero dell’essere, che prenda le mosse da una comprensione del senso e della storia della metafisica. Già in Essere e tempo Heidegger aveva mostrato come il pensiero filosofico elaborato dalla tradizione europea fosse caratterizzato sostanzialmente da una comprensione dell’essere come semplice-presenza (Vorhandenheit) e obiettività . Secondo questa tradizione- che nelle sue linee essenziali sarebbe rimasta invariata da Parmenide a Nietzsche- è, in senso pieno, ciò che sussiste, è incontrabile, si dà nella sua presenza e visibilità. L’essere , in altre parole, sarebbe stato pensato come analogo all’ente , alla cosa (res), rimuovendo e dimenticando la fondamentale differenza ontologica che li separa. In correlazione con questa concezione dell’essere come ente e come oggetto posto di fronte alla coscienza (ob-jectum), il pensiero metafisico moderno avrebbe poi prodotto la concezione di un soggetto concepito non più quale semplice substrato (hypokeimenon,sub-stantia,sub-jectum) portatore di qualità e accidenti, bensì quale io conoscente (ego cogitans) , soggetto puro, trascendentale, puro occhio sul mondo, fondamento della verità in quanto luogo del suo manifestarsi come presenza evidente. La correlazione conoscitiva tra soggetto e oggetto avrebbe quindi dato luogo a una concezione della verità come conformità o adeguazione tra linguaggio, pensiero ed ente, adaequatio rei et intellectus.
Se il filo conduttore dell’analitica esistenziale sviluppata in Essere e tempo era stato il tentativo di ritematizzare il rapporto tra essere e temporalità e di chiarire la dimensione concreta di quell’io pensato dalla filosofia neokantiana e dalla fenomenologia come io puro e come soggettività trascendentale, negli scritti degli anni Trenta Heidegger mette al centro della propria riflessione il problema della metafisica e della sua storia, soffermandosi sulle figure chiave di Cartesio, Leibniz e Nietzche. La tesi che sviluppa in questo periodo è quella secondo cui la metafisica, nel suo insieme e nella pluralità di forme che ha assunto storicamente, sarebbe caratterizzata da un oblio dell’essere , ossia dalla tacita precomprensione dell’essere come nozione ovvia, che non ha bisogno di ulteriori spiegazioni. Tale oblio della differenza ontologica tra essere ed ente avrebbe trovato poi un pieno dispiegamento nell’avvento di un mondo caratterizzato dal primato della tecnica , dove l’essere dell’ente non è più neanche remotamente qualcosa che occorre cercare oltre l’ente stesso, bensì il suo effettivo funzionamento all’interno di un sistema strumentale subordinato alla volontà del soggetto. Nel mondo della tecnica il pensiero diviene esso stesso strumento per la soluzione di problemi interni alla totalità strumentale degli enti, ed è finalizzato al raggiungimento di una razionalità sempre più perfetta ed efficiente.
Collocato sullo sfondo di questa riflessione sul senso della metafisica, il saggio L’origine dell’opera d’arte viene a occupare una posizione centrale nello sviluppo del pensiero heideggeriano, in quanto scritto in un periodo nel quale alla riflessione sulla storia e sul senso della metafisica si affianca il tentativo di sviluppare un nuovo pensiero sull’essere e sulla verità, a partire dalla rielaborazione di alcuni tempi centrale di Essere e tempo . Come è noto, la stesura di questo testo era stata interrotta da Heidegger essendo emersa la necessità di operare un radicale ripensamento del linguaggio filosofico. Superare la metafisica, infatti, non poteva significare semplicemente parlare di ciò che la metafisica ha sempre taciuto, ossia dell’essere, per darne una nuova “definizione” o elaborarne un nuovo “concetto”, più “adeguato”, più “vero” . L’elaborazione di un pensiero dell’essere alternativo a quello della metafisica, secondo Heidegger, doveva innanzitutto rifiutarne la terminologia e ripensarne radicalmente i concetti fondanti, a partire da quelli di cosa, ente e verità. E proprio a un tentativo di riformulazione del problema della verità è dedicato il saggio sull’opera d’arte, in cui si annunciano inoltre alcuni temi che saranno al centro della successiva riflessione heideggeriana: la concezione dell’essere come evento e il ruolo ontologico del linguaggio, argomento sviluppato in seguito da Heidegger in quel “dialogo storico-ontologico con i poeti” che prende avvio proprio nel saggio del 1935 e nel testo della conferenza intitolata Hoelderlin e l’essenza della poesia, del 1936.
In apertura del saggio Heidegger chiarisce che riflettere sull’origine dell’opera d’arte significa riflettere sulla sua essenza: “Origine significa,qui,ciò da cui e per cui una cosa è ciò che è ed è come è. Ciò che qualcosa è essendo così com’è, lo chiamiamo la sua essenza, L’origine di qualcosa è la provenienza della sua essenza. Il problema dell’origine dell’opera d’arte concerne la provenienza della sua essenza”. Intraprendere la ricerca dell’essenza dell’opera d’arte secondo le opinioni comunemente accettate,tuttavia, ci conduce subito in quello che appare un circolo vizioso da cui non si può uscire: l’opera d’arte sembra essere take in virtù dell’attività dell’artista che la crea e del nostro concetto di arte, mentre a loro volta l’arte e l’attività artistica sembrano poter essere definite solo a partire dalle opere d’arte. Tale circolo non deve però essere rimosso:”dobbiamo muoverci nel circolo”, sostare nella contraddizione da esso evidenziata, nella co-appartenenza di arte e opera. Per tentare di pervenire a comprendere l’essenza dell’arte Heidegger decide allora di partire dal concetto comune di cosa : le opere d’arte, nella loro materialità e maneggiabilità, sembrano infatti appartenere al dominio delle cose, benché non come “mere cose”, ma come cose a cui inerisce qualcosa d’altro . Ma cos’è una cosa? Per giungere a una comprensione dell’esser-cosa dell’opera , Heidegger ripercorre le dottrine tradizionali intorno all’ente o alla cosa, mostrandone l’insufficienza: l’opera non può essere compresa nella sua essenza né rifacendosi ai concetti di cosa come sostrato o sostanza (hypokeimenon,sub-stantia), né come sintesi di una molteplicità di percezioni sensibili (aistheton) o come unione di materia (hyle) e forma (morphe). In particolare, rinunciare alla coppia concettuale materia-forma significa, e Heidegger lo sottolinea, rinunciare allo “schema concettuale classico di ogni teoria dell’arte e di ogni estetica”, uno schema che ha costituito l’asse portante della riflessione sull’arte da Platone a Hegel e oltre, e in base al quale sono stati elaborati concetti chiave dell’estetica come quelli di creazione e imitazione.
Una volta chiarita l’insufficienza delle concezioni della cosa che emergono da un’analisi della tradizione filosofica, Heidegger, nell’intento di comprendere l’essenza dell’opera a partire proprio dalla sua cosalità, si rivolge al concetto di cosa come strumento, da lui stesso elaborato in Essere e tempo. Già nell’analitica esistenziale di Essere e tempo aveva infatti sviluppato una netta critica del concetto di cosa come res inerte e come semplice-presenza , proponendo una concezione della cosa come strumento caratterizzato dall’utilizzabilità (Zuhandenheit) e dal rimandare ad altro: lo strumento è sempre strumento-per-qualcosa- e si rapporta a una concezione dell’esistenza dell’uomo come essere-nel-mondo caratterizzato dall’apertura verso il poter-essere e dalla progettualità. Nel saggio L’origine dell’opera d’arte Heidegger riprende la concezione dell’opera come strumento-per, come mezzo, ma con una sostanziale differenza rispetto a Essere e tempo: il chiarimento dell’esser-mezzo del mezzo viene sviluppato non a partire dall’attività progettante dell’uomo, bensì attraverso l’analisi di un’opera d’arte, di una rappresentazione figurativa, un quadro di Van Gogh che raffigura un paio di scarpe da contadino. E’ qui che viene in luce qualcosa che la descrizione di un paio di scarpe effettivamente presenti non avrebbe potuto attingere: l’esser-mezzo del mezzo, la sua essenza, risiede in qualcosa di più profondo della semplice “utilizzabilità” di cui parlava Essere e tempo , risiede nella sua “fidatezza” (Verlassigkeit) ; “In virtù sua la contadina confida, attraverso il mezzo, nel tacito richiamo della terra; in virtù della fidatezza del mezzo essa è certa del suo mondo. Mondo e terra ci sono per lei, e per tutti coloro che sono con lei nel medesimo mondo (…) la fidatezza del mezzo dà al mondo immediato la sua stabilità e garantisce alla terra, la libertà del suo afflusso costante. L’esser-mezzo del mezzo, la fidatezza, tiene unite tutte le cose secondo il loro modo e la loro ampiezza. L’usabilità del mezzo non è che la conseguenza essenziale della fidatezza”.
La vera natura della cosa come mezzo è stata dunque stabilita non attraverso l’analisi di un ente concretamente esistente, ma ponendosi di fronte a un’opera d’arte, a un quadro, e quindi a un’immagine. Ed è proprio in relazione a questa capacità dell’opera di rivelare la verità del mezzo che Heidegger presenta la tesi centrale del saggio “Ciò che abbiamo potuto stabili è l’esser-mezzo del mezzo. Ma come? Non mediante la descrizione e l’analisi di un paio di scarpe qui presenti. Non mediante l’osservazione dei procedimenti di fabbricazione delle scarpe, e neppure mediante l’osservazione di qualche uso di calzature. Ma semplicemente ponendoci innanzi a un quadro di Van Gogh. E’ il quadro che ha parlato. Stando nella vicinanza dell’opera ci siamo trovati improvvisamente in una dimensione diversa da quella in cui comunemente siamo. L’opera dell’arte ci ha fatto conoscere che cosa le scarpe sono in verità (…) è solo nell’opera e attraverso di essa che viene alla luce l’esser mezzo del mezzo. Che significa ciò? Che cos’è in opera nell’opera? Il quadro di Van Gogh è l’aprimento di ciò che il mezzo , il paio di scarpe, è (ist) in verità. Questo ente si presenta nel non –nascondimento (Unverborgenheit) del suo essere, il non-esser-nascosto dell’ente è ciò che i Greci chiamavano aletheia. Noi diciamo:’verità? , e non riflettiamo sufficientemente su questa parola . Se ciò che si realizza è l’aprimento dell’ente in ciò che esso è e nel come è, nell’opera è in opera l’evento (Geschehen) della verità . Nell’opera d’arte la verità dell’ente si è posta in opera. ‘Porre’ significa qui: portare a stare. In virtù dell’opera, un ente, un paio di scarpe, viene a stare nella luce del suo essere. L’essere dell’ente giunge alla stabilità del suo apparire. L’essenza dell’arte consisterebbe quindi nel porsi in opera della verità dell’ente (das Sich-ins-Werk-Setzen der Wahrheit des Seieden)”.
L’arte ha dunque essenzialmente a che fare con la verità, e la riflessione sull’arte non può non assumere i tratti di una speculazione ontologica che conduce a una riformulazione del problema dell’essere dell’ente. Dire che l’arte consiste nel porsi in opera della verità, tuttavia, non significa affatto riproporre una concezione dell’arte come imitazione o riproduzione della realtà, in base alla tesi secondo cui la verità è adeguazione tra pensiero e ente, concetto e cosa, segno e designato, copia e modello. Il quadro di Van Gogh non ci ha rilevato l’essenza del mezzo imitando un paio di scarpe concretamente esistente, non si è posto come copia o ri-presentazione di un modello esterno e precedentemente esistente. Come chiarisce Gadamer in Verità e metodo parlando di “valenza ontologica dell’immagine”, nel testo heideggeriano viene in luce il fatto che l’immagine come opera d’arte non deve essere intesa come immagine-copia (Abbild) subordinata a un modello, ma come immagine (Bild) capace di manifestare la presenza del rappresentato e di porlo come originale (Ur-bild) . E’ infatti nell’inseparabilità ontologica tra immagine e rappresentato che quest’ultimo accede alla propria verità. Come scrive Heidegger, “ciò che è in opera nell’opera è l’apertura (Eroffnung) dell’ente nel suo essere, il farsi evento della verità (das Geschehnis der Wahrheit)”.
A partire da tali asserzioni appare sempre più chiaramente che proprio sul concetto di verità come non-nascondimento (Unverborgenheit) – termine con cui Heidegger riprende il senso del greco aletheia , “verità” (composta da a-privativo e letho o lanthano , “restare nascosto) – verte la riflessione del filosofo tedesco sull’opera d’arte. Questa deve essere sottratta alla sua precomprensione all’interno dell’estetica, della critica e della storia dell’arte al fine di enucleare il farsi evento della verità che in essa ha luogo, mostrando al tempo stesso come la verità sia intrinsecamente attraversata da una dinamica di svelamento e nascondimento.
A questo proposito Heidegger ricorre alla “descrizione” di un’altra opera, un tempio greco. Questo, delimitando una regione sacrale e racchiudendo al suo interno la statua del Dio, “dispone e raccoglie intorno a sé l’unità di quelle vie e di quei rapporti in cui nascita e morte, infelicità e fortuna, vittoria e sconfitta, sopravvivenza e ridona delineano la forma e il corso dell’essere umano nel suo destino. L’ampiezza dell’apertura di questi rapporti è il mondo di questo popolo storico”. Come scrive Heidegger , il tempio, “in quanto opera, espone un Mondo (…) mantiene aperta l’apertura del Mondo”. Al tempo stesso ,però, il tempio, come ogni opera, riconduce questo stesso Mondo alla Terra da cui esso proviene, una Terra concepita come fondamento generatore e al tempo stesso come chiusura e negazione: “La Terra è ciò in cui il sorgere riconduce, come tale, tutto ciò che sorge come nel proprio nascondimento protettivo. In ciò che sorge è presente la Terra come la nascondente-proteggente (als das Bergende)”. Essere un’opera significa,dunque, “esporre (auf-stellen) un Mondo”, aprire e rivelare un insieme di relazioni istituenti la vita e la storia di una comunità , e al tempo stesso “porre-qui (hier-stellen) la Terra”, ossia lasciar emergere ciò che fonda ritraendosi e chiudendosi in sé: Se però “esporre un Mondo e porre qui la Terra sono due tratti essenziali dell’esser opera dell’opera” e se nell’opera accade il porsi in opera della verità, è evidente che i due termini correlativi di Mondo e Terra hanno un significato che deve essere chiarito in relazione sia all’essenza dell’opera che a quella della verità.
In base al riferimento alla coppia Mondo-Terra, la verità non deve essere pensata né come evidenza né come adeguazione, bensì come “il non-esser-nascosto dell’ente (die Unverborgenheit des Seiendes), riprendendo il termine greco aletheia , ma non nel senso di semplice “svelamento” bensì come dinamica di nascondimento e non-nascondimento, illuminazione (Lichtung) che si staglia sempre sullo sfondo di un orizzonte di oscurità: “L’ente può essere come ente solo se si immerge e emerge dal seno dell’illuminato di questa illuminazione. (…)Grazie a questa luce, l’ente è non-nascosto in una misura particolare e mutevole. Lo stesso esser-nascosto dell’ente è possibile solo nel dominio di questo illuminato. Ogni ente che incontriamo e4 che ci accompagna sottostà a questa singolare natura oppositoria dell’esser-presente, poiché nel contempo si ritira nel nascondimento. L’illuminazione in cui l’ente si mantiene è parimenti un nascondimento (Verbergung ) (…) Il luogo aperto nel mezzo dell’ente, l’illuminazione, non è mai uno scenario immobile, a sipario costantemente sollevato, in cui si svolge la rappresentazione dell’ente. L’illuminazione ha invece luogo soltanto nell’ambito di questo duplice nascondimento”.
Riprendendo un tema già affrontato nel saggio L’essenza della verità, del 1930 Heidegger sostiene dunque che occorre pensare la verità come apertura e svelamento e, al tempo stesso, come oscurità e nascondimento, ossia come “non –verità” : “L’essenza della verità, cioè il non-esser-nascosto, è pervasa da un diniego. Questo diniego non è affatto una mancanza o un difetto, come se la verità fosse un semplice non-nascondimento liberatosi da ogni impaccio. Se ciò fosse possibile, il non-esser-nascosto non sarebbe più se stesso. E’ all’essenza stessa della verità come non-esser-nascosto che questo diniego appartiene nella forma del duplice nascondimento. La verità, nella sua essenza stessa, è non-verità”.
Se da un lato la coppia Mondo-Terra può essere intesa come modo per contestare la concezione metafisica della verità come presenza ed evidenza, mostrando la costitutiva compresenza di svelamento e nascondimento, dall’altro la dinamica tra questi due termini- dinamica descritta da Heidegger anche come “contrapposizione4” e “lotta originaria” – mostra che ogni opera, nel momento stessi in cui apre un mondo, offrendo una totalità comprensibile di significati e una nuova prospettiva sull’ente, mantiene in sé una riserva di significato mai definitivamente esplicitabile. L’opera è, costitutivamente, un darsi e un ritrarsi, e il porsi in opera della verità che in essa accade deve essere inteso come un’instaurazione (Stiftung) che è al tempo stesso “fondazione” e “donazione” , dono libero e immotivato ma proveniente da un orizzonte che rimane costitutivamente non esplicitato. A questa dinamica dell’apparire e del nascondimento Heidegger riconduce poi la stessa nozione di bellezza: “Ponendosi in opera, la verità appare. L’apparire, in quanto apparire di questo essere-in-opera e in quanto opera, è la bellezza. Il bello rientra pertanto nel farsi evento nella verità”.
Nell’ultima sezione del saggio, intitolata “Verità e arte”, ai temi fin qui esaminati se ne aggiunge un altro: il ruolo del linguaggio nel porsi in opera della verità. Già in Essere e tempo il linguaggio occupava una posizione peculiare, in quanto, come segno e come rimando, rendeva manifesta la stessa struttura ontologica dell’essere-nel-mondo dell’uomo. Ora esso si presenta come il modo stesso di aprirsi della verità dell’ente. Come scrive Heidegger,”La verità, come illuminazione e nascondimento dell’ente, si storicizza se viene poetata (gedichtet). Ogni arte, in quanto lascia che si storicizzi l’avvento della verità dell’ente come tale, è nella sua essenza Poesia (Dichtung) , ossia creazione e istituzione del nuovo, apertura di un mondo: E poichè l’apertura di un mondo accade innanzitutto e fondamentalmente nel linguaggio, il linguaggio stesso, nel suo “senso essenziale” , è Dichtung : “Abitualmente il linguaggio è inteso come una specie di comunicazione . Serve alla conservazione e all’accordo , cioè, in genere, alla comprensione interumana. Ma il linguaggio non è soltanto e in primo luogo l’espressione orale e scritta di ciò che deve essere comunicato. Esso non si limita a trasmettere in parole e frasi ciò che è già rivelato o nascosto ,ma, per prima cosa, porta nell’Aperto l’ente in quanto ente. Là dove non ha luogo linguaggio di sorta, come nell’essere della pietra, della pianta e dell’animale, non ha neppur luogo alcun aprimento dell’ente e quindi nessun aprimento del non-essente e del vuoto. Il linguaggio,nominando l’ente, per la prima volta lo fa accedere alla parola e all’apparizione”. Il tema della valenza ontologica del linguaggio e della poesia come evento e come “istituzione in parola dell’essere”, “nominare che istituisce l’essere e l’essenza di tutte le cose”, annunciato nell’ultima parte del saggio sull’opera d’arte, diventerà sempre più centrale nella riflessione heideggeriana successiva, a cominciare dal testo della conferenza su Hoelderlin e l’essenza della poesia, per proseguire con i saggi raccolti nel volume In cammino verso il linguaggio (1959).
MAURICE MERLEAU-PONTY
Pittura e ontologia della visione
Guarda ogni cosa, ma può anche guardarsi, e riconoscere in ciò che allora vede ‘l’altra faccia’ della sua potenza visiva. Si vede vedente, si tocca toccante , è visibile e sensibile per se stesso.
A cura di Claudia Bianco
Nel saggio Il filosofo e la sua ombra , Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) affronta il problema del suo debito nei confronti del pensiero husserliano, e scrive: “La tradizione è oblio delle origini, diceva l’ultimo Husserl. Ed effettivamente, se dobbiamo molto allo stesso Husserl, non siamo in grado di vedere esattamente ciò che gli appartiene”. L’intero percorso filosofico di Merleau-Ponty è caratterizzato da un continuo confronto con alcuni grandi temi della fenomenologia husserliana- lo statuto della percezione, della visione, del corpo proprio, dell’esperienza preriflessiva-, ripresi nell’interrogazione della pittura attraverso il confronto con l’opera di Paul Cézanne (1839-1906) che anima l’ultimo saggio da lui pubblicato, L’occhio e lo spirito (L’Oeil et l’Esprit, 1960) . Questo testo si colloca al termine di un percorso di pensiero iniziato con La struttura del comportamento (1942) e proseguito con la pubblicazione della Fenomenologia della percezione (1945) e delle raccolte di saggi Senso e non senso (1948) e Segni (1960) , e si pone in stretta relazione con le note di lavoro degli ultimi anni, pubblicate postume nel 1964 da Claude Lefort nel volume intitolato Il visibile e l’invisibile (1964). Nel tentativo di chiarire il modo in cui la riflessione di Merleau-Ponty sulla visione e la pittura si inserisce nel quadro del pensiero fenomenologico, cominceremo con l’esporre sinteticamente le osservazioni di Edmund Husserl (1859-1938) sul rapporto tra estetica e fenomenologia e sullo statuto dell’immagine.
Sebbene il progetto fenomenologico husserliano si sia progressivamente definito come edificazione di una scienza dei fondamenti capace di descrivere le strutture del mondo fenomenico e gli atti soggettivi che le costituiscono, assegnando così un ruolo centrale all’analisi delle dinamiche estetiche della percezione e della sensibilità, Husserl non ha mai dedicato un’attenzione specifica al problema dell’arte. Gli unici suoi contributi in questo senso sono costituiti da un manoscritto del 1906-1907 , Aesthetik und Phaenomenologie , dove critica le interpretazioni psicologistiche e soggettivistiche dell’opera d’arte proprie di autori come Theodor Lipps (1851-1914) , e da una breve lettera al poeta Hugo von Hofmannsthal(1874-1929) , scritta nel 1907. In entrambi i testi Husserl sottolinea le analogie tra metodo fenomenologico e atteggiamento estetico, accomunati dal fatto che l’atteggiamento”naturale” e “ingenuo” nei confronti delle cose e il nostro coinvolgimento irriflesso- di volta in volta conoscitivo, emotivo o pragmatico – nei confronti del modo vengono sospesi, messi tra parentesi. Il metodo fenomenologico presuppone la sospensione di ogni presa di posizione irriflessa nei confronti del mondo (epoche) per ricondurre le cose al loro darsi fenomenico nella sfera di una soggettività pura, trascendentale, costitutiva, intesa come puro “sguardo” (Schauen) che coglie intuitivamente e descrive strutture, somiglianze e differenze.
Ma anche l’atteggiamento puramente estetico si basa sulla sospensione di ogni assunzione di esistenza relative alle cose: “Le cose che ci stanno qui davanti sensibilmente, le cose di cui parlano i discorsi comune e scientifico, le vediamo come realtà, e su queste visioni d’esistenza (Existenzsehungen) si fondano atti del sentire e del volere: gioia che questo è ,dolore che quello non è , desiderio che ciò possa essere, e così via (prese di posizione esistenziali, cioè, dell’animo) : il contrario di quanto accade nell’atteggiamento spirituale della intuizione puramente estetica e della situazione del sentire ad essa corrispondente. Ma il contrario, anche, e con non minor ragione, di quanto accade nell’atteggiamento puramente fenomenologico, al cui interno soltanto i problemi filosofici possono venire risolti. Perché anche il metodo fenomenologico esige che venga rigorosamente messa fuori circuito ogni presa di posizione esistenziale. Soprattutto nella critica della conoscenza”. La differenza fra atteggiamento estetico dell’artista e atteggiamento fenomenologico del filosofo risiede invece nella diversa motivazione che sta dietro l’epoché : se da un lato il puro vedere del fenomenologo mira a “penetrare il senso del fenomeno del mondo e ad afferrarlo in concetti”, quello dell’artista è “un vedere per godere esteticamente”, che intende appropriarsi intuitivamente del mondo “ per raccogliere da ciò abbondanza di forme, materiali per creative formazioni estetiche”.
A partire da questi brevi ma suggestive osservazioni di Husserl, prende avvio una corrente di studi di estetica fenomenologia che si richiama proprio all’analogia tra atteggiamento estetico e atteggiamento fenomenologico, e ai due momenti chiave della riduzione degli oggetti a puri fenomeni che si danno alla coscienza nello spazio puro della soggettività trascendentale, e alla descrizione degli atti con cui questa stessa coscienza intenziona, prende di mira e costituisce i fenomeni stessi, Autori come Waldemar Conrad (1878-1915) , Moritz Geiger (1880-1937) o Roman Ingarden (1893-1970) descrivono l’evento estetico come fenomeno per eccellenza, come pura e significativa presenza di fronte a un soggetto, a cui questo si rapporta con il piacere, il sentimento, la partecipazione sensibile-emotiva, e propongono l’estetica fenomenologia come uno stile di ricerca che dovunque mira a evidenziare tratti caratterizzanti, costanti, differenze strutturali tra i fenomeni estetici presi in esame. Nel lavoro forse più noto di questa corrente, la Fenomenologia dell’opera letteraria (1931) di Ingarden, il testo letterario è affrontato come oggetto intenzionale- nel duplice senso che a esso è essenziale sia l’intenzione del creatore di fornirgli significato, sia l’intenzione del fruitore di decifrare tale significato – e descritto nella sua stratificazione, distinguendo tra strato fonico, strato dei significati delle parole e delle frasi, strato degli oggetti denotati e strato delle apparenze di tali oggetti.
Su un altro versante, il tema husserliano dell’analogia tra atteggiamento estetico e atteggiamento fenomenologico nel comune ricorso all’epoché , ossia alla sospensione delle assunzioni esistenziali nei confronti dei contenuti presi in considerazione, si rivela determinante per lo sviluppo della riflessione fenomenologia sulla natura dell’immagine. A differenza delle immagini percettive, in cui l’oggetto appare come “esso stesso presente”, “in carne e ossa” o, per così dire, “in persona”, nelle immagini della fantasia o in quelle rappresentative fissate su supporti materiali concretamente esistenti (quadri, disegni, incisioni, ecc,) l’oggetto ci appare “come se” ci fosse, “in immagine” , in quella sospensione di ogni credenza relativa alla sua esistenza o effettiva collocazione spazio-temporale che Husserl chiama “modificazione di neutralità. Nel paragrafo 111 del primo volume di Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica Husserl riassume la sua riflessione sullo statuto dell’immagine e sulla coscienza che la intenziona con una celebre analisi dell’incisione di Albrecht Durer dal titolo Il cavaliere, la morte e il diavolo. In questo testo Husserl distingue tra la percezione dell’immagine come cosa fisica , nella sua materialità di incisione su un supporto, e la coscienza d’immagine con cui le linee che costituiscono l’incisione vengono “attraversate” in direzione di ciò che è raffigurazione (cioè la coscienza delle piccole figure grigie, in cui (…) si ‘presenza in maniera raffigurativa’, in virtù della somiglianza, un’altra cosa) è un esempio di modificazione di neutralità della percezione. Questo obiectum-immagine che raffigura qualcos’altro non sta dinanzi a noi né come esistente né come non esistente né in qualunque altra modalità posizionale; o piuttosto, è dato alla coscienza come esistente, ma come esistente-per-così-dire, sottoposto alla modificazione di neutralità dell’essere”.
In quanto caratterizzata dalla sospensione delle posizioni d’essere dell’oggetto intenzionato, l’immaginazione – ossia l’attività di coscienza capace di presentificare , rendere presenti le immagini- assume un importante ruolo conoscitivo nella fenomenologia husserliana. Considerare un oggetto in immagine significa potersi distanziare dalla determinatezza del darsi percettivo dell’oggetto stesso e variarne le vedute, i profili, le prospettive. L’immagine finisce così per favorire attività cognitive specifiche che differiscono sia dalla percezione sia dall’intellezione: moltiplicando le prospettive a partire dalle quali è intenzionato l’oggetto, la coscienza riesce a superare i vincoli della percezione ( a cui spetta comunque un primato in quanto incontro in carne e ossa con il fenomeno) e ad aprirsi al più chiaro coglimento dell’essenza del fenomeno intenzionato, da un lato, e alla dimensione della possibilità e del “come se” dall’altro.
Il legame tra immaginazione, neutralizzazione e possibilità viene radicalizzato da Jean- Paul Sartre (1905-1980) in L’imaginaire (1940) , un testo che costituisce uno dei principali punti di riferimento, spesso polemico, per il pensiero di Merleau-Ponty. Sartre distingue nettamente tra percezione e immaginazione: attribuisce alla prima la capacità di connettersi con la datiti delle cose nel mondo, e alla seconda un radicale potere di nientificazione, di annullamento dei suoi contenuti. Nella coscienza immaginativa l’oggetto è posto come non-esistente , e in questo modo il soggetto perviene a divincolarsi dalla datiti del mondo esterno, sospendendolo e negandolo nella sua posizione d’esistenza e aprendosi al possibile e all’irreale. Come vedremo, nelle sue linee fondamentali, la riflessione di Merleau-Ponty si sviluppa in una direzione opposta a quella di Sartre, in quanto non considera l’immagine come il momento della nientificazione bensì come il luogo in cui si concretizza esemplarmente la relazione percettiva e corporea tra io e mondo e, nell’ultima fase della sua riflessione, come l’apertura della possibilità di un accesso alla dimensione ontologica della visione e della sensibilità.
Sebbene segnata anche da un confronto con il pensiero di Heidegger, l’opera di Merleau-Ponty non rinnega mai la propria provenienza husserliana, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento della centralità del problema della percezione e l’esigenza, propria dell’ultimo Husserl , di ricondurre l’insieme delle scienze oggettive al loro fondamento nella concretezza del mondo della vita(Lebenswelt). In La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale (pubblicata postuma nel 1954) Husserl parte dalla constatazione della sostanziale estraneità delle scienze oggettive rispetto al concreto mondo storico della vita soggettiva. Al fine di riscoprire questo fondamento comune di ogni prassi e di ogni forma di attività teoretica umana è necessario, secondo Husserl, operare “una epoche nei confronti di tutte le scienze oggettive”, ossia un’astensione “nei confronti di tutti gli interessi teoretici obiettivi, nei confronti di tutte le finalità e le azioni che assumiamo e compiamo in quanto scienziati o anche soltanto in quanto uomini avidi di sapere”. Solo in questo modo è possibile attingere il piano di quel “regno di evidenze originarie” che è il piano della Lebenswelt, “il mondo-ambiente realmente concreto, la realtà vera e propria in cui viviamo, il terreno e orizzonte già sempre datoci, esistente in anticipo, per ogni prassi, teoretica ed extrateoretica”, un mondo che esiste pur non essendo normalmente oggetto della nostra attenzione e riflessione.
Il riferimento alla tematica husserliana della Lebenswelt è fondamentale per comprendere lo sviluppo del pensiero di Merleau-Ponty e il suo approdo a un’ontologia del sensibile, Sin da La struttura del comportamento e dalla Fenomenologia della percezione, al centro della riflessione merleau-pontyana vi è infatti il tema della percezione , intesa non come puro sguardo capace di descrivere essenze e strutture fenomeniche ma piuttosto come esperienza primordiale dell’uomo, sfondo ultimo dal quale si staccano i suoi atti e il suo sapere. Soggetto della percezione non è tanto un ego trascendentale che opera la riduzione per attingere un piano di datiti fenomenica pura, quanto un corpo agente e senziente, animato da un’intenzionalità irriflessa e precategoriale. Il cardine su cui si incentra l’interpretazione della corporeità come soggetto della percezione è la distinzione husserliana tra il corpo proprio o vivo (Leib) – ossia il corpo “in carne e ossa”, vivente e vissuto in prima persona – e il corpo oggettivo (Korper) , corpo rappresentato e ridotto a cosa. La fenomenologia della percezione delineata da Merleau-Ponty mostra una percezione radicata nel corpo vivente, costantemente orientata in modo prospettico e strutturata da diverse forme di motivazione. In quest’ottica, la coscienza rappresentativa e la riflessione consono che momenti delimitati di una vista esperenziale dominata da una viva corporeità sensibile e agente. Al di sotto del cogito riflesso , ossia dell’io che si articola nel linguaggio razionale, giace un cogito tacito, silenzioso, preverbale e precategoriale, inscritto nel corpo e dotato di una capacità simbolico-espressiva che risiede nel tradursi spontaneo di un senso nell’altro e nella gestualità che accompagna il situarsi dell’io nel mondo concreto.
La prima riflessione di Merleau-Ponty sulla pittura di Cézanne, esposta nel saggio Il dubbio di Cézanne , nasce proprio sullo sfondo dei temi delineati da Fenomenologia della percezione e identifica nella pittura la forma più pregnante con cui si esplicita il linguaggio tacito del corpo vissuto. Il segreto della pittura sta nel suo riferirsi al corpo come apertura e veicolo dell’essere al mondo, e nella sua capacità di dischiudere il mondo della vita e la genesi del senso che vi ha luogo: “ Cézanne non ha creduto di dover scegliere tra sensazione e pensiero come tra caos e ordine: Non vuole separare le cose fisse che appaiono sotto il nostro sguardo e la loro labile maniera di apparire, vuole dipingere la materia che si stando una forma, l’ordine nascente attraverso un’organizzazione spontanea. Non introduce la frattura tra i ‘sensi’ e l’’intelligenza’, ma tra l’ordine spontaneo delle cose percepite e l’ordine umano delle idee e delle scienze. Noi percepiamo le cose, ci intendiamo su di esse, siamo ancorati ad esse e solo su queste fondamenta di ‘natura’ costruiamo delle scienze. Cézanne ha voluto dipingere questo mondo primordiale, ed ecco perché i suoi quadri danno l’impressione della natura alla sua origine, mentre le fotografie dei medesimi paesaggi suggeriscono i lavori degli uomini, le loro comodità e la loro presenza imminente”.
L’espressione pittorica è capacità di “ritornare, per prenderne coscienza, al fondamento d’esperienza muta e solitaria sul quale sono edificate la cultura e lo scambio delle idee”. L’arte non è imitazione , bensì è “un’operazione d’espressione” con cui “ il pittore riprende e converte appunto in oggetto visibile ciò che senza di lui resta rinchiuso nella vita separata da ogni coscienza: la vibrazione delle apparenze che è la genesi delle cose”.
In L’occhio e lo spirito l’accento cade sulla dimensione ontologica della pittura, e non più sulla pittura come espressione della soggettività corporea dell’artista e come prolungamento, seppure creativo, del gesto corporeo. Vengono in primo piano i grandi temi poi confluiti nel testo incompiuto pubblicato con il titolo Il visibile e l’invisibile : il passaggio da una fenomenologia come indagine trascendentale a un’ontologia fenomenologistica che cerca di attingere il senso dell’Essere in una sensibilità originaria, diffusa e de-soggettivata detta carne (chair) ,o, ancora, la centralità della visione in quanto capace di rivelare l’intreccio e la reversibilità tra io e mondo, soggetto e oggetto, vedente e visibile.
Il saggio si apre con una critica all’atteggiamento delle scienze moderne, che nascono da un pensiero che manipola le cose e le riduce, attraverso la costruzione di modelli, a “oggetti in generale”, anziché abitarle nella loro concretezza e opacità. Contro questa scienza che si rapporta al mondo come “pensiero di sorvolo (pensée de survol) “, Merleu-Ponty afferma l’esigenza di ricondurre il pensiero all’”Essere effettuale presente”, a quel “c’è” o “si dà (il y a) “ che è originaria coappartenenza di io e mondo mediata dal corpo. Solo l’arte, e in particolare la pittura, è ancora capace di attingere a questo “strato di senso bruto (nappe de sens brut)” , e lo fa proprio evidenziando la genesi corporea dell’immagine. Il corpo di cui parla Merleau-Ponty è “un fascio di funzioni, un intreccio (entrelacs) di visione e movimento” , un corpo enigmatico e paradossale in quanto al tempo stesso vedente e visibile : “Guarda ogni cosa, ma può anche guardarsi, e riconoscere in ciò che allora vede ‘l’altra faccia’ della sua potenza visiva. Si vede vedente, si tocca toccante , è visibile e sensibile per se stesso”. E’ dunque un corpo preso nel tessuto del mondo, caratterizzato dall’intreccio o chiasmo – termine derivante dalla retorica antica e indicante un’inversione o rovesciamento nel rapporto fra termini appartenenti a versi contigui- tra senziente e sentito:” Siamo in presenza di un corpo umano quando, fra vedente e visibile, fra chi tocca e chi è toccato, fra un occhio e l’altro, fra una mano e un’altra mano, avviene una sorta di reincrociarsi (recroisement).
L’immagine cui dà luogo la pittura non è quindi da intendersi come copia, ricalco, ri-presentazione del rappresentato, bensì è un’immagine che “non celebra mai altro enigma che quello della visibilità”, che si apre sulla trama dell’Essere. Un’immagine che è si somigliante, ma nel senso di “una similitudine efficace, che è genitrice, genesi, metamorfosi dell’Essere nella visione del pittore”. Il pittore non ricerca altro che il farsi della visibilità, il dispiegarsi del senso nel visibile, e al tempo stesso porta alla manifestazione quella visibilità diffusa in cui si annullano le differenze tra vedente e visibile, tra chi dipinge e chi è dipinto. Di qui l’emblematicità dello specchio come luogo in cui il vedente si scopre guardato e l’io si sdoppia nell’altro.
Nella terza parte del saggio, Merleau-Pontyu si confronta infine con la teoria della visione proposta da Cartesio nella Diottrica, dove la visione è ricondotta a un modello proiettivo geometrico (tramite l’analogia con la proiezione prospettica della immagini nella camera oscura) e le immagini percettive sono considerate alla stregua di segni arbitrari nel loro rapporto con le idee nel pensiero. Opporsi a questa interpretazione geometrica e meccanicistica della visione significa, per Merleau-Ponty, opporsi a ogni forma di pensiero rappresentativo e “di sorvolo” in cui va perla la capacità delle immagini di esprimere la coappartenenza di corpo e mondo. Ciò che deve ricercare il pittore non è tanto l’artificialità di una prospettiva geometrica statica e meccanica, quanto la vita del visibile, il “mistero di passività” che lo anima dall’interno.
WALTER BENJAMIN
L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica
Non è che il passato getti la sua luce sul presente o il presente la sua luce sul passato, ma immagine è ciò in cui quel che è stato si unisce fulmineamente con l’ora in una costellazione.
A cura di Claudia Bianco
Il saggio L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica viene scritto da Walter Benjamin (1892-1940) nel 1935 subito dopo aver partecipato come uditore al I Congresso internazionale degli scrittori, organizzato a Parigi al fine di dar vita a un’ampia mobilitazione intellettuale contro la diffusione del fascismo . Nel 1936 il saggio è pubblicato, nella traduzione francese di Pierre Klossowski , sulla celebre rivista Zeitschrift fur Sozialforschung , che in quel periodo si stampava a Parigi e il cui gruppo dirigente era costituito da Theodor Wiesengrund Adorno (1903-1969) , Max Horkheimer (1895-1973) e Herbert Marcuse (1898-1979) , fondatori dell’Istituto per la ricerca sociale di Francoforte. In una lettera del 16 ottobre 1935 a Horkheimer, Benjamin descrive il saggio come “una puntata in direzione di una teoria materialistica dell’arte”; in effetti la sua problematica adesione al marxismo e i rapporti con il gruppo di Adorno e con Bertolt Brecht costituiscono un quadro di riferimento imprescindibile per comprendere un testo che lega il problema del mutato statuto dell’opera d’arte – a seguito della diffusione di nuove tecniche di riproduzione- a considerazioni di carattere politico e sociale.
L’adesione di Benjamin al “materialismo storico”, ossia alla dottrina associata principalmente alle figure di Karl Marx (1818 – 1883) e Friedrich Engels (1820-1895) , secondo cui le produzioni cosiddette “spirituali” degli uomini – arte, religione e filosofia – sarebbero determinate, in quanto “sovrastruttura” , dalle strutture economiche soggiacenti delle diverse relazioni sociali e dei diversi modi di produzione, è sin dall’inizio assai problematica e originale. Nel saggio Eduard Fuchs, il collezionista e lo storico, Benjamin individua come compito del materialismo storico il superamento dell’atteggiamento “contemplativo” e neutrale assunto dallo storicismo per introdurre una visione dialettica della storia. Il passato non deve essere considerato come inserito in un ordine lineare e progressivo, bensì come qualcosa di unico, un’”esperienza originaria” in cui il presente si incontra con il passato in una “costellazione critica” che “fa deflagrare la continuità della storia”. L’idea di un presente nel quale si incontrano i diversi registri temporali dell’eternità e dell’istante era probabilmente maturata in Benjamin attraverso la lettura di Baudelaire, il quale, come abbiamo visto, nei saggi de Il pittore della vita moderna aveva definito la modernità come coesistenza, nel presente, del transitorio e dell’effimero con l’eterno e l’immutabile.
La critica della concezione della storia come progresso lineare e ascendente ritorna nelle tesi Sul concetto di storia (1940) , dove il compito del materialista storico è descritto come quello di “scardinare il continuum della storia”, a partire da “un presente che non è passaggio, ma nel quale il tempo è in equilibrio ed è giunto a un arresto (…) quel presente in cui egli, per quanto lo riguarda, scrive storia”. Il presente non è un istante astratto e anonimo dell’omogeneo fluire del tempo, né un’agostiniana distensio animi tutta racchiusa nell’interiorità della coscienza: esso è,invece, istanza originaria generatrice del tempo storico, luogo della sospensione e della critica in cui la storia è narrata e costruita guardando al futuro, a partire dalle urgenze dell’attualità (Jetztzeit). Questa costellazione di presente, passato e futuro, implicante al tempo stesso critica dell’esistenze e apertura verso il futuro, si rivela allo sguardo dello storico purificato dalle pecche dello storicismo sotto le sembianze di quella che Benjamin chiama un’”immagine dialettica”: un’immagine improvvisa, balenante, nella quale passato e futuro si illuminano a vicenda a partire dal presente.
E’nella sezione N del libro incompiuto dedicato ai passages di Parigi, intitolata “Elementi di teoria della conoscenza, teoria del progresso” che Benjamin sviluppa questo concetto, sostenendo che è solo attraverso le immagini dialettiche che la storia giunge alla leggibilità in una determinata epoca, là dove improvvisamente il passato subisce una sorta di “teléscopage” attraverso il presente: “Non è che il passato getti la sua luce sul presente o il presente la sua luce sul passato, ma immagine è ciò in cui quel che è stato si unisce fulmineamente con l’ora (Jetzt) in una costellazione. In altre parole: immagine è la dialettica nell’immobilità . Poiché, mentre la relazione del presente con il passato è puramente temporale,continua, la relazione tra ciò che è stato e l’ora è dialettica: non è un decorso, ma un’immagine discontinua, a salti. Solo le immagini dialettiche sono autentiche immagini (cioè non arcaiche); e il luogo, in cui le si incontra, è il linguaggio”. L’immagine dialettica appare là dove il pensiero si arresta in una costellazione, dove passato, presente e futuro si manifestano improvvisamente alla luce di una “vera sintesi” in cui appare ciò che Benjamin , riprendendo un termine fondamentale della morfologia goethiana , chiama un “fenomeno originario della storia”.
La riflessione benjaminiana su cosa significhi un approccio materialistico e dialettico alla storia e all’arte sta sullo sfondo del saggio L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica , che nella “premessa” è presentato come una raccolta di “tesi sopra le tendenze dello sviluppo dell’arte nelle attuali condizioni di produzione”. In apertura del saggio Benjamin cita un passo di un breve testo di Paul Valéry (1871-1945) , “La conquete de l’ubiquité”, pubblicato nel 1931 nella raccolta Pièce sur l’art. In questo testo Valéry si interroga sui mutamenti in atto nella nozione stessa di arte – nelle tecniche artistiche, nella concezione della creazione, nella riproduzione e trasmissione delle opere – in seguito all’incremento stupefacente del nostro “potere di azione sulle cose”. La futura diffusione di nuovi mezzi di comunicazione analoghi alla radio e al telefono avrebbe presto consentito, secondo Valéry, di “trasportare o ricostituire in ogni luogo il sistema di sensazioni – o più esattamente, il sistema di eccitazioni – provocato in un luogo qualsiasi da un oggetto o da un evento qualsiasi”. Nel caso dell’arte, ciò avrebbe significato la possibilità per le opere di avere una sorta di “ubiquità” , ossia di divenire delle “fonti” o “origini” i cui effetti potrebbero essere avvertiti ovunque. Su un piano più generale, lo scenario evocato da Valéry è quello di una società futura in cui sarebbe possibile suscitare un flusso di immagini visive o di sensazioni uditive con un semplice gesto, una società caratterizzata dalla possibilità di una “distribuzione della Realtà Sensibile a domicilio”. In questo aumentato potere di riprodurre e diffondere le opere, che Valéry vede già compiersi nel caso della musica, risiederebbe la “condizione essenziale della resa estetica più elevata”, ossia la possibilità di sganciare la fruizione dell’opera d’arte dall’hic et nunc della sua collocazione materiale o della sua esecuzione per renderla accessibile nel momento spirituale più favorevole e fecondo.
La stessa riflessione sui mutamenti in atto nello statuto e nella fruizione dell’arte in seguito all’elaborazione di nuove tecniche di riproduzione e trasmissione delle opere che anima il breve testo di Valéry è al centro del saggio di Benjamin, che ha come presupposto la grande diffusione della fotografia e del cinema nei primi decenni del secolo e il lavoro di sperimentazione condotto su queste due forme espressive da avanguardie artistiche come il dadaismo, il surrealismo o il costruttivismo. A differenza di Valéry, Benjamin conferisce però alla propria analisi una valenza esplicitamente politica, in quanto nelle nuove forme di produzione e trasmissione dell’arte messe in atto da cinema e fotografia vede la possibilità di liberare l’esperienza estetica dal sostrato religioso-sacrale che ne accompagnava la fruizione da parte della borghesia, impedendo l’instaurazione di un nuovo rapporto tra l’arte e le masse. Quelle proposte da Benjamin, secondo le sue stesse parole, sono tesi “che eliminano un certo numero di concetti tradizionali – quali i concetti di creatività e di genialità, di valore eterno e di mistero -, concetti la cui applicazione incontrollata (…) induce a un’elaborazione in senso fascista del materiale concreto”. Scopo dell’analisi deve essere elaborare concetti “del tutto inutilizzabili ai fini del fascismo”, concetti che consentano, al contrario, “la formulazione di esigenze rivoluzionarie nella politica culturale”.
Una riflessione sulla riproducibilità dell’opera d’arte non può non partire dalla constatazione che, “in linea di principio”, l’opera d’arte è sempre stata riproducibile”. La riproduzione intesa come imitazione manuale di disegni, quadri o sculture è sempre stata parte integrante della pratica artistica, dell’apprendimento e della messa in circolazione delle opere. Nel caso della musica,poi, l’opera stessa esiste innanzitutto come ri-esecuzione . Ciò che interessa a Benjamin , però, non è la riproduzione intesa in questo senso bensì la riproduzione tecnica delle opere d’arte, qualcosa che nella storia si è manifestato progressivamente nelle pratiche della fusione del bronzo, del conio delle monete, della silografia e della litografia come riproduzione della grafica e, soprattutto, della stampa come riproducibilità tecnica della scrittura. Con l’invenzione della fotografia e del cinema, la riproducibilità del visibile attinge a una dimensione nuova, sganciandosi ulteriormente dal condizionamento della manualità e velocizzandosi enormemente. Di fronte a una tale rivoluzione tecnica, il compito del critico, secondo Benjamin, consiste nel riflettere sul modo in cui questo tipo di riproducibilità dell’opera d’arte finisce per imporre una ridefinizione dello statuto stesso dell’arte nella sua forma tradizionale.
La tesi centrale del saggio di Benjamin risiede nell’affermazione che nella riproduzione fotografica di un’opera viene a mancare un elemento fondamentale : “l’hic et nunc dell’opera d’arte, la sua esistenza unica e irripetibile nel luogo in cui si trova”. Nell’unicità della collocazione spazio-temporale dell’opera risiede il fondamento della sua autenticità e della sua autorità come “originale”, ossia la sua capacità di assumere il ruolo di testimonianza storica. La trasmissione di un’eredità culturale poggia infatti sul permanere nel tempo dell’unicità e dell’autorità delle opere e sulla loro conservazione e celebrazione in spazi dedicati, come i musei, o nei quali esse si radicano nella loro unicità (una chiesa, un palazzo). Benjamin riassume i valori di unicità,autenticità e autorità dell’opera d’arte nella nozione di “aura” , un termine ricorrente nel lessico storico-artistico ed esoterico di inizio secolo nell’accezione di “aureola” (come quella che circonda le immagini dei santi) o in quella, assai più ambigua, di “alone” che circonda e avvolge ogni individuo, come negli scritti di carattere misterico o teosofico.
Il “declino”, il “venir meno” dell’aura (Verfall der Aura) determinato dall’avvento dei mezzi di riproduzione tecnica delle opere, sarebbe il sintomo, secondo Benjamin , di un più vasto mutamento “nei modi e nei generi della percezione sensoriale”: a ogni periodo storico corrispondono infatti determinate forme artistiche ed espressive correlate a determinate modalità della percezione, e la storia dell’arte deve essere accompagnata da una storia dello sguardo. Proseguendo la riflessione sul progressivo impoverirsi dell’esperienza avviata nel saggio Il Narratore. Considerazioni sull’opera di Nicola Leskov, in L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica Benjamin constata come nella società a lui contemporanea, mediante la diffusione dell’informazione e delle immagini, tenda ad affermarsi sempre più un’esigenza di avvicinamento, alle cose e alle opere.
Ciò che però viene meno, in un’epoca caratterizzata dal bisogno di “rendere le cose, spazialmente e umanamente, più vicine” e in cui “ si fa valere in modo sempre più incontestabile l’esigenza di impossessarsi dell’oggetto da una distanza il più possibile ravvicinata nell’immagine, o meglio nell’effigie, nella riproduzione”, è quel peculiare intreccio di vicinanza e lontananza nel quale risiede, secondo Benjamin, l’essenza dell’aura: “Cade qui opportuno illustrare il concetto, sopra proposto, di aura a proposito degli oggetti storici mediante quello applicabile agli oggetti naturali. Noi definiamo questi ultimi apparizioni uniche di una lontananza, per quanto questa possa essere vicina. Seguire, in un pomeriggio d’estate, una catena di monti all’orizzonte oppure un ramo che getta la sua ombra sopra colui che si riposa – ciò significa respirare l’aura di quelle montagne, di quel ramo”. Fine dell’aura significa fine di quell’intreccio tra lontananza, irripetibilità e durata che caratterizzava il nostro rapporto con le opere d’arte tradizionali, e avvento di una fruizione dell’arte basata sull’osservazione fugace e ripetibile di riproduzioni.
Originariamente, le opere d’arte erano parte inscindibile di un contesto rituale, prima magico e poi religioso; la loro autorità e autenticità, la loro aura, era determinata proprio da questa appartenenza al mondo del culto. In forme secolarizzate, l’atteggiamento rituale e culturale nei confronti dell’arte sarebbe poi trapassato nelle forme profane del culto della bellezza, che nasce nel Rinascimento e dura fino alle ultime derive del Romanticismo. L’avvento della riproducibilità tecnica e la sua diffusione mediante la fotografia segnano per la prima volta la possibilità di emancipare l’arte rispetto all’ambito del rituale: venendo meno i valori dell’unicità e dell’autenticità, si apre la possibilità di conferire all’arte una nuova valenza politica, al valore cultuale (Kultwert) dell’opera si sostituisce progressivamente il valore espositivo (Ausstellungswert).
Il discorso benjaminiano sulla fine dell’aura non è quindi riconducibile a una forma di nostalgia, bensì è un tentativo di individuare le potenzialità ancora non del tutto esplicitate della riproducibilità. Nella fotografia la dissoluzione del valore cultuale in favore del valore di esponibilità non è ancora completa, in quanto l’aura mantiene una sua ultima forma di sopravvivenza nel “volto dell’uomo”. Non è un caso che le prime fotografie siano state soprattutto dei ritratti, miranti a fissare e a tramandare nel tempo l’identità e lo sguardo dei soggetti fotografati:”Nell’espressione fuggevole di un volto umano, dalla prime fotografie, emana per l’ultima volta l’aura. E’ questo che ne costituisce la malinconica e incomparabile bellezza”. Il profondo legame tra l’immagine fotografica e l’unicità del soggetto rappresentato nell’hic et nunc del suo essere rappresentato, e quindi il legame tra immagine, temporalità e morte- che Roland Barthes (1915-1980avrebbe successivamente tematizzato tramite il concetto di punctum nel celebre saggio La chambre claire – viene meno con il cinema. La rappresentazione cinematografica, a differenza di quella teatrale, è fatta di mediazione , differimento, scomposizione: le azioni che ci si presentano nella loro sequenzialità sono girate in momenti diversi, e ciò che vediamo è il risultato di una serie di scelte legate all’inquadratura e al montaggio. A differenza del pittore – che è come un mago nel mantenere la distanza tra sé e ciò che è oggetto della rappresentazione e nel conferire un’autorità auratica alla rappresentazione stessa- l’operatore cinematografico è come un chirurgo ; penetra nelle immagini, le frammenta, le scompone, ne ridefinisce la sequenza, finendo però per eliminarne l’aura.
Lungi dal condividere il senso di disagio provato da Pirandello nei confronti della presenza del mezzo tecnico nella realizzazione dell’immagine cinematografica, come testimonia il romanzo Si gira del 1915, Benjamin afferma che proprio questa mediatezza consente al cinema di determinare un significativo approfondimento delle nostre capacità percettive. La possibilità di moltiplicare i punti di vista e le inquadrature mediante quella che Benjamin chiama “la dinamite dei decimi di secondo” rende infatti più libero e indipendente il nostro sguardo sulle cose. Lo spazio che si rivela alla cinepresa è, inoltre, profondamente diverso da quello che si rivela allo sguardo empirico: “ al posto di uno spazio elaborato dalla coscienza dell’uomo interviene uno spazio elaborato inconsciamente”. Quello rivelato dall’istantaneità dell’immagine fotografica e dalla sequenzialità dell’immagine in movimento è dunque un “inconscio ottico” che si rivela soltanto attraverso di esse, così come l’inconscio istintivo viene portato alla luce nella psicoanalisi.
La portata “rivoluzionaria” che Benjamin attribuisce alla fotografia come tecnica della riproduzione e,in maggior misura, al cinema, si esplica dunque su diversi piani: dissoluzione dell’aura attraverso riproduzioni che sottraggono l’opera d’arte all’hit et nunc della sua esistenza materiale e della sua fruizione, rivelazione di una visibilità che rimane inaccessibile all’occhio empirico e diventa invece accessibile grazie alla mediazione del dispositivo, contestazione di ogni atteggiamento cultuale e “feticistico”, tipicamente borghese, nei confronti dell’autenticità e dell’autorità dell’opera. Riguardo a quest’ultimo punto, Benjamin sottolinea come il cinema, a differenza della pittura, non consenta un atteggiamento puramente contemplativo, fatto di esaltazione e rapimento. Quella del cinema non è una fruizione fatta di raccoglimento ma una fruizione “distratta” in cui lo spettatore non si perde nell’opera, ma si mantiene in un atteggiamento nel quale piacere e giudizio critico coesistono senza limitarsi a vicenda. Il cinema, in altre parole, si allontana dal naturalismo e dall’illusionismo teatrale e consente di conservare la “distanza” e lo “straniamento” che erano al centro, negli stessi anni, della riflessione sul teatro di Brecht.
La capacità di ridefinire il rapporto tra l’arte e le masse aperta dal cinema, dunque, risiede per Benjamin nella possibilità di una fruizione collettiva nella quale la critica non è soffocata da una forma di devozione cultuale nei confronti dell’immagine. Certo, anche nel cinema è presente un residuo di aura, in particolare nel culto della personality che trasforma gli attori in divi, e del resto è chiaro che l’”industria cinematografica ha tutto l’interesse a imbrigliare, mediante rappresentazioni illusionistiche e mediante ambigue speculazioni, la partecipazione delle masse”. Alla ricognizione delle possibilità espressive del mezzo cinematografico operata da registi come Ejzenstejn si contrapponeva, in quegli stessi anni, l’impiego dell’immagine cinematografica da parte dei regimi fascisti a fini propagandistici – basti pensare al contributo della regista Leni Riefenstahl nel definire l’iconografia del nazismo – , testimoniando così come questa forma espressiva avesse un potenziale ambiguo, , che sarà poi analizzato da Adorno e Horkehimer , in relazione all’industria culturale americana, in Dialettica dell’illuminismo (1946). Rispetto a questo testo, l’analisi di Benjamin mostra di condividere l’interesse e le aspettative nutrite da diversi movimenti degli anni Venti e Trenta (neoplasticismo, costruttivismo, Bauhaus), oltre che dai giovani Lukàcs e Brecht , nei confronti dei nuovi mezzi espressivi, pur riconducendo la riflessione sull’arte a una finalità prettamente politica: Benjamin risponde infatti all’estetizzazione della politica e della guerra proposte dal fascismo, e condivise da futuristi come Martinetti, sostenendo la necessità di una “politicizzazione dell’arte” proprio a partire dal potenziale rivoluzionario e democratico del cinema.

