ETÀ CRISTIANA
“Non voler uscire da te stesso per trovarla, la verità abita nell’interno dell’uomo, e se troverai mutevole la sua natura, trascendi anche te stesso” (Agostino, La vera religione)
FILOSOFIA CRISTIANA
Per cristiana intendiamo quella filosofia sviluppatasi in epoca cristiana , ossia nel periodo tardo-antico e mediovale , e la si suole suddividere in due diversi tipi di filosofia , quella patristica e quella scolastica . Spesso tendiamo ad avere in mente una concezione erronea di filosofia cristiana e ad immaginarci che essa sia esclusivamente ciò che é nei vangeli , ma non é affatto così : la vita stessa di Gesù é carica di valori simbolici e filosofici . La parola Logos , con cui inizia il vangelo di Giovanni ( ” in principio era il Logos ” ) , é un intreccio evidentissimo con la filosofia , pensiamo solo ad Eraclito e agli Stoici : la parola di Dio é creatrice , vale a dire che bastano le parole di Dio a creare la realtà ; noi possiamo solo dire le verità , Dio invece le crea proprio . Peculiarità del cristianesimo é quella di non essere una setta , come le varie scuola filosofiche , ed é destinata a superare l’ ebraismo per aprirsi totalmente , pur con un nettissimo riallacciamento alle filosofie greche . La patristica é una filosofia apologetica , ossia un tentativo dei cristiani di giustificarsi nell’ ambito di un impero in cui sono una minoranza malvista ; successivamente si affermerà e diventerà la religione di stato e così i cristiani non dovranno più giustificarsi e passeranno così a ragionare sui veri e propri concetti , dando così vita alla scolastica , così denominata perchè si svilupperà nelle università . Problema fondamentale per i cristiani é come comportarsi di fronte al mondo classico greco ; le possibilità sono due : 1) un netto rifiuto di un mondo che non ha nulla a che fare con quello cristiano 2) lo sfruttamento di questa cultura . La prima delle due soluzioni però non era certo conveniente per i cristiani : si sarebbe rifiutato l’ impero sul piano politico e il cristianesimo si sarebbe ridotto ad una setta , come tutte le altre filosofie greche , destinato ben presto a sparire e non avrebbe certo avuto il seguito che invece ebbe . La seconda era invece migliore perchè con l’ intrecciamento con le altre filosofie , il cristianesimo si sarebbe potuto diffondere universalmente . Si scelse dunque la seconda e cristianesimo e impero si sfruttarono a vicenda : il cristianesimo si diffuse facilmente e l’ impero ebbe un valido strumento di sopravvivenza ; quando , infatti , l’ impero romano si sfascia , tutto ciò che ne resta é la Chiesa . Questa seconda scelta , però , implicò la perdita della purezza cristiana , che con la prima scelta si sarebbe mantenuta , ma guadagnò in capacità di diffusione e in capacità di permeazione tra società e stato : se avessero preferito trasmettere il loro messaggio in forma pura , avrebbero potuto trasmetterlo solo a poche persone e in forma di setta , ma loro scelsero di trasmetterlo in forma ” impura ” , ma a tutta Europa . Lo stesso vale per la cultura classica : ci furono anche qui due correnti di pensiero : vi era chi sosteneva che la cultura classica andasse rifiutata , e in questa direzione vanno le Lettere di San Paolo , in una delle quali la Croce di Cristo viene definita ” scandalo per gli ebrei e follia per i pagani ” ; follia per i pagani , perchè essi erano molto colti e avevano una concezione trascendente di dio , sulla scia di Plotino , e quando gli si parlava di un dio crocifisso , essi proprio non riuscivano a capire e prendevano i cristiani per pazzi . Si tratta di un qualcosa di più che indimostrato e indimostrabile : é un qualcosa addirittura di pazzo e assurdo . Il culmine di questo atteggiamento lo si trova in Tertulliano , la cui filosofia é sintetizzata in un’ espressione latina , ” credo quia absurdum ” ( credo proprio perchè é assurdo ) : la Croce diventa proprio la prova del cristianesimo : la ragione umana fino a un certo punto può farcela ad arrivare , ma oltre no , occorre avere fede : parrà quindi una cosa senza senso e indimostrabile con la ragione quella della Croce , ma tuttavia qui non ci vuole ragione , ma fede . La ragione non può arrivare a scoprire le verità più profonde perchè é vincolata dal peccato originale : se si é particolarmente pessimisti , come nel caso di Lutero , si arriva a dire che solo chi ha fede sarà salvato da Dio , mentre tutti quelli che non la hanno saranno dannati . Se invece si é meno radicali , si apprezza anche chi usa la ragione : certo la fede é meglio ancora , ma tuttavia la ragione qualcosa può fare e se unita alla fede é il massimo . Il ” credo quia absurdum ” diventa sensato solo se si ammette che la ragione umana é corrotta al massimo dal peccato originale . Per i cristiani meno radicali e più aperti , comunque , la filosofia greca é fortemente positiva , sebbene incompleta : é proprio il cristianesimo che si propone di completarla e la stessa costruzione dell’ impero può essere vista come in funzione del cristianesimo , come fa Dante . E’ risaputo che l’ impero romano fosse diviso in due parti , l’ Occidente , di lingua latina , e l’ Oriente , di lingua greca : la patristica che si sviluppò nell’ Oriente fu più ottimistica e aperta , in quanto reduce della tradizione greca e quindi più propensa ad accettare di buon grado la filosofia e la cultura greca ; é naturale che nell’ Oriente prevalse alla grande la seconda opzione , quella di accettare il mondo greco , e di riservare per l’ uomo maggiori possibilità di salvezza : pensiamo a Origene , che arrivò a dire che alla fine sarebbe stato salvato perfino il diavolo .
FILONE

Filone nacque ad Alessandria verso il 20 a.C. , da una ricca famiglia di giudei , si dedicò allo studio della Sacra Scrittura e della filosofia greca . Nelle opere di Giuseppe Flavio si possono trovare i pochi dettagli biografici che lo riguardano. Coltissimo esponente della potente comunità ebraica di Alessandria, nel 40 fu rappresentante della delegazione a Roma presso l’imperatore romano Caligola. Provenne da una delle più ricche ed influenti famiglie della città e forse fu il primo grande commentatore dei testi biblici da lui conosciuti in traduzione greca. Nel 39 d.C fu a capo di un’ ambasceria inviata dalla comunità a Roma , presso l’ imperatore Caligola , per protestare contro le vessazioni , alle quali gli ebrei erano sottoposti da parte del governatore romano della città , Flacco . L’ ambasceria non ebbe successo e Flacco tornò ad Alessandria , ove morì in data a noi ignota . Filone é autore di numerosi scritti in Greco , alcuni di carattere più specificamente filosofico , come quelli Sulla creazione del mondo , Sulla provvidenza , ma per la maggior parte dedicati all’ esegesi biblica . Particolare attenzione é prestata da Filone all’ esegesi dei primi cinque libri della Bibbia , il cosiddetto Pentateuco , considerato opera di Mosè , ispirato direttamente da Dio . Gli scritti di Mosè , che Filone definisce ” tesoriere e custode dei misteri dell’ essere ” , sono a suo avviso la fonte alla quale gli stessi filosofi greci hanno attinto le loro migliori dottrine . Emerge così , forse per la prima volta , per spiegare le coincidenze dottrinali tra la filosofia e la rivelazione contenuta nelle Scritture , la teoria del plagio perpetrato dai filosofi . Nella sua opera esegetica , Filone teorizza e applica sistematicamente il metodo dell’ integrazione allegorica , già usato nell’ ambito della filosofia greca , soprattutto da parte degli stoici a proposito di Omero . Esso si fonda sulla distinzione tra due significati presenti nello scritto da interpretare : la lettera e lo spirito . Quest’ ultimo racchiude il significato più autentico . Filone impiega tale metodo allo scopo di liberare la Scrittura da ogni antropomorfismo per coglierne il vero senso , che manifesta profonde corrispondenze con dottrine filosofiche greche . In questo modo , egli trova enunciata nella Bibbia principalmente una dottrina dell’ essenza di Dio , i cui tratti salienti sono il monoteismo , l’ unicità della divinità , e la trascendenza . Dio é ineffabile , il linguaggio umano non dispone di nomi adeguati per esprimerne l’essenza . La miglior definizione di Dio fu quella rivelata da Dio stesso a Mosè : ” Io sono colui che é ” . Filone interpreta questa affermazione come equivalente a : ” La mia natura é di essere , non di essere nominato ” . Per chiarire il racconto biblico della creazione , Filone ricorre a tematiche proprie del Pitagorismo e del platonismo , introducendo la distinzione tra mondo intellegibile e mondo sensibile . Tra Dio e il mondo , Filone colloca molte potenze , che svolgono funzioni di intermediari . La maggiore di queste , che comprendono anche gli angeli e i demòni , é il Logos , un concetto che Filone riprende dalla tradizione greca . Egli lo dice ” primogenito ” o ” immagine ” di Dio , ma non risulta del tutto chiaro se lo consideri un’ entità increata o creata da Dio stesso . Esso é il depositario delle idee , che svolgono funzione di modelli per la creazione del mondo , come già aveva sostenuto Platone ; il Dio cristiano , però , a differenza del Demiurgo platonico crea la materia dal nulla .
GIUSTINO

Giustino, che spesso si dichiarava in verità samaritano, visto il suo nome e il nome di suo padre – Bacheio – sembra piuttosto di origini latine o greche. La sua famiglia probabilmente si era stabilita da poco in Palestina, al seguito degli eserciti romani che qualche anno prima avevano sconfitto gli Ebrei e distrutto il Tempio di Gerusalemme. Come riferisce Giustino stesso nel Dialogo con Trifone, venne educato nel paganesimo ed ebbe un’ottima educazione che lo portò ad approfondire i problemi che gli stavano più a cuore, quelli riguardanti la filosofia. Racconta che la sua smania di verità lo portò a frequentare molte scuole filosofiche. Presso gli stoici non trovò giovamento, in quanto il problema di Dio, per questa filosofia, non era essenziale. Poi frequentò la scuola peripatetica, ma anche presso questi filosofi non trovò quanto cercava. Si recò presso un filosofo pitagorico che lo sollecitò dunque ad approfondire le arti della musica, dell’astronomia e della geometria. Ma Giustino, troppo concentrato nel voler raggiungere la “verità” e la “conoscenza di Dio”, reputava tempo sprecato il soffermarsi su tali materie. Da ultimo frequentò una scuola platonica; un maestro di questa filosofia era da poco giunto nel suo paese e presso questa corrente filosofica trovò quanto credeva di cercare. «Le conoscenze delle realtà incorporee e la contemplazione delle Idee eccitava la mia mente…», dice Giustino. Si convinse che questo lo avrebbe portato presto alla “visione di Dio”, che considerava essere lo scopo della filosofia. Decise di ritirarsi in solitudine lontano dalla città, ma in questo luogo appartato incontra un anziano, con cui inizia un serrato dialogo, incentrato su Dio e su cosa fare della propria vita. Dopo aver dichiarato all’anziano la sua idea di Dio «Ciò che è sempre uguale a sé stesso e che è causa di esistenza per tutte le altre realtà , questo è Dio», l’anziano lo porta a ragionare su di un aspetto che forse a Giustino era sfuggito: come possono i filosofi elaborare da soli un pensiero corretto su Dio se non l’hanno né visto né udito? E porta il giovane a meditare sulle persone considerate “gradite a Dio” e dallo stesso “illuminate”, i Profeti, che nel tempo avevano parlato di Dio e “profetizzato in Suo nome”, in particolare la “venuta del Figlio nel mondo” e la possibilità “attraverso di Lui” di avere una “vera conoscenza del divino”. Dopo questa esperienza, Giustino si converte al Cristianesimo e per tutto il resto della sua vita educherà i discepoli, utilizzando gli stessi schemi usati dalle altre scuole filosofiche. Oltre a questo incontro, che fu decisivo per la sua conversione, Giustino indica anche un altro fatto che lo rinfrancava nella fede: «Infatti io stesso, che mi ritenevo soddisfatto delle dottrine di Platone, sentendo che i cristiani erano accusati ma vedendoli impavidi dinanzi alla morte ed a tutti i tormenti ritenuti terribili, mi convincevo che era impossibile che essi vivessero nel vizio e nella concupiscenza». La sua fede lo porterà a subire pure lui una morte violenta. Fu condannato a morte da Rustico che era prefetto ai tempi dell’imperatore Marco Aurelio con queste parole: « Coloro che si sono rifiutati di sacrificare agli déi e di sottomettersi all’editto dell’imperatore, siano flagellati e condotti al supplizio della pena capitale, secondo le vigenti leggi » . Di questo processo esiste ancora il verbale. Giustino venne decapitato assieme ai sui discepoli, Caritone e sua moglie Carito, Evelpito, Jerace e Peone. « Io, Giustino, di Prisco, figlio di Baccheio, nativi di Flavia Neapoli, città della Siria di Palestina, ho composto questo discorso e questa supplica, in difesa degli uomini di ogni stirpe ingiustamente odiati e perseguitati, io che sono uno di loro. » (Apologia Prima, I, 2) La Prima Apologia dei cristiani è indirizzata all’imperatore Antonino Pio e al Senato romano. In essa compare un tema che sarà ampiamente sviluppato dall’apologetica cristiana, cioè la critica della prassi diffusa presso i tribunali romani, per la quale il solo fatto di appartenere alla religione cristiana era motivo sufficiente di condanna. Giustino inoltre polemizza con i pagani riguardo ad alcune contraddizioni interne alla società romana, per esempio fa notare come, mentre i cristiani sono condannati a morte perché ritenuti atei, vari filosofi greci e latini sostengono apertamente l’ateismo senza conseguenze. Interessante, poi, è il fatto che Giustino citi abbondantemente vari brani dei vangeli sinottici per esporre le dottrine cristiane; ancor più notevoli sono i tentativi dell’apologeta per convincere i pagani della verità del Cristianesimo attraverso le citazioni di autori classici sia di filosofia (come Socrate e Platone) che di mitologia (come Omero e la Sibilla) che vengono accostati a brani dei vangeli o dell’Antico Testamento. L’opera si conclude con una petizione che contiene una lettera dell’imperatore Adriano, la quale serve a Giustino per mostrare come anche un’autorità imperiale era del parere di giudicare i cristiani in base alle loro azioni e non in base a dei pregiudizi.
TERTULLIANO

VITA, OPERE E PENSIERO
Nell’ ambito del Cristianesimo vi fu anche chi rifiutò radicalmente la filosofia, anche se, come aveva insegnato Aristotele, anche per rifiutare la filosofia si deve comunque fare un ragionamento filosofico; il rappresentante più significativo in questa direzione é Quinto Settimio Fiorente Tertulliano. Nato a Cartagine tra il 150 e il 160 da genitori pagani, dotato di ampia cultura retorica e giuridica, esercitò forse l’avvocatura in Roma. Verso il 195 si convertì al cristianesimo, tornò in Africa, ove compose numerosi scritti in lingua latina in difesa della Chiesa contro pagani ed eretici. Fu anche prete, e le sue posizioni religiose si dimostrarono molto rigorose, tanto che nel 213 finì con l’aderire ad una delle sette più note per l’intransigenza e il fanatismo, quella dei Montanisti, che in vecchiaia abbandonò per dar vita ad un nuovo gruppo, quello dei “Tertullianisti”. Di Tertulliano ci sono pervenuti circa quaranta scritti, tra i quali sono particolarmente importanti l’ Ad nationes , contro i pagani , e l’ Apologetico , composti entrambi nel 197 , e il De praescriptione haereticorum , di poco successivo . Come abbiamo detto, verso il 207 aderì al montanismo, eresia introdotta da Montano, fondata sulla credenza nella fine imminente del mondo e sulla necessità di prepararsi ad essa con rigoroso ascetismo . Con vari scritti, Tertulliano intervenne anche su questioni etiche , come l’immoralità dell’assistere agli spettacoli teatrali e circensi o delle acconciature femminili. Morì a Cartagine dopo il 220. Profondamente intriso di cultura classica, anche filosofica e medica, Tertulliano attinge anch’egli a dottrine filosofiche. Esempio significativo di questo atteggiamento é dato dal suo scritto Sull’ anima , dove egli si fa sostenitore di una forma di materialismo. Riallacciandosi allo stoicismo, egli sostiene che tutto ciò che esiste é corpo e , dunque , é corpo anche l’ anima . Ne scaturisce il cosiddetto traducianismo , secondo cui l’anima é un derivato dell’anima dei genitori e di conseguenza attraverso di essa viene trasmessa la macchia del peccato originale, commesso dal primo uomo, cioè Adamo. Tertulliano ammette la possibilità di somiglianze tra la verità rivelata e determinate dottrine, per esempio etiche, dei filosofi pagani; egli giunse addirittura a definire Seneca ” saepe noster ” ( spesso nostro ), in quanto sostenitore di dottrine affini a quelle cristiane. Ma si tratta di somiglianze casuali: anche nelle tempeste, egli afferma, é talvolta possibile giungere per caso in porto. Di fatto, la sua condanna dei filosofi pagani é inesorabile. Il filosofo e il cristiano, i discepoli della Grecia e quelli del cielo, non hanno ai suoi occhi nulla in comune: ” che cosa hanno in comune ” egli chiede nel De praescriptione ” Atene e Gerusalemme , l’ Accademia e la Chiesa , gli eretici e i Cristiani ? “. Egli sottolinea la presenza nella vita dei filosofi dell’arroganza, dell’impudicizia, della slealtà, ma soprattutto della curiosità , il loro peccato capitale: dopo Cristo e il Vangelo, curiosità e ricerca non hanno più ragione di essere. In questa prospettiva egli giunge ad affermare che é meglio non sapere quanto Dio non ha rivelato, che imparare da congetture umane. La verità rivelata da Dio ha messo completamente fuori gioco le presunzioni dei filosofi di pervenire alla verità con forze proprie: l’ intera tradizione filosofica diventa la tradizione dell’ errore . Alle filosofie si oppone la tradizione unanime e concorde delle Scritture, dei profeti e degli apostoli, e questa tradizione contiene verità che possono apparire assurde nell’ ottica delle filosofie. Certezza e fede hanno il loro fondamento nella verità della rivelazione. A Tertulliano é stata erroneamente attribuita l affermazione ” credo quia absurdum ” ( credo perchè é assurdo ) , ma nello scritto intitolato De carne Christi , egli dichiara espressamente che la crocifissione e morte di Cristo é ” credibile perchè inconcepibile ” e la sua resurrezione é ” certa , perchè impossibile “. La presunzione di attingere una verità fuori dalla rivelazione fa invece della filosofia la causa delle eresie , in particolare delle eresie gnostiche, che sorgono nel seno stesso del cristianesimo, allontanandosi dalla tradizione unitaria delle Scritture e della Chiesa. La radicalità dell’attacco di Tertulliano alla filosofia é spiegata soprattutto proprio dalla necessità di attaccare questi nemici interni, più vicini. Meritano però di essere menzionate e, in qualche misura, commentate altre sue opere: nell’ Ad martyras troviamo una vibrante esortazione ad un gruppo di Cristiani incarcerati e in attesa del martirio: ” se riflettiamo che piuttosto lo stesso mondo è un carcere, possiamo dire che voi siete usciti dal carcere anziché entrati in esso “; nel De praescriptione haereticorum , del 200 circa, si scaglia contro i Cristiani che inquinano la loro fede con dottrine filosofiche pagane e propugnano interpretazioni troppo libere del testo biblico. L’ Ad Scapulam (212) è indirizzato al governatore dell’Africa proconsolare che conduceva un’efferata campagna contro i Cristiani. Con il De spectaculis Tertulliano si schiera contro la partecipazione agli spettacoli del teatro, dell’anfiteatro e del circo; ai vestiti delle donne è dedicato il De cultu feminarum : essi devono essere particolarmente discreti; interpretando in chiave diabolica la figura di Eva nell’episodio del serpente nella Genesi, Tertulliano mostra la più completa svalutazione della figura femminile e, in particolare, proibisce alle donne l’uso dell’ornamento e del trucco; nel De virginibus velandis impone l’uso del velo alle donne: esse non devono uscire di casa a viso scoperto. La donna è, secondo Tertulliano, un essere che Dio ha voluto inferiore; essa è ” diaboli ianua ” (“la porta del demonio”): ” tu, donna, hai con tanta facilità infranto l’immagine di Dio che è l’uomo. A causa del tuo castigo, cioè la morte, anche il figlio di Dio è dovuto morire; e tu hai in mente di adornarti al di sopra delle tuniche che ti coprono la pelle? “. Nel De pudicitia Tertulliano mette alla berlina i rapporti sessuali al di fuori del matrimonio. Con il De corona si scaglia contro il servizio militare, poiché è incompatibile con l’appartenenza alla fede cristiana. Con il De idolatria condanna tutte le attività economiche che siano in qualche modo connesse con i culti pagani. Nell’ Apologeticum (197) difende il cristianesimo dagli attacchi dei pagani: anche se ” la verità è straniera sulla terra “, essa chiede all’autorità giudiziaria di essere conosciuta prima di essere condannata, perché se le leggi ” la condanneranno senza ascoltarla, oltre all’accusa di ingiustizia si meriteranno anche il sospetto di una certa mala fede, per non voler ascoltare quello che non avrebbero potuto condannare, una volta ascoltato
CLEMENTE ALESSANDRINO
Tito Flavio Clemente meglio conosciuto come Clemente Alessandrino, fu un teologo, filosofo, apologeta e scrittore cristiano del II secolo (150 circa – 215 circa). Clemente nacque da genitori pagani, presumibilmente, ad Atene intorno al 150. Solo in età adulta si convertì al Cristianesimo. Dopo essersi convertito al Cristianesimo viaggiò di luogo in luogo alla ricerca di una istruzione sempre migliore, legandosi di volta in volta a maestri diversi: ad un greco ionico, ad un altro della Magna Grecia, ad un terzo di Siria, dopo tutti questi si rivolse ancora ad un egiziano, ad un assiro, e ad un ebreo palestinese convertito. Alla fine, intorno al 180, presso la scuola di teologia di Alessandria d’Egitto (Didaskaleion), incontrò il filosofo Panteno e, nei suoi insegnamenti, “trovò la pace”. Il luogo stesso fu ben scelto. Era naturale che la speculazione cristiana dovesse avere una casa ad Alessandria. Questa grande città era al tempo stesso sia un centro di cultura che commerciale. Sotto la lunga protezione dello stato era sorta e si era sviluppata una grande università. La tendenza intellettuale era vasta e tollerante, per questo divenne una città multietnica e multiculturale. I filosofi erano critici o eclettici, e Platone era il preferito tra i vecchi maestri. Il Neoplatonismo, la filosofia della nuova rinascita pagana, aveva un profeta ad Alessandria nella persona di Ammonio Sacca. Anche gli ebrei, che erano molto numerosi, vi poterono respirare la sua atmosfera liberale, e poterono assimilare la sua cultura secolare. Questi ultimi formarono la colonia più illuminata della Diaspora. Avendo abbandonato l’uso dell’ebraico, trovarono necessario tradurre le Sacre Scritture in greco, che era loro più familiare. Filone di Alessandria, il loro primo pensatore, divenne una sorta di Platone ebreo. Alessandria era, insomma, uno dei luoghi principali in cui trovare quel particolare miscuglio di paganesimo e speculazione cristiana noto come gnosticismo. Basilide e Valentino stessi insegnarono là. E non sorprende, perciò, trovarvi anche qualche Cristiano colpito, di tanto in tanto, dallo spirito scientifico. In questo ambiente, in una data incerta, comunque nella seconda metà del II secolo, sorse “una scuola di istruzione orale”. Qui venivano effettuate delle letture alle quali potevano assistere anche uditori pagani, mentre l’insegnamento avanzato era impartito separatamente ai Cristiani. Essa era un’istituzione ufficiale della Chiesa. Panteno fu il primo insegnante il cui nome è stato tramandato. Clemente prima assistette e poi succedette a Panteno stesso nella direzione della scuola (circa 190), quando Panteno venne designato dal patriarca Demetrio di Alessandria come missionario in India. Prima del pontificato di Papa Vittore I (188-199), comunque, Clemente era già noto come scrittore cristiano. Intorno a questo periodo probabilmente compose l'”Esortazione ai greci” (Protreptikos pros Ellenas), le “Disposizioni” (Hypotyposeis), la “Miscellanea” (Stromateis) ed il “Pedagogo” (Paidagogos). Sotto la sua guida dal, 190 al 202 la scuola alessandrina divenne molto famosa. Qui si formarono famosi teologi come Origene Adamantio che gli fu successore alla guida della stessa. Louis Duchesne (Histoire ancienne de l’Eglise, I, pagina 334 e seguenti) riassunse in questo modo gli anni successivi della vita Clemente. Non terminò la sua vita ad Alessandria poiché la quinta persecuzione si abbatté sull’Egitto nell’anno 202, ed i catecumeni furono colpiti in special modo. La scuola catechetica di Alessandria ne soffrì di conseguenza. Nei primi due libri della “Miscellanea”, scritti in questo periodo, si trova più di un’allusione alla crisi. Alla fine Clemente fu obbligato a scappare. Poco tempo dopo si trovava a Cesarea in Cappadocia, ospite del suo amico ed antico alunno il vescovo Alessandro. La persecuzione era comunque crudele anche in quel luogo e Clemente adempì ad un ministero di amore: dopo che Alessandro fu imprigionato per la sua fede in Cristo, Clemente si prese cura della Chiesa di Cesarea al suo posto, ne fortificò i fedeli, e fu addirittura capace di fare nuove conversioni. Questi avvenimenti vengono narrati in una lettera scritta nel 211 o 212 da Alessandro per congratularsi con la Chiesa di Antiochia per l’elezione Asclepiade alla guida della diocesi. In un’altra lettera, scritta intorno al 215 ad Origene, Alessandro, però, parlava di Clemente come di una persona defunta. In questi ultimi anni Clemente prese parte anche alla controversia pasquale (questione quartodecimana). Clemente non ebbe grande influenza nello sviluppo della teologia, se non la sua influenza personale sul giovane Origene. Le sue opere furono copiate di quando in quando, come da Sant’Ippolito di Roma nel suo Chronicon, da Arnobio e da Teodoreto di Cirro. San Girolamo ne ammirava la cultura, mentre Papa Gelasio I, nel catalogo attribuitogli, menzionava le sue opere, ma aggiungeva, “non devono in nessun caso essere accettate”. Fozio I di Costantinopoli nel Bibliotheca biasimava una serie di errori dedotta dai suoi scritti, ma mostrava una propensione benevola verso Clemente, che, nella storia, era stato ridimensionato dalla grandiosità del suo allievo Origene, che gli succedette alla guida della Scuola di Alessandria. Fino al XVII secolo, Clemente fu venerato come santo, il suo nome veniva citato nei martirologi, e la sua festa ricorreva il 4 dicembre. Ma quando il Martirologio Romano fu riformato da Papa Clemente VIII, dietro consiglio del cardinale Cesare Baronio, il suo nome fu eliminato dal calendario. Papa Benedetto XIV ratificò la decisione del suo predecessore per il fatto che la vita Clemente era poco conosciuta, che non ebbe mai un culto pubblico all’interno della Chiesa e che alcune delle sue dottrine erano, se non errate, almeno sospette. In tempi più recenti il favore nei confronti di Clemente si è accresciuto, vuoi per il suo affascinante stile letterario, vuoi per il suo attraente candore, vuoi per lo spirito coraggioso che lo rese un pioniere della teologia o per la sua inclinazione verso le speculazioni filosofiche. Il suo spirito era già moderno, inoltre, per l’epoca, era insolitamente colto: aveva una conoscenza completa dell’intera letteratura biblica e cristiana, delle opere sia ortodosse che eretiche; era versato nelle lettere ed aveva una eccellente conoscenza dei poeti e dei filosofi pagani, che amava citare e dei quali ha preservato un gran numero di frammenti di opere perdute. La mole di avvenimenti e citazioni raccolta e assemblata nelle sue opere è un evento eccezionale per l’antichità, sebbene non sia improbabile che utilizzase i florilegia (antologie) dai quali traeva brani di prima qualità. Per gli studiosi non è stato facile riassumere i punti principali degli insegnamenti di Clemente, infatti, mancava di precisione tecnica e non ricercò mai un’esposizione ordinata. È facile, perciò, mal giudicarlo. Attualmente, viene accettato il giudizio di Tixeront: le regole della fede di Clemente erano ortodosse; accettava l’autorità delle tradizioni della Chiesa, inoltre, prima di tutto, era un Cristiano che accettava “la legge ecclesiastica”, tuttavia, si sforzava anche di rimanere filosofo, e portava la speculazione sul perché della vita nelle materie religiose. “Sono pochi”, affermava “coloro i quali avendo fatto bottino dei tesori degli egiziani, ne fanno arredi per il Tabernacolo.” Egli si predispose, perciò, ad usare la filosofia come strumento per trasformare la fede in scienza, e la rivelazione in teologia. Gli gnostici già avevano affermato di possedere la scienza della fede, ma erano, piuttosto, meri razionalisti o puri sognatori. Clemente non aveva nulle, se non la fede come base per le sue speculazioni. Per questo motivo non può essere accusato di aver volontariamente sviluppato posizioni non ortodosse. Ma Clemente era un pioniere in un’impresa difficile e si deve ammettere che fallì nel suo alto intendimento. Era cauto nell’accostarsi alle Sacre Scritture per sviluppare la sua dottrina, tuttavia adoperò male il testo e ne uscì una esegesi difettosa. Aveva letto tutti i libri del Nuovo Testamento ad eccezione della Seconda lettera di Pietro e della Terza lettera di Giovanni. “Infatti”, dice Tixeront, i “suoi studi sulla forma primitiva delle scritture Apostoliche sono del valore più alto.” Sfortunatamente, interpretò le Sacre Scritture secondo lo stile di Filone, pronto a trovare allegorie dappertutto. I fatti narrati nell’Antico Testamento divennero, così, puramente simbolici. Tuttavia, non si permise tale ampia libertà col Nuovo Testamento. Lo speciale interesse che Clemente coltivava lo condusse ad insistere sulla differenza tra la fede del Cristiano ordinario e la scienza del perfetto, tanto che i suoi insegnamenti su questo punto sono proprio la sua caratteristica principale. Il Cristiano perfetto ha una comprensione particolare dei “grandi misteri” dell’uomo, della natura, della virtù, che il cristiano ordinario accetta senza comprendere. Ad alcuni è sembrato che Clemente esagerasse il valore morale della conoscenza religiosa; si deve tuttavia ricordare che non lodava la mera conoscenza fine a se stessa, ma la conoscenza che si trasformava in amore. È la perfezione cristiana che egli celebrava. Il cristiano perfetto, il vero gnostico, che Clemente amava descrivere, deve condurre una vita di calma inalterabile. E qui il pensiero clementino è indubbiamente intriso di Stoicismo. In questo caso, infatti, non stava realmente descrivendo il cristiano, con i suoi sentimenti e i suoi desideri sotto il dovuto controllo, ma l’ideale Stoico che ha sopito i suoi sentimenti. Il perfetto cristiano, quindi, doveva condurre una vita di devozione assoluta; l’amore nel suo cuore lo avrebbe dovuto incitare a vivere in una unione sempre più stretta con Dio attraverso la preghiera, a lavorare per la conversione delle anime, ad amare i suoi nemici e, persino, a sopportare il martirio stesso. Clemente fu anche un precursore della controversia Trinitaria. Insegnò che nella Divinità erano presenti tre Termini. Alcuni critici dubitano se li distinguesse come Persone, ma una attenta lettura delle sue opere lo prova. Il Secondo Termine della Trinità era il Verbo. Fozio credeva che Clemente professasse una molteplicità di Verbi mentre, in realtà, Clemente tratteggiava soltanto una distinzione tra l’attributo immanente dell’intelligenza del Padre Divino ed il Verbo fatto Persona che era il Figlio, eternamente generato ed in possesso di tutti gli attributi del Padre. Essi, insieme, erano un unico Dio. Fino a questo punto, infatti, questa nozione di unità proposta da Clemente sembrava avvicinarsi al Modalismo, o, addirittura all’errore opposto del Subordinazionismo. Ciò, tuttavia può essere spiegato altrimenti: Clemente dovrebbe essere giudicato, a differenza di quanto si fa generalmente con gli altri scrittori, non da una frase colta qui o là, ma dalla globalità dei suoi insegnamenti. Dello Spirito Santo non parlò molto e, quando si riferiva alla terza Persona della Trinità, si basava strettamente su quanto riportato dalle Sacre Scritture. Era, inoltre, un convinto assertore della duplice natura di Cristo. Cristo era l’Uomo-Dio che ci beneficia sia come Dio che come uomo. Clemente, evidentemente, vedeva Cristo come una Persona (il Verbo). Fozio accusava Clemente anche di Docetismo. Tuttavia, Clemente riconosceva chiaramente in Cristo un vero corpo, ma lo credeva immune dalle necessità comuni della vita, come mangiare e bere e pensava che l’anima di Cristo fosse esente dalle passioni, dalla gioia e dalla tristezza. Per questi motivi Clemente è considerato il primo gnostico cristiano. Per Clemente era problema essenziale mostrare come il cristianesimo fosse superiore a qualsiasi filosofia, tuttavia cercava anche di spiegare che nella fede cristiana era contenuto quanto di meglio la filosofia avesse prodotto prima di Cristo. Egli distingueva tra la funzione svolta dalla filosofia prima di Cristo e la funzione che avrebbe dovuto svolgere dopo di lui. Sottolineava come, attraverso la filosofia, fosse possibile avvicinarsi alla verità che comunque si sarebbe completata solo attraverso la rivelazione. Come San Giustino martire, Clemente individuava in in tutti gli uomini la presenza di una scintilla divina che permetteva di accedere alla fede. Secondo questa prospettiva, il cristianesimo appariva non come la negazione, bensì come il completamento della tradizione filosofica: esso non ha il carattere settario attribuito alle scuole filosofiche o ai gruppi gnostici, non è prerogativa di una minoranza, Dio chiama a sé tutti indistintamente. Questa lettura della fede attraverso la filosofia potrebbe essere stata scelta da Clemente per avvicinare le classi colte dell’Alessandria del suo tempo, presso le quali la filosofia godeva di molto prestigio.
OPERE: “Protrettico” (Protreptokos pros Ellenas) Il “Protrettico” o “Esortazione ai Greci” è un persuasivo appello alla Fede, scritto in un tono molto alto. In questa opera, Clemente cercava di dimostrare la trascendenza della religione cristiana mettendo in contrapposizione il Cristianesimo con l’abiezione dei riti pagani e con le vane speranze dei poeti e dei filosofi pagani. L’opera termina con la descrizione del Cristiano timorato di Dio. Questo scritto fu composto in risposta a coloro che predicavano quanto fosse sbagliato abbandonare l’antica religione. “Disposizioni” (Hypotyposeis): Si tratta di un’opera in otto libri in buona parte persi salvo alcuni frammenti in greco riportati da Eusebio di Cesarea, Ecumenio, San Massimo il Confessore, Giovanni Moschos e Fozio. Essa fu tradotta in latino da Tirannio Rufino con il titolo di Dispositiones. Secondo Zahn, un frammento in latino, Adumbrationes Clementis Alexandrini in epistolas canonicas, tradotto da Flavio Magno Aurelio Cassiodoro e depurato dai passaggi non ortodossi, riporta, in parte, il testo clementino. Eusebio descriveva le “Disposizioni” come un commentario compendiato con commenti dottrinali e storici sull’intera Bibbia e sui non canonici “Epistola di Barnaba” e “Apocalisse di Pietro”. Fozio che lo aveva anche letto, lo descriveva, invece, come una serie di chiarimenti sui testi biblici della Genesi, dell’Esodo, dei Salmi, dell’Ecclesiaste e delle epistole Paoline e cattoliche. Tuttavia aggiungeva che l’opera è buona, ma contiene anche delle “empietà e favole”, come l’eternità della materia, la molteplicità dei Verbi (Logoi), il docetismo e la metempsicosi. In ogni caso, alcuni studiosi più conservatori sono inclini a credere che Fozio abbia dato troppo rilievo agli errori di Clemente, qualunque essi fossero. Lo stile di Clemente, infatti, è difficoltoso, le sue opere sono piene di citazioni ed i suoi insegnamenti sono difficilmente riconducibili ad un corpus dottrinario unico. E questa opera primeva, essendo un commentario su parti isolate delle Sacre Scritture, dovette essere particolarmente soggetta a incomprensioni. Tuttavia, le sue opere superstiti mostrano Clemente in una luce migliore. “Miscellanea” (Stromateis) L’opera si compone di ben sette libri, dei quali i primi quattro sono antecedenti a quella successiva, il “Pedagogo”. Quando ebbe finito quest’ultimo lavoro, Clemente tornò alla “Miscellanea”, che non terminò mai. Le prime pagine dell’opera sono andate perdute, inoltre, ciò che è noto fin dai tempi di Eusebio come l’ottavo libro altro non è se non una raccolta di citazioni di filosofi pagani. È probabile, come ha suggerito von Annin, che Clemente intendesse avvalersi di questi materiali insieme ad estratti da Teodoto e dalla scuola valentiniana ed all’Eclogae Propheticae. Nella “Miscellanea” Clemente rinunciò ad ogni ordine e pianificazione. Egli comparava l’opera ad un prato dove tutti i generi di fiori crescono a caso, oppure ad una collina ombrosa o montagna su cui crescevano alberi di ogni genere. La sua analisi mostra che si trattava di una serie di appunti su argomenti vari, probabilmente note sulle sue lettura alla scuola. Tuttavia è il più completo dei lavori di Clemente. Lo scritto inizia con l’importanza della filosofia nella ricerca della conoscenza cristiana. In questa parte, forse voleva difendere il suo metodo scientifico dalla critica dei confratelli più conservatori. Nel proseguio Clemente dimostra come la fede è riferita alla conoscenza, ed enfatizza la superiorità della rivelazione sulla filosofia. La verità di Dio deve essere trovata nella rivelazione, un’altra sua parte può essere rinvenuta nella filosofia. È precipuo dovere del Cristiano non trascurare nulla. La scienza religiosa, dedotta dalla sua duplice fonte (rivelazione e filosofia) è anche elemento di perfezione, il Cristiano istruito (“il vero gnostico”) è il Cristiano perfetto. Colui che è asceso a questa quota è lontano dalla tentazione delle passioni; è unito a Dio, ed in un senso misterioso è uno con Lui. Tale era la linea di pensiero indicata nell’opera, che è piena di digressioni. Pedagogo (Paidagogos) È un trattato pratico in tre libri. Il suo scopo era quello di addestrare il Cristiano ad una vita disciplinata per divenire un Cristiano istruito. Nei tempi antichi il paedagogus era lo schiavo che era continuamente responsabile di un ragazzo, il suo compagno. Da lui dipendeva la formazione del carattere del ragazzo. Tale è l’ufficio della Parola Incarnata verso gli uomini. Nulla è troppo comune o banale per la cura del Pedagogo. La sua influenza ricade sui dettagli minuti della vita, sul modo di mangiare, di bere, di dormire, di vestire, di svagarsi ecc. Il tono morale di questo lavoro è gentile; molto bello è l’ideale di una vita trasfigurata descritta alla fine. Nelle edizioni successive delle opere di Clemente, il “Pedagogo” è seguito da due corti poemi, il secondo, dedicato al Pedagogo stesso, è opera di qualche pio lettore dell’opera; il primo, intitolato “Inno al Salvatore Cristo” (Hymnos tou Soteros Christou), nei manoscritti che lo contengono, viene attribuito a Clemente. L’inno potrebbe essere opera di Clemente (Bardenhewer), o antecedente, come il Gloria in excelsis Deo (Westcott).
ORIGENE

LA VITA
Origene, detto Adamanzio, l’“invincibile”, nacque ad Alessandria di Egitto nel 185 da genitori cristiani, primo di sette fratelli. Il padre, Leonida, morì martire quando Origene aveva circa diciassette o diciotto anni, sotto la persecuzione dell’imperatore Settimio Severo. Immediatamente dopo la morte del padre, poiché la sua era una famiglia numerosa e poiché ogni bene era stato sottratto loro dopo il martirio del padre, Origene fu costretto a darsi da fare per provvedere al sostentamento dei suoi cari e si dedicò interamente all’insegnamento delle lettere. Nel frattempo, ebbe comunque la possibilità di completare i suoi studi e la sua formazione presso la casa di una nobildonna, assieme ad un eretico, originario di Antiochia, in Siria, di nome Paolo. Insegnò per lungo tempo la grammatica, ma, essendo esperto anche di teologia e filosofia, fu incaricato dal vescovo di Alessandria di organizzare una vera e propria scuola, il famoso Didaskaleion. Tra il 203 e il 204 si occupò della composizione e della strutturazione della scuola alessandrina: affidò l’insegnamento dei corsi propedeutici e della grammatica per i catecumeni al caro amico, Eracla – il quale avrebbe poi diretto il Didaskaleion – ed egli si dedicò solamente all’insegnamento superiore dell’esegesi biblica e della teologia, proseguendo, nello stesso tempo, nel costante sostegno dei martiri. Tra il 210 e il 211 conobbe Ambrosio, un ricco alessandrino, convertito dalla gnosi valentiniana dallo stesso Origene: egli fu sempre una figura centrale nella produzione letteraria e filosofica di Origene – non solo, infatti, gli suggerì la stesura di sue moltissime opere, ma anzi mise a sua disposizione anche un copioso numero di stenografi e tachigrafi. In questo periodo, è attestato anche un viaggio di Origene a Roma, sotto il pontificato del vescovo Zefirino. Sotto l’impero di Caracalla, Origene andò in Arabia – in sua assenza, tuttavia, scoppiarono delle cruente persecuzioni ad Alessandria d’Egitto ed Origene non poté farvi ritorno. Per questa ragione, tra il 214 e il 216 trascorse moltissimo tempo in Palestina, ben accolto dal vescovo di Gerusalemme, Alessandro, e dal vescovo di Cesarea, Teoctisto. In questo periodo, sebbene egli non fosse stato ancora ordinato presbitero dal suo vescovo di riferimento, che era il vescovo di Alessandria, Demetrio, Alessandro di Gerusalemme e Teoctisto di Cesarea lo invitarono spesso a predicare ed insegnare presso le loro comunità. Demetrio, allora, impose ad Origene di tornare immediatamente ad Alessandria e quivi riprendere l’insegnamento e la guida del Didaskaleion. Tra il 217 e il 225 si dedica alla redazione e alla conclusione della maggioranza delle sue opere teologiche, esegetiche e dottrinali, come il Commento al Vangelo di Giovanni, il Commento ai Salmi, il Commento al Genesi, i Principi. Tra il 229 e il 230, mentre era tornato in Cesarea di Palestina, è ordinato presbitero da Teoctisto di Cesarea, il quale lo ammirava moltissimo. Tra il 230 e il 231, allora, il vescovo di Alessandria, Demetrio, convoca urgentemente un sinodo in cui l’ordinazione sacerdotale di Origene non venne riconosciuta ad Alessandria. Essendogli impedito di far ritorno ad Alessandria, Origene rimase quasi ininterrottamente dal 231 in poi a Cesarea: qui realizzò la maggioranza delle Omelie; l’Esortazione al martirio fu composta sotto la persecuzione di Massimino il Trace, imperatore dal 235 al 238, per i suoi allievi Ambrosio e Protocteto. Tra il 244 e il 245 partecipò ad importanti dispute teologiche: intervenne nel sinodo di Bostra, contro il vescovo Berillo e l’eresia patripassiana, al fianco di Alessandro di Gerusalemme e di Teoctisto di Cesarea; famosa è, inoltre, la sua Disputa con Eraclide ed una discussione sul tema della salvezza del diavolo con un cristiano alessandrino ad Efeso. A partire dal 246 si dedicò quasi interamente alla stesura del Commento al Vangelo di Matteo e del Contro Celso. Nel 250 l’imperatore Decio scatenò una furiosa persecuzione contro i cristiani: Origene fu catturato e torturato violentemente, ma sopravvisse alle sevizie e alla prigionia. Morì presso la città di Tiro intorno al 254.
L’ESEGESI: LETTERA E ALLEGORIA
Il metodo esegetico con cui Origene interpreta le sacre scritture è assolutamente nuovo e, tuttavia, fortemente debitore a Filone di Alessandria. Origene distingue, infatti, due livelli di interpretazione delle scritture: letterale ed allegorico. L’interpretazione letterale consiste nell’assunzione del significato puramente letterale del testo, ossia in ciò che il testo immediatamente ed esplicitamente dice; l’interpretazione spirituale, invece, consiste nell’assunzione di un significato spirituale, più profondo e nascosto nella lettera, che trascende la lettera e, tuttavia, nello stesso tempo, è inseparabilmente custodito in essa. Secondo Origene, generalmente ciascun passaggio delle scritture può essere interpretato sia secondo la lettera sia secondo l’allegoria, sia cioè secondo l’interpretazione letterale sia secondo l’interpretazione allegorica. Eppure, ci sono casi in cui è possibile applicare solamente l’interpretazione letterale e ci sono casi in cui è possibile applicare solamente l’interpretazione allegorica: non sempre, pertanto, le due interpretazioni coesistono. Ad esempio, quando in Gn. 2, 7 si dice che Dio modella la terra per creare Adamo e soffia nelle sue narici per dargli la vita, non si deve affatto pensare che ciò sia accaduto storicamente – non è possibile, cioè, applicare l’interpretazione letterale a questo passaggio: infatti, se Dio avesse effettivamente lavorato la terra e soffiato nell’uomo, allora sarebbe corporeo – ma questo è impossibile. Di questo passaggio non è possibile dare altra interpretazione se non quella allegorica. Allo stesso modo, per converso, ci sono passaggi dei quali non è possibile dare una interpretazione allegorica, ma letterale, storica. È il caso dei passaggi iniziali dei sinottici in cui si parla della nascita del Cristo, o della sua resurrezione: se, infatti, la nascita reale o la resurrezione di Gesù avessero un significato puramente simbolico o allegorico, e non storico e letterale, allora si potrebbe pensare che il Figlio di Dio sia venuto nella carne non in verità, ma in apparenza. In questo modo, si rischierebbe di cadere in un modello di cristologia doceta. Dunque, per Origene, non solo esistono due modi di interpretare la scrittura – lettera ed allegoria – ma ci sono passi della scrittura che possono avere una interpretazione solamente letterale – è il caso dell’inizio di Genesi – e ci sono passi della scrittura che possono avere una interpretazione solamente simbolico-allegorica – è il caso dei passi paralleli dei sinottici sulla nascita e sulla resurrezione del Cristo (onde evitare l’eresia doceta). Tuttavia – e questo è un motivo, tuttavia, già presente in Giustino – secondo Origene, oltre a queste due forme di esegesi del testo sacro, è possibile introdurre anche un terzo livello esegetico, la cosiddetta interpretazione tipologica o figurale dell’Antico e del Nuovo Testamento. L’introduzione da parte di Origene di questo terzo livello ermeneutico è essenziale nella polemica anti-marcionita. Marcione era un eretico dei primissimi secoli d.C., il quale sosteneva che il Dio dell’Antico Testamento, creatore crudele del mondo, fosse diverso dal Dio del Nuovo Testamento, Dio buono e Padre di Gesù Cristo, e per questa ragione, che l’Antico ed il Nuovo Testamento dovessero essere considerati due modelli teologici e due libri separati. Per contrastare questa posizione, molti autori cristiani antichi – tra cui lo stesso Origene – introducono il concetto di tipo: ci sono figure, episodi e personaggi dell’Antico Testamento che sono tipo di Cristo nel Nuovo Testamento e, se sono tipo del Cristo dei vangeli, sono comprensibili e pensabili solamente alla luce del Nuovo Testamento. Ad esempio, il sacrificio di Abele nell’Antico Testamento può essere considerato tipo del sacrificio dell’Agnello, ossia del Cristo, nel Nuovo Testamento; il Figlio dell’Uomo, che salverà dalla persecuzione del piccolo corno, nella visione di Daniele, nell’Antico Testamento, è tipo del Cristo, nel Nuovo Testamento, che verserà il suo sangue per la salvezza dell’umanità. Se, allora, numerosi passi – i cosiddetti passaggi cristologici – dell’Antico Testamento si inverano nella figura del Cristo del Nuovo Testamento, allora tra Antico e Nuovo Testamento sussiste un rapporto indisgiungibile e di continuità.
IL COMMENTO AL VANGELO DI GIOVANNI
Indubbiamente, il Commento al Vangelo di Giovanni è una delle opere più articolare e più concettualmente dense di Origene. Ambrosio, suo allievo convertito dalla scuola gnostica di Valentino, gli suggerì di scrivere un commento sistematico ed interlineare al quarto vangelo, per contrastare le interpretazioni gnostiche che circolavano su di esso a partire dal primo secolo, in particolare, l’interpretazione di Eracleone, delle scuola valentiniana. Origene scrisse la prima parte di questo commento ad Alessandria di Egitto e la seconda parte, in Palestina, a Cesarea. La redazione di quest’opera lo tenne impegnato per almeno dieci anni. Dell’opera, la quale doveva essere in ben trentadue libri, non ci è pervenuta la versione completa, ma solo alcuni libri e numerosissimi frammenti catenari, in particolare nella Filocalia, uno sterminato corpus di frammenti origeniani tradotto da Gregorio di Nissa, Gregorio di Nazianzo e Basilio Magno. Da ciò che di questo commento ci è pervenuto, tuttavia, è possibile ricostruire la sua teologia trinitaria: secondo Origene, esistono tre persone divine, ossia il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Origene chiama queste persone “ipostasi”, ossia “sussistenze”, e chiama, invece, l’unità delle persone divine “abisso” o, nei Principi, “inizio della trinità” o “natura della trinità” o “fondamento della trinità”. Innanzitutto, è particolarmente importante che Origene chiami l’unità delle tre persone divine “abisso”: infatti, nella letteratura gnostica e, in particolare, nell’Apocrifo di Giovanni, del quale abbiamo la principale e più dettagliata testimonianza nel Contro le eresie di Ireneo di Lione, l’“abisso” è un concetto essenziale, è il divino in quanto infinitamente trascende non solo il mondo sensibile, dal quale è necessariamente separato, ma anche la stessa successione di eoni in cui il divino stesso si articola. Il fatto che Origene usi l’espressione gnostica “abisso” per riferimento al concetto cristiano di “unità della trinità” è indicativo del dialettico rapporto che egli abbia con il pensiero e il linguaggio gnostico: da una parte, infatti, Origene si rende conto che prendere le distanze dal pensiero gnostico significa prendere le distanze anche dal linguaggio gnostico; dall’altra parte, però, non solo la teologia, ma lo stesso linguaggio teologico origeniano è attraversato da idee e termini centrali nella riflessione del primo gnosticismo. Un caso esemplare è, certamente, l’espressione “abisso”. Quanto alla relazione intradivina tra il Padre ed il Figlio – il Padre eternamente genera il Figlio ed il Figlio è eternamente generato dal Padre: il Figlio, pertanto, è coeterno al Padre. Se il Figlio non fosse eternamente generato dal Padre, se cioè Padre e Figlio non fossero co-eterni, allora ci sarebbe un tempo nel quale il Figlio non sia esistito e nel quale il Figlio non abbia partecipato della divinità del Padre. Ma questo è impossibile: il Figlio è dall’eternità generato dal Padre. Il Figlio, inoltre, è colui attraverso il quale Dio Padre crea il mondo, è cioè il “pensiero” di Dio, il “cosmo intellegibile”, l’insieme della totalità delle forme e delle idee con cui Dio crea il mondo reale. Se ciascun essere è creato da Dio Padre attraverso il Figlio, che è il Logos, allora ciascun essere custodisce dentro di sé l’immagine del Figlio, ossia una parte del Logos e solo grazie al fatto che possiede dentro di sé una parte del Logos, un “seme” del Logos, può ritornare a Dio Padre. In questo modo, Origene costruisce la sua “teologia del Logos” come “teologia dell’immagine”: il Figlio-Logos è immagine di Dio-Padre e, se ciascun essere è creato a immagine del Figlio-Logos, che è immagine di Dio-Padre, allora ciascun essere è immagine del Figlio-Logos, che è immagine di Dio-Padre – dunque, ciascun essere è immagine dell’immagine di Dio-Padre, indirettamente è immagine di Dio-Padre. Se ciascun essere partecipa del Figlio-Logos e se il Figlio-Logos partecipa di Dio-Padre, allora ciascun essere mediatamente partecipa anche di Dio-Padre. L’altro grande tema del Commento a Giovanni è il cosiddetto “subordinazionismo”: se il Figlio è eternamente generato dal Padre, allora il Figlio è “subordinato” al Padre, nel senso che la sua esistenza dipende dall’esistenza del Padre – se il Padre non esistesse, nemmeno il Figlio esisterebbe. Allo stesso modo, lo Spirito Santo, che è l’unità del Padre e del Figlio, in quanto la sua esistenza dipende dall’esistenza del Padre e del Figlio, è “subordinato” al Padre e al Figlio – se il Padre e il Figlio, per assurdo, non esistessero, nemmeno lo Spirito Santo esisterebbe. Nel Commento a Giovanni emergono diversi significati che Origene attribuisce al concetto di “Spirito”: 1) spirito in quanto unità delle persone divine – in questo senso lo “spirito di Dio” è essenzialmente la divinità che è comune alle tre persone della trinità; 2) spirito in quanto terza persona della trinità, ossia potenza divina deputata alla operazione della santificazione; 3) spirito in quanto unità di tutti gli esseri che, grazie alla loro partecipazione immediata del Figlio-Logos e mediata di Dio-Padre, tornano a Dio-Padre, ossia unità di tutti i santi. In quest’ultimo significato, Origene pensa lo “spirito” come “chiesa”, ossia come comunità degli uomini che vivono nella partecipazione a Dio.
IL COMMENTO AL CANTICO DEI CANTICI
Uno dei traduttori latini di Origene sostiene che se Origene aveva superato tutti gli altri autori cristiani dell’antichità con le sue opere, con il Commento al Cantico dei Cantici aveva indubbiamente superato se stesso. Il Cantico dei Cantici è uno dei testi più famosi e discussi dell’Antico Testamento. Associato spesso al libro della Sapienza, di matrice greca, ne condivide moltissimi temi di ispirazione chiaramente ellenistica – questa è la ragione per cui questo testo è sempre stato visto con un certo sospetto dalla cultura ebraica. Il tema centrale di questo scritto è un canto di amore di uno sposo e di una sposa. Secondo Origene, questo “canto di amore” tra i due sposi può essere interpretato almeno su tre livelli: 1) la sposa è l’anima umana e lo sposo è il Cristo – l’anima partecipa dentro di sé del Figlio-Logos e in questo modo, ha la possibilità di tornare a Dio e partecipare del Padre soltanto grazie alla mediazione del Figlio, ossia soltanto amando il Figlio-Logos che è dentro di sé; 2) la sposa è la chiesa e lo sposo è il Cristo – tutta la comunità cristiana ha la possibilità di salvarsi soltanto amando il Cristo, ossia vivendo secondo l’insegnamento delle sacre scritture e secondo il modello di Gesù; 3) la sposa è chiesa e lo sposo è Dio stesso – la comunità cristiana può conciliarsi con Dio soltanto attraverso la mediazione del Cristo. Inoltre, Origene sviluppa fortemente la distinzione tra una forma carnale di amore, che è detto eros, ed una forma spirituale di amore, che è detta agape: l’amore carnale nient’altro è se non l’amore per il corpo e del corpo; l’amore spirituale è l’amore per l’anima e dell’anima e la più alta forma di amore spirituale, a sua volta, è l’amore di Dio. Se amore è sempre amore di qualcosa di simile a colui che ama, allora l’amore spirituale null’altro è se non l’amore del divino, che è nell’anima umana, per il divino in assoluto, ossia Dio Padre, attraverso il Figlio-Logos.
LA RESURREZIONE.
Nei Principi Origene dice di essersi occupato del tema della resurrezione dell’anima e del corpo in altri testi. La tradizione non ci ha conservato degli scritti origeniani sulla resurrezione nient’altro se non pochi frammenti. L’argomento origeniano sulla resurrezione del corpo è articolato e, nello stesso tempo, uno dei più interessanti. Il mondo greco ha pensato la “resurrezione” come liberazione dell’anima dal corpo: l’anima, in vita, è costretta entro i limiti del corpo; dopo la morte, finalmente si libera dal corpo e ha la possibilità di tornare all’assoluta divinità. Nel mondo cristiano, in particolare in Paolo, la resurrezione non può essere pensata più solamente come immortalità dell’anima, ma anche come resurrezione del corpo. Infatti, nei vangeli, il Cristo risorge non solo come anima, ma anche come corpo. Il primo argomento di Origene sulla resurrezione del corpo è lo stesso di Atenagora di Atene: è impossibile dire che dopo la morte solo l’anima risorga – infatti, l’uomo è unità di anima e corpo, perciò, se vive nel bene, è l’unità di anima e corpo a vivere nel bene, se vive nel male, è l’unità di anima e corpo a vivere nel male. Pertanto, è necessario che dopo la morte, se l’unità di anima e corpo ha vissuto nel bene, sia premiata sia l’anima sia il corpo; se, invece, l’unità di anima e corpo ha vissuto nel male, è necessario che sia punita sia l’anima sia il corpo. L’altro argomento di Origene è il seguente: la resurrezione del corpo non può essere pensata come l’atto con il corruttibile diviene incorruttibile. Infatti, se così fosse, se cioè la resurrezione del corpo fosse il farsi incorruttibile da parte del corruttibile, sarebbe auto-contraddittoria e, quindi, impossibile: infatti, è impossibile che il corruttibile sia anche il suo opposto, l’incorruttibile. Se allora la resurrezione del corpo non può essere pensata in questi termini, allora deve esserci – secondo Origene – un “sostrato” o “soggetto” comune al corruttibile e all’incorruttibile, che, in questa vita, è corruttibile e, dopo la morte, diviene incorruttibile. Questo “soggetto” o “sostrato” comune è il “corpo”. Secondo Origene, la resurrezione è l’atto con cui il corpo, prima, è corruttibile, ossia corpo materiale, e poi è incorruttibile, ossia corpo spirituale o etereo. Infatti, in questo modo, la contraddizione che si origina dall’attribuzione di predicati contraddittori allo stesso soggetto nello stesso tempo è rimossa: il corpo, prima, è materiale e, poi, è spirituale – ad esso, dunque, possono essere attribuiti predicati contraddittori in tempi diversi.
IL CONTRO CELSO
Il Contro Celso è indubbiamente una delle più articolate opere apologetiche di Origene. Il testo è stato scritto in polemica con il platonico Celso che, tuttavia, Origene accusa di essere epicureo. Il principale argomento di Celso, contro il quale Origene dibatte lungamente, è l’impossibilità dell’incarnazione reale del Figlio di Dio, ossia l’impossibilità che il divino possa farsi umano – infatti, se Dio è perfetto, è impossibile che possa rinunciare alla sua propria divinità e perfezione per accogliere in sé l’imperfezione dell’umanità. Pertanto, secondo Celso, o è impossibile che Dio si sia incarnato nel Figlio oppure, se si ammette l’incarnazione, non può trattarsi di un’incarnazione “in verità”, ma solo “in apparenza” – l’incarnazione del Figlio non sarebbe cioè vera e propria. La risposta di Origene è la seguente: a Dio, in quanto è onnipotente, niente è impossibile – la potenza di Dio è talmente infinita ed illimitata da abbracciare anche la negazione di sé in quanto Dio, da essere cioè anche uomo. La divinità di Dio è talmente infinita ed onnipotente da rinunciare finanche a se stessa ed accogliere dentro di sé l’umanità. È molto interessante che, nonostante Origene sapesse che l’argomento di Celso fosse un argomento di chiara provenienza platonica, lo definisca “epicureo”. Si possono addurre almeno due ragioni che giustificherebbero questo giudizio: 1) Origene non può considerare l’argomento di Celso come platonico, nella misura in cui la stessa architettura filosofica e concettuale della sua teologia è platonica – rifiutare l’argomento di Celso come platonico significherebbe, quindi, mettere in discussione gli stessi concetti fondamentali su cui si fonda la teologia del Logos; 2) Origene eredita l’interpretazione di Clemente Alessandrino di At. 17, 22-31, ossia del discorso di Paolo all’Areopago di Atene – secondo Clemente, gli epicurei furono coloro che non riuscirono a comprendere le parole dell’apostolo.
I PRINCIPI
L’opera più sistematica che ci sia pervenuta di Origene è il trattato sui Principi. Il testo si compone di quattro libri, dei quali i primi due ci sono pervenuti solamente nella traduzione latina di Rufino o attraverso passi paralleli di Girolamo e Giustiniano, mentre degli ultimi due libri ci è pervenuta sia la traduzione latina sia la versione originale greca, tradotta tra i frammenti della Filocalia. Il fatto che la maggioranza del testo ci sia pervenuta non nell’originale greco, ma piuttosto nella traduzione latina di Rufino è un aspetto molto significato da un punto di vista ermeneutico: infatti, Rufino non si limita affatto ad una traduzione puramente letterale del testo di Origene, ma traduce la versione greca originale facendo in modo tale che il pensiero di Origene sia conforme e coerente con le posizioni teologiche e dottrinali dell’età dei Concili. Questo significa che è veramente difficile ricostruire la posizione originaria ed autentica di Origene solamente sulla base del testo che ci è stato trasmesso da Rufino e che, piuttosto, è necessario un serrato confronto dei frammenti greci che ci sono stati tradotti con il testo latino e con altre testimonianze indirette per avere un’idea più precisa e rigorosa del pensiero vero e proprio di Origene, nascosto dietro la traduzione latina che abbiamo. Nel primo libro, Origene si occupa della trinità, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, della relazione tra le divine persone, delle nature angeliche, della creazione del mondo e della apocatastasi, ossia della “ricostituzione finale di tutte le cose”; nel secondo libro, il tema principale è l’incarnazione del Logos, la creazione del mondo, la realizzazione delle promesse dell’Antico Testamento nella figura del Cristo del Nuovo Testamento; nel terzo libro, invece, il tema centrale è il libero arbitrio dell’anima individuale; nel quarto ed ultimo libro, infine, Origene si occupa essenzialmente di formulare sistematicamente i principi esegetici, ossia le modalità attraverso le quali sia possibile leggere la sacra scrittura, in particolare, riprendendo Paolo, della interpretazione “secondo la lettera” e “secondo lo spirito” ed introduce anche il criterio dell’interpretazione figurale o tipologica, che lega i due testamenti.
COMMENTO AL VANGELO DI MATTEO
Il Commento al Vangelo di Matteo è la sistematica analisi di Origene dei passaggi nei quali compare esplicitamente la definizione del Cristo come “re” e “Signore” e attraverso i quali è effettivamente possibile una ricostruzione del concetto stesso di “Regno del Figlio”. L’idea di Origene è che il Figlio è, per sua propria natura, “re” e “Signore”, allora all’età del Figlio corrisponde necessariamente un regno del Figlio: se il Figlio è «immagine del Dio invisibile» (Col 1, 16), se il Figlio è immagine di Dio, allora il regno del Figlio nient’altro è se non l’insieme di tutte le creature e di tutti gli esseri che si fanno ad immagine del Figlio, che è immagine di Dio. Se il Logos, seconda persona della trinità, è immagine di Dio Padre, allora gli esseri che sono ad immagine dell’immagine del Logos, gli esseri cioè che si fanno perfetta immagine del Logos, che è immagine di Dio, costituiscono il regno del Figlio. Le figure del Vangelo di Matteo che Origene affronta nel suo commento sono quella della rete, del tesoro e della perla, dello scriba del Regno dei cieli, dei due debitori, degli operai nella vigna e degli invitati al banchetto. Ciascun essere, secondo Origene, in quanto è stato creato attraverso il Figlio da Dio, è in se stesso immagine di Dio: tutti gli esseri, in quanto sono stati creati dal Logos, sono da sempre immagine del Logos; tuttavia, solo quegli esseri che vivono nel bene e facendosi perfetta immagine ed imitazione del Figlio, ossia facendo esattamente lo stesso che ha fatto il Figlio, diventano vera e perfetta imitazione del Figlio, ossia abitano il suo regno. Inoltre, l’analisi sistematica delle parabole e delle immagini regali del Vangelo di Matteo consente ad Origene di sviluppare anche una riflessione relativamente al concetto stesso di parabola e all’articolato rapporto tra immagine e realtà. Innanzitutto, secondo Origene, esiste una irriducibile asimmetria tra immagine e realtà, nel senso che né l’immagine dice perfettamente la realtà, né la realtà è mai perfettamente rappresentata dall’immagine: da una parte, infatti, la realtà è sempre più dell’immagine, pertanto, qualunque sia l’immagine che si dia della realtà, la realtà mai è perfettamente rappresentata da essa; dall’altra parte, l’immagine è sempre meno della realtà e mai è in grado di dirla perfettamente. Inoltre, secondo Origene, il fatto che l’immagine non sia in grado di dire perfettamente la realtà implica che l’immagine possa avere una molteplicità di significati: perciò, comprendere un’immagine significa che cercare di comprendere tutti i suoi diversi significati. L’immagine stessa rimanda alla polisemia dei suoi significati, che è la sua stessa natura. La parabola, allora, secondo questa interpretazione dell’immagine e della relazione tra immagine e realtà, nient’altro è se non quell’immagine che, avendo molti significati, deve essere interpretata secondo diversi livelli. Per Origene, quasi tutte le parabole del Nuovo Testamento e, in particolare, del Vangelo di Matteo, hanno una loro interpretazione e spiegazione all’interno del testo stesso, ma spesso è il lettore che, di volta in volta, ha da trovarne i diversi sensi.
OMELIE SUL VANGELO DI LUCA
Si tratta di un ciclo di omelie che Origene dedica interamente al Vangelo di Luca. È indubbiamente una delle fonti più rigorose e più sistematiche attraverso le quali sia effettivamente possibile una ricostruzione della ermeneutica origeniana. Innanzitutto, Origene distingue tra un livello letterale ed un spirituale del testo: il livello spirituale è evidentemente il significato immediato ed esplicito del testo; il livello spirituale, invece, è il significato profondo ed intimo della scrittura, che non è immediatamente comprensibile. Inoltre, egli distingue anche tra tre livelli di lettura della scrittura, sulla base, chiaramente, dei diversi livelli di cui la scrittura stessa si compone: l’interpretazione letterale della scrittura, ossia la comprensione del significato immediatamente letterale ed esplicito del testo; l’interpretazione spirituale, che consiste nella comprensione del significato spirituale e profondo della scrittura; infine, l’interpretazione morale, ossia la comprensione della prescrizione morale o del significato pratico che un passaggio della scrittura comunica. Origene chiama l’interpretazione letterale, ossia il primo livello di interpretazione, che corrisponde al contenuto più esterno della scrittura, “interpretazione somatica”; chiama il secondo livello, ossia l’interpretazione spirituale, che corrisponde al livello più profondo e nascosto della scrittura, “interpretazione pneumatica”; infine, chiama il terzo livello, che corrisponde al significato pratico o morale della scrittura, “interpretazione psichica”. La tripartizione di Origene è evidentemente in polemica con la divisione gnostica delle nature in psichica, pneumatica ed ilica.
DIONE DI PRUSA (CRISOSTOMO)

Nato da una famiglia di elevato ceto sociale nella città di Prusa in Bitinia, Dione si formò, dapprima, negli studi letterari ed esordì come retore e scrisse addirittura un’opera contro i filosofi in generale e una contro Musonio in particolare. A Roma ebbe dimestichezza con uomini di alto rango e, a motivo degli stretti legami di amicizia che ebbe con Flavio Sabino, fu condannato all’esilio, allorché costui fu sospetta-to di complottare contro l’imperatore Domiziano. Bandito dalla Bitinia e dall’Italia, costretto a peregrinare in paesi inospitali e a guadagnarsi i mezzi di sostentamento con i lavori più umili, privato di tutto ciò che aveva riempito e allietato la sua vita passata, seppe trovare la sua vocazione di fondo proprio a causa della sollecitazione di queste avverse circostanze, e divenne così «filosofo». Egli riscoprì in tal modo la validità di quella filosofia che nell’esser privato di tutto e nel condurre una vita di «primitivi» additava, contro la comune opinione, il più autentico bene. Dione nacque, probabilmente, nell’ultimo decennio della prima metà del secolo I d.C. Il soprannome Crisostomo, che vuol dire «Bocca d’oro», gli derivò dalla sua abilità nel parlare e dalla sua suadente eloquenza. Il suo esilio durò dall’82 d.C. all’uccisione di Domiziano, ossia fino al 96 d.C. Ebbe buoni rapporti con Traiano (98-117), alla cui presenza pronunciò alcuni dei suoi discorsi. Di Dione ci è pervenuto un complesso di ottanta orazioni, in cui predomina la forma letteraria della diatriba. Che lo stesso Diogene fosse diventato filosofo perché esiliato e privato di tutto era una convinzione comunemente condivisa. Ecco come Dione stesso, in una pagina esemplare, descrive la propria conversione alla filosofia cinica:
“Gli uomini che mi incontravano mi guardavano e mi giudicavano, alcuni un vagabondo, altri, un mendicante, alcuni, invece, un filosofo. Di qui, a poco a poco, mi venne il nome di filosofo, senza che io lo volessi e che me ne vantassi. Molti dei cosiddetti filosofi, infatti, si proclamano tali loro stessi, proprio come gli araldi alle Olimpiadi proclamano i vincitori; per quanto mi riguarda, invece, essendo gli altri a darmi questo nome, non potevo sempre oppormi a tutti quanti. Anzi, mi accadde di ricevere un certo beneficio da quel nome. Infatti molti venivano da me e mi chiedevano che cosa io ritenessi che fossero il bene e il male. Di conseguenza, io fui costretto a meditare intorno a queste cose, per poter rispondere a quanti mi ponevano quei quesiti. Inoltre, mi invitavano a presentarmi e a parlare in pubblico. Fui così costretto a parlare sui doveri degli uomini e su ciò che, a mio parere, giova ad essi. Mi formai allora la convinzione che tutti, per così dire, fossero sconsiderati e che nessuno facesse ciò che doveva fare né considerasse come potesse liberarsi dai mali che li affliggono, dalla grande ignoranza e dalla confusione e come potesse vivere una vita più conveniente e più virtuosa, essendo tutti quanti agitati e trascinati nello stesso luogo e intorno alle stesse cose, ossia intorno alle ricchezze, alla reputazione e a certi piaceri corporei, senza che nessuno di essi fosse capace di affrancarsi da queste cose e liberare la propria anima, proprio come cose che cadono in un vortice, son fatte roteare e son trascinate in circolo senza potersi liberare da esso”.
Gli scritti di Dione che risalgono a questo periodo dell’esilio ripetono i capisaldi della dottrina cinica, e, in essi, la figura di Diogene predomina incontrastata. Questi scritti esaltano in modo particolare la potenza liberatrice del verbo di Diogene, ribadiscono la validità della tavola cinica dei valori, ridifendono certi aspetti della cinica “anaideia” e sottolineano marcatamente l’importanza della lotta contro il piacere. Ecco un significativo stralcio dal Discorso sulla virtù:
“Un tale domandò a Diogene se egli pure fosse venuto per vedere i giochi ed egli rispose: «No, ma per prendervi parte anch’io». Quegli si mise a ridere e domandò quali fossero i suoi avversari. E Diogene, guardandolo di sotto in su, come era solito, disse: «I più pericolosi e i più difficili da vincere ed ai quali nessuno dei Greci sa resistere; non sono però avversari che corrono, lottano, saltano, combattono col pugilato, lanciano il disco o il giavellotto, ma quelli che fanno rinsavire gli uomini». « E chi sono?», domandò. «Sono le fatiche, rispose, le più rudi e non superabili dagli uomini ben sazi di cibi e pieni dei fumi dell’orgoglio, che passano tutte le loro giornate a mangiare e le loro notti a russare, ma che sono abbattuti da uomini sottili e magri, i cui ventri son più sottili di quello delle vespe. O tu credi che questi grossi ventri servano a qualcosa, questi individui che coloro che hanno buon senso dovrebbero menare attorno, purificare e poi cacciare, o piuttosto immolare, fare a pezzi e poi mangiare. Come si fa con la carne dei grandi pesci, che si fanno cuocere nel sale e nell’acqua marina, per far sciogliere il grasso, come fanno da noi nel Ponto col lardo dei maiali quelli che vogliono ungersi. Infatti io credo che costoro abbiano meno anima dei maiali. Invece l’uomo probo ritiene che le fatiche siano i suoi maggiori avversari e con questi ambisce battersi notte e giorno, non per ottenere un ramo di appio, come le capre, né un ramo di ulivo o di pinoma per ottenere la felicità e la virtù per tutta la vita».”
Questi avversari, precisa Dione, vanno attaccati con estrema decisione, come si fa con il fuoco, che, se aggredito senza esitazione, può essere spento, se no ha un sicuro sopravvento. Ma l’avversario di gran lunga peggiore, anche per Dione così come per gli antichi Cinici, è il piacere, il quale non usa la forza ma l’astuzia e seduce con funesti farmaci, come fece la maga Circe di cui parla Omero, la quale attrasse in questo modo i compagni di Ulisse, per poi trasformarli in porci e animali selvaggi. Il piacere ci minaccia in tutti i modi possibili, perfino durante il sonno, mediante sogni insidiosi. Per difendersi dal piacere è necessario stare lontano il più possibile da esso o avere commercio con esso solo per lo stretto necessario. Perciò conclude Dione:
“Un uomo veramente forte è davvero veramente tale, quando è capace di fuggire il più possibile lontano dai piaceri: infatti non è possibile frequentare il piacere e farne esperienza durante un periodo di tempo, senza esserne rovinati. Non appena ha il sopravvento e vince l’anima con i suoi filtri, subito fanno seguito gli effetti prodotti dalla maga Circe”.
Alla morte di Domiziano Dione tornò a Roma, e con la fine dell’esilio ebbe termine anche la sua «vita cinica»; la sua stessa visione filosofica si allargò, sussumendo numerosi concetti stoici e perfino alcune suggestioni platoniche. Risente ancora di forti influssi cinici l’orazione che reca il titolo “Euboico”, in cui si narra di una famiglia di cacciatori, la quale lontano dalla città, a contatto con la natura, vive serenamente, soddisfacendo solamente ai bisogni più elementari ed essenziali, senza desideri del superfluo e senza vane ambizioni, e realizza, in questo modo, pur senza saperlo, la vita ideale. Dione non ha dubbi che il vivere in povertà e non in mezzo alla ricchezza rappresenti il “vivere conforme a natura”. Sulla base di questa concezione di carattere squisitamente morale egli propone la soluzione del problema sociale della povertà dei ceti inferiori, che nelle grandi città diventava vieppiù preoccupante: bisognerebbe far uscire dalla città quelli che egli definisce i «poveri rispettabili», ossia quei poveri che conducono una vita onesta, portarli a vivere nelle campagne, e qui insegnare loro a procacciarsi i mezzi di sostentamento nel modo più naturale. È indubbio che Dione intendeva presentare questo programma non solo a scopo teorico, ma proprio come concreta soluzione dei gravi problemi sociali del momento storico in cui viveva. Un altro gruppo di scritti di carattere politico composti nel periodo posteriore all’esilio rispecchia ancora idee ciniche, fatte però rientrare nella più ampia prospettiva stoica della monarchia universale di cui è re Zeus. Il governo ideale è, per Dione, quello monarchico, e il monarca ideale è il migliore degli uomini, l’uomo più virtuoso. Leggiamo nella “Orazione IV”, dove i protagonisti sono Diogene (portavoce di Dione) e Alessandro (che probabilmente rappresenta, in qualche modo, l’imperatore Traiano, cui il discorso è rivolto):
“Allora Alessandro chiese a Diogene: «In che modo si dovrebbe esercitare l’arte regia nella maniera migliore?». Diogene lo guardò severamente di sotto in su e rispose: «Non si può esercitare l’arte regia in modo malvagio più di quanto non si può essere un malvagio onest’uomo! Infatti il re è il migliore degli uomini, il più coraggioso, il più giusto, il più umano, ed è invincibile rispetto ad ogni fatica e ad ogni desiderio»”.
Il re deve essere un «pastore di popoli», secondo il celebre detto di Omero, e deve essere l’imitatore del più grande di tutti i re, vale a dire del Re che governa l’Universo intero, ossia di Zeus. Leggiamo, per esempio, nella “Orazione I”: “Tra i re, dal momento che, come credo, essi ricevono da Zeus il loro potere e la loro funzione, quello che, guardando a Zeus, ordina e governa con giustizia e con bontà conformemente alla legge e al volere di Zeus, ha una buona sorte e una fine propizia”. E poco prima Dione precisa: “Il Re primo e supremo devono sempre imitare i mortali e coloro che governano le cose degli uomini nell’assolvere alle loro responsabilità, su quello, per quanto è possibile, regolando e a quello assimilando il proprio modo di agire”. Piegano invece decisamente verso le dottrine della Stoà l’Orazione XXXVI (dal titolo Boristenico), che contiene una vera e propria cosmologia stoica, e l’Orazione XII (dal titolo Olimpico), che dimostra come l’idea di Dio sia innata in tutti gli uomini, Greci o barbari che siano. Anche in Dione, come nel parallelo Neostoicismo, compare l’idea della «parentela» e del «legame naturale» che unisce gli uomini agli Dei, e quindi l’idea della fratellanza di tutti gli uomini. Come nel parallelo movimento Medioplatonico, in Dione compare non solo l’idea già sopra indicata che gli uomini devono «imitare Dio» e «assimilarsi a lui», ma addirittura la dottrina che il «Dèmone dell’uomo» è il suo nous, il suo «intelletto»:
“I demoni buoni e cattivi, i quali portano la sfortuna e la fortuna, non stanno al di fuori dell’uomo: l’intelletto che è proprio di ciascun uomo, questo è il Dèmone dell’uomo che lo possiede: il Dèmone di un uomo saggio e buono è buono, malvagio quello di un uomo malvagio, e, così, libero è quello di un uomo libero, schiavo quello di un uomo schiavo, regale quello di un uomo regale e magnanimo, miserabile è quello di un uomo miserabile e vile”.
LUCIANO DI SAMOSATA

LA VITA
Nato presumibilmente nel 120 d.C. a Samosata (capoluogo della Commagene di Siria), Luciano si accostò "dall’esterno" alla cultura greca, apprendendo la lingua greca a scuola. Nell’opera autobiografica Sogno, egli racconta di un fallito tentativo dei suoi genitori di avviarlo alla statuaria presso un loro parente scultore: non appena entrato nella bottega di costui, Luciano, impugnato lo scalpello, mandò in frantumi un blocco di marmo. La punizione inflittagli dal parente pose fine alla carriera scultorea di Luciano, che potè dunque dedicarsi a tempo pieno agli studi di retorica che gli fecero conoscere alla perfezione il greco e la letteratura da Omero in poi. A questo periodo risale il suo avvicinamento a quel movimento costituente la moda dell’epoca che era la "seconda sofistica": al pari degli altri sofisti, anche Luciano iniziò un incessante peregrinare che lo portò presso le città dell’Asia Minore, dell’Italia e della Gallia. Tra il 155 e il 160 d.C., dopo essere rientrato ad Atene, egli compì ulteriori viaggi che lo portarono forse nuovamente a Roma e sicuramente ad Antiochia, dove ebbe modo di conoscere l’imperatore Lucio Vero. Rientrato per breve tempo a Samosata, si trasferì definitivamente ad Atene, sua patria adottiva, dalla quale dovette poi allontanarsi perché chiamato dal prefetto di Egitto ad amministrare quella regione in qualità di archistator praefecti Aegypti (una sorta di cancelliere): tale incarico rivela le prestigiose amicizie che Luciano aveva stretto in quel torno di anni. Dimessosi per motivi politici nel 175, ritornò ad Atene e, da questo momento, perdiamo le sue tracce: senz’ombra di dubbio la sua morte va collocata dopo la fine del regno di Marco Aurelio e, pertanto, avvenne dopo il 180 d.C. Il lessico Suda tramanda che Luciano sarebbe stato sbranato da una muta di cani – sorte riservata agli atei (già Euripide ne era stato colpito) -, ma la notizia risulta poco attendibile.
IL PERIODO SOFISTICO
La figura di Luciano di Samosata si inserisce nella cornice della "
Seconda Sofistica", quel movimento culturale fiorito nei primi decenni di vita dell’impero romano e caratterizzato dalla mercificazione della parola, dal virtuosismo retorico e dall’abbandono di quei temi filosofici che stavano alla base della "Prima Sofistica" (quella che trovava in Gorgia e Protagora i suoi eroi): se la "Prima Sofistica" non solo non aveva rigettato la filosofia, ma anzi l’aveva posta al cuore della propria riflessione, la "Seconda Sofistica", dal canto suo, la ripudia completamente, preferendo un’oratoria sgargiante ed estremamente rifinita, costellata di paignia ("scherzi") consistenti spesso in futili e paradossali elogi (in questo genere va inscritto L’elogio della mosca di Luciano, opera nella quale egli riabilita il fastidioso insetto); interamente votati ad una vuota ars dicendi in cui a contare è esclusivamente la forma, i numerosi esponenti della "Seconda Sofistica" (Dione di Prusa, Favorino di Arles, Erode Attico, Elio Aristide, Claudio Eliano, Filostrato) non tardano a rivelare tutti i limiti della loro attività (un vuoto verbalismo barocco volto a destar la meraviglia nell’uditorio) e la netta inferiorità rispetto a quella "Prima Sofistica" che tanto peso ebbe nella vita filosofica della Grecia del V secolo a.C. E in effetti in Luciano troviamo tutti gli elementi portanti della nuova corrente di pensiero. Tuttavia egli si interessa di sofistica solamente in una prima fase della propria attività, in seguito ai lunghi viaggi che lo portarono a Roma, in Asia minore, in Egitto e in Gallia: frutto di tali interessi successivi al suo girovagare per il mondo sono le numerose meletai, ovvero gli esercizi retorici consistenti in declamazioni altisonanti e roboanti: risalgono a questo periodo il Tirannicida (al centro del quale troviamo un tale che uccide il figlio di un tiranno e, dopo che il tiranno stesso si è tolto la vita per il dolore, chiede un premio come tirannicida), il Diseredato (in cui un medico, diseredato dal padre impazzito, guarisce il genitore, che però lo disereda nuovamente per il suo rifiuto a guarire la matrigna, impazzita anch’ella), i due Falaridi (discorsi che accompagnavano il celebre toro di bronzo, donato dal tremendo tiranno Falaride a Delfi), il succitato Elogio della mosca e l’esilarante Tribunale delle vocali (davanti alla giuria delle vocali la consonante Sigma querela il Tau per le prevaricazioni di cui questo si è reso responsabile nel dialetto attico). Oltre alle , Luciano compone anche alcune prolaliai (o anche dialexeiV), ossia delle "chiacchierate" che introducevano alla recitazione e che di norma erano volte ad ingraziarsi il pubblico: tali erano l’Erodoto, Scita, Zeusi e – risalenti ad un periodo più tardo – Sulla dipsade (serpente velenoso della Libia il cui morso provoca un’arsura inestinguibile, come la sete che Luciano ha di pubblico), Bacco ed Eracle: in quest’ultima "chiacchierata" è descritta vivacemente una raffigurazione, vista in Gallia, del dio in sembianze di vecchio canuto. Ben presto però (a partire dallo scritto Due volte accusato), Luciano prenderà le distanze dalla sofistica: ciò non toglie, comunque, che essa lascerà in lui un retaggio imprescindibile, che costituirà la base del suo modo di far filosofia. In particolare, egli non si staccherà mai da quella dialettica implicante il contrapporsi di posizioni opposte (i classici dissoi logoi sofistici), da quel gradevole umorismo spesso coniugato con una satira pungente che ereditò dalla frequentazione dell’arte sofistica. Tuttavia, il fatto che l’Eracle risalga ad una fase della maturità di Luciano fa pensare che egli possa aver ripreso contatti con la sofistica.L’ALLONTANAMENTO DALLA SOFISTICA E LA SCOPERTA DELLA FILOSOFIA
L’abbandono della Sofistica avviene quando Luciano ha ormai quasi quarant’anni, com’egli stesso racconta nel Due volte accusato: quest’opera costituisce un imprescindibile punto cardinale nella riflessione del pensatore di Samosata, in quanto segna il passaggio dalla sofistica alla filosofia. Dietro l’indiavolata finzione di un processo intentato a Luciano sull’Acropoli di Atene dalla Retorica e dal Dialogo platonico, che lo accusano l’una di averlo abbandonato e l’altro di averlo stravolto e contaminato con la satira, veniamo a conoscenza dei motivi che inducono Luciano a cambiar rotta: la Retorica "non era più una donna per bene e non aveva più il decoro che portava ai tempi di Demostene, che se la sposò, ma ormai si conciava come una sgualdrina, tutta trucco e belletto", tanto più che l’irrequieto spirito di Luciano non poteva più sentirsi appagato dalla frequentazione di "tiranni, encomi e principi" e doveva dedicarsi a qualcosa di più elevato. In forza di ciò, egli si risolse a "divorziare" dalla Retorica e ad accostarsi al Dialogo (ovvero alla filosofia), lontano dalle lodi, dai rumorosi applausi e dalle "chiassate" caratterizzanti la sofistica: ciò non significa, tuttavia, ch’egli intendesse dedicarsi alla filosofia in maniera tradizionale, ed è appunto per via della sua concezione assolutamente originale e mai percorsa prima che il Dialogo lo accusa aspramente (forse anche più della Retorica). All’abbandono della sofistica, Luciano fece seguire alcuni scritti irriverenti in cui la metteva alla berlina, rivelandone i limiti e le contraddizioni: così nell’epistola Precettore dei retori (indirizzata fittiziamente ad un giovane) egli inscena una sarcastica descrizione dell’istruzione retorica; nello Pseudosofista invece egli fa una dura tirata contro un sofista che si vanta di saper riconoscere gli errori linguistici ma che, messo alla prova, fallisce miseramente. Occorre però prestare attenzione a non farsi trarre in inganno: il rigetto della Retorica in Luciano non si traduce in un’automatica "conversione" alla Filosofia, nei confronti della quale egli è anzi sempre un severo critico (riconoscendole più difetti che pregi); è piuttosto corretto affermare che l’irrequietezza che percorre lo spirito di Luciano lo porta a cercare nella Filosofia ciò che non era stato in grado di rinvenire nella Retorica: ma anche la Filosofia delude le attese di Luciano, tant’è che egli non appoggerà mai nessuna Scuola (pur provando di volta in volta simpatie e aperture verso certe scuole di pensiero – in primis l’epicureismo e la scuola cinica – e una costante insofferenza per lo stoicismo) né abbraccerà alcun credo filosofico. Originariamente deluso dal vuoto e capzioso verbalismo fine a se stesso di una Retorica incapace di risolvere i problemi concreti in cui l’uomo si trova impigliato, Luciano non tarderà a restare parimenti deluso dalla Filosofia, la quale, pur proponendosi (e qui sta il reale discrimine rispetto alla Retorica) di risolvere problemi concreti, finisce poi per tradursi in un desolante universo di sistemi contrastanti tra loro e uno più astratto dell’altro, tradendo in tal maniera i propri propositi. Essa, anziché offrire certezze in grado di diradare i dubbi martellanti che albergano nell’animo umano, finisce per destarne di nuovi: ciò è innanzitutto provato dal pullulare di teorie e sistemi che affollano lo scenario filosofico e che, in perpetuo contrasto fra loro, pongono l’uomo in un labirinto da cui egli è poi impossibilitato ad uscire. L’avvicinamento di Luciano alla filosofia avviene, oltrechè in virtù dello scontento in lui prodotto dalla Retorica, grazie all’incontro a Roma col platonico Nigrino, che verrà posto al centro di un dialogo (il Nigrino appunto) in cui Roma, ormai devastata dalla corruzione e dall’opulenza, è contrapposta ad un’Atene ideale ed eterna. Luciano affida la propria produzione a opuscoli irriverenti, a dialoghi esilaranti, a romanzi fantastici (anticipando, in ciò, Cyrano de Bergerac), da cui sempre traspare la stretta relazione intrattenuta con la satira e con la sofisticai: così, nell’Ermotimo (che degli opuscoli a carattere filosofico è il meno insolente) Luciano si fa portavoce di quella profonda insofferenza per il dogmatismo rigoristico degli Stoici che lo accompagnerà per tutta la vita. Nelle Vite d’incanto si immagina che Zeus venda al miglior offerente le diverse vite filosofiche, quali quella epicurea, quella scettica, quella peripatetica, quella pitagorica, ecc. Nel Pescatore Luciano – sotto lo pseudonimo di Parresiade (la
parrhsia era la "libertà d’espressione" di cui faceva professione il cinico Diogene di Sinope) – viene raggiunto dai filosofi da lui dileggiati nelle Vite d’incanto, ai quali Zeus ha concesso di far ritorno per un giorno sulla terra: viene pertanto istituito un processo al cospetto della Filosofia, ma Luciano viene assolto perché dimostra che era sua intenzione smascherare i ciarlatani che hanno continuato, a fin di lucro, l’insegnamento degli antichi maestri. Per questa via, proprio il Dialogo, che con Platone aveva fatto raggiungere al pensiero greco i suoi momenti più intensi ed elevati, diventa ora tra le mani dell’irriverente Luciano uno strumento agile e brioso – oltrechè gradevole e divertente – non già per condurre argomentazioni sull’immortalità dell’anima o sulla giustizia ideale, bensì per liquidare i principi filosofici e le sette filosofiche che ad essi fanno capo, tutte accusate di essersi intorpidite in pesanti e rigidi apparati concettuali che mal si attagliano ad una realtà babelica e spaesante – lungi dall’essere ordinata e teleologica, come la supponevano Aristotele e Platone – quale la intende Luciano. Gli dei stessi – che in quanto uomini all’ennesima potenza presentano gli stessi difetti dell’uomo, ma all’ennesima potenza – divengono il bersaglio dei dissacranti dialoghi di Luciano. Convolato a giuste nozze col dialogo, Luciano non lo lascerà mai, per tutta la sua produzione letteraria: in tale forma letteraria sono composti i celebri ventisei Dialoghi sugli dei e i quindici Dialoghi marini, in cui i miti tradizionali vengono rielaborati dalla fervida fantasia di Luciano, che attraverso di essi ci offre incantevoli scenette di vita quotidiana dei protagonisti (niente poco di meno che gli dei dell’Olimpo e quelli degli abissi marini); stessa forma presentano i quindici Dialoghi delle cortigiane, al cui centro troviamo, con un’ironia tenue e leggera, quei personaggi femminili già portati in scena dalla commedia "nuova" di Menandro. Di genere diametralmente opposto sono poi i trenta Dialoghi dei morti, nei quali la satira religiosa (sempre al centro della produzione di Luciano) e la lucidissima critica dei troppi luoghi comuni (l’importanza dei beni terreni, il valore della bellezza, ecc) costituiscono gli argomenti principe; il tutto è ravvivato dall’indiavolata presenza del celeberrimo filosofo cinico Menippo di Gadara (del III secolo a.C.), qui raffigurato – morto tra i morti – nell’atto di gettar scompiglio tra gli inquilini dell’Ade col suo irrinunciabile nichilismo. La stessa memorabile figura di Menippo troviamo nell’Icaromenippo e nel Menippo: nel primo, il filosofo cinico compie un incredibile viaggio in cielo al fine di rendersi personalmente conto della conformazione del cielo, poiché poco persuaso dalle numerose e confusionarie teorie formulate in merito dai filosofi; nel secondo, invece, egli scende agli Inferi col pretesto di chiedere all’indovino Tiresia quale vita sia preferibile vivere: la risposta è che la migliore è quella dell’uomo comune. Con questa sorprendente risposta, Luciano non fa che calcare le orme di Platone e del suo mito di Er (Repubblica, X). L’attenzione da Luciano rivolta a Menippeo può essere spiegata facendo riferimento all’ininterrotta battaglia da questi condotta per smascherare e smitizzare i falsi filosofi che si atteggiano come oracolari detentori della verità: proprio l’avversione palese di Luciano per ogni forma di dogmatismo che si dica possessore della verità è il punto di incontro della battaglia che egli intenta contro la religione e contro la filosofia cristallizzata in sistemi infinitamente lontani dal reale. Anziché risolvere i problemi concreti che gli sbarrano la strada, l’uomo preferisce alzare lo sguardo verso i cieli dell’Olimpo o verso i nebbiosi cieli della metafisica che, introducendo parole roboanti ma fondamentalmente prive di significato, finisce per creare ulteriore confusione (al pari della Retorica) in un mondo in cui la confusione domina già di suo. Il sarcasmo lucianeo verso le teorie delle diverse scuole filosofiche e verso il dogmatismo in cui è impantanata la religione diventa feroce e irrisorio nell’opuscolo redatto in forma epistolare Morte di Peregrino: Peregrino era un filosofo cinico assai noto (Aulo Gellio, VIII, 3; XII, 11) che Luciano conobbe occasionalmente mentre stava rientrando dall’Oriente ad Atene. Costui decise di suicidarsi platealmente dandosi fuoco ad Olimpia durante i Giochi del 165 d.C., e appunto a qualche anno dopo risale l’opuscolo di Luciano, dal quale traspaiono parecchie allusioni satiriche al fanatismo dei Cristiani (partorito, ancora una volta, da quel dogmatismo che pretende di stringere in pugno la verità). Negli Schiavi fuggitivi Zeus si lamenta per via del fetore che il rogo di Peregrino ha fatto salire fino alle vette dell’Olimpo, finchè non giunge la Filosofia sdegnata dei tanti filosofi impostori che maldestramente vorrebbero imitare Menippeo o Diogene e, calatasi sulla terra, sorprende quei ribaldi in sembianze di schiavi fuggitivi e li riporta dai rispettivi padroni. Nell’Eunuco, Diocle e l’eunuco Bagoa – entrambi appartenenti alla schiera degli Aristotelici – litigano aspramente dinanzi a una giuria di eminenti Ateniesi per l’assegnazione della cattedra di filosofia. Ci si domanda se un eunuco possa degnamente rivestire il prestigioso ufficio, ma ad un certo punto qualcuno dei presenti propone che ci si sinceri che Bagoa sia realmente eunuco. La lotta di Luciano contro il dogmatismo religioso si appunta, oltrechè sul cristianesimo, sulla religione dei Greci stessi: in questa cornice rientrano tre dialoghi dissacranti e insolenti scritti contro Zeus: in Zeus confutato, il padre degli dei si trova in inestricabili difficoltà di fronte alle argomentazioni di un tal Cinisco, indaffarato a dimostrare sia l’inutilità degli dei, in quanto meri esecutori della volontà della Moira, sia la falsità delle credenze relative ai premi e castighi che attendono le anime dopo la morte (stoccata al cristianesimo e al platonismo). In Zeus tragedo, Zeus cerca di far prevalere l’opinione dello stoico Timocle in un dibattito con l’epicureo Damide; quest’ultimo pare aver la meglio, ma il confronto degenera in zuffa, sotto gli occhi degli dei incapaci di riportare l’ordine. Infine, nel Concilio degli dei, il protagonista Momo (il "Biasimo", nume allegorico), in un’assemblea divina lamenta che troppi abitanti dell’Olimpo non siano equipaggiati dei requisiti necessari per essere considerati realmente dei: sicchè Zeus decide una verifica e il risultato è che molti inquilini della sacra dimora (fra cui Ganimede e Dioniso) sono da considerarsi abusivi: l’aspetto paradossale è che Zeus stesso è un abusivo! Di contro all’astrattezza della filosofia e della religione, Luciano ha a cuore i problemi concreti che travagliano gli uomini: così nei Saturnali – risalenti alla produzione tarda dello scrittore – egli prende spunto dalle festività in onore del Dio Saturno (durante le quali si praticava per un giorno l’appianamento delle disuguaglianze sociali e gli schiavi sedevano a tavola coi padroni) per fare delle amare riflessioni sulle ingiustizie sociali gravanti sulla società del tempo, in cui le ricchezze sono concentrate nelle mani di pochi (e malvagi), mentre i più (e buoni) sono condannati a vivere nella miseria. Sempre all’anzianità di Luciano risale l’Apologia, un discorso di genere giudiziario redatto poco prima che Luciano accettasse l’incarico in Egitto: essa si configura come una palinodia dell’opuscolo scritto parecchi anni prima Su coloro che vengono assunti per mercede, in cui l’autore tentava di dissuadere gli intellettuali greci dall’accettare incarichi umilianti, anche se ben retribuiti, presso le case romane. Nell’Apologia, ora che Luciano sente la necessità di giustificarsi poiché è lui in prima persona a non disdegnare un ben remunerato ufficio al soldo di Roma, si difende sofisticamente (e in maniera davvero poco persuasiva) distinguendo fra chi si umilia al servizio di una casa privata e chi, come lui, si presta ad un servizio pubblico, nell’espletamento del quale può certamente essere utile a città e popoli. Gli interessi di Luciano orbitano anche intorno alla storia e, soprattutto, intorno al modo di scriverla: sotto forma di breve trattato, egli compone una lettera su Come si deve scrivere la storia, in cui si schiera contro coloro che si attribuiscono la qualifica di storici senza realmente essere tali; il vero storico, dal canto suo, è tenuto ad essere obiettivo e fedele nella narrazione degli accadimenti storici, senza far trasparire le proprie opinioni. Sembrerebbero smentire in toto la tesi di un Luciano "concreto" e accanito rivale di chi – i filosofi e i religiosi, ma anche i sedicenti storici – si allontana dal vero i due libri in cui si articola il romanzo fantastico Storia vera, in cui, nella cornice di un’avventura incredibile e coinvolgente, l’autore racconta di un suo viaggio tra mille peripezie che l’han portato sulla luna, nella pancia di una balena, nella terra del ghiaccio e in moltissime altre lande sperdute. In realtà, dietro la finzione di questo viaggio incredibile, Luciano ci sta trasmettendo nitidamente un messaggio chiarissimo: la realtà, lungi dal presentarsi come un Tutto disciplinato in cui ad ogni causa segue un determinato effetto e in cui ogni cosa è stata posta da un Divino artefice in vista di qualcos’altro (questa era la dottrina dei Platonici, ma l’idea di un kosmoV ordinato era presente in pressoché tutte le scuole filosofiche), si configura come un caotico guazzabuglio irrazionale di eventi privi di significato e tali da non poter mai essere padroneggiati dalla ragione umana, quella tremenda facoltà con la quale i filosofi pretendono di rinvenire un ordine laddove esso manca. In maniera volutamente esagerata, con parecchi secoli d’anticipo rispetto all’Ariosto dell’Orlando furioso, Luciano mette magnificamente in luce come il mondo in cui ci troviamo a vivere sia il terribile regno del caos: nell’introduzione all’opera, tuttavia, Luciano sostiene filantropicamente che essa è stata redatta al fine di far riposare la mente del lettore ed ha come intento quello di parodiare sia i falsi discorsi dei poeti e degli storici sia – soprattutto – le elucubrazioni dei filosofi, che hanno scritto di cose mai viste spacciandole per verità assolute; sicchè l’autore ci avverte fin dalle prime pagine: "in una sola cosa dirò la verità, nel riconoscere che dirò unicamente menzogne". Ma egli sembra anche suggerirci, per via sotterranea, che con tale premessa egli è molto più corretto di filosofi e religiosi, i quali, pur dicendo anch’essi esclusivamente menzogne, non si premurano di avvisare il loro uditorio e anzi le fan passare per solenni verità. E così il viaggio di Luciano sulla luna o il suo ingresso nella pancia della balena saranno falsi non meno della dottrina delle Idee elaborata da Platone o di quella del LogoV universale partorita dalla mente degli Stoici, con l’aggravante che questi sedicenti filosofi eran convinti di aver colto la verità. Parimenti debbono essere disprezzati i poeti, anch’essi trasudanti dogmatismo: la conclusione cui perviene Luciano – con la solita dose di ironia – è che gli uomini sono soliti fare affidamento sui versi di Omero, poeta che "descriveva quel che c’era in cielo, ma che non poteva nemmeno vedere quel che c’era sulla terra". Ma sarebbe sbagliato limitarsi a leggere il Luciano della Storia vera (o, meglio, delle Storie vere) come mero confutatore del carattere veritativo che la filosofia e la religione falsamente si attribuiscono: quel mondo pervaso dalla follia e dall’assurdo ch’egli tratteggia con l’abile mano dello scrittore di satire non è poi così lontano dal vero mondo, in cui è possibile imbattersi in uomini imbevuti di fanatismo o in gente che si dà fuoco, un mondo insomma dove le regioni padroneggiate dalla ragione sono davvero poche. La trama dell’opera è particolarmente movimentata, ma proveremo a percorrerla sinteticamente: una tempesta solleva in cielo la nave su cui Luciano e cinquanta suoi compagni erano partiti dalle colonne di Ercole. Pervenuti così nell’isola delle Donne-viti, vengono trasportati da un’altra tempesta sulla luna, dove sono costretti a partecipare alla guerra fra Seleniti (abitanti della luna) ed Elioti (abitanti del sole). La nave riesce infine a scendere sul mare, ma una balena la inghiotte con tutto l’equipaggio superstite. In qualche maniera Luciano e compagni riescono a uccidere il cetaceo e a venirne fuori e così riprendono la navigazione che li conduce sul mar Ghiacciato. Allo scioglimento di questo, costeggiano svariate isole, come quella dei Tori e del Formaggio, e giungono alla terra dei Beati. Odisseo, che lì dimora, ne approfitta per affidare loro una lettera da recapitare a Calipso, presso cui la nave giunge dopo una lunga sosta. Lasciata anche la ninfa, l’equipaggio si imbatte in avventure ancora più strabilianti, quali l’assalto dei Zucchipirati e dei Nocinauti, l’attraversamento di un bosco marino, l’assalto dei Bucefali, l’incontro con gli Uomini-nave e altre ancora. Dopo tante peripezie, Luciano e i suoi compagni giungono agli Antipodi della terra, ma la distruzione della nave li obbliga ad approdarvi a nuoto. Vicenda altrettanto fantastica rispetto a quella della Storia vera è quella narrata in Lucio o l’asino (ammesso che si tratti di un’opera effettivamente attribuibile a Luciano: i dubbi in merito sono molti): un tale di nome Lucio, mentre sta incautamente armeggiando con alcuni filtri aiutato dall’ancella di una maga, viene repentinamente trasformato in asino, sebbene egli intendesse tramutarsi in uccello. Per poter riassumere le sembianze di uomo, egli si trova costretto ad affrontare una caterva di mirabolanti avventure e peripezie. L’argomento della trasformazione in asino era già stato trattato (stando alla testimonianza di Fozio) da un certo Lucio di Patre – la cui opera (Metamorfosi) tuttavia non ci è giunta – e sarà ripreso, in ambito latino, dallo stesso Apuleio.IL PENSIERO DI LUCIANO
Troppo spesso presentato semplicemente come esponente della Seconda Sofistica o come narratore di romanzi esilaranti, in Luciano si è raramente ravvisato un ingegno filosofico non di second’ordine, ancorché egli si serva della filosofia per liquidare la filosofia stessa: questa – al suo sguardo lungimirante – pecca di astrattezza e di dogmatismo, giacchè – anziché, se non risolvere, almeno affrontare le tematiche che travagliano l’uomo di tutti i giorni – si è arroccata dietro rigidi sistemi infinitamente lontani dalla realtà e implicanti una sorta di fede in cose mai esperite. Ciò è, in definitiva, quel che accomuna filosofia e religione (Luciano ha soprattutto in mente quella cristiana), immancabilmente tendenti a cristallizzarsi in dogmi e, in forza di ciò, a tacitare la voce della ragione: con l’espediente del riso demolitore, Luciano mette sapientemente in evidenza come quelli che vengono acclamati come "filosofi" altro non sono se non ciarlatani e mistificatori che sciorinano il loro presunto sapere in sistemi risolventisi in cumuli di fandonie. Di qui il ruolo preminentemente distruttivo che assume il filosofare di Luciano: egli filosofa per distruggere i filosofi – cosa in cui si rivela abilissimo -, ma quando poi si tratta di edificare sistemi alternativi a quelli aborriti, egli tace, rivelando in ciò una totale incapacità di proporre alternative valide. Già il patriarca Fozio aveva pienamente colto questo bifrontismo del pensiero lucianeo, in virtù del quale il filosofo di Samosata demolisce i sistemi di pensiero altrui senza però proporne di troppi: in tal senso, non sorprende il fatto che Fozio esprima un giudizio incontrovertibilmente negativo su di lui, giudicandolo un uomo senza rispetto di nulla e abile solo a contestare col suo riso beffardo le opinioni altrui ma incapace di proporne una e di prenderla veramente sul serio, "a meno che non si voglia dire che la sua opinione è quella di non avere opinioni" (e, in effetti, parecchi sono gli indizi di una sostanziale adesione di Luciano allo Scetticismo). La filosofia come viene intesa da Luciano pare allora configurarsi come un’instancabile attività di demistificazione e di abbattimento dei pregiudizi (religiosi e filosofici) che affollano le menti degli uomini: tale sarà, del resto, il compito che Nietzsche stesso attribuirà a se stesso in quanto filosofo in Ecce homo. Ma è forse possibile far tabula rasa di pregiudizi e opinioni senza poi introdurne di nuovi? Eliminate le opinioni, si dovrà dunque vivere senza di esse, come quel Pirrone di Elide che, liberatosi delle opinioni, si lasciava cadere nei precipizi e investire dai carri nell’impossibilità di opinare se ciò fosse un bene o un male? Qui risiede, francamente, il lato debole della prospettiva lucianea, pur così lucida nel ridicolizzare gli insensati luoghi comuni che ci accompagnano nell’agire senza che noi nemmeno ce ne accorgiamo. L’adesione di Luciano agli ammaestramenti epicurei e a quelli cinici (in particolare l’entusiasmo per la figura di Menippo) dev’essere a tal proposito intesa come un momentaneo traviamento del suo spirito troppo corrosivo per adagiarsi sui dogmi dei sistemi filosofici. Oltrechè dall’avversione verso il dogmatismo in sé, la polemica di Luciano nei confronti della filosofia trae origine anche dalla constatazione della sua sostanziale inutilità: di tutti i quesiti che essa ha sollevato nel corso dei secoli, a quanti ha definitivamente trovato una risposta? A nessuno, risponde ironicamente Luciano; al che gli si potrebbe obiettare – con Bobbio – che forse l’ufficio della filosofia consiste appunto nel mettere a fuoco i problemi, non nell’eliminarli. Se Aristotele (Protrettico; Metafisica, I) non si stanca mai di esaltare la superiorità della filosofia facendo leva sulla sua inutilità (proprio dalla constatazione ch’essa non serva a nulla se ne deduce che è la suprema delle scienze, poiché sciolta dal vincolo di servitù), Luciano la condanna in quanto inutile: per quanto ricca di una secolare esperienza, non è riuscita a fornire risposte chiare ed esaurienti, ma ha solo generato ulteriore confusione e ha partorito i tanti imbroglioni che si vendono per filosofi, senza in realtà essere addivenuti ad alcuna risposta concreta. Eppure Luciano – consapevole o no – nel momento in cui mette al muro la filosofia, sta filosofando, avvalorando l’assunto aristotelico dell’impossibilità di non fare filosofia (se si fa filosofia, si filosofa; e se si dimostra che non si deve far filosofia, si filosofa ugualmente). In maniera sotterranea, dietro ai riflessi abbaglianti delle sue molteplici opere (tutte orbitanti intorno agli stessi concetti di fondo: ripudio del dogmatismo, della religione, della filosofia, ecc ), Luciano ci sta suggerendo che se la filosofia mai è addivenuta a risultati convincenti, ciò è dovuto alla connaturata debolezza della nostra ragione (a Luciano sono debitori Montaigne e il "pensiero debole" di Vattimo), incapace di far presa su una realtà magmatica e sfuggente, caotica e inafferrabile, per sua natura renitente a farsi disciplinare dall’attività ordinatrice della ragione. Ne segue – così pare dirci Luciano – che una vita trascorsa in meditazioni è una vita non vissuta: sicchè, al lavoro intellettuale ed inconcludente dei filosofi, Luciano contrappone l’esistere dell’uomo comune (nel Menippo), che cavalca l’onda degli accadimenti mondani vivendo fino in fondo la vita e accettandola per quella che è, anche nei suoi aspetti più paradossali (un viaggio sulla luna o nella pancia di una balena, ad esempio): di qui l’accettazione – seppur parziale e momentanea – dell’epicureismo. Sempre nell’ambito della "distruttività" del filosofare lucianeo va annoverata la denuncia delle storture dilaganti all’epoca: in particolare (nei Saturnali) l’invettiva contro le disuguaglianze sociali che andavano sempre più inasprendosi; ancora una volta, però, Luciano diagnostica il male ma non sa proporre la cura: sicchè la sua è e resta una filosofia demolitrice ma non propositiva, venata da un certo pessimismo che impedisce all’autore di spingersi al di là della semplice constatazione dell’ingiustizia imperante nel mondo; dopo aver interpretato e criticato la realtà, egli non si rivela in grado di trasformarla, anche perché non provvisto di un disegno alternativo su cui modellarla. Sarebbe del resto da stolti ribellarsi ad un mondo in cui la volontà umana e, con essa, ogni singolo avvenimento dipendono direttamente da quella capricciosa e imperscrutabile entità che è la
Tuch: nel Menippo, Luciano ci esibisce un’icastica raffigurazione di ciò, descrivendo la vita umana come un corteo di maschere guidato dalla Tuch, che prima attribuisce a caso ai partecipanti certe qualifiche e i relativi abbigliamenti (da re, da schiavo, da nobile) e poi si diverte a scambiare di tanto in tanto e senza ragione il costume che essa stessa ha dato loro, trasformando improvvisamente chi è re in uno schiavo o viceversa. Solo la morte – e non l’operare dell’uomo – potrà appianare le disuguaglianze sociali che lacerano il mondo, distribuendo quella dose di giustizia e di parità che sulla terra manca. Gli dei stessi sono il frutto, oltre che della superstizione e del dogmatismo, dell’asservimento a cui l’uomo è condannato: avvezzo alle disuguaglianze nella società, egli non ha fatto che potenziarle e renderle insite alla natura stessa inventandosi gli dei come entità consustanzialmente superiori, di fronte ai quali l’uomo è tenuto a chinare il capo e a mostrare rispetto. E proprio contro gli abitanti dell’Olimpo Luciano scaglia i suoi dardi più velenosi: nello Zeus confutato il padre degli dei non riesce a reggere al fuoco della confutazione di chi gli fa notare l’inutilità degli dei e nel Concilio degli dei si arriva addirittura a sostenere che Zeus è un abusivo. Ha acutamente notato Karl Marx che "la storia è radicale e attraversa parecchie fasi quando vuole seppellire una vecchia forma sociale. L’ultima fase di una forma storica è la commedia. Gli dei della Grecia, tragicamente feriti a morte nel ‘Prometeo incatenato’ di Eschilo, dovettero subire una seconda morte, la morte comica nei ‘Dialoghi’ di Luciano…perché l’umanità si separi serenamente dal suo passato" (Per la critica della filosofia del diritto di Hegel).DEMONATTE
“Errare è degli uomini; ma sollevare chi è caduto in errore è di un Dio, o di un uomo simile a un Dio “.
Demonatte fu esponente della corrente radicale del Cinismo; egli fu contemporaneo di Enomao. Per la verità, Demonatte temperò, in alcuni punti, certi eccessi del Cinismo: “non falsava i suoi costumi e le maniere per essere ammirato”, ci riferisce Luciano, ossia per attirare su di sé ostentatamente l’attenzione della gente, e, in particolare, non si abbandonava a gesti estremistici tipici della cinica “anaideia”.
D’altra parte, egli espressamente confessava di non ammirare solamente Diogene, ma di rispettare Socrate e di amare Aristippo. Studiò anche il pensiero di altri filosofi e non in modo superficiale; cosa, questa, non comune fra i Cinici. Dal Cinismo trasse, in primo luogo, il grande amore per la libertà e il “franco parlare”, e nella “libertà” fece consistere la felicità. Ecco alcune significative testimonianze di Luciano:
Demonatte […] spregiò tutti i beni umani, non volle altro mai che essere libero e liberamente parlare. (Epitteto, Diatribe, III, 22, 45-54)
Uno gli domandò in che riponeva egli la felicità. Rispose: “Solo l’uomo libero è felice”. E quegli: “Ce n’è tanti liberi!”. Ed egli: “Per me è libero chi non teme né spera nulla”. E colui: “Ma come ci può essere costui, se tutti siamo servi di queste due passioni?”. Ed egli: “Se consideri le cose umane, troverai che per esse non si deve né sperare né temere, perché passano tutte e le piacevoli e le spiacevoli”.
Anche il suo atteggiamento nei confronti della religione pubblica, dei misteri e delle credenze circa l’anima e le sue sorti nell’aldilà fu in piena sintonia con il radicalismo cinico e, anzi, proprio per questo fu accusato e chiamato in giudizio, sulla base dell’accusa formale di non essere mai stato visto sacrificare agli Dei e di non essere mai stato iniziato ai misteri eleusini. Dall’accusa egli si difese brillantemente, sostenendo, in primo luogo, che gli Dei non hanno bisogno dei sacrifici degli uomini, e, per quanto concerne i misteri, sostenendo che egli non avrebbe in alcun caso potuto rispettarli e non parlarne ai non iniziati: infatti se gli fossero sembrati cattivi, lo avrebbe rivelato per distogliere i non iniziati da cose cattive, e se gli si fossero rivelati buoni ne avrebbe parlato a tutti per amore dell’umanità. Circa le sue opinioni intorno all’immortalità dell’anima e alle sue sorti ecco quanto Luciano riferisce:
Uno gli domandava se l’anima è immortale. “È immortale come ogni altra cosa” egli rispose.
Gli domandò alcuno: “Che cosa credi che ci sia nell’inferno?”. “Attendi che io vi sia – rispose – e di là te ne scriverò”.
Anche il culto dell’esercizio e della fatica fu da lui ribadito e fu esaltata l’autarchia.
Demonatte riprese, inoltre, la componente filantropica del cinismo, che, prima di lui, soprattutto Cratete aveva saputo far valere. Scrive Luciano a questo riguardo:
Non fu mai veduto gridare, contendere, adirarsi, neppure se doveva sgridare qualcuno: riprendeva i vizi, ma perdonava ai viziosi, e diceva doversi imitare i medici che curano le malattie, e non si sdegnano con gli ammalati. Credeva appunto che errare è degli uomini: ma sollevare chi è caduto nell’errore è di un Dio, o di un uomo simile ad un Dio.
E ancora:
Cercava di rappacificare i fratelli discordi, di mettere pace tra le mogli ed i mariti, e talvolta nelle dissensioni dei popolo parlò opportunamente, e persuase la moltitudine a fare il bene della patria. Di questa natura era la sua filosofia, dolce, amabile, allegra. Solamente lo addolorava la malattia o la morte di un amico perché stimava l’amicizia il maggior bene degli uomini: e perciò egli era l’amico di tutti, e teneva per prossimo chiunque era uomo.
E infine:
Visse intorno ai cent’anni senza malori, senza dolori, non importunando alcuno, né chiedendo nulla, utile agli amici, senza aver mai un nemico. Tanto amore avevano per lui gli Ateniesi e tutti i Greci, che quando egli passava, i magistrati si alzavano in piedi, e tutti si tacevano. Essendo assai innanzi negli anni spesso gii avveniva d’entrare a caso in un’abitazione, e ivi mangiava e dormiva, e la gente di quella casa credeva che fosse comparso un dio, e che fosse entrato un buon genio in casa loro.
PEREGRINO PROTEO
Di Peregrino (detto Proteo per sua stessa volontà) siamo informati con ampiezza, così come di Demonatte, solo da Luciano, ma con una narrazione di segno opposto.
Luciano tesse di Demonatte un vero panegirico con l’espresso intento di additarlo come esempio, mentre contro Peregrino scrive un libello, con l’espresso intento di esporlo al pubblico ludibrio. Quanto Luciano ecceda nell’idealizzare il primo e nel vilipendere il secondo è difficile dire. Pare certo che quel poco che Gellio (Noct. Att., XII, 11) ci riferisce di Peregrino (da lui ascoltato ad Atene) sembra di ben altro tenore. Peregrino presenta la più impensabile fusione di religiosità, o meglio di misticismo, e di radicalismo anarchico tipicamente cinico, unito ad una buona dose di spirito di avventura. Caduto in sospetto di parricidio, dovette lasciare la città natale e si recò in Palestina. Luciano dice che Peregrino aveva strangolato il padre “non volendo farlo andare oltre i sessant’anni” e che il suo allontanamento dalla patria fu un’autocondanna all’esilio.
In Palestina egli si legò ai Cristiani, di cui sembrò condividere le dottrine, e anzi scrisse “molti libri” su queste dottrine. Per essere stato uno dei personaggi più in vista dei Cristiani – o comunque considerato tale – fu gettato in carcere, la qualcosa gli procurò grande fama e autorità presso i Cristiani. Luciano non crede assolutamente che Peregrino aderisse in buona fede alla religione cristiana e scrive testualmente:
Così Peregrino, sotto il pretesto del carcere, ebbe da loro molte ricchezze, e si fece non piccola provvisionc per l’avvenire. Poiché credono questi sciagurati [scil: i Cristiani] che essi saranno immortali e vivranno nell’eternità; e perciò sprezzano la morte, e volentieri le vanno incontro. E poi il loro primo legislatore li persuade che sono tutti fratelli tra loro: e come si sono convertiti, rinnegano gli Dei dei Greci, adorano quel sapiente crocifisso, e vivono secondo le sue leggi. Per la qual cosa disprezzano tutti i beni ugualmente, e li credono comuni, e non se ne curano quando li hanno. Perciò se tra loro sorgesse un accorto impostore che sapesse ben maneggiarli, tosto diventerebbe ricco, canzonando questa gente credula e sciocca. (Della morte di Peregrino, 13)
Liberato dal proconsole, Peregrino tornò in patria, dove, dice sempre Luciano, per evitare un processo, essendo ancora vivi gli sdegni per la morte dei padre a lui imputata, lasciò al popolo le sostanze rimastegli. E, poiché si presentò all’adunanza col tipico acconciamento cinico – lunga chioma, mantello sbrindellato, bisaccia sulle spalle e bastone in mano –, il popolo lo salutò come vero filosofo seguace di Diogene e di Cratete. Egli tornò allora a vagare, ricevendo ancora l’appoggio dei Cristiani, che, però, dopo qualche tempo, lo abbandonarono. Luciano vuol fare credere che la causa della rottura sia stata l’aver mangiato “qualche cibo vietato”, ma dal modo in cui lo dice dimostra di essere proprio lui il primo a non crederci. Dopo aver cercato invano di riavere le sostanze lasciate al popolo, Peregrino si recò in Egitto, presso il Cinico Agatobulo, per addottorarsi – dice Luciano con ironia – nella dottrina che insegna a masturbarsi in pubblico sostenendo che è “cosa indifferente” (è questa una tipica manifestazione dell’”anaideia” cinica). Fu quindi in Italia, donde fu cacciato – dice Luciano –, perché si sbracciò a dire male di tutti, approfittando astutamente dell’indulgenza dell’imperatore; i suoi seguaci dissero, invece, che fu cacciato per il suo parlare franco e ardito, proprio dei Cinici. Tornato in Grecia – dice sempre Luciano – continuò ad esercitare la sua malalingua, fino a che, venuto in dispregio a tutti, decise di darsi la morte volontaria sul rogo in occasione dei giochi olimpici, desideroso di far parlare di sé a tutti i costi e di guadagnarsi fama presso i posteri. Peregrino e i suoi seguaci addussero, naturalmente, ben altre motivazioni: la morte sul rogo doveva servire al bene degli uomini, cioè per insegnare loro a disprezzare la morte e a sopportare i tormenti. Per la verità, sappiamo che il modello che Peregrino intendeva imitare era, oltre quello di Ercole, quello dei saggi indiani, nel cui modo di pensare e di vivere già il Cinico Onesicrito – che aveva partecipato alla spedizione di Alessandro in Oriente – aveva ravvisato strette analogie con quello dei Cinici. Riferisce sempre Luciano, il quale poté assistere di persona al rogo, che queste furono le precise parole di Peregrino:
Egli diceva che ad una vita d’oro voleva mettere una corona d’oro: esser vissuto come Ercole, voler morire come Ercole, e “vanire nell’aere”. “Voglio” diceva “fare un gran bene agli uomini, mostrando loro come si deve sprezzare la morte”. (Della morte di Peregrino, 33)
In conclusione, Peregrino Proteo fu certamente qualcosa di più di quell’avventuriero, sia pure di alta classe, che ci dipinge Luciano. Lo provano i numerosi seguaci che egli ebbe, sia, in un primo momento, fra i Cristiani, sia, successivamente, quando abbracciò il cinismo, fra i Pagani, e la testimonianza di Gellio lo riconferma in modo netto. Gellio dice (Noct. Att., XII, 11) espressamente dì avere visto e conosciuto di persona Peregrino “virum gravem et constantem”, allorché soggiornò ad Atene, di averlo trovato “in quodam tugurio extra urbem”, di avergli fatto molte visite e di averlo udito parlare intorno a molte cose “utiliter et honeste”. Purtroppo Gellio riferisce un solo punto della dottrina di Proteo, ma degno di considerazione, e cioè che il saggio non deve peccare, nemmeno se il suo peccato potesse restare a tutti sconosciuto, sia agli Dei sia agli uomini, giacché non bisogna astenersi dal commettere colpe per timore di punizioni o di infamia, ma per amore del bene in quanto tale. Peregrino Proteo rappresenta un momento di incontro del Cinismo, oltre che con la componente orientale con il misticismo che andava vieppiù diffondendosi.
SALUSTIO
Gli studiosi sono concordi nell’identificare Salustio con Saturnino Salustio Secondo, elevato da Giuliano, nel 361 d.C., alla carica di prefetto d’Oriente (e al quale fu dedicato, tra l’altro, il discorso Ad Helios Re).
Il suo trattato Sugli dei e il mondo (G. Rochefort sulla base di una serie di elementi plausibili ne fissa la data di composizione fra il marzo e il giugno 362 d.C.) rientra con tutta probabilità nel quadro della politica di restaurazione del politeismo pagano promossa da Giuliano, ed è una sorta di manifesto della fede politeistica o un catechismo degli articoli essenziali di essa.
Lo scritto – di formidabile chiarezza e lucidità – costituisce uno sforzo cospicuo di purificazione delle credenze pagane in modo da renderle competitive nei confronti della religione cristiana.
La maggior parte delle idee esposte nel breve trattato non sono originali. In alcuni punti, tuttavia, l’autore, per via della rivalità con la concezione cristiana, sostiene alcune tesi inconsuete.
Così, per esempio, egli sostiene che la Provvidenza esiste per i popoli, per le città, e anche per l’uomo singolo.
Relativamente all’origine del male, Sallustio afferma che nulla è male per sua natura, ma diviene male per le azioni degli uomini, o meglio, di alcuni uomini.
Inoltre, il male non è commesso dagli uomini per sé, ma perché si presenta falsamente sotto l’apparenza di un bene, come aveva già insegnato in certa misura Socrate.
I mali nascono sempre e solo a causa di una falsa valutazione dei beni.
La conoscenza dell’esistenza degli Dei, per Salustio come per tutti i Neoplatonici, è naturale.
L’ateismo è considerato da Salustio nei termini di un castigo.
Riportiamo le sue parole:
“Non è infine inverosimile che anche l’irreligiosità costituisca una forma di castigo, dato che è ragionevole supporre che quanti, in una vita anteriore, ebbero modo di conoscere gli dei, ma non li tennero nel rispetto dovuto, siano privati, in una successiva, anche del privilegio della conoscenza di questi; così come era necessario che Dike, Giustizia, facesse precipitare lontano dagli dei veri quanti onorarono i propri re come dei” (Salustio, Sugli dei e il mondo – 18, 2).
I Demoni, dice Salustio, non sono i soli a punire le anime, ma è anche l’anima stessa che «dà a se medesima il proprio castigo».
Egli riprende la dottrina della metempsicosi:
“Si può dedurre la trasmigrazione dall’osservazione dei difetti congeniti (perché mai, altrimenti, alcuni verrebbero al mondo ciechi, altri storpi, altri, ancora, menomati nell’anima stessa?), così come dall’osservazione che le anime – che sono atte, per natura, a reggere un corpo – non possono, una volta salta fuori di quello, restarsene a poltrire per l’eternità” (Ibidem – 20, 2).
Ed ecco le conclusioni del suo trattato:
“Felici sotto ogni rispetto e – in particolare – separate dall’anima irrazionale, e pure da ogni contatto corporeo, le anime che abbiano vissuto secondo virtù si uniscono agli dei e reggono con quelli il mondo intero.
Ma anche se nulla di tutto ciò fosse vero: senza contare il piacere e la gloria, che da quella discendono assieme a una vita priva di crucci e senza servitù, la virtù stessa basterebbe da sola a render felici quanti scelsero di vivere secondo virtù, e ne furono capaci” (Ibidem – 21, 1-2).
DEMETRIO CINICO

Demetrio è il primo nome di Cinico dell’età imperiale di cui ci sia giunta notizia: fu un contemporaneo di Seneca, e fu da questi assai ammirato e apprezzato. Demetrio nacque, probabilmente, agli inizi del I secolo d.C. Egli era già noto per la sua dottrina e per la sua vita cinica negli anni in cui imperava Caligola, a giudicare da quanto ci riferisce Seneca (De benef., VII, 11). Forse dovette lasciare Roma già una prima volta, dopo la condanne di Trasea Feto, di cui era amico, nel 67 d.C. E certa la sua espulsione da Roma nel 71 d.C., a motivo della sua opposizione alla politica dell’imperatore Vespasiano. Dei suoi ultimi anni di vita (trascorsi probabilmente, almeno in parte, in Grecia) poco sappiamo. La nostra principale fonte di informazione è Seneca, che lo frequentò con costanza. Leggiamo alcuni eloquenti passi, tratti dal De beneficiis, dalle Epistole e dal De providentia.
Demetrio il Cinico [è] filosofo di grande importanza, a mio giudizio, anche se paragonato ai sommi. (Seneca, De benef., VII, 1, 3)
Poco fa ho citato Demetrio […] uomo di saggezza completa (anche se egli sia il primo a negarlo) e di incrollabile costanza nei suoi propositi, di un’eloquenza quale si addice ai tempi più seri, cioè non preoccupata della ricerca degli ornamenti e della sceltezza dell’eloquio, ma tutta protesa all’esposizione dei concetti con vigorosa passione, secondo l’ispirazione. Sono sicuro che a quest’uomo la Provvidenza ha dato una tale vita e una tale facoltà di eloquio perché a noi non mancassero né un esempio, né un rimprovero. (Seneca, De benef., VII, 8, 2)
Io sempre porto intorno con me Demetrio il migliore degli uomini, lascio da parte i grandi porporati e converso con lui seminudo e lo ammiro. E come non ammirarlo? Ho constatato che nulla gli manca. Qualcuno può disprezzare tutto, ma nessuno c’è che possa avere tutto. La via più breve per giungere alla ricchezza è disprezzarla. Quanto al nostro Demetrio, egli vive non come chi disprezza ogni cosa, ma come chi ne ha lasciato ad altri il possesso. (Seneca, Epist., 62, 3)
Demetrio sosteneva la necessità di ridurre la filosofia alla conoscenza di pochi precetti e alla rigorosa applicazione di essi. Ci sono, sì, egli diceva, molte conoscenze interessanti e la cui acquisizione reca diletto, ma solo poche sono quelle essenziali e queste poche sono di facile apprendimento, giacché la natura le ha poste provvidamente a portata di tutti. Ed ecco quali sono questi precetti essenziali:
Se il nostro animo ha imparato a disprezzare tutto ciò che è dovuto al caso, se ha saputo dominare il timore, se non aspira con avide speranze a cose impossibili, ma ha imparato a chiedere a se stesso ogni ricchezza, se si è liberato dal timore degli dei e da quello degli uomini e sa che dagli uomini non c’è molto da temere, dagli dei nulla; se l’uomo disprezzando tutto ciò che adorna ma contemporaneamente tormenta la nostra vita è arrivato a capire chiaramente che la morte, di mali, non ne origina nessuno ma ne elimina molti; se si è dei tutto dedicato alla virtù e trova agevole qualunque strada essa gli indica; se, creatura destinata alla vita associata e generata per la collettività, considera il mondo come la casa comune di tutti e ha aperto la sua coscienza agli dei e in ogni circostanza, si comporta come se fosse esposto al controllo di tutti temendo più il suo stesso giudizio che quello di altri – allora quegli, sottrattosi alle tempeste, si è fermato sulla terra ferma, sotto un cielo sicuro ed è arrivato alla perfetta conoscenza di ciò che è utile e necessario. Tutte le altre cose servono a dilettare il nostro tempo libero: si può anche ricorrere ad esse quando l’animo è già al sicuro, ma esse lo affinano solamente, non lo temprano. (Seneca, De benef., VII, 1, 7)
In questo contesto riacquista tutto il suo antico significato il ponos, ossia la “fatica”, e l’esercizio che tempra l’animo e lo rende capace di affrontare tutte le avversità della vita. Un’esistenza che non ha mai subito gli urti della sorte e non si è mai cimentata con le avversità, per Demetrio, è “un mare morto”, per cui, di conseguenza, l’uomo che non è stato mai colpito da avversità, lungi dall’essere felice, come credono i più, è, in realtà, un infelice. Seneca riferisce, infatti, questo suo motto:
Nulla mi sembra più infelice di un uomo a cui non è accaduta mai nessuna avversità. (Seneca, De provid., VII, 3)
Infine, è da rilevare come il cinismo di Demetrio si colori di un considerevole sentimento religioso, molto vicino a quello che già aveva ispirato lo stoico Cleante.
È ancora Seneca che ci riporta la testimonianza più significativa in proposito:
Mi ricordo di avere udito anche questo discorso animoso di Demetrio, uomo di fortissimo cuore: ” 0 dei immortali, per una sola cosa posso lamentarmi di voi: perché non mi rendeste nota in anticipo la vostra volontà. Infatti, sarei venuto io per primo a sostenere quelle prove che sono qui a sostenere ora chiamato da voi. Volete prendere i miei figli? Per voi li ho messi al mondo. Volete qualche parte dei corpo? Prendetevela. Non “vi prometto una gran cosa: presto lo lascerò tutto intero. Volete il mio spirito vitale? Perché non dovrei essere prontissimo a farvi ricevere quel che voi stessi mi deste? Porterete via conforme alla mia volontà tutto ciò che mi avrete chiesto. Che cosa è dunque in questione? Avrei preferito offrire anziché consegnare queste cose. Che necessità c’era di togliermele? Potevate riceverle. Ma neppure ora voi me le toglierete veramente, perché nulla si rapisce se non a chi vuoi trattenere”. (Seneca, De provid., V, 5)
E’ una concezione, questa, la quale esprime un particolare sentimento della vita, che rivive anche nel neostoicismo romano, ossia nello stesso Seneca e, soprattutto, in Epitteto.
ENOMAO di GADARA

La componente radicale e contestatrice dell’antico cinismo – che trova la sua più tipica espressione nell’”anaídeia” e nella “parresía” – ritorna in primo piano in Enomao. Nei suoi scritti egli probabilmente trattò l’intero arco della tematica cinica, ma a noi sono pervenute dettagliate informazioni e ampi estratti di una sola opera che recava il titolo L’esposizione dei ciarlatani. In questa opera Enomao sferrava una sferzante requisitoria contro gli oracoli e contro la possibilità delle profezie e della mantica. Egli esaminava in modo analitico le più celebri profezie dell’oracolo di Delfi, ne mostrava l’inconsistenza e la capziosità e adduceva altresì alcune ragioni filosofiche contro la possibilità delle profezie stesse. Le argomentazioni filosofiche non si basavano su una generica negazione dell’esistenza della Divinità e di Demoni. Infatti Enomao, come in genere i Cinici, non era un ateo; egli riteneva, tuttavia, che la Divinità non dovesse occuparsi delle cose umane, e che, quindi, le pretese profezie non avessero nulla di demoniaco e di divino, ma fossero solamente imbrogli belli e buoni. Le argomentazioni in parola facevano appello alla contraddizione sussistente fra l’affermazione dell’esistenza del “Fato” o della “Necessità” che tutto governa, da un lato, e l’ammissione della libertà umana, dall’altro. La mantica dimostra la propria assurdità nella misura in cui fa appello, ad un tempo, ad ambedue questi presupposti, che reciprocamente si escludono.
Scrive Enomao:
È del tutto ridicolo porre nello stesso tempo che qualcosa dipenda dall’uomo e che tuttavia egli sia dominato dal Destino.
Questa contraddizione rende assurda la credibilità degli oracoli (e della mantica in genere) in tutti i sensi. In primo luogo, rende assurda la stessa pretesa libertà di profetare di Apollo, perché, se tutto fosse necessario, Apollo a Delfi non potrebbe stare in silenzio, nemmeno se lo volesse, e, in ogni momento, egli, lungi dal poter fare la propria volontà, dovrebbe fare ciò che la Necessità ha stabilito. In secondo luogo, posto anche che gli oracoli fossero possibili, non avrebbero alcun senso, nella misura, almeno, in cui essi comandano una qualsiasi cosa, perché, ammettendo la Necessità, nulla resterebbe in potere dell’uomo. In questa vivace polemica, si comprende come Enomao dovesse prendersela soprattutto contro gli Stoici, i quali, con la loro dottrina del Fato, pretendevano di dare una base filosofica alla mantica. Gli Stoici – secondo Enomao – non sono coerenti: infatti essi affermano che l’uomo può essere virtuoso; inoltre sono ad un tempo sicuramente persuasi che l’uomo possa essere tale non contro la propria volontà, ma solo per spontanea deliberazione. Ma se così è, non c’e nessuno, “Dio o Sofista che sia”, che possa osare affermare che questa spontanea deliberazione dipenda dalla necessità, a motivo dell’evidente contraddizione; e se così è, non regge il loro fatalismo. E, con un’impennata di cinica “parresía”, Enomao conclude:
E se osa affermarlo [scil: che ciò che si sceglie deliberatamente dipenda esso pure dalla necessità], non formuleremo più argomenti contro di lui, ma daremo mano ad un nervo di bue, il meglio teso, come quello che serve a raddrizzare i discoli, e gli spezzeremo i fianchi.
ALESSANDRO DI AFRODISIA

Nell’età ellenistica, le grandi opere di Aristotele erano scomparse dalla circolazione, cosicchè i filosofi che a lui si rifacevano non conoscevano in realtà nulla di quanto da lui scritto. Scomparse le opere essoteriche (per lungo tempo le più lette e studiate), nel I secolo a.C. tornano a circolare gli scritti di scuola di Aristotele, grazie alla riscoperta di essi realizzata da Andronico di Rodi, il quale li raggruppa secondo un ordine sistematico scandito dalla tripartizione ormai canonica (dall’ellenismo in poi) in logica, fisica ed etica. Essi, con la loro imponente strumentazione concettuale e sistematica, contribuiscono fortemente all’affossamento, già in atto, della filosofia stoica, opponendosi soprattutto alla filosofia della natura della Stoà; nel configgere con lo Stoicismo e il suo materialismo esasperato, l’aristotelismo finisce per assumere un carattere spiritualeggiante estraneo ad Aristotele e tende sempre più a confluire nell’alveo della tradizione platonica: è senz’altro significativo il fatto che uno degli esegeti del riscoperto Aristotele – il messenio Aristocle (II secolo d.C.) – arriva a definire l’Accademia come "il Peritato di Platone". In questa prospettiva, la pratica filosofica delle scuole si articola sempre più come esplicazione di testi ed assume soprattutto la forma del
"Poiché, come nell’intera natura c’è qualcosa che costituisce la materia per ciascun genere di cose (e ciò è potenzialmente tutte quelle cose), e qualcos’altro che è la causa e il principio produttivo, perché le produce tutte, allo stesso modo che la tecnica si rapporta alla sua materia, necessariamente queste differenze si trovano anche nell’anima. E c’è un intelletto analogo alla materia perché diviene tutte le cose, ed un altro che corrisponde alla causa efficiente perché le produce tutte, come una disposizione del tipo della luce, poiché in certo modo anche la luce rende i colori che sono in potenza colori in atto. E questo intelletto è separabile, impassibile e non mescolato, essendo atto per essenza, poiché sempre ciò che fa è superiore a ciò che subisce, ed il principio è superiore alla materia. Ora la conoscenza in atto è identica all’oggetto, mentre quella in potenza è anteriore per il tempo nell’individuo, ma, da un punto di vista generale, non è anteriore neppure per il tempo; e non è che questo intelletto talora pensi e talora non pensi. Quando è separato, è soltanto quello che è veramente, e questo solo è immortale ed eterno (ma non ricordiamo, perché questo intelletto è impassibile, mentre l’intelletto passivo è corruttibile), e senza questo non c’è nulla che pensi". (Aristotele, De anima 430 a 11)
Questa dottrina viene esposta in maniera criptica e sintetica, ma, ciononostante, si evince come esso non sia una prerogativa dei singoli individui, ma un qualcosa di unico per tutta la specie umana (per tutti gli uomini passati, presenti e futuri). C’è anche stato chi ha letto nell’intelletto attivo la divinità stessa. Entrambe le interpretazioni concordano sul fatto che Aristotele riconosca in quest’intelletto produttivo (e non in quello di cui sono dotati i singoli) la prerogativa dell’immortalità: ciò si ricondurrebbe, in qualche modo, all’impianto generale della filosofia aristotelica, secondo la quale a poter partecipare dell’eternità sono non i singoli, ma le specie; l’intelletto passivo di cui ciascuno di noi è dotato sarebbe dunque destinato a perire; mentre quello produttivo, comune a tutta la specie, dovrebbe perdurare in eterno. Aristotele, nell’analizzare l’intelletto, fa notare come tutto ciò che appartiene alla natura abbia determinate caratteristiche, tra le quali rientra l’avere una materia propria; essa è, potenzialmente, un mare magnum di cose (il marmo, infatti, è potenzialmente tutte le cose che col marmo possono essere create). Ma, accanto a questa causa materiale, c’è quella che lo Stagirita chiama causa “produttiva” (poihtikon), o “efficiente”, come la chiama nella Fisica. Essa, rispetto alla materia, produce tutte le cose che sono in potenza nella materia, cosicchè la statua di marmo è causa produttiva che fa sì che dal marmo derivino tutti gli oggetti possibili che possono essere fatti col marmo. Sotto questo profilo, la natura e l’attività tecnica procedono in maniera analoga, cioè attraverso la materia e la generazione di effetti: ma questo stesso discorso vale anche per l’anima, dove sarà possibile trovare una causa produttiva. Applichiamo ciò all’intelletto: al concetto di materia corrisponde quello di potenza, sicchè la materia dell’intelletto – cioè l’analogo del marmo – sarà l’intelletto potenziale, analogo alla materia nel senso che è potenzialmente tutte le cose (cioè tutte le nozioni intelligibili). Il grosso problema che si deve affrontare è che, accanto alla materia, deve esserci una causa produttrice, un intelletto che ad essa corrisponda. Quale è? Aristotele è, in questo caso, più criptico del previsto e, per chiarire la differenza tra intelletto produttivo e intelletto potenziale, asserisce – memore della metafora impiegata da Platone nella Repubblica – che l’intelletto produttivo è una luce, poiché anche “la luce rende i colori che sono in potenza in atto” [De anima, 430 a 17]. La luce è ciò che fa sì che i colori – potenzialmente visibili – siano effettivamente visti in atto; e cos’è che svolge mansioni analoghe alla luce nella sfera intelligibile? Per Platone era la verità; da Aristotele – giacchè non esistono idee come esseri universali a sé stanti – questa funzione della luce è attribuita all’intelletto produttivo, una sorta di luce che permette alle nozioni intelligibili di essere conosciute in atto. Ma qui cominciano a nascere le prime difficoltà; prima fra tutte: che cos’è questo intelletto produttivo? Chi ce l’ha? E’ – risponde lo Stagirita – un intelletto separabile, o, meglio, separato (cwristoV) dal corpo, è impassibile (cioè non subisce azioni), non è mescolato, essendo “atto per essenza“. Il suo modo di essere specifico è di essere in atto, ossia non in potenza: eppure finora Aristotele parlava dell’intelletto come capace di passare da potenza ad atto; per argomentare che invece quest’intelletto produttivo è in atto e che il principio è superiore (timiwteron) alla materia, fa una scala gerarchica di valori, in virtù della quale ciò che fa è superiore a ciò che subisce, ossia la causa è superiore all’effetto. Si tratta di una gerarchia destinata a godere di grande fortuna (sarà la base per la dimostrazione dell’esistenza di Dio in età cristiana), anche se – a rigore – è molto discutibile. Tuttavia è bene notare come Aristotele, in questo passo del De anima, non menzioni mai la divinità: ciononostante Alessandro di Afrodisia, chiedendosi che cosa fosse tale intelletto che non può appartenere ai singoli (poiché il singolo uomo non conosce tutti gli intelligibili e per di più in atto), arriva a collegare questo capitolo del De anima al XII libro della Metafisica, in cui vi è un’ampia trattazione del tipo di vita condotto dalla divinità. Nel XII libro della Metafisica (come forse nell’ultimo della Fisica), infatti, Aristotele ammette un primo motore da cui dipendono tutti i movimenti dei corpi celesti (e indirettamente tutti gli altri movimenti esistenti). Tale motore immobile, che muove senza esser mosso, non può, ovviamente, essere una sostanza come le altre, costituito di potenza e di atto, giacchè, se fosse dotato di potenza, sarebbe esso stesso suscettibile di essere mosso e di esser fatto passare da potenza ad atto. Se invece è immobile, allora non può subire questo passaggio, sicchè è solo atto, atto puro. Da ciò, Alessandro di Afrodisia ricava che l’intelletto produttivo altro non è se non l’intelletto di Dio, anche perché nel XII libro della Metafisica Aristotele stesso caratterizzava l’attività specifica della divinità come attività di pensiero (nohsiV), come pensante in atto (pensiero di pensiero, h nohsiV nohsewV). Ma allora a far passare da potenziale ad attuale l’intelletto umano è tale intelletto produttivo, per cui ogni nostro atto conoscitivo comporta l’attività dell’intelletto divino: è questa una teoria destinata ad avere grande successo – soprattutto grazie alla mediazione neoplatonica – in età cristiana, quando si parlerà di illuminazione divina. Del resto, anche Aristotele ripete spesso che la causa che fa sì che i nostri sensi passino dalla potenza all’atto è il sensibile in atto, cioè un oggetto esterno; similmente, a far passare da potenza ad atto il nostro intelletto potrebbe essere un intelligibile in atto, cioè Dio (l’intelletto in atto fa tutt’uno con l’intelligibile in atto). L’altra possibile strada interpretativa è quella che identifica l’intelletto produttivo con l’intelletto della specie umana, intelletto che non potrebbe perire perché le specie per Aristotele sono eterne: così com’esse sono eterne, così sono eterne anche le loro prerogative, nel cui novero rientra anche la razionalità. Ne consegue che a perire saranno il singolo uomo e il suo intelletto, ma non l’intelletto della specie umana, e allora – come diranno i filosofi Arabi, primo fra tutti Averroè – tale intelletto produttivo sarà unico, giacchè unica è la specie umana. Aristotele, dal canto suo, cerca di spiegare la priorità dell’intelletto in atto su quello in potenza dicendo che la conoscenza in atto è identica all’oggetto (poiché esso è intelligibile in atto), mentre quella in potenza è anteriore nel tempo per l’individuo (un neonato possiede potenzialmente la conoscenza di ogni cosa, sicchè la potenza sta prima rispetto all’atto). Però che la potenza venga prima dell’atto è valido solo per il singolo (il caso del neonato, ad esempio): da un punto di vista generale (olwV, dice Aristotele), l’anteriorità è invertita, l’atto sta prima della potenza, cosicchè la gallina (essere compiuto) viene prima dell’uovo (gallina in potenza), giacchè quest’ultimo necessita di una gallina in atto che lo covi (ciò significa che ciò che è in potenza, per passare in atto, ha sempre bisogno di qualcosa già in atto). Secondo Alessandro di Afrodisia, dunque, l’intelletto umano si sviluppa in un processo in cui interagiscono la disposizione, detta anche intelletto materiale, ad accogliere le forme universali, ovvero gli oggetti di apprendimento, e l’insegnamento e l’esercizio. Il risultato è la formazione dell’intelletto inteso come habitus, il quale, quando è in grado di pensare da sé, diventa intelletto in atto, cioè si esplica appunto nell’attività del pensiero. Secondo Alessandro, anche questo intelletto, in quanto proprio di un’anima corruttibile, la quale è forma di un corpo corruttibile, è anch’esso corruttibile e quindi non gode dell’immortalità. A che cosa corrisponde allora – si domanda Alessandro – l’intelletto incorruttibile di cui Aristotele parla nel De anima? Ad avviso di Alessandro, esso si identifica con quell’intelletto che, per natura, è sempre intelligente in atto, è completamente separato dalla materia e, essendo pura forma intelligibile in sommo grado, è causa dell’intelligibilità delle forme insite nella materia. Il dio aristotelico si configura allora come intelletto agente, in quanto causa dell’intelligibilità e dell’essere degli intelligibili. Ciò richiama la descrizione dell’idea del Bene nella Repubblica platonica, ma Alessandro non identifica l’intelletto divino, l’unico dotato di immortalità, con il sommo bene. Nonostante nelle dottrine di Alessandro paiano permanere tratti di materialismo, come l’attribuzione all’anima di una natura mortale, il primato da lui assegnato alla teologia e l’identificazione dell’intelletto agente (nouV poihtikoV) nel Motore Immobile, con la successiva assimilazione dell’intelletto umano a quello divino, costituiscono altrettanti elementi che, anche dal punto di vista terminologico, avvicinano il pensiero di Alessandro a quello dei Neoplatonici. Con lui l’aristotelismo compie il suo ciclo e si dissolve nel platonismo, come dimostra l’assenza pressoché totale di rilevanti personalità nel periodo successivo.
PLUTARCO DI CHERONEA
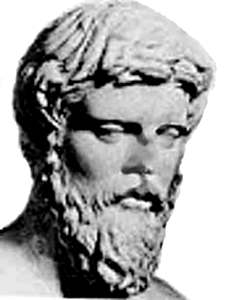
“Tutte queste considerazioni mettile a confronto con le cose dette dagli altri; e se esse avranno un grado né maggiore né minore di probabilità, manda a quel paese le opinioni, ritenendo più degno di un vero filosofo sospendere il giudizio sulle questioni poco chiare, piuttosto che darvi il proprio assenso” (De primo frigido, 955 c).
La vita
Quasi tutto ciò che sappiamo circa la vita di Plutarco si ricava da riferimenti interni alle sue stesse opere: in esse, egli ricorda (Moralia 385 b) di essere stato discepolo del platonico Ammonio nell’età in cui Nerone soggiornò in Grecia (66-67 d.C.); da questo riferimento, è possibile collocare la nascita di Plutarco poco prima del 50 d.C. Sempre nei suoi scritti, egli narra che la sua famiglia fu funestata dalla scomparsa prematura dei cinque figli che Plutarco ebbe dalla moglie Timossena. Plutarco trascorse la maggior parte della propria esistenza nella nativa Cheronea, in Beozia, (diceva scherzosamente di non volerla rendere più piccola andandosene), ma ciò non gli impedì di fare importanti viaggi sia in Grecia sia nelle altre zone dell’Impero: e così si recò ad Atene (ove fu insignito della cittadinanza onoraria), a Sparta, ad Alessandria e forse anche in Asia; ebbe modo di visitare l’Italia e di soggiornare a Roma, senza però riuscire ad impadronirsi alla perfezione della lingua latina per via dei molteplici impegni politici e culturali che lo impegnarono ( Vita di Demostene, 2, 2). Plutarco divenne cittadino romano col nomen di Mestrio (tratto dall’amico Mestrio Floro) e gli fu conferita da Traiano la dignità consolare, da Adriano quella di suo ambasciatore in Grecia. È curioso che di queste cariche prestigiose, di cui ci dicono Eusebio e il lessico Suda, Plutarco non faccia mai menzione nei suoi scritti: questa apparente stranezza è probabilmente dovuta alla fierezza greca di Plutarco, che per tutta la vita non volle vantarsi di cariche esercitate in favore del potere romano. Quest’ipotesi trova una potente conferma nel fatto che egli elenchi nei suoi scritti una dopo l’altra tutte le cariche da lui rivestite in Beozia (arconte eponimo, sovrintendente all’edilizia pubblica, telearco). L’incarico che più ebbe a cuore fu però quello di sacerdote delfico, che detenne per circa un ventennio e che molta influenza ebbe sulla sua spiritualità. Molte incertezze permangono sulla data della morte di Plutarco, che dovette in ogni caso coglierlo in età piuttosto avanzata: se prestiamo fede a Eusebio, Plutarco non sarebbe morto dopo il 119 d.C., anche se c’è chi sposta la data fino al 125.
Le opere
I titoli delle opere scritte da Plutarco ci sono stati tramandati dal cosiddetto “catalogo di Lampria”, nome che il lessico Suda attribuisce erroneamente ad un figlio di Plutarco stesso che avrebbe compliato il catalogo degli scritti del padre. In alcuni manoscritti il catalogo è poi preceduto da un’epistola nella quale un mittente anonimo scrive ad un altrettanto anonimo destinatario chiedendo di inviargli una lista degli scritti del proprio padre. Oggi si pensa che tanto l’epistola quanto il catalogo siano certamente di epoca posteriore, e si è fissata alla notevole cifra di 260 il numero delle opere di Plutarco (di cui però alcune sono sicuramente spurie). Di questa impressionante produzione a noi è giunto soltanto un terzo. Le opere di Plutarco possono essere suddivise in due grandi gruppi: le Vite parallele (che ci sono giunte in numero di 50) e i Moralia ( Ethicà), dei quali sono sopravvissuti circa 70 scritti (non contando quelli sicuramente falsi). Le 50 Vite parallele non sono altro che 50 biografie di uomini illustri del mondo greco e romano (con l’eccezione di quella del persiano Artaserse); di queste, 44 risultano ordinate secondo coppie di personaggi appartenenti ai due popoli (Alessandro-Cesare, Demostene-Cicerone, e così via), aspetto che giustifica la denominazione di “parallele”. Nella sua opera, infatti, Plutarco instaura un vero e proprio parallelo tra le vite di illustri Romani e quelle di illustri Greci, operando un vero e proprio confronto ( sùgrisis) tra il personaggio greco e quello romano presi in esame e spiegando le ragioni di tale parallelismo. Solo quattro vite (Arato, Artaserse, Galba, Otone) sono singole, e una delle coppie risulta costituita da due personaggi per parte (Agide e Cleomene-Tiberio e Gaio Gracco), portando il numero delle biografie a 50. Nei manoscritti, le 22 coppie ci sono state tramandate nel modo seguente:
1 Teseo-Romolo; 2 Solone-Publicola; 3 Temistocle-Camillo; 4 Aristide-Catone il Vecchio; 5 Cimone-Lucullo; 6 Pericle-Fabio Massimo; 7 Nicia-Crasso; 8 Alcibiade-Coriolano; 9 Demostene-Cicerone; 10 Focione-Catone il Giovane; 11 Dione-Bruto; 12 Emilio Paolo-Timoleonte; 13 Sertorio-Eumene; 14 Filopemene-T. Flaminio; 15 Pelopida-Marcello; 16 Alessandro-Cesare; 17 Demetrio-Antonio; 18 Pirro-Mario; 19 Agide e Cleomene-Tiberio e Gaio Gracco; 20 Licurgo-Numa; 21 Lisandro-Silla; 22 Agesilao-Pompeo.
Va notato che i paralleli sopra indicati col numero 3, 10, 16 e 18 sono gli unici privi del confronto. Il procedimento del confronto tra personaggi illustri non era certo una novità (basti pensare alla celebre comparatio tra Catone e Cesare nel cap. 54 della Congiura di Catilina di Sallustio), ma è sicuramente innovativo nella sua raffinatezza l’uso che ne fa Plutarco: egli accosta un personaggio greco ad uno latino con l’intenzione (insieme politica e culturale) di avvicinare i due popoli e le due civiltà, superando i rispettivi pregiudizi e favorendo una collaborazione incentrata su un rapporto di stima e rispetto reciproci. In un contesto in cui il dominio romano è una realtà indiscutibile, ma in cui al tempo stesso la Grecia, col suo glorioso passato, non vuole essere relegata ai margini come mera colonia, Plutarco sa bene che la sua è una missione storica di unificazione e conciliazione tra due realtà diverse e potenzialmente in conflitto. Il mondo greco e quello romano sono da Plutarco intesi come due mondi complementari, quasi come se quello romano non fosse altro che una riproposizione in parallelo degli antichi eroi greci, migrati a Roma. Il mondo romano non segna dunque la fine di quello greco, ma piuttosto la sua continuazione. Ma non è questo l’unico scopo dell’opera plutarchea: ve n’è un altro, altrettanto importante, che Plutarco enuncia nell’esordio della Vita di Emilio Paolo, allorché spiega che, “guardando nella storia come in uno specchio”, egli prova a modellare in qualche modo la sua vita sulle virtù dei protagonisti della storia, aggiungendo che “non esiste modo migliore e più piacevole di migliorare i propri costumi”. Le virtù degli eroi storici sono dunque un paradigma da cui mai bisogna allontanare lo sguardo e che dev’essere conosciuto per poter essere imitato. Plutarco sa bene che, per questa via, si esce dai sentieri della storia per imboccare quelli delle biografie personali, e lo dichiara programmaticamente nella Vita di Alessandro (I, I, ss.):
“Noi non scriviamo storie, ma biografie. […] Come dunque i pittori ricavano le somiglianze dal volto e dai tratti esteriormente visibili, attraverso i quali si manifesta il carattere, così a noi dev’essere concesso di penetrare maggiormente nei segni rivelatori dell’animo e mediante questi dare un’immagine della vita di ciascuno, lasciando ad altri le grandezze e le contese”.
Nel tratteggiare la vita dei suoi personaggi, Plutarco parte solitamente dalla gioventù, su cui si sofferma con particolare insistenza, giacché la intende come il momento di formazione dell’uomo e del suo éthos; poi passa alle imprese storiche compiute (che sono una diretta emanazione dell’éthos) dal personaggio cresciuto, per poi concludere con la vecchiaia e con la morte; numerosi sono gli aneddoti e le frasi celebri (“meglio essere i primi in un villaggio che i secondi a Roma”, dice ad esempio Cesare). Su un piano strettamente filosofico, è bene rilevare come ogni personaggio tenda, da un lato, ad assumere la fissità dell’archetipo platonico, eterno modello da imitare, e, dall’altro lato, sia attratto nella sfera dell’incessante divenire storico, entro cui recita dinamicamente il suo ruolo di protagonista. Sicché ciascun personaggio è un modello platonico calato nella storia o, se preferiamo, sceso dal cielo sulla terra, a segnalare la possibile attuazione di quei modelli che, a tutta prima, nella loro perfezione potrebbero sembrare meramente ideali. Questo schema è poi reso più intricato dall’intersecarsi di un terzo piano, quello “speculare”, in forza del quale ogni eroe greco si riflette specularmene nel suo parallelo romano, che ne rappresenta, per così dire, una reincarnazione.
Il pensiero filosofico
Se dalle Vite parallele ci è restituita l’immagine di un “Plutarco storico” o, meglio, biografo, quello che affiora dai Moralia è un “Plutarco filosofo” a trecentosessanta gradi, che non conosce zone inaccessibili alla sua indagine filosofica (dalla gnoseologia all’etica, dalla teologia alla psicologia, dalla pedagogia alla politica, ecc.): il titolo di Moralia, che rimanda necessariamente alla filosofia morale (e che fu attribuito all’opera plutarchea probabilmente in forza del fatto che gli scritti morali furono quelli più apprezzati), pare dunque riduttivo, perché trascura il carattere enciclopedico dell’indagine plutarchea. Una prima serie di scritti filosofici è quella di contenuto etico che sviluppa argomenti di filosofia spicciola ad uso quotidiano:
1 De adulatore et amico; 2 De profectibus in virtute; 3 De capienda ex inimicis utilitate; 4 De amicorum multitudine; 5 De virtute et vitio; 6 Consolatio ad Apollonium; 7 De tuenda sanitate praecepta; 8 Coniugalia praecepta; 9 De virtute morali; 10 De cohibenda ira; 11 De tranquillitate animi; 12 De fraterno amore; 13 De garrulitate; 14 De curiositate; 15 De cupiditate divitiarum; 16 De vitioso pudore; 17 De invidia et odio; 18 De laude ipsius; 19 Consolatio ad uxorem; 20 Amatorius; 21 Amatoriae narrationes; 22 De vitando aere alieno; 23 De amore.
Cinque sono le opere pedagogiche:
1 De liberis educandis; 2 De audiendis poetis; 3 De audiendo; 4 De musica; 5 Pro nobilitate.
Questi sono gli scritti politici:
1 Maxime cum principibus viris philosopho esse disserendum; 2 Ad principem indoctum; 3 An seni res publica gerenda sit; 4 Praecepta gerendae rei publicae; 5 De unius in re publica dominatione, populari statue t paucorum imperio; 6 De esilio; 7 Institutio Traiani.
Presentano un contenuto marcatamente speculativo alcune opere che passano in rassegna, non senza intenti polemici, le diverse posizioni assunte dalle varie scuole filosofiche:
1 Platonicae quaestiones; 2 De animae procreatione in Timaeo; 3 De Stoicorum repugnantiis; 4 Stoicos absurdiora poetis dicere; 5 De communibus notitiis adversus Stoicos; 6 Non posse suaviter vivi secundum Epicurum; 7 Adversus Coloten; 8 De latenter vivendo; 9 De libidine et aegritudine; 10 Quod in animo humano affectibus subiectum parsne sit eius an facultas; 11 De anima.
Fin dai titoli appare evidente come nel mirino della critica di Plutarco siano soprattutto gli Stoici e gli Epicurei, ai quali il pensatore di Cheronea contrappone come antidoto il platonismo, di cui si dichiara a gran voce seguace. Di argomento spiccatamente scientifico sono una serie di opere al cui cuore sta l’indagine del mondo fisico e animale; in esse Plutarco si occupa anche di astronomia e prende posizione contro l’uso alimentare della carne:
1 De facie in orbe lunae; 2 De primo frigido; 3 Quaestiones physicae; 4 De amore prolis; 5 De sollertia animalium; 6 Bruta animalia ratione uti; 7 De esu carnium.
Alla storia della religione e a problematiche teologiche sono poi dedicati scritti che risultano interessanti soprattutto alla luce delle preziosissime informazioni antropologiche e culturali sul contesto spirituale tardo-pagano che racchiudono:
1 De superstitione; 2 De Iside et Osiride; 3 De E apud Delphos; 4 De Pythiae oraculis; 5 De defectu oraculorum; 6 De sera numinis vindicta; 7 De genio Socratis.
Presentano poi un taglio antiquario ed erudito scritti che trattano, in forma rigorosamente eziologica, di riti e usanze greche e romane:
1 Mulierum virtutes; 2 Aetia Romana; 3 Aetia Greca; 4 Regum et imperatorum apophthègmata; 5 Apophthègmata Laconica; 6 Parallela minora; De fluviis.
Plutarco si occupa anche di critica letteraria, di poetica e di retorica, anche se i suoi scritti circa questi argomenti sono andati perduti: di essi conosciamo solo i nomi, riportati nel catalogo di Lampria. Due però ci sono giunti e sono rispettivamente dedicati ad un raffronto tra Aristofane e Menandro e alla malignità di Erodoto (malignità dimostrata soprattutto ai danni dei Corinzi e dei Beoti):
1 De comparatione Aristophanis et Menandri epitome; 2 De Herodoti malignitate; 3 De vita et poesi Homeri; 4 X oratorum vitae; 5 De placitis philosophorum; 6 De proverbis Alexandrinorum; 7 Ecloga de impossibilibus; 8 De metris.
Prove di declamazione e di talento retorico sono alcuni scritti (probabilmente giovanili) in cui Plutarco esercita la propria bravura stilistica:
1 De fortuna; 2 De fortuna Romanorum; 3 De Alexandri Magni fortuna; 4 De gloria Athenensium; 5 Aquane an ignis sit utilior; 6 An virus doveri possit; 7 An vitiositas ad infelicitatem sufficiat; 8 Animine an corporis affectiones sint peiores; 9 De fato.
Contenuto miscellaneo e difficilmente classificabile hanno infine le seguenti due opere:
1 Septem sapientium convivium; 2 Quaestiones convivales.
Le due forme stilistiche che Plutarco sembra di gran lunga preferire nel fare filosofia sono quella del dialogo alla maniera platonica e quella del trattato: ma il dialogo platonico, nelle mani di Plutarco, muta radicalmente essenza, perdendo il suo splendore stilistico e il suo procedere scandito dalla dialettica della “botta e risposta” in cerca del vero; gli stessi personaggi sono ben poco artisticamente caratterizzati, e non di rado il dialogo finisce per essere solo una cornice entro cui inserire l’esposizione dell’argomento sotto forma di trattato. Lo stesso trattato assume una forma particolare, declinandosi ora come declamazione oratoria, ora come invettiva (tali sono gli scritti contro Epicurei e Stoici), e talvolta come diatriba di derivazione cinica, con frequenti aneddoti e ammonimenti rivolti al lettore e con un uso piuttosto colloquiale del linguaggio. Dal lungo elenco di titoli sopra riportati è facile evincere come Plutarco fu un ingegno enciclopedico, che si occupò di tutto, mosso da una curiositas che lo spingeva a interrogarsi su ogni cosa. È soprattutto a Platone che Plutarco si richiama espressamente, anche se la sua etica ha molti tratti comuni con quella aristotelica: dall’Accademia egli mutua l’atteggiamento antidogmatico e scettico, che lo porta spesso a ricorrere alla sospensione del giudizio (epoché), rendendolo consapevole dell’impossibilità di raggiungere in via definitiva la verità. Ma ciò non vuol dire che Plutarco sia un relativista o uno scettico tout court: il dubbio e la sospensione del giudizio vengono esercitati da Plutarco limitatamente al mondo fisico, cioè al mondo della dòxa, dell’opinione e della congettura; per quel che invece riguarda l’ambito delle eterne verità religiose e morali, egli è profondamente dogmatico, a tal punto da poter attaccare senza remore gli Stoici e gli Epicurei in nome del vero. Così, nel De primo frigido, Plutarco conclude la sua indagine sull’origine del freddo con un’inaspettata professione di scetticismo al suo interlocutore Favorino, esortandolo ad evitare oculatamente le secche del dogmatismo; e poi, negli scritti religiosi, attacca duramente quanti mettono in forse l’esistenza dell’aldilà o l’immortalità dell’anima. Sulle orme dell’amato Platone, Plutarco non ritiene assurdo o impossibile conciliare la fede in un Dio unico col politeismo della religione tradizionale, verso la quale nutre un incredibile rispetto. Non a caso egli fu sacerdote di Apollo e venne iniziato anche ai misteri dionisiaci, nutrendo una fede incrollabile nell’immortalità dell’anima e nell’aldilà, di cui abbozza una descrizione di impareggiabile suggestività nel De sera numinis vindicta. Suggestionato dal pitagorismo, Plutarco credeva anche nella trasmigrazione delle anime: questo spiega il suo vivacissimo interesse per il mondo animale, per il vegetarismo e per la lotta contro l’uso alimentare delle carni. Seguace fedele del dio delfico, Plutarco credeva alla funzione dell’arte mantica e alla veridicità degli oracoli, il cui silenzio egli prova a spiegare nel De defectu oraculorum, attraverso le tesi esposte dai vari interlocutori: una di tali tesi ipotizza addirittura l’esistenza di demoni, ossia di esseri anfibi tra l’umano e il divino, coi quali in altri scritti si cerca di render conto anche del male nel mondo e della sua apparente inconciliabilità con la provvidenza divina. In questa prospettiva, il filosofo di Cheronea non può non condannare l’ateismo e la superstizione, propugnando la rivitalizzazione dell’oracolo di Delfi. Interessato alla religione egizia, egli interpreta il mito di Iside e Osiride alla luce delle nozioni (desunte dal Timeo di Platone) di intelletto, anima del mondo e materia come ricettacolo. All’interno dei suoi dialoghi, Plutarco non esita ad introdurre, ancora una volta seguendo le orme di Platone, miti escatologici sul destino dell’anima dopo la morte; e l’ammissione dell’immortalità dell’anima facilita l’ammissione di una provvidenza divina che, nell’aldilà, premia i buoni e punisce i malvagi. È questa (formulata nel De sera numinum vindicta, scritto in cui si discute appunto del perché la divinità tardi a vendicarsi) una vera e propria teodicea che risente notevolmente del mito di Er platonico. Richiamandosi alle Leggi di Platone, Plutarco tenta poi di render conto del male nel mondo, ammettendo l’esistenza, accanto ad un principio divino razionale e buono, di un principio che genera il male:
“La nascita e la sostanza di questo universo derivano dalla mescolanza di forze contrarie ma non di ugual potenza, dato che il principio vincente è sempre quello buono. Ma non è del resto possibile che la forza del male sia del tutto annientata: essa è innata sia nella struttura fisica sia nell’anima vitale del tutto, in un’eterna lotta contro la forza del bene” (De Iside et Osiride, 49, 371 a).
Come abbiamo detto, Plutarco nutre un atteggiamento profondamente ostile allo stoicismo e all’epicureismo: degli stoici, egli mette in luce le innumerevoli contraddizioni teoriche che inficiano il loro sistema, sottolineando anche l’incompatibilità tra l’impegno politico a cui essi esortano e il loro totale disimpegno e agnosticismo politico praticato nella vita di tutti i giorni. La stessa pretesa stoica di eliminare le passioni è un’assurdità degna di essere derisa: ad essa Plutarco contrappone l’antica strategia platonica di misurazione ragionata delle passioni, in modo tale da disciplinarle e renderle funzionali ad una buona costituzione politica. E del resto Plutarco recupera in toto l’antica tripartizione platonica dell’anima: una tripartizione che, com’è noto, lungi dal liquidare le passioni, le ammette e le promuove, a patto che siano regolate dalla guida lungimirante della ragione. Dell’epicureismo Plutarco attacca ogni parte, schierandosi con particolare accanimento contro l’etica: non è un caso che il giovane Marx, nella sua dissertazione dottorale (Differenza tra le filosofie della natura di Democrito e di Epicuro, 1841), non esiterà ad individuare in Plutarco (insieme con Cicerone) il massimo nemico dell’epicureismo. In particolare, il filosofo di Cheronea cerca di mettere in mostra come – parafrasando il titolo di un suo scritto – sia impossibile vivere felicemente seguendo Epicuro: e dato che l’etica è il cuore della filosofia epicurea, distrutta quella, crollerà l’intero sistema. Una sferzante requisitoria contro l’epicureismo è, ad esempio, quella condotta da Plutarco contro l’epicureo Colote e nello scritto De latenter vivendo (in cui prende di mira l’agnosticismo politico di Epicuro). Il pensatore di Cheronea, così critico verso le diverse scuole di pensiero, assume un atteggiamento di acquiescenza verso la realtà politica presente, tessendo a più riprese le lodi di Roma, alla quale riconosce il merito di assicurare la pace, la sicurezza e la libertà a quanti si affidano alla sua protezione. Il vero obiettivo politico da raggiungere è allora quello della concordia tra i cittadini, rimuovendo ogni lotta tra loro: a questo scopo, Plutarco propone un ritorno alla paideìa, sulla scia di Platone. In un’epoca in cui il disegno politico platonico è ormai irrealizzabile, resta comunque viva la linea pedagogica del filosofo delle idee, a patto che la si porti all’altezza della nuova temperie culturale, così intrisa di religione e spiritualità. Anche se non fu mai un professore di filosofia (come lo sarà di lì a non molti decenni l’aristotelico Alessandro di Afrodisia), Plutarco si occupò per tutta la vita di questioni filosofiche, con un interesse che forse lo accomuna più che ad ogni altro a Cicerone: come Cicerone, egli non è uno specialista di filosofia in senso stretto, talvolta commette errori e fraintendimenti, non elabora un sistema proprio, ma si pone in costante dialogo con le menti illustri del passato, di cui cerca di riproporre i temi. Così, nell’Amatorius, egli elabora una sorta di rifacimento del Simposio platonico, declinandolo secondo i canoni della nuova sensibilità del suo tempo e, in questo modo, scostandosi talvolta dagli insegnamenti platonici: così l’obiettivo stesso del dialogo (dimostrare la superiorità dell’amore eterosessuale rispetto a quello omosessuale) è profondamente antiplatonico; verso l’omosessualità, Plutarco mostra una vera e propria repulsione, pur senza giungere a condannarla inappellabilmente (giacché era pur sempre stata un costume di grandi ingegni antichi).Il dialogo si finge narrato da Autobulo, un figlio di Plutarco, che racconta ad un certo Flaviano un episodio risalente ad anni addietro: i genitori di Autobulo (cioè Plutarco stesso e sua moglie, Timossena) si erano recati a Tespie, ai piedi del monte Elicona, per fare un sacrificio in onore di Eros e delle Grazie; la città era sconvolta dal gran parlare che si faceva intorno alla decisione della ricca vedova Ismenodora di sposare il giovanissimo Baccone. Alcuni parenti del giovane approvano la decisione, altri la rigettano: la cosa che più colpisce è che a decidere il tutto è Ismenodora, mentre Baccone accetta passivamente le decisioni altrui. A Plutarco, appartato nel santuario di Eros, giungono informazioni sulla vicenda e ciò costituisce lo spunto per il dialogo: intanto Ismenodora macchina, con l’appoggio di Baccone, un finto rapimento del giovane, in maniera da mettere la famiglia del ragazzo di fronte al fatto già compiuto; proprio mentre Plutarco sta tessendo l’elogio del matrimonio (contrapposto all’amore omosessuale) e della virtù delle donne, arriva la notizia dell’imminente felice matrimonio tra Baccone e Ismenodora. Nel corso del dialogo, Plutarco prova a dimostrare la natura divina di Eros, messa in dubbio da un interlocutore epicureo che si rivela piuttosto critico verso la religione. Se nel Simposio platonico Eros era un daimon, Plutarco lo descrive invece come un vero e proprio dio, grazie ad un’appassionata argomentazione dialettica:
“Tu vuoi rimuovere gli inamovibili fondamenti della nostra fede negli dei, quando chiedi per ciascuno di loro una dimostrazione razionale. La fede ancestrale dei nostri padri si fonda su se stessa, non si può trovare ed escogitare prova più chiara di essa […]. Questa convinzione è una base, un fondamento comune posto all’origine della pietà religiosa; se in un solo punto viene messa in discussione la sua solidità e risulta scossa la convinzione generale, essa diventa tutta quanta instabile e sospetta” (Amatorius, 13, 756 B)
AGRIPPA
Il filosofo scettico Agrippa, vissuto nella seconda metà del I secolo d.C., non rimase soddisfatto della tavola dei dieci «tropi» redatta da Enesidemo.
Egli ne formulò una nuova, composta da cinque «tropi», che andò ad affiancarla al fine di rafforzare la conclusione della necessità di sospendere sempre il giudizio.
Il primo «tropo» concerne la discrepanza dei giudizi (diaphonia) rilevabile sia presso i filosofi, sia nella gente comune, a proposito di qualsiasi questione si prenda in esame. Il secondo «tropo» rileva come, se si vuole risolvere una questione, occorra addurre una prova: ora, nessuna prova si rivela esaustiva: ogni prova ha bisogno di un’altra prova, e, questa, di una ulteriore prova, e così si cade in un processo all’infinito. Il terzo «tropo» chiama in causa la relatività, evidenziando come ogni oggetto appaia in un certo modo solo in relazione al soggetto che lo giudica.
Il quarto «tropo» mostra come i filosofi dogmatici, per tentare di sfuggire al processo all’infinito, assumano i loro principi primi senza dimostrazione, pretendendo che essi siano immediatamente degni di fede. Il quinto «tropo» riguarda il «diallele», che si verifica quando, per voler dar ragione della cosa ricercata, la si presuppone dalla ragione stessa che si adduce per spiegarla, o, meglio ancora, quando la cosa che si assume per spiegazione e la cosadi cui si vole dare spiegazione hanno bisogno l’una dell’altra. Scrive Sesto Empirico:
“nasce il diallele quando ciò che deve essere conferma della cosa cercata ha bisogno, a sua volta, di essere provata dalla cosa cercata: allora, non potendo assumere nessuno dei due per concludere l’altro, sospendiamo il giudizio intorno ad ambedue”. (Schizzi pirroniani, I, 169).
I «tropi» di Agrippa cercano di colpire non solo le rappresentazioni, ma la possibilità stessa dei ragionamenti: chi si propone di spiegare qualcosa attraverso i ragionamenti, infatti, si ritrova imprigionato: (a) si perde in un processo all’infinito (b) o incappa nel circolo vizioso del diallele, (c) oppure assume punti di partenza ipotetici, quindi indimostrati. La necessità di sospendere il giudizio su tutto ne risulta definitivamente confermata. Brochard afferma: “i cinque tropi possono essere considerati come la formula più radicale e più precisa che sia mai stata data allo scetticismo”.
DIOGENE DI ENOANDA

«Per piccole cose la sorte incide sul saggio; le maggiori e più importanti, il ragionamento le ha sempre amministrate e per tutto il tempo della vita le amministra e le amministrerà».
La diffusione delle idee filosofiche era stata affidata da sempre alla voce o al libro. Ma nella piccola città di Enoanda, nella Licia (Asia Minore), un ricco convertito alla filosofia del Giardino, di nome Diogene, vissuto nel II secolo d.C., entusiasta della parola di Epicuro, decise di diffonderla in un modo del tutto nuovo.
Acquistò un vasto terreno su un’altura, vi fece costruire una piazza circondata da un portico ornato di statue, di forma rettangolare. In uno dei lati minori fece costruire le porte di ingresso; nell’opposto lato minore fece forse costruire il suo sepolcro; nei due lati maggiori fece incidere su lapidi un condensato, piuttosto ampio e circostanziato, della filosofia di Epicuro, corredato altresì con massime e con sentenze tratte dalle opere di Epicuro stesso.
Le iscrizioni, che erano disposte, probabilmente, ad altezza d’occhio, dovevano costituire un vero e proprio libro inciso sulla pietra.
Gli scavi archeologici compiuti sulla collina di Enoanda a partire dalla fine dell’Ottocento hanno portato alla luce ampi frammenti di questo libro murale.
Diogene aveva trovato nel filosofo del Giardino la dottrina che dona la pace e la tranquillità dell’anima, e, per amore di tutti gli uomini «dotati di buon senso», affinché non si perdessero in vane ricerche e non fossero colti da vani timori, volle mettere a loro disposizione il messaggio di salvezza rivelato agli uomini da Epicuro.
“Essendo al tramonto della vita – per vecchiaia appunto essendo quasi sul punto di staccarmi dal vivere – con un bel peana sulla pienezza dei suoi piaceri abbiamo voluto, per non essere colti prima dalla morte, soccorrere subito quelli che hanno buon senso. Se dunque uno soltanto, o due, o tre, o quattro, o cinque, o sei, o quanti tu vuoi che siano di più, o uomo, di un tal numero – ma certo non moltissimi – fossero malati, anche chiamandoli ad uno ad uno farei tutto ciò che è in mio potere per portarli alla migliore deliberazione. Ma poiché, come ho detto prima, i più sono in generale contaminati, come in una pestilenza, dalle loro errate opinioni sulle cose, e diventano anche di più (infatti per la reciproca imitazione si trasmettono l’un l’altro la malattia come le pecore) ed è giusto soccorrere anche quelli che verranno dopo di noi (anche quelli infatti sono nostri, anche se non sono ancora nati), ed è filantropico soccorrere anche gli stranieri che capitano qui, poiché dunque i benefici dello scritto si estendono a parecchie persone, ho voluto impiegando questo portico, porre in pubblico i farmaci della salvezza, dei quali appunto in una sola parola potremmo dir chiare a tutti le forme: infatti abbiamo dissolto le paure che ci dominano senza motivo e, dei dolori, alcuni li abbiamo davvero troncati via completamente, mentre quelli fisici li abbiamo ridotti assolutamente a poco, rendendo infinitesimale la loro grandezza” (A. Casanova, I frammenti di Diogene d’Enoanda, Firenze, pp. 90-94).
Diogene volle estendere questo messaggio di salvezza (salvezza tutta terrena) a tutti gli uomini senza distinzione, sia Greci sia stranieri, perché tutti gli uomini sono cittadini di quell’unica patria che è il mondo.
“E non di meno invero preparavamo queste cose anche per i cosiddetti stranieri, che in realtà non lo sono. Infatti, secondo ogni divisione della terra, chi ha una patria e chi ne ha un’altra, mentre, in base all’intero complesso di questo mondo, unica patria di tutti è tutta la terra, e il mondo è l’unica casa” (Ivi, pp. 184-185).
Il portico, con le sue incisioni, volle essere un libro per le generazioni presenti e per quelle future, un libro che Diogene volle consegnare alla pietra, affinché restasse indelebile.
Diogene chiedeva al visitatore del luogo di non avvicinarsi allo scritto distrattamente e, in secondo luogo, nel caso che provasse indifferenza o addirittura un sentimento di avversione, di evitare di dare uno sguardo qua e là e di andarsene via.
“Nessuno di voi io trascino a testimoniare con leggerezza e senza riflessione in favore di chi dice che queste cose sono vere – infatti non ho dogmatizzato nulla –, ma, osservando tutto, contemporaneamente riflettete. Una sola cosa vi chiedo, come anche prima, di non accostarvi agli scritti alla maniera in cui uno passa per la via, nemmeno nel caso che ci sia un po’ di indifferenza o di noia, volgendovi qua e là a ciascuno di essi e passando via” (Ivi, pp. 186-188).
Dai frammenti pervenutici, non pare che Diogene si occupasse espressamente della «canonica» epicurea, ma, nel corso dell’esposizione della «fisica», egli ne ribadiva i princìpi fondamentali, e in particolare il principio dell’assoluta validità della sensazione e la ferma convinzione circa la possibilità di raggiungere il vero, polemizzando contro coloro che avevano inficiato con le loro dottrine la validità di questi princìpi.
Per quanto concerne le dottrine propriamente fisiche, almeno nei frammenti pervenutici, noi ritroviamo le tipiche tesi dell’Epicureismo: dalla teoria degli atomi a quella dell’infinità dei mondi, dalla dottrina dell’anima a quella dei simulacri, dalla dimostrazione della tesi che la morte non è temibile (perché l’anima, e quindi il sentire, perisce col corpo) alla riaffermazione della tesi della naturalità del linguaggio.
Inoltre Diogene sembra ribadire la tesi che i fenomeni naturali sono spiegati da molteplici cause, e che non bisogna prendere posizione a favore di una sola delle possibili soluzioni.
Degna di rilievo è, poi, la difesa che egli accampa contro le accuse rivolte agli Epicurei di «empietà» e «ateismo»; egli menzionava espressamente i nomi dei veri empi e dei veri atei (gli accusatori di Socrate e di Anassagora, Diagora, Protagora), e affermava energicamente:
“Veneriamo gli dei, sia in feste che in occasioni qualunque, egualmente sia in pubblico che in privato, e seguiamo i patrii costumi verso di loro” (Ivi, p.142)
Nell’esposizione dell’«etica» Diogene additava il fine della vita – dal cui raggiungimento dipende in toto la felicità – nel piacere, ancora una volta in pieno accordo col verbo di Epicuro.
Egli polemizzava vivacemente contro gli Stoici, che indicavano il fine della vita nella virtù, la quale, a suo avviso, è solamente un mezzo e non un fine. In fin dei conti, Diogene – come la stragrande maggioranza degli altri Epicurei – si pone come divulgatore (più che come innovatore) del verbo di Epicuro nella sua forma originale.
“Io dico ora e sempre, gridandolo forte a tutti i Greci e i barbari, che il piacere è il perfetto compimento del migliore modo di vivere e che le virtù […] non sono mai un fine, ma sono produttrici del fine” (Ivi, p. 192)
A proposito dei piaceri, egli affermava:
“Nessun piacere di per sé è male; ma i mezzi di certi piaceri portano molti più turbamenti che piaceri” (Ivi, p.196)
Come mezzo per raggiungere l’«atarassia», ovvero l’assenza di turbamenti, veniva riproposto il «quadruplice farmaco» (il celebre «tetrafarmaco» epicureo), che così riassumeva:
“Dunque, quali sono le cose che turbano? Sono le paure, quella degli dei, quella della morte, quella dei dolori e, oltre a queste, il desiderio che va molto al di là dei limiti naturali. E infatti queste sono le radici di tutti i mali, e se recideremo queste alla base, nessuno dei mali spunterà in noi” (Ivi, p.249)
Inoltre, una serrata polemica doveva essere condotta contro le varie dottrine dell’immortalità dell’anima, come provano gli espliciti richiami alla dottrina della metempsicosi e alle ibride tesi degli Stoici.
Notevole doveva essere soprattutto l’energica polemica contro il Fato e contro la connessa dottrina della divinazione, nonché la difesa del movimento libero degli atomi e, quindi, della libertà umana (punto, questo, in cui – com’è noto – risiedeva la maggiore differenza tra la fisica epicurea e quella democritea).
Diogene difendeva, infine, la vecchiaia, mostrando come anche questa età recasse i suoi vantaggi e si opponeva fermamente a coloro che biasimavano la vecchiaia come «storpia».
Egli insegnava – in spirito squisitamente epicureo – che la vita può essere gustata sempre, fino all’ultimo momento, a patto che ci si renda conto che essa è un bene, il quale, fino a quando è presente, non può essere sopraffatto da nessun male.
Per l’epicureo la vita è sempre, in quanto tale e finché perdura, senza eccezioni, il bene assoluto: basta viverla come si deve, ossia usando i «farmaci della salvezza», per essere sempre felici.
La seguente ricostruzione di un’iscrizione esprime alla perfezione il carattere morale di Diogene:
“Per piccole cose la sorte incide sul saggio; le maggiori e più importanti, il ragionamento le ha sempre amministrate e per tutto il tempo della vita le amministra e le amministrerà” (Ivi, p.314)
SESTO EMPIRICO

Lo scetticismo, fiorito in età ellenistica con Pirrone di Elide e con i suoi successori, non si presenta come "scuola", poiché la sua stessa essenza è quella di essere una ricerca (skeyiV) inesauribile, cosicché gli Scettici non hanno propriamente nulla da insegnare: ed è per questa ragione che essi non lasciano testi scritti (eccezion fatta per Timone di Fliunte, le cui satire non sono tuttavia a noi pervenute). Per avere finalmente testi scettici dobbiamo attendere fino alla fine del II secolo d.C., quando Sesto detto "Empirico" (così soprannominato perché appartenente alla scuola medica empirica, secondo cui è impossibile conoscere le cause reali di una malattia: ci si può soltanto attenere agli effetti osservabili, eventualmente benefici, dei farmaci somministrati) compose un cospicuo numero di opere in cui faceva professione di scetticismo, rifacendosi soprattutto alla leggendaria figura di Pirrone. Sembra che sia nato intorno al 180 d. C., ma ci è ignoto il suo paese d’origine. Soggiornò ad Alessandria, Atene e Roma. Le sue opere mediche (comprendenti anche le Memorie mediche, le Memorie empiriche) sono andate perdute, insieme a un trattato Sull’anima.L’opera scettica invece ci è stata conservata e comprende: le Ipotiposi (o Schizzi) pirroniane, in tre libri, una sorta di compendio della filosofia scettica; Contro i dogmatici, in cinque libri, e Contro i matematici, in sei libri (contro coloro che in generale detengono le diverse forme di sapere e pretendono di possedere dottrine definitive e certe, dal greco maqhma). Morì verso il 220 d. C. Accennavamo poc’anzi alle simpatie di Sesto per la filosofia di Pirrone: non a caso Sesto etichetta il proprio pensiero come "pirroniano" e valuta negativamente i contributi che allo scetticismo avevano dato gli Accademici Carneade e Arcesilao, in quanto essi finivano per negare l’assunto fondamentale della dottrina pirroniana: la sospensione del giudizio (epoch); Carneade la sostituiva con il criterio del "persuasivo" (piqanon) e Arcesilao con quello del "ragionevole" (eulogon). Ma per Sesto entrambe queste forme sostitutive tradiscono immancabilmente l’essenza dello scetticismo. Parlando di "inconoscibilità" delle cose, anche Arcesilao e Carneade sono per Sesto scivolati nell’aborrito dogmatismo. Nei primi sei libri della sua opera Contro i matematici (Adversus mathematicos), letteralmente "contro chi insegna discipline", Sesto Empirico demolisce le pretese di scientificità accampate da varie discipline, come la grammatica e la retorica, la geometria e l’aritmetica, l’astrologia e la musica. Nei restanti cinque libri dell’ Adversus mathematicos Sesto sottopone a serrata confutazione le filosofie dogmatiche, seguendo la tripartizione canonica di logica, fisica ed etica. Nella sua opera più famosa – intitolata Schizzi pirroniani e articolata in tre libri -, Sesto premette alla confutazione un sommario di filosofia scettica, insistendo sull’originalità della posizione scettica (da un lato, nessuna forma di filosofia può essere paragonata allo scetticismo, e dall’altro questo ha gli strumenti per confutare le altre filosofie). Già nel I secolo a.C. Enesidemo aveva fatto rivivere una forma di scetticismo che si richiamava all’antico ammaestramento di Pirrone, in un’opera dal titolo emblematico: Discorsi pirroniani. Enesidemo aveva sostenuto che è impossibile conoscere le cause delle cose e fare inferenze attraverso segni indicativi, ossia inferire da ciò che è evidente ciò che di per sé non è tale, per esempio dal sudore che affiora sulla pelle l’esistenza di pori non percepibili. Enesidemo aveva inoltre ravvisato dieci tropoi, ossia dieci modi di argomentazione che conducono a sospendere il giudizio sulla verità o falsità delle tesi avanzate dai dogmatici. Essi sottolineano, ad esempio, la diversa costituzione degli individui, la quale dà luogo a percezioni differenti degli stessi oggetti, così come le differenze di educazione o delle leggi danno luogo a diverse valutazioni di ciò che è buono o cattivo, giusto o ingiusto. Sulle orme di Enesidemo, Agrippa assunse altri cinque tropoi, i quali argomentano l’impossibilità di dimostrare qualcosa. Infatti ogni dimostrazione parte da premesse che, per essere dimostrate, richiedono altre premesse, le quali a loro volta rinviano ad altre premesse, e così via all’infinito; ma se è possibile regredire in questo modo all’infinito, allora non è possibile avere alcuna dimostrazione certa a partire da premesse certe. Se invece si raggiungono conclusioni a partire da premesse, le quali a loro volta sono dimostrate a partire da quelle stesse conclusioni, si cade nel diallele o circolo vizioso. Resta la possibilità di assumere come punti di partenza ipotesi che non richiedano di essere dimostrate, ma in tal caso – nota Agrippa – è possibile assumere come ipotesi di partenza anche il contrario di qualsiasi premessa, cosicché anche in questo modo non è possibile costruire dimostrazioni certe. Ne segue allora per Agrippa la necessità dell’epoch, della sospensione di giudizio a cui ricorreva già Pirrone. Sesto Empirico fa proprie queste riflessioni di Enesidemo e di Agrippa finalizzate a distruggere la totalità delle dottrine filosofiche e cerca di mostrare le divergenze insanabili o le contraddizioni logiche alle quali tali dottrine danno luogo, anche nei casi in cui esse convergano. Esse sono costruite su dogmata, ovvero su presupposti assunti dogmaticamente come certi ma che, appena analizzati dall’occhio demolitore dello scettico (che non fa riferimento ai dogmi), crollano miseramente: a Sesto Empirico l’intera storia della filosofia appare incapace di offrire un criterio di verità che consenta di scegliere una filosofia piuttosto che un’altra: si genera in tal maniera un labirinto di filosofie, a cui ciascuno dà il proprio assenso in modo dogmatico. La critica alle filosofie dogmatiche fa affiorare infatti l’isosqeneia (letteralmente: uguaglianza di forza), l’egual peso delle tesi contrapposte e l’impossibilità di privilegiarne una se non in maniera dogmatica. Solo l’epoch permette di uscire dal dedalo delle credenze filosofiche, ma per giungere ad essa occorre un esame delle alternative della tradizione filosofica: solamente da questa ricognizione può risultare l’impossibilità di scegliere una di esse. In questo senso, la filosofia scettica è necessariamente parassitaria rispetto alle altre filosofie, ne ha bisogno per raggiungere il suo scopo (cioè la sospensione del giudizio e l’ataraxia – assenza di turbamento – che ne deriva) ma, dopo averlo raggiunto, può distruggere gli stessi argomenti dei quali si è servita, come chi, dopo essere stato in alto con una scala, butta giù la scala (immagine che torna in Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus 6.53-7) o come un purgante che, espellendo gli umori, espelle insieme anche se stesso. Solo la sospensione dell’assenso può garantire quella libertà che tutte le filosofie dogmatiche – in primis quella stoica, costante bersaglio polemico degli Scettici – intendono ritrovare nel sapiente ma che puntualmente non trovano a causa del loro stesso dogmatismo soffocante. In una vita libera dalle opinioni (le quali generano solo turbamento) il criterio della condotta sarà allora da riporre nei fenomeni, ovvero nelle cose come appaiono, senza pronunciarsi sulla loro verità o falsità, nelle consuetudini, nelle leggi, negli insegnamenti delle tecniche. In tal maniera il filosofo scettico viene nettamente a distinguersi da tutte le altre figure di filosofo, che sempre – anche se secondo modalità diverse – legittimano la propria identità attraverso la presa di distanza rispetto alle regole e ai modi della vita ordinaria. Al contrario, il filosofo scettico si radica nella vita ordinaria, alla stregua degli altri uomini: a differenza delle dottrine filosofiche, essa non richiede giustificazioni. E in tal modo lo scettico può realmente addivenire all’assenza di turbamenti, che è l’obiettivo ultimo della filosofia stessa. Il filosofo dogmatico, dal canto suo, è sempre teso a sostenere o perseguire qualcosa, ma da ciò non può nascere che turbamento, mentre all’epoch segue sempre, "come ombra", l’ataraxia. Il filosofo scettico risulta allora il terapeuta non delle passioni che attanagliano i più, bensì della malattia del dogmatismo che affligge i filosofi.
BRANI ANTOLOGICI
a) Raffronto fra lo scetticismo e le altre filosofie (Schizzi pirroniani, I, 210; 213-214; 219; 220-232)
1 Che dalla filosofia eraclitea differisca l’indirizzo nostro è manifesto: e invero Eraclito di fronte a molte cose oscure si pronuncia dogmaticamente; noi invece no.
2 La filosofia democritea dicono che abbia una comunanza con lo scetticismo, poiché pare servirsi della nostra stessa materia. Che dal fatto che il miele ad alcuni appare dolce, ad altri amaro, dicono che Democrito conclude non esistere per sé stesso né il dolce né l’amaro e per questo pronuncia l’espressione "non piú", che è un’espressione scettica. Tuttavia è differente il senso con cui adoperano quest’espressione "non piú" gli scettici e i democritei; poiché questi mettono avanti quest’espressione nel senso che non esiste né l’una né l’altra cosa, noi invece nel senso che ignoriamo se l’una o l’altra, oppure se né l’una né l’altra cosa esiste di quelle che appaiono.
3 Nell’affermare che la materia è fluttuante e che in essa sono contenute le ragioni di tutti i fenomeni, Protagora dogmatizza, mentre si tratta di cose oscure e sulle quali noi sospendiamo il giudizio.
4 Taluni affermano che la filosofia accademica sia la stessa che lo scetticismo […]. I seguaci dell’Accademia nuova, anche se dicono che tutte le cose sono incomprensibili, differiscono, forse, dagli scettici anche per ciò stesso, che dicono che tutte le cose sono incomprensibili (essi infatti affermano recisamente codesto punto, mentre lo scettico si aspetta, anche, che qualche cosa si possa comprendere). Differiscono poi manifestamente da noi nel giudizio dei beni e dei mali. E invero gli Accademici dicono che una cosa è bene e male, non al modo nostro, ma con la persuasione che quello che essi dicono essere bene, sia piú probabile del suo contrario. Altrettanto dicasi di quello che affermano essere male. Noi invece diciamo che una cosa è bene o male, senza credere che quello che noi diciamo sia probabile.
5 Poiché Carneade e Clitomaco parlano di un prestar fede e di un probabile accompagnato da una forte inclinazione, noi, invece, di un "credere", cosí, semplicemente, senza propensione, si differirebbe da essi anche in questo. Ma anche in ciò che riguarda il fine differiamo dalla nuova Accademia. E invero coloro che dicono di governarsi secondo quella setta, si servono del probabile per la vita. Invece noi, pur seguendo le leggi e i costumi e le affezioni fisiche, viviamo senza dogmi. Arcesilao invece, capo e iniziatore dell’Accademia di mezzo, pare a me che partecipi proprio dei ragionamenti pirroniani, tanto da essere unico l’indirizzo suo e il nostro. E invero né si trova che egli si pronunci intorno all’esistenza né intorno alla non esistenza delle cose, né giudica preferibile rispetto alla credibilità o non credibilità, una cosa o un’altra, ma in tutto sospende il suo giudizio.
b) Lo scettico e la possibilità di confutare il dogmatismo (Schizzi pirroniani, I, 2-4; 10)
Rispondiamo a coloro che sempre hanno in bocca che lo scettico non è affatto in grado né di investigare né di intendere le loro affermazioni dogmatiche. Dicono infatti: o lo scettico comprende quello che i dogmatici dicono, o non comprende. Se comprende, come potrebbe aver dubbi intorno a ciò che dice di aver compreso? Se non comprende, certo, intorno a quello che non ha compreso neppure sa parlare […]. Coloro che cosí parlano, rispondano ora a noi in che senso essi intendono la parola "comprendere": se nel senso di avere semplicemente la nozione, senza affermare recisamente l’esistenza di ciò di cui ragioniamo, oppure nel senso di aver la nozione e di affermare contemporaneamente l’esistenza delle cose di cui discorriamo. Poiché se per "comprendere" intendono, nel loro discorso, l’assentire alla rappresentazione catalettica, in quanto la rappresentazione catalettica proviene dalla cosa esistente, con l’impronta e il sigillo conforme alla cosa esistente, quale non potrebbe derivare da una cosa non esistente, in tal caso nemmeno essi vorranno probabilmente non essere in grado di investigare intorno a ciò che non hanno compreso in sí fatta maniera […]. Se invece diranno che non s’ha da intendere cosí la comprensione di ciò che forma l’oggetto della ricerca, ma come una nozione semplicemente, non è impossibile a coloro che sospendono il loro giudizio intorno all’esistenza delle cose oscure, il ricercare. Infatti lo scettico non è escluso, penso, dalla nozione che deriva e da ciò che impressiona i suoi sensi e dai ragionamenti che gli appaiono evidenti, quando essa nozione non induca in modo assoluto l’esistenza di ciò che forma oggetto della nozione.
LA LOGICA PROPOSIZIONALE DEGLI STOICI
Gli Stoici sognano un gran numero di ragionamenti indimostrati, ma ne espongono specialmente questi cinque, ai quali sembrano ridursi tutti i rimanenti: 1° quello che dalla connessione e dall’antecedente conclude il conseguente, come “Se è giorno, c’è luce. Ma è giorno. Dunque c’è luce. 2) Quello che dalla connessione e dal contrario del conseguente conclude il contrario dell’antecedente, come: “Se è giorno, c’è luce. Ma non c’è luce. Dunque non è giorno”. 3) Quello che da un collegamento negativo e da una delle parti del collegamento conclude il contrario dell’altra parte, come “Non è giorno e notte. Ma è giorno. Dunque non è notte”. 4)Quello che da un collegamento disgiuntivo e da una delle parti collegate conclude il contrario dell’altra, come “O è giorno o è notte. Ma è giorno. Dunque non è notte”. 5)Quello che da un collegamento disgiuntivo e dal contrario di una delle parti collegate conclude l’altra, come: “O è giorno, o è notte, ma non è notte. Dunque è giorno”. (Schizzi pirroniani, II, 109-117)
L’IMPLICAZIONE FILONIANA E DIODOREA
Si prenda ad esaminare tra queste, per il momento, la cosiddetta proposizione ipotetica. Questa risulta composta da una proposizione duplicata oppure da proposizioni fra loro differenti e collegate per mezzo della congiunzione ‘se’ o ‘se davvero’: così, ad esempio, da una proposizione duplicata e dal ‘se’ congiunzione viene a risultare la seguente ipotetica: ‘se è giorno, è giorno’; invece da proposizioni fra loro differenti e collegate mediante la congiunzione ‘se davvero’ viene a risultare quella che suona così: ‘se davvero è giorno, c’è luce’.[…] Ragion per cui, se si rispetta questa promessa e se il conseguente tien dietro all’antecedente, anche l’ipotesi risulta vera; se, invece, questa promessa non viene mantenuta, l’ipotetica risulta falsa. Perciò, prendiamo subito le mosse da questo punto e mettiamoci a considerare se si possa trovare una qualsiasi proposizione ipotetica che sia vera e rispettosa delle premesse suddette. (Sesto Empirico: Contro i logici, II, 109-117)
LATTANZIO

“Voglio dunque esporre quell’importantissima verità che mai i filosofi, che pur hanno detto il vero, hanno potuto scoprire, perché non seppero dedurre fino in fondo le conseguenze. Il mondo è stato creato da Dio, perché nascesse l’uomo. Gli uomini sono stati creati, perché riconoscessero Dio come padre: in ciò consiste la sapienza. Essi riconoscono Dio per onorarlo: in ciò consiste la giustizia. Essi lo onorano, per riceverne il premio dell’immortalità. Ricevono poi il premio dell’immortalità, per servire Dio in eterno. Vedi dunque come tutto è concatenato: il principio con il mezzo, e il mezzo con la fine? Consideriamo dunque le singole asserzioni, e vediamo se le prove reggono. Dio ha creato il mondo per l’uomo. Chi non vede ciò, non si distingue molto dagli animali. Chi guarda su in cielo, fuori che l’uomo? Chi ammira il sole, le stelle e tutte le altre opere di Dio, fuori che l’uomo? Chi coltiva la terra? Chi ne raccoglie i frutti? Chi naviga sul mare? Chi ha in suo potere i pesci, gli uccelli e i quadrupedi, se non l’uomo? Dunque Dio ha fatto tutto in vista dell’uomo, perché tutto è stato lasciato in uso all’uomo. Ciò hanno riconosciuto rettamente anche i filosofi pagani; ma la conseguenza che ne risulta, non l’hanno vista: che cioè Dio ha creato l’uomo stesso per Dio. Eppure questa sarebbe stata la conclusione ovvia, doverosa e necessaria” (Epitome delle Divine Istituzioni, 36-37).
Vita
L. Cecilio Firmiano Lattanzio nacque in Africa da famiglia pagana intorno alla metà del III secolo d.C.: fu allievo di Arnobio a Sicca. Per la sua fama di retore, Lattanzio fu chiamato da Diocleziano a Nicomedia, in Bitinia, capitale della parte orientale dell’Impero e residenza ufficiale dell’imperatore, come insegnante di retorica latina. Convertitosi in data imprecisata al cristianesimo, dopo gli scarsi risultati nell’insegnamento (data la prevalenza a Nicomedia di allievi greci), fu costretto a ritirarsi dall’incarico perché colpito dalle persecuzioni del 303, vivendo in miseria. Lattanzio abbandonò la Bitinia nel 306 per ritornarvi cinque anni dopo, forse grazie all’editto di tolleranza di Galerio, e nel 317 fu chiamato da Costantino a Treviri, in Gallia, come precettore di Crispo, figlio dell’imperatore. Probabilmente morì a Treviri dopo questa data. Tra il 303 e il 317 Lattanzio compone una nutrita serie di scritti apologetici, assumendo come modello il latino di Cicerone, fluente e architettonicamente ben strutturato: tra questi, le Istituzioni divine (Divinae Institutiones), in sette libri, sono un attacco indirizzato alla religione e alla filosofia pagane, alle quali il nostro autore contrappone i capisaldi della dottrina cristiana. L’opera Sulla creazione di Dio (De opificio Dei) è invece innervata dall’elogio della sapienza dispiegata da Dio nel creare l’uomo, del quale Lattanzio esalta la bellezza e la finalità. Sulle morti dei persecutori (De mortibus persecutorum) è invece un’opera dedicata alla tremenda fine dei persecutori dei Cristiani.
Opere
Perdute le opere che precedettero la conversione, nonché l’epistolario, di Lattanzio abbiamo – come dicevamo poc’anzi – numerosi scritti apologetici:
1. De opificio Dei (303-304): in quest’opera, Lattanzio esalta la potenza divina che si riflette nell’atto della creazione di quel microcosmo che è il corpo umano.
2. Divinae Institutiones (304-313): il titolo si contrappone alle Institutiones pagane, di tipo oratorio o giuridico; si tratta, infatti, di un trattato in sette libri che si propone non solo l’apologia del Cristianesimo tramite la confutazione degli errori pagani (libri I-III: De falsa religione, De origine erroris, De falsa sapientia), ma anche di fornire ai cristiani un manuale sistematico in cui dare un’esposizione complessiva del pensiero cristiano (libri IV-VII: De vera sapientia et religione, De iustitia, De vero cultu, De vita beata). Il grande successo dell’opera portò Lattanzio stesso a farne, dopo il 314, un riassunto (Epitome).
3. De ira Dei (dopo il 313): Lattanzio polemizza con gli Stoici e gli Epicurei, sostenitori dell’atarassia e dell’imperturbabilità degli dèi, affermando che Dio interviene nelle vicende umane, in bene o in male, specie per punire gli uomini che lo offendono. In particolare, Lattanzio si accanisce contro Epicuro e la sua convinzione del disinteresse divino per le umane vicende.
4. De mortibus persecutorum (316-21): di dubbia attribuzione per la violenza dello stile e delle sferzanti requisitorie, l’opera intende dimostrare che Dio ha sempre punito i persecutori dei cristiani, da Nerone in poi. L’attribuzione è dubbia per l’insistenza sulle immagini macabre e allucinate delle varie morti dei persecutori e per la violenza ed il compiacimento per la loro punizione, estranee alla medietà stilistica ed argomentativa di Lattanzio. Gli imperatori si dividono in due categorie: quelli che hanno tollerato o aiutato il Cristianesimo e quelli che l’hanno perseguitato. Contro questi ultimi si è abbattuta l’ira divina, che ha inferto loro tremende punizioni. Tra gli imperatori “amici” del Cristianesimo spicca la figura di Costantino, che assurge a vero e proprio simbolo del rapporto tra potere e Chiesa.
5. Carmen de ave Phoenice: di attribuzione incerta, è un carme simbolico che descrive, in 85 distici elegiaci, il mito della leggendaria fenice, che rinasce dalle sue ceneri: chiaramente nella fenice si adombra l’immortalità dell’anima o la resurrezione di Cristo.
Considerazioni
Lattanzio è essenzialmente un retore, che però possiede notevoli conoscenze filosofiche: come il suo maestro Arnobio, convertitosi al cristianesimo nell’età matura, resta legato più profondamente a schemi argomentativi e teorici della cultura classica, specie neoplatonica, assorbendo superficialmente gli elementi dottrinari e teologici cristiani. Già affermava san Girolamo, nelle sue biografie degli scrittori cristiani: “Lattanzio, che è quasi un fiume di eloquenza ciceroniana, magari avesse reso salde le nostre dottrine come ha smontato quelle altrui!”. Infatti, Lattanzio eccelle nella forma, in cui imita l’ampio periodare e il lessico di Cicerone, proponendosi in questo modo di accostare al cristianesimo i pagani colti. Tuttavia tanto la sua conoscenza della dottrina cristiana quanto in generale la sua cultura filosofica non sono all’altezza di questo stile, poiché spesso Lattanzio confonde e sbaglia nell’interpretare le stesse dottrine filosofiche pagane, attingendo il più delle volte a raccolte manualistiche e a compendi che legge erroneamente o frettolosamente. Resta comunque ammirevole il suo stile fluente e il fatto che l’argomentazione sia stringente e segua un preciso filo logico, secondo i dettami retorici. Nel De opificio Dei traspare un’evidente impostazione filosofica, mentre le Divinae Institutiones sembrano ormai lontane dalla filosofia e saldamente ancorate nella tradizione della sistematizzazione della dottrina cristiana. Interessantissimo è lo studio che il nostro autore conduce sul politeismo, indagandone le radici a partire dalla divinizzazione dei grandi uomini. In contrapposizione con Tertulliano, che traccia una vera e propria cesura tra filosofia antica e Cristianesimo, Lattanzio sembra sostenere che l’insuperabile grandezza del Cristianesimo risieda nella capacità di appropriarsi al meglio della cultura dei Greci, dei quali è, in un certo senso, il “frutto” naturale. E del resto, Lattanzio intrattiene coi filosofi greci un dialogo incessante, quasi come se anch’essi avessero sinceramente cercato la verità con ogni sforzo senza però riuscire a rinvenirla poiché non soccorsi dalla Rivelazione cristiana. Si tratta dunque di recuperare quanto di vero la ragione ha scoperto tramite i filosofi per poi arricchirlo dell’eterna verità rivelata da Dio.
GIULIANO

VITA
Nipote di Costantino I, figlio di Giulio Costanzo – figlio di secondo letto di Costanzo Cloro – e di Basilina, Flavio Claudio Giuliano (336-363) scampa allo sterminio dei maschi della famiglia per ordine di Costanzo II. Trasferito in Asia Minore, Giuliano ricevette un’educazione cristiana dal vescovo ariano Eusebio di Nicomedia insieme al fratellastro Costanzo Gallo, figlio di Giulio Costanzo e di Galla. Durante un nuovo esilio in Cappadocia Giuliano, adolescente, si appassiona alla cultura classica. Nel 351 è ad Atene, dove studia, protetto dall’imperatrice Eusebia, per cui scriverà un appassionato panegirico, il neoplatonismo sotto Massimo di Efeso, che lo inizierà ai misteri eleusini e alla teurgia di Giamblico. Suoi compagni in questo periodo, sono Gregorio di Nazianzo e Basilio di Cesarea, che ce lo descrivono come un idiota deforme. Divenuto imperatore nel febbraio del 361 in seguito a una serie di fortunate campagne in Gallia, Giuliano fa di Lutezia (Parigi) la sua capitale. Dopo solo poco più di due anni e di governo, Giuliano viene ucciso nella primavera del 363 nel corso della campagna contro i Sassanidi da un soldato cristiano, come riferito dall’amico e maestro Libanio, celebre rètore di Antiochia. Presso la chiesa monofisita (copta), Mercurio, questo il nome dell’assassino di Giuliano, è considerato santo.
IL PENSIERO
Giuliano individua nell’ormai affermatosi cristianesimo una delle cause principali della decadenza dell’Impero sotto molti punti di vista, inclusi quello economico e sociale: trova infatti riprovevole che una setta giudaica, emarginata dagli stessi giudei, si arroghi il diritto di disprezzare la cultura atavica, fautrice dell’unità del mondo classico e responsabile del buon funzionamento dell’Impero: la nuova religione ha permesso a Costantino e ai suoi discendenti di legittimare i loro omicidi, ha destabilizzato la classe aristocratica con la sua predicazione di povertà e ha introdotto il terrore e il senso di colpa nella vita quotidiana. Giuliano è però consapevole che l’antica religione non potrà tornare a prevalere su un’organizzazione come quella cristiana; la soluzione è imitarla secondo uno schema analogo alla gerarchia ecclesiastica con criteri presi dalla teurgia ipostatica di Giamblico: ogni sacerdote presiederà al culto di ciascuna ipostasi, manifestazioni degli dèi, che sono manifestazioni a loro volta del Sol Invictus o della Grande Madre, ai quali dedicherà due importanti discorsi: ‘Alla madre degli dèi’ e ‘Ad Helios re’. I suoi proclama saranno sempre vòlti al contenimento pacifico del cristianesimo, a cui è fatto divieto di proselitismo – espressioni di ciò sono l’editto ‘De magistris’, che vietava ai pedagoghi cristiani di insegnare la cultura in cui essi non credevano e aborrivano, e l’epistola a Ecdicio, prefetto in Egitto, a cui è fatta ingiunzione, dopo che l’incarico è stato ignorato più volte, di espellere il vescovo Atanasio, reintegrato dall’imperatore dopo essere stato perseguitato da Costanzo II, e accusato di aver battezzato forzatamente diverse mogli di aristocratici. Nel contempo Giuliano dimostra grande tolleranza, preoccupandosi spesso di controllare che non venga fatta violenza ai cristiani nelle province dell’impero, come dimostrano le epistole agli abitanti di Bostra e al prefetto Atarbio. Lungi dal voler convertire i cristiani, Giuliano chiarisce più volte il suo desiderio di lasciare ai cristiani libertà di coscienza, fino ad esortarli a scacciare i vescovi che impongono comportamenti riottosi alla comunità (Agli abitanti di Bostra), rimanendo tuttavia sempre profondamente diffidente nei loro confronti perché ’’è a causa della loro demenza che tutto è stato sovvertito’’ (Ad Atarbio). Nei confronti degli Ebrei Giuliano ha un atteggiamento ambivalente: li rispetta in quanto fedeli di un culto originale, non invasivo e propriamente etnico, ma li disprezza anche per le insanabili contraddizioni che riscontra nello stesso, come spiega in maniera esaustiva nel trattato Contro i Galilei (Κατά Χριστιανων) giuntoci quasi integro grazie alla critica fattane da Cirillo di Alessandria, che lo censurò in alcune parti senza stravolgerlo. A Cirillo, mandante dell’omicidio di Ipazia, dobbiamo anche l’epiteto di ‘Apostata’ con cui Giuliano passò alla storia.
LE OPERE
Scrittore prolifico di epistole, orazioni, satire e veri trattati teologico-filosofici, Giuliano non lesinò sforzi affinché la sua opera di restaurazione dell’antica religione fosse validamente argomentata, e fu sempre un appassionato della diatriba e un arguto polemista. Ecco alcuni tra i suoi scritti più importanti:
Κατά Χριστιανων: Partendo dalla Genesi, questo trattato in 3 libri esamina la religione ebraica e le sue contraddizioni e dimostra come il Cristianesimo non sia che una deviazione irrazionale dell’Ebraismo nutritasi di leggende appartenenti ad altri culti: per cominciare, il Dio ebraico è una bestemmia in sé, essendosi dichiarato più volte geloso e vendicativo, qualità detestabili che certo non si addicono a una divinità; in secondo luogo, il fatto che abbia voluto tenere le sue creature nell’ignoranza del bene e del male e poi si sia adirato con loro quando ne hanno avuto conoscenza è un’aporia molto grave, perché ammette che Dio non sia onnisciente, altrimenti avrebbe saputo che Eva sarebbe stata la causa della caduta di Adamo e del genere umano tutto, senza contare l’invidia dimostrata vietando all’uomo di diventare come lui, cioè cosciente del bene e del male. Chiamando in causa il Timeo platonico, Giuliano lo confronta con la Genesi: Platone dice che il mondo è eterno e increato; la Genesi non dà secondo Giuliano nessuna notizia intorno all’eziologia dello ‘spirito di Dio che aleggiava sulle acque’ [Gen. 1, 2] o degli angeli: non riesce a comprendere come il Λογος possa creare dal nulla senza un sostrato; Dio avrebbe dunque solo organizzato il mondo. Ancora: perché solo gli Ebrei hanno potuto conoscere Dio e i gentili no, se Paolo ha poi affermato che si trattava di un Dio delle genti? Inoltre, ben diversamente dal demiurgo platonico, che aveva assegnato agli dèi il compito di dare le nature e le conseguenti leggi agli uomini secondo un criterio etnico che ricorda alla lontana il criterio geografico-climatico reso famoso da Montesquieu, il Dio giudaico mostra di ignorare completamente la natura della sua creatura, tanto che le lingue e le leggi risultano essere risultati della superbia, della ύβρις degli uomini che hanno costruito la torre di Babele. Sembrerebbe dunque che anche le società nascano dalla colpa, non solo l’uomo. E una volta date leggi universali, ché la Bibbia non spiega la varietà dei costumi, che senso ha il divieto di adorare altri dèi se lui è l’unico Dio e gli altri sono solo simulacri? Perché non li ha distrutti, come ha fatto qualche volta solo per scuotere gli increduli che lo sfidavano apertamente? Ma se si ammette questo, Dio non è, ancora, onnipotente, non potendo distogliere l’uomo dagli altri dèi, ritenuti falsi ma invidiati, o è malvagio e permette loro di esistere per sfogare la sua invidia e la sua gelosia. Quindi, giudei e cristiani si sono costretti a scegliere ancora tra due enormi bestemmie. Il demiurgo platonico ha fatto sì che uomini del calibro di Solone, Licurgo e Numa governassero greci e romani, ha dato la cultura agli uomini, ma il Dio ebraico no, non fu lui a insegnare la scrittura, mentre lo stesso Platone afferma nel Fedro che fu il dio egiziano Thot ad insegnarla ai popoli, così come non li istruì nelle arti, tutte mutuate dai popoli mesopotamici o dai greci. E poi costrinse il suo popolo a vivere da schiavi, prima degli Egiziani, poi degli Assiri e ad essere in più occasioni stranieri in terra straniera, cosa che i cristiani mostrano di aver interiorizzato al meglio. Non essendo le scienze concessioni divine i cristiani hanno finito con il considerarle nocive e opera del diavolo. Quanto a coloro che si proposero di essere evergeti ispirati dal dio, Salomone non è certo un esempio paragonabile a Licurgo o Solone, o le sue sentenze a quelle degli oratori, se, come dice il primo libro dei Re,’’ amò donne straniere e venerò dèi forestieri’’ , contravvenendo alla legge divina, oppure Davide, che non si fece scrupolo a far uccidere in modo subdolo l’ittita Urìa, marito di Betsabea, laddove i legislatori greci e romani adottarono misure efficaci per prevenire gelosia e superbia. Il cristianesimo non ha sanato queste scelleratezze, ché, come diceva Socrate (secondo Stobeo), gli uomini diventano cattivi a causa delle cattive compagnie e della cattiva educazione, sottinteso, il Dio ebraico e il comportamento da esso tenuto; le ha semplicemente ‘lavate’ con il battesimo, al solo scopo di attirare a sé il popolaccio e i ceti più bassi. Venendo ai testi proto-cristiani e ai Vangeli: i profeti nel loro annuncio mai hanno parlato di ‘Figlio unigenito di Dio’ o di consustanzialità, tutte cose raccontate dal solo Giovanni, che oltretutto non risolve il problema delle genealogie o dei nomi dei discepoli, notoriamente diverso da sinottico a sinottico. E così è stata mantenuta la tradizione di non conferire alcun aspetto divino alle istituzioni in terra: il battesimo non guarisce come fanno i miracoli, peraltro ritenuti da Giuliano atti di poco conto; la legge mosaica è violata senza alcun riguardo nonostante quanto si dice in Matteo: Non sono venuto per abolirla ma per rinnovarla, specie riguardo all’alimentazione: perché mangiare tutto quello che prima era proibito, e perché accanirsi con tanta ferocia sulle le usanze pagane se neanche questo prescrive il Vangelo? Oltre al rimaneggio arbitrario della Legge, Giuliano torna ad accusare Giovanni di essersi contraddetto, avendo detto prima che Dio è invisibile, e poi che è venuto in mezzo alla gente nella persona del Figlio. Il trattato si conclude con una difesa degli Ebrei, lodati per essersi tenuti sempre fedeli ai loro riti e di avere, secondo Giuliano, integrato elementi sincretici, come il vaticinio con gli uccelli e la circoncisione dai Caldei e dagli Egiziani, mentre i Cristiani non festeggiano più la Pasqua con gli azzimi per motivi non chiari. Ultimo elemento di non trascurabile importanza è l’elemento dell’Alleanza (il berit) costantemente rinnovata, della cui sincerità si dubita sempre meno, mentre i Cristiani stabiliscono tutto in maniera accessoria e quindi incoerente. (*)
Εις Ηλιον βασιλευον: L’Inno al Re Sole è il primo dei due scritti religiosi programmatici: Dichiaratosi seguace di Helios, il Sol Invictus, Giuliano descrive, in un linguaggio ermetico e suggestivo, come Helios sia l’ipostasi intelligibile del Bene: la luce del Sole è l’energia intellettuale che illumina gli spiriti, e gli dèi visibili, cioè gli astri, gli stanno intorno come a un saggio che illumina quanto è indispensabile alla vista. Gli dèi non sono più arbitrari burattinai di cui aver paura, come dicono i miti, ma presiedono alle funzioni più alte del cosmo, sono infatti detti ‘intellettuali’, secondo la teurgia giamblico-porfiriana, ipostasi fuse e disgiunte a un tempo della stessa essenza: l’intelligibile genera l’intellettuale. Il cosmo è composto da 36 parti costituite dalle ipostasi orientali, e così le città sono presiedute e fondate dai propri fondatori etnici secondo lo schema ‘a ciascuno il suo’ già menzionato.
Εις μητρί θεων: La ‘Madre degli dèi’ è la divinità asiatica (frigia e scitica) generatrice conosciuta dai Greci come Cibale, consorte del demiurgo Attis. Dopo la narrazione dell’arrivo della dea in processione a Roma da Pergamo e relativo prodigio (la dea fa arrestare la nave finché il cinto della vergine consacrata non viene posto alla prua, conferendo così alla dea il comando della nave, che percorse anche un lungo tratto controcorrente), l’analisi si sposta al luogo della materia, le cui essenze sono contenute in un corpo circolare perfetto, da identificarsi con l’anima, che, come uno specchio, ne delinea i contorni: la potenza vien sempre prima dell’atto. L’unione, il sinolo aristotelico, si compie tramite il terzo dio, Gallo (il latteo). Chi è la Madre degli dèi? E’ la sorgente di tutti gli dèi, la creatrice vergine avente in sé tutte le cause, la Provvidenza, la madre degli dèi intelligibili e intellettuali, cui principio complementare è Attis. Il libro prosegue con una descrizione, fortemente mistica e invero complessa, dei riti iniziatici frigi, considerati sanguinari e brutali dall’ateo Luciano, a Giuliano appaiono aurei e degni di ogni onore.
Μισοπογον: ‘L’odiatore della barba’: Come i filosofi greci e il principe filosofo Marco Aurelio, che Giuliano, come vedremo, ammira moltissimo, Giuliano portava la barba, cosa per cui veniva sbeffeggiato dalla comunità cristiana di Antiochia: Giuliano ironizza su se stesso, descrivendosi come uno sporcaccione sudicio e intransigente cui la barba impedisce anche di lavarsi: afferma di odiare tutti i divertimenti , guarda perfino sei corse in tutto! Si presenta come un cinico maldestro, tanto che, volendosi temprare al freddo, fece portare carboni ardenti nel fuoco, col risultato che il fumo lo fece addormentare. Loro, gli antiocheni, invece, gozzovigliano da mane a sera: per forza dubitano del loro Sire, così austero e selvatico! Il libro prosegue elencando i luoghi di culto a cui Giuliano non farebbe visita, essendo un cattivo Cesare, e fa menzione di alcuni avvenimenti quando girava per le province orientali, mescolandole in maniera non troppo chiara a riferimenti mitici. Dopo aver riferito alcune delle calunnie fattegli dai Cristiani, che avevano nostalgia di Costanzo II (che Giuliano chiama K), persecutore dei non ariani! Oltretutto gli antiocheni sono evidentemente incapaci nelle questioni giuridiche più banali, come le elezioni dei magistrati o nelle politiche economiche, che gestite in maniera truffaldina arricchendovi a spese del fisco. e allora ecco dove sta il mio sbaglio, dice Giuliano: nell’aver affidato a loro, ingrati crapuloni, il governo della città! Possano gli dèi ricompensarvi giustamente
Συμποσιον ή Κρονια: il Simposio o i Saturnali, che si rifanno esplicitamente a Luciano, benché non abbiano nulla a che vedere con i ‘Saturnalia’ lucianei, che è in parte dialogo, parte discorso e parte epistole fittizie ma piuttosto con il ‘Concilio degli dèi’, essendo un dialogo a più voci, benché la forma non sia quella dialogica, talvolta irriverenti nella migliore tradizione menippea. Il banchetto si tiene sull’Olimpo, dove Romolo ha invitato gli Imperatori, da Cesare a Costantino. Dopo una breve descrizione e un giudizio sull’operato di ciascun partecipante, il concorso comincia, ma non prima che venga invitato Alessandro. Tutto sembra pronto, ma ecco che Hermes si ricorda di Marco Aurelio, che fa un’entrata trionfale. Cesare e Alessandro, dopo un canto di Sileno,cominciano a battibeccare su chi sia stato il miglior conquistatore. E’ il turno di Ottaviano, che pose fine all’ultimo regno ellenistico e iniziò l’Impero, a cui dette solide leggi pur continuando a conquistare territori. La parola passa a Traiano, conquistatore della parte orientale dell’Europa sotto cui l’Impero raggiunse la sua massima estensione, sebbene Giuliano lo lodi e lo stigmatizzi per la sua mitezza. Quindi prende la parola Marco Aurelio, che, nonostante la diffidenza dei satiri verso la sua natura di filosofo, dichiara tranquillamente di non aver nulla da dire, consapevole che il vantarsi di cose già celebri non è atteggiamento sobrio. Infine si arriva a Costantino, il quale non aveva occhi che per la Mollezza […] e sembrava non interessarsi minimamente al giudizio. Ma siccome anche lui deve dire qualcosa, eccolo raccontare le sue battaglie vittoriose contro Massenzio e Licinio, uno vecchio e l’altro imbelle. Non esita a dichiararsi migliore di tutti, poiché dice, sotto il suo principato non vi furono lotte intestine, come sotto Ottaviano, Cesare e lo stesso Alessandro; recuperò la Dacia, occupata dagli invasori; usò clemenza ai tiranni avversari di Roma. Quanto a Marco Aurelio, per non aver detto nulla, si esclude da sé. Ma le sue ‘imprese’ sono ben poca cosa, come riconosce arrossendo lo stesso Costantino. Siamo al giudizio finale: Alessandro viene bocciato per la sua condotta lasciva e iraconda; Cesare per la sua incapacità di sedare l’invidia altrui, che poi lo uccise; Ottaviano per aver edificato templi in maniera arbitraria senza tener conto del reale merito di ciascuna divinità ma solo per abbellire Roma; Traiano viene trattato anche lui da iracondo, addirittura Diòniso lo apostrofa con un brutale ‘Va’ all’inferno’; Il saggio Marco Aurelio invece ammette pacatamente di aver voluto seguire un regime politico guardando agli dèi, ma la moderazione dello stile di vita è solo segno di umiltà, perché altre sono le cose in cui si devono imitare gli dèi: le sue azioni sono solo imitazioni delle grandi gesta compiute dai. Con tale semplicità, l’imperatore filosofo chiude il suo turno. Costantino, interrogato anche lui su cosa ritenga migliore in assoluto e positivo nel suo operato, risponde: essere molto compiacente nei confronti dei propri desideri e prestarsi a quelli degli amici. Al che Sileno, ridendo sgangheratamente: ma allora, se volevi essere un banchiere, hai forse dimenticato il tuo io, vivendo come un cuoco o una parrucchiera? Alludendo ai capelli lunghi, ricci e incolti dell’imperatore, e ora anche il tuo pensiero ti accusa. Dopo aver pronunciato il verdetto, Marco Aurelio vincitore, gli dèi invitano i Cesari e scegliersi la loro divinità protettrice: Alessandro e Traiano vanno da Eracle, Ottaviano da Apollo e Cesare viene accolto da Ares e Afrodite. Marco Aurelio intanto conversa con Zeus e Crono. Costantino, invece, non sapendo chi scegliere, corre dalla sua innamorata, la Mollezza, che lo abbraccia teneramente e, rivestitolo di indumenti preziosi, lo conduce dalla Dissolutezza, con cui è anche il Cristo, che proclama a gran voce la purificazione per seduttori, assassini, sacrileghi nonché infami; E se qualcuno divenisse colpevole delle stesse cose, gli concederò di tornare puro, purché si batta il petto e si percuota la testa. Ma non è tutto: dopo questa sprezzante sintesi del cristianesimo, Costantino e i figli vengono tormentati dai dèmoni per il suo ateismo e non meno per […] il sangue dei loro congiunti, finché Zeus, per rispetto a Claudio-da cui Costantino si vantava di discendere- e Costanzo –probabilmente Costanzo Cloro, tetrarca e padre pagano di Costantino- non permise loro di riaversi. Il libro si chiude con il buon augurio a Giuliano sotto il segno degli dèi misterici: Rispetta i suoi [di Mitra] comandamenti, ti creerai così, durante la vita, un punto di riferimento e un porto sicuro, e quando sarà momento di abbandonare la terra, insieme con la Buona Speranza avrai presso di te come guida il dio benevolo.
GREGORIO DI NAZIANZO

Gregorio (330-389/390) ebbe amici importanti. L’amico per eccellenza fu Basilio, conosciuto prima durante l’adolescenza a Cesarea di Cappadocia, e poi ad Atene, dove i due si erano recati a perfezionare i loro studi. “Sembrava che fossimo un’anima sola in due corpi” (Discorsi 43, 20), scriverà più tardi rievocando quegli anni. L’affetto tra i due non venne mai meno, anche se conobbe momenti di grande tensione. La personalità forte ed energica di Basilio si scontrava con quella di Gregorio, dotato di un animo poetico, emotivo, propenso alla solitudine e alla contemplazione. Basilio diede vita a una comunità monastica ad Annisoi, nel Ponto, ma Gregorio, che pur aveva aderito al progetto di vita concepito insieme negli anni ateniesi, lo abbandonò e preferì tornarsene nella casa paterna sognando di poter condurre una vita più solitaria e ritirata. Verso la fine del 361, o l’inizio del 362, venne, suo malgrado, ordinato presbitero dal padre, Vescovo di Nazianzo. “Mi piegò con la forza” (Autobiografia 348), scrive ricordando quell’evento. Reagì a quella violenza nel modo che gli era più usuale: con la fuga. Poi, dopo alcuni mesi, assunse in piena obbedienza il suo ministero, accettando, come più volte gli accadrà nel corso della vita, di essere condotto là dove non voleva andare (Gv 21, 18). A distanza di una decina d’anni, sarà lo stesso Basilio, che pure conosceva così bene i suoi sentimenti, a imporgli la consacrazione episcopale. Basilio, eletto Vescovo di Cesarea nel 370, si era visto costretto dalla politica ariana dell’imperatore Valente a moltiplicare il numero delle diocesi dipendenti da Cesarea, in modo da assicurare un certo numero di Vescovi fedeli a Nicea, che fossero in grado di fronteggiare l’avanzata dell’arianesimo. Gregorio, contro ogni suo desiderio, fu ordinato Vescovo di Sasima, un paesino di frontiera tra la Cappadocia prima e la Cappadocia seconda, nel quale, a dire il vero, non entrerà mai. Avrebbe dovuto entrarci con le armi in pugno, poiché Sasima, insignificante sotto l’aspetto pastorale, si trovava in una posizione strategica da un punto di vista economico e politico ed era contesa da un altro Vescovo ariano. Ma Gregorio continua a sostenere l’amico Basilio con la sua amicizia; come era intervenuto, anni prima, a mettere pace tra lui, ancora presbitero e il Vescovo Eusebio, così, durante gli anni dell’episcopato, lo difende da chi lo accusa di essere troppo prudente nel proclamare la divinità dello Spirito Santo, e lo consola con le sue numerose lettere. Nel 379 Basilio muore e Gregorio, malato, non può essere accanto all’amico. Nel 380, l’imperatore Teodosio chiamò Gregorio a Costantinopoli a guidare la piccola comunità cristiana fedele a Nicea e in questa città, Gregorio pronunciò i cinque discorsi che gli meritarono l’appellativo di “Teologo”. Ma Gregorio stesso precisa nei suoi scritti che la teologia non è “tecnologia”, non è un’argomentazione umana, ma nasce da una vita di preghiera, da un dialogo assiduo con il Signore. In qualità di Vescovo di Costantinopoli, Gregorio partecipò al concilio del 381 e, dopo la morte di Melezio che ne aveva guidato la prima parte, fu chiamato alla presidenza. Le sessioni conciliari furono quanto mai tribolate: i sostenitori dei due candidati alla presidenza della Chiesa di Antiochia non trovavano una via d’intesa; e lo stesso Gregorio fu accusato di occupare illegittimamente la sede di Costantinopoli, poiché era già stato nominato Vescovo di Sasima. Si ripeteva, ancora una volta, quello che già un tempo Gregorio aveva proclamato con parole accorate: “Abbiamo diviso Cristo, noi che tanto amavamo Dio e Cristo! Abbiamo mentito gli uni agli altri a motivo della Verità, abbiamo nutrito sentimenti di odio a causa dell’Amore, ci siamo divisi l’uno dall’altro!” (Discorsi 6, 3). Gregorio, confessandosi incapace di fare opera di comunione, lascia il concilio. “Lasciatemi riposare dalle mie lunghe fatiche, abbiate rispetto dei miei capelli bianchi … Sono stanco di sentirmi rimproverare la mia condiscendenza, sono stanco di lottare contro i pettegolezzi e contro l’invidia, contro i nemici e contro i nostri. Gli uni mi colpiscono al petto, e fanno un danno minore, perché è facile guardarsi da un nemico che sta di fronte. Gli altri mi spiano alle spalle e arrecano una sofferenza maggiore, perché il colpo inatteso procura una ferita più grave … Come potrò sopportare questa guerra santa? Bisogna parlare di guerra santa così come si parla di guerra barbara. Come potrei riunire e conciliare questa gente? Levano gli uni contro gli altri le loro sedi e la loro autorità pastorale e il popolo è diviso in due partiti opposti … Ma non è tutto: anche i continenti li hanno raggiunti nel loro dissenso, e così Oriente e Occidente si sono separati in campi avversi” (Discorsi 42, 20-21). È il mese di giugno del 381. Nell’autunno del 382 accetta la guida della comunità di Nazianzo: vi resta un anno e poi si ritira in solitudine ad Arianzo, dove proprio lui, uomo della Parola, trascorre un’intera Quaresima in assoluto silenzio, quale segno e monito che la parola era stata svilita, ridotta a chiacchiera vana e ad arma da usare contro l’altro. Negli anni compose il poema Sulla sua vita, una rilettura in versi del suo cammino umano e spirituale, e numerose poesie. Nulla sappiamo degli ultimi anni di solitudine e di preparazione all’incontro con il Signore, che avvenne verso il 390; forse in questi versi sono racchiusi i suoi sentimenti: “Fu soltanto tirannia? Sono venuto al mondo. Perché sono sconvolto dai flutti tempestosi della vita? Dirò una parola audace; sì, audace, ma la dirò. Se non fossi tuo, o mio Cristo, quale ingiustizia!” (Poemi II, 1, 74). Gregorio è un uomo mite, un uomo di pace, che ha lottato lungo tutta la sua vita per fare opera di pace nella Chiesa del suo tempo, tribolata e divisa dalla controversia ariana, dalle rivalità e gelosie tra i pastori; ma è anche un uomo che con audacia evangelica sa vincere la sua timidezza, il suo carattere incline al silenzio per proclamare la verità senza paura. Scrittore fecondo, ha composto numerosi Discorsi: i 45 giunti fino a noi sono stati pronunciati per la massima parte a Costantinopoli, negli anni 379-381 e comprendono i 5 discorsi teologici, le invettive contro Giuliano, alcune omelie liturgiche, alcuni panegirici, i discorsi di circostanza in cui difende il suo operato, l’addio a Costantinopoli e i discorsi sulla povertà. Oltre alle numerose lettere, da lui stesso pubblicate, Gregorio compose 17.533 versi in 185 opere poetiche, un’attività che ha qualcosa di prodigioso a prescindere dai risultati artistici che può aver conseguito. Molte di queste poesie sono autobiografiche. Il poema più lungo (1949 versi) è quello dedicato alla narrazione della propria vita dalla nascita alla partenza da Costantinopoli. Aveva scritto: “Servo della Parola io aderisco al ministero della Parola; che io non consenta mai di esserne privato. Questa vocazione io l’apprezzo e la gradisco, ne traggo più gioia che da tutte le altre cose messe insieme” (Discorsi 6, 5). E ancora: “Ho lasciato tutto il resto a chi lo vuole, la ricchezza, la nobiltà, la gloria, la potenza … abbraccio solo la Parola” (Discorsi 4, 10). Il numero dei panegirici pronunciati in onore di Gregorio testimonia eloquentemente il culto di cui godette nella tradizione bizantina. I sinassari celebrano la sua festa il 30 gennaio nel gruppo dei tre “gerarchi”, insieme con Basilio e Giovanni Crisostomo, ma lo commemorano più solennemente, e da solo, il 25 dello stesso mese. L’introduzione del culto di Gregorio in Occidente è meno documentata.
ARIO

La vita
ARIOArio (ca. 256-336) fu il più famoso eresiarca del IV secolo e diede il nome all’arianesimo, la dottrina, grande alternativa del credo cattolico nel mondo cristiano dell’epoca: tuttavia egli non contribuì granché allo sviluppo teologico di questo pensiero.
Ario nacque in Libia nel 256 ca., e poco si sa della prima parte della sua vita: è verosimile che avesse studiato presso la scuola di Luciano di Antiochia, dove conobbe sia Asterio di Cappadocia che Eusebio di Nicomedia.
Nel 306 A. prese le parti di Melezio di Licopoli, fondatore della Chiesa dei martiri confessori, di cui Ario faceva parte, contro il vescovo di Alessandria, Pietro, con il quale, però, Ario si riconciliò in seguito, tant’è vero che fu ordinato diacono da Pietro stesso nel 311.
Nel 313, Ario fu fatto presbitero dal successore di Pietro, Achilleo, e chiamato a condurre una chiesa nel rione Baucalis di Alessandria.
Si impegnò a fondo nel combattere alcune eresie come lo Gnosticismo e il Modalismo o Sabellianismo, ma nel 319 entrò in rotta di collisione con il suo nuovo vescovo, Alessandro, accusandolo di insegnare che il Figlio fosse identico al Padre, mentre Ario ormai predicava i principi della sua dottrina, l’arianesimo, che in seguito sarebbe stata qualificata con l’infamante etichetta di “eresia”.
Alessandro convocò nel 321 un sinodo di circa cento vescovi egiziani e libici e fece scomunicare Ario, fuggito nel frattempo in Palestina. Qui l’eresiarca scrisse una lettera a Eusebio di Nicomedia, da cui venne accolto a braccia aperte.
Eusebio creò un centro di riferimento per l’arianesimo nella propria diocesi e si fece promotore dell’arianesimo a livello di dispute teologiche; Ario, dal canto suo, come un moderno comunicatore, compose canzoni e slogan per propagandare le sue idee presso la gente comune, come i marinai e viaggiatori.
Nel frattempo la posizione degli ariani venne rinforzata da alcuni sinodi locali, tenuti in Palestina e in Bitinia e favorevoli ad Ario e al positivo ascendente di Eusebio sull’imperatore Costantino, che aveva legalizzato il Cristianesimo nel 313.
Dopo qualche anno, nel 325, l’imperatore si decise di convocare un concilio per dirimere la questione fra cattolici ortodossi e ariani.
Il Concilio Ecumenico (il primo della storia del Cristianesimo) ebbe luogo a Nicea ed iniziò il 20 Maggio 325 alla presenza di circa 220 vescovi (secondo altri autori, 318), in larghissima maggioranza della parte orientale dell’Impero.
Ario comparve, portando un atto di fede, stracciato, tuttavia, in pubblico ed anche l’intervento di Eusebio non fu tra i più felici: egli lesse un documento, allineato sulle posizioni ariane, dove si affermava molto palesemente che Cristo non era Dio.
Questa terminologia senza compromessi alienò i favori dei moderati, che, dopo estenuanti discussioni, aderirono al cosiddetto “Credo Niceno”, dove, a proposito della natura di Cristo, si ribadiva il termine homooùsion (consustanziale, cioè della stessa sostanza del Padre e generato, e non creato).
L’arianesimo fu condannato e Ario fu mandato in esilio in Il lirico: i suoi libri vennero bruciati.
Tuttavia, i sostenitori dell’arianesimo, rimasti in maggioranza, persuasero l’imperatore a richiamare Ario dall’esilio nel 331 (o 334) (Eusebio era già stato richiamato nel 328) ed a progettare un suo rientro nella Chiesa, dopo che Ario era riuscito a convincere Costantino stesso della sua ortodossia in un colloquio privato.
Ma il vecchio eresiarca, oramai ottantenne, morì improvvisamente per strada a Costantinopoli nel 336.
La dottrina
Ario si formò presso la Scuola di Antiochia, la quale era famosa per la sua propensione a leggere alla lettera i testi sacri: la tesi fondamentale che egli elabora è che l’unità di Dio è incompatibile con la pluralità delle persone divine. Con tale affermazione, prende il via la nota “disputa trinitaria” che durerà per tutto il IV secolo d.C. Ad avviso di Ario, il Figlio di Dio, Cristo (cioè il Verbo) non ha la stessa natura del Padre (Dio), ma è la sua prima creatura e, insieme, il tramite per la creazione degli altri esseri. L’inevitabile conseguenza di questa posizione è che l’incarnazione e la resurrezione di Cristo non sono eventi divini e che la redenzione non avviene attraverso di essi o tramite la mediazione della Chiesa. Contro Ario si schiera Atanasio (295-373), vescovo di Alessandria, che propugna l’unità e la Trinità di Dio: tesi che, com’è noto, uscirà vincitrice dal Concilio di Nicea, il quale sancirà la dottrina dell’unità di Dio e della divinità del Figlio. La polemica nasceva dalla terminologia greca impiegata: per caratterizzare la nozione di divinità, infatti, si utilizzavano i termini filosofici “sostanza” (ousìa in greco) e “persona” (hypòstasis in greco). Ora, Ario sostiene la non “consustanzialità” (homousìa in greco) del Padre e del Figlio: essi non sono fatti della stessa sostanza e solamente il Padre è Dio.
L’insegnamento ortodosso del Cristianesimo ai tempi di Ario propugnava dunque la dottrina di Dio Padre e Dio Figlio come due persone distinte con una sola essenza.
La principale preoccupazione di Ario era di negare che così potessero coesistere due Dei oppure che non si scivolasse nel “moralismo”, la dottrina che affermava che le persone della Trinità non erano altro che “modi” di essere e di agire dell’unico Dio.
Il fulcro dell’arianesimo era invece la negazione della consustanzialità del Figlio con Dio Padre. Secondo Ario, il Padre era eterno, la sorgente, cioè, non originata di tutta la realtà, mentre il Figlio, sebbene fosse il primo nato fra tutte le creature e il creatore del mondo, era “dissimile” (anòmoios in greco) e inferiore al Padre “in natura e dignità”, perché generato e creato dal Padre stesso, prima di tutti i tempi. Tuttavia, “ci fu un tempo in cui il Figlio non c’era”: così recitava una celeberrima frase di Ario.
EUTICHE
Eutiche (ca. 378-454) era diventato nel 440 archimandrita (superiore) di un monastero con più di trecento monaci a Costantinopoli, succedendo a Dalmazio.
Egli fu politicamente molto influente a causa del suo ascendente sul ministro eunuco bizantino, Crisafio, di cui era stato padrino di battesimo.
Nel 448, all’età di settant’anni, egli scese in campo nella disputa teologica con Nestorio, ed in polemica con quest’ultimo, che affermava la presenza di due persone distinte (l’una divina e l’altra umana) nel Cristo incarnato, Eutiche ribadì che, prima dell’incarnazione, c’erano due nature, ma dopo l’incarnazione una sola, quella divina, derivata dall’unione delle due nature stesse (ek duo physeon, “da due nature”).
In questa maniera, Eutiche negò che la natura di Cristo fosse consustanziale alla nostra: il che, quindi, impedirebbe di redimerci attraverso di Lui.
Detta dottrina fu definita “monofisismo”, ma secondo alcuni autori, Eutiche non ne fu il vero fondatore, che si deve probabilmente ricercare in Cirillo di Alessandria (376-444, Vescovo e Padre della Chiesa). Altri fanno risalire le prime credenze monofisite ad Apollinare di Laodicea.
Eutiche fu denunciato da Domno, Patriarca di Antiochia e da Eusebio di Dorilea e condannato come eretico dal Concilio di Costantinopoli, presieduto da Flaviano, arcivescovo della città, sempre nel Novembre 448. Fu, inoltre, deposto dal proprio incarico.
Tuttavia, la causa di Eutiche fu presa a cuore dal Patriarca di Alessandria, Dioscoro di Alessandria, che era stato interessato alla vicenda dallo stesso Papa, Leone Magno (440-461), ma il cui scopo era più politico che teologico: indebolire l’immagine del Patriarcato di Costantinopoli per dare più prestigio alla sede di Alessandria.
Eutiche e Dioscoro ottennero, dopo un infruttifero sinodo nell’Aprile 449, la convocazione, da parte dell’Imperatore Teodosio II (408-450), di un concilio, che si tenne nell’Agosto 449 ad Efeso.
Il Papa Leone Magno non presenziò direttamente, ma inviò due rappresentanti recanti una lunga missiva indirizzata a Flaviano, nota come Tomus ad Flavianum, in cui egli ribadì la propria posizione anti-monofisita, ma anche anti-nestoriano.
L’andamento dell’intero concilio fu palesemente falsato dall’atmosfera di terrore e violenza, instaurata da Dioscoro e da suoi monaci semianalfabeti e fanatici, capeggiati da Barsumas. A farne le spese fu soprattutto Flaviano, il quale fu deposto ed esiliato, morendone poco dopo per le percosse ricevute dallo stesso Barsumas durante il concilio, a testimonianza del clima ben poco pacifico in cui questo si svolse.
Inoltre, nel concilio, Dioscoro destituì i più importanti teologi antiocheni (Domno di Antiochia, Eusebio di Dorileo, Iba di Emessa e Teodoreto di Ciro) con l’accusa di nestorianesimo e l’insegnamento monofisita di Eutiche venne dichiarato ortodosso.
Papa Leone Magno, acutamente, definì questo sinodo non un “concilium”, bensì un “latrocinium” (brigantaggio), e lo annullò, ma in contrasto con il pensiero papale, l’imperatore lo ritenne valido.
Tuttavia l’inattesa morte dall’Imperatore Teodosio II (450) e l’esecuzione capitale del protettore di Eutiche, Crisafio, rimisero in gioco gli Ortodossi, che ottennero dall’Imperatrice Pulcheria, essa stessa fervente cattolica ortodossa, la convocazione di un Concilio a Calcedonia nell’Ottobre 451.
In seguito a questo concilio, il monofisismo venne condannato e furono esiliati sia Dioscoro, che morì nel 454 in Paflagonia, che Eutiche.
Eutiche morì nel 454.
NESTORIO DI COSTANTINOPOLI

Nestorio (ca. 381- ca. 451), il fondatore del nestorianesimo, nacque in Germanicia, in Siria, nel 381 ca. e studiò alla scuola di Teodoro di Mopsuestia ad Antiochia, prendendo i voti ed entrando successivamente nel monastero di Euprepio, vicino ad Antiochia.
Nell’Aprile 428 Nestorio fu scelto dall’imperatore Teodosio II (408-450) per diventare Patriarca di Costantinopoli come successore di Sisinnio, in un momento di lotta per la successione al seggio da parte dei due presbiteri, Filippo e Proclo.
Comunque la scelta dell’imperatore di favorire un altro uomo della scuola di Antiochia, dopo Giovanni Crisostomo, non fu una delle più felici: anche il Santo ebbe un patriarcato molto tribolato, culminato con il suo esilio decretato nel sinodo di Ad Quercum (la Quercia, sobborgo di Costantinopoli) nel 403, in seguito alle losche manovre del suo nemico Teofilo di Alessandria.
Nestorio prese a cuore il suo compito e si impegno nella lotta contro i vari eretici imperanti al tempo e presenti nella sua diocesi: ariani, macedoniani, quartodecimani, apollinaristi e novaziani.
Nei confronti dei pelagiani mantenne un atteggiamento neutrale, anzi protesse i profughi, come Giuliano di Eclano e Celestio, che si erano rifugiati a Costantinopoli.
Alla fine dello stesso 428, però, esplose il caso sul termine Theotòkos. Infatti, il presbitero Anastasio, un protetto di Nestorio, ricusò il titolo di Theotòkos (in greco, Madre di Dio), utilizzato nei sermoni di Proclo per la venerazione della Vergine Maria.
Proclo del resto stava soltanto seguendo le dottrine del Concilio di Nicea, dove era stato ribadito la consustanzialità di Cristo e Dio Padre, e conseguentemente, era opinione diffusa che la madre di Cristo fosse anche madre di Dio.
Anastasio e Nestorio, invece, provenivano dalla scuola antiochena di Diodoro di Tarso e di Teodoro di Mopsuestia, dove si tendeva a dare maggiore peso alla natura umana di Cristo: per Nestorio era inconcepibile, quindi, che una donna avesse potuto generare Dio, che era eterno. In alternativa propose il termine Christotòkos, Madre di Cristo oppure Theodòchos, “che riceve Dio”.
Inoltre, il termine Theotòkos, per Nestorio, poteva significare che la natura umana di Cristo era stata annullata da quella divina. Egli era, infatti, convinto che esistessero due persone separate nel Cristo incarnato, l’uno Divino e l’altro umano, cioè le due nature erano solo congiunte, mentre negò che ci fosse una unione ipostatica fra le due nature, come affermato dalla scuola alessandrina.
I primi a protestare furono Eusebio, successivamente diventato vescovo di Dorilea e i due ex pretendenti al seggio di patriarca, Filippo e, ovviamente, Proclo, parte in causa.
Il tutto arrivò all’orecchio del vescovo di Alessandria, Cirillo, nipote di quel Teofilo, nemico giurato di Giovanni Crisostomo, e, come lo zio, ambizioso e geloso del prestigio goduto dagli esponenti della scuola di Antiochia e dal patriarca di Costantinopoli, come appunto Nestorio.
Cirillo provvide immediatamente ad informare Papa San Celestino I (422-432) con uno scritto, in cui, camminando sul filo del rasoio di un apollinarismo latente, contestò la dottrina nestoriana, accusando Nestorio e il suo maestro, Teodoro, di duofisismo, cioè di sostenere la doppia natura di Cristo.
Tutta la situazione non era particolarmente favorevole a Nestorio per varie ragioni:
Già da tempo le sedi di Alessandria e Roma si erano unite contro il potere e prestigio delle sedi di Costantinopoli e Antiochia.
Cirillo aveva dalla sua parte le due donne più potenti dell’impero: la sorella dell’imperatore, Pulcheria e la moglie Eudossia.
Circolava uno scritto anti-nestoriano (De incarnatione Domini contra Nestorium) di Giovanni Cassiano, tenuto in grande considerazione in Occidente.
La protezione data da Nestorio ai pelagiani, residenti in città, non deponeva molto a suo favore.
Oltretutto il carattere non proprio facile di Nestorio non aiutava certo la ricerca di una mediazione.
Comunque il papa convocò un sinodo per l’agosto del 430, che condannò Nestorio e diede mandato a Cirillo di notificare la condanna a Nestorio. L’alessandrino, però, prevaricò l’incarico ricevuto, stendendo di sua iniziativa un elenco di 12 anatemi, che inviò a Nestorio, facendo intendere che la sottomissione alla decisione papale comportasse la sottoscrizione di questo documento.
Nestorio, stizzito, contestò la cosa, rielaborando un controdocumento in 12 punti e chiedendo all’imperatore Teodosio II che il dibattito fosse portato in un concilio plenario, che fu effettivamente convocato ad Efeso per il giugno 431.
Tuttavia l’intero andamento del concilio fu sfalsato da una serie di eventi:
L’arrivo in massa degli alleati di Cirillo il 22 giugno, che, senza attendere la controparte, confermarono la scomunica a Nestorio.
Gli atti di violenza della popolazione, aizzata da Memnone di Efeso, alleato di Cirillo.
L’arrivo il 24 giugno di Giovanni di Antiochia e dei vescovi favorevoli a Nestorio, che annullarono la sentenza e controscomunicarono Cirillo e Memnone.
L’arrivo dei delegati occidentali il 10 luglio, che permisero a Cirillo di riaprire i lavori, confermando la scomunica precedente e aggiungendoci i nomi di Giovanni di Antiochia e dei suoi seguaci.
I tentennamenti dell’imperatore a dare ragione all’una o all’altra parte, con palesi tentativi di corruzione in atto.
Infine l’intervento del comes Giovanni, inviato dell’imperatore, che fece arrestare Nestorio, Cirillo e Memnone e dichiarare sciolto il concilio.
L’errore successivo di Nestorio fu quello di abbandonare il campo, ritirandosi nel suo antico monastero di Eupreprio, mentre Cirillo, scatenatissimo, riuscì a diventare un po’ più diplomatico, trovando, nel 433, una formula di compromesso, che portasse Giovanni di Antiochia dalla sua parte e isolasse Nestorio.
Quest’ultimo fu definitivamente condannato dall’imperatore nel 435 all’esilio nell’oasi di El Kharga, nella Tebaide, la zona attorno a Tebe, nell’Alto Egitto, dove, spesso sottoposto a violenze fisiche, morì infelice e dimenticato nel 451 ca.
I vescovi, che non accettarono la formula di compromesso del 433, costituirono gradualmente una Chiesa Nestoriana separata.
EUSEBIO DI CESAREA

Nato a Cesarea di Palestina all’incirca nel 265 d.C., Eusebio fu allievo di Panfilo (a sua volta allievo di Origene), del quale amava chiamarsi “figlio”: a lui spetta il titolo di storico ufficiale della Chiesa. Divenuto vescovo a Cesarea di Cappadocia nel 315 circa, Eusebio non rimase immune da tendenze ariane, e in veste di seguace di tale eresia fu ricordato da altri storici della Chiesa, quali Socrate, Gerolamo e Teodoreto. Probabilmente Eusebio, ottimo amico di Costantino oltre che suo fidato consigliere, operò attivamente per la convivenza dell’Arianesimo con l’ortodossia. Morì poco dopo il sovrano e, dunque, in una data sicuramente successiva al 337. Eusebio operò in stretta relazione con il maestro Panfilo, che aveva fondato a Cesarea una scuola di studi cristiani; dopo la morte di quest’ultimo nel 309, durante la persecuzione di Diocleziano, lasciò Cesarea per tornarvi nel 313, assumendo la carica di vescovo e acquistando ben presto grande influenza. Condannato dal Concilio di Antiochia per aver seguito le tesi ariane (che differenziavano la sostanza del Figlio dal Padre e quindi negavano il dogma della Trinità), nel successivo Concilio di Nicea (giugno 325) si piegò all’ortodossia cattolica per compiacere il suo protettore Costantino, che del resto lo difese anche nelle polemiche contro Atanasio di Alessandria, che lo accusava di essere scampato alle persecuzioni perché aveva abbandonato la fede. Proprio il rapporto con l’imperatore fu l’occasione di un viaggio a Costantinopoli intorno al 335, data in cui Eusebio tenne un discorso celebrativo dei trent’anni di regno del sovrano. Nonostante le accuse di arianesimo, dunque, orientamento cui non era estraneo lo stesso Costantino, Eusebio rimase tranquillamente a capo della diocesi di Cesarea fino alla morte. Eusebio fu fecondo scrittore e si interesso di svariati argomenti (teologici, filosofici, apologetici, esegetici), benché la sua attività preferita fosse la ricerca storica e filologica. Tali studi erano del resto possibili perché gli era facile avvalersi delle ben fornite biblioteche di Cesarea e di Gerusalemme. Frutto dei suoi interessi e delle sue ricerche fu in primo luogo la Cronaca, suddivisa in due parti: la prima conteneva una sintesi – basata su fonti bibliche – della storia orientale e greca, nonché di quella romana. La seconda parte era invece costituita da una tavola sincronica su più colonne, la quale, a partire da Abramo (2016/15 a.C.), giungeva fino al 303 d.C., con una serie di brevi notizie; l’originale dell’opera è andato perduto, ma resta la traduzione armena e (limitatamente alla seconda parte) una versione latina. Già Giulio Africano, nativo di Gerusalemme e vissuto tra il II e il III secolo, aveva redatto un’opera intitolata Cronache, in cui tentava di sincronizzare la storia del mondo dalla creazione fino al 221d.C. Alla Cronaca di Eusebio è sotteso un intento apologetico, poiché in essa si evidenzia la maggiore antichità della religione giudaica e dunque la dipendenza del Cristianesimo da questa. L’altra grande opera di Eusebio è la Storia ecclesiastica, in dieci libri, che tratta del periodo compreso fra la nascita della Chiesa e la sconfitta di Licinio per mano di Costantino (324). Probabilmente la redazione tramandata è l’ultima e la meglio aggiornata di molte altre ad essa precedenti. L’opera di Eusebio può essere fatta rientrare lato sensu nel genere storiografico, benché in essa manchino un’interpretazione storica e coordinate generali (inoltre presenta carattere marcatamente apologetico, giacché volta a illustrare l’inarrestabile sviluppo del Cristianesimo nonostante le feroci persecuzioni cui esso andò incontro). Si tratta comunque di un’opera particolarmente preziosa, in quanto fonte di numerose notizie su diversi scrittori, delle cui opere ha trasmesso un numero cospicuo di estratti che, altrimenti, sarebbero caduti nell’oblio. La Cronaca fu continuata fino al V secolo da storici poc’anzi menzionati (Socrate e Teodoreto), oltre che dall’ariano Filostorgio. Fra le opere specificamente apologetiche di Eusebio occupa un posto a sé l’importantissima Preparazione evangelica (Praeparatio evangelica), in 15 libri, in cui l’autore si sforza di dimostrare la superiorità della religione ebraica sul culto pagano: la prospettiva avanzata da Porfirio nel suo Contro i Cristiani, in cui l’allievo di Plotino metteva in luce la superiorità del mondo pagano, è da Eusebio rovesciata, giacchè egli mostra non solo come la religione ebraica sia superiore all’intero mondo pagano, ma anche come ogni singolo aspetto del mondo pagano (compresa la filosofia) non sia che una sorta di “preparazione” per l’avvento della religione ebraica. Sicché l’intero mondo greco – da Talete ad Aristotele, fino ad Epicuro – ha valore se e solo se inteso come preparazione al messaggio evangelico. Alla stessa esigenza apologetica risponde l’opera Dimostrazione evangelica in 20 libri (sopravvissuti solo per metà), in cui Eusebio si propone di dimostrare la superiorità del messaggio cristiano sulla legge mosaica. Di dubbia paternità eusebiana risulta l’opera panegiristica dal titolo Vita di Costantino, in quattro libri; assai interessante è, infine, l’opera sui Martiri di Palestina, che raccoglie fatti cui lo storico assistette di persona durante l’ultima persecuzione. Eusebio ci mostra chiaramente, tramite la sua collaborazione con il potere politico, la raggiunta indipendenza politica del cristianesimo, che appare ora compiutamente definito non solo a livello interno e nei rapporti con l’Impero, ormai divenuto “cristiano”, ma anche capace di creare una sua originale produzione letteraria. Eusebio appare in sostanza un seguace di Origene, in quanto ribadisce il tentativo di conciliare la dottrina cristiana con la filosofia greca (ancorché quest’ultima non abbia alcun valore se autonomamente presa), come appare dal fatto che applica ai testi sacri i metodi della filologia classica d espone le biografie dei personaggi ecclesiastici secondo lo stile e la metodologia delle biografie sui filosofi greci. Dunque è in questa cristianizzazione della metodologia che va cercata l’importanza di Eusebio, che fonda il genere della storiografia della Chiesa e del moderno metodo di interpretazione dei dati, riportati in originale, ed inoltre porta a compimento la cronologia, adottata dai cristiani in quanto pone davanti al lettore l’intero arco dei tempi per poterlo interpretare alla luce del compimento della salvezza umana, che Eusebio fa cominciare esplicitamente dal patto stretto tra Dio e Abramo. Eusebio, d’altronde, pecca nell’interpretazione dogmatica, che appare quantomeno falsata dalla prospettiva ariana e, di converso, dall’adesione di facciata all’ortodossia cattolica, o nello stile greve e sciatto che costituisce uno scotto pagato dal vescovo di Cesarea alle roventi discussioni dell’epoca. L’opera di Eusebio riveste un’importanza eccezionale anche riguardo il tema della successione apostolica. Di fatto, la sua Storia ecclesiastica ha fra i suoi obiettivi quello di mostrare la realtà storica di quest’ultima, sebbene escluda nettamente il primato romano. La Chiesa per Eusebio è una vergine madre che soltanto l’eresia ha infangato. Eusebio rifiuta qualsiasi legame del cristianesimo con il giudaismo, mostrando come in seno al cristianesimo non si rispetti il sabato né esista proibizione alcuna di mangiare certi alimenti, tutto ciò in armonia con le Scritture. In relazione al canone, l’informazione fornita da Eusebio è di enorme importanza. Considera la lettera di Giacomo e quella di Giuda non canoniche, benché ammetta che si leggono in quasi tutte le Chiese (HE, I, 23). In quanto alle lettere di Pietro, considera autentica la prima, rifiutando la seconda, benché ne riconosca l’utilità (II, 3). Allo stesso tempo non considera canonici il Vangelo, gli Atti e l’Apocalisse di Pietro. Di Paolo riconosce quattordici lettere, benché ammetta che la lettera agli Ebrei non sia universalmente accettata. Inoltre sottolinea la diversità di opinione in relazione al Pastore di Erma. In quanto alle lettere di Giovanni, la prima viene riconosciuta come canonica, ma le altre due sono oggetto di discussione. Le opinioni riguardo le apocalissi sono egualmente discordanti (HE, II, 24). In campo escatologico, ammette la credenza in un castigo eterno per i condannati (HE, IV, 18) e si professa nettamente anti-millenarista. In campo mariologico, sembra rifiutare, sebbene indirettamente, la verginità perpetua di Maria, in quanto considera i fratelli di Gesù come fratelli di carne (I, 20) e adduce a suo favore testimonianze storiche. Tuttavia, l’aspetto della teologia di Eusebio posto maggiormente in discussione è stato quello cristologico. In verità, il fondamento della sua posizione iniziale- ossia il desiderio che le categorie cristologiche fossero solo bibliche e il timore di scivolare nel sabellianismo se si fosse accettata la tesi omousica di Atanasio- risulta comprensibile, ma non è meno certo che la negazione dell’uguaglianza della natura fra il Padre e il Figlio collocava quest’ultimo in una posizione di creatura, il che risultava contrario al messaggio della Scrittura e alla credenza sostenuta dal cristianesimo fin dalle sue origini. Infine, tale tesi tendeva a fondersi con l’arianesimo, cosa che venne evidenziata dall’influenza che Eusebio ebbe sull’imperatore in favore dei seguaci di Ario danneggiando così gli ortodossi. Eusebio era convinto che l’alleanza con il potere imperiale si traduceva in qualcosa di benefico per la Chiesa. È certo che l’atteggiamento “costantiniano” di Eusebio portò soltanto al tragico cesaropapismo orientale e all’alleanza dei poteri civile e religioso contro l’ortodossia cristiana.
SCHEMA SU EUSEBIO
Opere
1. Esegesi biblica
Le opere di questo tipo sono quasi tutte perdute. Comprendevano i Canoni evangelici (in essi, secondo tabelle, l’autore registrava i numeri in cui aveva diviso il testo dei Vangeli), il trattato Sulla festività della Pasqua, Commenti ai Salmi e ai Profeti (solo frammenti), Onomasticon (repertorio dei nomi di luogo biblici, giuntoci nella traduzione di Girolamo).
2. Opere apologetiche
– Introduzione generale elementare: in 10 libri, era volta a spiegare ai neofiti le profezie sul Messia e le sue prove terrene. Di quest’opera, perduta, abbiamo le rielaborazioni dello stesso Eusebio:
a) Preparazione evangelica: in 15 libri, è l’opera a cui Eusebio dedicò le cure maggiori. L’autore si propone di dimostrare, con numerosissime citazioni dagli autori pagani, che la religione cristiana è radice e superamento delle false credenze politeiste. Il tema è in aperta polemica con lo scritto del neoplatonico Porfirio Contro i Cristiani (perduto, ma di cui l’opera eusebiana è una delle fonti di ricostruzione principale).
b) Dimostrazione evangelica: in 20 libri, di cui restano solo I-X. Prosecuzione dell’opera precedente, ne forma quasi la seconda parte, come Eusebio stesso afferma, e intende provare l’avverarsi, con la venuta di Cristo, delle profezie dell’Antico Testamento.
– Sulla teofania: opera che tratta del Logos e della sua azione redentrice, secondo l’esempio dell’inizio del Vangelo di Giovanni. Abbiamo frammenti dell’originale, ma ci è pervenuta integralmente in traduzione siriaca;
– Contro la difesa di Ierocle a favore di Apollonio di Tiana: Eusebio confuta l’esaltazione fatta dal neoplatonico Ierocle del santone pagano Apollonio, che i pagani ritenevano superiore al Cristo;
– Confutazione e apologia (perduta);
– Apologia di Origene (perduta, scritta con Panfilo).
3. Opere storiche
– Chronicon: si tratta di una cronologia universale divisa in più colonne (Ebrei, Persiani, Egizi, Romani, Greci ecc.) che partiva dalla nascita di Abramo (2016 a.C.) ed arrivava fino al 303 d.C. Essa ci è nota in una traduzione armena, integrale, e in quella, parziale, di Girolamo, che la continuò fino al 378 (morte dell’imperatore Valente ad Adrianopoli), aggiungendovi notizie di letteratura latina.
– Storia ecclesiastica: in 10 libri, elenca i successori degli apostoli e dunque le vicende della Chiesa fino all’editto di tolleranza del 313, per concludere con un’appendice (VIII-X) fino al 324, probabile indizio della pubblicazione di due edizioni poi accorpate.
Pur disorganica e superficiale, la Storia di Eusebio inaugura un nuovo filone storiografico, che fonda la metodologia pragmatica classica (Polibio, per il tema del trionfo di un’idea) con la necessità apologetica di riportare alla lettera, nell’originale, le fonti documentarie citate, senza alterarle retoricamente come negli storici classici, ed è quindi una fonte insostituibile di documentazione.
– Sui martiri della Palestina: si tratta di un opuscolo giuntoci in due redazioni: una più breve, in greco, dopo l’VIII libro della Storia; l’altra, più estesa, in traduzione siriaca.
– Vita di Costantino: vera e propria biografia encomiastica in 4 libri, senza pretese di obiettività storica, in cui Eusebio esalta il sovrano, difensore della religione cristiana, senza soffermarsi sui suoi difetti e sugli elementi negativi della sua politica.
4. Orazioni
Le due orazioni eusebiane pervenute sono certamente un aspetto minore della sua attività letteraria: sono il Triaconteterico, tenuto a Costantinopoli in occasione dei Tricennalia di Costantino, e il Discorso regale.
MUSONIO RUFO
Musonio Rufo nacque a Volsini intorno al 30 d.C. Costretto all’esilio in più occasioni, morì verso la fine del primo secolo d.C. Le lezioni di Musonio, Le diatribe, furono raccolte dal suo discepolo Lucio. Il suo pensiero fu caratterizzato innanzitutto da una forte riduzione dell’aspetto teoretico della filosofia in favore del suo aspetto pratico.
“Chiunque abbia sempre bisogno di una dimostrazione, anche nel caso in cui la questione sia chiara, oppure voglia che gli si dimostri con molti passaggi quello che gli si potrebbe dimostrare con pochi, è in tutto e per tutto stolto e ottuso”
(Diatribe, I, ed. Bompiani, pp. 41 sgg.)
È ravvisabile una sensibile distanza dallo Stoicismo di Crisippo, che alla logica assegnava un grandissimo spazio; questo, tuttavia, non deve farci pensare che disprezzasse la logica, anzi, la riteneva necessaria ed era severissimo con i discepoli che commettevano errori in tale disciplina. Egli riteneva che la logica dovesse essere ridotta al minimo indispensabile, e assegnava alla pratica il primato sulla teoria.
“Come potrebbe essere molto più importante sapere la teoria in ogni questione, piuttosto che abituarsi ad agire secondo la guida della teoria? Infatti l’abitudine conduce alla capacità di agire, mentre la conoscenza della teoria porta alla capacità di discorrere. È senz’altro vero che la teoria collabora con la pratica, insegnando come si debba agire e cronologicamente essa precede l’abitudine, poiché non è possibile acquistare un’abitudine positiva se non secondo la teoria; ma per importanza la pratica viene prima della teoria, dal momento che essa è capace, più della teoria, di guidare l’uomo all’azione”.
(Diatribe, V, ed. Bompiani, pp. 81 sgg.)
In coerenza con questa convinzione, affermò la necessità dell’esercizio (askesis). La virtù, che costituisce il fine stesso di ogni uomo e ogni donna, è impossibile senza l’«esercizio». In altri termini, la virtù è come l’arte della medicina e della musica. Essa non è fatta di sola teoria, bensì postula la pratica, e chi vuole essere virtuoso non deve accontentarsi di «apprendere» quegli insegnamenti che conducono alla virtù, ma deve diligentemente «esercitarsi» secondo tali insegnamenti. Questo «esercizio», che è proprio del filosofo e che conduce alla virtù, è il più complesso e il più difficile che esista. Poiché l’uomo è costituito di corpo e di anima, e il corpo serve da strumento, vi sarà un duplice ordine di esercizi: uno che riguarda anima e corpo insieme e uno che riguarda l’anima sola. Secondo il nostro filosofo bisogna abituare il corpo alla fame, alla sete, alla rinuncia dei piaceri e alla sopportazione delle fatiche. Questo per esercitare anima e corpo insieme. L’esercizio proprio dell’anima invece consiste nel dimostrare quali siano i veri beni e i veri mali e saper seguire i primi ed evitare i secondi.
Le cose «che appaiono buone» ma che in realtà non lo sono, per Musonio come già per l’antica Stoa, sono il «piacere», la «ricchezza», la stessa «vita» e, in genere, ogni cosa che non partecipi alla virtù, mentre le cose «che appaiono cattive» ma che in realtà non lo sono, sono la «fatica», la «povertà», l’«esilio», la «vecchiaia» e la «morte» stessa. In particolare, Musonio esaltò l’alto valore morale della «fatica», che è strettamente connessa all’«esercizio», e giunse ad affermare che colui il quale non vuole faticare «si dichiara da sé indegno di qualsiasi bene»
Ecco le sue parole:
“Mi è possibile affermare che, chi non vuole faticare, subito si autocondanna a non essere degno di alcun bene, poiché i beni noi li acquistiamo tutti con fatica”
(Diatribe, VII, ed. Bompiani, p. 101)
Per quanto concerne, poi, l’esilio, Musonio rilevò come esso, in realtà, non potesse privare l’uomo della sua patria, dato che il cosmo intero è la vera patria dell’uomo, facendo valere un cosmopolitismo radicale:
“La patria comune a tutti gli uomini non è forse il mondo, come riteneva Socrate? Cosicché, non si deve pensare di essere esiliati veramente dalla patria, se ci si allontana dal luogo in cui si è nati e cresciuti, ma soltanto di ritrovarsi privi di una certa città, specialmente se ci si reputa una persona ragionevole. Chi, infatti, è tale, non onora né disprezza una terra come fosse causa di felicità, ma pone tutto quanto in se stesso e si considera cittadino della città di Zeus, che consiste, insieme, di uomini e di dèi”.
(Diatribe, IX, ed. Bompiani, p.123)
Musonio sosteneva che il mezzo più conveniente al filosofo per guadagnarsi da vivere fosse l’agricoltura, la quale costringe a un tipo di vita naturale, favorisce in tutti i sensi la pratica dell’esercizio e della fatica, e permette di non aver bisogno di altri per soddisfare le proprie necessità. Il pensiero del nostro filosofo ebbe un forte respiro sociale, che desunse dall’ethos della romanità, e che lo portò a concepire il matrimonio «come cosa grande e degna del più alto rispetto» e come base della società stessa.
“La cosa più importante in un matrimonio è la comunanza di vita e la generazione dei figli. Infatti lo sposo e la sposa devono unirsi l’uno all’altra, generare insieme e considerare tutto in comune, nulla come proprio, neppure il corpo stesso. E grande evento è la generazione di un essere umano che questo giogo procura. Ma per lo sposo non basta questo soltanto, che invero potrebbe risultare anche al di fuori del matrimonio, da altre unioni, come anche gli animali si uniscono tra loro. Bisogna invece che nel matrimonio abbia luogo una completa comunanza di vita e una reciproca sollecitudine dell’uomo e della donna, sia nella salute, sia nella malattia, sia in qualsiasi circostanza. […] Quando dunque tale sollecitudine è completa, e gli sposi che convivono se la donano compiutamente in modo reciproco, facendo a gara per vincersi l’un l’altro, questo matrimonio funziona come si deve ed è degno di emulazione, perché simile unione è bella”.
(Diatribe, XIII A, ed. Bompiani, pp. 173 sgg.)
Nel pensiero di Musonio ricorrono inoltre precetti che hanno riscontri nel Vangelo, ancorché giustificati con motivazioni differenti, in particolare il precetto dell’amore e del perdono. Interrogato sulla questione se il filosofo dovesse sporgere querela in caso di oltraggio, Musonio rispose negando che ciò fosse lecito e giustificando la sua asserzione non solo facendo richiamo al cinico disprezzo che il filosofo deve avere per le percosse e per il biasimo, ma anche alla fecondità e alla positività del perdono verso chi ci ha offesi.
DIOGENE LAERZIO

“I sapienti sono divini: è infatti in loro qualcosa di divino”. (Vite dei filosofi, VII, 118)
Dell’eruditissimo Diogene Laerzio ignoriamo ogni dato biografico: la collocazione tra fine II ed inizio del III secolo d. C. si deve al fatto che egli cita il filosofo Potamone di Alessandria, operante appunto nell’età dei Severi. Alcuni hanno ipotizzato che egli fosse originario della città di Laerte in Caria, in Asia Minore, come proverebbe il soprannome “Laerzio” e che fosse platonico, giacché esalta Platone ed elogia la destinataria dell’opera come “giustamente filo-platonica” (III, 47). Ma si tratta di congetture. Diogene Laerzio è autore di un’opera dall’inestimabile valore documentario: la Raccolta delle vite e delle dottrine dei filosofi, solitamente abbreviata in Vite dei filosofi. Si tratta di quella che potremmo definire la prima storia della filosofia in senso autentico, nata con lo scopo di presentare le dottrine dei grandi filosofi dell’antichità. Anche il primo libro della Metafisica di Aristotele aveva in fondo i tratti della storia della filosofia, ma bisogna ricordare che l’intento dello Stagirita era anzitutto teoretico e che dunque egli si avvicinava alle dottrine dei suoi predecessori con piglio teoretico più che storico. L’opera di Diogene Laerzio, invece, vuole essere una storia della filosofia: tenendo fede al titolo, essa espone in dieci libri la biografia e il pensiero dei principali filosofi, dai primi sapienti fino a Epicuro. Dell’opera di Diogene non ci sono giunti la dedica (ma da allusioni contenute nel resto dell’opera apprendiamo che il destinatario era una donna) e l’ultima parte del libro VII. Si tratta di un vasto compendio bio-dossografico, che illustra vita e dottrine di 84 filosofi. Diogene apre la sua opera con un ampio proemio in cui discute delle origini della filosofia e che sembra essere in diretta polemica con i cristiani, per poi passare all’esposizione della vita, opere (con il pinax, ossia l’elenco completo degli scritti, divisi per temi) e pensiero dei filosofi, divisi in “ionici” ed “italici”, seguiti dagli “sporadici” (libri IX-X), ossia i filosofi che non possono essere inclusi nelle due categorie suddette. È molto interessante il proemio, in cui Diogene discute sull’origine della filosofia: in opposizione con quanti sostengono che essa è nata in Oriente (lo stesso Aristotele, nel perduto Magico, aveva propugnato questa tesi, esponendo le dottrine dei Magi persiani), Diogene Laerzio afferma con decisione che “la filosofia è una creazione dei Greci: il suo stesso nome non ha nulla a vedere con una denominazione barbarica”. L’obiettivo polemico di questo proemio non è tanto Aristotele, quanto piuttosto il clima culturale contemporaneo a Diogene: un clima che aveva finito per concepire l’Oriente come culla della filosofia (si pensi ai cosiddetti Oracoli Caldaici e al Corpus hermeticum). Sicché il proemio discute dell’origine della filosofia (1-11), del nome filosofia (12), delle divisioni della filosofia, della successione dei filosofi e della loro distinzione (13-17), delle parti della filosofia (18) e infine delle scuole filosofiche (19-20). Nel I libro la trattazione si sofferma sui “sapienti”, seguiti, nel II libro, dai fisici e da Socrate e i socratici minori; i libri III-IV sono dedicati a Platone e agli Accademici. Nel V libro si tratta di Aristotele e dei peripatetici suoi allievi per poi passare, nel VI, ai Cinici (tra cui spiccano Antistene e Diogene). Il VII libro, il più lungo e complesso (mancante dell’ultima parte) tratta degli Stoici, partendo da Zenone e concentrandosi soprattutto su Crisippo. Nel libro VIII si parla di Empedocle e dei Pitagorici, seguiti, nel libro IX, da Eraclito, gli Eleatici, Democrito, Protagora e gli Scettici. Il X libro è tutto dedicato ad Epicuro e alla sua scuola: visto l’interesse epicureo della destinataria, Diogene inserisce tre lettere di Epicuro (A Erodoto sulla fisica, A Pitocle sulla meteorologia, A Meneceo sull’etica) intercalando il suo commento e facendo poi seguire le Massime Capitali come sintesi del pensiero epicureo, con cui l’opera si chiude. Grande merito di Diogene è anche quello di averci tramandato questi testi epicurei, i quali sarebbero altrimenti andati irrimediabilmente perduti. Seguendo un costume diffuso, Diogene compose anche una raccolta di suoi epigrammi, Pammetros (Raccolta in tutti i metri), di cui a noi restano 56 componimenti, da lui stesso inclusi nelle Vite, di scarso valore artistico, ma di grande eleganza formale e metrica. Le Vite dei filosofi si pongono come un manuale senza pretese di originalità, ma che è per noi fonte preziosa di testimonianze e cronologia sui vari filosofi classici ed ellenistici. Con scrupolo erudito, infatti, Diogene opera su materiali come lessici, repertori bibliografici, cronologie, e riporta con puntiglio le sue fonti, citando spesso passi degli stessi pensatori come esemplificazione nell’esposizione della loro dottrina, fino al caso limite dei lunghi testi epicurei del libro X. Si tratta di un “manuale biografico”, basato su ottime fonti cronologiche e bibliografiche, risalenti all’erudizione ellenistica, e dossografico: ma a Diogene mancano lo spirito critico e l’attitudine filosofica, e la sua esposizione è spesso mancante di chiarezza o troppo sintetica proprio nei punti salienti delle diverse dottrine (basti pensare alle cadute nelle sezioni sulle dottrine di Platone, Aristotele e degli stoici). Detto altrimenti, Diogene, in balia a una curiosità quasi morbosa, si sofferma per pagine e pagine sulla vita degli autori per poi liquidarne in poche righe le dottrine: quasi come se a lui la vita dei filosofi interessasse più del loro pensiero. Un esempio del suo modo di procedere si può estrapolare da questo passo del III libro, dedicato a Platone, in cui cita in modo disordinato e ripetitivo le tappe della formazione del filosofo, concedendo ampio spazio all’aneddoto:
“All’inizio filosofò nell’Accademia, poi nel giardino vicino a Colono, come dice Alessandro nelle Successioni, secondo la filosofia eraclitea. Poi, desiderando gareggiare con una tragedia, ascoltato Socrate davanti al teatro di Dioniso, bruciò i suoi versi dicendo:
Vieni qui, o Efesto, chè Platone ti chiama!
Da allora, avendo vent’anni, dicono, seguì Socrate: dopo la sua morte seguì Cratilo l’eracliteo ed Ermogene, che seguiva la filosofia parmenidea. In seguito, a ventotto anni, secondo quanto dice Ermodoro, si recò a Megara da Euclide con altri socratici. Poi andò a Cirene dal matematico Teodoro; di lì in Italia presso i pitagorici Filolao ed Eurito. Da lì in Egitto, presso i sapienti”.
Così, Diogene si sofferma diffusamente sulla vita di Platone per poi liquidarne rapidamente la dottrina delle “Idee”, come se fosse di poca importanza. Tuttavia, proprio questi difetti ci consentono una sostanziale obiettività e chiarezza nell’esposizione, che si configura come una raccolta di aneddoti e motti celebri, simile alle biografie di Svetonio (a cui lo accomuna l’interesse per i “pettegolezzi”), che non riesce però a cogliere il nucleo filosofico dei singoli pensatori. Una curiosità è che Diogene Laerzio mostri una sorta di venerazione per Epicuro (solo a lui e a Platone dedica un libro intero), con la trattazione del quale si chiude l’opera: ciò ha indotto alcuni critici a ritenere che fosse un epicureo. In effetti, Diogene Laerzio sembra fare con Epicureo ciò che Eusebio di Cesarea fa col cristianesimo: tutta la storia della filosofia, nell’ottica di Diogene Laerzio, si configura come una sorta di “praeparatio epicurea”, ossia come un qualcosa di subordinato e funzionale a Epicuro; similmente a come, per Eusebio, tutta la filosofia non era che una “praeparatio evangelica”.
GREGORIO DI NISSA

Grande nemico dell’ arianesimo , Gregorio di Nissa , autore di un Contro Eunomio , un insieme di più scritti composti tra il 381 e il 384 , ma anche di scritti contro Apollinare e contro i Macedoniani , é il più importante dei Padri di Cappadocia . Più giovane del fratello Basilio , esercitò dapprima la professione di retore e sposò Teosebia . Nel 371 proprio il fratello lo indusse ad accettare il vescovato di Nissa in Cappadocia , dove incontrò notevoli difficoltà pratiche : accusato di dilapidare i beni della Chiesa , fu deposto dall’ incarico di vescovo nel 376 . Ebbe poi altri incarichi ecclesiastici e nel 381 fu accolto nel Concilio di Costantinopoli come pilastro dell’ ortodossia . Morì nel 394 . Oltre a scritti di carattere etico , quali ” Sulla perfezione cristiana ” e ” Sulla verginità ” , Gregorio scrisse all’ inizio del 381 un ” Dialogo sull’ anima e sulla resurrezione ” a imitazione del ” Fedone ” di Platone . In esso , la sorella Macrina , morta da poco , espone la concezione cristiana dell’ anima , della morte , dell’ immortalità e della resurrezione . Nell’ opera ” Sull’ Esamerone ” , ossia sui sei giorni impiegati nella creazione del mondo , Gregorio difende l’ interpretazione del testo biblico , formulata dal fratello Basilio in un’ opera omonima . A completamento di queste tematiche egli compose anche uno scritto ” Sulla creazione dell’ uomo ” . Ma l’ opera teologica più importante di Gregorio é il ” discorso catechetico grande ” , composto verso il 386-87 , nel quale espone le dottrine cristiane sulla trinità , sul peccato , l’ incarnazione e la redenzione ad opera di Cristo e sul battesimo e l’ eucarestia . Gregorio é un ammiratore di Origene , da cui riprende la tecnica dell’ interpretazione allegorica del testo sacro , ma applicandola con maggior cautela . Pur nutrendo sfiducia sulle capacità conoscitive umane , Gregorio non ritiene incompatibili la ragione e la fede . Dal platonismo , egli assume la distinzione tra mondo intellegibile e mondo sensibile , ma le radicalizza come separazione : tutto ciò che appartiene al sensibile , anche l’ intelletto umano , non ha la possibilità di travalicarne i limiti . Ne consegue l’ inconoscibilità dell’ essenza divina da parte dell’ uomo ; neppure in un’ estasi mistica o nella visione beatificata dopo la morte é possibile un superamento di questi limiti . Ciò tuttavia non conduce Gregorio a una forma drastica di teologia negativa . Egli , infatti , ammette che il mondo creato contiene le tracce di Dio creatore , sicchè proprio in tale mondo l’ intelletto umano può attingere una conoscenza della divinità , anche se imperfetta . Questo processo conoscitivo si accresce all’ infinito , dal momento che Dio é inesauribile , cosicchè tutto ciò che si conosce di esso rinvia sempre ad altro che deve essere ancora conosciuto e genera il desiderio e l’ amore di conoscerlo . La creazione del mondo e dell’ uomo da parte di Dio é un atto istantaneo fuori dal tempo , con il quale egli ha posto i semi o le ragioni di tutte le cose , consentendo loro di svilupparsi secondo la natura propria di ciascuno . Pur riprendendo la concezione stoica del mondo come ordine provvidenziale , Gregorio ne respinge la dottrina della conflagrazione : il mondo non ha in sè cause che lo conducano alla sua distruzione . Ma al contempo Gregorio accetta la tesi , enunciata nei testi sacri , della fine del mondo , determinata dal volere di Dio . Le cose , quali sono nella condizione attuale , non sono quindi frutto della creazione diretta di Dio . L’ uomo , in particolare , é stato creato a immagine di Dio , ossia come archetipo , idea-modello dell’ uomo perfetto in senso platonico . Tale idea non racchiude in sè la distinzione dei sessi , maschio e femmina : questa si produce in un secondo tempo . L’ uomo attuale , dotato di corpo e sensibilità , é infatti il risultato di una seconda creazione , in previsione del peccato e della caduta , dovuti alla libertà propria dell’ uomo . Ma il corpo non é altro che una connessione di qualità incorporee , sicchè materia e male non hanno consistenza propria . Solo così diventa possibile l’ apocatàstasi , ossia la ricostruzione finale delle cose e dell’ uomo nella loro perfezione originaria , e affinchè ciò avvenga , occorre che il Logos salvatore si incarni e in tal modo ricostituisca lo stato originario dell’ uomo , operando da mediatore in questa direzione per tutti gli uomini . La resurrezione finale consisterà appunto nel ritorno all’ archetipo di uomo , creato direttamente da Dio .
PELAGIO

VITA E OPERE
Può l’uomo salvarsi con le sue sole forze, senza la Grazia divina o è predestinato alla salvezza o alla dannazione eterna?
Questo dilemma, ricorrente nella storia del pensiero Cristiano (basti solamente pensare al dibattito nell’ambito del Protestantesimo), fu posto, per primo, dal monaco britannico Pelagio.
Pelagio Britannico (360-420 circa), di nome e di fatto poiché era nato in Britannia nel 360 ca., fu un monaco teologo di grande cultura, vissuto a Roma almeno dal 400, altamente rispettato da molti personaggi dell’epoca, tra cui quel Sant’Agostino, che tuttavia diventò in seguito il suo acerrimo avversario.
A Roma egli conobbe Celestio, un uomo di legge di origini nobili, diventato suo amico e con il quale Pelagio fuggì, in seguito all’invasione e sacco di Roma da parte dei Goti di Alarico nel 410. I due si rifugiarono dapprima ad Ippona, in Nord Africa, e poi a Cartagine, dove rielaborarono la dottrina del pelagianismo.
Durante il suo soggiorno in Africa, Pelagio conobbe solo occasionalmente il suo futuro avversario, Sant’Agostino, impegnato all’epoca nella disputa contro i donatisti.
Successivamente, Pelagio si trasferì in Palestina, mentre Celestio, rimasto in Nord Africa, fu condannato dal sinodo di Cartagine nel 411 per le sue dottrine. In Palestina Pelagio produsse svariati scritti, alcuni dei quali ci sono pervenuti: una lettera alla nobile romana Demetria, residente a Cartagine, contenente i principi della sua filosofia e un lavoro, De natura, del 415, condannato da Sant’Agostino nel suo De natura et gratia.
Nel luglio del 415 San Girolamo e Paolo Orosio, un prete spagnolo, discepolo di Sant’Agostino, cercarono di far condannare Pelagio da parte di un sinodo a Gerusalemme, presieduto dal vescovo della città, Giovanni, ma sia l’atteggiamento di quest’ultimo, favorevole al pelagianismo, sia l’ottima autodifesa di Pelagio fecero sì che il sinodo non prendesse alcuna decisione rimandando il tutto a Papa Innocenzo I (401-417).
Simile risultato ebbe un ulteriore sinodo nel dicembre dello stesso anno a Diospolis, convocato in seguito alla denuncia dei vescovi francesi, Ero di Arles e Lazzaro di Aix.
Tuttavia l’offensiva degli ortodossi fu senza sosta: l’anno successivo, nell’autunno del 416, furono convocati ben due sinodi, il primo a Cartagine, con la presenza di 67 vescovi ed il secondo a Milevi (in Numidia) con la presenza di 59 vescovi. Entrambi condannarono il pelagianismo e i relativi atti, rinforzati da una lettera di Sant’Agostino e di altri 4 vescovi, furono inviati a Papa Innocenzo I per l’avvallo. Il papa, pur precisando la suprema autorità di Roma nelle decisioni in materia dottrinale, in un sinodo a Roma nel 417 condannò il pelagianismo. Tuttavia, quando tutto sembrò volgere al meglio per gli ortodossi, il papa Innocenzo I morì ed il suo successore Zozimo (417-418) venne, in un incontro, abilmente convinto da Celestio, dell’ortodossia del pelagianismo: il papa prosciolse la dottrina da ogni accusa, anzi addirittura tirò pure le orecchie a Sant’Agostino e ai vescovi africani per la precipitazione delle loro decisioni. Successivamente, Zozimo corresse il tiro, dando ai vescovi il tempo per portare, davanti a lui, le prove dell’eresia pelagiana.
Per ottemperare a questa disposizione papale, fu convocato il sinodo di Cartagine del 418, dove, in presenza di 200 vescovi, furono stabiliti otto (o nove) dogmi di confutazione del pelagianismo, riaffermando il peccato originale, il battesimo degli infanti, l’importanza della grazia divina ed il ruolo dei santi. Tutti questi dogmi, avvallati da Papa Zozimo, sono poi diventati articoli di fede per la Chiesa Cattolica.
Inoltre, in seguito al sinodo di Cartagine, anche l’imperatore Onorio (395-423) scese in campo a fianco degli ortodossi, emanando nel 418 un ordine di espulsione dal territorio italiano per tutti i pelagiani e per coloro che non approvassero, controfirmandola, l’enciclica di condanna del pelagianismo Epistola tractoria, inviata da Zozimo a tutti i vescovi: furono costretti all’esilio Celestio e Giuliano vescovo di Eclano (vicino a Benevento).
L’ordine non colpì Pelagio, che ormai da tempo risiedeva in Palestina e dove probabilmente morì nel 420 ca.
LA DOTTRINA
La dottrina di Pelagio venne da lui sviluppata come reazione al monachesimo ascetico di San Girolamo e al fatalismo manicheo, molto diffuso all’epoca: si pensi che anche Sant’Agostino stesso era stato manicheo in gioventù.
Secondo Pelagio, gli uomini non erano predestinati (concetto di Sant’Agostino elaborato da una sua interpretazione molto personale del pensiero di San Paolo), ma potevano, invece, solamente con la propria volontà (liberum arbitrium) e per mezzo di preghiere ed opere buone, evitare il peccato e giungere alla salvezza eterna: non era necessario l’intervento della Grazia divina.
Questo concetto, comunque, non era nuovo, essendo già stato abbozzato dal grande teologo Origene all’inizio del III secolo, e la conseguenza di questo revival fu che l’origenismo stesso fu condannato nel 401 dal vescovo di Alessandria, Teofilo.
Il pelagianismo inoltre negava la trasmissione del peccato originale, che aveva danneggiato solo Adamo e non tutto il genere umano, anche se sembra che questo concetto sia stato per primo introdotto da un tale Rufino il Siriano, aderente alla setta, e solo successivamente ripreso da Pelagio. Poiché non sussisteva il peccato originale, il battesimo era visto da Pelagio come un momento di accoglimento nella Chiesa: tuttavia, se il bambino moriva senza battesimo, veniva ugualmente accolto in paradiso.
Il punto sul peccato originale venne vigorosamente contestato da Sant’Agostino, convinto assertore che il peccato originale fosse ereditario e collegato all’atto sessuale (il furore sessuofobico di Agostino era leggendario), quindi “siamo tutti peccatori”.
Le idee pessimistiche di Agostino, molto influenzate da una visione di tipo manicheo, trionfarono sulla scelta umana di Pelagio e influenzarono il Cristianesimo per secoli.
Del resto la libertà di decisione data all’uomo da Pelagio mal si sposava con un apparato ecclesiastico, che non aveva altrimenti ragione di esistere, se non di aiutare l’uomo, perenne peccatore, ad evitare la dannazione eterna. Il punto di partenza da cui muoveva la riflessione di Pelagio era il seguente: l’uomo è creato da Dio per raggiungere la perfezione e, in forza di ciò, non può che essere un ente assolutamente libero e responsabile di ogni sua azione. Del resto, si domanda Pelagio, non sarebbe un’evidente contraddizione se Dio esigesse dall’uomo la perfezione e questi fosse impossibilitato a raggiungerla? Di qui discendono le note tesi pelagiane circa il peccato originale: se, come aveva mostrato lo stesso Agostino, il male è non essere, ne segue che esso non può aver corrotto la natura umana. Né tanto meno aver distrutto la libertà che Dio ha concesso all’uomo. Ne segue allora che il peccato originale commesso da Adamo non può essersi trasmesso ereditariamente a tutti gli altri uomini; ciascuno di noi, allora, è responsabile solo dei propri peccati. L’ulteriore conseguenza che Pelagio trae da queste premesse è che, in quanto esente dal peccato originale, l’uomo è potenzialmente in grado di raggiungere la salvezza con le proprie forze, ossia con le proprie opere buone, senza l’intervento di Dio o la mediazione della Chiesa. Alla luce di ciò, secondo Pelagio, ogni cristiano deve sforzarsi per raggiungere la perfezione, secondo il modello del monachesimo. Dopo la morte di Pelagio nel 420 ca., il bastone del comando fu preso soprattutto da Giuliano, vescovo di Eclano, che, dal suo esilio in oriente, si impegnò in una disputa decennale con Sant’Agostino. Tuttavia, un fatto alquanto imprevedibile segnò il destino dei pelagiani: il supporto dato loro dal patriarca di Costantinopoli, Nestorio. Quando il nestorianesimo venne condannato dal Concilio di Efeso del 431, anche il pelagianismo seguì la stessa sorte e fu perseguitato in Oriente dall’imperatore Teodosio II (408-450) fino alla sua estinzione.
In Occidente esso sopravvisse più a lungo nelle isole Britanniche, particolarmente in Galles ed in Irlanda, ed in Gallia, dove fu rielaborata dal monaco Giovanni Cassiano nella forma del semi-pelagianismo, condannato dal II sinodo di Orange del 529.
DAMASCIO

La figura e l’opera di Damascio (462 – 538 d.C.) si inseriscono nel complesso panorama storico-culturale del neoplatonismo pagano fra il V ed il VI sec. d.C., in particolare sullo sfondo dei continui scambi e delle reciproche influenze fra le scuole di Alessandria e di Atene. La maggior parte delle notizie pervenuteci intorno alla sua vita ed al ruolo che egli svolse come ultimo scolarca dell’Accademia sono contenute nella sua opera Vita di Isidoro e nelle Storie di Agazia1. Egli nasce a Damasco, presumibilmente intorno al 462. La prima fase della sua formazione intellettuale, caratterizzata dagli studi di retorica, si svolge ad Alessandria. Qui conosce Ammonio, dal quale viene introdotto alla lettura di Platone ed avviato allo studio della filosofia e della dialettica, per la quale fin da principio mostra particolare propensione. Affascinato dagli studi intrapresi e attratto dalla fama di Proclo, Damascio si trasferisce ben presto ad Atene per riceverne l’insegnamento. Il rapporto di Damascio nei confronti di Proclo, come emerge dal complesso dell’opera, si connota come libera revisione e talora serrata critica della dottrina del predecessore, intesa al ripensamento e alla riformulazione dei fondamenti della metafisica procliana, pur sullo sfondo di un costante riferimento ai suoi principi e alle sue fondamentali acquisizioni. L’autore nei confronti del quale Damascio dimostra invece particolare predilezione è Giamblico, spesso definito “il divino”, dalla cui speculazione egli attinge a mani piene nella costruzione della struttura archelogica che costituisce la materia del Trattato sui Primi Principi. Durante la sua permanenza ad Atene, scomparso Proclo e dopo il breve intermezzo di Marino, Damascio partecipa alle vicende della successione nello scolarcato. La nomina di Isidoro e successivamente dello stesso Damascio doveva essere intesa e forse anche osteggiata, in ambiente accademico, come tentativo di innesto di un ceppo alessandrino sul sempre più debole tronco ateniese. F. Trabattoni ipotizza a tal proposito che la Vita di Isidoro sia stata composta dall’autore con intento apologetico-propagandistico oltre che puramente biografico. Damascio avrebbe voluto legittimare la sua posizione di scolarca e l’indirizzo che intendeva imprimere agli studi accademici, quello cioè di un ritorno alla più autentica tradizione platonica, inscrivendo la sua attività in un preciso programma culturale, auspicato e voluto dallo stesso Proclo. L’orientamento ormai predominante conduceva a privilegiare l’aspetto mistico-religioso del pensiero platonico e la pratica della magia e della teurgia, come suo esito interpretativo estremo, a scapito dell’aspetto dialetticospeculativo. Damascio assume su di sé il compito, di cui cifra emblematica è la composizione del Trattato sui Primi Principi, di ricondurre l’Accademia al suo antico vigore dialettico-speculativo attraverso il recupero integrale dello spirito autentico del pensiero di Platone, salvando e per ciò stesso fondando la componente metadialettica ed irrazionale della filosofia greca. Il fervore di tale dibattito va quindi inserito e letto sullo sfondo di un ben più ampio e articolato contesto i cui elementi determinanti si possono forse ricondurre a due:
1. la progressiva diffusione del cristianesimo in area mediorientale e mediterranea,
2. la commistione e fusione delle istanze della più autentica tradizione filosofico-razionale greca con elementi della tradizione sapienziale orientale. Damascio, come già Proclo, appare consapevole del fatto che la tradizione filosofica del mondo pagano poteva proporsi come alternativa al nuovo messaggio cristiano e ai sistemi teologici che esso generava sul piano speculativo, peraltro mutuando e reinterpretando il lessico e gli strumenti concettuali del pensiero greco, solo operando un integrale ripensamento e recupero delle sue origini mitiche ed a-razionali. Il corpus dei testi di Platone viene studiato e letto come il compendio della totalità della teologia greca, secondo una linea di continuità che unisce Orfeo, attraverso Pitagora, a Platone stesso. Il sapere intorno a Dio e agli dei, questo significa propriamente il termine “teologia”, viene così ricondotto alla sua origine simbolica. Custodito dal segreto dei riti misterici e cantato dal mito è tratto infine alla luce del logos, da cui pure non è mai esaurito né, per ciò stesso, profanato. Al contrario, affidato alla parte più alta della filosofia, è sospinto oltre il limite della inestinguibile tensione fra gli opposti dell’intelletto e al di là dei continui rovesciamenti del metodo dialettico, in modo tale che il possederlo coincida sempre con il perderlo ed il perderlo con il possederlo. Il testo in cui si ritiene compiuto il “venire alla luce” di queste verità è il Parmenide, che assume il ruolo di fondamento esegetico sul quale sorgono e a partire dal quale si sviluppano e si consolidano le costruzioni metafisico-dialettiche degli autori neoplatonici. In questa prospettiva, sia Proclo sia Damascio si rivolgono, in forza della comune radice, sia al pensiero di Platone, ritenuto e quasi venerato come lo “ierofante” delle verità intorno ai principi, patrimonio sacro del più autentico spirito della filosofia greca fin dal suo nascere, sia al pensiero di Aristotele, considerato come estremo sforzo di affinamento degli strumenti logici necessari alla penetrazione della dottrina platonica, invocando una linea di continuità e un fondamentale accordo fra i due filosofi che si trasmetterà, come eredità neoplatonica, a tutto il medioevo. L’unicità dell’oggetto del discorso filosofico (l’Uno) e la sua assoluta trascendenza rispetto al logos legittima, in ottica neoplatonica, un’operazione di ripensamento in senso enologico e deontologico delle categorie del pensiero aristotelico. Astratte dal loro contesto originario, quello di una metafisica ontologica la cui cifra è l’anteriorità dell’atto sulla potenza, dell’affermazione sulla negazione e dell’essere sul nulla, sono trasposte nell’orizzonte dell’ineffabile e del silenzio come sullo sfondo di un nulla, matrice del logos e della parola, che le sostanzia e conferisce loro un nuovo significato. Ciò spiega molte delle difficoltà di lettura delle pagine procliane e damasciane. Termini tecnici come quelli, ad esempio, di atto e potenza, possesso e privazione, sostanza ed accidente, vanno riletti e ridefiniti nella cornice di un universo concettuale totalmente mutato, in cui alla preminenza del finito e del determinato si è sostituita quella dell’illimitato e dell’indeterminato, in cui il sinolo parmenideo di essere-conoscere-parola viene scomposto e ricomposto alla luce del riferimento ultimo al nulla-tenebra-silenzio. Questo mutamento di prospettiva rimette in discussione l’intuizione centrale del pensiero greco, scaturita in prima istanza dal problema linguistico di definire il significato del verbo œinai come fondamento dell’attribuzione e della proposizione di senso compiuto. La sostanzialità dell’essere è un guadagno squisitamente ellenico, lì dove nella tradizione orientale il termine, quando esiste, significa principalmente la presenza e l’esserci. Le idee di essere e di sostanza vengono così restituite al loro valore di simbolo e reinterpretate come un permanere che rinvia ad un dileguarsi, come una presenza sempre irriducibilmente segno di un’assenza. In questo il pensiero di Proclo e ancor più quello di Damascio rivelano il tentativo di comporre le istanze del più autentico “intellettualismo greco” con elementi propri delle religioni orientali. Questo tentativo costituisce la prospettiva che ho scelto per il mio lavoro di ricerca. E’ probabile, infatti, che Damascio, nella composizione del Trattato sui Primi Principi, abbia voluto radicalizzare, attraverso una serrata revisione critica del pensiero di Proclo e attingendo alle strutture portanti della riflessione di Giamblico, una prospettiva già definita dal pensiero neoplatonico ma non percorsa e sviluppata fino alle sue estreme conseguenze. Il Trattato sui Primi Principi non si presenta semplicemente come commento al pensiero dei predecessori o come inventario delle fonti mitiche e religiose del pensiero. Accanto a questi elementi e profondamente innestato su essi, l’opera contiene uno studio originale e rigoroso della sintassi del principio, strutturato secondo un metodo logico-dialettico la cui novità consiste nella funzione attribuita all’aporia e nell’uso che di essa si fa. La prima sezione del testo articola una complessa aporetica del principio assoluto nel corso della quale Damascio si pronuncia, a favore di Giamblico e contro Proclo, per l’esistenza di un principio ineffabile anteriore all’Uno che conservi, in relazione al tutto, le caratteristiche dell’incoordinazione e dell’assoluta inconoscibilità-inesprimibilità. La postulazione di tale principio non è un omaggio reso all’autorità di Giamblico, ma l’approdo ultimo di una critica stringente intorno alla nozione di principio e all’Uno neoplatonico.
1. Critica alla nozione di principio.
La nozione di principio è intrinsecamente e irriducibilmente aporetica. Infatti, la nozione di totalità, come unità mediata dal molteplice, contiene in modo costitutivo la coordinazione del principio ai suoi derivati. Viceversa, la nozione di principio contiene in modo costitutivo il carattere della trascendenza assoluta. In tal modo soltanto ciò che non rientra in nessuna guisa nell’unica
coordinazione del tutto può essere pensato come principio del tutto. Il ragionamento conduce a conclusioni contraddittorie ma entrambe necessarie: il principio è, ad un tempo, trascendente ed immanente ai suoi prodotti.
2. Critica all’Uno neoplatonico.
L’Uno neoplatonico, in quanto principio primo, è soggetto in pieno all’aporia di immanenzatrascendenza che riguarda la relazione del fondamento al fondato. Esso presenta un’inconciliabile duplicità di aspetti. E’ origine di tutte le cose, dunque rimane presente ad ognuna come causa immanente e si inscrive nella struttura della realtà non solo come ciò da cui tutto discende e verso cui tutto ritorna ma altresì come ciò attraverso cui ogni processione ed ogni ritorno appare possibile. D’altro canto, in nessun modo rimane implicato nei suoi prodotti né si pluralizza in essi, ma conserva rispetto agli enti la sua trascendenza e la sua alterità perfetta. Il ragionamento conduce alla ricerca di un altro principio, che sfugga alla coordinazione del tutto in cui persino l’Uno è avvolto e
che, pertanto, sia anteriore all’Uno stesso.
A questo punto si apre una duplice prospettiva di lettura del testo.
1. Si può ritenere che la postulazione del principio ineffabile non rappresenti altro che il tentativo di estrarre dal sistema la contraddizione e di confinarla in un luogo la cui alterità assoluta consenta di dominarla. In questo caso bisognerebbe indagare se la posizione di tale principio costituisca un reale progresso teorico o non impedisca il ripresentarsi delle medesime aporie del fondamento anche a proposito dell’Uno di Damascio. Per tale giudizio sembra propendere A. Linguiti. Egli ritiene che la posizione dell’esistenza di un principio anteriore all’Uno sia dettata dall’esigenza di superare nel senso della trascendenza la dialettica immanenza-trascendenza dell’Uno neoplatonico. L’ineffabile non assolverebbe nel sistema di Damascio altra funzione che questa e finirebbe per risultare affatto estrinseco alla costruzione metafisica generale. “Sembra che l’unica funzione svolta dal principio ineffabile – afferma Linguiti – sia quella di “concetto-limite”, e dubito che si possa parlare di un effettivo progresso rispetto alla tesi tradizionale che pone come irriducibile la duplicità di aspetti del principio supremo”. In questa direzione si poneva già nel 1946, in modo senz’altro più categorico, R. Strömberg. Egli si propone di riscattare il filosofo dall’immagine di metafisico e mistico dedito alla ripetizione pedissequa dei suoi maestri. Pur riconoscendo a Damascio un ingegno particolare nella refutazione di obiezioni ed eccezioni, un grande acume dialettico nella sua attività di interprete e commentatore, una reale inclinazione alla ricerca e un autentico amore per la filosofia e per la verità, egli finisce per ritrarlo come una mente non creativa, dedita a modificare o rettificare indipendentemente le dottrine dei predecessori, in particolare quelle di Proclo e di Giamblico. La sua filosofia viene
ritenuta agnostica e fondata su un costitutivo scetticismo nei confronti di una possibile stabilità dei sistemi speculativi neoplatonici.
2. D’altro canto si può avanzare l’ipotesi che la revisione critica della metafisica di Proclo alla luce del pensiero di Giamblico rappresenti l’intento di ricondurre il movimento dialettico di costituzione dell’essere e di tutte le sue determinazioni ad un fondo ultimo di decostituzione radicale, cui allude simbolicamente ed in modo sempre insufficiente l’Ineffabile. La posizione di questo principio, coerentemente sviluppata nella costruzione archelogica del Trattato sui Primi Principi, sarebbe pertanto un reale approfondimento della dottrina procliana della negazione. L’intuizione attraverso cui Damascio ripensa la teologia negativa ed il suo metodo è paragonabile forse all’intuizione di una possibile legge per cui si possa far cominciare la serie dei numeri dallo zero anziché dall’uno. La scoperta o anche solo il sospetto dell’esistenza di un simile principio di derivazione determinerebbe, nella serie numerica, la ridefinizione di tutte le relazioni sussistenti fra i termini. Così anche nella gerarchia dei principi neoplatonici mutano i rapporti reciproci. I processi di derivazione divengono vere e proprie “funzioni” dell’assoluto, fondate sulla dialettica dell’autocostituzione del misto. Ogni funzione di autocostituzione si determina come l’inverso della decostituzione radicale che fa da sfondo a tutta la struttura dei principi. Ogni principio si configura come una funzione di inversione dell’assoluto, di modo che tutta la dialettica dei diacosmi dell’essere sembra riscrivere l’Ineffabile al contrario. La posizione del principio ineffabile come duplice nulla, d’essere e d’uno, determina, rispetto al sistema di Proclo, la ridefinizione della natura dell’essere e delle sue proprietà. Esso appare finalmente come la prima funzione di autocostituzione, fondamento di tutti i misti, che si articola
fra le funzioni di decostituzione dell’Ineffabile e della materia. Ad un tempo l’intelligibile, prima proprietà dell’essere, e le sue forme si ridisegnano sullo sfondo dell’inconoscibile e la parola diviene anch’essa funzione del silenzio. L’Ineffabile non è un espediente logico creato al fine di salvaguardare la coerenza del sistema, né il trinceramento dietro l’inconoscibile e l’indicibile dell’inevitabile processo all’infinito cui da luogo il tentativo di mediare il continuo e il discreto. L’intuizione, che spesso l’autore definisce “sospetto”, dell’esistenza di questo principio libera all’interno del sistema un potenziale dialettico tale per cui tutti gli elementi ne risultano movimentati. La relazione fra l’Uno e il Tutto, paradigma della relazione del fondamento al fondato, del nulla all’essere, viene ripensata alla luce della possibile relazione fra l’Ineffabile e l’Uno. Determinare le modalità di questa “relazione”, se ancora di relazione si può parlare, coincide a mio parere con l’individuare l’idea centrale su cui si regge tutto il discorso di Damascio e alla luce della quale valutare i punti di continuità e di frattura rispetto al pensiero di Proclo.
FILOPONO
A cura di Miriam Tedeschi
Nel periodo in cui Proclo (412-485) fu alla direzione della Scuola di Atene la lettura e lo studio delle opere di Aristotele occupò la maggior parte delle discipline di insegnamento. Già precedentemente con Plutarco di Atene prima e Siriano poi, entrambi maestri di Proclo, Aristotele era diventato una vera e propria iniziazione a Platone, con la conseguenza che la conciliazione tra i due autori non era più problematica, come ancora con Porfirio, ma un assunto teorico di base. Eredi di questa tradizione in quanto discepoli di Proclo sono Ermia e il figlio Ammonio. Quest’ultimo succedette al padre nella direzione della scuola di Alessandria. E mentre la decadenza della scuola di Atene iniziò in coincidenza con la morte di Proclo, la scuola di Alessandria proseguiva le sue ricerche sotto la Giovanni Filopono, grammatico e commentatore di Aristotele, visse e studiò ad Alessandria d’Egitto nel VI sec. d.C. Dopo avere concluso gli studi di grammatica, divenne discepolo dell’aristotelico Ammonio. Tra i discepoli di quest’ultimo ricordiamo, oltre a Filopono, Asclepio e Olimpiodoro. Né bisogna dimenticare Simplicio, il quale divenne in seguito allievo di Damascio, che scelse la linea di un platonismo intransigente molto legato alla tradizione, distaccandosi così dall’impronta aristotelica caratterizzante la scuola di Alessandria e le lezioni dello stesso Ammonio. Queste ultime venivano trascritte da alcuni degli allievi più meritevoli, tra cui Filopono. A coloro cui era assegnato il delicato compito della redazione delle lezioni di Ammonio apparteneva anche Asclepio, al quale fu affidato, per esempio, il commento alla Metafisica di Aristotele. Si può affermare con una certa sicurezza che gli allievi rispettassero gli insegnamenti del maestro: la forma didascalica e scolastica che utilizzano nei loro scritti non sembra essere espressione di originalità di pensiero e fa pensare a una trascrizione fedele delle lezioni di Ammonio. Prendiamo ora in considerazione il clima culturale dell’Alessandria del VI sec., in cui Filopono si formò e visse. Egli è legato alle vicende che si susseguirono ad Alessandria in quel periodo, contemporaneamente alla progressiva decadenza della scuola di Atene e alla sua definitiva chiusura ad opera di Giustiniano nel 529: tali fatti contribuirono a fare di lui il primo commentatore cristiano di Aristotele. Lo stesso nome “Filopono” (letteralmente: “amante del lavoro”) indicava colui che faceva parte di confraternite missionarie al servizio della Chiesa. Non è un caso se, proprio nello stesso anno in cui si ordinava la chiusura della scuola di Atene, veniva pubblicato, sotto la guida di Ammonio, il testo di Filopono De aeternitate mundi contra Proclum (Sull’eternità del mondo, contro Proclo). Scritta al fine di salvare la scuola di Alessandria, l’opera sosteneva la dottrina della creazione criticando la concezione aristotelica dell’eternità del mondo. Questo fatto suscitò le simpatie dei cristiani, la cui amicizia era necessaria per assicurarsi il favore dell’imperatore e proseguire gli studi. Lo scritto dev’essere messo in relazione ad un’altra opera, significativamente intitolata Sulla creazione del mondo, in cui Filopono commenta il primo libro della Genesi. Ad Alessandria dunque si continuarono a studiare i classici, ma con l’avvertenza di non ergersi contro la nuova dottrina cristiana. A garanzia di ciò allievi cristiani seguivano lezioni di professori pagani. Pertanto, con la redazione del testo De aeternitate mundi contra Proclum, Ammonio e Filopono riuscirono a salvare la scuola di Alessandria. Sull’altro versante, fu chiusa definitivamente da Giustiniano la scuola ateniese, la quale non solo non voleva scendere a compromessi con il cristianesimo, che non aveva ancora alle sue spalle una elaborazione teorica compiuta e convincente, ma addirittura pretendeva di attribuire ai testi platonici una sacralità che la nuova religione vedeva come oltraggiosa nei confronti dell’unico testo sacro, la Bibbia, e che dunque non poteva in alcun modo accettare. Dopo tale avvenimento, cioè la chiusura dell’Accademia, Filopono intraprese una carriera che sarebbe più corretto definire teologica piuttosto che filosofica. Si occupò delle controversie monofisite e fu promotore del triteismo, posizione che fu condannata nel 680. Nella stesura del suo Commentario al De anima, Filopono riportò probabilmente in modo abbastanza fedele ciò che Ammonio diceva nelle sue lezioni. Ammonio commentava nelle sue lezioni il testo aristotelico, che era però usato solo come punto di partenza per addentrarsi in speculazioni di impronta marcatamente platonica. Per quale motivo, allora, si parla di commentatori di Aristotele e non di Platone? È Simplicio a fornirci una spiegazione di ciò: Platone è l’unico interprete della verità e Aristotele, da parte sua, è il miglior interprete di Platone e quindi della verità. Per ottenere la verità di Platone basterà dunque commentare Aristotele. Nel Commentario al De anima di Filopono, a partire dal proemio, si può riscontrare proprio questa tendenza: si utilizzano argomentazioni aristoteliche (molto spesso tratte dalla logica di Aristotele) ma al fine di accogliere verità platoniche. Il discorso sulle fonti utilizzate da Filopono per scrivere il suo Commentario al De anima è troppo lungo per essere affrontato se non per brevi cenni. Ci è pervenuto il De anima di Alessandro di Afrodisia, testo che, pur non essendo il principale riferimento usato da Filopono, è tuttavia conosciuto da quest’ultimo. Tale testo svolgerà un ruolo importante in particolare nell’analisi che condurremo sull’intelletto attivo. Molto più vicino a Filopono è invece Temistio, nonostante alcune divergenze dottrinali: Filopono dimostra spesso di utilizzare il commento al De anima di questo autore del IV sec. d.C. come fonte. Naturalmente sono molto grandi le affinità tra il commento di Filopono e quello (sempre al De anima) del suo compagno, nonché rivale, Simplicio: l’appartenenza alla medesima scuola ne chiarisce il motivo. Un altro trattato sull’anima che non possiamo trascurare, in quanto Filopono non ne ignora l’esistenza, è quello di Giamblico, conservatoci frammentariamente da Stobeo. In ogni caso l’interlocutore privilegiato di Filopono, come, d’altra parte del suo maestro, rimane Proclo. Quando il filosofo si volge verso se stesso per intraprendere una ricerca sulla natura dell’anima, mentre esercita la sua attività e acquista una sempre maggiore capacità di astrazione, contemporaneamente si purifica e si avvicina alla sfera del divino. Per mezzo di questo esercizio l’intelletto
umano sarà in grado di passare all’atto sempre più frequentemente e di raggiungere la sua perfezione. La facoltà dell’intelletto è, infatti, la più perfetta, ma la caduta nel corpo assopisce, per così dire, le sue capacità, che è compito dello studio e della contemplazione risvegliare. In questo modo l’individuo, in questa vita, ha la possibilità di raggiungere la condizione più perfetta possibile e di contemplare, già ora, gli intelligibili. L’indagine sull’anima non è, dunque, una ricerca che si compie su un altro oggetto; è il soggetto che utilizza se stesso come materia di studio e di analisi, in quanto in se stesso sono già racchiuse tutte le conoscenze, anche se ancora solo in uno stato di potenzialità. Aristotele, tuttavia, non aveva prospettato questo percorso di purificazione interiore, ma lo scopo principale della sua analisi era la ricerca e la fondazione della psicologia come base per lo studio delle altre scienze della natura. Per il neoplatonismo e per i tardi commentatori del De anima, lo scopo non è, invece, la ricerca per se stessa, ma la purificazione e l’apprendimento al fine di risvegliare all’interno di sé le conoscenze offuscate dalla caduta nella materia. Lo scopo dei commentari al De anima non è, dunque, esclusivamente didascalico, ma, in qualche modo, anche “maieutico”: colui che apprende è coinvolto in prima persona nella ricerca e deve ritrovare in se stesso ciò che gli viene insegnato. Infatti, come dice Filopono, non c’è cosa più vicina a noi che la conoscenza di noi stessi. E Filopono – seguendo il suo maestro Ammonio – riprende una opinione di Olimpiodoro che paragona l’anima a un essere anfibio: essa può appartenere sia al mondo fisico sia a quello metafisico. In essa essere e divenire, divisione e in divisione coincidono. Dunque, nello studio dell’anima, non solo bisognerà fare riferimento al mondo metafisico, ma anche a quello fisico. Filopono, pur citando l’intelletto esterno, ne ridimensionerà in modo decisivo la trascendenza. In Filopono la parte superiore dell’anima è sempre strettamente collegata con quella inferiore, come la forma alla materia. Nel suo monumentale lavoro di commento ad Aristotele, in particolare (oltre al già citato De anima) alle Categorie, agli Analitici, alla Fisica, al Generazione e corruzione, Filopono non esita a sottoporre a dura critica parecchi aspetti delle teorie aristoteliche, soprattutto quelle fisiche e cosmologiche: in particolare, Filopono critica duramente la tesi aristotelica secondo la quale i corpi celesti sarebbero composti di etere e, in forza di ciò, sarebbero divini e imperituri. Al contrario, nota Filopono, anch’essi sono costituiti della stessa materia che compone tutti gli altri corpi sublunari e, al pari di tutti gli altri, sono corruttibili. Con quest’operazione speculativa, Filopono può includere anche gli astri tra le opere della creazione divina, in antitesi con la credenza pagana che essi abbiano carattere divino e siano eterni oltreché incorruttibili. Nonostante questa critica della cosmologia aristotelica, Filopono non esita, in materia teologica (a proposito della natura di Dio e della Trinità), a richiamarsi all’apparato concettuale e linguistico di marca aristotelica.
AGOSTINO

LA VITA E LE OPERE
Agostino nasce nel 354 a Tagaste , nell’ attuale Algeria . La madre Monica é cristiana e sarà la figura dominante nella vita del figlio . Il padre Patrizio , pagano , pur avendo scarsi mezzi , gli fa impartire un’ educazione letteraria e retorica . Nella provincia d’ Africa da tempo fioriva la cultura retorica , come dimostra l’ opera di pagani quali Apuleio e di cristiani quali Tertulliano . Agostino studia a Madaura e poi nel 371 a Cartagine , ma non apprende il greco . In questo periodo conduce una vita di dissipazione e si lega con una donna , della quale si ignora il nome , con la quale convive per 15 anni , avendone anche un figlio di nome Adeodato . Respinto dalla rozzezza dei racconti e dello stile della Bibbia , legge un’ opera perduta di Cicerone , l’ Ortensio , dove trova teorizzato il primato della vita filosofica . Si avvicina allora ad una forma di religione di tipo gnostico , il manicheismo , ampiamente diffuso in Africa . Il fondatore di esso , Mani , originario della Persia , si era presentato come apostolo di Cristo , ma fautore di una religione universale e aveva svolto intensa opera di predicazione , sicchè verso il 276 era stato giustiziato dal governo sassanide . I suoi discepoli ne avrebbero continuato l’ attività missionaria , diffondendo il manicheismo fino in Cina . A Cartagine il manicheismo si era insediato già dal 297 . Si trattava di una religione dualistica , nella quale confluivano elementi di origine persiana , ma soprattutto elementi gnostici , anche cristiani . Il nucleo era il riconoscimento dell’ esistenza di due regni , della luce e delle tenebre , ciascuno retto da un principio divino . La vita del manicheo era vista come preparazione all’ evento che avrebbe posto fine alla mescolanza di luce e tenebre . Per 9 anni circa , dal 374 al 383 , Agostino , suscitando la contrarietà della madre , aderisce al manicheismo come uditore ( l’ equivalente del catecumeno cristiano ) : per il manicheismo é il male il creatore del mondo e paradossalmente questo é il peggiore dei mondi possibili ( l’ esatto contrario di quanto dicevano gli Stoici ) . Il manicheismo era una religione che andava incontro ad un personaggio come Agostino che sentiva assai forte il senso del peccato in quanto essa dava al male consistenza ontologica : da giovane Agostino aveva condotto una vita piuttosto dissoluta e peccaminosa e questo lo testimonia egli stesso affermando di aver proferito in gioventù queste parole ” Signore dammi la castità , ma non adesso ” . Dopo un soggiorno a Tagaste nel 375 , si reca a Cartagine per continuare i suoi studi e insegnare la retorica . Qui si circonda di alcuni amici , tra i quali Alipio e Nebridio , compone verso il 380 il suo primo scritto ” Sul bello e sul conveniente ” , che non ci é pervenuto , e comincia a nutrire i primi dubbi sul manicheismo : si reca da uno dei principali esponenti manichei per avere spiegazioni esaurienti , però quello gli dà spiegazioni effettivamente poco convincenti sul piano razionale : fa appello a una mitologia ricca e lussurreggiante . Deluso tanto dal cristianesimo della madre , rozzo e irrazionale quanto dal manicheismo si dà alla filosofia scettica dove arriva alla conclusione di sapere di non sapere , per dirla alla Socrate . Tutte queste esperienze lasciano tracce in lui : del manicheismo permane in Agostino l’ idea del senso del peccato e la visione dell’ umanità come ” massa damnationis ” , dello scetticismo gli rimarrà l’ idea dell’ impossibilità di avere certezze . Nel 382 decide di trasferirsi con la madre , la concubina , il figlio e alcuni amici a Roma , dove insegna retorica , riscuotendo successo e attirando l’ attenzione di Simmaco , prefetto della città . Questi riceve l’ ordine di scegliere un professore di retorica per Milano , dove risiede la corte imperiale , e propone Agostino . Anche per l’ appoggio di influenti manichei ( sebbene Agostino si fosse già sganciato da tale religione ) , la proposta é accolta . Nel 384 Agostino arriva a Milano e può assistere alle prediche del vescovo Ambrogio . Sorrette dall’ interpretazione allegorica e spirituale delle Scritture , pervase dalla presenza di dottrine neoplatoniche , dal riconoscimento della superiorità dell’ anima sul corpo e del suo destino ultraterreno , queste prediche lo predispongono alla lettura della Bibbia . Nel 385 decide di farsi catecumeno , abbandona la sua concubina e , insieme ad alcuni amici , legge i ” libri dei Platonici , ossia Plotino e Porfirio , forse nella traduzione di Mario Vittorino . In essi , egli trova argomentata la supremazia e l’ autonomia del mondo incorporeo e spirituale . Neoplatonismo e cristianesimo gli appaiono conciliabili , ma avverte che il primo é sprovvisto dei concetti di incarnazione e redenzione ad opera di Cristo . Ciò che egli cerca é appunto una garanzia di stabilità in un ” dottore invisibile ” , Dio . Agostino rimane affascinato dal cristianesimo in chiave platonica , raffinato ed esauriente , a differenza di quello della madre : in questo periodo il cristianesimo sta sempre più diventando la religione di stato , anche grazie ad Ambrogio ; Agostino scopre che ciò che dice il vangelo di Giovanni é affine a ciò che dicevano i neoplatonici ed in particolare Plotino : in principio era il Logos . Noi moderni non ci stupiamo tanto , in quanto é evidente che Giovanni é assai influenzato dal neoplatonismo . Nel 386 avviene la conversione , che egli racconterà più tardi nelle Confessioni . Affetto da un dolore al petto , decide di ritirarsi con il figlio , la madre e alcuni amici nella villa di un amico a Cassiciaco , vicino al lago di Como . Qui scrive un primo gruppo di opere , dialoghi alla maniera di Cicerone : ” Contro gli Accademici ” , ” Sulla vita beata ” , ” Sull’ ordine ” , ” Sull’ immortalità dell’ anima ” , quest’ ultimo rimasto incompiuto . Nuovi anche nel titolo , oltre che nella forma , sono invece i ” Soliloqui ” , che iniziano con una preghiera e proseguono come colloquio tra la sua ragione e la sua anima . Nell’ aprile del 387 riceve il battesimo a Milano da Ambrogio e prende la decisione di tornare in Africa a condurre una vita cristiana di meditazione . Durante il tragitto , muore ad Ostia la madre Monica . Alla fine del 388 Agostino arriva in Africa e si stabilisce a Tagaste , vivendo per due anni con un piccolo gruppo di persone secondo il modello della comunità monastica , ma continua anche a scrivere libri . In particolare , egli progetta di comporre una serie di scritti sulle arti liberali : di essi é rimasto soltanto quello ” Sulla musica ” . Di questo periodo sono anche opere di rilevanza filosofica , come ” Sul maestro ” , nel quale egli espone le sue concezioni dell’ apprendimento , ” Sul libero arbitrio ” e ” Sulla vera religione ” , dove é elaborata la tesi del cristianesimo come vera religione , fondata sulla concezione di un unico Dio creatore . Questa tesi segna anche l’ ormai netto distacco dalle posizioni manichee , contro le quali egli compone in questi anni una serie di opere polemiche , in particolare sull’ interpretazione della Genesi . Nel 391 si reca a Ippona con l’ intenzione di fondarvi un monastero , ma é fatto prete per aiutare il vescovo della città , Valerio , che gli consente di predicare : inizia così l’ attività pastorale di Agostino , che durerà sino alla fine della sua vita . Nel 395 é nominato vescovo coadiutore e l’ anno successivo , alla morte di Valerio , vescovo a pieno titolo di Ippona . Sono anni in cui con gli scritti e con la predicazione Agostino combatte anche contro la Chiesa del vescovo Donato , fondata su una concezione rigoristica e settaria della comunità ecclesiale , dalla quale devono essere esclusi tutti gli impuri . Nella lotta contro i donatisti , Agostino non esita ad appoggiarsi alle autorità imperiali e ad auspicare l’ uso di mezzi coercitivi anche violenti : l’ umanità , caduta con Adamo nel peccato , ha bisogno di freni , che le impediscano di ricadere nel male . Nel 411 un sinodo di vescovi riunito a Cartagine condanna il donatismo . Sempre più impegnato nella sua attività di vescovo , come protettore della comunità cristiana e arbitro nelle liti , Agostino continua a scrivere . Si tratta di opere in gran parte legate ai problemi della sua comunità e quindi dirette in primo luogo ai membri di essa ; ma al tempo stesso egli si dedica anche ad opere di maggior respiro , che lo impegnano per parecchi anni . In particolare , nel 396 inizia uno scritto ” Sulla dottrina cristiana ” , che sarà completato in 4 libri soltanto nel 427 . In esso , egli fornisce un quadro complessivo della cultura cristiana , fondata sull’ utilizzazione del sapere elaborato dalla cultura classica , ma avente al suo vertice lo studio e l’ interpretazione della Bibbia . Verso il 397 egli inizia anche la composizione della sua opere letterariamente più originale , le Confessioni , in 13 libri , terminate verso il 400 ; e fra il 399 e il 419 scrive la sua opera teologica più importante , i 15 libri ” Sulla Trinità ” . Parecchi anni , dal 401 al 414 , richiede anche la stesura del suo trattato esegetico più importante , un commento alla Genesi . Nell’ agosto del 410 i goti , guidati da Alarico , saccheggiano Roma . Girolamo si chiede : ” se Roma può perire , che cosa può esservi di sicuro ? ” . Anche per rispondere alle accuse dei pagani , che imputano le sventure dell’ impero all’ ira degli dei contro i cristiani , Agostino compone nel 413 i primi tre libri della ” Città di Dio ” . L’ opera sarà completata nel 426 raggiungendo il numero complessivo di 22 libri . In essa Agostino tenta di dimostrare la superiorità del cristianesimo su tutta la cultura pagana e sugli pseudo-valori che la sorreggono , ma nel frattempo egli é costretto anche ad affrontare un nuovo avversario , il pelagianesimo , che ai suoi occhi minaccia anch’ esso , come il donatismo , di frantumare l’ unità della Chiesa e del suo insegnamento . Pelagio era un monaco originario della Britannia , ma si era stabilito a Roma , vivendovi da laico battezzato per oltre 30 anni . Qui era riuscito ad attrarre nella sua cerchia anche l’ amico di Agostino , Paolino da Nola . Nel 411 Pelagio era sbarcato in Africa , ma non si era incontrato con Agostino , e l’ anno dopo era partito per la Palestina . Le sue dottrine continuarono però ad essere diffuse nell’ ambiente di Agostino soprattutto ad opera di Giuliano di Eclano . Contro i pelagiani , e in particolare contro Giuliano , Agostino scrisse numerose opere , quali ” Sulla grazia di Cristo ” e ” Sul peccato originale ” , ” Sulla grazia e sul libero arbitrio ” , Sulla predestinazione dei santi . Tra la fine del 429 e la primavera del 430 i vandali , guidati da Genserico , invadono l’ Africa del nord e pongono l’ assedio anche a Ippona , difesa da Bonifacio con l’ aiuto di mercenari goti . Nell’ agosto del 430 Agostino é colpito da febbre e poco dopo muore . L’ anno successivo Ippona é evacuata ed in parte incendiata , ma la biblioteca di Agostino probabilmente sfugge alla distruzione . Verso la fine della sua vita Agostino aveva voluto riordinare i suoi scritti , li aveva riletti e aveva scritto le Retractationes ( termine che significa propriamente ” nuova trattazione ” ) , nelle quali guardava all’ indietro a tutta la sua attività letteraria . Esse sono composte di due libri , forniscono l’ elenco delle sue opere principali , indicano l’ occasione della loro composizione e quali sono i loro contenuti e al tempo stesso danno una valutazione , talvolta autocritica , di esse . Nelle intenzioni di Agostino il lettore di questo nuovo tipo di libro deve percepire , come avviene anche con le Confessioni , l’ itinerario percorso dall’ autore . Agostino vuol dare un’ immagine di sè , inquietamente in evoluzione sino al suo periodo conclusivo .
IL PROBLEMA DEL MALE
La lettura giovanile dell’ Ortensio di Cicerone , come già accennato , pone davanti agli occhi di Agostino l’ ideale di una vita filosofica ; tuttavia , egli avverte di non avere in sè forze sufficienti per realizzare il modello del sapiente stoico , che disprezza i piaceri e le ricchezze . Sin dall’ inizio egli si pone l’ interrogativo : perchè facciamo il male ? La sua adesione al manicheismo é legata alla convinzione di poter trovare in esso la risposta a questa domanda . Esso , infatti , riconosce l’ esistenza reale di un principio del male , dal quale dipendono le nostre azioni cattive ; ma il manicheismo é permeato anche dal desiderio di essere liberati dal male e di tornare al regno della luce . Ciò che del manicheismo attrae il giovane Agostino é anche la critica alla rappresentazione antropomorfica della divinità nell’ Antico Testamento e soprattutto il fatto che esso richiede un’ adesione fondata non sull’ autorità , bensì sull’ approfondimento filosofico . Ma la rilettura a Milano , nel 384 , degli scritti di Cicerone , vicini allo scetticismo dell’ Accademia , comincia a suscitare dubbi sulla coerenza della dottrina manichea , oltre che sul suo dogmatismo e settarismo . I manichei parlano di due principi in lotta tra loro : ma se il principio delle tenebre non può esercitare un’ azione o addirittura danneggiare il principio della luce , ha significato parlare di una lotta tra essi ? Se Dio trova contrapposto a sè un principio del male , é segno che egli ne subisce l’ azione , ma come é possibile che Dio subisca mutamenti e addirittura soffra ? Dio , se é bene perfetto , deve essere immutabile e incorruttibile . Platone aveva insegnato che solo ciò che é incorporeo e puramente intellegibile é immutabile ; questo stesso insegnamento Agostino ritrova nelle prediche di Ambrogio . Plotino , dal canto suo , aveva mostrato che il bene , ben lungi dall’ essere passivo , irradia da sè i molti . La conclusione di Agostino é che non possono esistere due principi contrapposti , tanto meno due principi corporei : la divinità é unica , incorporea e incorruttibile . Ma se Dio é bene ed é l’ unico principio , creatore di tutte le cose , il male fisico e il male morale , i dolori e le colpe , derivano anch’ essi da Dio ? In un primo momento , negli anni della conversione , la risposta di Agostino é vicina alla soluzione del neoplatonismo . Tutto ciò che é , in quanto é , é bene e proviene dal Sommo Bene , che é anche il supremo essere . Certamente esiste una gerarchia dei beni , che va dal Sommo Bene , Dio , a ciò che é soltanto corporeo . Il livello spirituale si trova nel mondo sensibile solo in forma indebolita e imperfetta , ma anche le entità del mondo sensibile , in quanto sono dotate di essere , non sono male . Il male non é altro che mancanza , non essere , come la cecità é rispetto alla vista . Dunque quello che sarà chiamato male metafisico non esiste propriamente , secondo Agostino . Dal manicheismo , che riconosce nel male addirittura un principio costitutivo del mondo , Agostino é passato alla posizione opposta , negando vera e propria realtà al male . Inoltre , come già aveva insistito Plotino , un ordine é tanto più perfetto quanti più contrasti presenta al suo interno : la bontà di quest’ ordine risulta dall’ insieme dei suoi costituenti , non dalle cose singolarmente prese . Ciò che singolarmente preso può apparire male , infatti , visto nell’ insieme ordinato delle cose si configura come bene . Resta da chiarire in che cosa consistano allora le sofferenza e i dolori , ossia il male fisico e le azioni malvage , ossia il male morale . Quando l’ anima compie il male , non passa da un bene a un’ entità che sia di per sè un male , in quanto , come si é visto , il male non ha propriamente realtà . L’ azione malvagia consiste , invece , nel dirigersi dalla volontà del bene eterno a un bene temporale , nell’ amare un bene che é inferiore al Sommo Bene come se fosse il Sommo Bene . In ciò consiste il peccato : esso é male , e non l’ oggetto che , peccando , é amato . E’ la volontà umana che , peccando , rende male ciò che di per sè non è male : in essa é dunque l’ origine del male , non in Dio . Orientandosi verso ciò che é inferiore a Dio , la volontà malvagia si oppone a Dio . E’ quanto fanno gli angeli ribelli a Dio , i demoni e gli uomini . Con il peccato non si produce del male a Dio o all’ ordine complessivo del mondo , ma a se stessi : é la propria natura che viene corrotta . Chi commette una colpa ha già in ciò la sua punizione , in quanto si priva del Sommo Bene , che é Dio , per rivolgersi a beni inferiori e mutevoli . I mali fisici , a loro volta , non sono altro che conseguenze del male morale , punizioni per i peccati commessi . In questa prima fase della riflessione di Agostino il riferimento alla caduta , dovuta al peccato originale commesso da Adamo , non ha ancora posizione centrale . Si pone invece il problema , affrontato soprattutto nello scritto Sul libero arbitrio , del perchè Dio abbia dato all’ uomo la libertà . La risposta di Agostino é che senza la libertà non sarebbe possibile azione retta da parte dell’ uomo . Se l’ uomo non fosse libero di agire , come si potrebbe definire buona o cattiva una sua azione ? D’ altra parte , se l’ uomo usa male la sua libertà , ossia la usa per peccare , ciò non dipende da Dio . Questi non ha dato all’ uomo la libertà , che di per sè é un bene , per peccare . Ma come é possibile ciò con la prescienza propria di Dio ? Si potrebbe , infatti , obiettare che , in quanto presciente , Dio sappia che l’ uomo peccherà e dunque é necessario che l’ uomo pecchi : ma se é necessario , allora il peccare non é un atto libero . Agostino risponde che Dio prevede la nostra azione , ma la prevede come dovuta alla nostra volontà . Questa non potrebbe essere propriamente volontà , se non fosse in nostro potere ; ma essa é in nostro potere , se noi siamo liberi , dunque Dio prevede la volontà come in nostro potere e pertanto la sua prescienza non ci sottrae la libertà .
RICERCA E INTERIORITA’
Per arrivare alla conversione é vero che Agostino viene influenzato dal neoplatonismo , ma questo di per sè non basterebbe : egli effettua un ragionamento di forte influenza scettica : gli uomini di fatto vengono ingannati dai sensi , la loro conoscenza é limitatissima , e dubitano di tutto : pare quindi che non vi siano certezze , ma in realtà una c’è , ed é la certezza di dubitare , la certezza di essere soggetti dubitanti ; se si é certi di qualcosa , vuol dire che c’é una verità posseduta dall’ uomo che gli permette di entrare in contatto con la Verità , la verità in sè per dirla alla Platone : all’ uomo basta cogliere una sola verità per entrare in contatto con la Verità in sè , l’ idea di Verità : tutte le particolari verità con le quali l’ uomo può entrare in contatto sono pallide manifestazioni del principio supremo , ossia la Verità in sè ; secondo Agostino dall’ unica verità che possediamo , quella di non avere certezze , possiamo risalire fino a raggiungere la Verità assoluta , che altro non é che Dio . Si parte quindi dai limiti dell’ uomo per arrivare a conoscere Dio . Questo processo particolare vuole che la ricerca della Verità assoluta sia tutta interna all’ uomo ( Agostino diceva ” redi in te ipsum ” ) , ma che il culmine , ossia Dio , sia qualcosa di trascendente : Agostino diceva sempre di aver cercato due cose , l’ anima e Dio , senza mai indagare la realtà , ma limitandosi alla trascendenza . La ricerca dell’ anima e quella di Dio sono poi la stessa cosa : é lo scavare nell’ anima che mi porta a Dio ; il punto estremo dell’ interiorità é un qualcosa che va oltre all’ anima , similmente a ciò che diceva Plotino . L’ essenza della nostra anima é divina : é come se si avesse un principio divino dentro di noi . Esaminiamo ora il tutto in termini di Logos , ossia di razione divina : scavando dentro di noi , il Logos interno che possediamo , ossia la nostra facoltà razionale , altro non é che una manifestazione del Logos divino , che altro non é che Dio , o meglio la ragione divina , o ancora meglio la seconda persona della Trinità , concezione che presenta parecchie analogie con le ipostasi plotiniane , con la differenza che i livelli della Trinità sono sullo stesso piano ; l’ Arianesimo , però , voleva il Figlio subordinato al Padre . Con Agostino , il cristianesimo sorpassa la concezione di Trinità ( Padre , Figlio e Spirito Santo ) puramente metaforica e arriva a dare una dimostrazione filosofica : il Padre é potenza , il Figlio é sapienza e lo Spirito Santo é amore ; ma perchè ? Esaminiamo il Credo cristiano , dove il rapporto tra Padre e Figlio é così definito : ” il Figlio é generato dal Padre , lo Spirito procede dal Figlio e dal Padre ” ( la differenza tra Chiesa occidentale e Chiesa orientale é che quella orientale dice che lo Spirito procede solo dal Padre , mentre quella occidentale dice ” filioque ” , anche dal Figlio ) . La prima persona é onnipotente , e la figura del padre dà l’ idea di potenza , poi essa genera un’ altra persona guardando dentro di sè , come se il Padre si specchiasse dentro : il ” rispecchiamento ” é metafora dell’ attività conoscitiva , e quindi il Figlio é la sapienza . Lo Spirito , invece , é l’ amore che unisce Padre e Figlio : la potenza del Padre crea un altro dio , il figlio , che è la sapienza del Padre e tra loro c’è un rapporto di amore come tra due persone , e così abbiamo una terza persona : é quindi più sensata l’ interpretazione della Chiesa occidentale che vuole che l’ amore proceda da entrambe . Proprio come in Plotino vi é una ipostatizzazione delle facoltà umane : potenza , amore e sapienza , che nell’ uomo sono presenti in forma limitata , in Dio illimitata ; la differenza rispetto a Plotino e ai Neoplatonici é che per Agostino l’ uomo é più completo , in quanto in lui non vi é solo la sfera conoscitiva . Va però detto che il cristianesimo dei tempi di Agostino era profondamente diverso rispetto a quello dei giorni nostri : in un primo tempo infatti il cristianesimo non prometteva al credente l’ immortalità dell’ anima , ma solo la resurrezione del corpo , che sarebbe dovuta avvenire nell’ arco di un breve periodo di tempo ; visto che però il mondo non finiva mai e che quindi la resurrezione dei corpi continuava ad essere rimandata , i cristiani attinsero da Platone e dalla sua teoria dell’ immortalità dell’ anima ; ma ricordiamoci che il Dio cristiano é un Dio incarnato , che viene definito nella lettera ai Romani ” scandalo per gli ebrei e follia per i pagani ” : é una concezione molto rozza , dalla quale Agostino non poteva che aborrire . Quando egli parla della resurrezione parla di corpi trasfigurati dove non vi é l’ irrecuperabilità della materia , ossia essa non ha connotazioni negative come era per Platone : il cristianesimo antico , e quindi anche quello di Agostino , non era , come quello del giorno d’ oggi , avverso alla materia e il vero spiritualismo era costituito soprattutto dal neoplatonismo . Agostino riprende , come detto , l’ ipostizzazione e la colloca nell’ ambito delle facoltà umane : le nostre facoltà , per esempio la ragione , sono imitazioni , per dirla alla Platone , delle tre persone divine , ossia della Trinità ; la potenza , l’ amore e la sapienza di Dio sono personificate , a differenza da ciò che aveva fatto Plotino : per questo , dice Agostino , l’ uomo é fatto a immagine e somiglianza di Dio : la nostra ragione non é altro che una pallida imitazione del Logos divino . La conversione al cristianesimo non significa in Agostino abbandono della filosofia , ma fiducia di poter proseguire l’ indagine intellettuale con l’ aiuto di Dio . Filosofia ed esperienza religiosa si fondono in un insieme inscindibile , un ” sinolo ” , per dirla alla Aristotele . Per arrivare al processo di ricerca interiore già esplicato , Agostino ricorre alla citazione biblica ” Cerca e troverai ” . Nel periodo in cui egli scrive i suoi primi scritti , Cristo , in una certa misura , incarna ancora in forma visibile quella saggezza che il filosofo cerca nella sua forma invisibile . In questo periodo egli é convinto che gli antichi filosofi , se rinascessero , diventerebbero cristiani . La felicità risiede in primo luogo nella sapienza , nel vivere in conformità a quanto ha di meglio la natura umana , ossia in conformità alla ragione . E la sapienza é conseguibile , come mostrano le verità matematiche , che sono indubitabili : che tre per tre faccia nove é necessariamente vero , anche se il genere umano per ipotesi non esistesse . Ritenere , come fanno gli scettici , che l’ unico criterio é dato dal verosimile e non dal vero é per Agostino assurdo , perchè non é possibile dire che qualcosa é simile al vero , se non si conosce il vero . Nello scritto Sul libero arbitrio , Agostino elabora la seguente argomentazione : tu sai di esistere e di ciò non puoi dubitare , perchè se tu non esistessi non potresti neppure essere ingannato . Questo fatto non potrebbe esserti evidente se tu non esistessi : é dunque evidente che tu esisti e vivi . Ma allora é anche evidente che qualcosa ti é evidente e che tu lo comprendi , dunque chi esercita il pensiero deve esistere e vivere . Questa argomentazione é ripresa da Agostino nel de Trinitate e nella Città di Dio e si può compendiare nella formula : si fallor , sum . Se m’ inganno , esisto ed ho la certezza di esistere . Questa argomentazione ha la peculiarità di cercare la garanzia della verità e della certezza non nel mondo esteriore , bensì in quello interiore , come già abbiamo detto . Ma non abbiamo ancora spiegato che cosa Agostino intenda per Verità . Agostino lo spiega nello scritto Sulla ragione dove afferma che essa é una e immutabile e mostra ciò che é . La Verità non é altro che il pensiero , la parola di Dio ; essa é eterna e quindi continua a sussistere anche nell’ ipotesi che il mondo vada distrutto . Infatti , argomenta Agostino , se il mondo perirà , é vero che perirà e , se rimarrà , é vero che rimarrà . Si può addirittura concludere che , se anche la Verità scomparirà , sarà vero , dopo la scomparsa della Verità , che essa é scomparsa . Ma questo argomento non può essere vero , se la verità non c’é più : occorre , dunque , ammettere che la Verità é eterna . Anche questa argomentazione agostiniana a favore dell’ eternità della Verità ha la prerogativa di svincolare la nozione di Verità dall’ esistenza delle cose esterne . Chiaramente Agostino fa dell’ anima il luogo della conoscenza sulla scia dei platonici , dicendo che il mondo sensibile non ha autonomia , ma che nella migliore delle ipotesi é soltanto immagine del mondo intellegibile , al quale solo l’ anima può accedere . Così ogni processo educativo ha soltanto una funzione esterna di preparazione all’ avvento della ragione : il vero apprendimento avviene all’ interno , dove l’ anima entra in contatto con quel maestro interiore che é Cristo . Il linguaggio stesso é solo uno strumento per insegnare , imparare e ricordare ciò che si é appreso . Le parole sono segni , ma il contenuto a cui si riferiscono i segni non può essere colto con certezza attraverso i segni stessi . L’ impossibilità di una conoscenza diretta delle cose e la necessità di una conoscenza e comunicazione indiretta attraverso segni sono interpretate da Agostino come risultati della caduta nel peccato , quando Adamo e Eva si accorsero di non poter comunicare se non attraverso l’ artificio del linguaggio e dei gesti . Il ponte tra Dio e l’ uomo é colmato dalla Bibbia con le sue immagini e il suo linguaggio di segni dai molteplici significati . La Bibbia é la base della dottrina cristiana , che per intendere la parola di Dio depositata in essa utilizza tutti gli strumenti utili , dalla grammatica alla dialettica , elaborati dalla cultura pagana . Il mondo delle scienze profane può così essere riassorbito e posto al servizio dello studio della Bibbia . La Verità é eterna , mentre l’ anima umana é una sostanza immortale , indipendente dal corpo , ma non eterna . La Verità non proviene dai sensi , nè é prodotta dall’ uomo ; altrimenti essa sarebbe effimera come i corpi e sottoposta a tutte le oscillazioni alle quali é sottoposto l’ uomo . La Verità é qualcosa , come detto , che l’ anima trova dentro di sè , non fuori , nel mondo . E’ solo l’ illuminazione , l’ irradiarsi della parola divina , che può condurre alla conoscenza oggettiva ; essa consente all’ uomo di accedere alla verità , come già aveva detto Platone nella ” Repubblica ” , é l’ analogo della luce . Grazie a questa luce interiore l’ anima può recuperare , in un processo di reminescenza , le verità immutabili , le idee e le ragioni delle cose , quelle che Agostino chiama ” regole eterne ” , i principi universali , i criteri di verità . Platone aveva identificato la fonte di quella luce che é la Verità con l’ idea di Bene . Agostino , sulla scorta del Vangelo di Giovanni , può ravvisarla nel Logos che ” illumina ogni uomo che viene in questo mondo ” . Contrariamente a quanto aveva sostenuto Platone , le idee non hanno esistenza autonoma , ma esistono nel Logos come modelli della creazione delle cose . Grazie alla verità universale e immutabile diventa allora possibile il riconoscimento delle stesse verità da parte di individui diversi . La verità generata dall’ illuminazione divina garantisce la stessa possibilità di comunicazione e accordo tra gli uomini . Il programma di Agostino trova allora la sua piena enunciazione all’ inizio dei Soliloqui : voglio conoscere Dio e l’ anima , ma la ricerca dell’ uno é indisgiungibile da quella dell’ altra . Più precisamente , si tratta di quell’ itinerario già descritto che porta dall’ anima a Dio . Dio è , secondo il dettato neoplatonico , pura unità , ma per Agostino , contrariamente a quanto pensava Plotino , Dio é anche vero essere , verità , pensiero , . L’ anima partecipa della luce dell’ intellegibile , che ha il suo fondamento in Dio . Di conseguenza l’ anima che conosce se stessa , riconosce in sè come sua origine Dio . Per conoscere é quindi necessario non uscire fuori di sè ; emerge in questo modo la dimensione costitutiva dell’ attività filosofica di Agostino : uno spazio entro il quale Dio e l’ anima sono soli e l’ anima può rivolgersi direttamente a Dio . Agostino riprende la forma platonica del dialogo , ma essa si trasforma ora nel dialogo diretta a tu per tu fra l’ uomo singolo e Dio . Platone aveva sostenuto che il pensiero é dialogo dell’ anima con se stessa , non con Dio , nè Plotino aveva colloquiato con l’ Uno impersonale , privo di qualsiasi tratto che potesse avvicinarlo all’ uomo . Per Agostino , invece , il pensiero diventa dialogo interiore tra l’ uomo e Dio . Questa impostazione dà origine a un tipo nuovo di scritto , emblematicamente rappresentato dalle Confessioni , nelle quali domanda filosofica e preghiera a Dio fanno tutt’ uno . Agostino adotta il linguaggio dei Salmi , di un uomo che si rivolge a Dio , ma in generale le Sacre Scritture possono ora essere costantemente introdotte come la parola e la risposta di Dio alle domande dell’ anima . I testi sacri non sono tanto un oggetto esterno da interpretare , quanto uno dei poli del dialogo tra l’ anima e Dio . Nelle Confessioni i fatti biografici sono inquadrati entro una cornice teologica . L’ esperienza individuale di Agostino , nella totalità delle sue componenti carnali , emotive e conoscitive , ricapitola la storia della redenzione dal peccato per l’ intervento della grazia . In questo senso essa diventa anche storia collettiva dell’ itinerario dell’ anima verso la verità e la salvezza . E contemporaneamente è anche la dimostrazione del fallimento dei tentativi , da parte dei filosofi antichi , di raggiungere la felicità con forze soltanto proprie . Non é più la filosofia ad essere la vera terapia dell’ anima , Agostino dice : ” il nostro cuore é inquieto finchè non riposi in te ” , ossia nel Dio guaritore che parla nell’ interiorità e attraverso i testi sacri . Ciò non significa che l’ aver ritrovato Dio ponga fine alla ricerca , almeno finchè si é in questa vita . Il porto al quale approda il convertito può ancora sempre essere agitato da tempeste e nell’ interiorità continuano a rimanere zone oscure , insondabili .
FEDE E RAGIONE
Uno dei temi fondamentali trattati da Agostino é quello riguardante il rapporto tra fede e ragione ; la concezione agostiniana a riguardo può essere sintetizzata nell’ espressione : ” Credo ut intelligam , intelligo ut credam ” , ossia credo per capire e capisco per credere . In Agostino il rapporto fede e ragione non è vissuto in termini di esclusione reciproca ed é convinto che si possano intrecciare vicendevolmente ; dunque se la ragione può intrecciarsi con la fede , allora la ragione umana non é corrotta , come aveva sostenuto Tertulliano . Per Agostino solo chi ha la fede può capire fino in fondo , ma , paradossalmente , chi ha solo la fede , a sua volta , non può capire fino in fondo : fede e ragione si completano a vicenda . Per avere una piena conoscenza di una verità bisogna partire dall’ atto di fede , tipico di una filosofia cristiana quale quella agostiniana : ricordiamoci che Agostino in primo luogo era cristiano , poi anche filosofo . Una volta fatto l’ atto di fede , si può capire meglio e applicare la ragione . Solo chi ha la fede può applicare la ragione fino in fondo , nel migliore dei modi . Però é solo con la ragione che si può comprendere l’ atto di fede : é come se la ragione illuminasse la fede . E tuttavia la sola ragione non basta, e cercare di capire Dio con essa, rifiutando l’atto di fede, sarebbe per Agostino come voler racchiudere in una ciotola l’intero mare; tuttavia, compiuto l’atto di fede, la ragione può illuminarci e farci comprendere meglio tale gesto, sì perché in fondo sia la fede sia la ragione per Agostino hanno origine divina. Questa concezione fortemente positiva della ragione in Agostino trova corrispondenza con la Trinità : in fondo nella Trinità la ragione umana , il logos , non é altro che un barlume del Logos divino , ossia della ragione divina : la ragione umana é una copia della seconda persona della Trinità , la sapienza ; é come se la ragione di ciascuno non fosse altro che un briciolo di divinità presente in noi . Fede e ragione risultano quindi essere per Agostino all’ incirca la stessa cosa , in quanto sono entrambi legati a Dio . Certo talvolta nel corso della storia ci sono stati evidenti casi di contrasto tra ragione e fede , e Agostino ne era consapevole : pensiamo alla vicenda di Galileo , sebbene posteriore ad Agostino : Galileo servendosi della ragione andò contro la fede . Ma Agostino ha una risposta a questo possibile contrasto : di per sè tra fede e ragione non c’é contrasto , anzi si completano , in quanto derivano entrambi da Dio ; che non siano in contrasto , però , non toglie che esse possano essere mal interpretate . Per Agostino il rapporto tra fede e ragione é un rapporto di intimità , di radicale non contraddizione .
IL PROBLEMA DEL TEMPO
Nell’ undicesimo libro delle confessioni Agostino analizza il problema del tempo : Agostino diceva ” io so che cosa é il tempo , ma quando me lo chiedono non so spiegarlo ” . Il punto di partenza é dato dal racconto biblico che presenta la creazione come una successione di operazioni e di eventi . Da questo racconto sembra risultare che la creazione avvenga nel tempo , sia frutto di una decisione da parte di Dio e comporti dunque un mutamento nella sua volontà . In particolare , ci si può anche chiedere che cosa facesse Dio prima della creazione . Questa domanda presuppone che anche Dio sia nel tempo . In realtà , secondo Agostino , Dio é fuori dal tempo , é nell’ eternità e non crea le cose nel tempo . Con la creazione delle cose , Dio crea anche il tempo , quindi non esiste tempo prima della creazione . Ma che cosa é il tempo ? Parrebbe ovvio considerare il tempo come la somma di passato , presente e futuro : ma il passato non é più e il futuro non é ancora . Parrebbe dunque che soltanto del presente si possa dire che é . E allora che cosa significa che é ? Se il presente fosse sempre attuale , sarebbe l’ eternità . In realtà esso esiste come presente solo a condizione di tramutarsi in passato e di non essere ancora futuro . Il tempo allora sembra esistere solo in quanto ” tende a non essere ” . Di fatto però esso non può essere nulla , dal momento che percepiamo e misuriamo gli intervalli di tempo , distinguendo tra brevi e lunghi . Gli intervalli di tempo sono divisibili all’ infinito ; se trovassimo il non ulteriormente divisibile , questo sarebbe il presente . Ma se il presente é un intervallo , si divide in qualcosa di passato e in qualcosa di futuro : il presente non ha estensione ; si dà allora soltanto il continuo tradursi del futuro nel passato . Per cogliere la vera realtà del tempo occorre guardare nell’ interiorità . Se il passato é oggetto di ricordo , e questo ricordo é vero , chi lo ricorda deve vederlo e quindi in qualche modo il tempo deve essere . Parlando del passato noi non esponiamo le cose che sono passate , ma usiamo parole formate secondo le immagini impresse nel nostro animo delle cose nel loro accadere . La memoria ha la facoltà di trattenerle ; essa , però , é qualcosa che si possiede al presente . La memoria , allora , non é altro che presente del passato . Un discorso analogo vale anche per le altre due dimensioni del tempo : il futuro non é altro che attesa presente di ciò che sarà e il presente attenzione presente a ciò che é . Le 3 dimensioni del tempo sono dunque tre ” presenti ” nella nostra anima : eventi passati , presenti e futuri sono in quanto sono presenti nella nostra anima . Solitamente per misurare il tempo che trascorre si assumono come termine di riferimento i moti degli astri , ma Agostino capovolge la prospettiva : non sono questi moti a determinare l’ unità di misura del tempo . E’ piuttosto il tempo ad essere il fondamento della determinazione della durata di questi stessi moti ; un moto astronomico , infatti , potrebbe mutare . Il tempo invece é ” distensio animi ” , un distendersi dell’ anima . E’ questo a darci la misura del tempo . Ciò che viene misurato dall’ anima non sono , quindi , le cose nel loro trascorrere , ma l’ affezione che esse lasciano e che permane nella nostra anima anche quando esse sono trascorse . Le tre dimensioni del tempo non sono altro che tre articolazioni del distendersi dell’ anima : il ricordo , il prestare attenzione a qualcosa , l’ attesa . L’ anima consente di connettere le tre dimensioni temporali in un’ unità . La conseguenza é che , se non ci fosse l’ anima , non ci sarebbe il tempo . L’ unità divina , invece , comprende nel presente stabile della sua eternità tutto ciò che é stato , é e sarà . In tal modo , l’ unità divina é la garanzia che il tempo , che é traccia della nostra lacerazione e lontananza da essa , non trascini tutto verso il non essere .
LA PREDESTINAZIONE E LA GRAZIA
Nell’ assumere come sacerdote e vescovo posizione attiva nella vita della Chiesa , Agostino si trova a dover continuare la lotta contro i manichei e ad affrontare il problema delle relazioni tra le libertà e il peccato . In una prima fase , come si é visto , Agostino difende la libertà del volere : la volontà é in nostro potere ed é essa la causa del male . Il peccato , in quanto allontanamento dall’ ordine naturale voluto da Dio , é anche un atto di superbia , che presuppone la volontà di essere come Dio . Progressivamente Agostino viene accentuando l’ accusa di superbia contro i filosofi , soprattutto stoici , ma anche platonici , che hanno preteso di raggiungere la virtù e la felicità soltanto con le proprie forze . Contro l’ ottimismo dei filosofi , che credono nell’ onnipotenza della ragione e nelle sue capacità di autodeterminarsi con piena libertà , Agostino si viene via via persuadendo della fragilità umana . La volontà umana non gode di completa libertà . Sull’ agire umano esercita grande forza l’ abitudine , fondata sul ricordo del piacere , amplificato dalla memoria stessa . In questa vita si può solo sperare di essere felici . Alla superbia dei filosofi pagani Agostino oppone la virtù dell’ umiltà . Il peccato originale di Adamo ha contaminato la natura umana , l’ uomo pertanto non é in grado di redimersi da sè . Al centro dell’ esperienza cristiana si collocano dunque l’ incarnazione e la resurrezione di Cristo , da cui dipende la redenzione degli uomini . Il baricentro si sposta nel futuro , nella resurrezione finale : solo allora sarà possibile la piena felicità . Nell’ opera di redenzione , la Chiesa svolge una funzione essenziale di mediazione tra l’ uomo e Dio . Agostino é ora consapevole che essa é un’ organizzazione per le grandi masse , inclusi i peccatori , e si distingue radicalmente dalle comunità settarie dei donatisti o dei pelagiani . Per i donatisti nessun peccatore può fare parte della Chiesa , che é santa , una comunità di eletti che evita ogni mescolanza con un mondo esterno impuro . Per Agostino invece il problema é diventare santi : occorre dunque convivere con i peccatori , rimproverandoli e correggendoli . Grazie all’ acquisizione di questo concetto di Chiesa come comunità universale , Agostino può compiere un salto decisivo rispetto alle dottrine filosofiche tradizionali dell’ azione . Per queste ciò che era essenziale per valutare la qualità morale di un’ azione era la qualità morale dell’ agente : é questa che rende buono un atto . Per Agostino invece determinati atti ecclesiastici , come la somministrazione dei sacramenti ( per esempio il battesimo ) sono validi indipendentemente dalla condizione morale di chi li compie . E’ Cristo che dà efficacia al sacramento , anche se il sacerdote attraverso cui Egli opera , é peccatore . La lettura di San Paolo contribuisce ad accentuare agli occhi di Agostino la tensione e il dissidio tra la carne e lo spirito . Egli giunge a una concezione dell’ uomo come essere totalmente dipendente da Dio : la salvezza dell’ uomo dipende dalla grazia concessa da Dio . Questa convinzione diventa dominante soprattutto nell’ ultima fase della vita di Agostino , quando a partire dal 412 egli deve affrontare le dottrine pelagiane : secondo Pelagio l’ uomo può raggiungere la salvezza grazie alle sole sue opere , senza l’ intervento di Dio . Per Agostino invece appartengono alla Chiesa anche i peccatori : la fede stessa sorge nell’ uomo solo per grazia divina . Prima che la grazia sia concessa la volontà umana non é propriamente libera . In seguito al peccato di Adamo , con il quale e nel quale non un singolo uomo , ma l’intera natura umana ha peccato , l’ umanità é diventata una ” massa dannata ” , meritevole di punizione . Per spiegare la trasmissione ereditaria del peccato originale Agostino riprende la dottrina del traducianesimo , secondo cui l’ anima é trasmessa di padre in figlio insieme con la generazione del corpo . La dottrina del peccato originale accentua in Agostino il disprezzo per la sessualità : a causa della concupiscenza tutto ciò che viene generato partecipa del peccato originale . Solo Cristo ne é rimasto immune ; solo nascendo da una vergine Egli poteva nascere senza peccato . Così come solo Dio nella sua misericordia può salvare l’ umanità dannata : col peccato di Adamo , infatti , l’ umanità ha perso la libertà del volere , ha soltanto la libertà di fare il male , ma questa non é la vera e propria libertà . L’ umanità é uscita radicalmente menomata dal peccato originale , infatti anche dopo aver ricevuto il battesimo , il cristiano resta un invalido , bisognoso di guarigione . Il Dio di Agostino é dunque un Dio che ha inflitto una pena collettiva per il peccato del primo uomo ; questa é la condizione dell’ umanità : molti sono i dannati , pochi gli eletti . Per Agostino Dio é onnipotente e quindi nulla accade se Egli non lo provoca o non lo permette . Come é possibile allora che un Dio sapiente , che ha creato l’ uomo , voglia che ci siano azioni cattive da parte degli uomini ? Su questo interrogativo Agostino si travaglia incessantemente , arrestandosi infine di fronte all’ imperscrutabilità del giudizio di Dio . Libertà , secondo Agostino , non significa possibilità di scegliere indifferentemente il bene o il male . Col peccato infatti l’ uomo ha acquistato la libertà solo nel senso di ” non poter non peccare ” . La libertà di Adamo prima del peccato consisteva nel poter non peccare : vera libertà é invece l’ essere liberi dal peccato , non poter peccare . Ma questa non é una prerogativa dell’ uomo in quanto uomo , bensì solo di coloro che sono eletti dalla grazia divina . La volontà deve essere salvata per diventare libera dal peccato : libero é appunto colui che é chiamato dalla grazia divina alla vera libertà , consistente nel sottomettersi al bene . La volontà che ha ricevuto la grazia , possiede l’ amore , la caritas , la quale fa sì che l’ anima preferisca ciò che é maggior bene rispetto a ciò che lo é meno . Ma il Sommo Bene é appunto Dio , la vita felice diventa , allora , un dono , che Dio accorda indipendentemente da qualsiasi merito o , comunque, non in base a meriti conosciuti dall’ uomo . Se essa dipendesse dalle opere e dai meriti dell’ uomo , allora la salvezza non dipenderebbe più da Dio . E’ stato detto che in Agostino ” Dio assume i tratti dell’ arbitro e diventa sempre più simile a un imperatore tardo antico ” . La dottrina della grazia é strettamente connessa in Agostino alla dottrina della predestinazione : é Dio che stabilisce coloro che si salveranno e coloro che saranno dannati ; certo Egli non induce a compiere il male , ma coloro che sono privati della sua misericordia non possono non peccare . Sapere che tutto dipende dalla predestinazione divina non rende tuttavia inutili gli sforzi umani : il singolo , infatti , non é certo della sua salvezza o della sua dannazione . Ciò contribuisce a far assumere un atteggiamento combattivo , interpretando ogni evento come un atto deliberato , da parte di Dio , di misericordia per l’ eletto e di condanna per il reprobo .
LE DUE CITTA’
Ai pagani il sacco di Roma del 410 appare una punizione degli dei per aver consentito l’ affermazione della religione cristiana nell’ impero . Per Agostino la colpa della razza umana nel suo insieme spiega e giustifica ogni tribolazione , ma scrivendo ” la Città di Dio ” egli vuole anche mostrare la superiorità del cristianesimo rispetto a tutte le istituzioni e le forme di cultura puramente umana . Al centro é il tema della provvidenza divina : é Dio che fa nascere e perire gli imperi . E’ convinto che la vicenda della vera Chiesa non sia e non possa essere condizionata dalle vicende umane e travolta con esse in un sol destino . Per dimostrarlo egli elabora una teologia della storia . Questa non deve essere confusa con una filosofia della storia , che tenti di individuare un significato immanente ai fatti storici . Il significato degli eventi storici é invece dato dalla struttura teologica sottesa al loro avvicendarsi . Tale struttura é ritmata dai momenti salienti della creazione del mondo , del peccato originale , dell’ incarnazione di Cristo e del giudizio finale : le vicende storiche dipendono , quindi , dall’ ordinamento voluto da Dio . All’ interno di tale ordinamento anche il negativo può trasformarsi in positivo . In tal modo , l’ intero corso della storia può essere concepito carico di significati , che il credente può cogliere soltanto parzialmente , perchè il significato globale é noto solo a Dio . Passato , presente e futuro sono in gran parte per l’ uomo opachi . Tuttavia é possibile , secondo Agostino , individuare il filo che percorre l’ intera storia universale nei suoi momenti decisivi . Contro il parere prevalente dei filosofi antichi , Agostino ritiene che la storia abbia una durata limitata e che la sua epoca , in cui il mondo é ormai vecchio ( senectus mundi ) , sia vicina alla fine . Egli rifiuta la dottrina ciclica dell’ eterno ritorno , propria soprattutto degli stoici ; se così fosse , egli obietta , non sarebbe possibile essere felici in modo stabile e duraturo . La vicenda storica ha invece un andamento lineare , il quale sfocia in un evento finale ultraterreno , che dà senso a tutto quanto procede . E’ questa la prospettiva escatologica di Agostino , ma avendo abbandonato la credenza in possibilità umane autonome e riconosciuto il peso determinante della grazia divina nell’ economia della salvezza , egli non può ammettere la concezione di un progresso lineare ininterrotto verso la beatitudine finale . Il filo rosso della storia é dato invece dalla lotta tra il bene e il male , che si costituiscono in 2 regni , dei quali Agostino indaga l’ origine , la durata e la fine . In tal modo , egli riprende alcuni aspetti del suo manicheismo giovanile ; ma distingue anche la storia sacra da quella profana , pur riconoscendo che prima dell’ evento finale , i due regni coesistono , intrecciati e confusi tra loro . Agostino distingue tra due città : la città di Dio , ovvero la città celeste , retta dall’ amore di Dio , e la città terrena , dominata dall’ amore in sè . La prima é costituita dagli uomini giusti , che vivono secondo lo spirito ; la seconda invece dagli ingiusti , angeli ribelli , diavolo e uomini , che vivono secondo la carne . La lotta tra le 2 città ritma il corso della storia e prende il sopravvento sullo schema della successione delle età del mondo . Sin dalla caduta di Adamo la razza umana é stata divisa in due città : l’ appartenenza a ciascuna delle due dipende solo dalla grazia divina . Già prima di Cristo infatti alcuni uomini facevano parte della città di Dio . Il termine città , civitas , indica la comunità dei cittadini , il corpo al quale essi appartengono e nel quale trovano la propria identità . Coniando la nozione di città celeste , agostino dava ai suoi fedeli il senso e la certezza di essere popolo di Dio , rafforzandone i legami interni di solidarietà di fronte a un mondo ostile . Un popolo , infatti , si definisce in relazione a ciò che ama : sulla base di ciò che ama esso fonda la propria unità e costruisce rapporti di subordinazione e obbidienza . Pertanto la città terrena non deve essere identificata con lo Stato ; essa é pittosto la società che venera gli ” dei falsi e bugiardi ” , come li definisce Dante , dei demoni e perciò non vive secondo i veri valori . Nasce di qui la ” libido dominandi ” , il desiderio del potere , su cui si fonda la città del diavolo , ossia gli imperi umani , che coltivano i culti pagani . I membri della città terrena rifiutano , infatti , di cinsiderare effimero ciò che essi hanno creato e in tal modo sconvolgono l’ ordine delle cose . Quest’ ordine é costituito dalle relazioni naturali di dipendenza tra le varie parti che lo compongono : il rispetto di queste relazioni si caratterizza come obbedienza delle parti inferiori verso quelle superiori nell’ ordine gerarchico . Agostino ammette la liceità del dominio di un uomo su un altro uomo ; anch’ esso , infatti , diventa necessario come conseguenza della caduta di Adamo nel peccato . L’ autorità e l’ obbedienza sono quindi necessarie per impedire violenze reciproche , non a caso Agostino ravvisa in Caino il capostipite della città terrena . La politica si configura allora come mezzo per garantire la sicurezza e impedire la violenza . Negli ultimi decenni della sua vita , Agostino tende a scorgere nello Stato una sorta di braccio secolare della Chiesa , ma ciò non lo conduce alla tesi che la Chiesa come istituzione visibile debba esercitare il dominio sulla città terrena , come sarà poi sostenuto durante la lotta tra il papato e l’ impero nell’ età medioevale . La città di Dio é la Chiesa di quanti vivono secondo Dio . Essa non coincide numericamente con tutti quanti fanno parte della Chiesa visibile ; non a tutti , infatti , Dio elargisce la sua grazie . Il criterio in base a cui Agostino distingue tra la Chiesa visibile e la Chiesa vera é dato dall’ evento che emergerà alla fine della storia . La Chiesa sarà di puri soltanto nel giorno del giudizio finale . Prima di allora il membro della città di Dio é solo peregrinus , cioè uno straniero in terra . Per lui si tratta di vivere nel mondo , dove si trova ” come un’ oliva pressata in un frantoio ” , ma distaccato dal mondo , in attesa di ritornare alla sua terra . In questo mondo non potrà mai realizzare il desiderio umano fondamentale : il desiderio di pace . Nella città terrena e nella stessa vicenda storica , nella quale bene e male coesistono intrecciati e in perenne conflitto , non é possibile la realizzazione della vera pace , la pace raggiunta in terra é soltanto strumentale ed effimera . Solo la resurrezione finale apporterà la risoluzione di ogni tensione e di ogni conflitto , tra carne e spirito e tra uomo e uomo . Allora si realizzeranno pienamente la vera pace e la vera libertà di non poter peccare : il bene trionferà completamente soltanto alla scomparsa della storia .
BENEDETTO DA NORCIA

San Benedetto da Norcia nacque circa nel 480 d.C.,in un’agiata famiglia romana. Eutropio, il padre, era Capitano Generale dei romani nella regione di Norcia, mentre la madre era Claudia Abondantia Reguardati, contessa di Norcia. Qui trascorse gli anni dell’infanzia e della fanciullezza, avvertendo l’influsso di coloro che già dal III secolo erano giunti dall’Oriente lungo la valle del Nera e in quella del Campiano. Scampati dalle persecuzioni, essi avevano abbracciato una vita di ascesi e di preghiera in diretto contatto con la natura, vivendo in “corone” di celle scavate nella roccia, facenti capo ad una piccola chiesa comune (Laure). A 12 anni (secondo alcuni) fu mandato, con la sorella, a Roma a compiere i suoi studi ma, come racconta san Gregorio Magno nel II Libro di I Dialoghi, sconvolto dalla vita dissoluta della città ritrasse il piede che aveva appena posto sulla soglia del mondo per non precipitare anche lui totalmente nell’immane precipizio. Disprezzò quindi gli studi letterari, abbandonò la casa e i beni paterni e cercò l’abito della vita monastica perché desiderava di piacere soltanto a Dio. All’età di 17 anni, insieme con la sua nutrice, Cirilla, si ritirò nella valle dell’Aniene presso Eufide (l’attuale Affile) dove secondo la leggenda devozionale avrebbe compiuto il primo miracolo riparando un vaglio rotto dalla stessa nutrice. Abbandonò poi la nutrice e si avviò verso la valle di Subiaco, sorta intorno agli antichi resti di una villa neroniana che sfruttava il fiume Aniene formando tre laghi (la città sorgeva appunto sotto “sub”, questi laghi). A Subiaco incontrò il monaco romano di un vicino monastero retto da un abate di nome Adeodato, che, vestitolo degli abiti monastici, gli indicò una grotta impervia del Monte Taleo (attualmente contenuta all’interno del Monastero del Sacro Speco) dove Benedetto visse da eremita per circa tre anni, fino alla Pasqua dell’anno 500. Conclusa l’esperienza eremitica, accettò di fare da guida ad altri monaci in un ritiro cenobitico presso Vicovaro, ma, dopo un tentativo di avvelenamento, tornò a Subiaco. Qui rimase per quasi trenta anni, predicando la “parola del Signore” ed accogliendo discepoli sempre più numerosi, fino a creare una vasta comunità di tredici monasteri, ognuno con dodici monaci ed un proprio abate, tutti sotto la sua guida spirituale. Intorno al 529 a seguito di due tentativi di avvelenamento, il primo materiale con un pane avvelenato e il secondo morale chiamando delle prostitute per tentare i propri figli spirituali da parte di un tal prete Fiorenzo (la sua figura esemplifica l’ostilità del clero locale che Benedetto doveva aver subito), per salvare i propri monaci Benedetto decise di abbandonare Subiaco. Si diresse verso Cassino dove, sopra un’altura, fondò il monastero di Montecassino, edificato sopra i resti di templi pagani e con oratori in onore di san Giovanni Battista (da sempre ritenuto un modello di pratica ascetica) e di san Martino di Tours che era stato iniziatore in Gallia della vita monastica. Nel monastero di Montecassino Benedetto compose la sua Regola verso il 540. Prendendo spunto da regole precedenti, in particolare quelle di san Giovanni Cassiano e san Basilio (ma anche Pacobio, Cesario e l’Anonimo della Regula Magistri), egli combinò l’insistenza sulla buona disciplina con il rispetto per la personalità umana e le capacità individuali, nell’intenzione di fondare una scuola del servizio del Signore, in cui speriamo di non ordinare nulla di duro e di rigoroso. La Regola, dotta e misteriosa sintesi del Vangelo, nella quale si organizza nei minimi particolari la vita dei monaci all’interno di una “corale” celebrazione dell’uffizio, diede nuova ed autorevole sistemazione alla complessa, ma spesso vaga e imprecisa, precettistica monastica precedente. I due cardini della vita comunitaria sono il concetto di stabilitas loci (l’obbligo di risiedere per tutta la vita nello stesso monastero contro il vagabondaggio allora piuttosto diffuso di monaci più o meno “sospetti”) e la conversatio, cioè la buona condotta morale, la pietà reciproca e l’obbedienza all’abate, il “padre amoroso” (il nome deriva proprio dal siriaco abba, “padre”) mai chiamato superiore, e cardine di una famiglia ben ordinata che scandisce il tempo nelle varie occupazioni della giornata durante la quale la preghiera e il lavoro si alternano nel segno del motto ora et labora (“prega e lavora”) I monasteri che seguono la regola di san Benedetto sono detti benedettini. Anche se ogni monastero è autonomo sotto l’autorità di un abate, si organizzano normalmente in confederazioni monastiche, delle quali le più importanti sono la congregazione cassinense e la congregazione sublacense, originatesi rispettivamente attorno all’autorità dei monasteri benedettini di Montecassino e di Subiaco. A Montecassino Benedetto visse fino alla morte, ricevendo l’omaggio dei fedeli in pellegrinaggio e di alcune personalità come Totila re degli Ostrogoti, che il monaco ammonì. Qui Benedetto morì intorno al 547, poco dopo sua sorella Scolastica con la quale ebbe comune sepoltura; secondo la leggenda devozionale spirò in piedi, sostenuto dai suoi discepoli, dopo aver ricevuto la comunione e con le braccia sollevate in preghiera, mentre li benediceva e li incoraggiava. Le diverse comunità benedettine ricordano la ricorrenza della morte del loro fondatore il 21 marzo, mentre la Chiesa romana ne celebra ufficialmente la festa l’11 luglio, da quando papa Paolo VI ha proclamato san Benedetto da Norcia patrono d’Europa il 24 ottobre 1964. La Chiesa Ortodossa celebra la sua ricorrenza il 14 marzo. Da quando le reliquie erano considerate quasi indispensabili alla comune devozione nel Medioevo, e specialmente ai monaci, era naturale che fossero cercate e “trovate” dappertutto. Il possesso della salma di san Benedetto è stato disputato per molti secoli (e in un certo senso è disputato ancora) tra Montecassino e Fleury-sur-Loire (detto anche Saint Benoît sur Loire) in Francia. Secondo il processo verbale circa la ricognizione delle reliquie del 9, 10 e 11 luglio 1881, firmato dal vescovo di Orléans e redatto dall’abate di Fleury, Dom Edmondo Sejourne, la maggior parte delle ossa attribuite a san Benedetto si trovano collocate nella grande teca del monastero di Fleury sur Loire; salvo una mandibola conservata in un reliquiario speciale, e un frammento importante della regione pareto-occipitale del cranio posto anch’esso in un reliquiario particolare. Si possono ricollegare altre reliquie a questo insieme di resti scheletrici, prelevate in diversi tempi da questo insieme, e perfettamente autenticate[citazione necessaria]. Ad esempio: un frammento di costola (Benedettine del Calvario di Orléans), altro frammento di costola (Benedettine del Santo-Sacramento di Parigi), estremità superiore di un radio sinistro (Grande seminario di Orléans), parte inferiore di un radio destro e parte inferiore di un perone sinistro (tutti due all’abbazia della Pierre-qui-Vire), frammento della parte centrale di un osso lungo (abbazia di Santa Marie di Parigi), estremità inferiore di una radio sinistro (abbazia di Saint-Wandrille), frammento di falange dell’alluce sinistro (abbazia Notre Dame de la Garde), frammento della parte centrale di un osso lungo (abbazia di Timadeuc), rotula sinistra (abbazia di Aiguebelle), frammento di omero sinistro (abbazia della Grande Trappe). Secondo i monaci benedettini di Montecassino, invece, le reliquie autentiche sono sempre restate a Montecassino. Dalla ricognizione del 1950, protratti in diversi periodi dal 1 Agosto fino al 29 settembre, sono state trovate i resti di due persone di sesso maschile e femminile (mentre a Fleury ci sono solo quelle maschili) e quasi intere, sono certamente i resti di San Benedetto e di Santa Scolastica. La difficoltà di superare il problema, confrontando i due reperti contemporaneamente, a tutt’oggi non ha avuto nessun esito, per la poca propensione a volere simultaneamente, una ulteriore ricognizione e arrivare, di fatto, a chiarire i resti del santo. La presenza delle reliquie a Montecassino è riconosciuta da quasi la totalità del mondo benedettino, fondandosi su una documentazione accertata, che riporta la presenza delle sante reliquie, sempre a Montecassino, escludendo il periodo buio dell’abbandono dopo la distruzione saracena. La tradizione di Fleury, che ha avuto il suo apice nel periodo medievale, a tutt’oggi non ha trovato nessun confronto scientificamente inoppugnabile. Lo studioso e monaco benedettino Jean Mabillon (Saint-Pierremont, 1632 – Parigi, 1707) pubblicò nel 1685 la seguente narratio brevis ricavata da un manoscrittomedievale del monastero di San Emmeram situato a Ratisbona, che egli giudicò vecchio di 900 anni e perciò contemporaneo con la “traslazione” del corpo del santo. « Nel nome di Cristo. C’era in Francia, grazie alla provvidenza di Dio, un Prete dotto che intraprese un viaggio in Italia, per poter scoprire dove fossero le ossa del nostro santo padre Benedetto, che nessuno più venerava. [Montecassino, monastero fondato da S. Benedetto su un rilievo roccioso dell’Appennino tra Roma e Napoli, era stato distrutto dai Longobardi nel 580 circa, e rimase disabitato fino a 718 ndr]. Alla fine giunse in una campagna abbandonata a circa 70 o 80 miglia da Roma, dove S. Benedetto anticamente aveva costruito un convento nel quale tutti erano uniti da una carità perfetta. A questo punto questo Prete ed i suoi compagni erano inquietati dall’insicurezza del luogo, dato che non erano in grado di trovare né le vestigia del convento, né quelle di un luogo di sepoltura, fino a quando finalmente un guardiano di suini indicò loro esattamente dove il convento era stato eretto; tuttavia fu del tutto incapace di individuare il sepolcro finché lui ed i suoi compagni non si furono santificati con due o tre giorni di digiuno. Allora il loro cuoco ebbe una rivelazione in un sogno, e la questione apparve loro chiara poiché al mattino fu mostrato loro, da colui che era sembrato più infimo di grado, che le parole di S. Paolo sono vere (I Cor. 1, 27): “Ma Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti” o di nuovo, come il Signore stesso ha predetto (Matt. 20: 26): “Colui che vorrà diventare grande tra voi, si farà vostro servo”. Allora, ispezionando il luogo con maggiore diligenza, trovarono una lastra di marmo che dovettero tagliare. Finalmente, spezzata la lastra, rinvennero le ossa di S. Benedetto e, sotto un’altra lastra, quelle di suoi sorella; poiché (come pensiamo) il Dio onnipotente e misericordioso volle che fossero uniti nel sepolcro come lo furono in vita, in amore fraterno ed in carità cristiana. Dopo avere raccolto e pulito queste ossa le avvolsero, una ad una, in un fine e candido tessuto, per portarle nel loro paese. Non fecero menzione del ritrovamento ai Romani per paura che, se questi avessero saputo la verità, indubbiamente non avrebbero mai tollerato che reliquie così sante fossero sottratte al loro paese senza conflitti o guerre di reliquia, il che Dio ha reso manifesto, affinché gli uomini potessero vedere come grande era il loro bisogno di religione e santità, mediante il seguente miracolo. Avvenne cioè che, dopo un po’, il lino che avvolgeva queste ossa fu trovato rosso del sangue del santo, come da ferite aperte di un essere vivente. Dalla qual cosa Gesù Cristo ha inteso mostrare che colui a cui appartengono quelle ossa è così glorioso che avrebbe vissuto veramente con Lui nel mondo a venire. Allora furono poste sopra un cavallo che le portò durante tutto quel lungo viaggio così agevolmente che non sembrava ci fosse nessun carico. Inoltre, quando attraversavano foreste o percorrevano strade strette, non c’era albero che ostruisse il cammino od asperità del percorso che impedissero loro di proseguire il viaggio; così che i viaggiatori hanno visto chiaramente come questo potesse avvenire grazie ai meriti di S. Benedetto e di sua sorella S. Scolastica, affinché il loro viaggio potesse essere sicuro e felice fino al regno di Francia ed al convento di Fleury. In questo monastero sono seppelliti ora in pace, finché sorgeranno nella gloria nell’Ultimo Giorno; e qui conferiscono benefici su tutti coloro che pregano il Padre tramite Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che vive e regna nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. » (Mabillon: Vetera Analecta, vol. IV, 1685, pag. 451-453)) . Comunque sia la presenza delle reliquie, è certo che un culto di san Benedetto esisteva già a Montecassino fin dalla fine dell’VIII secolo, come testimoniano i quattro calendari pubblicati da Dom Morin che menzionano tutti la festa del 21 marzo. E la dedica di un altare a san Benedetto il 3 giugno nell’oratorio di San Giovanni Battista, menzionata da tre di questi calendari, permette di aggiungere che un culto esisteva già sul luogo che San Benedetto aveva scelto per essere inumato e dove il suo corpo tornò in polvere, luogo che resterà sempre santo e venerabile per ogni figlio del santo Patriarca.
APOLLINARE DI LAODICEA

A cura di Eresie.it
La vita
Apollinare nacque nel 310 ca. e compì i suoi studi in Alessandria, e successivamente in Antiochia, diventando vescovo di Laodicea (oggi in Turchia) nel 360.
Fu dapprima altamente apprezzato da Padri della Chiesa, come Girolamo e Atanasio, per la sua lealtà al “Credo Niceno”, ma poi nella sua lotta anti-ariana, a partire dal 352, iniziò ad enfatizzare eccessivamente la natura divina di Cristo.
Fino al 376, Apollinare non fu particolarmente preso di mira, ma fu successivamente condannato dai sinodi di Roma nel 377 e 381, di Alessandria nel 378, di Antiochia nel 379 e dal Concilio Eucumenico di Costantinopoli nel 381: quest’ultima condanna fu avvallata da Papa Damaso (366-384).
Perfino le altre eresie cristiane dell’epoca, come il nestorianesimo, si opposero tenacemente all’apollinarismo.
Infine l’imperatore Teodosio I (379-395), con una ordinanza imperiale nel 388, fece condannare ed esiliare Apollinare., che morì nel 390.
Alla sua morte, i seguaci di Apollinare (tra cui Vitale e Polemone) non sopravvissero molto a lungo: entro il 416 o erano rientrati nella Chiesa Cattolica o avevano aderito al monofisismo.
Molti degli scritti di Apollinare sono andati persi: quelli sopravvissuti li conosciamo dai libri scritti contro Apollinare dai Padri della Chiesa, come Atanasio, Gregorio di Nissa e Gregorio Nazianzeno: e per questo motivo devono essere presi per quel che sono, scritti inevitabilmente di parte.
La dottrina
Partendo dalla concezione platonica tricotoma dell’uomo, secondo la quale l’uomo è formato di “corpo” (sarx), “anima” (psyche) e “intelletto razionale” (nôus), ad avviso di Apollinare, per salvaguardare la divinità di Gesù, il Logos aveva preso la parte spirituale dell’anima del Cristo: questi non aveva quindi un’anima come gli altri uomini, in quanto mancava dell’intelletto razionale (il nôus).
E poiché l’uomo era mortale e la carne umana profondamente corrotta, l’esperienza terrena di Gesù ne risultava essere immune, venendo a mancare la parte della volontà ed intelletto.
Il vero problema era che in questo modo l’incarnazione del Verbo non era stata integrale: in sostanza, Apollinare non accettava la piena ed intera umanità di Cristo, che a questo punto non poteva redimere il genere umano nella sua interezza, ma solo nei suoi elementi spirituali.
TICONIO
Ticonio Afro, o più semplicemente Ticonio (330 – 390 circa), fu un teologo donatista romano. In coscienza si considerò sempre di retta fede e, a motivo di ciò, fu attaccato in maniera asperrima da Parmeniano e considerato come traditore della causa donatista. Oltre ad alcuni frammenti del suo commento all’Apocalisse, si è conservato di Ticonio il Liber Regularum. Il testo è considerato il primo compendio di ermeneutica biblica. I testi di Ticonio influenzarono il pensiero dei teologi posteriori, tra i quali Agostino d’Ippona, che ne elogiò il valore. Scarsissime sono le testimonianze che gli autori antichi hanno tramandato intorno al pensiero e alla vita di Ticonio. Sicché la sua vita resta in larga parte oscura. Gli avvenimenti principali della sua esistenza sono racchiusi nel De viris illustribus di Gennadio di Marsiglia. Stando a questa fonte, Ticonio sarebbe nato nella provincia imperiale d’Africa intorno al 330. Aderì precocemente al donatismo, il movimento eretico sorto nella Proconsolare all’inizio del IV secolo, in polemica con i traditores, vale a dire con quei vescovi che, durante la persecuzione di Diocleziano (303-305), avevano consegnato i libri sacri alle autorità civili. E però, per via dell’ampiezza della cultura biblica e dell’indipendenza di giudizio, Ticonio occupò un posto di rilievo tra i donatisti, benché il suo pensiero non possa essere ridotto in alcun caso a semplice episodio del donatismo. Ticonio fu comunque uno scrittore laico: possedeva una conoscenza decisamente approfondita sia della letteratura profana, sia del testo sacro. Egli affrontava con rigore teologico le dispute religiose del suo tempo. Osservando il modo in cui i donatisti venivano osteggiati dalla politica imperiale, Ticonio giunse a sostenere che la Chiesa fosse destinata a essere perseguitata dal potere secolare fino alla fine dei tempi. Tuttavia, Ticonio non condivideva – con la maggior parte dei suoi correligionari – la necessità di separarsi dai traditores per preservare la purezza dei veri cristiani. Animato dal desiderio di contribuire alla ricomposizione dello scisma, che nel IV secolo vedeva divisi i cristiani dell’Africa, Ticonio richiamò primieramente l’attenzione sull’inopportunità della iniziale separazione. Ma in seguito sostenne, attraverso un’originalissima ermeneutica biblica, l’universalità della vera Chiesa di Dio e la necessità della coesistenza di buoni e malvagi. Va sottolineato che, adombrando i punti deboli dell’ecclesiologia donatista, Ticonio fornì ai cattolici un’arma fondamentale contro il donatismo (di cui egli stesso faceva parte) fino a divenire oggetto delle critiche del vescovo donatista Parmeniano. Intorno al 380, Ticonio finì per essere condannato da un concilio donatista. Dopo il dibattito polemico con Parmeniano, Ticonio non ritenne in ogni caso opportuno aderire alla Chiesa cattolica e, attratto sempre più dalla contemplazione del mistero della salvezza, si dedicò in forma pressoché esclusiva all’esegesi biblica. Forse negli anni Settanta del IV secolo – e forse proprio in conseguenza dello scisma di Rogato, che nel 366 aveva cagionato la divisione della stessa Chiesa donatista –, Ticonio pubblicò il De bello intestino e le Expositiones diversarum causarum. Sono due trattati che sono andati perduti, e però in gran parte possono essere conosciuti per il tramite delle opere antidonatiste di Agostino d’Ippona. In seguito alla scomunica, e dunque intorno al 383, Ticonio compose il già menzionato Liber Regularum. Nel testo, si postula l’esistenza di sette regole in grado di interpretare tutta la Scrittura. L’opera è, dunque, un importante contributo all’esegesi biblica. Verso il 385, Ticonio completò il Commentarius in Apocalypsin. Nell’opera, si interpretano in chiave ecclesiologica gli avvenimenti del libro dell’Apocalisse. È verosmile che, con la pubblicazione del Liber Regularum e del Commentarius in Apocalypsin, Ticonio abbia raggiunto il vertice della sua carriera. Gennadio, a cui – come si diceva – si deve la massima parte delle informazioni su Ticonio, associa il massimo splendore del nostro teologo al momento in cui Teodosio era al potere con uno dei suoi figli. Agostino, nel 396, scrivendo al vescovo di Cartagine Aurelio, tratta del Liber Regularum come di un’opera ormai classica. E proprio Agostino riproduce, nel De doctrina christiana, le regole ermeneutiche di Ticonio. Tali regole esercitarono largo influsso sull’esegesi medievale. Dal concetto delle “due Chiese”, di cui tra breve ancora diremo, Agostino mutuò il motivo fondamentale del contrasto fra “le due città”, accennato in vari scritti e svolto compiutamente nel poderoso testo De civitate Dei. In quest’opera troviamo anche l’interpretazione simbolica del millennio. Esso principierebbe con la passione di Gesù Cristo per chiudersi con il Giudizio universale, che Ticonio aveva esposto nel suo commento all’Apocalisse, andato perduto, ma ricostruibile almeno nelle sue linee essenziali attraverso scrittori che se ne avvalsero, tra i quali san Girolamo. Il caposaldo dell’apologetica donatista, che cioè la vera Chiesa è quella dei perseguitati, si trasforma in Ticonio, per il tramite di un’originale ermeneutica biblica, in una dottrina della coesistenza necessaria di buoni e malvagi nel seno stesso della Chiesa: questo fu il contributo teologico più importante della riflessione di Ticonio. La seconda delle regulae, intitolata de Domini corpore bipartito, spiega che il corpo della Chiesa ha due aspetti, uno sinistro e uno destro, uno malvagio e uno buono. Su questa base, si spinge a sviluppare la tesi secondo cui la Chiesa è sdoppiata secondo una Chiesa dei malvagi e una Chiesa dei giusti. Per questo, fino al giorno del Giudizio universale la Chiesa sarà, insieme, Chiesa di Cristo e dell’Anticristo. Ticonio sarà un autore centrale anche per Joseph Ratzinger, divenuto papa nel 2005 con il nome di Benedetto XVI. Divenuto pontefice, Ratzinger evocherà nuovamente Ticonio nell’udienza generale del 22 aprile 2009, con ciò avvalorando la centralità dell’interpretazione del “corpo bipartito” del Signore.

