FILOSOFIA E RELIGIONE
“Il fondamento ontologico originario dell’esistenzialità dell’Esserci è la temporalità” (M. Heidegger, Essere e Tempo)
INTRODUZIONE ALLA FILOSOFIA DELLA RELIGIONE – FILOSOFIA E RELIGIONE

Di Antonietta Pistone
La filosofia nasce come ricerca metafisica[i] del principio, e causa prima, di tutta la realtà, nel VII sec. A.C. nelle colonie dell’Asia Minore a Mileto, con la speculazione dell’astronomo Talete, che riconosce l’arché originario nell’acqua. Contemporaneamente nell’Oriente arabo ha inizio la predicazione del profeta Maometto, che diffonde la religiosità di Allah e del Corano, attraverso la fede islamica. Nel VI sec. A.C., in Nepal, ai confini settentrionali con l’India, si afferma il Buddhismo, un particolare approccio filosofico religioso ai problemi dell’esistenza umana, interpretata essenzialmente come dolore e sofferenza. Il Buddha Siddhārtha Gautama, monaco e asceta, fondatore della religione indiana, crede di poter rimediare al dolore sospendendo il desiderio, da cui deriva ogni sofferenza, e invita i suoi seguaci a praticare l’ascetismo, che è distacco dalle passioni del mondo, per raggiungere la pace dei sensi e l’equilibrio interiore. Le tecniche di meditazione, che fanno riferimento al respirare attraverso successive inspirazioni ed espirazioni, sono perciò molto importanti per raggiungere un buon livello di estraniazione dalla realtà, con la conseguente sospensione della brama. Si apprende, così, a gestire il proprio corpo per percepirlo in sintonia con la natura ed il creato, e per ricostituire l’armonia iniziale primigenia fusionale con il tutto. Già intorno al XIII sec. A.C. era sorto, nelle regioni dell’Europa orientale l’Induismo, con cui il Buddhismo successivamente condivide i concetti di Samsara, il ciclo di reincarnazione dell’anima immortale; di Karma, la legge di causa-effetto che definisce l’andamento dei fenomeni osservabili in natura nel loro svolgimento; e di Dharma, la legge cosmica universale che interpreta l’esistenza come dolore e sofferenza perché condizionata dall’attaccamento alla realtà del vivere, e determinata dalla volontà del desiderare con passione attraverso la brama di volere. Se la speculazione filosofica comincia come indagine sui principi primi della natura, nel buddhismo e nell’islamismo si pone già il problema di risolvere l’esistenza umana attraverso le domande di senso dell’uomo sulla realtà di Dio, sulla vita e sulla morte, sulla natura dell’anima, sull’immortalità, sulle questioni riguardanti l’agire morale ed il comportamento nella scelta libera, sui possibili legami della spiritualità umana con realtà escatologiche non storiche e materiali. La stessa ricerca filosofica, che già Aristotele riconosce come speculazione metafisica, si pone sul nascere i problemi ineludibili della fondazione gnoselogica, ontologica e teologica. Difatti, quando si vogliano affrontare questioni radicali dell’esistenza, non si può prescindere dalla ricerca metafisica sui fondamenti ontologici, né si possono evitare le domande religiose, che ogni uomo, in ogni tempo, ad ogni latitudine geografica, si è sempre posto, si pone e si porrà. Donde la necessità di un filosofia della religione, che abbia come suo principale obiettivo di ricerca l’approfondimento delle tematiche spirituali della vita, nel tentativo di fornire risposte di senso e tecniche di salvezza che possano, in qualche modo, arginare lo spettro del nichilismo, del vuoto di valori, della morte del senso e del deserto in cui ci si trova, in assenza di una morale universale, di un’etica accettabile e comunemente condivisibile, che si ponga come rimedio al terribile evento della morte di Dio[ii], e della fine dei valori universali che avevano predicato l’ebraismo e il cattolicesimo. Una filosofia della religione che riconosca tra i suoi obiettivi principali il problema di valutare, di ripercorrere, di affrontare per intero, scalzando paure e infingimenti, la tragedia contemporanea dello smarrimento dell’uomo, senza riferimenti certi e adeguati, in risposta alle sempre insistenti domande in vista del recupero di una ragione forte. Prendendo atto che nemmeno chi si definisce e reputa ateo può eludere dal suo percorso esistenziale gli interrogativi su Dio. Né può, l’ateo, vivere senza optare per il mondo dei valori o per quello dei disvalori, non potendo nessuno liberarsi della propria coscienza morale, né della necessità di scegliere. Entro le questioni della filosofia della religione rientrano, perciò, di diritto tutte le problematiche morali, comportamentali e spirituali dell’uomo, che continui a vivere nel mondo senza tralasciare le istanze più profonde ed inquietanti della propria spiritualità religiosa. La religione è la fede che si predilige come risposta agli interrogativi della religiosità spirituale. Ogni religione è frutto della storia di una civiltà, e parla della cultura, delle credenze, dei valori di un popolo. Il legame con la sua storia è inevitabile. Perché risulta davvero impossibile comprendere le ragioni di una civiltà senza capire i valori religiosi cui si ispira. Sembra che si voglia qui rovesciare, paradossalmente, il presupposto su cui regge il materialismo storico di Marx. Se è vero che l’ideologia sovrastrutturale deriva dall’insieme dei rapporti economici di ogni società, pare si stia a perdere tempo soffermandosi ad approfondire i nessi tra spiritualità religiosa e cultura, storia e tradizioni dei popoli. Ma già Weber, ne L’etica protestante e lo spirito del capitalismo modifica il rapporto tra struttura e sovrastruttura a vantaggio della seconda, e rilegge il materialismo storico marxista, invertendolo. Deriva infatti, secondo la sua analisi, il capitalismo dalla religione protestante calvinista, e non il contrario, la religione protestante dal capitalismo. Certamente economia e religione sono due aspetti fondamentali della vita dell’uomo in società. E costituiscono due approcci indispensabili per la comprensione storica profonda e disillusa delle ragioni che animano le civiltà. Da questo presupposto si evince facilmente l’importanza di uno studio serio delle religioni, come imprescindibile passaggio per la comprensione storica di epoche e civiltà. Con questo spirito si vuole intraprendere un percorso di ricerca che approfondisca il senso delle religioni monoteiste, cattolica, ebraica ed islamica, viste nel tempo attraverso lo sguardo critico ed acuto dei filosofi, che le hanno variamente interpretate. Ma comprese anche alla luce dei fatti storici più importanti che le hanno da sempre viste protagoniste della scena fino ai nostri giorni, a partire dalle Crociate, attraverso le guerre di religione, per giungere all’attuale fenomeno del terrorismo internazionale di matrice islamica. E alle questioni e ai dibattiti sempre aperti e dialettici, e non per questo meno rilevanti, tra la Chiesa cattolica e il mondo laico, soprattutto in materia di scelte sessuali, ma anche per questioni di tipo razziale e sociale in senso lato. Proponendo, inoltre, anche quelle filosofie della religione come il Buddhismo e l’Induismo, unitamente alle ulteriori suggestioni provenienti dall’oriente, che possano essere utili e funzionali a capire le anomale inefficienze della nostra epoca polimorfa, ma anche a saper intravedere una possibile via di recupero dei valori della civiltà orientale, che non abbiamo sin qui saputo valorizzare, troppo miopi nel nostro diffuso eurocentrico occidentalismo, ponendoci stupidamente in contrasto con culture e civiltà che hanno ancora tanto da dire, attraverso i valori della pace e della nonviolenza. Valori che noi abbiamo del tutto scotomizzato dalle nostre coscienze dialettiche, per interpretare il mutamento come rivoluzione possibile solo a partire dal di fuori dell’uomo. Dimenticando che il vero cambiamento è quello che avviene dentro le coscienze, perché è il solo rinnovamento possibile nell’ambito di un’educazione alla pace e al rispetto reciproco. Che rimane oggi l’unico approccio reale all’altro, in un contesto che voglia definirsi ancora patrimonio culturale umanamente condivisibile e spendibile entro reti di relazioni significative, per impegnarci a restituire un senso alle nostre esistenze annichilite ed abbrutite dalla mancanza e dal bisogno cui non si trova risposta per cui valga la pena spendersi. Tornare dentro le coscienze potrebbe, invece, svelare un patrimonio di cultura inesplorato, che deve essere necessariamente valorizzato e riscoperto, come una tra le altre possibilità aperte per il nostro futuro. A partire dalla filosofia presocratica, attraverso l’approccio degli atei e degli agnostici, fino a giungere alla filosofia della religione cattolica, senza trascurare le altre fedi, tutte ugualmente meritevoli di doverosa attenzione e di altrettanto rispettosa considerazione. Per religione si intende, infatti, la garanzia soprannaturale offerta all’uomo per la propria salvezza[iii], non necessariamente da una divinità. Prova di ciò è l’esistenza di quelle religioni atee come il Buddhismo di cui si è già prima fatto cenno. Né risulta indispensabile il rapporto dell’uomo con Dio, tenuto conto che l’Epicureismo ammette l’esistenza di divinità che vivono isolate dal contesto umano, senza occuparsi affatto delle questioni mondane. La salvezza che la religione vuole garantire all’uomo non è salvezza dai mali del mondo, ma può essere anche salvezza dal mondo stesso, come nel caso del Buddhismo. Bisogna, inoltre, sottolineare, la differenza intercorrente tra la credenza religiosa nella salvezza soprannaturale, e le tecniche che garantiscono il perseguimento della salvezza stessa. Esse sono costituite dall’insieme dei riti della preghiera, del sacrificio, della penitenza, della partecipazione alle celebrazioni, dei sacramenti, delle cerimonie e del servizio, divino o sociale che sia. Ed è necessario distinguere, parimenti, tra religione naturale, come diretta disposizione individuale a credere nel soprannaturale; e religione positiva, che è l’insieme delle pratiche rituali pubbliche che contribuiscono al raggiungimento della salvezza spirituale. Nel suo aspetto naturale, la religione è più vicina alla religiosità, come sentimento individuale per il soprannaturale; nel suo aspetto istituzionale, la religione assume le vesti della fede apertamente dichiarata e praticata, attraverso i riti. In effetti il concetto di religione comprende entrambi gli aspetti considerati. Cicerone fa derivare il termine dall’espressione latina relegere, perciò si dicevano religiosi quelli che anticamente compivano con accortezza e scrupolo tutti gli atti riguardanti il culto divino. Se il concepire la religione come un insieme di tecniche di salvezza la avvicina inevitabilmente alla filosofia, quando questa venga ritenuta una terapia dell’anima; la religione può anche essere studiata per le sue specificità epistemologiche e strutturali, in quanto dottrina dell’origine divina; dottrina dell’origine politica e dottrina dell’origine umana. Come dottrina dell’origine divina, la religione è rivelazione, cioè espressione filosofica della verità oggettiva, e del suo valore assoluto. In questa concezione vi è l’implicita idea che la religione consista nell’ «accettare ogni cosa particolare come una parte del Tutto, ogni cosa finita come un’espressione dell’infinito[iv]». La dottrina dell’origine politica della religione svuota la religione stessa delle sue finalità intrinseche di guida alla salvezza dello spirito, perché la ritiene un semplice spauracchio inventato dagli uomini che, attraverso la presenza di un Dio antropomorfo da loro stessi creato, si sono garantiti il rispetto delle leggi e la rettitudine morale della comunità tutta: «gli antichi legislatori finsero la divinità come una specie di ispettore delle azioni umane, sia buone che cattive, affinché nessuno recasse ingiuria o tradimento al suo prossimo, per paura di una vendetta degli dèi[v]». Questo medesimo pensiero lo si ritrova in molte correnti filosofiche atee, come il libertinismo, l’illuminismo ed il marxismo. La dottrina dell’origine umana della religione interpreta la religione stessa come un bisogno teoretico conoscitivo dell’anima, o come una necessità derivata dal timore dell’ignoto e dalla paura del futuro che non si sa e non si può prevedere. Il concetto di storia provvidenziale che è insito in ogni cultura religiosa mette al riparo dall’alea, e pacifica rasserenando l’esistenza. È fuor di dubbio il valore conoscitivo di ogni religione, che è sempre e comunque un tentativo di spiegarsi il mondo per dominarlo e dirigerlo. In questo senso ogni religione è una metafisica ontologica della realtà. E se oggi la fede viene naturalmente accostata alla filosofia, nell’antichità ogni religione faceva uso di tecniche propiziatorie legate alla pratica della magia. Si trattava, in sostanza, di muovere le forze oscure e misteriose dell’universo, per propiziarsele. Freud interpreta questo rapporto dell’uomo con la divinità come un legame ancestrale tra il figlio, bisognoso di protezione e di cure, ed il padre, che rappresenta la certezza e la forza possibile. Il riferimento incrollabile per le proprie fragilità e debolezze. Dio è dunque il super-io, il sistema dei divieti e delle censure indispensabili per il regolare svolgersi della vita morale; l’uomo è l’io che si deve barcamenare tra il luogo delle imposizioni coatte e dogmatiche e l’es, istintuale e pulsionale, che chiede prepotentemente di emergere dall’inconscio della vita psichica. Si è detto che la religione è tecnica di salvezza attraverso i rituali. La salvezza è interpretata ora come liberazione dal mondo; ora come rivelazione della verità; oppure come espressione di un sistema di valori morali e comportamentali. La religione che libera dal mondo è il Buddhismo, che ritiene doverosa la sospensione della brama di vivere praticando il distacco dal desiderio, attraverso il Nirvana, smettendo di anelare nella condizione di pace assoluta del misticismo. Questo rifiuto della socializzazione e della relazione umana comunitaria, per evitare dolore e sofferenza, anticipa la constatazione esistenzialistica di Jean Paul Sartre «l’inferno sono gli altri[vi]». Completamente differente l’approccio delle tre religioni monoteistiche israeliana, cattolica, ed islamica, che prevedono, invece, un premio nella vita ultraterrena, senza tuttavia considerare questo mondo un inferno invivibile da esorcizzare. Per israeliani e cattolici si può essere felici e beati anche durante la vita, che anzi si ha il dovere di vivere fino in fondo. Non è previsto il suicidio collettivo per motivi religiosi, come invece accade ai musulmani kamikaze, che credono di poter raggiungere in questo modo il paradiso e le sue vergini in attesa. Quando la religione si fa interpretazione della verità essa finisce per culminare nell’approccio teoretico di tipo filosofico. La religione è il sistema dei dogmi della verità rivelata, che la filosofia ha il compito di dimostrare. Mentre la fede è credenza non ragionata ma solo intuita. La differenza tra religione e filosofia è che «la religione è il rapporto con l’Assoluto nella forma del sentimento, della rappresentazione, della fede[vii]», laddove la filosofia si assume il compito oneroso di provare attraverso la ragione, per dimostrarlo vero, l’esistenza effettiva di questo rapporto. La religione è poi, in quanto garanzia alla moralità, «credenza nella conservazione dei valori[viii]». Già Platone nelle Leggi faceva riferimento ad una giustizia divina punitiva per chi non rispettasse l’ordine dei valori stabiliti dalla legge soprannaturale per la vita associata degli uomini. Ma è Kant che definisce l’idea del comandamento divino come imperativo categorico del dovere per il dovere: «la religione è la conoscenza di tutti i doveri come comandi divini[ix]», distinguendo, inoltre, tra una religione rivelata, in cui il comando di Dio precede la consapevolezza individuale soggettiva, da una religione naturale, che detta i suoi obblighi direttamente alla coscienza dell’uomo, prima che questi vengano impartiti per via eteronoma dall’esterno. Venendo poi, per concludere, alla funzione della religione nell’economia generale della società, certamente le credenze di salvezza hanno, sin dall’antichità, un loro ruolo importantissimo nella conservazione e perpetuazione della specie umana, rafforzando i vincoli sociali, infondendo speranza e coraggio in chi si affida ad esse, per consolidare il suo rapporto con gli altri e con il mondo: «Abbandonato alla mercè degli elementi, delle stagioni, di ciò che la terra gli dà e gli rifiuta, delle buone o cattive possibilità della sua caccia o della sua pesca, delle vicende delle sue lotte con i suoi simili, l’uomo crede trovare il mezzo per regolarizzare con simulacri di azione le sue possibilità più o meno incerte. Ciò che egli fa non serve a niente rispetto allo scopo che si propone, ma egli acquista fiducia nelle sue imprese, in se stesso, osa e osando ottiene realmente più o meno ciò che vuole. Fiducia rudimentale e attraverso un’umile strada; ma è il cominciamento del coraggio morale[x]».
Prof.ssa Antonietta Pistone
Docente di storia e filosofia
[i] Aristotele, Metafisica, libro IV
[ii] Nietzsche, La gaia scienza, 1882
[iii] Nicola Abbagnano, Dizionario di filosofia, TEA, Utet, 1999
[iv] Schleiermacher, Reden über die Religion, 1799
[v] Crizia in Sesto Emp., Adv. Math., IX, 54
[vi] Jean Paul Sartre, L’essere e il nulla
[vii] Hegel, Filosofia del diritto
[viii] H. Höffding, Religionsphilosophie, 1902
[ix] Kant, Religion, IV, sez. I
[x] A. Loisy, Essai historique sur le sacrifice, 1920
LA SPE SALVI FACTI SUMUS DI PAPA BENEDETTO XVI
Di Antonietta Pistone
Nella sua ultima lettera enciclica Spe salvi facti sumus Papa Benedetto XVI conforta il popolo cattolico alla speranza, ricevuta nel battesimo da ciascun nuovo nato con la grazia di essere chiamato figlio di Dio, e la certezza dell’immortalità dell’anima, e della vita eterna. Ogni cristiano è amato da Dio Padre, anche nel peccato, e sarà perciò salvato e redento da Lui. L’inferno è la pena che spetta a chi ha rifiutato di camminare lungo la strada di Cristo durante la sua vita terrena. Ma il fuoco è Cristo stesso che brucia e consuma, purificando le anime dal lerciume di cui si sono macchiate allontanandosi dalla sorgente dell’Amore e della Verità. E finendo col tradire la vocazione più profonda e più propria dell’uomo che è la chiamata all’Amore e alla condivisione del Bene in Dio, nella comunità dei fratelli. La speranza, dunque, insieme alla fede e alla carità, costituendo una delle tre virtù teologali, è il fondamento del cristianesimo. L’uomo che ha fede non dispera, perché crede in Dio e nella giustizia vera, che non opera distinzioni di sorta tra i fratelli, figli anche dello stesso Padre. Soprattutto, la speranza, nella quale i cristiani sono fatti salvi, è saldamente ed inscindibilmente unita alla fede. La speranza è difatti la fede che si fa attesa di ciò che verrà. Ed è sentimento di amore che lega presente e futuro, nella certezza che ciò che si spera e si attende non tarderà a compiersi. Le promesse di Dio, infatti, sono già certezza del presente, e colmano l’esistenza umana di senso e di significato, conferendo all’uomo dignità e valore. In quanto tali esse risiedono nella domanda filosofica di Kant sul noumeno, che è ricerca metafisica sulle idee regolative di ragione, anima, mondo e Dio, ma che al tempo stesso si fa interrogativo radicale per la vita umana. Anche l’uomo laico e l’ateo non possono vivere senza porsi il problema sul senso stesso della vita e dell’Essere. La ricerca scientifica e tecnologica sono possesso e dominio sulla natura. “Scire est posse”, diceva Bacone. Ma questo dominio freddo sulla realtà diventa il principale strumento di offesa per l’uomo, che si fa oggetto, piuttosto che essere soggetto, della stessa ricerca scientifica. Umanizzare la scienza significa tornare ancora all’interrogativo kantiano sul cosa mi è lecito sperare. Poiché la vita dell’uomo non ha senso vero fino a quando è chiusa nei limiti asfittici dello sterile scientismo tecnologico. Ecco allora che si fa chiaro il bisogno di rintracciare una morale che salvi la dignità umana dalla miseria del materialismo, e che permetta all’uomo di scorgere oltre il cielo stellato un senso alla sua propria vita. Una poeticità che Galilei e Copernico non intravedevano ancora. Un’unità totale che fa dell’uomo un’appartenenza imprescindibile del cielo stellato. Che nella legge morale e nelle idee regolative di ragione trovava il suo fondamento ontologico, metafisico e perciò stesso radicale e definitivo. In ultima istanza si comprende bene come la ricerca metafisica condotta dall’agnostico Kant abbia appassionato anche il teologo Ratzinger, che è uomo di fede. Non bisogna essere cattolici per porsi domande nuomeniche di tipo metafisico. Cosi come non è necessario credere per svelare la profondità dell’idea di Dio, radicata nell’interiorità della coscienza. Basta semplicemente essere uomini per comprendere che guardare il cielo stellato col binocolo per scoprirne i moti, e guardare il cielo per apprezzarne il sublime dinamico di cui parla Kant nella Critica del Giudizio, sono cose completamente diverse. E che lo sguardo dell’astrofisico è pur sempre limitato rispetto allo sguardo dell’uomo-persona, che si pone l’ulteriore domanda radicale sul senso della bellezza e sulla finalità del creato. Il meccanicismo materialistico deve essere superato in una visione finalistica della natura che permetta di scorgere, oltre la causalità, il significato più vero del creato e dell’uomo. L’uomo figlio di Dio è, infine, persona, non individuo. Ed è, in quanto tale, l’unità inscindibile di anima e corpo. La visione olistica consente di superare il meschino interesse privato degli individualisti. La persona è il valore più grande del cattolicesimo. Ed è precisamente quel valore che l’Occidente ha ormai perso di vista e dimenticato. C’è una cecità profonda che offende la nostra civiltà. Ormai incapace di sconvolgersi e di scandalizzarsi per il disprezzo che si prova nel post moderno per la vita umana. Basta leggere una pagina di quotidiano per rendersi conto di come si sia scivolati in basso. L’anestesia al dolore di vivere è, ormai, tutt’uno con l’indifferenza per l’uomo che muore, ucciso ogni volta dai suoi propri simili. Cristo è stato ucciso dall’uomo, e viene ancora ucciso migliaia di volte ogni giorno dall’efferata violenza dell’uomo senza valori. Nietzsche ci racconta della morte di Dio e assimila alla bestia l’uomo che uccide il Suo Proprio Creatore. “Razza di vipere!”, Tuonava Cristo. Non è il Cristianesimo, che di per sé non esiste se non in quanto pura astrazione teoretica, ma è l’uomo carne e sangue che si è macchiato dell’infamia peggiore. Quella di aver ucciso il Suo Dio, e di essersi sostituito a Lui, con spaventosa e nefasta arroganza. Ed è probabilmente proprio in questa presunzione il dramma dell’Occidente. Il suo pericolo più grande.
Antonietta Pistone
Docente di storia e filosofia
Commento al post “Due note sulla Spe Salvi”, comparso in data 13/1272007, sul blog Minimo Karma di Antonio Vigilante, all’indirizzo http://minimokarma.blogsome.com/2007/12/10/due-note-sulla-spe-salvi/#comments
Sitografia
Lettera Enciclica Spe salvi facti sumus, di Papa Benedetto XVI, del 30 novembre 2007, all’indirizzo web:
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20071130_spe-salvi_it.html
ATEISMO E MONDO SENZA DIO IN NIETZSCHE
Di Antonietta Pistone
Un mondo senza Dio, è questo l’errore dell’Occidente. Non un mondo senza fede, credenti, religioni o chiese. Ma un mondo generato dalla morte di Dio, che rifiuta nel nichilismo quei valori scomparsi di cui parla Nietzsche. La morte di Dio non è un evento paragonabile, nella storia dell’Umanità, alla morte esistenziale, determinata da malattia o violenza accidentale. L’uccisione della persona di Cristo ha segnato profondamente il cammino dell’uomo nel mondo, cominciato con il più pesante e imperdonabile crimine della Storia: la creatura che uccide il suo Creatore. “Siamo stati noi ad ucciderlo: voi e io! Siamo noi tutti i suoi assassini! Ma come abbiamo fatto questo? Come potemmo vuotare il mare bevendolo fino all’ultima goccia? Chi ci dette la spugna per strusciar via l’intero orizzonte? Che mai facemmo, a sciogliere questa terra dalla catena del suo sole? Dov’è che si muove ora? Dov’è che ci muoviamo noi? Via da tutti i soli? Non è il nostro un eterno precipitare? E all’indietro, di fianco, in avanti, da tutti i lati? Esiste ancora un alto e un basso? Non stiamo forse vagando come attraverso un infinito nulla? Non alita su di noi lo spazio vuoto? Non si è fatto più freddo? Non seguita a venire notte, sempre più notte? Non dobbiamo accendere lanterne la mattina? Dello strepito che fanno i becchini mentre seppelliscono Dio, non udiamo dunque nulla? Non fiutiamo ancora il lezzo della divina putrefazione? Anche gli dei si decompongono! Dio è morto! Dio resta morto! E noi lo abbiamo ucciso! Come ci consoleremo, noi, gli assassini di tutti gli assassini? Quanto di più sacro e di più possente il mondo possedeva fino ad oggi, si è dissanguato sotto i nostri coltelli; chi detergerà da noi questo sangue? Con quale acqua potremo noi lavarci? Quali riti espiatori, quali giochi sacri dovremo noi inventare? Non è troppo grande, per noi, la grandezza di questa azione? Non dobbiamo noi stessi diventare dèi, per apparire almeno degni di essa?…Che altro sono ancora queste chiese, se non le fosse e i sepolcri di Dio?”[1]. Oggi, quel misfatto raccontato e condannato nella filosofia del Novecento dal pensatore tedesco, si ripropone inequivocabilmente e ripetutamente ogni giorno, nel crimine del fratello che uccide e sopprime il fratello; nell’uso di un linguaggio non propriamente empatico; nelle azioni efferate contro l’altro; nel tentativo reiterato di soggiogare il proprio simile piuttosto che lasciarlo crescere accanto. È il trionfo della violenza sul dialogo, della sopraffazione sull’incontro, del linguaggio della spada piuttosto che di quello dell’amore. Inequivocabilmente colpisce l’attento osservatore del quotidiano la mancanza di un valore fondamentale alla sopravvivenza del genere umano, smarrito del tutto nell’oblio della cultura e della morale sociale ed individuale. Non si ha più alcun rispetto per la vita umana, che non è valore ontologico, ma piuttosto un accidenti come direbbe Aristotele, che c’è ma che può non esserci nell’assoluta indifferenza. Come per i passaggi di stato in chimica e fisica, la vita umana è il percorso di un mutamento incessante che ha il suo culmine nell’evento finale. In che modo esso avvenga ha assai poca importanza. La morte assume, perciò, il significato di un’epurazione, come lo era per i nazionalsocialisti tedeschi durante la tragedia criminale dell’Olocausto nella seconda guerra mondiale. Essa è utile ad “eliminare” le persone scomode, quelle che recano intralcio all’esistere. Un esistere vuoto. Deserto spirituale e sterile per le coscienze immiserite e sconvolte dal sopraggiungere, nel capitalismo post-moderno, di obiettivi materialistici che rinvengono nel profitto il solo fine dell’esistenza. La miopia dell’uomo occidentale è quasi cecità davanti ai massimi interrogativi filosofici, quando non è concepibile una vita senza denaro e senza potere sugli altri. Quando alla vita umana non si attribuisce alcun valore intrinseco. Quando l’uomo nella sua persona non è più, come voleva Kant, un fine dell’agire politico, ma diviene strumento cosificato, offeso e vilipeso, pietrificato dalla violenza dell’essere usato, dallo sguardo la cui prospettiva lo sopravanza, per scorgere in lontananza gli appalti, il profitto imprenditoriale, le armi, la droga, il mercato della prostituzione, le ecomafie dei rifiuti. Assistiamo attoniti al proliferare di assassini che insanguinano le pagine dei nostri giornali, dei misteri che ammorbano l’Italietta borghese e perbenista. Putrida, come i suoi cadaveri, dell’ipocrisia dei valori che hanno perso di vista la persona, il senso della vita, i riferimenti ontologici della morale esistenziale. Che non riesce più a distinguere bene e male, stordita e confusa com’è dal piacere orrido delle carcasse senza vita e dai loro assassini, dalle trame psicoanalitiche di menti sconvolte da traumi infantili, che riconducono ancora una volta, prepotentemente, al punto di partenza. A quei valori fondamentali smarriti nel vuoto cosmico delle coscienze abbrutite dalla banalità, dall’ostentazione, dal non avere più nulla da dire e da raccontare ai giovani che rappresentano il solo futuro possibile che ogni società civile possa immaginare. Perché è allora che proliferano la mamme assassine dei figli, le amiche che uccidono le conviventi, i mariti traditi che si trasformano in lucidi criminali di cronaca nera, i ragazzi quindicenni e bulli che minacciano un compagno per estorcergli denaro, accanto al terrorismo religioso e politico dei mafiosi che derubano le splendide bellezze naturali del mezzogiorno italiano, infangandole della loro miseria e pochezza. Spargendo attorno rancore e odio, dolore e sofferenza, paura e terrore. Perché laddove si strappa la vita umana non c’è altro vero valore ontologico che si possa immaginare al suo posto, per riempire di senso e significato veri quella croce di Cristo che libera nel dolore, e che fa crescere l’uomo come signore e padrone responsabile dell’universo e dei propri simili, nel prendersi cura dell’altro, nel bene e nel male. Nel viversi accanto come fratelli, nel rispetto reciproco, nonostante la differenza, tolleranti e amorevoli gli uni verso gli altri. Abbiamo bisogno di una nuova morale, ammonisce Nietzsche, che ripudi il nichilismo, il vuoto di senso lasciato dalla morte di Dio, che veda l’uomo in vista di un suo possibile superamento. Una nuova morale, oggi, che abbia il suo fondamento nella metafisica di nuovi valori, e di un uomo nuovo capace di farsene interprete. La morte di Dio è un evento irripetibile nella storia, che consegna l’umanità del day after al nulla che rimane nelle chiese, cimiteri di Cristo, sepolcri di preghiere senza ritorno. Solo prendendo amaramente atto di questa realtà si può uscire fuori per liberarsi della menzogna del cristianesimo, che vive dopo duemila anni nell’eterna illusione di un Dio che non c’è. Che non si fa capace dell’annunzio dell’uomo folle della Gaia Scienza, perché non sa accettare l’assenza. Dio, se mai è esistito, non può che essere insostituibile. È giunto il momento, per l’uomo, di crescere. Si può auspicare la rinascita di un’umanità abbrutita dalla materia senza spirito e priva di poesia, incapace di cogliere la grandezza del tutto in un solo filo d’erba e nello sguardo di chi chiede ascolto, comprensione, condivisione reciproca. A volte, solo un sorriso. Ma bisogna, virilmente, assumersi le conseguenze amare dell’inqualificabile gesto dell’umanità. L’ateismo, in Nietzsche, non è una scelta. Ma la necessaria constatazione di uno stato di fatto. La ragionevole presa d’atto di un fatto storico irreversibile. L’uomo è ateo, perché Dio è morto. L’uomo è ateo perché è rimasto solo, senza Dio. Piuttosto che rifugiarsi nelle chiese, cimiteri di Dio, l’uomo, a partire dalla sua solitudine, ha la necessità di reinventarsi una nuova morale, dei nuovi valori, che risolvano il nichilismo in una restaurata possibilità per l’uomo di essere e di esistere in modo nuovo.
Antonietta Pistone
Tratto dal mio articolo Un mondo senza Dio si appresta a vivere il Natale, edito sul Provinciale di Foggia, anno XIX-n. 11-12, novembre-dicembre 2007
Bibliografia
1. Nietzsche, La Gaia Scienza, 1882, brani antologici
2. Protagonisti e testi della filosofia, Nicola Abbagnano e Giovanni Fornero, volume D, tomo 1, Paravia, Milano, 2000
[1] Aforisma 125, trad. it in Opere, Adelphi, Milano, 1965, n.e. 1991, vol. V, tomo 2, pp. 150-152
GANDHI E LA PROVA DEL FUOCO
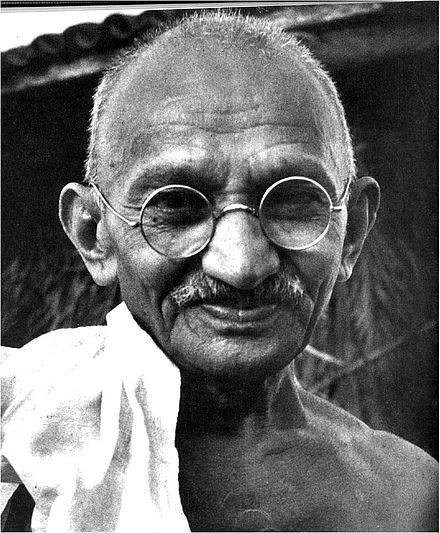
Di Antonietta Pistone
È stato pubblicato di recente il terzo volume della collana di testi e studi su pace e nonviolenza l’aratro, diretta e curata dal Prof. Antonio Vigilante, per le Edizioni del Rosone di Foggia. L’opera, intitolata “La prova del fuoco”, rappresenta una traduzione di scritti gandhiani, tra i quali si può annoverare l’articolo omonimo al libro. Il tema principale è quello della nonviolenza, che si radicalizza come principio morale basilare della religione filosofica Induista, Buddhista e Jainista, a cominciare dal rispetto per la vita animale, e per la mucca ritenuta sacra in India. Altri temi affrontati da Gandhi sono la scelta della dieta vegetariana, e la proibizione dell’eutanasia, se praticata per ottenere vantaggi e secondi fini, che non siano quelli della pietà nei confronti di chi soffre una condizione di malattia terminale che non trova più alcun tipo di sollievo nelle pratiche mediche e negli interventi di cura.
Ma il fondamento dell’Induismo gandhiano resta comunque l’ahimsa (nonviolenza), che diviene fine e scopo della religione, e che si fa anche percorso di crescita e di educazione per i seguaci credenti, che sono chiamati ad addolcire la naturale tendenza umana alla violenza. La himsa, infatti, è presente in ogni più apparentemente ingenuo atto del vivere, a cominciare dalla respirazione che, inavvertitamente, ci mette nella condizione di dover sopprimere alcuni microrganismi presenti nell’aria che inaliamo ad ogni inspirazione. Eppure, senza l’atto del respirare la nostra stessa vita risulterebbe impossibile. Una certa percentuale di himsa (violenza) è perciò connaturata all’esistenza stessa della vita e delle forme viventi più disparate. Ma quando l’uomo diviene consapevole di ciò, deve fare di tutto per limitare la violenza ontologica del vivere e dell’esistere, accettando come legittima solo ed esclusivamente quella quota di inevitabile, senza la quale sarebbe impossibile la vita stessa, cercando di limitare, per quanto è in suo potere, il livello della violenza insita nella realtà del mondo naturale. L’etica nonviolenta si fonda sul rispetto della tradizione; sulla profondità dell’esperienza individuale di vita propria di ciascuno; sul dialogo e sull’ascolto della voce interiore. Gandhi pone a confronto la sacralità della vita cristiana, che interpreta l’esistenza come dono di Dio e accettazione benevola che non può decidere l’uomo quando rifiutare con la morte; e la qualità della vita laica, che conferisce valore umano a quell’esistenza dignitosa che ciascuno può condurre solo ed esclusivamente in condizioni di buona salute e di integrità mentale, ritenendo che non sia giusto chiamare vita la condizione di inabilità che deriva dagli stati di coma profondo ed irreversibile, come da qualsivoglia condizione di infermità che vada a compromettere le normali attività quotidiane della persona. Per il Mahatma (l’infallibile), è atto di pietà religiosa liberare l’uomo sofferente dal suo dolore di vivere, quando la sua condizione manifesti il carattere dell’irreversibilità. Egli parla di “sentiero dell’amore” che diventa precisamente “la prova del fuoco” alla quale si sottrae chi è incapace di amare il proprio simile fino in fondo. L’impedimento dell’eutanasia per il malato terminale diventa un atto di violenza, al pari delle parole dure, dei giudizi severi, del rancore, della rabbia, delle malignità e della brama di crudeltà. L’eutanasia non è un atto di violenza se le intenzioni di chi la pratica sono buone, e la morte del sofferente può essere interpretata come un momento di liberazione dai vincoli del dolore di vivere esistenziale. “Il principio di aggrapparsi alla vita in ogni circostanza tradisce una certa codardia…”, sostiene Gandhi, che in un passo successivo dice ancora:”fino a quando non è disposto ad assumersi i rischi e ad affrontare le conseguenze, un uomo non può essere libero dalla paura, e fino a quando non è libero dalla paura è, ipso facto, incapace di praticare l’ahimsa”. La nonviolenza viene dunque interpretata come scuola di liberazione delle coscienze, che matura l’uomo facendolo diventare realmente adulto e responsabile di fronte alle proprie azioni individuali e collettive.
Le condizioni imprescindibili richieste per praticare l’eutanasia senza che venga commessa violenza sul paziente sono la presenza di una malattia terminale, il non poter fare più nulla per salvare la sua vita, l’incapacità acquisita di esprimere liberamente la personale volontà e il presentarsi del caso come disperato oltre ogni possibilità di aiuto.
Un altro valore fondamentale resta quello della incessante ricerca della verità. “Io insegno al bambino che è affidato alla mia cura non essendo arrabbiato con lui, ma amandolo, tenendo conto della sua ignoranza e giocando con lui”, sostiene Gandhi. Come a dire che la nonviolenza resta anche un precetto sostanziale della relazione tra allievo e maestro. La citazione ricorda La realtà liberata di Aldo Capitini, che fonda una civiltà dell’amore sulla liberazione dell’uomo. Ma anche la pedagogia del bambino liberato di Maria Montessori. Inoltre, con riferimento a Socrate, il Bapu sostiene che la verità è la voce interiore che parla all’uomo. Ma la verità, per colui che ricerca insieme agli altri, è anche Dio, e Dio è Amore. Dunque l’uomo trova dentro di sé ogni principio religioso e conoscitivo che lo conduce sulla strada dell’Amore, che è sacrificio, rinuncia, sottomissione al dovere e rigoroso dominio sulle proprie passioni. L’uomo è più spirito che corpo, come prova la disciplina del sesso (che si perfeziona nella castità) e la dieta rigorosamente vegetariana (che culmina nell’astinenza), in linea con il rispetto degli animali e della natura, su cui l’uomo non ha alcun diritto di opporre il proprio potere. Gli animali, come gli alberi, sono amici. E sono amici tutti gli esseri umani a noi vicini. La fusione con la totalità del creato fonda l’armonia primigenia di tutti i viventi in Dio. Conseguentemente, la vita non è degna di essere vissuta se non preservando la dignità spirituale e il destino che va oltre la morte corporale. “Un seguace dell’ahimsa –scrive Gandhi- al momento di coricarsi deve chiedersi:”Oggi ho parlato duramente a qualche collaboratore?…Mi sono sottratto al mio dovere e ho scaricato il fardello sul mio collaboratore? Ho mancato di servire il vicino che era malato? Ho rifiutato di dare dell’acqua ad un passante assetato che me l’aveva chiesta? Mi sono preoccupato di accogliere chi è arrivato? Ho sgridato un lavoratore? Sono stato esigente con lui senza pensare che poteva essere stanco? Ho pungolato i buoi con bastoni appuntiti? Mi sono arrabbiato in cucina perché il riso era cotto male? Tutte queste sono forme intense di violenza…”. Nel momento attuale di crisi dei valori, per l’Occidente la nonviolenza è un’idea semplice che tutti possono comprendere e fare propria, applicandola alla loro vita. Ripartire dalle piccole cose forse è la strada giusta per non smarrire del tutto il senso del progresso sociale, che è oggi da intendersi come integrazione delle culture e dei popoli, verso una nuova forma di civiltà della pace e dell’amore che l’Oriente può aiutarci a scorgere proficuamente.
Antonietta Pistone
Docente di storia e filosofia
IL PENSIERO NONVIOLENTO DI ANTONIO VIGILANTE
Di Antonietta Pistone
Risale a qualche anno fa la pubblicazione del pensiero nonviolento del Prof. Antonio Vigilante, per le Edizioni del Rosone di Foggia e la collana l’aratro, da lui medesimo diretta e curata. L’autore prende spunto dal lavoro del filosofo tedesco Martin Heidegger che nel 1935, nel suo corso di Metafisica, pone agli allievi la domanda ontologica radicale: “Perché l’Essere e non piuttosto il nulla?”. Lo smarrimento dell’uomo del Novecento, che vede distrutta ogni sua precedente edificazione dalla crudele violenza del primo conflitto mondiale, chiede di venire risolto attraverso la ricerca del fondamento dei valori ormai desueti. E si può accompagnare, nelle intenzioni del nostro filosofo, padre dell’Esistenzialismo tedesco, alla questione metafisica sul fondamento dell’Essere. Ciò che stupisce l’uomo di cultura di ogni tempo è il prendere atto che anche le religioni spesso nascondono, in modo più o meno evidente, una sufficiente dose di violenza. E nella storia, in nome di Dio, si sono compiuti e si compiono tuttora misfatti e nefandezze, crimini contro l’umanità, che nulla hanno da invidiare agli atti terroristici veri e propri. Effettivamente, ogni religione ha una quota di inevitabile violenza. Perché ogni religione è un’interpretazione dell’uomo. E l’uomo è un essere violento e pacifico al tempo stesso. La violenza è ontologicamente connaturata alla vita e alla sopravvivenza, se anche l’atto del respirare è atto violento che sopprime milioni di microrganismi presenti nell’aria. Essendo però la religione un prodotto della cultura, e non della natura umana, è possibile estirpare la violenza dalla e della religione, abbattendo ogni forma di dogmatismo o di presunzione, che fa della verità un possesso privilegiato e dogmatico, destinato ad alcune “caste”. Ma per estirpare la violenza delle religioni bisogna educare il cuore dell’uomo. Ed è a questo punto che la nonviolenza diventa atto formativo e impegno pedagogico, che è metànoia spirituale, facendosi così operazione intellettuale di raffinata sensibilità culturale che innesta valori e rispetto per l’uomo, operando dal di dentro, a partire dalla sua anima. L’uomo nonviolento è perciò forte e saldo nella sua fede, che trae la religiosità più antica e profonda dal cuore stesso. Ed è dunque la forma più autentica di religione quella che nega se stessa come prodotto della storia per ritrovare nella natura umana la sua più vera modalità di essere e di porsi. È il richiamo all’uomo di Socrate, al “redi in te ipsum” di Agostino. Alla scoperta dell’uomo “possibile”. Di un futuro che non è ancora, ma che si può definire a partire dall’uomo, dalla sua alterità e dall’incontro con l’altro. L’apertura, l’uscire da sé per comunicarsi è l’atto implicito del dialogo e della vera condivisione, che abbatte le frontiere dell’incomunicabilità e della distanza tra le culture. E consente il proliferare di un’umanità più ricca di valori disponibili, e la comunione di intenti e di spiriti, anche nella diversità. Il rispetto della vita dell’altro è perciò accettazione della sua parola, del suo modo di vivere e di sentire, e approssimazione alla sua gioia, ma soprattutto compassione per la sofferenza. Sembra, infatti, che il dolore accomuni l’uomo di ogni tempo e di ogni razza e latitudine. La condivisione del dolore, fisico e psichico, unisce ogni uomo al proprio simile indissolubilmente, confermando la comune e identica natura dei viventi che esistono, e non sono, in senso strettamente ontologico. L’attenzione per l’altro si fa etica della responsabilità che permette un’intelligenza dell’uomo che è trascendimento, nel superare i limiti delle angustie quotidiane. È con il riconoscersi nel volto dell’altro e nelle condivise ragioni del cuore che si realizza attualmente la più matura razionalità della persona, che arricchisce il suo intelletto di quei valori affettivi ed emozionali che solo le religioni possono considerare proprie dell’uomo, nel superamento dell’antica concezione che antepone la fredda riflessione del logos al forte, intrinseco bisogno di espandersi entro e oltre i confini dell’anima. Il pacifismo appare di conseguenza un atteggiamento ai limiti dell’utilitarismo politico e culturale, fermandosi passivamente alla condanna della guerra, laddove la nonviolenza si propone di risolvere il conflitto, trascendendolo per l’arricchimento reciproco delle parti. La nonviolenza è, in tal senso, ricerca della verità più propria all’uomo, che si ritrova come soggetto di Amore, capace di costruire relazioni e di gettare ponti tra le culture. Nonviolenza è educazione della mente e del cuore attraverso la mano. Il lavoro manuale, più di quello intellettivo, rappresenta un primo passo verso una società edificata su valori di pace. Una civiltà del dialogo che attraverso il tu trascende nella compresenza ogni forma di individualismo e di totalitarismo. Nel dialogo inteso come incontro per tutta la comunità si fondano i presupposti di una radicale trasformazione della società mafiosa, votata al silenzio omertoso ed atterrito di tutti coloro i quali si rendono in qualche modo conniventi del fenomeno malavitoso. Sarebbe perciò auspicabile una società maieutica in senso socratico che, attraverso l’interlocuzione dialogante, si ponga domande radicali e fornisca a se stessa risposte soddisfacenti e critiche per un futuro nuovo, pensabile e progettabile attraverso le categorie della possibilità responsabile e matura di tutta la collettività umana dei cittadini e dei politici. In tal senso l’educazione alla nonviolenza diventa un primo passo indispensabile ed imprescindibile verso la valorizzazione pedagogica e politica della società del futuro. La violenza, come il silenzio efferato dell’omertoso colludente, riduce gli uomini a cose, pietrificando gli esseri, ritiene Simone Weil. Mentre la forza è la virtù di lasciar crescere accanto. Nella efferata violenza del secolo delle due guerre mondiali, dall’altra parte del mondo, in India, Gandhi tenta una risposta alla domanda radicale e ontologica di Heidegger, attraverso la filosofia della nonviolenza. Il profeta della nonviolenza, infatti, ci ha dato prova di come sia possibile una metafisica che interpreti l’Essere del reale come forza suprema dell’Amore, il cui equilibrio viene purtroppo sistematicamente infranto dalla cosificazione annichilente dell’atto che rompe l’armonia dell’uomo con la natura, e l’accordo primigenio dell’anima con Dio. L’Essere che Heidegger cercava, per opporlo al nulla annichilente della morte, risiede perciò, nell’interpretazione di Gandhi, nella forza della nonviolenza, praticata con testarda convinzione, nell’intento di vivere l’esperienza esistenziale in accordo supremo con il mondo e con la natura, con gli altri esseri che abitano la terra, nel mutuo, reciproco sostegno che rende l’uomo fratello dell’altro uomo, mentre si specchia nel volto del proprio simile, mentre incontra l’altro nel dialogo e nella comunione reciproca. Se dunque l’Essere è la forza dell’Amore, e della nonviolenza, mentre il Nulla è l’Odio violento e distruttore, l’Essere esiste in quanto generatore della vita, ed il Nulla esiste come suo opposto, in quanto morte e degenerazione. Ma poiché è l’Amore a dare la vita, l’Essere vince il Nulla, cioè la totale assenza, il buio, il vuoto cosmico, l’assordante silenzio del day after, finché ci sarà ancora un uomo a costituire la speranza per un Suo nuovo inizio.
Antonietta Pistone
Docente di storia e filosofia
versione integrale di un mio articolo comparso sul periodico “Il Provinciale” di Gennaio-Febbraio 2008, a pag.10, con il titolo Per vivere in accordo supremo con il mondo e la natura.
RELIGIOSITÀ E FILOSOFIA DELLA PACE E DELLA NON VIOLENZA. I VALORI DEL BUDDHISMO

Di Antonietta Pistone
Il Buddhismo nasce in India nel VI sec. A.C. e si diffonde successivamente in Cina, accanto al Confucianesimo e al Taoismo, in Giappone, in Tibet, in Mongolia, nell’isola di Ceylon, in Thailandia, in Birmania, in Cambogia e persino nell’Europa occidentale, in Francia e in Germania. Siddhartha, il Buddha Gautama, ne predica la dottrina per la quale la vita è essenzialmente sofferenza. La strada per sospendere questa condizione di insoddisfazione è la pratica del distacco dalle cose del mondo materiale. Se vivere è desiderare, e il desiderio causa dolore, bisogna smettere di volere e bramare per smettere di soffrire. Cioè praticare il distacco ascetico dalla realtà materiale, per trovare la pace dei sensi. Per i Buddhisti tutto è permeato di spirito, e la meditazione consente di diventare una sola cosa con la realtà dell’intero universo. La penetrazione dell’essenza spirituale del reale abolisce l’opposizione di soggetto e oggetto, e permette la fusione dell’individuo singolo con l’universalità di tutto il reale circostante. Questo “respiro” totale e totalizzante, che abbraccia l’interezza dell’essere esistente, deriva dal distacco dalla materialità del desiderio, del potere, del denaro e della fama. L’unica cosa che importa è la ricerca della pace interiore, che è saggezza ed equilibrio nuovo dell’uomo con il proprio habitat naturale e sociale. Ne deriva una predisposizione alla vita contemplativa ed ascetica, praticata dai monaci buddhisti, i quali fanno voto di povertà, castità e silenzio. Difatti, proprio il silenzio è un elemento fondamentale per la meditazione religiosa. Mentre gli ideali della povertà e della castità rimandano alla liberazione e alla purificazione dal bisogno sessuale o materiale. Le tecniche di meditazione, come il controllo della respirazione e del proprio corpo, sono tutti strumenti utili a raggiungere questa condizione di ascetismo sognante e di piena soddisfazione dell’anima. Referenti filosofici del Buddhismo sono, in epoche successive, l’umanesimo di Socrate e di S. Agostino, per i quali la verità risiede nel cuore dell’uomo; Schopenhauer, che predica la necessità del distacco dal bisogno e del superamento dei desideri che animano la volontà, proponendo un ideale di vita ascetico; Cartesio, che pratica il dubbio metodico e invita l’uomo a fidarsi solo ed esclusivamente di ciò in cui crede per sola, provata esperienza. Il Buddhismo, in quanto atteggiamento filosofico, può definirsi antimetafisico, perché contiene continui richiami all’esperienza concreta di vita degli uomini, rifiutando sistemi onnicomprensivi ed autoesplicativi del reale. Attualmente, il Buddhismo rappresenta anche un richiamo ai valori della pace e della non violenza di Gandhi, per tutti i popoli dell’Occidente. Costituisce, inoltre, un esplicito invito a prendere decisamente posizione nei confronti della contemporaneità, eleggendo a scelta ideologica dominante l’antipositivismo, l’antiscientismo, l’antirazionalismo tecnologico e globalizzante. Attraverso la capacità di “sentire” la spiritualità che permea di sé tutta la storia dell’umanità. Intesa come un eterno ritorno, senza sviluppo, senza inizio né fine. Entro questa concezione circolare dello spirito è possibile la reincarnazione Karmica, che richiama alla memoria la metempsicosi delle anime dopo la morte, di cui parlano sia Pitagora che il grande Platone. I valori del Buddhismo si iscrivono, in questo senso, entro una cultura filosofica della pace. Si pensi a Erasmo da Rotterdam, allo stesso Socrate, ma anche a Kant, a Kelsen. Al personalismo di filosofi cattolici quali Mounier e Maritain, che esaltano l’umanesimo integrale di anima e corpo. E c’è anche un filone ebraico di studi filosofici sulla pace. Buber, ad esempio, parla della relazione intersoggettiva io-tu, che si instaura nel dialogo tra due persone. E che ricorda il Buddhismo Zen del giapponese Nishitani. Vi è poi la filosofia laica della pace di Lévinas, che individua il criterio del rispetto dell’altro nella fenomenologia del volto. L’Altro è colui che si incontra e che mostra, al primo impatto, il suo volto, nel quale si scorge l’infinito, ciò che attrae e respinge. In ogni caso, l’elemento che impone di considerare ogni uomo come una parte del tutto, di quella globalità nella quale quella singola, individuale esistenza è assolutamente indispensabile. Pertanto, ciò che accade ad ogni uomo non può restare indifferente alla categoria degli Altri. Perché ciascuno ha in sé quel briciolo di umanità che impone ad ognuno di riconoscersi nell’Altro. La dimensione filosofica della pace, di cui parla Lévinas, è l’ateismo. Seppure esista un Dio, è proprio nella distanza che intercorre tra Lui e l’uomo ateo che emerge la rispettiva grandezza. Quella del Creatore e quella delle creature. Che sono esistenze degne proprio perché dotate di intelligenza e di libertà morale. Anche per Lévinas non esiste più alcun residuo di metafisica che, come nel Buddhismo, finisce per coincidere proprio con la filosofia morale e con la religiosità, intese come spirito infinito che anima l’umana coscienza.
Antonietta Pistone
Docente di storia e filosofia
Articolo pubblicato sul “Rosone”, anno XXVII, marzo-aprile 2004
DEUS CARITAS EST | LA PRIMA ENCICLICA DI PAPA BENEDETTO XVI

Di Antonietta Pistone
“L’amore promette infinità, eternità-una realtà più grande e totalmente altra rispetto alla quotidianità del nostro esistere”. Queste le parole che Papa Benedetto XVI indirizza al più grande e travolgente sentimento umano di ogni tempo, nella sua prima Enciclica Deus caritas est. L’uomo, per Ratzinger, è amore nella sua più intima essenza. Si può facilmente constatare che le imprese più illustri, le trovate geniali, le spinte emotive più creative della storia siano state determinate dalla passione dell’uomo a vivere ed esistere come possibilità, entro cui rimettersi continuamente in gioco, sfidando anzitutto se stesso. Papa Benedetto opera una distinzione terminologica essenziale per chiarire il senso della parola amore. Spesso si dicono amore l’eros o la volgarità. Ma la pornografia non è amore, come non lo è il desiderio sfrenato senza temperanza che consuma rapidamente e si estingue ancor più velocemente di un fuoco fatuo. L’amore cristiano era detto dagli antichi agape, ed è affetto che va oltre il sesso mercificato o vissuto frettolosamente. L’agape rappresenta l’amore dell’uomo di fede, capace di sacrificarsi per il bene dell’altro, dimenticando se stesso, i suoi desideri, le sue passioni. L’agape è amore senza concupiscenza, che si fa unità inscindibile e totale nello spirito e nelle anime, oltre che nei cuori. Amore che supera, travalicandoli, i limiti asfittici della storia umana, per approdare all’eternità senza tempo dello spazio infinito. L’uomo, in quanto unità inscindibile di corpo e anima, sperimenta nella sua esistenza entrambe le tipologie di amore, che nell’unione sponsale tra uomo e donna si fanno Assoluto. L’eros che tutto desidera prendere, diviene a poco a poco agape cioè rinuncia, dedizione, legame affettivo duraturo e coinvolgente. Non per questo meno erotico dell’esperienza sessuale. Anzi ancora più completo nella complicità del rapporto maturo tra uomo e donna. Solo questo Amore può elevare la dignità umana, sublimandola nel legame religioso dell’uomo con Dio stesso. Anche Dio, difatti, crea per Amore. Ed il suo Amore è allo stesso tempo possessivo e oblativo. Possessivo perché Egli desidera con ardore e passione di legarsi inscindibilmente a tutte le sue creature. Oblativo perché tutto è capace di donare, senza aspettarsi nulla in cambio, restando tuttavia in paziente attesa di vedersi ricongiunto al peccatore, del cui amore Egli ha bisogno. Proprio per questo Dio comprende la solitudine dell’uomo e decide di mettere Eva accanto ad Adamo: “Questa volta essa è carne della mia carne e osso dalle mie ossa” (Gn 2,23). Sembra di leggere il mito platonico delle anime gemelle, che narra di un essere sferico e bastante a se stesso tagliato in due dagli dei, le cui due parti cercano ossessivamente di ricongiungersi per ritrovare l’antica unità ormai perduta. “Per questo l’uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne” (Gn 2,24). Dove l’essere un’unità totale non prescinde dall’eros, dovendo però culminare nell’ agape, nell’amor platonico, che è contemplazione dell’amato e conoscenza, in cui si fondono vita etica e scienza del Bene, in virtù dell’intellettualismo classico. Ma proprio l’intellettualismo etico rappresenta il limite del razionalismo filosofico degli antichi, che principia con Socrate e attraversa il pensiero delle grandi sintesi teoretiche di Platone e di Aristotele. L’uomo greco, infatti, non sa la differenza tra conoscere e agire. Essendo per lui la scienza fondamento di virtù. Manca agli antichi la concezione della libertà umana, intesa come scelta responsabile tra due alternative possibili, prescindendo dalla conoscenza del Bene in esse presente. Per Socrate, per Platone e Aristotele, l’uomo desidera la felicità. E la felicità è una conquista della ragione. L’uomo è tanto più felice quanto più è saggio e virtuoso. Quanto più conosce e sa. Perché colui che conosce il Bene fa e agisce per il Bene. L’uomo antico pare essere, perciò, tutto ragione e intelletto. Non vi è traccia, nel pensiero filosofico della debolezza del peccato, della caduta e della redenzione. Problemi, questi, che appartengono alla schiera degli ignoranti. Il messaggio biblico segna la nascita dell’uomo nuovo, che è individuo dotato di libertà. La facoltà di scegliere tra almeno due alternative, il Bene e il Male, è il principio dell’agire libero e responsabile del credente, che nella scelta del peccato dimostra la fallacia dell’intellettualismo etico, riconfermando la libertà della storia umana. Lo stesso Agostino diceva conosco il Bene, tuttavia compio il Male. A voler provare che la causa determinante dell’agire non è la conoscenza del Bene, bensì la volontà di fare il Bene. L’agape, pertanto, non è un presupposto dell’amore tra uomo e donna, ma costituisce il punto d’arrivo di una ricerca di perfezione che implica rinuncia e sacrificio. Spesso, infatti, l’eros può risultare meno coinvolgente ed impegnativo; più risolutivo e semplice. L’Amore delle anime implica comunque un impegno totale del corpo e dello spirito nel fare costante dono di sé, senza nulla pretendere di possedere. Esso è l’amore che più imita quello di Cristo che lascia sempre libero l’uomo, e continua ad amarlo con pazienza anche nel rifiuto. Il dolore silenzioso dell’amante che tutto spera senza mai chiedere è il dono più bello e santo del vero Amore cristiano, che aspetta desideroso e trepido che l’amata si accorga finalmente della sua presenza e che a lui con fede si conceda per l’eternità. Maria, la Madre di Cristo, è un esempio di abnegazione totale per l’altro: Ella resta in attesa durante gli anni della predicazione, e resta in attesa sotto la croce a piangere il Figlio che le hanno ucciso. Ciononostante, mai una parola di disperazione, né un grido a Dio Padre che ha permesso che Le venisse sottratto il suo unico Bene. La carità cristiana deve, perciò, esplicarsi in opere sollecite nei confronti del prossimo, bisognoso di aiuto. La Chiesa non può sostituirsi allo Stato. E lo Stato giusto deve comunque garantire un’equa distribuzione delle ricchezze, onde evitare sperequazioni sociali. Ciononostante, è quasi irrealizzabile il sogno di un mondo assolutamente giusto e senza povertà o emergenza dal bisogno. La carità cristiana, impone pertanto un soccorso pronto e immediato verso i fratelli più indigenti. Tuttavia, “L’azione pratica resta insufficiente se in essa non si rende percepibile l’amore per l’uomo, un amore che si nutre dell’incontro con Cristo. L’intima partecipazione personale al bisogno e alla sofferenza dell’altro diventa così un partecipargli me stesso: perché il dono non umilii l’altro, devo dargli non soltanto qualcosa di mio ma me stesso, devo essere presente nel dono come persona”. Papa Benedetto conclude, così, con un’invocazione a Maria: perché possiamo anche noi diventare capaci di vero amore ed essere sorgenti di acqua viva in mezzo a un mondo assetato.
Antonietta Pistone
Docente di storia e filosofia
Articolo pubblicato sul Provinciale di Foggia, anno XVIII-n.2, febbraio 2006
Fonti sitografiche
Enciclica di Papa Benedetto XVI, Deus caritas est
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est_it.html
LE DINAMICHE ESISTENZIALI E L’IO CHE SI SENTE SMARRITO | “PERCHÉ VIVO” DI TOLSTOJ PUBBLICATO A PALERMO
Pubblicato nel 2004, a Palermo, nella nuova collana L’Epos, a cura degli “Amici di Tolstoj”, il libro dell’autore russo intitolato Perché vivo?, affronta le dinamiche esistenziali dell’uomo contemporaneo. Nella società attuale, dominata dalla tecnologia e dalla fede incondizionata per la scienza, l’io si sente smarrito, in bilico tra il richiamo al potere, al denaro, alla fama, e la domanda insistente della coscienza interiore che chiede un senso, un significato ed uno scopo per la vita. L’opera contiene intense pagine liriche e dense di sentimento religioso, appartenenti al secondo Tolstoj, l’uomo della conversione al Vangelo, che supera nell’abbandono in Cristo la crisi spirituale del cammino intimistico dell’autore. Si tratta del Tolstoj che rifiuta completamente il periodo letterario dei romanzi Guerra e pace, Anna Karenina e Resurrezione, e che si incammina per un sentiero di ricerca più speculativo e filosofico. È il Tolstoj che si converte al Cristianesimo, e che parla di valori di pace e di fratellanza tra gli uomini. La riscoperta del Vangelo, della sua semplicità di vita, gli aprono la strada alla critica alle istituzioni ecclesiastiche, divenute ormai potere costituito, in sede civile e temporale, Stato nello Stato. Parimenti, vi è il rifiuto totale del messaggio evangelico proposto da Paolo ai Romani. In esso c’è, per Tolstoj, il più alto tradimento della lettera evangelica, e l’espressione dell’asservimento della Fede al potere laico e civile. Vi è, insomma, nel libro, un forte richiamo ai valori dello spirito. Sostenendo che, anzi, la fede rende più matura la ragione dell’uomo, attraverso quei valori di pace che consentono la convivenza tra la tolleranza delle diversità reciproche. Mentre la violenza e la sua rassegnata accettazione rendono il mondo moderno folle, e tanto più miope quanto meno si rende criticamente conto della follia in cui costantemente viene ingoiato. Il paradosso è nel credere che la guerra possa generare la pace: è folle. Eppure questo assunto regge da secoli il mondo. Un mondo senza Dio, senza valori. Che condurrà l’uomo all’autoannientamento. La sfida è quella di tornare alla verità semplice del cristianesimo evangelico per ritrovare, con la fede e la ragionevolezza, anche la libertà del sentirsi ed essere tutti figli del Dio creatore. Per aborrire la Guerra Santa islamica e la Guerra Giusta cattolica, attraverso la riscoperta dei contenuti di pace di entrambe le civiltà del mondo. Perché, sia l’Oriente che l’Occidente meritano di essere riscoperti. Ma la cultura è amore e genera amore. E nulla le è più estraneo della sopraffazione. Perché vivo? È anche testo filosofico che ha ispirato molta parte del pensiero non violento di Gandhi, invitando l’umanità alla fratellanza e alla pace, attraverso la riscoperta dei valori fondamentali da condividere con gli altri. “Io, per me stesso, ho risolto il problema del senso della vita, dicendomi che consiste nell’accrescere l’amore in se stessi e nel mondo”, così pare concludere Tolstoj la sua ricerca. L’angoscia e la disperazione esistenziali sono generate dal desiderio smodato di felicità per l’individuo. Ogni volta che ci si dimentica degli altri, che si smarrisce il senso della condivisione fraterna della gioia e del dolore, allora non resta altro che il vuoto nulla, il deserto esistenziale. Ma se l’uomo impara a porsi nella prospettiva della comunità fraternamente predisposta all’ascolto attivo della parola di Cristo, e alla Sua imitazione, ripercorrendo la vita come un cammino ed un pellegrinaggio terreni, allora saprà comprendere il valore della gioia e anche del dolore, perché sarà capace di leggerli in una dimensione eterna, alla luce degli eventi della morte e della resurrezione di Nostro Signore. L’uomo ha un disperato bisogno di Dio, ed un sentire profondamente religioso, che gli impongono di aver fede in qualcosa che trascenda la dimensione corporale. La vita deve essere intesa come una progressiva liberazione dello spirito dalla carne, dimenticandosi dell’aspetto materiale dell’esistenza, per conquistare sempre più quella pienezza della vita spirituale, che supera il limite della finitezza umana. La realtà dell’uomo è grande proprio in virtù di questa certezza di superamento del disagio, della malattia, della sofferenza, del male metafisico, connaturati alla miseria della carne. I valori dello spirito conferiscono all’uomo la sua dignità di figli di Dio, innalzando la Storia verso l’Essere che la trascende, traghettandola nell’eternità. Fede e Speranza devono legarsi saldamente alla carità fraterna, intesa come servizio per gli altri, i bisognosi, i sofferenti, i poveri di spirito. L’amore è la forza più grande e potente che il credente ha a disposizione, per rompere le chiusure, per superare i confini che spesso sembrano steccati invisibili e invalicabili, ma che sempre con maggiore frequenza dividono l’uomo dall’uomo, isolandolo nella sua solitudine e uccidendolo nella sua miseria. Degno di nota è l’appello che Tolstoj rivolge ai giovani, ai quali chiede di testimoniare di essere luce vera e viva per il mondo: “Credete in voi stessi…abbiate fiducia in voi nel momento solenne in cui nella vostra anima per la prima volta sorgerà la coscienza luminosa della vostra divina origine. Non fate spegnere questa luce, ma vegliatela come cosa preziosa e lasciatela dilatare. In questo espandersi della luce risiede l’unico grande gioioso senso della vita di ogni uomo”.
Antonietta Pistone
Docente di storia e filosofia
Fonti bibliografiche
Lev N. Tolstoj, Sulla follia, Scritti sulla crisi del mondo moderno, l’aratro, collana di testi e studi su pace e non violenza, diretta da Antonio Vigilante, Edizioni del Rosone, Foggia, 2003
Articolo di Antonietta Pistone pubblicato sul Provinciale di Foggia, anno XVI-n.2, febbraio 2004
Articolo di Antonietta Pistone pubblicato sul Rosone di Puglia, anno XXVII-n.1, gennaio-aprile 2005
INTEGRAZIONE DEI POPOLI E CATASTROFE DELLE CIVILTÀ
Di Antonietta Pistone
Il terrorismo di matrice islamica domina lo scenario politico contemporaneo. Effettivamente le guerre di religione hanno da sempre insanguinato il mondo. Lo stesso Cristo è morto sulla croce, come un banale assassino. I martiri sono stati perseguitati per la loro fede. Le Crociate testimoniano l’acerrima lotta dei cattolici nel tentativo di frenare l’espansione dei Turchi Ottomani nel Mediterraneo. La Controriforma, culminata nel Concilio di Trento, ha rappresentato un momento di riflessione dottrinaria ed evangelica della Chiesa cattolica, per ripensare se stessa dopo la Riforma protestante di Lutero. Le vicende del cattolicesimo hanno dovuto, in seguito, estrinsecarsi in atteggiamenti tolleranti e accoglienti nei confronti delle differenti fedi professate, per misurarsi con i credenti in modo pacifico e per rendere possibile un’integrazione delle culture. Papa Giovanni Paolo II si è conquistato di diritto, in quest’opera di apertura al dialogo tra le diversità religiose, un posto di grande rilievo nella storia. E sempre verrà ricordato per la sua capacità di andare incontro alla gente, per accogliere le difformità di cui ogni popolo è ricca e feconda testimonianza. Dopo gli attentati dell’11 settembre, cui sono seguite le rappresaglie nei Paesi europei sostenitori della guerra di Bush all’Iraq, molti sostengono che il fanatismo musulmano vada in cerca di occasioni di conflitto che possano ulteriormente esacerbare i rapporti già assai tesi tra Occidente ed Oriente. E se così fosse, viene da chiedersi a cosa potrebbe giovare, per la pace ecumenica, ostentare ed esibire simboli che deridono o offendono la dignità della religione islamica, indipendentemente dalle sue degenerazioni fanatiche e terroristiche. Va poi considerato che la religione cattolica, che si definisce espressione della cultura del mondo occidentale, nasce in Israele ad oriente del globo terrestre. Essa è figlia dell’ebraismo con cui costituisce, unitamente a quella islamica, una delle tre religioni monoteistiche del pianeta. Alcuni politici e uomini di cultura si ritengono offesi sostenendo che le radici cristiane dell’Europa sarebbero state svilite e mortificate da una cultura orientale che tende a sopraffare i valori dell’Occidente cattolico. I valori della pace e dell’amore che Cristo predica sono i capisaldi di un mondo che non fa del denaro il proprio signore. Espressione di un modo di sentire che esprime in tutta evidenza la sua dissonanza con la difesa del capitalismo e della società conformista e di massa del nostro Occidente. Quell’Occidente che non attribuisce valore e senso alla vita dell’uomo. I valori del mondo cattolico sono senso e fine della vita. E la vita umana assume, in questa prospettiva, una centralità ed una sacralità soprannaturale, scotomizzata dalla tecnologia dell’informazione e dalla cultura globale dell’Occidente. Non riusciamo, accecati dalla nostra presunzione, a comprendere la differenza, l’incontro, il dialogo tra le culture. Né possiamo sperare in un’integrazione dei popoli del Mediterraneo e dell’Oriente, sebbene tanto a noi geograficamente prossimi. La chiave del contendere se tenere il Crocifisso nelle aule scolastiche o se rendere possibile, ove richiesta, l’ora di religione musulmana in classe per discutere il Corano, è e resta un confronto assai rispettabile tra posizioni dialettiche. L’insegnamento della religione viene, difatti, impartito nelle scuole pubbliche, che sono scuole dello Stato e che pertanto hanno il dovere di trasmettere un’educazione laica e secolare ai cittadini, senza per questo voler sconfessare il cattolicesimo che rappresenta una radice identitaria e storica della cultura del nostro popolo. Sembra doveroso cominciare a pensare, senza falsi rigurgiti di bigottismo di facciata, ad una scuola che permetta realmente agli studenti di misurarsi con le ideologie religiose della contemporaneità e della storia del mondo. L’ora di religione non è l’ora di catechismo parrocchiale. I giovani hanno il diritto ad essere informati ed istruiti sulla storia delle religioni. Così come hanno il dovere di formarsi in proprio un’opinione assolutamente libera da pregiudizi, autonoma e critica. La fede adulta è una scelta consapevole, nella quale si gioca tutto il futuro dell’uomo. Una scelta radicale che non può essere affidata al caso o alla tradizione. La fede religiosa oltrepassa la ragione, valicando i limiti angusti e finiti del pensiero umano. Ma non vi può essere fede certa senza ragione critica. L’intuire Dio, il suo amorevole e paterno abbraccio, è atto della noesis, l’intellezione di cui parla Agostino, che muove dalla ragione dialogata e la supera, per unirsi inscindibilmente al Creatore. L’insegnamento della filosofia nelle nostre scuole dovrebbe perciò essere accompagnato e sostenuto dall’ora di Storia delle Religioni, che provvederebbe ad approfondire nel tempo gli aspetti dottrinari delle fedi monoteistiche e di quelle così dette orientali: il Buddhismo, il Taoismo, il Confucianesimo, l’induismo. Si renderebbe in tal modo assai evidente il richiamo ad una spiritualità che permea di sé tutte le religioni del mondo, invitando l’uomo a cercare rifugio nella propria coscienza interiore, resa viva dal dialogo intimistico con Dio. Il mondo verso il quale stiamo andando si muove in prospettiva pluralistica, ed in tale direzione è auspicabile un’accoglienza dell’altro, che si faccia accettazione della sua cultura e contaminazione con la sua diversità. Solo un cammino pacifico verso la reale integrazione dei popoli ci salverà dalla catastrofe delle civiltà, innescata dalla guerra meschina e sciocca delle culture religiose, che si combattono l’un l’altra nella presunzione di possedere la verità metafisica, l’interpretazione eternamente valida della vita e del destino dell’uomo.
Antonietta Pistone
docente di storia e filosofia
articolo edito sul Provinciale di Foggia, anno XVIII-n.4, aprile 2006
L’UOMO COME POSSIBILITÀ E SCELTA TRA VALORI E DISVALORI. LA CATEGORIA ONTOLOGICA DEL SINGOLO
Di Antonietta Pistone
Incessante fonte di disorientamento per l’uomo contemporaneo, sono l’attuale carenza, in ambito filosofico, di un sistema organicistico e razionale, in grado di infondere certezze, e parallelamente il progredire accelerato delle acquisizioni in ambito scientifico e tecnologico, insieme al nichilismo dei valori in sede morale e politica. Quanto più cresce la richiesta di evidenze, traducibile per l’intellettuale come nostalgia delle passate filosofie rassicuranti, ed insieme come constatazione dell’assenza di una nuova sintesi del pensiero occidentale, tanto più l’individuo prende atto del limite insito nella sua esistenza, che si fa precaria e vuota. Si sente, oggi, il peso di questa solitudine, di questo abbandono a se stessi, in mancanza di punti solidi di riferimento, fosse anche nell’aggancio ai motivi religiosi di una trascendenza attualmente dissacrata per la constatazione amara che anche le istituzioni ecclesiastiche sono state travolte in questa crisi dei valori, quanto più si sperimenta un bisogno forte di avvicinamento all’altro, e dunque a Dio. Il parallelo riscontro dei limiti dell’esistenza, chiusa nella sua misera solitudine e finitezza, impotente ad uscire dai confini della precarietà temporale, ma con grandi aspirazioni romantico-idealistiche nei più intimi meandri della coscienza e del sogno, fanno dell’uomo un individuo unico e irripetibile, nei confronti degli altri viventi, ed univocamente di ogni uomo verso i suoi propri simili. Emerge dal fondo della realtà umana la categoria sostanziale dell’uomo contemporaneo, che è l’uomo della solitudine, dell’incertezza, del disorientamento e della precarietà, ma è anche il singolo, colui che si costruisce, si progetta in modo assolutamente autentico nei confronti di se stesso, alla continua ricerca di risposte mai definitive. L’uomo che rientra continuamente in gioco, perché ha la capacità di rimettersi sempre in discussione: in relazione alle sue acquisizioni, alla sua sussistenza ed al suo posto nel mondo. Mettersi in discussione equivale a dire che non vi è certezza assoluta di essere, ma significa anche esaltare la valenza positiva di tale carenza ontologica, per conferirle un senso. Ciascuno è un singolo, perché le esperienze di ognuno sono differenti da quelle di chiunque altro, a cominciare dal nascere e dal morire. L’attimo del venire al mondo è un momento di grande dolore e fatica per il piccolo che si trova ad affrontare, così giovane, una prova tanto grande: è però un’esperienza di solitudine perché nessuno, per quanto lo ami, potrà mai sostituirsi al nascituro nell’attimo doloroso del distacco tra sé e la madre, del giungere alla luce. Ugualmente è momento di solitudine quello della morte, perché per quanto si possa essere vicini a colui che muore, ciononostante l’esperienza del morire può farla solo il morente. Ogni attimo di gioia e di dolore è del tutto singolare e irripetibile, come lo sono l’ambiente in cui l’uomo vive, la storia della sua famiglia e quella del suo paese, il livello culturale emergente nel suo status sociale. E tutto ciò lo formerà e condizionerà inequivocabilmente, perché chiunque non voglia sottrarsi a se stesso, non potrà sottrarsi nemmeno alla sua propria storia. La categoria del singolo è perciò categoria della storicità dell’essere, del limite, della precarietà e della finitezza dell’uomo, così come è categoria del dolore e della solitudine, ma al tempo stesso è spiraglio di luce che si getta nel buio dell’incertezza, dell’indecisione, dell’approssimazione di ciascuno al suo essere più proprio, al suo poter essere.
Schema della categoria ontologica del “singolo”
singolo
libertà
possibilità = angoscia del nulla
scelta
valori
nessuna scelta
disvalori
disperazione
Il singolo come possibilità
Aristotele aveva definito l’uomo animale razionale, cioè sinolo di materia e forma, spiegando che la materia è in atto e la forma in potenza. Ciò significa che ogni materia, dotata di forma in atto, può sempre assumere un’altra forma in potenza. Cioè ogni realtà materiale è soggetta a modifiche ed è in evoluzione. Poiché l’uomo è anche realtà materiale, in quanto corpo e spirito, anche l’uomo potrà acquisire una forma diversa da quella attuale, ed è una realtà in evoluzione e in movimento. Inoltre se l’uomo è realtà materiale è anche finito. Tutte le modificazioni del suo stato sono possibili a partire dal presupposto che esse si svolgano nell’arco della sua esistenza. Altrettanto sottolineava Heidegger sostenendo che l’uomo fosse poter essere in quanto essere per la morte. In questa definizione, infatti, è implicita l’idea evolutiva dell’uomo che cambia, ma anche la sua finitezza. Dove l’idea del finito conduce agli a-priori kantiani dello spazio e del tempo. Max Scheler definisce l’uomo «essere illimitatamente aperto al mondo», e Arnold Gehlen parla di «poter essere». L’uomo è dotato di intelletto finito e razionale, in un carpo caduco, cioè mortale, e tutte le sue esperienze si muovono nello spazio e nel tempo. Tutte le forme di conoscenza umana sono storiche e, proprio per questo, hanno il carattere della possibilità. Tale possibilità acquisisce perciò valenza storica e filosofica ma anche biologica, oltre che scientifico-conoscitiva, nel lavoro che Gehlen pubblica nel 1940, titolandolo L’uomo. La sua natura e il suo posto nel mondo. Nel trattato antropologico in questione egli asseconda, in contrapposizione a quanto sosteneva Darwin nella sua teoria dell’evoluzione, l’idea che l’uomo, derivando dalla scimmia, avesse perso tutte le specializzazioni proprie del mondo naturale, e che tale perdita potesse essere definita in termini scientifici condizione e presupposto di ritardo, da parte dell’uomo, ad acquisire una sua propria e specifica forma mentale. Tale ritardo egli chiamava neotenia. Si può allora concludere che se la categoria ontologica dell’esistenza è il singolo, il singolo è tale in quanto possibilità e poter essere, cioè capace in potenza di realizzare il suo proprio se stesso senza alcun limite derivante da specializzazione, dunque in libertà. Caratterizzato da un certo ritardo nell’acquisire una forma specifica, e dunque neotenico.
Schema di definizione del singolo come possibilità
Aristotele
Animale razionale = sinolo di materia e forma
Max Scheler
Essere illimitatamente aperto al mondo
Arnold Gehlen
Poter essere
Heidegger
Essere per la morte = finito
UOMO
intelletto finito
corpo caduco
razionale
animale
spazio-tempo
mortale
(elementi kantiani a-priori della conoscenza)
poter essere = storicità = conoscenza limitata a-priori
spazio
tempo
Categoria della possibilità
Se l’uomo è poter essere, cioè possibilità di realizzare il se stesso più proprio in una forma non prestabilita, importa dare conto dell’emergere, nel pensiero filosofico occidentale, della categoria della possibilità. Tale categoria, che sottolinea la dispersione e l’incertezza umana, anche in ambito etico, è propria dell’esistenzialismo, ma i suoi inizi sono già rintracciabili nella rivoluzione copernicana che Kant affronta in ambito gnoseologico, per culminare, dal positivismo, nella filosofia evoluzionistica di Darwin, e perciò nell’esistenzialismo filosofico. Kant, infatti, con la scoperta delle categorie dello spazio e del tempo, abbatte le certezze della gnoseologia aristotelica. Pensare non è più cogliere la realtà oggettiva, ma interpretarla attraverso il giudizio. E ciò significa storicizzare le conoscenze per metterle in relazione all’ambiente, alle circostanze e ai vissuti del soggetto conoscente. E mentre Bacone e Galilei sovvertivano l’universo scientifico di Aristotele, Bacone sostituendo l’induzione alla deduzione sillogistica attraverso la sperimentazione empirica, Galilei ponendo al centro della conoscenza scientifica le sensate esperienze e le necessarie dimostrazioni, i Positivisti esaltavano l’idea perfettibile dell’uomo con la loro fede nel progresso scientifico, attraverso il verificazionismo. Così la comparsa dell’evoluzionismo darwiniano rappresentò la rivalsa scientifica di un’idea di adattamento in progressivi accomodamenti osmotici dell’individuo nei confronti dell’ambiente verso il fissismo di Linneo, mutuato dal creazionismo biblico. Ancora oggi è accettato l’approccio darwiniano al mondo, tanto che l’epistemologo Piaget parla di equilibrio osmotico dell’uomo, cioè di un equilibrio sempre precario e comunque mai definitivo. L’ambito del possibile, interpretato con questa valenza di instabilità e incertezza, si apre come categoria principe nell’esistenzialismo filosofico.
Rivoluzione scientifica post-rinascimentale e suoi effetti sulla gnoseologia kantiana e sul positivismo
La categoria della possibilità nasce dalla rivoluzione scientifica copernicana e dalla caduta del sistema di pensiero filosofico basato sull’Ipse dixit di aristotelica memoria. L’universo aristotelico, sia filosofico che scientifico, aveva origine dalla concezione che il posto dell’uomo fosse di assoluta centralità, non solo sulla terra ma anche nell’intero universo. Conseguenza di tale credenza era il ritenere l’uomo capace di acquisire conoscenze del tutto vere ed, in quanto tali, completamente conformi alla realtà, dunque oggettive. La scienza era perciò parimenti in grado di produrre teorie vere in assoluto, una volta per tutte, dunque non oggetto di errore, la presenza del quale avrebbe inficiato del tutto la valenza scientifica di ogni teoria come tale accreditata. Una tale concezione dell’uomo e della scienza come suo prodotto induce a pensare ad un’idea di conoscenza oggettiva, incontrovertibilmente vera, assoluta, dunque eterna. Nell’universo aristotelico, sia esso filosofico o scientifico che si voglia, manca del tutto la nozione ed il concetto di storicità, nozione che si andrà a scoprire attraverso la demolizione del suo sistema di pensiero nel corso di tutta la rivoluzione scientifica post-rinascimentale, che ha inizio con Copernico. Tale rivoluzione spazzerà via d’un sol colpo non solo il pensiero concettuale di Aristotele, ma anche e soprattutto le sue svariate interpretazioni rinascimentali. Copernico pone al centro del sistema solare il sole e non più la terra come voleva il sistema aristotelico-tolemaico, mentre Brahe sostituisce le orbite al posto delle sfere celesti materiali di Aristotele e, successivamente Keplero scopre la loro ellitticità contrapponendola alla circolarità delle sfere aristoteliche. Ma l’impulso alla svolta definitiva arriverà con Galilei, in ambito scientifico, e da Bacone, in ambito filosofico. Sia Galilei che Bacone, infatti, tra loro contemporanei, spostano l’attenzione sull’esperimento scientifico e sull’osservazione del fenomeno nella successiva ricostruzione in laboratorio, puntando all’uso di una logica di tipo induttivo, piuttosto che su deduzioni sillogistiche, con l’ausilio delle matematiche. Lo studio del particolare e la sua osservazione artificialmente riprodotta al fine di ricavarne una teoria scientifica, sostituiscono l’analisi deduttiva alla sintesi sperimentale. L’idea di Bacone espressa dal detto “scire est posse”, sapere è potere e dominio dell’uomo sulla natura, è di notevole impulso all’introduzione degli strumenti idonei e qualificati ad ottenere un risultato scientifico. L’uso delle tecniche e delle tecnologie come strumento ausiliario di ricerca sarà un’innovazione introdotta dal pensiero baconiano e da Galilei, che per primo utilizza il telescopio per i suoi studi sui corpi celesti. L’effetto di tale rivoluzione scientifica, oltre che di pensiero, determina in ambito squisitamente filosofico, da un lato l’emergere di costruzioni razionali e di sintesi sistematiche, come quelle del dubbio metodico di Cartesio, del panteismo monistico e deterministico di Spinoza o del finalismo monadico ed ottimistico di Leibniz, dall’altra favorisce il sorgere di uno scetticismo empirico e nominalistico alla Locke, Berkeley ed Hume. Il punto di incontro tra razionalismo e scetticismo empirico è proprio il criticismo kantiano. Ormai era già emersa una rinnovata fede per il progresso scientifico, e tale fede per tutto l’uomo e per le sue capacità conoscitive si sarebbe trasmessa globalmente nel positivismo di Comte e di Spencer, che guardavano alla storia dell’uomo come ad un incessante progredire delle acquisizioni scientifico-conoscitive, interpretando tutto ciò come evoluzione e sviluppo dell’umanità in crescita. Ciononostante la rivoluzione scientifica aveva anche sconvolto profondamente la pretesa di assolutismo ed oggettività in ambito gnoseologico, avendo scardinato del tutto il sistema filosofico di Aristotele. Kant, perciò, si trovò a fare i conti con una concezione della scienza radicalmente mutata: una scienza bisognosa di sostegni filosofici che compendiassero la caduta di paradigmi certi, assoluti, oggettivi ed eterni: il venir meno dei quali era già schietta dimostrazione della loro vacuità. La scienza sperimentale di Galilei e Bacone era saldamente radicata all’osservazione in un preciso momento, in un dato luogo, in condizioni particolari: era perciò strettamente connessa all’attimo specifico della riproduzione artificiale del fenomeno studiato in natura; il suo paradigma non poteva che essere storico. Come tale era la negazione dell’eternità, della oggettività, dell’assoluto. Ma se il paradigma della scienza sperimentale era la storicità, allora le strutture mentali sottostanti tale paradigma erano di necessità gli a-priori spazio-tempo. Da Kant in poi, infatti, lo spazio ed il tempo saranno considerati condizione imprescindibile per l’osservazione del fenomeno, ed ogni acquisizione scientifica sarà sempre inquadrata nel suo ambiente e nella sua storia, denotandosi con la valenza della possibilità, come valenza intrinsecamente connessa alle strutture conoscitive proprie dell’uomo.
Tavola storico-filosofica del periodo post-rinascimentale
Bacone
Empirismo
Razionalismo
(Locke-Berkeley-Hume)
(Cartesio-Spinoza-Leibniz)
convenzionalismo nominalismo scetticismo
meccanicismo monismo finalismo
criticismo kantiano (a-priori spazio-tempo)
Illuminismo (ragione)
Idealismo (spirito) (Fichte-Schelling-Hegel)
Positivismo (razionalità positiva) (Comte e Spencer)
Evoluzionismo (progresso) (Darwin)
Esistenzialismo (esistenza come apertura) (Kierkegaard)
Possibilità
Singolo
scelta o angoscia
Schema della Rivoluzione scientifica post-rinascimentale
Copernico De revolutionibus 1543
Il sole è al centro del sistema solare
Brahe
Sostituisce le orbite alle sfere materiali; la terra è al centro del sistema solare
Keplero
Le orbite sono ellittiche e non circolari
Galilei Sidereus nuncius 1610; Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo 1632
Uso del telescopio. Cade l’aristotelismo. Non c’è distinzione tra la costituzione naturale del mondo celeste e del mondo terrestre. Ogni moto è relativo: non esiste un motore immobile. Lo stato di quiete e di moto sono persistenti (vedi leggi sul pendolo). La forza non produce moto ma accelerazione (principio di inerzia). Il moto è possibile nel vuoto. Il sapere scientifico parte dall’esperimento e dalla sua osservazione. La scienza descrive la realtà. Sensate esperienze e necessarie dimostrazioni.
Newton Principia mathematica 1687
Teoria corpuscolare della luce contro teoria ondulatoria di Huygens (1629-1695). Semplicità ed uniformità ontologica della natura. Il mondo è una macchina. Tempo e spazio sono assoluti. Legge di gravitazione universale: la forza gravitazionale è direttamente proporzionale al prodotto delle masse ed inversamente proporzionale al quadrato delle loro distanze. Nasce la meccanica classica: legge di inerzia – cambiamento di stato (velocità ed accelerazione) – azione e reazione. Calcolo infinitesimale: piccole variazioni di grandezza – rapporti = derivate; somme = integrali. La retta è la traiettoria di un punto.
Schema dell’evoluzionismo darwiniano
Darwin L’origine della specie 1859
Evoluzionismo
Organismi unicellulari (procarioti)
Organismo pluricellulari (eucarioti: ameba e paramecio)
Esseri viventi (flora-fauna-uomo)
Scimmia
Uomo
Selezione naturale
Sopravvivono le specie viventi che hanno accumulato, nel tempo, tutte le mutazioni genetiche necessarie a quell’ambiente.
Adattamento
Teorie concernenti l’idea di origine della specie
Evoluzionismo di Darwin
Concetto di neotenia di Arnold Gehlen
(mitiga il concetto di evoluzionismo di Darwin)
Creazionismo biblico
(fissismo) Linneo (1707-1778)
La possibilità nell’esistenzialismo filosofico di Kierkegaard
Libertà ed eticità del singolo nella scelta
L’emergere della categoria della possibilità mutua la sua origine dalla rivoluzione scientifico-copernicana, e dalla interpretazione che di questa ne fa Kant, in ambito squisitamente filosofico-conoscitivo, storicizzando le acquisizioni umane; ma deriva al contempo anche dalla nascita del positivismo e dell’evoluzionismo darwiniano, che rappresentavano gli effetti a lungo termine espressi da tale rivoluzione scientifica. Infatti, tra la rivoluzione scientifico-copernicana e la sua interpretazione kantiana, ed il positivismo filosofico come precondizione dell’evoluzionismo darwiniano vi è, storicamente, tutto il Romanticismo idealistico che condiziona l’interpretazione della rivoluzione scientifica nel pensiero positivistico ed evoluzionistico e, conseguentemente, in tutto l’esistenzialismo filosofico che di tali precedenti filosofie è il prodotto storico. Culturalmente, infatti, il Romanticismo rappresenta la caduta della concezione enciclopedica del sapere, ancora di stampo aristotelico, insieme al crollo di una concezione razionale ed organicistica della realtà, prima ritenuta conoscibile in toto nella sua oggettività. E tutto questo avviene sia attraverso la storicizzazione delle conoscenze, sia attraverso la specializzazione delle varie branche del sapere che sempre più si andavano emancipando dalla filosofia per ricercare un’impostazione metodologica del tutto autonoma, nello statuto scientifico, da quella disciplina. Al tempo stesso l’uomo del romanticismo è l’espressione più completa della contraddizione esistente tra l’aspirazione a grandi ideali e la caduta di certezze, facendosi perciò simbolo di uno smarrimento storico e nostalgico nei confronti del passato e di illusori vagheggiamenti tanto più fallaci quanto più aspro si faceva il confronto con la realtà. Questo concerto di sentimenti, oltre che di conoscenze filosofiche e storico-scientifiche, eredita completamente l’esistenzialismo, che interpreta la categoria della possibilità come sua categoria per eccellenza. La novità del pensiero di Kierkegaard, padre dell’esistenzialismo filosofico, rispetto agli altri pensatori facenti parte della stessa temperie culturale, è tutta nel recupero di un’immagine integrale dell’uomo e del singolo, che muove da un’interpretazione etica e morale di quella categoria del possibile, e che dirigendosi in tale direzione permea di sé tutta la concezione umanistica che gli è propria e che, come tale, trasmette: l’uomo, e tutte le forme di conoscenza che pretendano di tenere in considerazione l’uomo, non possono più essere scisse dalla concezione del singolo come soggetto morale ed etico, in funzione del fatto che agisce. La possibilità viene allora interpretata come caratteristica propria del singolo ed al tempo stesso come precondizione della sua libertà, cioè del suo agire morale. Una concezione deterministica parmenidea dell’uomo, come era quella espressa dall’idealismo hegeliano preclude, infatti, ogni possibilità all’agire morale del singolo, i comportamenti del quale, perché possano essere detti propri dell’agire etico, devono presupporre la libertà come libertà di scelta. Ma la possibilità è fonte di vertigine e smarrimento per l’uomo il quale, di fronte alla responsabilità della propria coscienza nei confronti della sua libertà, dunque della sua possibilità, che in quanto tale è anche possibilità del nulla, oltre che possibilità dell’essere (come pienezza dell’agire morale, fonte di valori), genera il sentimento dell’angoscia. L’angoscia, dunque, come possibilità del nulla se non si tramuta in scelta, genera a sua volta un circolo vizioso che porta l’individuo alla disperazione. Kierkegaard propone, perciò, un antidoto alla disperazione nella decisione e nella scelta. Egli intravede tre possibili stili di vita: quello estetico del Don Giovanni che vive alla giornata, quello etico di chi predilige la progettualità morale propria della scelta matrimoniale, ed infine quello religioso di Abramo, il quale è disposto a sacrificare il figlio, dunque a ribellarsi alla legge etica, pur di non disobbedire al suo Dio. Tra i tre possibili stili di vita, dice Kierkegaard, bisogna operare una scelta, e tale scelta è portata a termine con il criterio della selezione dello stile a ciascuno più confacente: la dialettica della scelta è, perciò, quella dell’aut-aut, perché un tipo di vita esclude automaticamente un altro. Ma il recupero integrale dell’uomo è, nell’umanesimo di Kierkegaard, nella scelta che egli propone imprescindibilmente per salvare il singolo dalla disperazione. Tale scelta è quella dell’ideale di vita religiosa, che Kierkegaard interpreta come la vera scelta radicale e rischiosa per l’uomo: scelta che lo rimette sempre in discussione come singolo davanti alla possibilità del peccato e della caduta. La radicalità dell’umanesimo di Kierkegaard, rispetto a tutti gli altri pensatori esistenzialisti è tutta in questa riscoperta integrale dell’uomo come singolo davanti a Dio, proprio perché espressione di tale possibilità di caduta e di ripresa, che si realizzano costantemente nella concezione etica e morale della vita umana, libera di scegliere tra valori e disvalori, o addirittura di non scegliere, nella paralisi prodotta dalla vertigine della propria umanità come fragile e finita possibilità di potere. La morale che ne deriva non è quindi un intellettualismo socratico, fatto dai razionalisti alla Spinoza; né una morale di tipo formale, come quella di Kant; ma è una morale in cui tutte le potenzialità filosofiche e di pensiero sono espresse nella considerazione per quel recupero dell’integralità umana come corpo e spirito, più vicina all’umanesimo sofferto e profondo delle Confessioni di S. Agostino, e proprio per questo tanto più intimamente ispirata alla lettera dell’insegnamento evangelico.
Schema della possibilità nell’esistenzialismo di Kierkegaard (1813-1855)
singolo
libertà
possibilità = angoscia
disperazione (peccato – caduta)
scelta
vita estetica
Aut
vita etica
dialettica della responsabilità
vita religiosa
Aut
rischio di rimettersi sempre in discussione
Categoria della scelta nella morale cattolica
Opzione fondamentale e scelta deliberata
«La riflessione razionale e l’esperienza quotidiana dimostrano le debolezze da cui è segnata la libertà dell’uomo. È libertà reale, ma finita: non ha il suo punto di partenza assoluto e incondizionato in se stessa, ma nell’esistenza dentro cui si trova e che rappresenta per essa, nello stesso tempo, un limite ed una possibilità. È la libertà di una creatura, ossia una libertà donata, da accogliere come un germe e da far maturare con responsabilità. È parte costitutiva di quell’immagine creaturale, che fonda la dignità della persona…È insieme inalienabile auto possesso e apertura universale ad ogni esistente, nell’uscita da sé verso la conoscenza e l’amore dell’altro…Ragione ed esperienza dicono non solo la debolezza della libertà umana, ma anche il suo dramma. L’uomo scopre che la sua libertà è misteriosamente inclinata a tradire questa apertura al Vero e al Bene e che troppo spesso, di fatto, egli preferisce scegliere beni finiti, limitati ed effimeri. Ancor più, dentro gli errori e le scelte negative, l’uomo avverte l’origine di una ribellione radicale, che lo porta a rifiutare la Verità e il Bene per erigersi a principio assoluto di se stesso: “Voi diventerete come Dio” (Gn 3,5)». Denso di significato e molto profondo è questo passo dell’Enciclica di Papa Giovanni Paolo II Veritatis Splendor, che mette in esaltata evidenza quella dispersione dell’uomo contemporaneo nell’esercizio della sua libertà, già ampiamente sottolineata e scientificamente e filosoficamente comprovata. Il problema emergente è, difatti, proprio quello dell’uso razionale che ciascuno dovrebbe fare dei meccanismi di scelta in ambito morale. Il superamento dell’angoscia esistenziale è nella scelta, ma la possibilità di ricaduta nel circolo vizioso della disperazione è, per l’uomo, sempre in agguato finché non divenga capace di gestire la sua possibilità di scelta morale dentro un sistema ben consolidato di valori. Ciononostante è sempre probabile la scelta errata, sia per ignoranza sia per consapevole decisione, ma qualora si riproponga la domanda sul senso dell’esistenza è necessario imprimere nel singolo la consapevolezza della sua propria responsabilità, ed il peso che da tale responsabilità deriva. Tutta la lettera Enciclica prende, infatti, proprio spunto dalla domanda fondante e fondamentale che il giovane ricco fa, sul senso della propria esistenza, a Gesù. La risposta che gli viene offerta dal Maestro è di rispettare i comandamenti e, dopo aver abbandonato tutti i suoi averi per darli ai poveri, di seguirlo. Ma il giovane va via. L’insegnamento che giunge da questo brano del Vangelo, e dalla sua analisi fatta dal Papa nell’Enciclica, è per tutti identico, e si risolve nel comandamento principe di ogni cattolico “ama il prossimo tuo come te stesso”. La strada per seguire Cristo è, perciò, una strada tutta in salita, nella quale davvero si tratta di porre la propria libertà al servizio di principi più alti da cui discendono tutti gli altri valori morali. Il rispetto per l’integrità della vita, ed il rispetto per la vita in se stessa, come valore, insieme al rispetto per la dignità di ogni uomo e per la sua alterità, che è già contenuta nella soggettività del singolo, in quanto uomo, sono i primi principi da assumere come postulati nell’esercizio della libertà individuale. Sono, cioè, gli elementi cardine che costituiscono l’opzione fondamentale tra l’insieme delle scelte possibili per l’uomo. Ma il Papa così continua nell’Enciclica «…le scienze umane hanno giustamente attirato l’attenzione sui condizionamenti di ordine psicologico e sociale, che pesano sull’esercizio della libertà umana…». Tale constatazione, peraltro assai esatta dal punto di vista filosofico, ha portato alcuni a negare la libertà dell’uomo, interpretando la sua storia in un contesto provvidenziale o destinale, altri a propendere per uno scetticismo morale che ha avvalorato, per le scelte cosiddette deliberate, un insieme di atteggiamenti relativistici, variabili di volta in volta in relazione alle situazioni e alle caratteristiche del soggetto morale agente. Ben consapevole di tale degenerazione morale, i cui effetti sono peraltro sotto gli occhi di tutti, riverberati come sono in ambiti tra loro più disparati, il Papa richiama nell’Enciclica tutti i cattolici a confermare, anche nelle scelte deliberate, quell’opzione fondamentale della morale cattolica, che si rifà al sistema di valori, basati sul rispetto della vita e di tutti gli uomini in generale. Costanti si fanno, nel corso della Lettera, i riferimenti a questo insieme di valori, la cui profondità è nell’appartenere, prima che ad una morale di tipo cattolico, ad una legge naturale impressa nell’uomo ed in tutti gli uomini come tali. L’integrità della persona è fatta salva dal considerare ogni uomo un fine costante dell’agire morale, mai un mezzo o uno strumento atto al conseguimento di una finalità estrinseca a quella primaria del rispetto per la dignità del singolo e per la sua individuale alterità. Emerge dal discorso del Papa un’altissima considerazione per l’uomo come tale, per le sue possibilità di agire nel bene, e per la sua debolezza nell’operare il male, insieme al grande amore di dio nel perdono e nella redenzione. Il singolo, con le sue strutturali debolezze e con la sua umana grandezza, acquista proporzioni titaniche nell’agire morale, perché in esso solo trova la conferma della sua libertà finita e limitata, nel cui angusto spazio si apre lo spiraglio dell’incontro e del dialogo costruttivo con l’altro da sé. La possibilità dell’incontro dialogico con l’altro si muove sul terreno dell’azione morale e sul riconoscimento di sé nell’altro. L’antidoto all’angoscia è, in questa prospettiva, un avvicinarsi all’altro da sé attraverso i valori della comunicazione, della partecipazione e della solidarietà. L’esercizio di tali valori porta a lenire l’angoscia della solitudine e dell’abbandono a se stessi, perché riempie di significato il sé di ognuno e valorizza quella ricerca costante di forma per il se stesso più proprio del singolo, che non è uomo se non in quanto relazione e socialità all’altro.
Solitudine dell’uomo e scelta dei disvalori
Si è visto come il progredire della scienza, in quanto investigazione sperimentale del fenomeno, abbia avvalorato anche l’introduzione delle tecnologie come strumenti idonei a facilitare lo studio della natura. Purtroppo, l’uso indiscriminato ed irrazionale di tali ritrovati della tecnica, ha finito con l’accrescere il disordine esistenziale dell’uomo, anziché diminuirlo. L’idea di sapere come potere dell’uomo sulla natura è diventata tutt’uno con la presunzione di dominare e di creare una natura artificiosa da parte dell’uomo stesso. Inoltre, gli interventi dell’uomo sulla natura, posti al servizio di false idee politiche ed economiche rivolte ad un capitalismo selvaggio, erroneamente, o in mala fede, ritenuto fonte di benessere per tutti, ha aumentato l’entropia del sistema ecologico, riversando tale disordine anche sulla psicologia del sociale. La nobile idea di scienza come prodotto dell’intelligenza umana nella tecnica, di cui però resta sovrano e soggetto principe l’uomo, ha finito col soccombere dinanzi ad un progresso tumultuoso e trascinante di cui l’uomo stesso è divenuto l’oggetto passivo. L’evoluzione della storia è, così, diventata un accelerato susseguirsi di eventi cui nessuno più riesce a darsi una spiegazione razionale e serena, ma che tutti più o meno subiscono, come se fosse prodotto di qualche esistenza sconosciuta e aliena. Questo aumento della velocità delle informazioni e della produzione dell’uomo, a tutti i livelli, siano essi politici, economici, culturali, ha significato una progressiva perdita del senso dell’agire morale, intimamente connesso ad ogni atto produttivo. Determinando, parimenti, una perdita del senso della verità, significando, l’aumento di velocità, una diminuzione accelerata della domanda sul senso. La ricerca della verità dell’agire morale si è squalificata di pari passo con questa perdita del senso, invischiata da una mole emergente di informazioni, vuote di contenuti reali. La corsa accelerata di ognuno verso mete non ben definite, in vista di un accrescimento delle risorse economiche private, a discapito di qualsivoglia ordine e rispetto per se stessi prima che per gli altri; lo smodato ravvolgersi nella quotidianità, in vista del successo e della notorietà personale; il mito di un’America da raggiungere, sia pur idealmente, svuotano di significato ogni domanda sul senso, mentre nessuno si chiede più perché. Ed in tanto correre dispendioso di energie, ma generoso e magnanimo di stress, depressione, ed angoscia, si consumano giornalmente i delitti contro il rispetto della vita e l’alterità dell’altro. Quando poi ci si ferma un solo attimo non è difficile capire come un’esistenza così vuota e superficiale sia destinata a consumarsi in solitudine. E le persone che ne soffrono di più non sono gli affaccendati manager di successo, o l’uomo di mezza età. Le classi sociali costrette a subire gli effetti di questa vergognosa parodia del progresso contemporaneo sono quelle che, per fascia di età, non sono in grado di tener testa a tanta gloriosa avanzata di eroi in accelerazione. Sono, perciò, i bambini, con i loro ritmi di crescita rallentati, e gli anziani, che quell’accelerazione hanno perso. Ma sono anche i giovani, con le loro noiose domande sul senso, per capire la contraddizione in cui si avviluppa la contemporaneità. Un progresso ignobile è questo che non consente di capire, pretendendo di trascinare; un progresso di cui diffidare perché si ammanta di facili sogni e di chimere, privando l’uomo di valori di solidarietà, rubando alla scienza la sua verità, spezzando il circolo della comprensione, per ottenere il consenso. Ma soprattutto un falso progresso che, in nome di una falsa scienza asservita all’uso immorale delle tecnologie, dimentica l’uomo come persona, l’uomo fonte di valori; calpesta il rispetto per la vita e la dignità, esaltando del poter-essere del singolo l’aspetto più deleterio della caduta di sé, della perdita di sé come possibilità di agire per l’uomo e per la sua totalità. Questo è il mondo dei disvalori: il nulla e la contraddizione senza giustificazione; svuotamento del senso e della domanda fondante sul senso; corsa accelerata ed impazzita al profitto, al traguardo sociale; noncuranza dimentica dell’altro. Il rappresentante di questa categoria pensa «la vita vale nulla». L’aggancio all’infinito è stato spezzato, l’uomo è precipitato nel suo abbandono, e la solitudine che ne discende è solo un suo insignificante corollario.
Corso di Scienze umane e sociologiche
Dispense del corso monografico “L’uomo come possibilità e scelta tra valori e disvalori”, tenuto dalla Prof.ssa Antonietta Pistone presso l’Università della terza età di Foggia, durante l’anno accademico 1993-1994
BIBLIOGRAFIA
1. Arnold Gehlen, L’uomo, Feltrinelli editore, Milano 1983
2. Emanuele Severino, La filosofia contemporanea, Biblioteca universale Rizzoli S.P.A., Milano 1992
3. Giovanni Reale, Dario Antiseri, Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi, Editrice La Scuola, Brescia 1983
4. Lettera Enciclica di S.S. Giovanni Paolo II, Veritatis Splendor, Edizioni Piemme, Casale Monferrato (AL) 1993
EPICURO, LETTERA SULLA FELICITÀ A MENECEO
di Antonietta Pistone
La filosofia è ricerca di verità. Ma uno dei compiti fondamentali della euristica filosofica riguarda l’individuazione di mezzi e strumenti per raggiungere la felicità. La religione, come tecnica di salvezza e di rassicurazione per l’uomo, rappresenta una delle metodiche finalizzate a garantire il benessere dell’animo e la pace interiore. La religione, che non sia però intesa necessariamente come fede nell’esistenza di un solo dio, di un’anima immortale, o di una morale simile a quella della tradizione cattolica. Riconosciuta piuttosto come possibilità di liberazione e di rifugio, come farmaco per la guarigione dei mali dell’anima. «Mai si è troppo giovani o troppo vecchi per la conoscenza della felicità»[1], con queste parole comincia la Lettera sulla felicità che Epicuro scrive a Meneceo, per parlargli della filosofia come quadrifarmaco, contro la paura degli dei e della morte, del dolore e del piacere, che risulta essere il solo fine della ricerca filosofica in grado di assicurare benessere all’uomo. La felicità risulta un compito doveroso per giovani e vecchi, perché non esiste un’età per essere felici, ma anche e soprattutto perché l’aspirazione alla gioia dovrebbe comprendere l’intero segmento esistenziale, accompagnandolo dalla nascita al momento del suo tragico epilogo, con la morte. La letizia, però, non è solo ricerca, ma anche conoscenza delle cose che la rendono possibile ed attuale, e che determinano quel senso di compiutezza, che fa percepire il possesso di ogni bene, oltre il quale tutto è privo di senso e di valore. È poi bene essere appagati perché il ricordo delle gioie passate è sempre capace di riempire il presente che sia meno gaio di quello. Ma anche l’attesa, l’aspettativa della gratificazione, conferiscono uno scopo significativo per la vita dell’uomo che, altrimenti, non avrebbe valori imperituri cui ispirarsi. I giovani che vivono nell’aspettativa della contentezza, si irrobustiscono e fortificano nello spirito, perché conducono un’esistenza di speranza e di fede nel futuro, che li invita a gioire delle esperienze di vita che fanno in tenera età. Gli anziani, invece, possono contare su un cospicuo bagaglio di bei ricordi, che li fa sentire giovani anche quando il tempo della spensieratezza è ormai trascorso. «Considera l’essenza del divino materia eterna e felice, come rettamente suggerisce la nozione di divinità che ci è innata»(pag.7), continua poi Epicuro, a voler significare che non ci può essere felicità che non passi per le questioni concernenti le nozioni di divino e di divinità, e per di più esprimendosi esplicitamente a favore di una concezione innatista di tale ente noumenico. La divinità rappresenta il livello eccelso di beatitudine pensabile. Quando si pensi ad essa, non ci si può discostare dall’immaginarla come dotata di tutte le caratteristiche simili a quelle di qualunque altro essere vivente, solo massimamente amplificate e rese superlative dalla condizione di esultanza e giubilo che le accompagna. Epicuro, pur rifiutando la fede monoteistica in un solo dio, confida nell’esistenza degli dei, «Gli dei esistono, è evidente a tutti, ma non sono come crede la gente comune, la quale è portata a tradire sempre la nozione innata che ne ha»(pag.7). E ritiene questa loro esistenza evidente a tutti, per il solo fatto che non c’è uomo che non la creda possibile, a partire dalla convinzione innata del divino, profondamente radicata nella coscienza di ciascuno. Essere religiosi, per Epicuro, vuol dire essere profondamente certi della evidenza e della sostanziale profondità dell’idea infusa del divino. Comprendere la naturalità del senso religioso, che è un comune intuire riguardo alla domanda concernente la divinità, ed emergente nella coscienza di ogni uomo. Avere consapevolezza che non ci sia essere umano al mondo che non si ponga, prima o poi, questo sconcertante interrogativo. Al quale si risponde sempre con l’ammissione della certezza istintiva di un senso religioso del divino, prorompente ed inquietante. Al contrario, l’accettazione incondizionata ed indiscussa delle tradizioni popolari non vuol dire affatto essere religiosi. Perciò religioso è colui che riconosce e accetta in sé questo senso della divinità come connaturato. Gli dei non possono nuocere all’uomo, perché vivono negli intermundia, lontani dai problemi della vita terrena, e si gloriano costantemente del loro stato di assoluto e perfetto compiacimento. Perciò, non avendo bisogno di nulla, non hanno necessità di arrecare danno ad alcuno degli umani, completamente indifferenti come sono alle vicende che li vedono coinvolti. E simpatizzano solo con i loro stessi simili, cioè con le altre divinità. E nemmeno la morte, esperienza irreversibile e assai temuta dagli uomini, può far loro alcun male. Godere e soffrire sono disposizioni dell’animo che sente. Mentre la morte si pone come la risolutiva negazione di ogni sentire, perché ne costituisce l’assenza assoluta. La morte, per l’uomo, è nulla. Perché quando lei subentra, l’uomo non è più. «La morte, il più atroce dunque di tutti i mali, non esiste per noi. Quando noi viviamo la morte non c’è, quando c’è lei non ci siamo noi. Non è nulla né per i vivi né per i morti. Per i vivi non c’è, i morti non sono più»(pag.9). L’uomo saggio accetta la morte serenamente, così come ha vissuto. E se la vita non è per lui un male, non sarà un male nemmeno il morire. Piuttosto che scegliere per sé il tempo più lungo, sceglierà quello più dolce. Nella consapevolezza che il bene più grande sia sempre la vita. Il vecchio, perciò, dovrà amarla quanto il giovane, e non desiderare la morte perché ormai sente il suo tempo approssimarsi alla fine. La vita è sempre ricolma di dolcezza, e soprattutto il vivere costituisce un’esperienza unica ed irripetibile. Chi poi non sia affatto soddisfatto della vita, può liberamente scegliere di darsi la morte. Epicuro accetta la possibilità del suicidio, ma solo per colui il quale abbia compreso che non vi è alternativa immaginabile ad un esistere riconosciuto ormai come un non senso, perché non più corrispondente alle personali aspirazioni dell’essere umano. Se, invece, si decide al contrario di vivere, allora è necessario adoperarsi per la vita sino in fondo. «Ricordiamo poi che il futuro non è del tutto nostro, ma neanche del tutto non nostro»(pag.11). Il destino dell’uomo è, in qualche modo segnato, ma ci sono dei margini di libertà, che sono lasciati alla emancipata determinazione della sua scelta. Come il vivere, il vivere bene, o il decidere di farla finita, nella convinzione che la vita non valga la pena di essere vissuta fino in fondo e con coerenza. Così l’uomo può desiderare autonomamente. Ma tra i desideri possibili solo alcuni sono naturali, e corrispondono a quelli necessari, mentre i restanti sono inutili. E senz’altro tra i desideri necessari vi è quello fondamentale alla felicità, al benessere fisico, e alla stessa vita. Vivere pienamente, cioè, è la stessa cosa che stare bene ed essere felici. Una vita che non contempli lo stato di benessere psico-fisico non è una vita probamente spesa. Soprattutto, è giusto che vi sia una buona conoscenza dei desideri, perché ogni scelta operata dall’uomo finisca per armonizzarsi con lo stare bene nel corpo e con la serenità dell’animo. Chi non conosce profondamente il valore dei desideri umani, non è nemmeno capace di assecondarli e di gestirli al meglio. Fine dell’agire è il raggiungimento del piacere, e l’evitamento del male, della sofferenza e dell’ansia. Nella condizione di serenità ogni turbamento interiore cessa di esistere, e lo stato di calma procura beneficio anche al corpo. La sofferenza che si prova è chiara testimonianza dell’assenza di piacere, che muove al bisogno. Quando non si soffre vuol dire che c’è il godimento. «Per questo noi riteniamo il piacere principio e fine della vita felice, perché lo abbiamo riconosciuto bene primo e a noi congenito. Ad esso ci ispiriamo per ogni atto di scelta o di rifiuto, e scegliamo ogni bene in base al sentimento del piacere e del dolore»(pag.13). Piacere e dolore sono i due estremi entro i quali si estrinseca e determina l’esistenza umana. Al fine di evitare il dolore ogni uomo agirà per procurarsi il piacere, il cui primo livello è determinato dall’abbandono della condizione di sofferenza precedentemente provata. Ogni piacere è un bene in sé, in quanto allontana dal dolore, ma non per questo ogni piacere è da ritenersi, in ogni caso, preferibile. Va operata la distinzione tra piaceri necessari e piaceri inutili, che sono da ritenersi superflui al raggiungimento dello stato di benessere e di felicità. Allo stesso modo ogni dolore è un male, ma non per questo ogni dolore è, necessariamente, da fuggire. Spesso ciò che, apparentemente, sembra essere un bene, si rivela poi un male. E viceversa, ciò che appare un male, dimostra successivamente di essere un bene. Una delle condizioni che contribuiscono al raggiungimento della felicità è l’affrancamento dai bisogni, sia per imparare ad accontentarsi di poco, sia per apprezzare e godere di quello che si ha. «I sapori semplici danno lo stesso piacere dei più raffinati, l’acqua e un pezzo di pane fanno il piacere più pieno a chi ne manca. Saper vivere di poco non solo porta salute e ci fa privi d’apprensione verso i bisogni della vita ma anche, quando ad intervalli ci capita di menare un’esistenza ricca, ci fa apprezzare meglio questa condizione e ci rende indifferenti verso gli scherzi della sorte»(pag.16 e seg.). Pare qui di intuire lo spirito precursore della semplicità francescana del vivere. Basta poco per essere felici, perché le cose davvero indispensabili sono facilmente reperibili, al contrario di quelle superflue. L’importante è imparare a godere di quei valori semplici, primitivi, ma immortali, che rendono l’uomo avvezzo al minimo, e grande estimatore del molto. Perché chi non sia abituato ad uno stile spartano di vita, non si forgia nella durezza, ed è anche incapace di apprezzare gli agi delle comodità, quando questi a lui si presentassero. Il piacere di cui parla Epicuro non è quello dei goderecci. La prima forma di piacere è l’allontanamento del dolore causato dalle paure più diffuse dell’uomo, come quella degli dei e della morte. Secondariamente il piacere consiste in ciò che aiuta il corpo a vivere meglio, assicurandosi quella condizione di benessere psico-fisico, indispensabile ad un sereno svolgersi dell’esistenza umana senza traumi e lacerazioni interiori. Quindi, tutto «quanto aiuta il corpo a non soffrire e l’animo a essere sereno»(pag.17). E a discernere rettamente le cause della scelta e del rifiuto, attraverso l’intelligenza delle cose, che si apprende, e che è arte superiore anche alla stessa filosofia. Difatti essa è madre di tutte le virtù, e realizza che non si dà vita felice che non sia anche intelligente, bella, giusta, virtuosa. Perché è felice l’uomo giusto e virtuoso. Riemerge, in questo tratto della lettera di Epicuro, l’intellettualismo socratico che ha caratterizzato di sé tutta la filosofia antica. Il pensiero cristiano segna poi la svolta definitiva, attraverso l’affermazione della scelta morale libera, e nient’affatto condizionata dal sapere e dalla conoscenza umana del bene. «Chi suscita più ammirazione di colui che ha un’opinione corretta e reverente riguardo agli dei, nessun timore della morte, chiara coscienza del senso della natura, che tutti i beni che realmente servono sono facilmente procacciabili, che i mali se affliggono duramente affliggono per poco, altrimenti se lo fanno a lungo vuol dire che si possono sopportare?»(pag.19). L’uomo saggio è colui che accetta il senso del divino che è innato in ognuno. È colui che sa che proprio questo vuol dire essere profondamente religiosi. Ed è perciò, colui il quale è consapevole che la religiosità sia patrimonio naturale universale ed irrinunciabile per gli uomini di tutti i tempi storici e di tutte le latitudini geografiche. Ma proprio perché saggio, è anche colui che riconosce il mancato fondamento della paura degli dei, che vivono lontani dall’uomo e indifferenti alla sua sorte. E nega ad un tempo il timore della morte, che subentra alla vita, nel momento in cui questa cessa di essere, annullando anche ogni dolore esistenziale. Il saggio è il filosofo che riconosce come prioritaria la ricerca del piacere, intesa come superamento delle umane paure, poi come evitamento del dolore, che non è nulla, in quanto se dura molto è sopportabile, se dura poco ed è intenso conduce alla morte, che è assenza di ogni forma di sentire. «Questo genere d’uomo sa anche che è vana opinione credere il fato padrone di tutto, come fanno alcuni, perché le cose accadono o per necessità, o per arbitrio della fortuna, o per arbitrio nostro. La necessità è irresponsabile, la fortuna instabile, invece il nostro arbitrio è libero, per questo può meritarsi il biasimo e la lode»(pag.19). Epicuro crede al destino fino ad un certo punto; ma gli preferisce senz’altro il volere degli dei e la libertà dell’uomo. E fa capire che l’agire morale può incidere sull’andamento degli eventi in modo significativo. Ed è perciò utile che l’uomo saggio sia consapevole di questa possibilità che ha di modificare la sua propria vita, compiendo scelte morali lungimiranti e virtuose, che lo allontanino dallo spettro del dolore, inteso qui come necessaria conseguenza del male morale. Leibniz nella Teodicea riprenderà esattamente questa distinzione tra male metafisico, che è connaturato al limite insito nell’esistenza umana finita; male fisico, che è originato dal dolore e dalla malattia; male morale, che deriva direttamente dalle cattive scelte operate dall’uomo, e che a sua volta può determinare conseguenze rilevanti nel riprodurre se stesso anche sul piano del male fisico. «Piuttosto che essere schiavi del destino dei fisici, era meglio allora credere ai racconti degli dei, che almeno offrono la speranza di placarli con le preghiere, invece dell’atroce, inflessibile necessità»(pag. 19 e seg.), continua Epicuro. E invita l’uomo a conseguire l’arte della saggezza, meditandola come esposta sin qui, per vivere come un immortale tra i mortali, come un dio, perché «non sembra più nemmeno mortale l’uomo che vive fra beni immortali»(pag.21). È ovvio che i beni immortali di cui si parla sono i frutti dello spirito e della saggezza, che si tramutano in virtù imperiture, le sole capaci di sollevare l’uomo al di sopra delle passioni terrene, e di renderlo simile ad un dio, senza paure, libero, capace di gioire e di godere dei beni della vita, felice, in una parola. Una felicità impossibile da conseguire, per Epicuro, senza il ricorso alla religione. Che risponde, ad un tempo, al bisogno di infondere all’uomo certezze, e alla necessità di procurare un appagamento stabile, inteso nella forma di un piacere duraturo. Simile senso del divino si ritroverà poi in Feuerbach, nei suoi studi sulla essenza del cristianesimo e della religione naturale.
[1] Epicuro, Lettera sulla felicità a Meneceo, Millelire Stampa Alternativa Marcello Baraghini, Roma 1992, pag. 5
LA CONCEZIONE DELL’ANIMA IMMORTALE ED ETERNA NEL FEDRO DI PLATONE
di Antonietta Pistone
I discorsi sulla religione hanno sempre contemplato riflessioni più o meno profonde sull’idea del divino e dell’anima. Platone, nel Fedro, una delle sue ultime opere scritte prima delle Leggi con il Simposio e il Fedone, affronta il problema del sentire spirituale e dell’eros, imprescindibili elementi di congiunzione tra l’umano e l’ultrasensibile, entro una concezione immortale ed eterna dell’anima stessa. Il Fedro, conosciuto come uno dei dialoghi sull’amore, in realtà affronta il problema della conoscenza, della scrittura e dell’arte, attraverso il mito della biga alata, quello di Theuth e delle cicale. Per la natura particolare dell’amore platonico, l’opera si occupa prevalentemente delle realtà dello spirito e del divino, strettamente connesse al sentimento erotico. Anche l’ambientazione del Fedro si presenta differente da quella di tutti gli altri dialoghi, sempre svolti entro le mura della città di Atene, ad eccezione delle Leggi, che hanno come loro teatro naturale lo scenario dell’isola di Creta. Il dialogo in questione vede Socrate allontanarsi fuori della città, verso l’abitato campestre, e isolarsi con il suo interlocutore, Fedro appunto, per poter speculare nel silenzio e nel mistero della natura su argomenti che meritano una riflessione accorta, perché fondamentali per indicare un senso e una direzione alla vita dell’uomo. L’atmosfera insolita sottolinea la ricerca del rapporto con dio, per essere pieni di lui, invasati della presenza spirituale del divino, condizione che in greco viene indicata con la parola enthousiasmòs. Solo il recupero del divino, difatti, può indirizzare la vita dell’uomo, che non si può sottrarre al valore dell’interiorità. Donde la conseguente nobilitazione dell’eros «battistrada verso le idee»[1]. È come se ci si mettesse in ascolto, in attesa della rivelazione, perché lo spirito possa poi parlare alla coscienza e dettare parole che sono espressione immediata della inequivocabile sua potenza. Così Socrate si apre al messaggio di dio, per poterlo poi successivamente enunciare a sua volta al compagno di verità. Nel Fedro Platone esprime la concezione tripartita dell’anima già chiaramente configurata nella Repubblica[2], in cui si era parlato delle tre facoltà dello spirito umano. L’anima razionale, irascibile e concupiscibile, è qui raffigurata come un carro alato, la biga, guidato dal suo auriga, che ha l’ingrato compito di tenere a bada due cavalli, uno bianco ed uno nero, espressione delle passioni intellettuali e sensibili, che hanno la capacità di trascinare il carro ora troppo in alto, verso il cielo, ora troppo in basso, facendolo precipitare sulla terra. Compito dell’auriga è tenere in equilibrio i due cavalli, e le passioni dell’anima, perché la biga possa procedere dritta, e senza scossoni, sempre in avanti. L’esposizione del concetto di eternità dell’anima, unitamente a quello della sua immortalità, narrato nel mito della biga alata, fornisce un sicuro sostegno alla dottrina dell’anamnesi, che si pone a fondamento dell’innatismo pedagogico di Platone. Di modo che, l’immortalità dell’anima e la reminiscenza finiscono per giustificarsi a vicenda, provando come sia impossibile distinguere la religiosità platonica dalla sua filosofia dell’educazione. La concezione tripartita dell’anima ha una ricaduta non meno rilevante per la teoria dello stato giusto, espressa nella Repubblica[3] attraverso il mito dei figli della terra. Qui addirittura le tre anime diventano simbolo delle tre classi sociali riconosciute in quella dei filosofi, la classe aurea che esprime la guida formativa e politica razionale; dei guerrieri, la classe d’argento che rappresenta la virtù del coraggio; e dei produttori, la classe di bronzo, espressione della temperanza tra le passioni. La spiritualità immortale ed eterna che Platone riconosce all’uomo, diventa così inevitabilmente condizione della concezione pedagogica ed educativa, ed al contempo manifestazione certa della ideologia politica dello stato. Non è un caso che Popper[4] consideri questa visione come fortemente condizionata da elementi di totalitarismo, successivamente ripresi dall’idealismo dello stato etico di Hegel[5]. Così nel Fedro l’anima, già nella sua consistenza prenatale, vive autonomamente la congiuntura, per la quale può successivamente riempirsi di oblìo e malvagità ed esautorarsi, condizioni che determinano la sua caduta nei corpi materiali e sensibili. La discesa dell’anima nel decadere non è conseguente alla sua incarnazione o reincarnazione, ma ne è l’esatta condizione, in quanto è proprio la guida disordinata dell’auriga, incapace di condurre sulla retta via la biga alata, a determinare il presupposto dell’appesantirsi progressivo del carro, che finisce per discendere nelle realtà corporee materiali. Donde la necessità di condurre una vita morigerata, che riesca a completare il ciclo della purificazione dell’anima, fino a poterle garantire successivamente una reincarnazione più degna, in un eterno succedersi di cadute e di rigenerazioni dello spirito. Perché al di sopra dell’intelletto, che figura come l’attività superiore dell’anima, vi è sempre il mondo Iperuranio delle Idee, al vertice del quale si colloca in posizione preminente l’idea di dio, che coincide con quella del Bene assoluto ed eterno. Nel concetto di trasmigrazione delle anime, Platone si distingue dal cristianesimo che, pur ritenendo l’anima immortale, non accetta la reincarnazione, poiché essa rappresenta chiaramente l’individualità del soggetto persona che la possiede. Per i cattolici, affermare l’immortalità dell’anima significa concepire una vita eterna che vada oltre quella del corpo. Vita necessaria per la santificazione dello spirito, che risulterebbe impossibile se l’anima morisse con l’uomo. Ad ogni modo, essendo anima e corpo una totalità olistica inseparabile nella persona umana, l’appartenenza dello spirito ad un solo uomo è condizione imprescindibile per la successiva resurrezione dei corpi, che si ricongiungeranno alle loro anime. Il cristianesimo puntualizza con forza l’unità dell’essere umano attraverso il tomismo e l’aristotelismo, che interpretano l’uomo come unità indissolubile di corpo e anima, di materia e forma. Qui è la differenza profonda con il dualismo platonico. La cui ripresa nella filosofia della res cogitans e della res extensa di Cartesio, che separa nettamente la materia dallo spirito, costringe poi il filosofo razionalista ad ipotizzare l’esistenza della ghiandola pineale, situata nel cervello, per poter in qualche modo consentire l’interazione tra l’anima ed il corpo. Unità che resta sospesa e incompleta quando si parli del suo dualismo metafisico, incontrovertibile espressione di quello platonico, ben narrato nel mito della caverna[6]. Ciò accade evidentemente perché Platone considera mortale il corpo, ed immortale solo l’anima. Separando la materia sensibile, che degenera, da quella spirituale, che invece vive in eterno. Laddove la concezione cattolica propende per una immortalità dell’anima, cui fa seguito di necessità anche una resurrezione dei corpi, per ricostituire la primigenia unità cristiana delle nature, nell’idea di persona. In Platone, diversamente, il corpo resta una zavorra dell’anima, e la morte, secondo le suggestioni pitagoriche ed orfiche, viene ritenuta una liberazione dello spirito, che finalmente può librarsi leggero, senza il peso della materia che lo incatena, impedendogli di conoscere il vero. «Fino a quando noi possediamo il corpo e la nostra anima resta invischiata in un male siffatto, noi non raggiungeremo mai in modo adeguato quello che ardentemente desideriamo, vale a dire la verità. Infatti, il corpo ci procura innumerevoli preoccupazioni per la necessità del nutrimento; e poi, le malattie, quando ci piombano addosso, ci impediscono la ricerca dell’essere. Inoltre, esso ci riempie, di amori, di passioni, di paure, di fantasmi di ogni genere e di molte vanità, di guisa che, come suol dirsi, veramente, per colpa sua, non ci è neppure possibile pensare in modo sicuro alcuna cosa […] se mai vogliamo vedere qualcosa nella sua purezza, dobbiamo staccarci dal corpo e guardare con la sola anima le cose in se medesime»[7]. Anche la conoscenza certa ha sede nello spirito, e origina dalle idee innate, attraverso il ricordo, la reminiscenza, perché quella sensibile è fallace ed apparente, ed induce in errore. Infatti, l’anima è simile alle idee, ed ha la loro stessa natura spirituale. Ulteriore testimonianza della fede platonica nell’immortalità dell’anima si può rinvenire nel mito di Er[8], guerriero morto in battaglia, e successivamente ritornato alla vita, che racconta di come la sua anima si fosse staccata dal corpo a raggiungere le realtà celesti dell’Iperuranio, per poi successivamente ricongiungersi a lui, e consentirgli di tornare a vivere. La vera vita dell’uomo dipende dunque dallo spirito, che anima il corpo, vuota effigie e simulacro. «L’anima tutta è immortale. È immortale, infatti, tutto ciò che si muove sempre; mentre ciò che muove altro e da altro è mosso, come ha la cessazione del moto, ha anche la cessazione della vita. Solo ciò che dà a se stesso il proprio moto, in quanto non viene meno a se stesso, non cessa mai di muoversi, anzi è sorgente e principio di movimento per tutte quante le altre cose che si muovono. Ora, principio è ciò che non è generato da altro: di necessità, tutto ciò che ha nascimento nasce da principio, esso invece da nulla; e se il principio nascesse da qualcosa, non potrebbe più stare come principio. Poiché, dunque, è ingenerato, esso è anche, necessariamente, indistruttibile, giacché, una volta finito il principio, né esso potrebbe nascere mai da alcuna cosa né altro da quello, dal momento che bisogna che dal principio nascano tutte le cose. Così, appunto, è principio di moto ciò che muove se stesso; questo poi non è possibile che finisca né che nasca, altrimenti tutto il cielo e tutto il creato cadendo insieme dovrebbero fermarsi e mai più avrebbero di nuovo donde essere mossi e nascere. Apparso chiaro che è immortale ciò che si muove da sé, non si avrà tema di affermare che questa, in termini razionali, è l’essenza dell’anima. Ogni corpo, a cui il moto è prorogato dall’esterno, è inanimato; quello invece a cui viene dall’interno di se stesso è animato: ed è questa la proprietà naturale dell’anima. E se le cose stanno in questi termini, che nient’altro si muove da sé se non l’anima, l’anima sarà necessariamente qualcosa di ingenerato e di immortale»[9]. Con queste parole Socrate dimostra al suo interlocutore Fedro l’immortalità dell’anima, continuando con il mito della biga alata. «Si può assomigliare l’anima ad una pariglia alata ed al suo auriga, insieme uniti da congenita potenza. Ora, i cavalli e gli aurighi delle anime divine sono tutti buoni essi stessi e da buoni hanno avuto nascimento; quelli degli altri sono misti. E così, il nostro auriga guida una coppia di cavalli, di cui l’uno è eccellente e originato da genitori pur essi eccellenti, l’altro è l’opposto e nato da genitori simili a lui; onde è cosa necessariamente difficile e malagevole fare l’auriga a noi […] Quanto alle anime, c’è quella che, seguendo quanto più vicino possibile gli dei, solleva nella regione sovraceleste il capo dell’auriga e si lascia trasportare nel moto circolare, ma, disturbata dai cavalli, a stento riesce a contemplare gli enti; e c’è quella che ora s’innalza ora s’immerge e, per la riluttanza dei cavalli, alcune cose vede, altre no»[10]. Dunque, l’immortalità dell’anima è in sé dimostrata, essendo l’anima per sua stessa essenza fonte di movimento e di vita. E ciò che si muove da sé, senza presupporre di essere mosso da qualunque altra realtà e natura, è essenza e vita, e perciò realtà immortale ed eterna. Pare di risentire l’eco dei discorsi di Socrate a Cebete nel Fedone quando, condannato a morte, andava sereno incontro alla sorte, e consolava gli amici disperati, dicendo loro che la parte sua più nobile gli sarebbe sopravvissuta, perché essendo l’anima vita per sua stessa essenza, questa non sarebbe mai giunta a dover morire.
[1] Cfr. W. Buchwald, Platone, Fedro, pag. 166.
[2] Cfr. Platone, La Repubblica IV.
[3] Ivi III
[4] Cfr. Popper, La società aperta e i suoi nemici, 1945.
[5] Cfr. Hegel, La fenomenologia dello spirito, 1807.
[6] In Platone, La Repubblica VII.
[7] Cfr. Platone, Il Fedone.
[8] Platone, La Repubblica X.
[9] Cfr. Platone, Il Fedro XXIV.
[10] Ivi XXV, XXVIII
LA CARITAS IN VERITATE DI PAPA BENEDETTO XVI
di Antonietta Pistone
Nell’ultima Lettera Enciclica Caritas in veritate di Papa Benedetto XVI vi è un richiamo costante ai valori della verità e dell’amore già presenti nella precedente Deus caritas est. Dio è per sua stessa essenza amore,
scrive il Papa teologo. Pertanto ogni espressione dell’amore maturo è manifestazione certa della presenza di Dio tra noi. Adesso, suggerisce ulteriormente, questo amore caritatevole di Dio si rende evidente nella verità, perché Dio è verità. Perciò se Dio è amore, e se Dio è verità, l’amore di Dio coincide con quello per la verità di Dio. E tra amore e verità, in Dio, non può esserci esclusione, quanto piuttosto un rapporto di reciproca implicanza che dall’uno porta all’altro, proprio perché dall’uno discende l’altro. Rovesciando il detto di San Paolo «veritas in caritate» (la verità è nell’amore), Papa Ratzinger sostiene «caritas in veritate» (l’amore è nella verità). Quanto più ci si accosta, ricercandola, alla verità, tanto maggiormente ci si avvicina all’amore vero e profondo di Dio. Dunque caritas e veritas sono svelati nel loro reciproco rapporto di reversibilità non escludente, proprio come agápe e lógos sono l’uno il presupposto e la conseguenza dell’altro. Non vi è possibilità di amore senza parola, perché la parola è amore. Ma la parola è Dio, perciò Dio è parola, verità e amore. Eppure il lógos non si accontenta del suo essere monologo comunicativo nel linguaggio, e diviene diá-lógos, comunione nel dialogo, in cui si incontrano e si compenetrano due differenti identità, nella parola vera dell’amore di Dio. Avviene così il mutuo riconoscimento tra un io ed un tu, nell’attimo in cui si percepiscono entrambi carne viva della stessa storia dell’umanità. Figli di quell’amore che è dono e grazia al tempo stesso, e che si fa elemento sorgivo della vita sociale dei popoli. Perché non c’è amore senza giustizia, ma nemmeno senza la comprensione del significato e del senso del dono e del perdono. Nell’amore per la verità e la giustizia si uniscono così gli elementi più radicali del sentimento religioso della compassione per l’altro, con quello della lotta politica per il perseguimento degli ideali di uguaglianza tra gli uomini. L’amore si fa ricerca della verità e della giustizia nel rispetto del dono e del perdono, attraverso la grazia, in Dio. Ma va chiarito, inevitabilmente, che non può esservi alcuna verità senza l’amore, perché è dall’amore che la verità discende, nel senso più ampio del termine. Anche nella forma della giustizia e del bene comune che interessa di necessità tutto il consorzio umano. L’amore per la verità, lungi dall’essere mera espressione di sentimentalismo romantico, diviene lotta per i diritti, battaglia politica, impegno e sacrificio nell’interesse comune. È adoperarsi efficacemente per il bene dell’altro, di colui che si ama. Solo in questa direzione è possibile ipotizzare l’edificazione di quella città dell’uomo in vista della città di Dio di cui parlava Agostino. Quando Papa Paolo VI pubblica, nel 1967, la sua Lettera Enciclica Populorum progressio, fa costante riferimento allo sviluppo delle Nazioni che comincia, in primo luogo, dalla diffusione del messaggio evangelico, e continua attraverso la promozione dei valori umani, e la scoperta di un nuovo umanesimo integrale, che si avvicina all’immagine olistica di uomo, unità inscindibile ed indifferenziata di anima e corpo, che da Aristotele e da San Tommaso era approdata alla filosofia dell’umanesimo cattolico integrale del francese Maritain[1]. Non c’è sviluppo in cui l’uomo non passi da condizioni meno umane a condizioni più umane. «Tutta la Chiesa, in tutto il suo essere e il suo agire, quando annuncia, celebra e opera nella carità, è tesa a promuovere lo sviluppo integrale dell’uomo […] l’autentico sviluppo dell’uomo riguarda unitariamente la totalità della persona in ogni sua dimensione». Queste le due grandi verità comunicate nella Lettera Enciclica da Paolo VI[2]. «Lo sviluppo non si riduce alla semplice crescita economica. Per essere sviluppo autentico, dev’essere integrale, il che vuol dire volto alla promozione di ogni uomo e di tutto l’uomo. Com’è stato giustamente sottolineato da un eminente esperto: noi non accettiamo di separare l’economico dall’umano, lo sviluppo dalla civiltà dove si inserisce. Ciò che conta per noi è l’uomo, ogni uomo, ogni gruppo d’uomini, fino a comprendere l’umanità intera»[3]. Ma non è possibile uno sviluppo integrale della persona umana che non sia vocazione e incarnazione, perché queste due sole dimensioni dei figli di Dio li portano a riconoscersi in una missione di vita che supera nella trascendenza il momento dell’attimo dell’hic et nunc, il qui ed ora, inducendo l’uomo a dichiararsi fratello dell’altro uomo in Cristo. «Nel disegno di Dio, ogni uomo è chiamato a uno sviluppo, perché ogni vita è vocazione. Fin dalla nascita, è dato a tutti in germe un insieme di attitudini e di qualità da far fruttificare: il loro pieno svolgimento, frutto a un tempo dell’educazione ricevuta dall’ambiente e dello sforzo personale, permetterà a ciascuno di orientarsi verso il destino propostogli dal suo Creatore. Dotato d’intelligenza e di libertà, egli è responsabile della sua crescita, così come della sua salvezza. Aiutato, e talvolta impedito, da coloro che lo educano e lo circondano, ciascuno rimane, quali che siano le influenze che si esercitano su di lui, l’artefice della sua riuscita o del suo fallimento: col solo sforzo della sua intelligenza e della sua volontà, ogni uomo può crescere in umanità, valere di più, essere di più»[4]. Se tutti siamo fatti ad immagine e somiglianza di Dio, in Lui solo ci possiamo ritrovare nella comune e condivisa umanità di persone, alla ricerca di una vocazione esistenziale verso il trascendente. «Se il perseguimento dello sviluppo richiede un numero sempre più grande di tecnici, esige ancor più uomini di pensiero capaci di riflessione profonda, votati alla ricerca d’un «umanesimo» nuovo, che permetta all’uomo moderno di ritrovare se stesso, assumendo i valori superiori di amore, di amicizia, di preghiera e di contemplazione. In tal modo potrà compiersi in pienezza il vero sviluppo, che è il passaggio, per ciascuno e per tutti, da condizioni meno umane a condizioni più umane»[5]. Continua Paolo VI nell’Enciclica Populorum progressio, senza tuttavia discostarsi dal Magistero della Chiesa cattolica, dopo l’impostazione che si era data la cristianità durante il Concilio Vaticano II[6], ribadendo la sua vocazione all’ecumenismo e avvicinandosi con sensibilità sempre maggiore a tutte le questioni di natura sociale ed economica, che coinvolgessero i popoli e le nazioni. La dimensione dello sviluppo, fortemente legata all’idea filosofico-religiosa di uomo, piuttosto che alla sua distorta interpretazione in chiave economico-capitalistica, rappresentava un’innovazione rivoluzionaria all’interno della Chiesa romana, che rende ancora assai attuale il discorso politico della Populorum progressio, costituendo una svolta definitiva nell’orientamento dei cattolici, laici e religiosi, di tutto il mondo. Soprattutto, si faceva interprete fedele di quella nuova teologia della liberazione che incarnava gli ideali postconciliari di emancipazione sociale, a partire dalla considerazione della realtà dei preti operai. Con la Lettera apostolica Octogesima adveniens del 1971 Paolo VI trattò il problema della politica e del rischio di visioni utopistiche ed avveniristiche che esulassero da considerazioni di tipo etico, e al tempo stesso rinnovò le sue esternazioni nei confronti di quegli atteggiamenti sociali rivolti alla promozione della tecnica intesa in senso radicale come unica e sola possibilità di sviluppo umano. Con la Lettera enciclica Humanae vitae del 25 luglio 1968 Paolo VI aveva invece sottolineato il valore dell’amore sponsale, che si esplica in senso unitivo e procreativo nella sessualità della vita di coppia, rimarcato nella Evangelium vitae di Giovanni Paolo II, del 25 marzo 1995. Nella Populorum progressio Paolo VI sottolinea come lo sviluppo dell’uomo sia questione non solo economica ma anche e soprattutto morale. Solo attraverso una filosofia dell’umanesimo integrale trascendente, che recuperi quei valori immortali di unità intrinseca, nella persona, di corpo e anima, è possibile comprendere la liberazione dell’uomo dalla schiavitù delle passioni e dei bisogni, alla luce della scoperta, in ciascuno, della individuale vocazione. «Non vi è dunque umanesimo vero se non aperto verso l’Assoluto, nel riconoscimento d’una vocazione, che offre l’idea vera della vita umana»[7]. Sembra di rileggere le pagine del filosofo Mounier, quando ritrova nella persona, inscindibilmente unite, le tre dimensioni della vocazione ad essere, dell’incarnazione ad esistere, e della comunione a relazionarsi con gli altri, che si realizza, in ultima analisi, solo ed esclusivamente attraverso la condivisione dei vissuti psichici e fisici, entro la comunità. Anche per l’approccio del personalismo francese difatti la persona è concepita come prospettiva, sguardo in avanti, facendosi essenzialmente incarnazione dei vissuti. Allo stesso modo, la dimensione della vocazione cristiana della persona umana, in Paolo VI come in Benedetto XVI, passa inevitabilmente per la relazione sociale, che rende operativa e concreta la individuale vocazione dello spirito, incarnata nella concretezza corporea dell’esistenza storica. Vocazione ed incarnazione sono possibili solo nella relazione sociale che si fa comunione totale in una dimensione dei vissuti capace di superare il momento transeunte della storicità, per farsi sguardo prospettico sulla trascendenza divina della dimensione ultraterrena. La vocazione umana, cioè, è richiamo ai valori che proiettano la persona verso orizzonti immortali dell’essere e dell’esistere, costituiti dalle frontiere dello spirito. L’uomo, come il popolo, che abbraccia interamente, perché la riconosce come propria, la sua vocazione, sa anche farsi autentico interprete della verità dell’amore, nella giustizia e nella libertà. Qui il discorso della Populorum progressio abbandona lo scandaglio delle ragioni intimistiche e spirituali della coscienza e del cuore, per approdare alla complessità delle questioni sociali e politiche, legate intimamente al mondo dei valori e delle scelte morali. La ripresa di questi temi dell’enciclica di Paolo VI in Benedetto XVI fa credere che vi sia una sintonia molto intima di intenti e di propositi nel pensiero di entrambi. Papa Ratzinger vuole, in sostanza, sottolineare il profondo significato della relazione autentica, che si fa amore e condivisione con l’altro, lungi dall’essere mero sentimentalismo romantico nella ricerca della verità e della giustizia per la persona umana e per i popoli tutti della terra. Se è vero che non esiste la possibilità di una relazione profonda, al di fuori dell’amore reciproco, è altrettanto vero che ogni relazione d’amore deve necessariamente nutrirsi della ricerca della verità, attraverso la libertà e la giustizia, per non sfociare nel banale sentimentalismo compassionevole. Ogni relazione autentica con l’altro è reciproco impegno per la giustizia e la verità, nell’esercizio individuale e collettivo della libertà responsabile che si prende cura e progetta l’avvenire, a partire dal passato e dalla considerazione attiva e pronta del presente. Un vero sviluppo umano, perciò, non può che essere ricerca di un umanesimo integrale trascendente, in vista dell’uomo e per tutto l’uomo, verso Dio. Gli uomini politici dovrebbero essere capaci di armonizzare doti di pensiero, di spirito e di cuore, per realizzare compiutamente quella fratellanza tra i popoli che oggi manca, la cui carenza è purtroppo alla base di grandi ingiustizie sociali che allontanano irrimediabilmente le nazioni del mondo dalla pace e dalla libertà. Sebbene sia, di fatto, aumentata la ricchezza del pianeta, si sono evidentemente accresciute insieme anche le disparità sociali e le disuguaglianze economiche, per il cattivo uso delle risorse disponibili, che ha sottratto beni di prima necessità, come l’acqua e il cibo ai popoli del mondo, determinando gravi condizioni di sottoviluppo in alcune aree geografiche, condannate ancora oggi a dover risolvere il problema della denutrizione e della fame. Ma per costruire quella civiltà dell’amore che riconosca il suo centro vitale nella persona umana e nei suoi valori, primo fra tutti quello alla vita, è necessario prendere in considerazione le situazioni difficili che si presentano anche nei cosiddetti paesi industrializzati, dove apparentemente non si dovrebbero determinare condizioni di sistematico bisogno. Si parla della mancanza di lavoro che affligge le nuove generazioni, insistendo pesantemente sulla condizione economica del paese, ma anche necessariamente sulla vita privata dei singoli, che faticano a formare famiglia. Di conseguenza si assiste ad un continuo decremento dei matrimoni, e ad una diffusa crisi dell’istituto familiare, proprio in un momento storico caratterizzato dall’incertezza generalizzata e dalla sfiducia nei valori della tradizione cattolica, e bisognoso pertanto di ritrovare nella comunità istituzionalizzata della famiglia un rifugio sicuro per arginare il rischio della devianza giovanile nell’uso e nell’abuso di stupefacenti, nella criminalità organizzata, in tutti quei fenomeni degenerativi della violenza individuale e di gruppo, che sostituisce semplicisticamente l’abitudine alla parola e al dialogo tollerante e costruttivo nel confrontarsi con gli altri. Così come l’unione sponsale dei coniugi nel matrimonio è il remedium concupiscentiae contro le esterne tentazioni della carne. Ovviamente si vuole intendere qui, per famiglia, quella istituzione che si avvicini il più possibile al suo modello idealizzato di rifugio e porto della persona, lungi dal voler significare con questa terminologia le aberrazioni alle quali la degenerazione odierna dei costumi morali ci ha, purtroppo, dolorosamente abituato. Sebbene si debba fare i conti, ormai, con una nuova e variegata tipologia di famiglia, sempre più sovente così detta “allargata”, che comprende diversi nuclei, compreso i nonni e gli zii spesso conviventi, ma anche le nuove famiglie che si costituiscono dopo separazioni e divorzi. Oggi, come ieri, la famiglia è diventata spesso il luogo privilegiato della violenza taciuta. Certamente non è a questa degenerazione tipologica che Benedetto XVI si riferisce quando ne parla come di un antico baluardo da riscoprire e difendere strenuamente. Anche la globalizzazione ha contribuito a diffondere questo generalizzato clima di insicurezza che, ritengo, impedisce agli intellettuali di esercitarsi nella dialettica dei distinti di crociana memoria. Il fenomeno cui si assiste è quello doppio dell’eclettismo o dell’appiattimento culturale. In entrambi i casi, la cultura viene mercificata attraverso la semplificazione strumentale della complessità dei fenomeni da essa rappresentati. In un’ansia di omologazione che, nell’intento di omogeneizzare il tutto, banalizza le differenze per renderle irriconoscibili alla maggior parte della gente, vendendo il prodotto finito come standardizzato ed universalmente fruibile. Di questa deriva della cultura è responsabile, credo, anche la scuola, con i suoi diplomifici impegnati a distribuire titoli culturali spendibili sul mercato del lavoro, piuttosto che a generare crisi di coscienza, e a divenire davvero termostato della società, secondo le indicazioni del noto pedagogista Postman. Si finisce così per produrre un comune sentire, incapace di stabilire connessioni o differenze, in un mondo che ha semplificato ogni diversità, assimilando l’una all’altra le culture dei popoli, nell’illusione di creare una falsa integrazione, assolutamente irrealizzabile senza un minimo di conoscenza profonda delle specificità delle culture e delle civiltà differenti. La coesistenza che ne deriva è solo una mera apparenza di pace e di non violenza, sotto la quale si nascondono l’indifferenza per l’altro, la sua storia, le sue tradizioni. Anche l’intolleranza religiosa che ha da secoli prodotto le false utopie delle guerre sante di liberazione, è un ostacolo non indifferente che impedisce la costruzione della civiltà dell’amore. Il rispetto per l’altro non prescinde dall’amore, che è sempre una forma di intelligenza e di comprensione anche per la sua fede religiosa. L’odio separa e distrugge, laddove l’amore unisce ed edifica. Per questo motivo esso è inseparabile dalla ricerca della verità. Perché non è possibile un amore che sia privo di intelligenza. E l’intelligenza è commistione di mente e di cuore. L’amore, poi, in quanto intelligenza del cuore, è la più intima e profonda ricerca della verità, intuita attraverso tutta la persona, oltre che ragionata con gli strumenti propri dell’intelletto umano. Ma per realizzare questa civiltà dell’amore andrebbero riscoperti la logica del dono e della speranza cristiana, ed il conseguente principio di gratuità, come espressione della fraternità dei popoli. Dono è “ciò che è dato”. Ammettere il dono significa supporre l’esistenza di realtà indipendenti e al di fuori dell’umana capacità di disporre. Vuol dire entrare nell’ottica della trascendenza, per la quale e alla quale l’uomo deve concedere qualcosa a Qualcuno che gli è di fatto superiore. Il relativismo etico derivato dal crollo dei valori è una diretta conseguenza della fede totalizzante che l’individuo ha acquisito nei confronti di se stesso, sostituendosi a Dio in tutto e per tutto, anche nel ritenersi onnipotente. Questa presunzione di grandezza ha finito col determinare la fine della trascendenza, sostituita dalla logica del mercato, per la quale ogni bene è acquistabile attraverso il denaro-capitale, che è perciò divenuto il bene per eccellenza, calpestando anche i diritti umani della persona. La logica mercantile della giustizia commutativa è fondata sulla legittimità del contratto e del do ut des. Questa logica sterile ha immiserito i rapporti umani, facendoli dipendere esclusivamente dalla natura e dalla tipologia dello scambio, entro il quale si è configurata l’esistenza individuale del capitalismo post-moderno, di stampo individualistico ed utilitaristico. L’edonismo ne è il frutto degenerato. La logica della giustizia commutativa andrebbe, invece, sostituita da quella della giustizia sociale distributiva, che dà secondo necessità e bisogno ai poveri, piuttosto che continuare a rimpinguare le casse già sonanti dei ricchi. Alcune distorsioni economiche e morali generate da questo sistema di cose sono rinvenibili dal pontefice nel trasferimento dei capitali all’estero, nei paradisi fiscali, nell’individualismo edonistico ed utilitaristico già detto, nella pratica dell’eutanasia, dell’aborto, della contraccezione, nel controllo delle nascite, nel concepimento artificiale in tutte le sue forme, nella ricerca scientifica sugli embrioni umani, nello scarso rispetto per l’ambiente, per la distribuzione delle risorse e per la salvaguardia del clima contro l’inquinamento atmosferico. L’etica personalistica, al contrario, rivaluta l’uomo in tutte le sue attribuzioni, ponendo la vita al centro di ogni questione, laddove oggi è il denaro nelle forme del capitale ad aver surclassato la persona umana. Un’etica che recuperi la persona non può che osservare alla luce della legge morale anche i fatti economici, di cui resta protagonista sempre e comunque l’uomo, lungi dal rappresentarsi come oggetto succube e passivo. La persona umana al centro consegna nuova dignità all’istituzione del matrimonio e alla famiglia, fondata sull’unione sponsale dei coniugi che si amano e che, desiderandosi, generano la vita. L’uomo, per la teologia cattolica, è immagine e somiglianza di Dio. Il volto, che si fa prospettiva e sguardo in avanti nel personalismo filosofico, diventa espressione della storia del singolo individuo come di tutta l’umanità in cammino verso Dio. Partecipare, come genitori, alla mirabile opera del Creatore, è contribuire fattivamente al progetto di Dio per l’uomo. La natalità diventa così una benedizione celeste. La morale cattolica è alimentata da valori ontologicamente fondati nella trascendenza di Dio e dello spirito umano, che si riconosce nell’anima di ciascuno. Perciò, anche i valori sono intramontabili e trascendenti. L’uomo, poi, ha ricevuto, con il dono della vita, anche quello della natura, che gli è stata affidata da Dio perché se ne nutra, proteggendola, attraverso il rispetto per l’ambiente, le risorse, il clima. Tuttavia l’uomo deve amministrare con grande devozione la natura, senza infierire su di essa, come oggi avviene, perché disponendone a suo piacimento, senza regole morali, finisce col distruggere il rapporto equilibrato degli esseri, inquinando l’ambiente e autodistruggendo se stesso. Un altro spettro della contemporaneità con il quale si deve doverosamente lottare è la solitudine, un male di cui soffrono ormai quasi tutti per l’impossibilità di costruire rapporti e relazioni autentiche che vadano oltre la dimensione del contratto economico e della logica dello scambio. La solitudine si configura come una nuova forma di povertà: «Paolo VI notava che il mondo soffre per mancanza di pensiero. L’affermazione contiene una constatazione, ma soprattutto un auspicio: serve un nuovo slancio del pensiero per comprendere meglio le implicazioni del nostro essere una famiglia; l’interazione tra i popoli del pianeta ci sollecita a questo slancio, affinché l’integrazione avvenga nel segno della solidarietà piuttosto che della marginalizzazione. Un simile pensiero obbliga ad un approfondimento critico e valoriale della categoria della relazione. Si tratta di un impegno che non può essere svolto dalle sole scienze sociali, in quanto richiede l’apporto di saperi come la metafisica e la teologia, per cogliere in maniera illuminata la dignità trascendente dell’uomo. La creatura umana, in quanto di natura spirituale, si realizza nelle relazioni interpersonali. Più le vive in modo autentico, più matura anche la propria identità personale. Non è isolandosi che l’uomo valorizza se stesso, ma ponendosi in relazione con gli altri e con Dio»[8]. La solitudine è determinata anche dall’intolleranza religiosa propria del fondamentalismo come del laicismo, dell’indifferentismo religioso come dell’omologazione culturale che appiattiscono tutte le religioni facendole sembrare uguali tra loro. Ma anche la superstizione impedisce un dialogo sereno, che è invece simbolicamente espresso e significato dalla compenetrazione delle tre persone del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo nella Trinità di Dio. Il vero dialogo, come la vera relazione, lascia sbocciare il meglio di ciascuno. Come in famiglia, così nella Chiesa cattolica, ogni individualità è esaltata dentro la comunità, non umiliata e oppressa come avviene invece nei totalitarismi. Perché la comunità che rispetti l’individuo è profondamente democratica. Dio deve, perciò, trovare un suo spazio nella sfera pubblica. Uno stato, qualunque esso sia, per quanto si dica laico, non può non tener conto degli orientamenti religiosi dei suoi cittadini, che per di più dettano le norme del loro agire morale. Lungi dalle possibili interpretazioni di orientamento confessionale, a questa riflessione di Benedetto XVI va posta la giusta attenzione, ponderando anche i suoi possibili risvolti dogmatici e teocentrici nell’attuale delicato momento storico-politico internazionale. Nel vuoto di potere che ci rende profondamente carenti di figure di spicco e di rilievo, con uno spessore culturale ed un impegno serio e responsabile, è piuttosto facile che una presenza così forte come quella del nostro pontefice Benedetto XVI possa finire per “dettare legge” anche in sede civile. Lo Stato laico, però, ha il dovere di conoscere gli orientamenti della chiesa cattolica, come di tutte le altre confessioni, per arginare ogni eventuale tentativo della religione di oltrepassare i leciti confini dello spirito, nell’intento di imporsi a governare in sede politica. Ritengo, ad ogni modo, che questa considerazione del Pontefice si proponga come lo specchio fedele dei rapporti da sempre intercorsi tra Chiesa e Stato, esemplificando espressamente come le vicende storico-politiche siano strettamente connesse a quelle della fede religiosa dei popoli, divenendo in tal modo la religione uno degli aspetti preminenti e più inquietanti, unitamente a quelli economici, che ogni storico che si rispetti deve prendere seriamente in considerazione nella ricostruzione di un’epoca. L’identità e la cultura di un popolo sono, difatti, intimamente legate anche e soprattutto alle sue scelte di natura religiosa. Già Weber ne L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, invertendo il rapporto dialettico marxista tra struttura e sovrastruttura, riconosceva il valore primario delle scelte morali e religiose su quelle di natura prettamente economica. La religione, dunque, in quanto espressione della cultura e della storia dei popoli, è un elemento fondamentale per l’approfondimento dei valori e della moralità, dell’agire e del comportamento sociale, quando si vogliano studiare gli elementi complessi di una civiltà. Essa è, difatti, distinta dalla religiosità, come sentimento privato ed intimistico, laddove la religione comprende l’insieme delle pratiche comportamentali e rituali che necessariamente finiscono per riversarsi sul sociale, sul pubblico e, in ultima analisi, sul politico. Ciò che, in effetti, colpisce di questa enciclica è la novità del porgere il pensiero su due fronti distinti, sebbene convergenti. Da una parte si osserva la speculazione filosofica sui temi del personalismo cattolico, con afferenze dirette alla religiosità dello spirito umano. Dall’altra, l’approccio personalistico si socializza nelle riflessioni di natura economico-politica, divenendo ampio sguardo critico della realtà internazionale, a partire dalla questione religiosa. Quella che Papa Benedetto propone in Caritas in veritate è un’analisi spietata della contemporaneità, segnata dallo smarrimento dei valori etici e dalla perdita di centralità della persona umana in ogni ambito. Solo il recupero di questa priorità potrà garantire, nella prospettiva del Pontefice, un nuovo orientamento mondiale in vista della pace universale e della fraternità dei popoli tutti. Lo sviluppo economico politico è ciò che seguirà necessariamente una rivoluzione dello spirito di tale portata. Senza la quale null’altro ci è, tuttora, permesso di sperare. Ragione e fede non sono tra loro in contrasto, ma necessitano di dialogare in modo fecondo per affermare nella comunità una collaborazione attiva tra credenti e non credenti, alla luce del principio di sussidiarietà contro ogni forma di assistenzialismo paternalistico. La sussidiarietà è l’unico modo per gestire responsabilmente la globalizzazione, in vista di un’operosa e solidale cooperazione tra i popoli. In questa prospettiva, gli aiuti internazionali allo sviluppo non devono favorire situazioni di dominio. La cooperazione allo sviluppo deve invece saper gestire le risorse umane, divenendo luogo di incontro tra le culture. Bisogna lavorare al recupero dei valori della persona umana anche per risolvere i problemi relativi all’educazione dei bambini, che non può più essere affidata ad etiche relativistiche; quelli derivanti dal turismo sessuale, dai flussi migratori, dalla povertà e dalla disoccupazione dei giovani, dalle divisioni politiche delle organizzazioni sindacali di categoria, dall’usura, dai consumatori e dalle loro associazioni, che dovrebbero assumersi il compito di segnalare criticamente il significato dell’acquisto e dell’uso di un bene. Pagine che dovrebbero leggere con attenzione critica tutti i nostri politici. Questa enciclica sembra, difatti, più un manifesto programmatico che un invito spirituale rivolto alla salvezza delle anime. Il pericolo che corre, attualmente l’Occidente, è sicuramente quello di perdere ancora di vista la distinzione tra Stato e Chiesa, già riconosciuta nel 1250 dal re svevo Federico II. La concezione di uno stato laico, sebbene tollerante in materia di professioni religiose, è il primo basilare pilastro dello stato moderno, sorto da tante sanguinose rivoluzioni come quella americana, che dette origine agli Stati Uniti d’America, e quella francese, fondata sugli ideali di uguaglianza, libertà e fraternità dei popoli. Il Risorgimento italiano ha rappresentato la continuità con queste rivoluzioni. Alessandro Manzoni, Antonio Rosmini, Giuseppe Mazzini, pur essendo cattolici, hanno strenuamente combattuto per uno stato laico, che distinguesse le sue posizioni politiche dalle scelte morali della chiesa cattolica. C’è da augurarsi davvero che i politici del mondo siano in grado di capire ed interpretare con intelligenza le parole del Papa, che suonano come un monito, ma anche come una minaccia per l’umanità. Così gli intellettuali e i pensatori dovrebbero soffermarsi a leggere e riflettere le considerazioni del Pontefice sulla conoscenza. «Conoscere non è un atto solo materiale, perchè il conosciuto nasconde sempre qualcosa che va al di la` del dato empirico. Ogni nostra conoscenza, anche la più semplice, è sempre un piccolo prodigio, perchè non si spiega mai completamente con gli strumenti materiali che adoperiamo. In ogni verità c’è più di quanto noi stessi ci saremmo aspettati, nell’amore che riceviamo c’è sempre qualcosa che ci sorprende. Non dovremmo mai cessare di stupirci davanti a questi prodigi. In ogni conoscenza e in ogni atto d’amore l’anima dell’uomo sperimenta un «di più» che assomiglia molto a un dono ricevuto, ad un’altezza a cui ci sentiamo elevati. Anche lo sviluppo dell’uomo e dei popoli si colloca a una simile altezza, se consideriamo la dimensione spirituale che deve connotare necessariamente tale sviluppo perchè possa essere autentico. Esso richiede occhi nuovi e un cuore nuovo, in grado di superare la visione materialistica degli avvenimenti umani e di intravedere nello sviluppo un ‘‘oltre’’ che la tecnica non può dare. Su questa via sarà possibile perseguire quello sviluppo umano integrale che ha il suo criterio orientatore nella forza propulsiva della carità nella verità»[9]. Politica e scienza non possono procedere autonomamente l’una dall’altra, e indipendenti dalla legge morale e religiosa. Perché ogni tentativo in questo senso rappresenta il più profondo tradimento dell’uomo a se stesso. Solo un nuovo umanesimo, un umanesimo cristiano, potrà trasformare i “cuori di pietra” in “cuori di carne”. Implicita si scorge qui la critica al machiavellismo politico, come al tecnicismo esasperato che culmina nella cecità dello scientismo odierno, con cui il Pontefice conclude la sua lettera enciclica, prima dell’invocazione alla Vergine.
Studio pubblicato sulla rivista Pianeta Cultura.
[1] J. Maritain, L’umanesimo integrale, Parigi 1936.
[2] Cfr Paolo VI, Lett. enc. Populorum progressio, 14: l.c., 264.
[3]Cfr. Paolo VI, Lett. Enc. Populorum progressio, 14.
[4] Cfr. Paolo VI, Lett. Enc. Populorum progressio, 15.
[5] Ivi, 20.
[6] Il Concilio Vaticano II venne convocato da Papa Giovanni XXIII nel 1959 per dare la parola ai Vescovi di tutto il mondo; furono creati il sinodo dei Vescovi, la Conferenza episcopale italiana (Cei), il collegio dei Cardinali, e venne rinnovata la Curia. In epoca postconciliare gli succedette nel 1963 Papa Montini, noto come Paolo VI.
[7] Cfr. Paolo VI, Lett. Enc. Populorum progressio, 42: l.c., 278.
[8] Benedetto XVI, Lett. Enc. Caritas in veritate, pag. 90.
[9] Benedetto XVI, Caritas in veritate, pagine 22 e 23.
LA SANCTA NOVITAS
A cura di Elisabetta La Vista
Il francescanesimo è stato un grande movimento religioso che, più degli altri ordini mendicanti,ha scosso, segnato, impregnato l’insieme della società cristiana del XIII secolo, cioè dell’età in cui nacque. Ha utilizzato nuovi metodi di apostolato e, rompendo con l’isolamento del monachesimo precedente, ha spinto i suoi membri sulle strade e, soprattutto nelle città, allora in pieno sviluppo. In tutti gli ambienti il suo successo è stato clamoroso. San Francesco d’Assisi ha contribuito, grazie alla sua personalità storica e leggendaria, a garantire tale successo. Infatti, la novità del messaggio di Francesco, il suo stile di vita e di apostolato colpirono subito i suoi contemporanei. Tommaso da Celano (1190-1265), frate francescano,scrittore e biografo del santo, celebre per aver composto due Vitae di san Francesco e una Vita di santa Chiara, ha insistito molto sull’originalità del santo, vissuto in un’epoca in cui la tradizione rappresentava un valore essenziale e la novità, invece, era motivo di scandalo.
“Nell’avvilimento in cui, non in particolare, ma in generale, dovunque era caduta la dottrina evangelica, egli fu mandato da Dio a testimoniare per tutto il mondo, come gli apostoli, la verità. Il suo insegnamento mostrò la stoltezza di tutta la sapienza del mondo, ed in breve lo riportò, con l’aiuto di Cristo, per mezzo della stoltezza della sua predicazione, alla vera sapienza di Dio; poiché nuovo evangelista in questi ultimi tempi, come un fiume in Paradiso, inondò il mondo intero con le acque fluenti del Vangelo, e con le opere predicò la vita del Figlio di Dio e la dottrina della verità. Così in lui e per lui si è operato sulla terra un insperato fervore e il santo rinnovamento, con il germe dell’antica religione, ha ringiovanito i rami assai vecchi e induriti […][1]
Gli storici sono stati colpiti anche dalla novità del tipo di santo imposto da Francesco ai suoi contemporanei. Nella Vita prima di Tommaso da Celano,l’aspetto fisico di Francesco è descritto, assai realisticamente, secondo un canone estetico radicalmente opposto a quello tradizionale del santo grande, biondo, improntato al cavaliere nordico: “di media statura, quasi piccolo, la testa rotonda e proporzionata, il volto allungato, la fronte piatta e piccola, gli occhi di media grandezza, neri ingenui, i capelli molto scuri, le sopracciglia diritte, il naso piccolo e rettilineo, le orecchie diritte ma minute, le tempie piatte, i denti ben allineati, regolari bianchi, le labbra sottili, la barba nera, il pelo ineguale, le spalle dritte, le braccia corte, le mani piccole, le dita affilate, le unghie lunghe, le gambe esili, la pelle levigata, scarnita…”[2]
Tale ritratto appare in sintonia con le tendenze essenziali della sensibilità gotica, venata di realismo e di delicatezza, come si può facilmente riscontrare nelle rappresentazioni artistiche dell’epoca dove anche l’umanità di Cristo è fatta visibile e tangibile, perché l’uomo ne tragga luce e conforto. Riproducendo potentemente e rigorosamente, in tutte le sue figure, la realtà, le azioni e passioni della vita, l’arte esprimeva ed affermava l’umanità che aveva ritrovato se stessa.
Gli storici della fine del XIX e XX secolo esaltarono la modernità di San Francesco, iniziatore del Rinascimento e del mondo moderno: accumunavano Francesco di Assisi e Federico II, vedendo in questi due grandi moderni del Medioevo coloro che, ciascuno nella sua sfera , avevano liberato l’Italia e la cristianità dal disprezzo del mondo, dall’ossessione del diavolo, dal peso dell’AntiCristo. Francesco era il liberatore e i caratteri distintivi della religione francescana, ovvero la libertà di spirito, l’amore, la pietà, la serenità gioconda, la fraternità formarono per lungo tempo l’originalità del cristianesimo italiano .
Sicuramente il francescanesimo costituisce ancora oggi una sancta novitas ,secondo la definizione di Tommaso da Celano, una novità santa. Ponendosi come programma un ideale positivo, aperto all’amore per tutte le creature, ancorato alla gioia e non più alla tristezza, rifiutando di essere il monaco della tradizione votato al pianto, Francesco rivoluzionò la sensibilità medievale e cristiana, ritrovando una genuina allegrezza.
Prendendo e proponendo come modello Cristo stesso, egli impegnò la cristianità in un’imitazione del Dio incarnato che dischiuse all’umanità un orizzonte infinito.
Sottraendosi alla tentazione della solitudine per vivere in mezzo alla società vivente, nelle città e non nei deserti,nelle foreste o nelle campagne, ruppe in modo definitivo con un monachesimo che voleva la separazione dal mondo .
San Francesco è stato moderno perché tale era il suo secolo. Come hanno fatto notare alcuni storici, San Francesco non sorge come un albero magico in mezzo ad un deserto, ma è il prodotto di un luogo e di un’epoca, l’Italia comunale al suo apogeo. Ciò che lo colpì fu l’asprezza e la frequenza delle lotte sociali e politiche cui dovette egli stesso prendere parte prima della conversione. Le lotte tra partigiani del papa e partigiani dell’imperatore, tra città, tra famiglie, non facevano che esasperare le opposizioni tra gruppi sociali. Francesco, figlio di mercante , si trovò a metà tra ceti popolari e nobiltà: apparteneva al popolo per nascita, ma era vicino all’aristocrazia per fortuna, cultura e tenore di vita. Voleva essere sempre umile di fronte ai suoi superiori, ma anche al cospetto dei suoi pari e dei sottoposti.
Così, ad esempio, accolse l’ammonimento di un contadino, intento a lavorare il suo campo che egli attraversava in groppa ad un asino, il quale l’esortò a non tradire la fiducia che molti riponevano in lui e ad essere così buono come si diceva. Francesco scese dall’asino, baciò i piedi del contadino e lo ringraziò per la lezione.
Sormontare le fratture sociali, dando l’esempio dell’uguaglianza e della vicinanza ai ceti più diseredati, ai poveri , ai malati e ai mendicanti, fu dunque il suo scopo. E all’interno della società secolare, fu sua aspirazione fare opera di pace .
[1] TOMMASO DA CELANO, Vita Prima di San Francesco d’Assisi, trad.it di A.Calufetti e F. Olgiati, in Fonti Francescane, Edizioni Messaggero, Padova 1983, 482-483.
[2] Ibidem, 476.

