ILLUMINISMO
“Abbi il coraggio di usare la tua testa: è questo il motto dell’Illuminismo” (I. Kant, Risposta alla domanda: che cos’è l’Illuminismo?)
INTRODUZIONE

CARATTERI GENERALI DELL’ILLUMINISMO EUROPEO
Nonostante i grandi progressi in campo di cultura avvenuti nel 1600 per l’ audacia e l’ intelligenza individuale di pochi pensatori , la più diffusa immagine del mondo restava nel 1700 , al termine di quei cento anni rivoluzionari e innovatori , assai vicina a quella di tre o quattro secoli prima . Nell’ ambito della scienza il modello galileiano e quello copernicano , con il Sole fermo al centro , erano ancora lontani dall’ essere universalmente riconosciuti e ciò non solo nei paesi cattolici , ma pure in quelli protestanti , che pure avevano avuto una maggiore alfabetizzazione dovuta soprattutto alla teoria luterana del libero esame : la Bibbia continuava ad essere per la grande maggioranza degli uomini una fonte indiscutibile o almeno assai attendibile di verità . Solo un’ ostilità irriducibile nei confronti della religione poteva portare ad accentuare il contrasto tra scienza e Bibbia , ma di fatto personalità quali Galileo e Newton non misero mai in dubbio la perfetta compatibilità fra il proprio operato fisico e la fede cristiana . Le dimensioni fisiche dell’ universo , quindi , continuavano a rimanere tanto per gli scienziati ( che volevano rimanere fedeli alla Bibbia ) quanto per la gente comune piuttosto ristrette e in molti erano ancora convinti che il mondo fosse stato creato da Dio 4004 anni prima della nascita di Cristo . Tuttavia la scoperta degli indiani d’ America , a suo tempo , aveva creato qualche problema a riguardo della concezione classica del mondo , ma solo una migliore conoscenza del lontano oriente asiatico ( India e Cina ) e una riscoperta del Mediterraneo orientale ( Egitto ) avevano posto l’ umanità di fine 1600 di fronte a problemi insormontabili : le fonti storiche e letterarie di queste terre lontane sembravano testimoniare fatti che implicavano cronologie bizzarre , impossibili da mantenere entro la data 4004 a.C . Certo Aristotele aveva perso buona parte della sua autorità e cominciava ad essere messo in discussione , ma l’ ampliamento della conoscenza delle civiltà asiatiche stava producendo un nuovo effetto imprevisto . Il generale allargamento della prospettiva storica portò allora a un atteggiamento più critico nei confronti dei testi sacri e classici e non mancò chi arrivò a trattare la Bibbia come un qualsiasi testo e non come l’ infallibile parola di Dio , rivelando tra l’ altro le incongruenze di tali testi . Nel 1700 pare davvero inconcepibile che il mondo sia stato creato nel 4004 a.C. e la geologia , che si stava all’ epoca affermando , nell’ esaminare i fossili e i procedimenti di erosione portò alla conclusione che i 6000 anni concessi dalla Bibbia non bastavano per spiegare fenomeni così antichi . Nel 1700 la ricerca scientifica ottiene buoni risultati ; ma questo in fondo era già accaduto nel 1600 : ciò che accade nel 1700 e non nel 1600 é che le novità scientifiche diventano rapidamente patrimonio comune di un maggior numero di uomini , essenzialmente per due fattori : la diffusione dell’ alfabetismo e la nascita di strumenti capaci di trasmettere con facilità le nuove conoscenze . Va senz’ altro notato come in questo periodo si moltiplichino i giornali quotidiani , approfittando anche dell’ attenuazione dei controlli censori sulla stampa : da questo punto di vista , l’ Inghilterra é senz’ altro il paese più ” libero ” , anche perchè qui la censura era stata addirittura abolita ( 1695 ) . Questa apprezzabile alfabetizzazione non fa altro che conferire all’ illuminismo e ai suoi pensatori un carattere tipicamente divulgativo : ci si vuole rivolgere al maggior numero possibile di persone e quindi non si deve scrivere in modo complesso : ecco allora che il latino perde terreno e al trattato filosofico si preferisce il romanzo filosofico , comprensibile anche per un pubblico di media cultura . Se l’ Inghilterra si libera della censura , la Francia invece riesce a scrollarsi di dosso il clima cattolico intollerante e bellicoso che aveva caratterizzato il periodo in cui aveva governato Luigi XIV . Con questa liberazione Parigi torna a diventare la capitale intellettuale del paese ; nella prima fase del 1700 Parigi era già il più grande centro di produzione di idee e il francese si era affermato come lingua internazionale . E proprio a Parigi e in generale in Francia si avvia un rapido sviluppo di una produzione letteraria dotata di una forte carica di critica intellettuale nei confronti delle istituzioni politiche e , soprattutto , religiose . Spontaneamente questo ” esercito ” di saggisti e scrittori si diede un’ identità collettiva , una vera coscienza di partito di opposizione , seppur privo di influenza politica . Essi si chiamarono e si fecero chiamare ” filosofi ” e si attribuirono il compito di sgretolare con i ” lumi della ragione ” tutto ciò che la pesante e morta eredità dei secoli passati aveva trasmesso a un’ epoca che doveva essere una dinamica transizione verso un futuro di progresso e rinnovamento . In Francia si parla di filosofia dei lumi , altrove , in modo più generale , di illuminismo . Ma in fin dei conti che cosa é l’ illuminismo ? Il filosofo tedesco Kant risponde a questa domanda con un breve testo intitolato : ” Risposta alla domanda : che cosa é l’ illuminismo ? ” ; egli dà una definizione che , più che alle manifestazioni storiche del movimento , bada alla trasformazione dell’ atteggiamento intellettuale e culturale che esso comporta in ciascun individuo . L’ illuminismo é uscire dallo stato di minorità intellettuale , divenire maggiorenni sul piano razionale e imparare a pensare con la propria testa , staccandosi nettamente dalla superstizione . Kant definisce così l’ illuminismo : ” L’ illuminismo é l’ uscita dell’ uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a se stesso [ … ] abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza ! E’ questo il motto dell’ illuminismo ” . Rousseau , pensatore francese , dirà : ” grande e bello spettacolo veder l’ uomo uscir quasi dal nulla per mezzo dei suoi propri sforzi ; disperdere , con i lumi della ragione , le tenebre in cui la natura l’ aveva avviluppato ; innalzarsi al di sopra di se stesso ; lanciarsi con lo spirito fino alle regioni celesti : percorrere a passi di gigante , al pari del sole , la vasta distesa dell’ universo ; e , ciò che é ancor più grande e difficile , rientrare in se stesso per studiarvi l’ uomo e conoscerne la natura , i doveri e il fine ” . E’ innegabile il rapporto di parentela tra l’ età del razionalismo (1600) , ossia l’ età dell’ indiscussa onnipotenza della ragione umana , e l’ illuminismo : é evidente come vi siano analogie con l’ illuminismo , che prende il nome proprio dai lumi della ragione . Tuttavia tra razionalismo e illuminismo possono essere ravvisate anche differenze : il 1600 é l’ epoca in cui si riscopre , dopo un lungo periodo di svalutazione durato tutto il medioevo , la ragione umana e come ogni scoperta appena fatta vi é la tendenza ad entusiasmarsi troppo e a non vederne i limiti : ecco allora che nel 1600 i filosofi ripongono tutta la loro fiducia nella ragione in modo acritico , senza domandarsi se essa abbia dei limiti o meno . Nel 1700 , invece , dopo cento anni che questa riscoperta é stata introdotta , ci si comincia a chiedere se la ragione abbia dei limiti o meno : certo l’ illuminismo é figlio del razionalismo in quanto si predilige la ragione ad ogni altro strumento di indagine , ma l’ approccio con la ragione stessa risulta diverso , più ponderato e critico . Ma a questo punto sembra che con l’ illuminismo si ritorni al medioevo perchè in fondo già San Tommaso , che nutriva grande fiducia nella ragione , si era chiesto fin dove potesse arrivare . La vera differenza tra illuminismo e medioevo é che mentre per il medioevo la ragione é limitata da Dio stesso , per l’ illuminismo i limiti della ragione sono imposti dalla ragione stessa : questo lo posso conoscere , quest’ altro no . Locke , filosofo preilluminista , definisce la ragione come una candela che ci illumina il cammino ; é sì l’ unica luce che possa illuminarci il cammino , ma rimane comunque una luce fioca , che non può tutto . E’ anche interessante la metafora di cui si avvale il più grande filosofo illuminista , Kant , nella Critica alla ragion pura : egli dice di aver istituito il tribunale della ragione : la ragione é contemporaneamente sia giudice sia imputato : si vedono i limiti e si dà un giudizio , ma a dare il giudizio é proprio colei che é accusata , la ragione . Ecco allora che per gli uomini del 1700 la ragione non é più un qualcosa di illimitato come era per gli uomini del 1600 , ma é tuttavia l’ unico mezzo a nostra disposizione per conoscere la realtà . Tutti gli illuministi hanno grande fiducia nella ragione umana e nel futuro e grande svalutazione del passato , visto come somma di errori scientifici , ingiustizie sociali e superstizioni religiose ; é soprattutto contro il Medioevo che si scagliano i pensatori settecenteschi , che nutrono grandi speranze nel futuro , che ai loro occhi sarà migliore perchè retto non dalla tradizione e dalla religione , bensì dai lumi della ragione , una ragione uguale dappertutto : non si deve fare questo perchè lo dice la Chiesa o la tradizione , ma perchè la ragione dice che é giusto . Ecco allora che l’ illuminismo ha come sfondo l’ utilitarismo , ossia il far felici con la ragione il maggior numero possibile di uomini ; e il futuro consiste nel progresso : gli illuministi , di fronte all’ antico quesito se il bene consiste nel futuro o nel passato non esitano a scegliere il futuro . E quest’ idea in buona parte l’ hanno derivata dal Cristianesimo ( l’ acerrimo nemico degli illuministi ) che , a differenza delle concezioni classiche del tempo in chiave circolare , colloca l’ uomo su una linea retta strutturando la storia in punti che volgono al progresso : da Adamo fino alla redenzione . All’ atteggiamento illuministico é dunque connesso un sostanziale ottimismo , una fondamentale fiducia nel futuro e nel carattere progressivo della storia umana . La ragione a cui l’ illuminismo affida il compito di rischiarare l’ umanità non é però la ragione assoluta di Cartesio , dalla quale scaturiscono deduttivamente i sistemi metafisici della realtà , ma piuttosto una ragione scientifico – strumentale che , per il suo condizionamento empirico , é assai vicina a quella di Locke e di Newton ( e , più alla lontana , di Galileo . Pur avendo un’ identità collettiva , questo fronte di scrittori costituenti il partito dei filosofi , non avevano un’ identità di vedute su tutti i problemi : su parecchi problemi scientifici la pensavano in modo divergente tra loro , ma é soprattutto interessante notare la differenza nelle opzioni politiche e religiose : tra i filosofi ci furono sia atei dichiarati sia sostenitori dell’ esistenza di Dio , con le più diverse sfumature gli uni dagli altri ; c’ era chi vedeva nella natura la realizzazione di un progetto divino e chi invece pensava che la natura fosse autosufficiente . Ma almeno su un punto tutti i filosofi illuministi erano d’ accordo : il radicale rifiuto della Chiesa cattolica (“schiacciate l’ infame” era uno dei motti), con la sua intolleranza universale , i suoi dogmi inaccettabili per la ragione , il suo appoggio ai regimi tirannici , il suo ruolo di divulgazione dell’ ignoranza e la sua superstizione più profonda . L’ anticlericalismo dei filosofi talvolta era davvero infuocato ; non mancarono coloro che videro nella religione un grande inganno intessuto dai preti di tutte le epoche per tenere i popoli nell’ ignoranza e nell’ impotenza . Tuttavia vi furono anche illuministi ” simpatizzanti ” nei confronti della religione , nella quale vedevano un fenomeno naturale con un nucleo razionale ( l’ esistenza di un Dio buono e ordinatore del mondo ) . Senz’ altro l’ atteggiamento religioso più diffuso presso le compagini dei filosofi illuministi fu il deismo , ossia il credere nell’ esistenza di Dio solo sulla base di argomentazioni razionali , rifiutando ogni forma di rivelazione , un pò come aveva fatto Aristotele a suo tempo vedendo la divinità come ” primo motore ” , come ” causa incausata ” . Non si tratta , certo , di ateismo , tuttavia é evidente come sia assurdo pregare una divinità come quella in cui credevano i deisti , una divinità che di umano non ha nulla e che può essere colta non con la fede , bensì con la ragione : non é un Dio a immagine e somiglianza dell’ uomo ( come invece vuole il ” teismo ” ) , bensì é una sorta di principio metafisico garante dell’ ordine nel mondo . In qualche modo il pensiero anti – cristiano degli illuministi contribuirà ad una vera e propria scristianizzazione tipica del 1700 ; tuttavia sarebbe errato pensare che solo gli illuministi abbiano portato a questa laicizzazione della società : merita allora di essere ricordata la massoneria , ossia l’ associazione segreta che si suppone essersi sviluppata dalla corporazione medioevale dei muratori ; essa , nata in Scozia ed Inghilterra , divenne una vera e propria società e con diramazioni dislocate in tutta l’ Europa . Come gli illuministi , anche la massoneria propugnava il deismo , però in modo più ” terra a terra ” , più comprensibile a tutti : se il popolo si scristianizzò non fu certo perchè leggeva le opere dei filosofi illuministi , ma per via della massoneria e del suo ruolo intermedio di società nè nobile nè popolare . Tuttavia nell’ illuminismo troviamo anche vere e proprie posizioni atee : viene ripresa la definizione di Cartesio dell’ uomo come animale macchina dotato di anima ; ma ad essa si preferisce quella di animale macchina senza anima ; é un ateismo radicale . Ma illuminismo non significa solo anti – cristianesimo ; nel 1700 presso i filosofi nasce il gusto della scoperta per il nuovo , magari con soluzioni spericolate , il che spiega bene la grande passione di questi pensatori per le forme enciclopediche e per i romanzi filosofici , tipici del 1700 ; nasce anche l’ interesse per civiltà diverse rispetto a quella europea : così come la Terra non é più al centro dell’ universo , comincia ad affacciarsi l’ idea che l’ Europa non sia più il centro della Terra . E’ interessante citare a proposito le ” Lettere persiane ” di Montesquieu nelle quali si immagina un gruppo di persiani in visita a Parigi che descrivono tramite lettere ai loro corrispondenti iraniani vita e costumi di una società cattolica e assolutistica , con sguardo distaccato , nella loro nuda oggettività : l’ ovvio e il quotidiano diventano l’ assurdo e il grottesco e il lettore viene abituato all’ ottica del relativismo culturale : la Francia e l’ Europa non sono più il centro , ma solo un angolo del mondo ; ciò che a noi europei pare banale e ovvio perchè ci siamo abituati , agli Iraniani sembrerà ridicolo e bislacco . Una simile operazione , naturalmente , la si potrà compiere con un cinese o con un pellerossa . Si può anche addurre come esempio dell’ interessamento degli illuministi per le civiltà straniere il mito del buon selvaggio , sostenuto da Rousseau , che , a differenza degli altri illuministi , tende a vedere nel progresso qualcosa di fortemente negativo , destinato ad aumentare sempre più la dusuguaglianza tra gli uomini ; ecco allora che egli sintetizza questo concetto nell’ idea del buon selvaggio , non corrotto dalle tradizioni e che con la sua ragione può arrivare ad una concezione di Dio più pura e veritiera di quella di un teologo cattolico . Rousseau riscopre quindi una nozione moderna di primitivo , capace di illuminare il passato e la storia della civilizzazione umana . Se é vero che presso gli illuministi affiora l’ interesse per le culture diverse , tuttavia dobbiamo specificare che l’ Europa finisce comunque per rimanere al centro : in altre parole , l’ esame che Montesquieu e Rousseau fanno di civiltà lontane ed estranee all’ Europa non é volto effettivamente a conoscere meglio le medesime , ma a vedere l’ Europa e gli Europei da un altro punto di vista . Ma il manifesto del partito illuminista é senz’ altro l’ Enciclopedia , un’ opera mastodontica prevista in 17 grandi volumi che illustra attraverso i suoi articoli disposti alfabeticamente i progressi della scienza e della tecnica e che discute con la libertà consentita dal sistema di censura francese i grandi problemi teologici , filosofici e politici . La direzione del progetto era stata affidata a uno dei più vivaci e originali pensatori illuministi , Denis Diderot , e al matematico famoso un pò ovunque d’ Alembert : l’ intero partito dei filosofi era stato chiamato a raccolta per dar vita a quest’ opera di ampio respiro , baluardo della filosofia illuministica . L’ opera potè superare tutte le opposizioni ( forti erano soprattutto quelle dei gesuiti ) e godette perfino dell’ appoggio di molti aristocratici . Le vicende dell’ Enciclopedia sono esemplari : dimostrano come la cultura illuminista non tema rivali e come coi lumi della ragione tutto può essere vinto . Tuttavia dobbiamo dire che la forma enciclopedica , di misure mastodontiche , non era la sola forma di stesura : c’ erano , come accennavamo , i romanzi filosofici e in più anche il pamphlet , breve e non tecnico , alla portata di tutti . Molti studiosi hanno pensato che l’ illuminismo fosse una cultura tipicamente borghese , cosciente della propria opposizione globale alla società del tempo . Però non é del tutto corretto : infatti i borghesi non leggevano i testi illuministi in quanto totalmente assorbiti da attività più proficue ; essi circolavano soprattutto nei salotti aristocratici e non é quindi scorretto affermare che l’ illuminismo finì per diventare una manifestazione dello scetticismo dell’ aristocrazia e della sua perdita dei valori tradizionali . Detto questo , bisogna ora affrontare le posizioni degli illuministi in ambito politico : gli illuministi erano tutti grandissimi ammiratori del sistema liberale inglese ed erano tutti d’ accordo su alcuni punti essenziali : la completa libertà di religione , la fine del potere culturale della Chiesa cattolica , la libertà di stampa ( come già avveniva in Inghilterra ) , l’ abolizione dei privilegi fiscali , il netto ridimensionamento dell’ assolutismo regio . Ma anche in campo politico , come in campo religioso , non ci fu mai una totale identità di idee tra gli illuministi . Nel 1734 , nelle ” Lettere filosofiche ” Voltaire prende in esame il sistema parlamentare inglese ; nel 1748 Montesquieu argomenta in favore di tale sistema nella sua opera più importante , ” Lo spirito delle leggi ” : a suo avviso il sistema delle leggi di ciascun paese ha uno spirito , una logica occulta e quindi esse non sono il risultato del caso ; il che deve rendere consapevole chi cerca di attuare dei progetti di riforma che non tutte le evoluzioni sono facili o possibili . Un riformatore che non tiene in considerazione la struttura sociale di un paese , delle sue tradizioni , della densità umana , dell’ estensione geografica e dei determinismi ambientali é destinato a fallire . Le leggi non sono soltanto il prodotto della volontà del legislatore , ma ” intese nel loro significato più ampio , sono i rapporti necessari che derivano dalla natura delle cose ” , dice Montesquieu . Egli ravvisa tre modelli fondamentali : 1 ) repubblicano : , fondato sulla virtù e sulla libertà ( repubblica romana e cantoni svizzeri ) ; 2 ) tirannico : ispirato dalla paura dei sudditi ( in ultima istanza schiavi ) nei confronti del sovrano – tiranno : il sovrano é padrone assoluto del popolo ( civiltà orientali , Russia ) ; 3 ) governi temperati ( o moderati ) : c’ é un monarca e il rapporto monarca – sudditi é temperato da corpi intermedi : il suddito non é mai completamente solo di fronte al sovrano . Montesquieu é convinto che queste tre forme siano dettate dalle condizioni climatiche : la tirannide é tipica delle grandi pianure ( Russia ) dove la società , quasi come il terreno , si appiattisce : il cittadino é solo di fronte al sovrano , che su di lui può tutto . Le migliori sembrano le piccole repubbliche , ma esse vanno bene solo su territori ridotti ; quindi i più adatti per l’ Europa sono i regimi temperati , le monarchie costituzionali : se la Francia non degenera in tirannide , secondo Montesquieu é solo perchè il regime é temperato da organi intermedi quali l’ aristocrazia e il parlamento . Montesquieu guarda con simpatia al sistema inglese , ma sa di non poterlo trasferire in Francia in maniera pura e semplice . Dell’ Inghilterra bisogna secondo lui imitare soprattutto un elemento , la pratica di dividere il potere tra istituzioni diverse , la migliore procedura per evitare la tirannide : la magistratura dovrà essere totalmente dipendente dal potere del governo , il parlamento dovrà emanare leggi generali , il re e il suo governo dovranno eseguire le leggi e svolgere gli incarichi di alta politica , senza che nessuno dei tre poteri cerchi di usurpare le funzioni altrui . Tuttavia accanto a posizioni liberali , ne troviamo altre di stampo democratico in Rousseau , uno dei pochi illuministi a guardare al popolo con discreta simpatia : nella democrazia ognuno deve rinunciare ai propri per cederli ad un’ istanza superiore ; già Hobbes e Spinoza , nel secolo passato , avevano fatto discorsi simili ; per Hobbes però il sovrano era un qualcosa a parte , per Spinoza invece non é altro che la società che acquisisce in collettivo i diritti di cui si é privata singolarmente ; Rousseau la pensa come Spinoza : io cittadino contribuisco per quel che mi compete a elaborare le leggi che poi sono tenuto a rispettare , cedo i miei diritti di singolo per poi riacquistarli come collettivo : é la maggioranza a decidere le leggi e la volontà della maggioranza va vista come volontà di tutti : il paradosso é che devo considerare volontà mia ( ciò che ha deciso la maggioranza ) anche ciò che va contro la mia volontà . E’ bene quindi sottolineare come democrazia e liberalismo non siano la stessa cosa , ma anzi siano quasi concetti antitetici : il liberalismo consiste nel difendere il singolo cittadino ritagliando uno strato privato del cittadino intoccabile anche per lo Stato ; la democrazia invece vuole che tutti abbiano diritto a partecipare alle decisioni politiche ma che poi chi perde debba ” subire ” riconoscendo sue volontà che sue non sono , ma che tali ha deciso la maggioranza . Durante il 1700 non mancarono anche le utopie comunistiche , che si opponevano al progresso materiale che andava contro la coesione sociale e l’ uguaglianza tra gli uomini : queste utopie sono quasi un distacco dalla società ingiusta per rintanarsi con l’ immaginazione in una società giusta e garante dell’ uguaglianza . In ambito politico , come accennato , prevalse il liberalismo mentre in campo economico il liberismo , ossia la teoria secondo la quale lo Stato non deve intromettersi nell’ economia del cittadino . Il liberismo si basò soprattutto su una critica al mercantilismo ( ossia quella teoria che sosteneva che le ricchezze non fossero in crescita e che l’ unico modo per arricchirsi fosse farle entrare nel proprio Stato per poi non farle più uscire ) : non é vero che i traffici delle principali potenze commerciali stavano crescendo gli uni a spese degli altri . Tuttavia l’ intera discussione liberista assume due diverse posizioni ; da un lato troviamo la fisiocrazia ( soprattutto in Francia ) , dall’ altro troviamo l’ economia politica classica ( soprattutto in Inghilterra ) . Ma quali sono le differenze ? La fisiocrazia (fusiV + kratoV) é , in generale , il governo della natura ed é significativo che si sviluppi in Francia , dove l’ agricoltura era il settore primeggiante . I fisiocratici sostenevano che la vera ricchezza derivasse dalla natura , dalla coltivazione dei campi , in parole povere dall’ agricoltura . Certo aveva anche un significato metaforico questo governo della natura : i fisiocratici erano pur sempre illuministi e si richiamavano a ciò che é naturale ( la natura appunto ) in contrapposizione a ciò che é artificiale , riallacciandosi essenzialmente al mito del buon selvaggio di Rousseau ; i fisiocratici francesi sono convinti che nella ragione sia insita un’ organizzazione politica giusta , ma che gli uomini si siano visti dare costituzioni e sovrani ingiusti , che vanno contro la ragione . Rousseau questo aspetto lo coglierà dal punto di vista sentimentale ( ” La nuova Eloisa ” ) : il matrimonio per lui si deve fondare sul sentimento e non sui soldi , come capitava all’ epoca : tutti gli illuministi rivendicano ciò che é giusto per ragione in contrasto con ciò che é giusto per convenzione. I fisiocratici , sostenendo il governo della natura , sono convinti che l’ economia abbia le sue leggi naturali : spetta allo Stato non influenzarle ; esso per l’ economia non deve fare assolutamente niente , se non riscuotere le tasse . L’ idea generale fisiocratica é che , visto che l’ economia ha le sue leggi naturali , é ovvio che se lasciata a sè e alla natura non può che andare bene ! Ecco allora la caratteristica frase politica fisiocratica : laissez faire, laissez passer (“lasciate fare, lasciate passare”) ; se anche c’ é una carestia non bisogna intervenire : secondo gli illuministi se ci fosse una crisi in Piemonte , per dire , il grano arriverebbe comunque dalle zone vicine ( la Lombardia per esempio ) dal momento che in Piemonte , essendoci crisi salgono i prezzi perchè il grano scarseggia , e i venditori lombardi ci guadagnano solo a venire in Piemonte a vendere il grano perchè potranno venderlo a prezzi più cari che non in Lombardia . Ci fu un fisiocratico illuminista , di nome Turgot , che potè applicare questa teoria alla corte di Luigi XVI : ci furono grandi carestie e lui , da buon fisiocratico , propose di non intervenire ma la situazione non migliorò affatto : il grano non arrivò e Turgot fu licenziato e le sue teorie fisiocratiche vennero abbandonate . Va subito detto che se il progetto di Turgot si rivelò fallimentare fu solo perchè un’ economia di tipo fisiocratico é efficace solo con mezzi di traspoorto efficaci ( che all’ epoca non c’ erano ancora ) , ossia se il grano può arrivare in fretta laddove scarseggia . L’ economia politica classica ravvisa il suo esponente più importante nello scozzese Adam Smith : egli , in un periodo in cui si discuteva ampiamente se la vera ricchezza fosse nell’ agricoltura o nell’ industria , si chiese : ma che cosa é che fa il valore di una cosa ? La risposta che trovò fu sostanzialmente questa : la cristallizzazione del lavoro presente nella merce in questione . Di fatto tutte le cose che abitualmente compriamo o vendiamo sono incommensurabili e sarebbe quindi impossibile effettuare vendite o acquisti : un fruttivendolo che vada da un calzolaio quanti kg di patate dovrebbe dargli per avere un paio di scarpe ? E’ assurdo ! Teoricamente si potrebbero solo scambiare merci uguali : patate con patate e scarpe con scarpe . Eppure noi sappiamo che le scarpe e le patate hanno un loro valore , che é dato dal lavoro presente in esse : un tot di lavoro per fare le scarpe e un tot per le patate . Quindi il perno dell’ economia per Smith non é l’ agricoltura ( come era invece per i fisiocrati francesi ) bensì l’ industria ; la teoria economica di Smith , proprio per distinguerla da quella fisiocratica francese , verrà definita ” economia politica classica ” . Tra le varie ” scoperte ” di Adam Smith c’é anche quella dell’ importanza della divisione del lavoro : contò che per produrre uno spillo occorrevano 19 passaggi e capì che facendo fare un solo passaggio ad una sola persona si ottenevano due effetti positivi : innanzitutto costava meno perchè si trattava di manodopera meno qualificata , dovendo fare solo un passaggio . Poi si accorse che effettuando un solo passaggio l’ operaio finiva per diventare bravissimo . Smith , tuttavia , si accorse anche dei limiti della suddivisione del lavoro : un fabbricatore di liuti ha un rapporto soggettivo con ciò che produce , lo fa con amore perchè lo vede nascere e poi lo vede finito ; un operaio al quale spetti un solo passaggio non può avere questo rapporto con ciò che produce e , per di più , il compiere sempre e solo lo stesso passaggio causa in lui un abbrutimento fisico . Riprendiamo ora in modo più approfondito la questione della mano invisibile : per Smith lo stato non deve assolutamente intervenire nell’ economia ( egli é quindi un liberista ) e le cose vanno lasciate al loro destino senza interventi statali : ciascuno deve fare i propri interessi ; d’ altronde Smith diceva : ” non é dalla generosità del macellaio , del birraio o del fornaio che noi possiamo sperare di ottenere il nostro pranzo , ma dalla valutazione che essi fanno dei propri interessi ” . Ma allora , dirà qualcuno , ci sarà chi si arricchisce e chi si impoverisce sempre più ! Per Smith non é così : se tutti fanno i propri interessi é ovvio che aumenterà in qualche misura la ricchezza collettiva e tutti godranno dei vantaggi , sebbene in maniera diversa : é ovvio che chi investe guadagnerà di più del povero , ma tuttavia anche quest’ ultimo avrà un incremento positivo di ricchezza : ” cercando per quanto può di impiegare il suo capitale a sostegno dell’ industria interna e di indirizzare questa industria in modo che il suo prodotto possa avere il massimo valore , ogni individuo contribuisce necessariamente quanto può a massimizzare il reddito annuale della società … egli mira soltanto al proprio guadagno e in questo , come in molti altri casi , egli è condotto da una mano invisibile a promuovere un fine che non entrava nelle sue intenzioni . Nè per la società è un male che questo fine non entrasse nelle sue intenzioni . Perseguendo il proprio interesse , egli spesso promuove quello della società in modo più efficace di quando intende realmente realmente promuoverlo . ” Quello che può essere considerato un vizio nel campo privato , ossia il fare i propri interessi , diventa una virtù nel campo pubblico . La forma più tipica della politica illuministica é indubbiamente l’ assolutismo illuminato , ossia il punto di incontro tra il governo assoluto ( la cui politica si può sintetizzare in una celebre frase di Luigi XIV : ” lo stato sono io ” ) e l’ illuminismo , incontro che avviene sostanzialmente tra il 1740 e il 1790 ; si capisce che per riformare ci si deve avvalere delle teorie illuministe . Gli illuministi intendono , sulla scia di quanto pensava Montesquieu , arrivare ad un compromesso che equilibri i rispettivi poteri ( monarchia , parlamento , ecc ) . I filosofi non avevano certo troppa fiducia nel popolo , nel quale tendevano a vedere una massa senza cervello succube degli inganni della religione ; certo si sarebbe voluto togliere il popolo dalla lunga notte dell’ ignoranza con i lumi della ragione , ma in fin dei conti gli illuministi preferirono riformare l’ alta società : bisognava conquistare i vertici della società , che detenevano il potere politico ed economico e non il popolo : ma l’ assolutismo illuminato dimostrerà ben presto i suoi limiti , trovando resistenze nella società stessa ( che si oppone con rivolte ) o talvolta nei sovrani ” illuminati ” , che accettano la collaborazione dell’ illuminismo finchè funzionale al rafforzamento del loro potere di sovrani ; in altre parole abbiamo sovrani molto assoluti e poco illuminati . L’ assolutismo illuminato si arena , pur avendo sortito qualche effetto positivo quale la stesura di catasti , ossia veri e propri censimenti degli averi dei cittadini volti a far pagare a tutti le tasse e a servire come spunto per gli investimenti ; l’ assolutismo illuminato fece sviluppare la cultura ( anche quella del clero tramite seminari ) e diede contro alla Chiesa : l’ illuminismo le diede contro perchè la riteneva una forma di superstizione , l’ assolutismo perchè vedeva in essa un rivale per il suo potere , un contropotere : il cattolicesimo prevedeva una duplice fedeltà ( al re e al papa ) e la Chiesa finiva per essere uno stato dentro lo stato . L’ assolutismo illuminato si affermò un pò ovunque in Europa , fatta eccezione per lo Stato Pontificio , per Venezia ( che era un’ oligarchia ) e per l’ Inghilterra , dove non c’ era l’ assolutismo , bensì il parlamento e dove le riforme erano già tutte avvenute nel secolo passato . Ma l’ assolutismo illuminato finì per arenarsi per diversi motivi : in primo luogo assolutismo e illuminismo sono e restano due cose ben differenti tra loro che non potranno mai essere del tutto congiunte ; in secondo luogo anche quando c’ era un monarca davvero illuminato ( quale fu , ad esempio , Giuseppe d’ Austria ) , fu la società ad ostacolare i progetti . Dobbiamo ancora fare una precisazione : da come abbiamo finora descritto l’ illuminismo , sembrerebbe essere il trionfo della fredda ragione e del meccanicismo , il vedere l’ universo come una grande macchina ; ma in realtà , sebbene in una prima fase l’ illuminismo non si discostasse molto da come l’ abbiamo appena descritto , dobbiamo dire che si assistette ad una seconda fase dove accanto alla ragione ( che pure si ammorbidisce , passando da scienze matematiche a scienze biologiche e chimiche ) nacque il sentimento : sarà ancora una volta Rousseau a dare la spinta iniziale : egli con ” La nuova Eloisa ” si schiera in favore ad un amore romantico e passionale contro le ragioni pratiche dettate dalla tradizione ; così come in economia non bisogna intromettersi e sovvertire le leggi della natura , anche in amore non bisogna immischiarsi , bensì bisogna lasciar trionfare la natura e l’ amore ; invece con l’ ” Emilio ” difende la figura del bambino che , secondo la tradizionale etica aristotelica , era privo di valore in quanto ” uomo in potenza ” : non aveva un valore in sè , ma aveva un valore come futuro uomo : non c’ era bisogno di tenere in considerazione le esigenze del bambino . Rousseau invece attribuisce valore e dignità al bambino in sé : in primis bisogna prendersi cura del bambino in quanto tale e solo dopo di ciò che sarà ; Emilio , il bambino che dà il nome all’ opera , viene messo dal maestro nelle condizioni di fare esperienze che gli permettano di imparare direttamente dalla natura . Quindi con l’ ” Emilio ” si dà nuova dignità al bambino , con la ” Nuova Eloisa ” alla donna , che non é più vista esclusivamente come ” creatrice di bambini ” , ma comincia ad assumere un valore di per sè . Va poi sottolineato , sempre a riguardo del sentimento e dell’ umanità illuministica , il rifiuto del diritto penale tradizionale , con il suo apparato di torture e pene orripilanti e fantasiose sul corpo del delinquente . Merita aìdi essere citato a proposito il libro del filosofo illuminista italiano Cesare Beccaria intitolato ” Dei delitti e delle pene ” , che ebbe una risonanza europea . Egli si schierò apertamente in primis contro la tortura , sottolineando come essa colpisca tanto i colpevoli quanto gli innocenti e come sotto tortura chiunque confessi , anche se innocente . Inoltre egli parlò contro la pena di morte , che a quei tempi era vista come una forma di vendetta istituzionalizzata ; nel 1700 lo Stato in generale si é nettamente rafforzato e i delinquenti vengono comunque catturati con più facilità : il delinquente sa che corre il rischio di essere preso e dovrà essere punito e quindi non agirà comunque , che ci sia o che non ci sia la pena di morte . Beccaria poi fa notare come la pena debba avere due funzioni : in primis deve correggere il criminale ( e uccidendolo non lo si corregge ) ; essa poi deve rendere più sicura la società . Anche una pena ” mite ” , purchè lo Stato sia efficiente e garantisca l’ applicazione della pena stessa , può funzionare per correggere perchè se so che sarò punito mi guarderò bene dal commettere ingiustizia . Fino al secolo passato la pena di morte era uno spettacolo pubblico ; con il 1700 invece spariscono le compiacenze pedagogiche verso i pubblici squartamenti degli assassini e dei parricidi : la gente non vuol più assistere a questi spettacoli tremendi ; ecco allora che entra in gioco il sentimento.
L’ILLUMINISMO ITALIANO
In Italia la diffusione della cultura illuministica si sviluppa in ritardo rispetto agli altri paesi europei. Ciò è dovuto al differente contesto storico-culturale della penisola. L’arretratezza economica, l’immobilità delle istituzioni, l’instabilità politica dovuta alla catena delle guerre di successione, l’assenza di una borghesia dotata di consistente peso economico-sociale, l’assolutismo delle dinastie regie, la pesante atmosfera controriformistica, il prevalere di una cultura umanistica e storico-erudita, dimentica della tradizione scientifica galileiana, producono per lungo tempo una situazione di stasi sociale ed intellettuale (la cui unica eccezione è costituita dal Vico). Solo con la pace di Aquisgrana (1748), che assicura al paese un arco quarantennale di pace, la situazione generale della penisola comincia a dare segni di risveglio. In campo politico, Milano, Parma, Firenze e Napoli, grazie alle nuove dinastie riformatrici degli Asburgo, dei Lorena e dei Borboni, che si ispirano ai “dispotismi illuminati” europei, avviano una serie di riforme in senso anti-feudale ed anti-clericale. Per ciò che riguarda la cultura, da un lato si ha lo studio e la divulgazione di importanti opere d’Oltralpe (compresa la traduzione della Enciclopedia), dall’altro si ha la creazione di una cattedra di economia a Napoli e la fondazione del giornale milanese ,Il Caffè, nel cui ambito abbiamo la comparsa di un libro di valore europeo: Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria. Invece negli altri stati italiani, soprattutto nel Piemonte e nello Stato pontificio, la situazione tende a rimanere stagnante e le tendenze autoritarie dei governanti impediscono una consistente diffusione del pensiero illuministico, anche se non riescono a frenare l’eco delle nuove idee. Pur non essendo privo di debiti verso il pensiero inglese, l’Illuminismo italiano – che non è fatto di ” grandi solitari ” ma di figure di media statura impegnate in problemi sociali e cariche pubbliche – appare strettamente connesso a quello francese ed ha come sua caratteristica l’apertura verso problemi morali, giuridici ed economici. Perciò l’importanza dell’Illuminismo deve “essere rintracciata prevalentemente sul piano politico, dove esso rappresenta una vigorosa reazione al disinteresse per la cosa pubblica e alla separazione della cultura dalla società… Più empiristico di quello tedesco, meno speculativamente penetrante di quello inglese, meno radicale di quello francese, l’Illuminismo italiano non è per questo impedito dallo svolgere la sua specifica funzione, organicamente commisurata alle esigenze della società del tempo e capace di creare una temperie culturale vivace “. In Italia, come detto, i due centri in cui l’Illuminismo trova terreno più fertile per la sua diffusione sono Napoli e Milano: a Napoli lo spirito dell’Illuminismo trova i suoi precursori soprattutto in Ludovico Antonio Muratori (1672-1750) e in Pietro Giannone (1676-1748). Il primo, storico ed erudito di fama europea, autore degli Annali d’Italia (1744-1749) e delle Riflessioni sopra il buon gusto nelle lettere e nelle arti (1708), è importante per la polemica contro i ritardi della cultura italiana del tempo e per aver stabilito alcuni principi della metodologia storiografica critico-scientifica: la messa tra parentesi della tradizione, l’accertamento della realtà dei fatti e dell’autenticità dei documenti, il rispetto dell’oggettività storica. Il secondo, autore della Istoria civile del Regno di Napoli (1723), mostra come il potere ecclesiastico abbia, per via di successive usurpazioni, limitato e indebolito il potere politico e come sia interesse di questo ridurre lo stesso potere ecclesiastico nei puri limiti spirituali. Il Giannone si attendeva dalla sua opera tra l’altro “il rischiaramento delle nostre leggi patrie e dei nostri propri istituti e costumi”.Una figura che appartiene più all’Illuminismo francese che all’italiano è quella del napoletano abate Ferdinando Galiani (1728-1787) che fu per dieci anni (1759-1769) segretario dell’Ambasciata del Regno di Napoli a Parigi e dominò i salotti intellettuali della capitale francese con il suo spirito e il suo brio. Galiani fu specialmente un economista. Il suo trattato Della moneta (1751) è diretto a criticare la tesi del mercantilismo che la ricchezza di una nazione consista nel possesso dei metalli preziosi. Le sue idee filosofiche, non esposte in forma sistematica, ma gettate qua e là come motti di spirito, sono contenute nelle Lettere (scritte in francese) e sono in tutto conformi alle idee dominanti nell’ambiente francese in cui Galiani è vissuto. Nei filosofi i quali affermano che tutto è bene nel migliore dei mondi, Galiani vede degli atei patentati che, per paura di essere arrostiti, non hanno voluto terminare il loro sillogismo. Ed ecco qual è questo sillogismo. “Se un Dio avesse fatto il mondo, questo sarebbe senza dubbio il migliore di tutti; ma non lo è, neppur da lontano; dunque non c’è Dio”. A questi atei camuffati bisogna rispondere, secondo Galiani, nel modo seguente: “Non sapete che Dio ha tratto questo mondo dal nulla? Ebbene, noi abbiamo dunque Dio per padre e il nulla per madre. Certamente nostro padre è una grandissima cosa, ma nostra madre non vale niente del tutto. Si prende dal padre, ma si prende anche dalla madre. Ciò che vi è di buono nel mondo viene dal padre e ciò che vi è di cattivo viene dalla signora nulla, nostra madre, che non valeva gran che” (Lett. all’Abate Mayeul, 14 dicembre 1771). Dal sensismo francese deduce il fondamento delle sue dottrine economiche Antonio Genovesi (1712-1769) che fu il primo in Europa a professare nelle università la nuova scienza dell’economia: ricopri infatti, dal 1754, la cattedra di lezioni di commercio nell’Università di Napoli. Genovesi riconosce come principio motore, sia degli individui sia dei corpi politici, il desiderio di sfuggire al dolore che deriva dal bisogno inappagato e chiama tale desiderio interesse, considerandolo come ciò che sprona l’uomo, non solo alla sua attività economica, ma anche alla creazione delle arti, delle scienze e ad ogni virtù (Lez. di commercio, ediz. 1778, 1, p. 57). Genovesi è anche autore di opere filosofiche: Meditazionifilosofiche sulla religione e sulla morale (1758); Logica (1766); Scienze metafisiche (1766); Diceosina ossia dottrina del giusto e dell’onesto ( 17 76). Nelle Meditazioni egli rifà a suo modo il procedimento cartesiano; ma riconosce il primo principio non nel pensiero ma nel piacere di esistere. Questo indirizzo che sembra derivato da Helvétius non impedisce al Genovesi di difendere le tesi dello spiritualismo tradizionale: la spiritualità e l’immortalità dell’anima, il finalismo del mondo fisico e l’esistenza di Dio. A Montesquieu si ispirava Gaetano Filangieri (1752-1788) nella sua Scienza della legislazione (1781-1788), che mette a partito l’opera del filosofo francese per dedurne ciò che si deve fare per l’avvenire, cioè per trarne i principi e le regole di una riforma della legislazione di tutti i paesi. Dalla riforma della legislazione, Filangieri si attende il progresso del genere umano verso la felicità e l’educazione del cittadino. Ispirato da questa fiducia ottimistica nella funzione formatrice e creatrice della legge, il Filangieri delinea il suo piano di legislazione. Nel quale è notevole una difesa dell’educazione pubblica, difesa che muove dal principio che solo essa può avere uniformità di istituzioni, di massime e di sentimenti e che per ciò soltanto la minor parte possibile dei cittadini va lasciata all’educazione privata.La dottrina di Vico delle tre età e dei corsi e ricorsi storici è ripresa nello spirito dell’Illuminismo da Mario Pagano (1748-1799) nei Saggi politici dei principi, progressi e decadenza della società (1783-1785). Ma a Pagano è estranea completamente quella problematicità della storia che domina l’opera di Vico. Il corso e ricorso delle nazioni è per lui un ordine fatale, dovuto più a cause fisiche che a cause morali. Pagano considera il mondo della storia come un mondo naturale, le cui leggi non sono diverse da quello fisico. L’altro centro dell’Illuminismo italiano fu Milano dove una schiera di scrittori si riunì intorno a un periodico, Il Caffè, che ebbe vita breve ed intensa (1764-1765). Il giornale, concepito sul modello dello Spectator inglese, fu diretto dai fratelli Verri, Pietro e Alessandro, e vi collaborò fra gli altri Cesare Beccaria. Alessandro Verri (1741-1816) fu letterato e storico. Pietro Verri (1728-1797) fu filosofo ed economista. In un Discorso sull’indole del piacere e del dolore (1773) Pietro Verri sostiene il principio che tutte le sensazioni, piacevoli o dolorose, dipendono, oltre che dall’azione immediata degli oggetti sugli organi corporei, dalla speranza e dal timore. La dimostrazione di questa tesi è fatta dapprima per ciò che riguarda il piacere e il dolore morale, riportati a un impulso dell’anima verso l’avvenire. Il piacere del matematico che ha scoperto un teorema deriva, per esempio, dalla speranza dei piaceri che lo aspettano in avvenire, dalla stima e dai benefici che la sua scoperta gli apporterà. Il dolore per una disgrazia è similmente il timore dei dolori e delle difficoltà future. Ora poiché la speranza è per l’uomo la probabilità di vivere nel futuro meglio che nel presente, essa suppone sempre la mancanza di un bene ed è per ciò il risultato di un difetto, di un dolore, di un male. Il piacere morale non è che la rapida cessazione del dolore ed è tanto più intenso quanto maggiore fu il dolore della privazione o del bisogno. Il Verri estende poi la sua dottrina anche ai piaceri e ai dolori fisici, facendo vedere come molte volte il piacere fisico non è che la cessazione di una privazione naturale o artificiale dell’uomo. All’obiezione che la tesi si può invertire, sostenendo con eguale verisimiglianza che ogni dolore consiste nella rapida cessazione del piacere, il Verri risponde che una simile generazione reciproca non si può dare, perché “l’uomo non potrebbe cominciare mai a sentire né piacere né dolore; altrimenti la prima delle due sensazioni di questo genere sarebbe e non sarebbe la prima in questa ipotesi, il che è un assurdo” (Discorso, 6). Verri giunge a confermare la conclusione che Maupertuís aveva tratto dal suo calcolo, e cioè che la somma totale dei dolori è superiore a quella dei piaceri. Difatti la quantità del piacere non può mai essere superiore a quella del dolore perché il piacere non è che la cessazione del dolore. ” Ma tutti i dolori’che non terminano rapidamente sono una quantità di male che nella sensibilità umana non trova compenso e in ogni uomo si dànno delle sensazioni dolorose che cedono lentamente” (ivi, 6). Anche i piaceri delle belle arti hanno la stessa origine: a loro fondamento ci sono quelli che Verri chiama dolori innominati. L’arte non dice nulla agli uomini che sono tutti presi dalla gioia e parla invece a coloro che sono occupati dal dolore o dalla tristezza. Il magistero dell’arte consiste anzi nello ” spargere le bellezze consolatrici dell’arte in modo che ci sia intervallo bastante tra l’una e l’altra per ritornare. alla sensazione di qualche dolore innominato, ovvero di tempo in tempo di far nascere delle sensazioni dolorose espressamente, e immediatamente soggiungervi un’idea ridente, che dolcemente sorprenda e rapidamente faccia cessare il dolore” (ivi, 8). La conclusione è che “il dolore è il principio motore di tutto l’uman genere”. Da questi presupposti muove l’altro discorso di Verri Sulla felicità. Per l’uomo è impossibile la felicità pura e costante, ed invece è possibile la miseria e l’infelicità. L’eccesso dei desideri sulle nostre capacità è la misura dell’infelicità. L’assenza dei desideri è piuttosto vegetazione che vita, mentre la violenza dei desideri può essere provata da ognuno ed è talvolta uno stato durevole. La saggezza consiste nel commisurare in ogni campo i desideri alle possibilità e perciò la felicità non è fatta che per l’uomo illuminato e virtuoso.
GEORGE BERKELEY
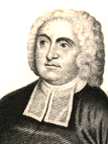
George Berkeley (Kilkenny, 12 marzo 1685 – Oxford, 14 gennaio 1753) è stato un filosofo e teologo irlandese, uno dei tre grandi empiristi britannici assieme a John Locke e David Hume. Si laureò a Dublino nel 1707 e ben presto formulò il principio fondamentale della sua metafisica: l’immaterialismo. Nel 1709 pubblicò il Saggio di una nuova teoria della visione e l’anno dopo il Trattato sui principi della conoscenza umana. Nel 1713 scrisse anche i Dialoghi tra Hylas e Philonous. Dopo alcuni anni trascorsi in studi e viaggi concepì il proposito di evangelizzare e civilizzare i selvaggi d’America. Così nel 1728 partì per fondare un collegio nelle isole Bermude. Poi si fermò a Rhode Island attendendo inutilmente i sussidi promessigli fino al 1731. In questo periodo compose l’Alcifrone, un dialogo polemico contro i liberi pensatori dell’epoca. In seguito ritornò a Londra per proseguire i suoi studi, prima di essere nominato vescovo di Cloyne in Irlanda, dove si stabilì. Nel 1744, credendo di aver trovato un medicamento miracoloso alle epidemie che colpirono l’Irlanda, scrisse la Siris, in cui giunge ad una dottrina metafisica di stampo neoplatonico. Per Berkeley l’unico scopo autentico della filosofia è quello di confermare e avvalorare la visione della religione: è Dio, infatti, l’unica causa della realtà naturale. Berkeley era contro l’esistenza delle idee astratte e fautore di un nominalismo radicale. Infatti secondo l’irlandese non esistono idee generali o universali, ma semplici idee particolari usate come segni, appartenenti ad un gruppo di altre idee particolari tra loro affini. Gli oggetti che noi crediamo esistere sono in realtà delle astrazioni ingiustificate; non esistono oggetti corporei, ma soltanto collezioni di idee che ci danno una falsa impressione di materialità e sussistenza complessiva. La celebre formula che riassume la filosofia di Berkeley, «Esse est percipi», significa “l’essere è essere-percepito”, ossia: tutto l’essere di un oggetto consiste nel suo venir percepito e nient’altro. La teoria immaterialistica così enunciata sentenzia che la realtà si risolve in una serie di idee che, per essere considerate esistenti, hanno bisogno di essere percepite da uno spirito umano. È Dio, spirito infinito, che ci fa percepire sotto forma di cose e fatti le sue idee calate nel mondo. Idee, in un certo senso, “umanizzate”, e in quanto tali “percepibili”. La dottrina di Berkeley esclude in virtù di questo principio l’esistenza assoluta delle cose. Secondo il teologo irlandese tutto ciò che esiste è o idea o spirito, quindi le cose non sono altro che le idee. Berkeley nega la distinzione fra qualità primarie e secondarie, propria di Locke, (tutte le qualità sono secondarie, cioè soggettive) e anche l’idea di substrato, ovvero di materia. Se esistesse una materia, essa sarebbe soltanto un limite alla perfezione divina. In questo senso anche la scienza di Newton non ha altro valore che quello di una mera ipotesi, che ci aiuta a fare previsioni per il futuro, ma non ha alcun riferimento con la realtà materiale, che non solo non è conoscibile, ma non esiste affatto. Le idee, secondo Berkeley, vengono impresse nell’uomo da uno spirito infinito, cioè Dio. Inoltre lo stesso Dio si configura come la Mente infinita grazie a cui le idee esistono anche quando non vengono percepite. Berkeley porta quindi alle estreme conseguenze l’empirismo di Locke, giungendo a negare l’esistenza di una sostanza materiale perché non ricavabile dall’esperienza, e recidendo così ogni possibile legame tra le nostre idee e una realtà esterna. Egli anticipa lo scetticismo di Hume, ma se ne mette al riparo ammettendo una presenza spirituale che spieghi l’insorgere di simili idee dentro di noi, rendendocele vive e attuali, sebbene prive ormai di un fondamento oggettivo.
DAVID HUME

“Io ho di me stesso l’immagine di un uomo il quale, dopo aver cozzato in molti scogli, ed evitato a malapena il naufragio passando in una secca, conservi ancora la temerarietà di mettersi per mare con lo stesso battello sconquassato, con l’intatta ambizione di tentare il giro del mondo nonostante queste disastrose circostanze”.
DAVID HUME
Il filosofo scozzese David Hume si colloca sul filone dell’empirismo inglese e la sua filosofia finisce per avere un esito scettico. La prima grande distinzione che egli effettua nell’ambito delle percezioni é tra impressioni ed idee; se Locke definiva idea qualsiasi contenuto della mente, Hume preferisce distinguere le impressioni dalle idee, risolvendo il tutto in una questione di vivacità . Nel momento in cui vedo il libro, ossia mentre ce l’ho davanti agli occhi, ne ho una percezione vivissima, che Hume chiama impressione; quando poi mi allontano dal libro e non ne ho più percezione attuale, tuttavia in qualche modo lo percepisco, in maniera depotenziata e più debole rispetto a quando ce l’avevo davanti agli occhi: ho l’ idea del libro, non più l’impressione. In altre parole, si ha impressione quando si percepisce attualmente, quando cioè si ha una percezione vivacissima; si ha invece l’idea quando si ha un ricordo, una percezione sbiadita, non più vivacissima. Tuttavia il processo non é per il filosofo scozzese risolvibile solo in una questione di presenza dell’oggetto di cui si hanno percezioni; e per questo egli invita a provare ad analizzare ciò che si sta percependo: non si può dire con certezza di avere il libro davanti agli occhi e quindi l’impressione e poi, quando esso non c’é più, solo l’idea; si potrà con certezza affermare che in quel dato momento si ha percezione vivace (impressione) di un qualcosa, poi, quando si é affievolita, pur essendo lo stesso il contenuto, l’ho ancora, ma meno vivace, più sbiadito: é cioè un’idea. Ridurre il tutto ad una pura e semplice questione di presenza (c’é il libro, ho impressione; non c’é, ho idea) é già interpretare gli stessi concetti di idea e di impressione, dovuto al fatto che quando ho impressione la vivacità si accompagna psicologicamente alla convinzione dell’esistenza attuale della cosa (nel nostro caso il libro). Bisogna però chiarire che cosa significa che una cosa esiste e a proposito Hume introduce un discorso che avrà la sua influenza sullo stesso Kant: il pensatore scozzese non accetta la definizione di esistenza data nel Medioevo da Anselmo da Aosta, a parere del quale l’esistenza era caratteristica del concetto. Per Hume, al contrario, l’esistenza non fa parte del contenuto del concetto , é solo una maggiore o minore vivacità con cui la percezione si presenta. L’ippogrifo non esiste e , secondo Hume, non per questo un ipotetico ippogrifo esistente avrebbe contenuto diverso: il concetto di ippogrifo é completo sia che l’ippogrifo esista sia che non esista. E d’altronde se all’improvviso si estinguessero le giraffe, non per questo cambierebbe il concetto di giraffa. Ecco allora che l’esistenza é caratterizzata dalla vivacità con cui l’impressione si presenta: se immaginassimo di nascere adesso e di aprire per la prima volta gli occhi, non sapendo nulla del mondo, potremmo solo dire che percepiamo cose più vivacemente rispetto ad altre e poi che , per esperienza, le meno vivaci vengono sempre dopo alle più vivaci (il libro che era qui lo percepivo in modo vivace, poi non é più qui, me lo ricordo, lo percepisco cioè in modo meno vivace) : se del libro non avessi avuto l’impressione, non poteri averne l’idea. Allora abbiamo percezioni, non tutte sono uguali e sappiamo che le idee stanno dopo le impressioni; ecco allora che l’esistenza é la convinzione psicologica connessa alla vivacità di una cosa: se ho percezione vivace del libro sono convinto che esista qualcosa fuori di me . L’esistenza consiste proprio nella vivacità di percezione. E in effetti già Locke aveva notato che se ho solo l’idea del libro senza avercelo in carne ed ossa davanti, posso supporre che esso esista ancora (anche se non lo vedo più), pur non avendone la certezza (potrebbe essere stato distrutto). E d’altronde questo é particolarmente evidente nei bambini: in presenza di un oggetto a loro gradito, essi sono felici, ma se l’oggetto viene nascosto essi piangono temendo che l’oggetto non ci sia più: e in fondo che cosa mi garantisce che il libro di cui ho impressione, che vedo cioè coi miei occhi, una volta che non lo vedo più e di lui ho solo l’idea, continui ad esistere? Ecco che Hume dovrà affrontare proprio questo problema: perchè noi abbiamo un atteggiamento diverso rispetto al bambino? Perchè di una cosa di cui abbiamo avuto impressione, quando ne abbiamo solo l’idea continuiamo ad essere convinti che esista? Perchè vedo il libro e quando mi giro dall’altra parte e non lo vedo più, continuo ad essere convinto che esso ci sia? L’atteggiamento di Hume sembra scivolare nello scetticismo più radicale: definire l’esistenza come convinzione psicologica irrazionale, infatti, sembra tipico dello scetticismo più rigoroso. Ed é proprio quel che fa Hume: vedo il libro e deduco che esista, mi volto e, non vedendolo più, continuo a credere che esista: é irrazionale, é la nostra mente stessa che é fatta così, in modo tale da credere che esista ciò di cui ho impressione. L’esistenza dell’intera realtà in fondo é indimostrabile per Hume: vediamo ciò che ci circonda e intuiamo immediatamente che esista: ma é una deduzione che esula dalla ragione. Ma con questo Hume non intende scivolare nello scetticismo e ci tiene a ribattere a quelli che glielo rinfacciano: é convinto che l’esistenza della realtà sia indimostrabile, ma non per questo non crede che la realtà che ci circonda non esista. Anzi, dice Hume, l’indimostrabilità e l’irrazionalità dell’esistenza della realtà non fa altro che sortire l’effetto opposto, ossia ci porta ancora di più a credere che la realtà esista proprio perchè lo si coglie con l’intuizione immediata, senza bisogno di ragionamenti razionali. E d’altronde tutti i filosofi medioevali che avevano provato a dimostrare l’esistenza di Dio in termini razionali avevano fatto fiasco: non é per via di un ragionamento, anche se ben condotto, che si arriva a credere in Dio: é una cosa che si sente dalla nascita, che va accettata con un atto di fede; e lo stesso é per la realtà che ci circonda, la cui esistenza va accettata con un atto di fede, senza dimostrazioni, accontentandoci del fatto che la nostra mente é propensa a credervi. E se l’esistenza del mondo fosse dimostrabile in termini razionali , in fondo, fa notare Hume, nessuno si lascerebbe convincere. Hume non intende mettere in forse l’esistenza del mondo esterno, come aveva fatto Cartesio, ma vuol far semplicemente notare che l’esistenza del mondo esterno non é dimostrabile ma non per questo per lui il mondo non esiste. Se Locke con la sua critica alla conoscibilità della sostanza aveva assestato un primo duro colpo alla metafisica, Hume può essere considerato il distruttore definitivo della metafisica: egli le fa crollare i due pilastri portanti, l’idea di sostanza e di causalità: secondo la concezione metafisica classica, infatti, il mondo non era altro che una serie di sostanze in rapporto causale tra di loro. E proprio criticando questi due concetti, di causalità e di sostanza, Hume farà crollare l’antico edificio della metafisica, aprendo gli occhi a Kant e svegliandolo dal suo sonno dogmatico: il filosofo scozzese, sostenendo la non ovvietà dei concetti di causalità e di sostanza ha svegliato Kant, il quale comunque non potrà condividere con Hume l’ingiustificabilità dei due concetti sostenuta dal pensatore scozzese. Anzi, per Kant si tratterà di due concetti che possono e devono essere fondati. Hume imposta la sua critica al concetto di sostanza partendo dalla definizione stessa di sostanza: si dice sostanza tutto ciò che per esistere non ha bisogno di null’altro all’infuori di sè. A dirmi che il libro é una sostanza é la convinzione stessa che esso esista di per sè, indipendentemente da me; certo se mi convincessi che esiste la percezione ma non la cosa fuori di me non parlerei di sostanza, ma di immagini virtuali (l’immagine libro, senza riscontro fuori di me) inviate alla mia mente. Occorre però porsi il problema: che cosa é che mi dà la convinzione che l’oggetto (il libro) esista indipendentemente da me ? Per Hume é la convinzione della permanenza dell’oggetto, di cui ho avuto impressione (percezione vivace: ho visto il libro) e di cui ora ho solo l’idea (percezione depotenziata: mi ricordo il libro senza averlo più davanti). E così mi convinco dell’esistenza indipendente della cosa: sono cioè convinto che la cosa che ho visto (impressione) e che quindi so esistere, anche se non la percepisco più vivamente ma la ricordo solo, continui ad esistere, abbia cioè una permanenza di esistenza. Guardo il libro, lo percepisco, so che esiste, arrivo a dire che é una sostanza dotata di esistenza autonoma e arrivo a sostenere che abbia permanenza. La domanda successiva però é la seguente: e da dove nasce la convinzione dell’esistenza permanente della cosa? Chi mi garantisce che quando non ce l’ho più davanti il libro continui ad esistere? Questa domanda é a sua volta riconducibile alla seguente: se esistenza é vivacità di percezione (impressione), come mai continuo a credere che la cosa esista anche quando di essa non ho più una percezione vivace? So che il libro che mi sta davanti esiste perchè lo percepisco vivacemente, ma chi mi dice che continui ad esistere anche quando non mi sta più davanti agli occhi? A questo punto Hume, per poter rispondere alla domanda, introduce il concetto di abitudine: ho visto il libro (impressione), mi sono allontanato tenendolo a mente (idea), sono tornato e l’ho ritrovato: ha continuato ad esistere. Ecco allora che per Hume determinati fenomeni mentali sono legati all’abitudine: in questo caso, ad esempio, a forza di vedere alternarsi impressione e idea del medesimo oggetto (immaginiamo il libro sul tavolo: lo vedo, esco, torno e lo rivedo, poi ri-esco, torno e lo rivedo…), l’abitudine fa sì che la convinzione dell’esistenza (che ho maturato intuitivamente dall’impressione) tenda ad estendersi anche all’idea. Nasce così il concetto di sostanza, il credere che una cosa esista anche se non la si percepisce vivacemente, quasi come se la nostra mente colmasse gli intervalli di tempo in cui non abbiamo impressioni, assicurandoci che la sostanza continua ad esistere. Per spiegare questo concetto Hume fa riferimento all’immagine del contagio : la vicinanza di idee e di impressioni di medesimo contenuto fa sì che le idee siano contagiate dalla vivacità delle impressioni, quasi come se con un processo osmotico: ho l’impressione del libro, sono convinto che esso esista, poi l’idea del libro viene contagiata dalla vivacità della percezione precedente e mi porta a credere che il libro esiste anche se non lo vedo. Ecco allora che ci saranno idee che ricevono vivacità dalle impressioni e ci danno convinzione di esistenza, ma non tutte le idee saranno di questo tipo: é evidente che nell’ambito della causalità non funziona; se vedo un fumo, penso che sia causato da un fuoco e posso pensare che tale fuoco esista, ma magari si é già estinto da parecchio e non esiste più. Hume nella sua critica all’idea di sostanza non accetta l’argomentazione lockiana per cui la sostanza, pur essendo inconoscibile, esiste ed é, come un puntaspilli, ciò che tiene unite certe caratteristiche che si presentano costantemente insieme ai miei occhi. La concezione di Locke viene scartata da Hume proprio perchè, in fondo, non c’é nulla che mi vieti di pensare che le idee semplici (blu, forma parallelepipedo, odore cartaceo…) siano legate direttamente tra loro in un’idea complessa (il libro, unione delle idee semplici citate) e non da una cosa comune a noi ignota (la sostanza). La sostanza é inconoscibile proprio perchè non esiste. E questa stessa negazione della sostanza porta Hume alla critica dell’io, che in fondo é una forma di sostanza: in termini lockiani, non sappiamo che cosa sia la sostanza io (come tutte le altre sostanze), ma sappiamo che c’é perchè tiene unite tutte le caratteristiche che ad essa ineriscono (pensare questo, percepire quello…). Parlare di “io” é solo un modo di esprimersi che non trova fondatezza nella realtà proprio perchè non c’é nessuna sostanza “io”. Proviamo a fare un esperimento mentale: togliamo tutti i contenuti che ineriscono alla sostanza io; non rimane più niente, neanche l’io. Il nostro errore sta proprio nell’essere convinti che il nostro io (come se esistesse un qualcosa a monte di tutto) abbia caratteristiche, pur essendo lui una cosa a parte. Ma per Hume l’io non é altro che un fascio di percezioni : l’io é dato solo dall’unione di queste percezioni senza le quali non esisterebbe. Nell’Ottocento Nietzsche dirà che pensiamo le idee, ma magari potrebbe benissimo essere che le idee si pensano tra loro, senza che esista un io, andando e venendo in noi, che siamo appunto il luogo in cui esse si incontrano. Hume a riguardo si avvale anche di un’altra efficace immagine: la mente umana é un palcoscenico su cui passano le idee, anzi, a essere precisi, il palcoscenico non c’é neanche. Ed é interessante notare che Hume voleva presentarsi come uno Newton della psicologia: se il grande scienziato inglese aveva scoperto una legge fondamentale (la gravitazione universale), Hume ritiene di poter fare la stessa cosa per il mondo psicologico: le singole percezioni sono atomi psicologici, retti da leggi analoghe a quelle che Newton aveva attribuito ai corpi fisici: le percezioni avranno allora la proprietà di attrazione, di opposizione e avremo idee che si attraggono a vicenda, altre che si respingono. La scienza moderna ha senz’altro riconosciuto un merito a Hume riscontrando la veridicità della sua teoria dell’io come fascio di percezioni in alcuni tipi di serpenti. Smontata e distrutta la sostanza, Hume si accinge a fare altrettanto con la causalità : che cosa significa che una causa produce un effetto? Spesso il rapporto causale finiamo per considerarlo come un rapporto produttivo: A causa B , quasi come se lo producesse. Ma dire che A causa B é un modo superficiale di analizzare il fatto: é causa di B ogni volta che riteniamo che ad A segua sempre necessariamente B, quando cioè la presenza di B implica quella di A. Ma così la causalità si riduce a successione costante : ogni volta che c’é B ci deve anche essere A che l’ha causato, anche se non constato di persona che A ha causato B. Ma siamo di fronte ad un problema analogo a quello della sostanza: oltre ad avere la convinzione che esistano come sostanze B e A, avrò anche quella che B deriva sempre da A, anche quando A non lo vedo. Ed é ancora una volta l’abitudine che mi porta alla convinzione che se c’é B ci deve essere stato A: l’abitudine a vedere che B segue necessariamente A. A questo punto occorre tener presente quella distinzione attuata da Leibniz tra verità di ragione (la somma degli angoli interni di un triangolo vale 180 gradi) e verità di fatto (Cesare ha attraversato il Rubicone): Hume, riprendendo questi due concetti, li chiama rispettivamente relazioni tra idee (le verità di ragione) e materie di fatto (le verità di fatto). L’uomo nelle relazioni di idee può dedurre il predicato dal soggetto (il triangolo ha la somma degli angoli interni uguale a 180 gradi: se non l’avesse non sarebbe un triangolo!), ma non può fare questo nelle materie di fatto (che Cesare abbia attraversato il Rubicone non lo posso dedurre dall’essenza del soggetto Cesare: lo so perchè l’han detto gli storici). Ecco allora che Hume si pone il quesito: la causalità é una relazione tra idee o una materia di fatto? Se fosse una semplice relazione tra idee, ossia se nel soggetto (triangolo) fosse già implicito il predicato (l’avere la somma degli angoli interni uguale a 180 gradi), allora il primo uomo venuto al mondo dall’essenza stessa del fuoco avrebbe dovuto capire che bruciava: ma evidentemente non é andata così, al contrario, l’uomo non ha capito che il fuoco bruciava finchè non ha messo la mano sul fuoco e non se ne é accorto. Pare quindi che si tratti di una materia di fatto, non deducibile dall’essenza stessa del soggetto: finchè non lo provo empiricamente o non me lo dicono, non potrò mai sapere se il fuoco brucia. Ma in realtà non é così: il fuoco brucia perchè una o più volte mi sono scottato, l’ho cioè provato sulla mia pelle. Ma non per questo posso dedurre che il fuoco causa il bruciore: le esperienze (per definizioni) sono sempre testimoni di ciò che é accaduto, mai di quel che accadrà: mettere una o due volte la mano sul fuoco, non mi dice, a rigore, che cosa mi capiterà quando metterò la mano sul fuoco: mi dice solo quel che é successo quando l’ho messa. Per fare un esempio che rende meglio l’idea: constato che i cigni sono bianchi perchè tutti quelli presi in considerazione lo sono, ma nulla mi dice che siano solo bianchi (e infatti esistono anche cigni neri in Oriente). L’esperienza lo é solo del passato . Il concetto di causalità, come quello di esistenza, non é razionalmente fondato: non é nè relazione tra idee nè materia di fatto; ma questo non toglie nulla all’idea istintiva che ho, ossia che A causi B. Ecco che ancora una volta la credenza istintiva in certe verità é innegabile, dettata dalla struttura stessa della mente umana: il mondo per Hume esiste, così come per lui A causa B. Ma se non é razionale, come nasce la convinzione? Per abitudine. Dunque la causalità viene ricondotta da Hume a pura e semplice successione regolare: diciamo che A causa B poichè vediamo che dopo A viene B e ci sentiamo dunque autorizzati, alla presenza di B, a dire che c’é stato A. Ma, é evidente, si tratta solo di una successione regolare, ossia dopo A viene regolarmente B. Il rapporto di causalità non é nè una materia di fatto nè di relazione: non si può predire l’effetto della cosa in questione dall’essenza della medesima (non so che il fuoco brucia finchè non lo tocco con mano) e se uno constata empiricamente l’effetto, può dire che é andata così, ma non é del tutto lecito dire che in futuro andrà ancora così (mi son bruciato mettendo la mano sul fuoco, ma non c’é nulla che mi garantisca che rimettendola mi bruci nuovamente): Hume fa l’esempio del sole, facendo notare come non ci sia nulla che ci garantisca ogni mattina il suo sorgere. Questo non vuol dire che posso tranquillamente mettere la mano sul Fuoco, ossia che posso dubitare che dal fuoco derivi il bruciare, tuttavia significa che il rapporto di causalità non é razionalmente dimostrabile. E allora come nasce la convinzione del rapporto di causalità? Come posso essere convinto che mettendo la mano sul fuoco, esso mi brucerà? Come accennavamo, Hume intende proporsi come uno Newton della psicologia, una psicologia associazionistica: come per l’atomismo ci sono parti elementari e forze che le aggregano, così per l’associazionismo vi sono percezioni che si radunano nell’io (fascio di percezioni) , una sorta di “luogo psichico”, in cui le percezioni si attraggono e si respingono secondo alcune leggi, le cui più importanti sono la legge di contiguità e la legge di similitudine: la legge di contiguità dice che due percezioni percepite l’una vicina all’altra tenderanno ad attrarsi automaticamente nella mia mente: se ad esempio ho visto un libro su un tavolo in casa di un mio amico, e rivedo il medesimo libro in un altro luogo, esso mi fa tornare alla mente per contiguità il tavolo del mio amico e la sua stessa casa: é la vicinanza con cui le percezioni vengono acquisite che fa sì che, vedendo il libro, mi venga in mente il tavolo. La legge di similitudine é invece quella secondo la quale due percezioni possono richiamarsi, proprio come gli atomi: vedo la nebbia e per similitudine mi viene in mente il fumo. C’é poi il meccanismo della causalità, tale per cui quando vedo un fenomeno mi aspetto che ce ne sia stato un altro e che ce ne sarà un terzo: vedo B e sono convinto che ci sia stato A e che ci sarà C. In tutte e tre queste leggi (contiguità, similitudine, causalità) c’é l’impressione che richiama alla mente l’idea: nel caso della contiguità, vedo il libro e mi viene in mente l’idea del tavolo su cui era appoggiato; nel caso della legge di similitudine, vedo la nebbia e mi viene in mente l’idea del fumo; nel caso della legge di causalità, vedo il fumo e traggo la conseguenza che c’é stato il fuoco. Tuttavia il rapporto di causalità si differenzia dalle altre due leggi (contiguità e similitudine) perchè mentre le altre due conducono ad idee senza comportare l’esistenza (vedo il libro, mi viene in mente l’idea di tavolo, ma non c’entra niente l’esistenza del tavolo!), la legge di causalità porta ad una idea accompagnata dalla convinzione dell’esistenza della medesima: vedo il fumo, mi viene in mente l’idea del fuoco e sono convinto che il fuoco ci debba essere per forza stato, altrimenti non si spiegherebbe il fumo. Come mai sono portato ad attribuire esistenza con certezza ad un’idea? Anche qui entra in gioco il contagio, proprio come nell’idea di sostanza: là era l’alternanza di impressioni e idee che finiva per essere un flusso di percezioni in cui le idee diventavano (per contagio) impressioni; nella causalità, il fatto che io, vedendo il fumo, sia convinto che ci sia stato il fuoco deriva dal fatto che sono abituato a vedere la sequenza fuoco-fumo, ossia ogni volta che ho visto il fumo prima ho anche visto il fuoco. A forza di vedere sotto forma di impressioni (ossia dal vivo) questi due fenomeni (fuoco-fumo) , nella mia mente finiscono per diventare un’impressione sola: e così quando vedo una delle due (ad esempio il fumo), automaticamente viene fuori anche l’altra (il fuoco) come idea ed é talmente legata alla prima (che mi appare come impressione: il fumo lo vedo coi miei occhi) che la vivacità dell’impressione si trasmette all’idea: vedo il fumo e dico con certezza che c’é stato il fuoco; vedo il fuoco e dico con certezza che ci sarà il fumo. E così si sfocia di nuovo nella credenza: il rapporto causale non é razionale, ma si fonda su una credenza, sul credere che ogni volta che c’é il fumo ci debba essere stato il fuoco. Hume respingeva le accuse di chi lo accusava di scetticismo: in effetti lui dice che il rapporto di causalità e l’idea di sostanza non hanno fondamenta razionali, ma sostiene altresì di essere convinto della loro esistenza, anzi, proprio per via della loro indimostrabilità razionale, finisce per crederci ancora di più, perchè in fondo l’atto di credere implica proprio un atto di fede. Tuttavia bisogna cercare di comprendere i suoi avversari, che gli imputavano l’accusa di scetticismo: dire che una cosa non é razionale, in fondo, vuol dire che tanto certa non é! Kant riconoscerà a Hume il merito di avergli fatto notare che il rapporto di causalità non é un’ ovvietà: ma Kant non si limiterà a prendere atto di questo, bensì si prenderà la briga di rifondare quel rapporto di causalità smontato da Hume, tenendo appunto conto delle critiche mosse dal pensatore scozzese. Come Platone riprendeva i Sofisti per rifondare una verità solida, così Kant riprenderà Hume, convinto della necessità di avere rapporti causali solidi in natura, tenendo conto che la causalità va fondata razionalmente. E d’altronde con lo smontamento humeano della causalità o si rinuncia totalmente ad una scienza o la si rifonda da capo. Tuttavia, nonostante Kant senta l’esigenza di rifondare la causalità, possiamo affermare che Hume é un pensatore “più moderno” in quanto più vicino alle posizioni della fisica contemporanea, che tende a concepire i rapporti causali come probabilistici, e non del tutto perfetti. E questo in fondo era già presente in Hume, il quale sosteneva che in ultima istanza non é possibile attribuire valore assoluto alla causalità; Kant e Newton invece preferiscono una scienza che esprima rigorosamente i rapporti causali. Un discorso simile ai precedenti vale anche per l’ etica humeana, che può essere sintetizzata nell’ormai famosa espressione (che sconvolse non poco i pensatori dell’epoca) :”La ragione é, e deve solo essere, schiava delle passioni, e non può rivendicare in nessun caso una funzione diversa da quella di obbedire e di servire ad esse.” Se questa asserzione scandalizzò mezzo mondo, fu perchè era diametralmente opposta a quelle di tutti i filosofi fino ad allora esistiti: in fondo tutti erano oscillati tra un’abolizione razionale delle passioni o un misurazione razionale delle medesime: per Platone, Aristotele ed Epicuro le passioni andavano regolate, per gli Stoici abolite, il tutto con l’ausilio della ragione: e così Epicuro parlava di “calcolo razionale dei piaceri” e Platone ricorreva alla metafora della biga alata, secondo la quale l’auriga-ragione deve dominare e regolare i cavalli-passioni. Hume fa però notare che, a ben pensarci, la ragione non é in grado di dirci che cosa vogliamo e ci dice sempre e soltanto che cosa dobbiamo fare per ottenere quello che vogliamo : quello che vogliamo, tuttavia, esula dai dettami della ragione. Se uno vuole andare in vacanza ai tropici, la ragione gli indicherà la via per ottenere quel fine, suggerendogli di lavorare e di risparmiare denaro; ma quando gli si chiederà “perchè vuoi andare ai tropici”, lui risponderà “perchè mi piace”: non vi é una risposta razionale, é una passione. Il fine non é razionale, ma i mezzi per raggiungerlo sì, é la ragione stessa ad indicarceli. I fini ultimi sono per Hume dovuti al sentimento morale: ciò che vogliamo fare lo sentiamo immediatamente con istinto morale e non con la ragione; e ciò che ognuno é per sua natura portato a volere é il bene personale: Hume é convinto che l’uomo sia un essere egoista e antisociale (un pò come Hobbes) ; ma la vera grande novità introdotta da Hume é il giustificare con l’egoismo perfino l’altruismo! Il comportamento é legato ai sentimenti di piacere e di dolore, ossia ciascuno cerca il proprio piacere ed evita il proprio dolore. Il problema però deriva dal fatto che il piacere e il dolore, come molte altre cose nella filosofia humeana, finiscono per “contagiare”: se uno soffre vedendo una persona che gli sta davanti e che a sua volta soffre poichè ha avuto un incidente, lo fa perchè la sofferenza é contagiosa, nel senso che a seconda della maggiore o della minore vicinanza con la persona che soffre ( o che prova piacere) , il dolore (o il piacere) di quella persona si espande su di noi contagiandoci: vedo una persona che soffre e soffro anch’io per contagio; se cerco di aiutare tale persona, lo faccio solo perchè essa non soffra più e quindi perchè neanche io soffra più (per contagio). Questa azione apparentemente altruista é in realtà dettata dall’egoismo più profondo: faccio star bene uno per star bene io. Hume parlando di persone vicine cui diamo una mano perchè non soffrano più (per non soffrire più noi, a nostra volta) intende due diverse accezioni della parola “vicino”: soffriamo quando vediamo una persona magari a noi sconosciuta ma che ci é vicina fisicamente: ad esempio quando vediamo un mendicante; ma soffriamo anche quando sappiamo che una persona a noi vicina sentimentalmente (un parente) soffre, pur noi non vedendolo (magari abita lontanissimo). Tutto questo non ha nulla a che vedere con la ragione: é un sentimento morale. Sono le passioni che ci dicono che cosa vogliamo, sono egoistiche, ma fondano i comportamenti altruistici. La ragione ci suggerisce solo come raggiungere lo scopo prefissato dalle passioni. E anche a questo proposito Kant si opporrà a Hume rifondando razionalmente la morale e cercando di dimostrare che alcune scelte morali sono dettate dalla ragione; Kant distinguerà tra “imperativi ipotetici” e “imperativi categorici” : gli ipotetici sono quelli del tipo “se…, allora…”: se vuoi far denaro, allora devi lavorare: e questo é quel che pensa Hume, non vi é cioè una spiegazione razionale al fatto di “voler far denaro” e la ragione ci può solo dire come fare (lavorare per fare denaro) ; tuttavia con gli imperativi categorici Kant prenderà le distanze da Hume proprio in quanto in questi imperativi non c’é il “se, allora” , che presuppone la schiavitù della ragione alle passioni: nei categorici é la ragione stessa a dirmi “fai questo”, indicandomi che cosa é giusto in assoluto.
ADAM SMITH

Uno dei maggiori rappresentanti della filosofia scozzese del Settecento è Adam Smith. Nato a Kirkcaldy, presso Edimburgo, nel 1723, Smith studiò a Glasgowcon Hutcheson e, qualche anno dopo la morte di quest’ultimo, gli succedette sulla cattedra di Filosofia morale. Nel 1763 lasciò l’insegnamento per andare in continente in qualità di precettore privato: durante questo viaggio soggiornò a Parigi, dove entrò in contatto con l’ambiente della fisiocrazia francese, in particolare con Quesnay e con Turgot. Ritornato in patria, condusse a lungo vita privata, poi divenne commissario alle Dogane e infine Rettore dell’università di Glasgow. Morì nel 1790. La prima opera di Smith, la Teoria dei sentimenti morali (1759), risente ampiamente della frequentazione di Hutcheson e di Hume. Il principio fondamentale della vita morale è infatti il sentimento della simpatia: gli uomini sono naturalmente portati a giudicare positivamente le azioni che contribuiscono alla socievolezza reciproca e negativamente quelle che la ostacolano. Questo giudizio riguarda non solo le azioni degli altri, ma anche le nostre proprie. Ciascuno di noi ha infatti uno “spettatore imparziale ” dentro di sé , che gli consente di valutare le sue azioni con gli occhi degli altri, in base quindi dell’utilità che esse presentano per la sua persona, ma alla loro accettabilità dal punto di vista sociale. La stessa coscienza morale non è quindi per Smith un principio razionale interiore, ma , scaturendo dal rapporto simpatetico che l’uomo ha con gli altri uomini, presenta un carattere prevalentemente sociale e intersoggettivo. Il sentimento della simpatia permette così di introdurre un principio di armonizzazione nell’apparente conflitto tra gli impulsi sociali e quelli egoistici. Infatti la felicità di ognuno è possibile soltanto attraverso la realizzazione del bene degli altri. Un analogo principio armonicistico guida l’analisi dei processi socio-economici che Smith compie nel suo capolavoro, l’ “Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni ” (1776). Testimone delle trasformazioni che investono la vita economica dell’Inghilterra, nella quale si stanno affermando, sia pure in forma embrionale, i meccanismi del moderno capitalismo industriale, Smith non nega che l’elemento propulsore di ogni attività economica è l’interesse individuale. Apparentemente, la comparazione di questi interessi descrive una condizione di aspra conflittualità sociale: gli imprenditori hanno interesse a pagare il meno possibile il lavoro dei loro operai e questi ultimi, viceversa, vogliono percepire il salario più alto possibile. Ma quando si considerino gli interessi individuali e i processi socio-economici cui essi danno luogo da un punto di vista generale, anziché particolare, si vede che essi trovano la loro armonizzazione nel tutto e conducono pertanto a un vantaggio generale da cui traggono profitto anche coloro che sono apparentemente più svantaggiati. Esiste dunque una mano invisibile che guida i singoli interessi al di là delle loro specifiche intenzioni, componendoli in una totalità che sfugge allo sguardo parziale dell’individuo. Smith condivide pertanto i presupposti ottimistici dell’illuminismo in generale e della fisiocrazia francese in particolare – da lui frequentata, come si è visto, durante il viaggio in Europa – in base ai quali i processi socio-economici rivestirono, come tutte le altre attività umane, un carattere naturale che garantisce la loro bontà, almeno finché non interviene l’uomo con un improvvido intervento artificiale. Per questo Smith ritiene – ancora una volta riprendendo un suggerimento dei fisiocrati parigini – che l’azione dello Stato in fatto di economia, vuoi regolamentando i processi produttivi, vuoi introducendo restrizioni nella libertà di commercio, sia del tutto dannosa: essa rischia infatti di compromettere quel vantaggio generale che che necessariamente si acquisisce quando si lascia che le cose seguano il loro ordinario corso naturale. In alternativa alla politica economica del mercantilismo seicentesco, che prevedeva massicci interventi dello Stato, soprattutto in direzione della difesa della produzione nazionale con dogane o divieti di importazione di merci estere, Smith e i fisiocrati francesi caldeggiano l’instaurazione del più completo liberismo economico. L’unico intervento legittimo da parte dello Stato è quello di prelevare imposte dai guadagni privati degli individui in modo da poter garantire quei servizi pubblici che ridondano poi a beneficio di tutti e di ciascuno . Smith non ritiene che i meccanismi socio-economici da lui illustrati o le regole da lui raccomandate in fatto di economia siano semplici teorie: al contrario egli pensa che esse rispecchino leggi del tutto assimilabili a quelle che determinano il carattere, la concatenazione e lo sviluppo dei fenomeni naturali. Con Smith l’economia politica, cioè l’arte di bene amministrare la vita economica dello Stato, esce quindi dall’ambito della precettistica empirica per aspirare allo statuto di una vera e propria scienza . Smith , in un periodo in cui si discuteva ampiamente se la vera ricchezza fosse nell’ agricoltura o nell’ industria , si chiese : ma che cosa é che fa il valore di una cosa ? La risposta che trovò fu sostanzialmente questa : la cristallizzazione del lavoro presente nella merce in questione . Di fatto tutte le cose che abitualmente compriamo o vendiamo sono incommensurabili e sarebbe quindi impossibile effettuare vendite o acquisti : un fruttivendolo che vada da un calzolaio quanti kg di patate dovrebbe dargli per avere un paio di scarpe ? E’ assurdo ! Teoricamente si potrebbero solo scambiare merci uguali : patate con patate e scarpe con scarpe . Eppure noi sappiamo che le scarpe e le patate hanno un loro valore , che é dato dal lavoro presente in esse : un tot di lavoro per fare le scarpe e un tot per le patate . Tra le varie ” scoperte ” di Smith c’é anche quella dell’ importanza della divisione del lavoro : contò che per produrre uno spillo occorrevano 19 passaggi e capì che facendo fare un solo passaggio ad una sola persona si ottenevano due effetti positivi : innanzitutto costava meno perchè si trattava di manodopera meno qualificata , dovendo fare solo un passaggio . Poi si accorse che effettuando un solo passaggio l’ operaio finiva per diventare bravissimo . Smith , tuttavia , si accorse anche dei limiti della suddivisione del lavoro : un fabbricatore di liuti ha un rapporto soggettivo con ciò che produce , lo fa con amore perchè lo vede nascere e poi lo vede finito ; un operaio al quale spetti un solo passaggio non può avere questo rapporto con ciò che produce e , per di più , il compiere sempre e solo lo stesso passaggio causa in lui un abbrutimento fisico . Riprendiamo ora in modo più approfondito la questione della mano invisibile : per Smith lo stato non deve assolutamente intervenire nell’ economia ( egli é quindi un liberista ) e le cose vanno lasciate al loro destino senza interventi statali : ciascuno deve fare i propri interessi ; d’ altronde Smith diceva : ” non é dalla generosità del macellaio , del birraio o del fornaio che noi possiamo sperare di ottenere il nostro pranzo , ma dalla valutazione che essi fanno dei propri interessi ” . Ma allora , dirà qualcuno , ci sarà chi si arricchisce e chi si impoverisce sempre più ! Per Smith non é così : se tutti fanno i propri interessi é ovvio che aumenterà in qualche misura la ricchezza collettiva e tutti godranno dei vantaggi , sebbene in maniera diversa : é ovvio che chi investe guadagnerà di più del povero , ma tuttavia anche quest’ ultimo avrà un incremento positivo di ricchezza : ” cercando per quanto può di impiegare il suo capitale a sostegno dell’ industria interna e di indirizzare questa industria in modo che il suo prodotto possa avere il massimo valore , ogni individuo contribuisce necessariamente quanto può a massimizzare il reddito annuale della società … egli mira soltanto al proprio guadagno e in questo , come in molti altri casi , egli è condotto da una mano invisibile a promuovere un fine che non entrava nelle sue intenzioni . Nè per la società è un male che questo fine non entrasse nelle sue intenzioni . Perseguendo il proprio interesse , egli spesso promuove quello della società in modo più efficace di quando intende realmente realmente promuoverlo . ” Quello che può essere considerato un vizio nel campo privato , ossia il fare i propri interessi , diventa una virtù nel campo pubblico.
THOMAS REID

Tra i maggiori oppositori della filosofia dagli esiti scettici di Hume nell’ ambiente accademico scozzese vi fu Thomas Reid , il successore di Adam Smith all’ università di Glasgow . Egli fu autore di una fortunata Ricerca dello spirito umano secondo i princìpi del senso comune , risalente al 1765 . La dottrina del senso comune rappresenta infatti il nucleo teorico centrale , oltre che della filosofia di Thomas Reid , anche dell’ indirizzo di pensiero da lui iniziato , generalmente noto con il nome di Scuola scozzese . Secondo Reid lo scetticismo di Hume non va imputato esclusivamente al pensatore scozzese , ma é la conseguenza di un’ illusoria prospettiva gnoseologica che risale a Locke e a Berkeley e , per tornare ancora più indietro negli anni , a Cartesio . Tutti questi pensatori hanno infatti aderito a quella che Thomas Reid definisce la teoria delle idee , fondata sul concetto che l’ oggetto immediato della conoscenza umana non sono le cose , bensì le idee . Riguardando solamente le idee , la conoscenza non comporta , secondo quella tradizione , nessun giudizio immediato sull’ esistenza delle cose , che rimane sostanzialmente problematica . A questa dottrina Thomas Reid oppone la convinzione che la conoscenza dell’ uomo ha sempre come oggetto le cose stesse , tramite le percezioni che ci provengono da esse , e non può mai essere separata da un giudizio affermativo sulla loro esistenza . Conoscere qualcosa vuol dire conoscere le cose in quanto esistenti e non le idee delle cose . Ma su che cosa si può allora fondare la certezza , che il dubbio di Cartesio metteva in dubbio , di conoscere direttamente le cose ? Chi non mi dice che quelle che io credo essere cose esistenti in realtà non siano immagini virtuali inviate alla mia mente da un genio maligno che impiega tutta la sua onnipotenza per ingannarmi ? Chi mi garantisce che esista il mondo che mi circonda ? Secondo Thomas Reid non c’ é nient’ altro che possa garantirlo se non il senso comune , ovvero il sentimento in base al quali tutti credono sull’ esistenza delle cose esterne e del nostro io : nessuno si sognerebbe mai di pensare che il mondo sia solo una proiezione virtuale inviataci da un genio malvagio ! Il senso comune di Thomas Reid svolge quindi una funzione molto simile a quella esercitata dalla ” credenza ” di Hume : ma mentre Hume stabiliva una netta distinzione tra la certezza della credenza e quella del conoscere razionale e dimostrativo , Thomas Reid unifica i due termini , restituendo al senso comune il valore di un sapere assolutamente certo e non lasciando spazio ad alcuno sviluppo in direzione dello scetticismo : non ha senso dubitare delle cose che ci circondano perchè é il senso comune che ci dice che esistono e sono così . Pastore presbiteriano oltre che professore universitario , Thomas Reid si preoccupa di combattere anche le conseguenze religiose dello scetticismo humiano ; ritiene infatti che il senso comune stia alla base non solo nel credere nella realtà della percezione , ma anche nel credere alle verità fondamentali . Queste ultimi concernono sia l’ ambito logico-matematico , sia quello etico – metafisico : in virtù di esse l’ uomo può quindi essere certo della sua libertà individuale , dei princìpi morali che trova innati in sè e , soprattutto dell’ esistenza di Dio , che é dettata dal senso comune . Thomas Reid eserciterà il suo influsso su un notevole numero di autori scozzesi. Tra questi va ricordato un certo Thomas Brown che riconoscerà al filosofo il valore del suo contributo nel futuro sviluppo dell’associazionismo. Di Hume criticò lo scetticismo e di Locke la formazione ancora troppo aristotelica che lo condusse a considerare le idee come filtro tra il mondo esterno e la mente. Reid fu tra i primi della sua epoca a riconoscere alla mente umana facoltà che la rendevano attiva per sua stessa natura in modo innato senza essere altresì frutto di strutture perfette perché fatte ad immagine e somiglianza di dio, come aveva affermato Cartesio. Inoltre Reid riconosceva l’esistenza di facoltà mentali che erano naturalmente rivolte alla socialità. Contemporaneo e amico di David Hume giocò un ruolo importante nell’era dei lumi in Scozia. Compì studi teologici e fu, per lungo tempo, pastore nel villaggio di Newmachar (1737-1752), nei pressi di Aberdeen. Successivamente si trasferì ad Aberdeen dove fu insegnante al King’s College dal 1752 al 1764. Nel 1764 venne nominato alla cattedra di filosofia dell’Università di Glasgow succedendo a Adam Smith. Nel 1765 pubblica la sua più conosciuta opera Ricerca dello spirito umano secondo i principi del senso comune. Questo lavoro confutava le teorie basate sullo scetticismo, da Thomas Reid definite teorie delle idee dei vari David Hume, John Locke e René Descartes, opponendo un concetto che si basava sulle cose.
ANTHONY ASHLEY COOPER CONTE DI SHAFTESBURY

Accanto alla formulazione di tesi deistiche, la riflessione morale rappresenta uno dei maggiori contributi forniti dalla filosofia inglese all’illuminismo europeo; in questo senso è particolarmente significativa la figura di Anthony Ashley Cooper, terzo conte di Shaftesbury (Londra 1671 – Napoli 1713) e nipote del primo conte di Shaftesbury, che fu amico di John Locke. Le sue opere furono da lui stesso raccolte in un unico volume dal titolo ” Caratteristiche di uomini, costumi, opinioni, tempi ” (1711). Il più propriamente illuministico di questi scritti è probabilmente il primo, la ” Lettera sull’entusiasmo ” (1708), in cui Shaftesbury mette in guardia gli uomini contro il pericolo del fanatismo, dell’intolleranza, della prepotenza di chi crede di avere sempre ragione. All’ entusiasmo (che nella terminologia dell’epoca esprime appunto questi gravi difetti), Shaftesbury contrappone un tollerante senso dello humour . In tema di filosofia morale, Shaftesbury è specialmente preoccupato, come la stragrande maggioranza dei pensatori del suo tempo, di combattere lo sctticismo etico e l’individualismo egoistico di Hobbes. Alla concezione pessimistica e conflittuale che Hobbes ha della natura umana (“homo homini lupus”), egli contrappone una prospettiva, desunta dal platonismo di Cambridge, che si fonda sull’ ottimismo e sull’ armonicismo (contro questa posizione shaftesburyana si schiererà, in quegli anni, Bernard de Mandeville). L’universo è un sistema ordinato, in cui le leggi più generali sono armonicamente connesse a quelle più particolari e ciò si riflette anche dal piano metafisico a quello morale, dove il bene comune si accorda pienamente con quello individuale. In tale prospettiva, dunque, non c’è alcun conflitto tra egoismo e altruismo, dal momento che, quando l’interesse privato viene guidato da “scelte razionali” che tengono conto dell’interesse comune, l’individuo raggiunge la più alta felicità individuale nello stesso perseguimento del bene universale. Sbaglia, quindi, Hobbes a dire che nello stato di natura gli uomini si trovano in uno stato di guerra di ciascuno contro tutti gli altri (“bellum omnium contra omnes”), perché, nell’ottica hobbesiana, ciascuno di essi ha tanto la capacità quanto la volontà di nuocere al prossimo, cosicchè l’unica via di salvezza è data dalla convivenza sociale regolata dalle ferree leggi di uno Stato che incombe come un Leviatano, come un mostro biblico che incute terrore. Per Shaftesbury non è affatto vero: viceversa, l’uomo è spontaneamente incline alla società con gli altri uomini poiché l’istinto sociale è insito nella sua stessa disposizione naturale. La soluzione prospettata da Shaftesbury godrà di gran successo: sarà condivisa dalla maggior parte dei filosofi settecenteschi, sia inglesi sia continentali, anche se non sempre verrà accolta anche la cornice armonicistica in cui essa si colloca. Il principio da cui muove Shaftesbury nella sua argomentazione è il seguente: ” se in una creatura o in una specie v’è qualche cosa di naturale, è ciò che contribuisce alla conservazione della specie stessa e determina il suo benessere e la sua prosperità ” ( ” Sensus communis “, III, 2). Anche per Hobbes la conservazione di se stessi era un principio naturale, ma da esso egli traeva conclusioni antitetiche rispetto a quelle di Shaftesbury: proprio il naturale diritto a conservare la propria vita e la propria integrità fisica autorizza l’uomo, nello stato di natura, ad aggredire il suo vicino per difendersi da lui prevenendolo; per Shaftesbury, al contrario, l’istinto di autoconservazione porta alla ricerca della società con gli altri uomini e alla tutela dell’umanità in generale: ” se c’è qualche senso o appetito che sia naturale, tale è anche il senso della comunità “; ed è soprattutto nella guerra, per quanto odiosa essa sia, che si manifesta il comune senso di appartenenza alla società e di amore per essa: ” è strano pensare che la guerra, la quale appare la più selvaggia di tutte le azioni, possa appassionare gli spiriti più eroici. Ma è appunto in guerra che si serra più forte il nodo della fraternità. E’ in guerra che più si esercita il mutuo soccorso, più ci si espone al comune pericolo, più si coltiva e si pone a frutto il comune affetto. Eroismo e filantropia sono una cosa sola “. Per guidare l’uomo verso le giuste scelte morali non è però sufficiente la ragione, secondo l’illusione del razionalismo di marca cartesiana. Alla debolezza della ragione sopperisce un particolare sentimento, detto senso morale , che comporta l’immediata percezione della differenza tra bene e male, in quanto mostra la bellezza intrinseca alle buone azioni e fa provare un naturale senso di disgusto per quelle cattive. In questa connessione tra senso morale e gusto, ossia tra elemento etico ed elemento estetico, Shaftesbury rivela ancora una volta l’influenza del platonismo maturato a Cambridge; egli sostiene, però, la completa autonomia della morale dalla religione : le leggi morali non derivano dal fatto che Dio è buono e giusto, bensì, viceversa, Dio è tale in quanto esistono una giustizia e una bontà in sé, riconosciute nella loro oggettività tanto dagli uomini quanto da Dio. Per riagganciarsi famoso interrogativo posto da Platone nell’ “Eutifrone”, se le cose sono belle e giuste perché piacciono a Dio o, al contrario, piacciono a Dio perché sono belle e giuste, Shaftesbury non avrebbe dubbio alcuno nell’optare per la seconda possibilità. Percepire il bene o il male significa, ad avviso di Shaftesbury, avere sentore di un’armonia o di una disarmonia proprio come avviene nel giudizio estetico; la virtù non si fonda sulla rivelazione divina, ma, al contrario, poiché l’uomo è naturalmente virtuoso, è la retta coscienza ad ispirare la fede in Dio. Pur respingendo l’esistenza di idee innate, Shaftesbury difende il valore dell’innatismo , da lui considerato però come concordanza con la natura e conformità all’istinto, in opposizione a tutto ciò che deriva dalla cultura e dall’educazione. Tale innatismo non ha quindi un valore razionale, ma sentimentale, poiché si fonda sui sentimenti immediati, innati nell’uomo. Tali sentimenti vengono posti a fondamento della vita morale, religiosa ed estetica dell’uomo. L’uomo possiede un “sentimento morale” che nasce dall’istinto naturale e che si oppone alle passioni disordinate. Dato che tutto nell’universo è conforme ad un ordine buono, il sentimento morale altro non è che aspirazione all’ordine e all’armonia. Dapprima questo si configura come un’aspirazione all’equilibrio tra egoismo ed altruismo, poi come tendenza all’armonia sociale e, infine, come un abbandono nell’unità ed armonia universali. Tale virtù si identifica con un altro sentimento: l’ intuizione del bello . Saper cogliere l’ordine e l’armonia del tutto, significa altresì saper cogliere il pensiero e la presenza di Dio, immanente al creato. Ecco allora che la filosofia di Shaftesbury sfocia nel panteismo, quasi a costituire una sorta di remoto preludio al romanticismo. In ” Consigli a un autore “, pubblicati nel 1710, (opera piena di arguzia, intelligenza, spinto di tolleranza e profondità) Shaftesbury sostiene che ciò che viene solitamente denominato “dare consigli” è una parte rilevante dell’attività degli scrittori o, come diremmo oggi, degli intellettuali. Ma non è per nulla facile fare dei consigli un dono gratuito. Colui che li impartisce tende principalmente a far mostra della propria saggezza a spese altrui e colui che dovrebbe riceverli è in genere disposto ad accettare la figura di un maestro in matematica, in musica, o in qualsiasi altra scienza, ma non certo in intelligenza e buon senso. Ciò nonostante tutti gli autori – esplicitamente o meno si dichiarano, per la loro epoca, maestri di intelligenza. L’aspirazione dell’operetta di Shaftesbury non è quella di dare consigli, ma di valutare i modi di dare consigli. Il compito non è superiore a quello che si propone un insegnante di lingue o di logica, ma il problema, in questo caso, va considerato come un caso particolare di chirurgia. In quest’ultima contano insieme e contemporaneamente la compassione, la delicatezza della mano e la fermezza e l’audacia. Su chi esercitare un’arte siffatta? Come trovare un paziente cosi docile con il quale si possa procedere con rapidità e decisione e verso il quale si sia certi di conservare la massima delicatezza possibile? La soluzione è una sola: ricorrere a quel soliloquio che è da sempre prerogativa dei poeti e che, mediante una vera e propria arte della dissezione, trasforma una persona in due persone distinte. Si è insieme discepolo e precettore, insegnante e allievo, si impara la difficile arte del controllo. Ci si rende conto che preferiremmo essere insolentiti dagli altri piuttosto che venire accusati da noi stessi. Un vero, costante colloquio con se stessi può configurarsi come una forma di autoaddestrarnento, può anche presentarsi come un argine ai detestabili grandi parlatori nelle pubbliche assemblee che sono del tutto incapaci di parlare con se stessi e che di questo hanno letteralmente paura. Shaftesbury sta davvero alle origini dell’etica dei moderni o, meglio, è l’idea stessa di modernità che si pone nelle sue pagine come problema etico. L’entusiasmo è alla base dell’ispirazione che anima i poeti, gli artisti e i filosofi, ma anche i politici e gli eroi; va invece ripudiata la passione, nei confronti della quale consiglio come antidoto il buonumore. Come spiega nel ” Saggio sulla libertà dello spirito umoristico “, che è scritto sotto forma di una lettera a un amico, esistono varie forme di umorismo satirico, che varia secondo la libertà di pensiero di ognuno. In qualunque modo si voglia considerare l’umorismo, Shaftesbury lo ritiene un rimedio contro l’eccessivo zelo in qualsiasi campo: nella morale, nella politica ed anche nella religione.
FRANCIS HUTCHESON

A cura di Alessandra Nisticò
“L’azione migliore è quella che procura la maggior felicità per il maggior numero; la peggiore è quella che, in modo simile, produce sofferenza”. (“Ricerca sull’origine delle nostre idee di bellezza e virtù”, III)
VITA E OPERE
Il filosofo Francis Hutcheson fu una figura preminente nel periodo generalmente conosciuto come “Illuminismo Scozzese”. “L’Illuminismo Scozzese” si riferisce all’esplosione dell’attività scolastica avvenuta nel XVIII secolo in Scozia – soprattutto a partire dal 1740. In questo periodo, un numero di scolastici scozzesi produsse molte opere influenti nei campi della filosofia, della storia, del diritto e della scienza. Alcuni dei più famosi contemporanei di Hutcheson comprendono David Hume, il quale fu profondamente influenzato dagli scritti di Hutcheson, e Adam Smith del quale Hutcheson fu un insegnante. Sebbene la sua famiglia fosse di origini scozzesi, Hutcheson nacque nel 1694 a Armagh, in Irlanda. Suo padre fu un ministro presbiteriano che stabilì una congregazione nel paese. Da giovane studiò presso l’università di Glasgow. Studiò poesia classica, filosofia, e teologia per divenire un ministro presbiteriano. Hutcheson si laureò presso l’Università di Glasgow nel 1712. Ma rimase all’Università fino al 1716 studiando teologia sotto la supervisione del professore John Simon, un famoso teologo del tempo. Hutcheson ricevette il permesso di predicare all’interno della Chiesa Presbiteriana nel 1716. Poco tempo dopo fu assegnato ad una congregazione nella città di Magherally, in Scozia. Comunque, la sua vocazione come ministro ebbe vita breve e problematica. Prima dal suo arrivo a Magherally, alcuni membri eminenti della comunità espressero dubbi su Hutcheson. Alcuni sentivano che i suoi sermoni “irlandesi” non si accordavano molto con lo spirito “scozzese” delle loro Scritture. Queste perplessità sembra abbiano più a che fare con la politica presbiteriana del tempo, piuttosto che con Hutcheson stesso. Comunque, la polemica fu abbastanza forte da dissuadere Hutcheson dal prendere posto a Magherally. Hutcheson, sebbene fosse un uomo molto religioso, abbandonò presto il ministero e iniziò a seguire una vita all’interno dell’accademia. Spese la prima parte della sua carriera accademica insegnando presso l’Accademia di Dublino, in Irlanda. Insegnò all’Accademia per alcuni anni mentre continuava privatamente gli studi. Nel 1725 il nome di Hutcheson divenne conosciuto all’interno dei più famosi circoli con la pubblicazione della sua “Indagine nell’originale delle nostre idee di Bello e Virtù”. Nel 1729 fu consigliato per la cattedra di Filosofia morale all’Università di Glasgow. L’Università di Glasgow, insieme con l’Università di Edimburgo, erano i centri intellettuali dell’Illuminismo Scozzese. Hutcheson accettò immediatamente la cattedra all’Università di Glasgow, ove rimase fino alla sua morte, avvenuta nel 1746. Le due prime opere di Hutcheson sono “L’Indagine nell’originale delle nostre idee di Bello e Virtù” (1725) e un “Saggio sulla Natura e la Condotta delle Passioni e delgi Affetti, con Illustrazioni del Senso Morale” (1728). Il resto del corpus di Hutcheson include: “Synopsis Metaphysicae, Ontologiam et Phneumatologiam Complectens” (1744), “Philosophiae Moralis Institutio Compendiaria” (1743), “Reflections upon Laughter and Remarks Upon the Fable of the Bees” (1750) e “A System of Moral Philosophy” (1755).
L’ESTETICA
La filosofia di Francis Hutcheson è il punto di partenza dell’estetica moderna come distinta disciplina filosofica. Sebbene molti filosofi prima di lui abbian fatto diversi commenti sulla bellezza e l’estetica, Hutcheson fu il primo scolastico a sviluppare una comprensiva teoria della bellezza; scrisse anche ampiamente sulla sensibilità morale e la teoria politica. Le teoria estetica di Hutcheson è profondamente influenzata da due pensatori: John Locke e Shaftesbury. Hutcheson accetta l’empirismo di Locke, dell’esperienza come fonte di tutte le idee e utilizza anche la divisione di Locke dei sensi in due categorie: esterne e interne. I frammentati commenti di Shaftesbury sull’estetica servirono a Hutcheson nell’esposizione del “senso” filosofico della bellezza. L’“Indagine nell’Originale delle nostre Idee di Bello e Virtù” fu pubblicata anonima: egli non volle porre il suo nome sul saggio per insicurezza sulla materia trattata. Comunque, il saggio fu accolto molto bene. Nell’Indagine Hutcheson sostiene che insieme ai sensi eterni come l’udito, la vista, il tatto, noi abbiamo anche un “senso interno”. Questo “senso interno” è una facoltà che ci permette di provare piacere quando siamo a contatto con qualcosa di bello. Hutcheson afferma che i nostri sensi esterni non ci possono far conoscere e sperimentare l’idea di Bello. Per saggiare il Bello, occorre un “senso interno” che riconosce e registra il fenomeno “Bello”. I sensi esterni lavorano assieme al senso interno per offrirci il piacere del bello. In questo modo, i nostri sensi esterni portano un oggetto alla nostra conoscenza e poi il nostro “senso interno” reagisce alla nostra esperienza dell’oggetto. Se l’oggetto possiede bellezza, allora il nostro “senso interno” produce piacere. Al contrario, se l’oggetto è deformato o brutto, allora il nostro “senso interno” provoca disgusto. Hutcheson descrive l’importanza del “senso interno”:
“Questo potere superiore della percezione è giustamente chiamato senso, a causa della sua affinità con gli altri sensi in ciò, che il piacere non sorge da alcuna conoscenza di princìpi, proporzioni, cause o dall’utilità dell’oggetto; ma ci colpisce subito con l’idea di Bellezza”.
Hutcheson sottolinea l’importanza della relazione tra il nostro “senso interno” e il concetto di bello. La sua teoria estetica è una teoria soggettivista del bello. Per Hutcheson, il concetto di bello esiste nella mente e non nell’oggetto (su ciò Hume concorderà pienamente). Comunque, il soggettivismo può portare ad un relativismo estetico. Conseguentemente, Hutcheson definisce e descrive attentamente quali caratteristiche negli oggetti suscitano la sensazione di “bello” all’interno del nostro “senso interno”. Hutcheson divide il bello in due categorie: bello originale e bello comparato. Il bello originale è percepito dagli oggetti che naturalmente accadono nella nostra esperienza. Proporzione e armonia sono le caratteristiche primarie in questi oggetti che eccitano il nostro “senso interno” del bello. Hutcheson usa la frase “uniformità mista a varietà” per descrivere le giuste proporzioni del bello. Un oggetto è bello se è armonioso, la quantità di bellezza ricevuta da un oggetto risulta dalla quantità di armonia e proporzioni contenuta nell’oggetto. Per Hutcheson, le forme geometriche sono belle a causa della loro armonia e proporzione. Sicchè la buona architettura, la rivoluzione dei pianeti, un giardino ben tenuto, sono considerati belli a causa della loro uniformità alle proporzioni. Si deve notare che un oggetto non deve essere tangibile affinché sia bello. Hutcheson afferma anche che i teoremi matematici posseggono “bellezza” nella proporzione e nell’armonia delle loro variabili. Hutcheson definisce il bello comparato come il bello prodotto imitando un oggetto, una persona, un’idea originale. Questa categoria di bello risiede nelle Belle Arti. Hutcheson afferma che il bello comparato viene registrato dal nostro “senso interno” perché contiene aspetti che imitano il bello originale. Un senso di bello può derivare anche dalle imitazioni confrontandole direttamente con l’oggetto originale che è stato imitato. In questo modo un’opera d’arte è bella se cattura l’armonia e le proporzioni dell’oggetto, della persona o dell’idea originale.
L’ETICA
Il pensiero inglese di inizio Settecento che trova in Shaftesbury e in Hutcheson i suoi campioni si accanisce contro Mandeville e contro Hobbes e la sua negazione della naturale bontà del genere umano (“homo homini lupus”, dice Hobbes). Questi due pensatori, aristocratici e dalle condizioni agiate, asseriscono che, lungi dal ridursi a mero sforzo di autoconservazione, l’uomo è naturalmente simpatia per gli altri suoi simili: viene in questo modo fondato il Settecento “sentimentale” che protesta e rompe con il razionalismo e l’intellettualismo all’epoca dilaganti; l’uomo non è solo ragione, ma è anzi anche e soprattutto sentimento, tale per cui prova per natura simpatia verso i suoi simili e, seguendo gli slanci di siffatto sentimento, dà vita alla famiglia e allo Stato. Si tratta di un sentimento naturale nel senso che è immediato e spontaneo, è cioè un qualcosa che la natura ci detta al di qua di ogni riflessione e di ogni arte, è un “istinto divino” in tutti presente e a cui tutti tendiam l’orecchio: suoi oggetti sono, innanzitutto, le evidenze preriflessionali quali la benevolenza e la simpatia per i nostri simili, nonché un senso di giustizia volto a realizzare nella società un’armonica convivenza (rispecchiante quella della natura) fra gli individui. Ciò che nello specifico Shaftesbury predica è un umanesimo della simpatia, il cui fine naturale consiste primariamente nel raggiungere la virtù e la felicità che ne scaturisce. Hutcheson, esprimendosi in termini affini, va dicendo che l’uomo è animato da un immediato sentimento morale, che è sentimento del bene comune e che noi proviamo inintenzionalmente, a prescindere da ogni riflessione: tale sentimento si sostanzia del desiderio che ciascuno sia felice, sicchè l’uomo non si muove esclusivamente per promuovere e tutelare i suoi individuali interessi, ma, viceversa, per garantire quelli di tutti e non agisce così in vista del proprio bene: se per Machiavelli e Hobbes il perseguimento dell’interesse comune era la cornice per meglio perseguire quello individuale, per Hutcheson e Shaftesbury quello comune vien prima di quello individuale, e anzi quest’ultimo è a al primo subordinato. E questo sentire, configurato come disinteressato, non si colloca né sul piano della razionalità né su quello delle passioni, bensì su un altro e più elevato livello: di esso la metafisica classica non era ignara, e anzi in buona parte tanto l’eros platonico quanto la meraviglia aristotelica – che della filosofia è il motore – ne erano una prima precisa formulazione, quasi come se in essi si presentisse per via arazionale la verità a cui la ragione perviene solo secondariamente. Hutcheson riprende il tema shaftesburiano della benevolenza universale come componente cardinale della natura umana: pur nutrendo maggior fiducia nell’umana ragione rispetto a quella nutrita dallo stesso Shaftesbury, egli non fa che rivalutare il sentimento, ed è da qui che Rousseau prenderà le mosse. Gli uomini, così come posseggono un senso estetico o un gusto stante alla base delle loro valutazioni estetiche, dispongono anche di un senso morale che li spinge spontaneamente a provar piacere di fronte alle azioni virtuose, senza tener conto dell’utilità che da esse può derivare. Le azioni che il senso morale induce ad approvare di più sono quelle procuranti “la maggior felicità per il maggior numero”: da tale constatazione prenderà le mosse l’utilitarismo di fine Settecento e inizio Ottocento.
BERNARD DE MANDEVILLE

“Il vizio è tanto necessario in uno stato fiorente quanto la fame è necessaria per obbligarci a mangiare. È impossibile che la virtú da sola renda mai una nazione celebre e gloriosa”.
BREVE INTRODUZIONE
Bernard del Mandeville nasce a Dordrecht, presso Rotterdam, nel 1670. Appartenente ad un’agiata famiglia di politici e medici, frequenta e si laurea in medicina alla celebre Università di Leyden a soli ventuno anni, nel 1691. Ben presto si trasferisce a Londra, dove esercita con eccellenti risultati la pratica medica (specializzandosi nei disturbi nervosi e in quelli dello stomaco) e dove si stabilisce definitivamente dopo essersi sposato, nel 1699, sino al 1733, quando si spegne ad Hackney. A parte questo della sua vita conosciamo poco. Al debutto del nuovo secolo, pur non abbandonando la professione medica, si dedica all’attività letteraria, prima come traduttore, poi facendo emergere la sua funambolica vena satirica che lo renderà un polemista capace di suscitare entusiasmo come feroci critiche. Data al 1704 la prima edizione della sua opera di maggiore successo, che gli procura fama e invettive in patria e che lo ha reso famoso ai posteri: The grumbling hive, or knaves turn’d honest (L’alveare ronzante ovvero i truffatori divenuti onesti). Successivamente, nel 1714, ne cura una nuova edizione che pubblica con il titolo The fable of the bees, or, private vices, publick benefits (La favola delle api, ovvero vizi privati, pubbliche virtù), nella quale inserisce anche un saggio intitolato Ricerca sull’origine della morale ed un ricco apparato di note. La favola delle api viene più volte modificata ed integrata sino al 1729 quando raggiunge la sua forma definitiva, alla quale oggi facciamo riferimento. Tra le altre sue opere che ne hanno fatto un rappresentante del primo illuminismo inglese, insieme a Jonathan Swift e a Alexander Pope, ricordiamo A modest defence of public stews (Una modesta difesa delle case di piacere), An inquiry into the origin of honour (Un’indagine sull’origine dell’onore) e A letter to Dion. La favola delle api, che fruttò all’autore anche noie giudiziarie, rappresenta il tipico esempio dei trattatelli filosofici di quella stagione felice e prospera di ingegni che fu l’illuminismo inglese, a torto negletta a vantaggio del successivo periodo francese, con la quale ha poco o punto a che vedere. Breve ed estremamente semplice da leggere, colma di sferzante sarcasmo e di immagini immediatamente recepibili, si tratta tuttavia di un’opera che sottende un’articolata indagine sul costume, sulla morale, pubblica e privata, e sull’effetto dell’intervento normativo dell’autorità pubblica. Di questo incessante approfondimento sono espressione le note e soprattutto il saggio che completano la favola. Mandeville dice, significativamente, che i vizi e le imperfezioni dell’uomo, sommate alla intemperie ambientali, spingono l’uomo stesso all’evoluzione biologica: proprio perché pungolato dall’amor proprio, egli organizza al meglio la sopravvivenza terrena, e le passioni in cui essa si ordina (orgoglio, avarizia, ecc) producono finalità (desiderio di arricchirsi e di primeggiare) e comportamenti (emulazione, concorrenza, ecc) la cui utilità pubblica è innegabile: quelli che sono vizi sul piano privato (l’emulazione, l’arricchirsi, ecc) diventano virtù sul piano pubblico, come recita il titolo della favola di Mandeville “La favola delle api. Vizi private e pubbliche virtù”, in cui l’autore racconta di un favo di api in cui la produzione del miele procede magnificamente poiché tutti lavorano instancabilmente, finchè esse non decidono di chiedere a Giove di far sì che si comportino non più per interesse ma per virtù: accontentate dal padre degli dèi, il loro favo va presto in rovina. La morale che se ne ricava è fin troppo evidente: “il vizio è tanto necessario in uno stato fiorente quanto la fame è necessaria per obbligarci a mangiare. È impossibile che la virtú da sola renda mai una nazione celebre e gloriosa”.
IL PENSIERO
Medico e filosofo olandese di origine francese, trascorse gran parte della sua vita in Inghilterra dove pubblicò i propri scritti in cui combatteva le convinzioni sociali e morali del tempo. In particolare, egli sostenne che l’egoismo non deve essere represso, in quanto perno attorno al quale si dispiegano le facoltà umane atte a realizzare il progresso e la convivenza sociale, ed è tramite appunto l’egoismo che i vizi privati si convertono in pubblici benefici. La sua opera fondamentale è “La Favola delle Api”, in cui esprime in modo radicale l’opinione secondo cui è l’interesse personale a guidare l’azione economica e a rendere possibile il pubblico beneficio. Incentrata sul poema allegorico dal titolo “L’alveare scontento”, venne pubblicata per la prima volta nel 1703, ma acquisì notorietà, grazie agli scandali che sollevò, nelle sue successive edizioni del 1714 e del 1723, con un commentario dello stesso autore con quello che sarà il titolo definitivo dell’opera, ossia “La Favola delle Api – vizi privati e pubblici benefici”. All’origine prospero e potente, questo “alveare” finisce per diventare povero e spopolato nel momento in cui i suoi abitanti mutano le proprie abitudini, divenendo parchi, risparmiatori, nonché virtuosi cittadini, da prodighi, orgogliosi e dediti a una vita lussuosa quali erano in precedenza. E la diminuzione dei consumi conseguente al mutamento dei costumi, finisce per provocare disoccupazione, depressione, e, di conseguenza, impoverimento generalizzato. Questo rapporto che Mandeville individua tra consumi e occupazione sembra indicarlo come un “keynesiano ante-litteram”. L’autore inglese ritiene che esistano due concezioni differenti della società civile, una prima che presuppone l’immagine di una comunità piccola , frugale e pacifica, retta dalla virtù e dallo spirito pubblico dei cittadini, e una seconda che si identifica con una società vasta e popolosa, commerciale e militare, priva sia della capacità, che del bisogno di suscitare la dedizione dei cittadini. Il confronto tra queste due concezioni diviene in Mandeville il fulcro di un’intera idea sociale e morale. Secondo Mandeville, un gruppo poco numeroso insediato su un territorio limitato, arriva a creare una società chiusa, pacifica ed egualitaria; frugale, senza commercio e denaro, dove i consumi sono limitati ai prodotti naturali del luogo. Una società, per dirla con Mandeville: “di uomini buoni e pacifici, disposti a essere poveri pur di stare tranquilli”. All’opposto, la società grande e popolosa, resa militarmente forte ed espansiva da un esercito permanente e professionale, controllata giuridicamente e amministrativamente da un potere politico sovrano e unitario, volta al commercio interno ed estero. I bisogni crescenti di questa società provocano la necessità di una moltiplicazione delle risorse disponibili, del progresso delle scienze e delle arti, mentre la sua prosperità e la sua potenza è legata al numero degli abitanti. Lo spirito civico cessa di essere il principio cardine della società, come pure il senso di appartenenza ad una comunità morale da parte dei suoi membri, la cui cooperazione reciproca (ognuno realizza i suoi fini lavorando per gli altri) è motivata unicamente dal proprio interesse personale. Ciò comporta che la grande società è una società commerciale, cui ognuno partecipa attraverso lo scambio di beni e servizi, rendendo così possibile la divisione del lavoro, e quindi il progresso tecnico e scientifico, ottenuto con la specializzazione, l’accumulo e la trasmissione dell’esperienza. Di conseguenza, l’istituzione del denaro diviene condizione per l’ordine, l’economia e la stessa esistenza della società civile. Mandeville è stato interpretato in vari modi dagli economisti moderni, chi ne ha fatto un epigono del “laissez-faire”, chi lo ha considerato un vero e proprio mercantilista, ma non si è lontani dal vero quando si afferma che risentì delle idee di un’epoca di transizione dal mercantilismo al liberoscambismo. Tra gli autori pre-classici, comunque, sembra essere quello che più di ogni altro ha enfatizzato il ruolo dell’interesse nella guida delle azioni individuali. Secondo Mandeville, le azioni umane sono indotte da considerazioni egoistiche sui propri desideri e passioni, e sui modi più semplici per soddisfarli, dal che si evince che le relazioni degli uomini con i loro bisogni materiali sono più importanti delle relazioni degli uomini tra loro, e che gli uomini vivono in società non perché la loro natura sia fondamentalmente sociale, ma unicamente per soddisfare i loro bisogni. Contrariamente a quanto sosterrà un secolo più tardi uno dei profeti del “laissez-faire”, Frederic Bastiat, Mandeville non credeva che vi fosse un’automatica armonia tra interessi sociali e individuali. Egli riteneva che i vizi privati possono portare a pubblici benefìci solo se l’interesse egoistico è propriamente indirizzato verso fini sociali dalla mano del governo politico. Il governo, secondo Mandeville, deve assicurare certi diritti fondamentali, promuovendo lo sviluppo istituzionale adeguato a liberare le potenzialità produttive dei cittadini ampliandone i bisogni e i desideri. Allo stesso modo, passioni quali orgoglio e vanità devono essere appropriatamente stimolate a perseguire l’interesse individuale, a patto che non si traducano in crimini che interferiscano con la pace e il benessere pubblico. Poiché anche gli economisti classici delle generazioni successive consideravano un quadro di istituzioni sociali e legali come premessa per l’operare efficiente dell’economia di mercato, si può sostenere che la forza con cui egli ha sottolineato il ruolo dell’interesse personale e la capacità equilibrante del mercato, avvicina Mandeville più alle posizioni liberali che non a quelle mercantiliste. È infine importante rilevare come in Mandeville si intraveda un nuovo modo di concepire il rapporto tra etica e ordine sociale. Se da un punto di vista etico le azioni virtuose sono quelle che intenzionalmente conducono al bene pubblico, le azioni effettivamente intraprese dagli individui riguardano il loro proprio interesse, mentre il benessere collettivo dipende da azioni che non sono consapevolmente rivolte a tale scopo. Dopo la religione, con Mandeville, anche la morale viene espulsa dalla considerazione degli affari umani, il che ci porta a considerare Mandeville come un autore “di transizione”, che opera una cesura tra sistema etico da un lato, nel quale l’ordine sociale dipende da regole morali che si riferiscono alla società intera, e sistema economico dall’altro, le cui regole dipendono dalle motivazioni individuali.
LA FAVOLA DELLE API
“Un numeroso sciame di api abitava un alveare spazioso. Là, in una felice abbondanza, esse vivevano tranquille. Questi insetti, celebri per le loro leggi, non lo erano meno per il successo delle loro armi e per il modo in cui si moltiplicavano. La loro dimora era un perfetto seminario di scienza e d’industria. Mai api vissero sotto un governo piú saggio; tuttavia mai ve ne furono di piú incostanti e di meno soddisfatte. Esse non erano né schiave infelici di una dura tirannia, né erano esposte ai crudeli disordini della feroce democrazia. Esse erano condotte da re che non potevano errare, perché il loro potere era saggiamente vincolato dalle leggi. Questi insetti, imitando ciò che si fa in città, nell’esercito e nel foro, vivevano perfettamente come gli uomini ed eseguivano, per quanto in piccolo, tutte le loro azioni. Le opere meravigliose compiute dall’abilità incomparabile delle loro piccole membra sfuggivano alla debole vista degli uomini; tuttavia non vi sono presso di noi né macchine, né operai, né mestieri, né navi, né cittadelle, né armate, né artigiani, né astuzie, né scienza, né negozi, né strumenti, insomma non v’è nulla di ciò che si vede presso gli uomini di cui questi operosi animali pure non si servissero. E siccome il loro linguaggio ci è sconosciuto, non possiamo parlare di ciò che le riguarda se non impiegando le nostre impressioni. Si ritiene generalmente che tra le cose degne d’esser notate, questi animali non conoscevano affatto l’uso né dei bossoli né dei dadi; ma, poiché avevano dei re, e conseguentemente delle guardie, si può naturalmente presumere che conoscessero qualche specie di giochi. Si vedono mai, infatti, degli ufficiali e dei soldati che si astengono da questo divertimento? Il fertile alveare era pieno di una moltitudine prodigiosa di abitanti, il cui grande numero contribuiva pure alla prosperità comune. Milioni di api erano occupate a soddisfare la vanità e le ambizioni di altre api, che erano impiegate unicamente a consumare i prodotti del lavoro delle prime. Malgrado una cosí grande quantità di operaie, i desideri di queste api non erano soddisfatti. Tante operaie e tanto lavoro potevano a mala pena mantenere il lusso della metà della popolazione. Alcuni, con grandi capitali e pochi affanni, facevano dei guadagni molto considerevoli. Altri, condannati a maneggiare la falce e la vanga, non potevano guadagnarsi la vita se non col sudore della fronte e consumando le loro forze nei mestieri piú penosi. Si vedevano poi degli altri applicarsi a dei lavori del tutto misteriosi, che non richiedevano né apprendistato, né sostanze, né travagli. Tali erano i cavalieri d’industria, i parassiti, i mezzani, i giocatori, i ladri, i falsari, i maghi, i preti, e in generale tutti coloro che, odiando la luce, sfruttavano con pratiche losche a loro vantaggio il lavoro dei loro vicini, che non essendo essi stessi capaci d’ingannare, erano meno diffidenti. Costoro erano chiamati furfanti; ma coloro i cui traffici erano piú rispettati, anche se in sostanza poco differenti dai primi, ricevevano un nome piú onorevole. Gli artigiani di qualsiasi professione, tutti coloro che esercitavano qualche impiego o che ricoprivano qualche carica, avevano tutti qualche sorta di furfanteria che era loro propria. Erano le sottigliezze dell’arte e l’abilità di mano. Come se le api non avessero potuto, senza istruire un processo, distinguere il legittimo dall’illegittimo, esse avevano dei giureconsulti, occupati a mantenere le animosità e a suscitare malefici cavilli: questo era lo scopo della loro arte. Le leggi fornivano loro i mezzi per rovinare i loro clienti e per approfittare destramente dei beni in questione. Preoccupati, soltanto di ricavare degli elevati onorari, non trascuravano nulla al fine d’impedire che si appianassero le difficoltà attraverso un accomodamento. Per difendere una cattiva causa, essi analizzavano le leggi con la stessa meticolosità con cui i ladri esaminano i palazzi e i negozi. Ciò soltanto allo scopo di scoprire il punto debole in cui potessero prevalere. I medici preferivano la reputazione alla scienza e le ricchezze alla guarigione dei loro malati. La maggior parte, anziché applicarsi allo studio dei princípi della loro disciplina, cercavano di acquistarsi una pratica fittizia. Sguardi gravi e un’aria pensosa erano tutto quello ch’essi possedevano per darsi la reputazione di uomini dotti. Non preoccupandosi della salute dei pazienti, essi lavoravano soltanto per acquistarsi il favore dei farmacisti, e per conquistarsi le lodi delle levatrici, dei preti e di tutti coloro che vivevano dei proventi tratti dalle nascite o dai funerali. Preoccupati di acquistarsi il favore del sesso loquace, essi ascoltavano con compiacenza le vecchie ricette della signora zia. I clienti, e tutte le loro famiglie, erano trattati con molta attenzione. Un sorriso affettato, degli sguardi graziosi, tutto era impiegato e serviva ad accattivarsi i loro spiriti già prevenuti. E si badava pure a trattare bene le guardie, per non doverne subire le impertinenze. Tra il grande numero dei preti di Giove, pagati per attirare sull’alveare la benedizione del cielo, ve n’erano ben pochi che avessero eloquenza e sapere. La maggior parte erano tanto presuntuosi quanto ignoranti. Erano visibili la loro pigrizia, la loro incontinenza, la loro avarizia e la loro vanità, malgrado la cura ch’essi si prendevano per nascondere agli occhi del pubblico questi difetti. Essi erano furfanti come dei borsaioli, intemperanti come dei marinai. Alcuni invece erano pallidi, coperti di vestiti laceri e pregavano misticamente per guadagnarsi il pane. E, mentre che questi sacri schiavi morivano di fame, i fannulloni per cui essi officiavano, si trovavano bene a loro agio. Si vedevano sui loro volti la prosperità, la salute e l’abbondanza di cui godevano. I soldati che erano stati messi in fuga venivano egualmente coperti di onori, se avevano la fortuna di sfuggire all’esercito vittorioso, anche se tra essi vi fossero dei veri poltroni, che non amavano affatto le stragi. Se vi era qualche valente generale che metteva in rotta i nemici, si trovava qualche persona che, corrotta con dei regali, favoriva la loro ritirata. Vi erano pure dei guerrieri che affrontavano il pericolo comparendo sempre nei punti piú esposti. Prima perdevano una gamba, quindi un braccio, infine, quando tutte queste mutilazioni li avevano resi non piú in grado di servire, li si congedava vergognosamente a mezza paga; mentre altri, che piú prudentemente non andavano mai all’attacco, ricavavano la doppia paga, per restare tranquillamente tra di loro. I loro re erano, sotto ogni riguardo, mal serviti. I loro ministri li ingannavano. Ve n’erano invero parecchi che non tralasciavano nulla per far progredire gl’interessi della corona; ma contemporaneamente essi saccheggiavano impunemente il tesoro che s’industriavano ad arricchire. Essi avevano il felice talento di spendere abbondantemente, nonostante che i loro stipendi fossero molto meschini; e per giunta si vantavano di essere molto modesti. Si esagerava forse nel considerare le loro prerogative quando le si denominava le loro “malversazioni”? E anche se ci si lamentava che non si comprendeva il loro gergo, essi si servivano del termine di “emolumenti”, senza mai voler parlare naturalmente e senza camuffamenti dei loro guadagni. Infatti non vi fu mai un’ape che sia stata effettivamente soddisfatta nel desiderio di apprendere, non dico quello che guadagnavano effettivamente questi ministri, ma neppure ciò che essi lasciavano scorgere dei loro guadagni. Essi assomigliavano ai nostri giocatori, i quali, per quanto siano stati fortunati al gioco, non diranno tuttavia mai in presenza dei perdenti tutto quello che hanno guadagnato. Chi potrebbe descrivere dettagliatamente tutte le frodi che si commettevano in questo alveare? Colui che acquistava del letame per ingrassare il suo prato, lo trovava falsificato per un quarto con pietre e cemento inutili; e per giunta qualsiasi poveretto non avrebbe avuto la facilità di brontolare di ciò, perché a sua volta imbrogliava mescolando al suo burro una metà di sale. La giustizia stessa, per quanto tanto rinomata per la sua fortuna di essere cieca, non era per questo meno sensibile al brillante splendore dell’oro. Corrotta dai doni, essa aveva sovente fatto pendere la bilancia che teneva nella sua mano sinistra. Imparziale in apparenza, quando si trattava d’infliggere delle pene corporali, di punire degli omicidi o degli altri gravi crimini, essa aveva bens’ spesso condannato al supplizio persone che avevano continuato le loro ribalderie dopo esser state punite con la gogna. Tuttavia si riteneva comunemente che la spada che essa portava non colpiva se non le api che erano povere e senza risorse; e che anche questa dea faceva appendere all’albero maledetto delle persone che, oppresse dalla fatale necessità, avevano commesso dei crimini che non peritavano affatto un tale trattamento. Con questa ingiusta severità, si cercava di mettere al sicuro il potente e il ricco. Essendo cosí ogni ceto pieno di vizi, tuttavia la nazione di per sé godeva di una felice prosperità. era adulata in pace, temuta in guerra. Stimata presso gli stranieri, essa aveva in mano l’equilibrio di tutti gli altri alveari. Tutti i suoi membri a gara prodigavano le loro vite e i loro beni per la sua conservazione. Tale era lo stato fiorente di questo popolo. I vizi dei privati contribuivano alla felicità pubblica. Da quando la virtú, istruita dalle malizie politiche, aveva appreso i mille felici raggiri dell’astuzia, e da quando si era legata di amicizia col vizio, anche i piú scellerati facevano qualcosa per il bene comune. Le furberie dello stato conservavano la totalità, per quanto ogni cittadino se ne lamentasse. L’armonia in un concerto risulta da una combinazione di suoni che sono direttamente opposti. Cosí i membri di quella società, seguendo delle strade assolutamente contrarie, si aiutavano quasi loro malgrado. La temperanza e la sobrietà degli uni facilitava l’ubriachezza e la ghiottoneria degli altri. L’avarizia, questa funesta radice di tutti i mali, questo vizio snaturato e diabolico, era schiava del nobile difetto della prodigalità. Il lusso fastoso occupava milioni di poveri. La vanità, questa passione tanto destata, dava occupazione a un numero ancor maggiore. La stessa invidia e l’amor proprio, ministri dell’industria, facevano fiorire le arti e il commercio. Le stravaganze nel mangiare e nella diversità dei cibi, la sontuosità nel vestiario e nel mobilio, malgrado il loro ridicolo, costituivano la parte migliore del commercio. Sempre incostante, questo popolo cambiava le leggi come le mode. I regolamenti che erano stati saggiamente stabiliti venivano annullati e si sostituivano ad essi degli altri del tutto opposti. Tuttavia con l’alterare anche le loro antiche leggi e col correggerle, le api prevenivano degli errori che nessuna accortezza avrebbe potuto prevedere. In tal modo, poiché il vizio produceva l’astuzia, e l’astuzia si prodigava nell’industria, si vide a poco a poco l’alveare abbondare di tutte le comodità della vita. I piaceri reali, le dolcezze della vita, la comodità e il riposo erano divenuti dei beni cosí comuni che i poveri stessi vivevano allora piú piacevolmente di quanto non vivessero prima. Non si sarebbe potuto aggiungere nulla al benessere di questa società. Ma, ahimè, qual è mai la vanità della felicità dei poveri mortali! Non appena queste api avevano gustato le primizie del benessere, tosto mostrarono che è persino al di là del potere degli dèi il rendere perfetto il soggiorno terrestre. Il gruppo mormorante aveva spesso affermato di esser soddisfatto del governo e dei ministri; ma al piú piccolo dissesto cambiò idea. Come se fosse perduto senza scampo, maledí le politiche, gli eserciti e le flotte. Queste api riunirono le loro lagnanze, diffondendo ovunque queste parole: “siano maledette tutte le furberie che regnano presso di noi!”. Tuttavia ciascuna se le permetteva ancora; ma ciascuna aveva la crudeltà di non volerne concedere l’uso agli altri. Un personaggio che aveva ammassato immense ricchezze, ingannando il suo padrone, il re e i poveri, osò gridare a tutta forza: “il paese non può mancare di perire a causa di tutte le sue ingiustizie!”. E chi pensate che sia stato queste severo predicatore? Era un guantaio, che aveva venduto per tutta la sua vita, e che vendeva anche allora, delle pelli d’agnello per pelli di capretto. Non faceva la minima cosa in questa società che contribuisse al bene pubblico. Tuttavia ogni furfante gridò con impudenza: “buon Dio, dateci soltanto la probità!”. Mercurio (il dio dei ladroni) non poté trattenersi dal ridere nell’ascoltare una preghiera cos’ sfrontata. Gli altri dèi dissero che era stupidità il biasimare ciò che si amava. Ma Giove, indignato per queste preghiere, giurò infine che questo gruppo strillante sarebbe stato liberato dalla frode di cui essa si lamentava. Egli disse: “Da questo istante l’onestà s’impadronirà di tutti i loro cuori. Simile all’albero della scienza, essa aprirà gli occhi di ciascuno e gli farà percepire quei crimini che non si possono contemplare senza vergogna. Essi si sono riconosciuti colpevoli coi loro discorsi, e soprattutto col rossore suscitato sui loro volti dall’enormità dei loro crimini. È cosí che i bambini che vogliono nascondere le loro colpe, traditi dal loro colorito, immaginano che quando li si guarda, si legga sul loro volto malsicuro, la cattiva azione che hanno compiuto”. Ma, per Dio, quale costernazione! quale improvviso cambiamento! In meno di un’ora il prezzo delle derrate diminuí ovunque. Ciascuno, dal primo ministro sino ai contadini, si strappò la maschera d’ipocrisia che lo ricopriva. Alcuni, che erano ben conosciuti già da prima, apparivano degli stranieri, quand’ebbero ripreso le loro maniera naturali. Da questo momento il tribunale fu spopolato. I debitori saldavano di propria iniziativa i loro debiti, senza eccettuare neppure quelli che i loro creditori avevano dimenticato. Si condonava generosamente a coloro che non erano in grado di soddisfarli. Se sorgeva qualche difficoltà, quelli che avevano torto rimanevano cautamente in silenzio. Non si videro piú processi in cui entrassero la malvagità e la vessazione. Nessuno poteva piú accumulare ricchezze. La virtú e l’onestà regnavano nell’alveare. Che cosa potevano fare allora gli avvocati? Anche coloro che prima della rivoluzione non avevano avuto la fortuna di guadagnare molto, disperati, abbandonavano la loro scrivania e si ritiravano. La giustizia, che sino ad allora si era occupata di far impiccare alcune persone, concedeva la libertà a quelle che teneva prigioniere. Ma, dopo che le prigioni furono vuotate, diventando inutile la dea che ad esse presiedeva, costei si vide costretta a compiere una ritirata, con tutta la sua corte e il suo seguito rumoreggiante. Tra esso si videro i fabbri, addetti alle serrature, ai catenacci, alle inferriate, alle catene e alle porte munite di sbarre di ferro. Poi si videro i carcerieri, i secondini e i loro aiutanti. Venne poi la dea preceduta dal suo fedele ministro scudiero, il carnefice, grande esecutore delle sue sentenze severe. Essa non era armata della sua spada immaginaria, bensí in sua vece portava l’ascia e la corda. La signora giustizia, con gli occhi bendati, seduta su di una nuvola, fu cosí cacciata nell’aria accompagnata dalla sua corte. Attorno al suo seggio e dietro di esso vi erano i sergenti, gli uscieri e i domestici di tale specie, che si nutrivano delle lagrime degli sfortunati. L’alveare aveva ancora dei medici, cosí come prima della rivoluzione. Ma la medicina, quest’arte salutare, non era piú affidata se non a uomini abili. Essi erano cosí numerosi e cosí diffusi nell’alveare, che nessuno di essi aveva bisogno di una vettura. Le loro vane dispute erano cessate. Il compito di guarire prontamente i pazienti era quello che unicamente le occupava. Pieni di disprezzo per le medicine importate da paesi stranieri, essi si limitavano alle semplici medicine prodotte nel loro paese. Convinti che gli dèi non mandavano alcuna malattia alle nazioni senza donar loro, nello stesso tempo, i veri rimedi, si dedicavano a scoprire le proprietà delle piante che crescevano presso di loro. I ricchi ecclesiastici, destati dalla loro vergognosa pigrizia, non facevano piú servire le loro chiese da api prese alla giornata; officiavano essi stessi. La probità da cui erano animati li spingeva a offrire preghiere e sacrifici. Tutti coloro che non si sentivano capaci di adempiere questi doveri, o che ritenevano che si potesse fare a meno dei loro servizi, si dimettevano senza indugio dalle loro cariche. Non vi erano occupazioni sufficienti per tante persone, se pur ne restava ancora qualcuna: giacché il loro numero diminuiva intensamente. Erano tutti modestamente sottomessi al pontefice, il quale si occupava esclusivamente degli affari religiosi, abbandonando agli altri gli affari dello stato. Il reverendo capo, divenuto caritatevole, non aveva piú la durezza di cuore di cacciare dalla sua porta i poveri affamati. Mai si sentiva dire ch’egli prelevasse qualcosa dal salario del povero. Era invece presso di lui che l’affamato trovava cibo, il mercenario il suo pane, l’operaio bisognoso la sua tavola e il suo letto. Il cambiamento non fu meno considerevole fra i primi ministri del re e fra tutti gli ufficiali subalterni. Divenuti economi e temperanti, i loro stipendi bastavano loro per vivere. Se un’ape povera era venuta dieci volte per richiedere il giusto pagamento di una piccola somma, e qualche funzionario ben pagato l’aveva obbligata o a regalargli uno scudo o a non ricevere mai il suo pagamento, prima si era denominata una tale alternativa la “malversazione” del funzionario; ma ora la si chiamava, col giusto nome, una ribalderia manifesta. Una sola persona era sufficiente per adempiere le funzioni per le quali si richiedevano tre persone prima del felice cambiamento. Non v’era piú bisogno di affiancare un collega per sorvegliare le azioni di coloro a cui si affidava il mantenimento degli affari. I magistrati non si lasciavano piú corrompere e non cercavano piú di facilitare i ladrocini degli altri. Una sola persona compiva allora mille volte piú lavoro di quanto non ne facessero prima parecchie persone. Non era piú cosa onorevole il far figura alle spese dei propri creditori. Le livree restavano appese nelle botteghe dei rigattieri. Quelli che brillavano per la magnificenza delle loro carrozze, le vendevano a poco prezzo. I nobili si liberavano di tutti i loro superbi cavalli tanto sontuosi e persino delle loro campagne, per pagare i loro debiti. Si evitavano le spese inutili con la stessa cura con cui si evitava la frode. Non si mantenevano piú degli eserciti all’estero. Non curandosi piú della stima degli stranieri e della gloria frivola che si acquista con le armi, non si combatteva se non per difendere la propria patria contro coloro che attendevano ai suoi diritti e alla sua libertà. Gettate ora lo sguardo sul glorioso alveare. Contemplate l’accordo mirabile che regna tra il commercio e la buona fede. Le oscurità che offuscavano questo spettacolo sono scomparse: tutto si vede allo scoperto. Quanto le cose hanno mutato il loro volto! Coloro che facevano delle spese eccessive e tutti coloro che vivevano su questo lusso; sono stati costretti a ritirarsi. Invano tenteranno nuove occupazioni: esse non potranno fornir loro il necessario. Il prezzo dei poderi e degli edifici crollò. I palazzi incantevoli, i cui muri, simili alle mura di Tebe, erano stati elevati con armonia musicale, divennero deserti. I potenti, che prima avrebbero preferito perdere la loro vita piuttosto che veder cancellare i loro titoli fastosi scolpiti sui loro portici superbi, schernivano ora queste vane iscrizioni. L’architettura, quest’arte meravigliosa, fu del tutto abbandonata. Gli artigiani non trovavano piú nessuno che li volesse impiegare. I pittori non diventavano piú celebri con le loro pitture. La scultura, l’incisione, il cesello e la statuaria non furono piú rinomate nell’alveare. Le poche api che vi restarono, vivevano miseramente. Non ci si preoccupava piú di come spendere il proprio denaro, ma di come guadagnarne per vivere. Quando dovevano pagare il loro conto alla taverna, decidevano di non rimetterci piú piede. Non si vedevano piú le donne da bettola guadagnare tanto da poter indossare abiti drappeggiati d’oro. Torcicollo non donava piú delle grosse somme per avere del borgogna e degli uccelletti. I cortigiani, che si compiacevano di regalare a Natale alla loro amante degli smeraldi, spendendo in due ore tanto quanto una compagnia di cavalleria avrebbe speso in due giorni, fecero bagaglio e si ritirarono da un paese cosí miserevole. La superba Cloe, le cui grandi pretese avevano un tempo costretto il suo marito troppo condiscendente a saccheggiare lo stato, ora vende il suo abbigliamento, composto dei piú ricchi bottini delle Indie. Ora sopprime le sue spese e porta tutto l’anno lo stesso abito. L’età spensierata e mutevole è passata. Le mode non si susseguono piú con quella bizzarra incoscienza. Dal canto loro, tutti gli operai che lavoravano le ricche stoffe di seta e d’argento e tutti gli artigiani che dipendevano da loro, si ritirarono. Una pace profonda domina in questo regno; e ha come sua conseguenza l’abbondanza. Tutte le fabbriche che restano producono soltanto le stoffe piú semplici; tuttavia esse sono tutte molto care. La natura prodiga, non essendo piú costretta dall’infaticabile giardiniere, produce bensí i suoi frutti nelle sue stagioni; però non produce piú né rarità, né frutti precoci. A misura che diminuivano la vanità e il lusso, si videro gli antichi abitanti abbandonare la loro dimora. Non erano piú né i mercanti né le compagnie che facevano decadere le manifatture, erano la semplicità e la moderazione di tutte le api. Tutti i mestieri e tutte le arti erano abbandonati. La facile contentatura, questa peste dell’industria, fa loro ammirare la loro grossolana abbondanza. Essi non ricercarono piú la novità, non hanno piú alcuna ambizione. E cosí, essendo l’alveare pressoché deserto, le api non si potevano difendere contro gli attacchi dei loro nemici, cento volte piú numerosi. Esse difendevano tuttavia con tutto il valore possibile, finché qualcuna di loro avesse trovato un rifugio ben fortificato. Non v’era alcun traditore presso di loro. Tutte combattevano validamente per la causa comune. Il loro coraggio e la loro integrità furono infine coronate dalla vittoria. Ma questo trionfo costò loro tuttavia molto. Parecchie migliaia di queste valorose api perirono. Il resto dello sciame, che si era indurito nella fatica e nel lavoro, credette che l’agio e il riposo, che mettono a sí dura prova la temperanza, fossero un vizio. Volendo dunque garantirsi una volta per sempre da ogni ricaduta, tutte queste api si rifugiarono nel cupo cavo di un albero, dove a loro non resta altro, della loro antica felicità, che la contentatura dell’onestà.
MORALE
Abbandonate dunque le vostre lamentele, o mortali insensati! Invano cercate di accoppiare la grandezza di una nazione con la probità. Non vi sono che dei folli, che possono illudersi di gioire dei piaceri e delle comodità della terra, di esser famosi in guerra, di vivere bene a loro agio, e nello stesso tempo di essere virtuosi. Abbandonate queste vane chimere! Occorre che esistano la frode, il lusso e la vanità, se noi vogliamo fruirne i frutti. La fame è senza dubbio un terribile inconveniente. Ma come si potrebbe senza di essa fare la digestione, da cui dipendono la nostra nutrizione e la nostra crescita? Non dobbiamo forse il vino, questo liquore eccellente, a una pianta il cui legno è magro, brutto e tortuoso? Finché i suoi pampini sono lasciati abbandonati sulla pianta, si soffocano l’uno con l’altro, e diventano dei tralci inutili. Ma se invece i suoi rami sono tagliati, tosto essi, divenuti fecondi, fanno parte dei frutti piú eccellenti. È cosí che si scopre vantaggioso il vizio, quando la giustizia lo epura, eliminandone l’eccesso e la feccia. Anzi, il vizio è tanto necessario in uno stato fiorente quanto la fame è necessaria per obbligarci a mangiare. È impossibile che la virtú da sola renda mai una nazione celebre e gloriosa. Per far rivivere la felice età dell’oro, bisogna assolutamente, oltre all’onestà riprendere la ghianda che serviva di nutrimento ai nostri progenitori.”
VOLTAIRE

TEORIE E VITA DEL FILOSOFO
Francois-Marie Arouet , detto Voltaire , è sicuramente l’ autore che , nella coscienza culturale settecentesca , così come in quella posteriore , meglio rappresenta i caratteri , gli ideali e i limiti dell’ illuminismo francese . In lui , scrittore estremamente fecondo che sperimenta tutti i generi letterari , anche i più spericolati , convivono il filosofo , lo storico , il politico , il poeta e il romanziere . Tutte queste attività sono accomunate da uno spirito critico che oscilla tra la garbata ironia e il sarcasmo più corrosivo , soprattutto rivolto alla Chiesa cattolica ( schiacciate l’ infame era uno dei suoi motti ) e ai pregiudizi in generale , che impediscono all’ uomo di pensare con la sua testa , servendosi della propria ragione , la candela che ci illumina la strada ( come l’ aveva definita Locke ) . Quella di Voltaire è una vita che ben risponde al nuovo stile dell’ illuminismo . Nato a Parigi nel 1694 , egli fu esponente di quell’ agiata borghesia francese che si avviava ad assumere un ruolo di primo piano nella vita economica e culturale del paese . Da giovane fu assiduo frequentatore dei salotti parigini , in cui circolava una cultura di schietta ispirazione libertina , che molto risentiva di quei pensatori brulicanti nella Francia del 1600 . Un’ offesa perpetrata al cavaliere di Rohan gli causò una breve incarcerazione nella Bastiglia e un lungo esilio , durante il quale egli dimorò in Inghilterra , rimanendo fortemente affascinato dalla cultura e dallo stile inglese . Durante la sua lunga vita non gli mancarono onori e incarichi prestigiosi . Attraverso gli uffici di madame de Pompadour , favorita di Luigi XV , fu nominato storiografo e poeta di corte . Contemporaneamente entrò in stretti rapporti epistolari con il futuro re di Prussia , Federico II il Grande , e , quando i suoi rapporti con la corte francese si guastarono del tutto , si trasferì a Berlino presso il suo nuovo protettore , ormai asceso al trono . L’ amicizia tra Voltaire , il philosophe per eccellenza , e Federico II, il re filosofo imbevuto di razionalismo , è emblematica dei rapporti che la prima generazione di illuministi cercò di intrattenere con il potere politico : l’ idea generale era quella di riformare il tutto per avere una società più giusta , nella quale dominasse la ragione e si cercasse il bene per l’ uomo ; si cercò quindi di riformare partendo dall’ alto , ossia cercando alleanze con i sovrani . Quando però ci si accorgerà dell’ inattuabilità di questo progetto , ecco che allora si deciderà di riformare dal ” basso ” e scoppierà la Rivoluzione Francese . La critica della tradizione non veniva ancora intesa come attacco al potere costituito ma , senza mettere in dubbio i fondamenti giuridico-politici dell’ assolutismo , i filosofi speravano di avere udienza presso i potenti, coinvolgerli nei programmi razionalistici e promuovere attraverso di essi , dall’ alto la riforma della società : tutto ciò diede luogo alle esperienze dell’ assolutismo illuminato . Ma le speranze riposte da Voltaire in Federico II , come più tardi quelle riposte da Diderot in Caterina di Russia , rimasero deluse , e lo sposalizio tra filosofia e potere si tradusse presto in divorzio , preludendo alla nuova funzione che gli intellettuali illuministi avrebbero dovuto avere nei decenni successivi . Caduto in disgrazia anche presso la corte berlinese , Voltaire si ritirò dapprima in Svizzera e poi , per un ventennio , nel castello di Ferney , dove continuò l’ infaticabile attività di scrittore . La sua fama era ormai grandissima , e le nuove generazioni di illuministi vedevano nell’ anziano “patriarca di Ferney” un’ autorità che si poteva a volte discutere , ma non disconoscere . Il suo ritorno a Parigi nel 1778 , poco prima di morire , ultraottuagenario , fu un vero trionfo : l’ illuminismo cominciava a celebrare se stesso e ad avviarsi , perciò , sulla strada del tramonto . Dopo il soggiorno in Inghilterra Voltaire pubblica le Lettere filosofiche (1734) , nelle quali esprime la sua ammirazione per la cultura , i costumi e le istituzioni di quella nazione , che vedeva in quegli anni trionfare il liberalismo propugnato da Locke . L’ Inghilterra diventa così indirettamente un modello da proporre ai francesi per uscire dalla loro arretratezza culturale e civile . Sul piano religioso Voltaire ammira la convivenza , realizzatasi sul suolo inglese , di fedi diverse e lo spirito di tolleranza che impronta i rapporti tra di esse . A livello politico il regime parlamentare presenta molti vantaggi rispetto alle tendenze oscurantistiche della monarchia francese . Ma è soprattutto sul piano scientifico e filosofico che gli inglesi hanno molto da insegnare . Voltaire infatti individua nel metodo sperimentale di Newton e nell’ empirismo gnoseologico di Locke i due fulcri concettuali che hanno trasformato la cultura europea . Soprattutto attraverso Voltaire , quindi Newton e Locke appaiono agli intellettuali francesi (e poi europei) i capostipiti ideali della nuova cultura illuministica , i maestri di un nuovo modo di pensare che deve essere sviluppato in tutti gli ambienti del sapere e della cultura . In realtà il pensiero filosofico di Voltaire non presenta particolare originalità nel suo complesso . Esso si trova esposto , ad esempio , in opere quali il Trattato di metafisica (1734) e gli Elementi della filosofia di Newton (1738) . La sua concezione del mondo naturale è strettamente legata al modello del meccanicismo newtoniano , a fondamento sperimentale , in esplicita contrapposizione con quello cartesiano , costruito con un’ operazione astrattamente intellettuale . Di derivazione lockiana è invece la gnoseologia di Voltaire , che vede nell’ esperienza il principio di ogni conoscenza ed esclude la possibilità di dare una risposta razionale ai problemi metafisici che vanno al di là della verificabilità empirica : nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu .Ancora di ascendente inglese è il deismo di Voltaire , avversario di ogni religione rivelata ( schiacciate l’ infame era il suo pungente motto contro la Chiesa cattolica ) quanto di ogni forma di ateismo : l’ esistenza di Dio , causa e ordinatore del mondo , è razionalmente dimostrabile , mentre và al di là di ogni conoscenza umana la definizione dell’ essenza e degli attributi divini : secondo Voltaire , che in questo caso si avvicina molto al razionalismo aristotelico , l’ esistenza di Dio può essere dimostrata con la ragione ; Dio é il motore immobile , il garante dell’ ordine nell’ universo : Se Dio non esistesse, bisognerebbe inventarlo, ma tutta la natura ci grida che esiste. La provvidenza di Dio si limita quindi a garantire l’ ordine e la necessità delle leggi naturali e non investe le vicende umane ( come aveva detto pure Epicuro ) . Partito da un moderato ottimismo , in cui ( sull’ esempio del poeta-filosofo Alexander Pope ) si presume che la realtà , non soltanto quella naturale , presenti nel complesso un carattere ordinato e positivo . Voltaire approda poi a un sostanziale , anche se moderato , pessimismo . Nel Poema sul disastro di Lisbona (1756) , il riferimento al terremoto che colpì quella città diventa motivo di sarcastica irrisione di troppi facili ottimismi: si tratta di una violenta requisitoria contro la Provvidenza che permette l’esistenza di mali gratuiti e orribili e contro le concezioni consolatorie dei filosofi sostenitori del provvidenzialismo. Voltaire riscontra amaramente che il “tutto é bene” mi sembra ridicolo quando il male é sulla terra e sul mare. Dieci secoli di atrocità e stupidaggini, esplorate nell’ Essais sur les moeurs (Saggio sui costumi) danno a Voltaire una ragione in più per non credere tanto facilmente nella possibilità della felicità umana: bisogna ammetterlo, il male é sulla terra . Questo é il contesto in cui nasce Candido ; il libro apparve anonimo ma , avendo alcuni amici riconosciuto il suo stile, lo scrittore protestò la propria estraneità all’opera definendola una coinnerie (coglioneria) . Il romanzo filosofico Candido o l’ ottimismo (1759) é esplicitamente diretto contro la concezione leibniziana del “migliore dei mondi possibile” : si narra di un giovane , Candido appunto , di nome e di fatto , che passa attraverso inenarrabili disgrazie . Viene cacciato dal suo castello , é arruolato a forza in un esercito che non lo riguarda , fa esperienza di un naufragio e di un terremoto , cade nelle mani dell’ Inquisizione e patisce un autodafè , perde infine tutte le ricchezze conquistate nel paese d’ Eldorado . Nè meno sventurati sono i personaggi che circondano Candido : dalla sua amata Cunegonda sino alla vecchia serva , che assistono al massacro dei loro familiari , vengono esse stesse violentate , sventrate e mutilate , provano la miseria , il travaglio e la servitù . Alle tremende sventure subite da Candido fa da contrappeso l’ ottimismo ad oltranza del filosofo Pangloss , il cui nome , di derivazione greca (pan tutto +glwssa lingua ) significa pressapoco ” colui che ha sempre da dire su tutto ” ; Pangloss é irrimediabilmente convinto della tesi leibniziana secondo la quale viviamo nel migliore dei mondi possibili . L’ inconcussa fede filosofica di Pangloss non viene , almeno in apparenza , incrinata neppure dalle grandi sciagure che piovono anche sul suo capo , come su quello di tutti gli altri . Nella conclusione del romanzo , Pangloss insiste nel dire che tutto é andato per il meglio . Ma Candido-Voltaire , che ha ormai imparato la lezione di vita , preferisce rinunciare a ogni interpretazione metafisica della realtà , accontentandosi di operare utilmente nel piccolo spazio che gli é riservato . Il pessimismo di Voltaire è del resto accompagnato da una radicale critica all’ antropocentrismo tradizionale . Riprendendo le tesi di Giordano Bruno , egli osserva come la rivoluzione copernicana abbia privato la Terra , e quindi l’ uomo , della sua centralità nell’ universo . L’ uomo è soltanto un essere naturale al pari degli altri innumeri esseri che popolano l’ universo e , contrariamente a quanto aveva sostenuto l’ esistenzialista Pascal , non ha , rispetto al mondo della natura , nessun privilegio ontologico . Ma il tratto più caratteristico dell’ opera di Voltaire , e insieme quello che meglio incarna , in generale , lo spirito dell’ illuminismo , è la polemica religiosa , politica e sociale che contraddistingue soprattutto l’ ultimo periodo della sua vita e trova l’ espressione più sistematica del Dizionario filosofico portatile (1746) . Le questioni metafisiche passano ora in second’ ordine e il compito della ragione diventa piuttosto quello di elaborare una critica e una trasformazione della società che investa tutte le sue istituzioni . La concezione deistica di Voltaire viene ora apertamente finalizzata alla critica del cristianesimo , inteso come fonte di intolleranza e di guerra e , quindi ostacolo allo sviluppo storico dell’ umanità : una religione del tipo di quella cristiana impedisce all’ uomo di servirsi della propria ragione imponendogli di compiere assurdi atti di fede . Analogamente , in ambito politico , Voltaire difende il diritto di ogni cittadino alla libertà civile e politica (in primo luogo alla libera espressione delle proprie idee) , in contrapposizione a un assolutismo dal quale egli non si attendeva ormai più alcuna collaborazione . I diversi aspetti della polemica illuministica di Voltaire trovano quindi il loro centro unificatore nella difesa della tolleranza come valore imprescindibile per garantire pace , giustizia e progresso civile , come egli sostiene accoratamente nel Trattato sulla tolleranza del 1763; ‘ disapprovo ciò che dici, ma difenderò alla morte il tuo diritto di dirlo ‘ egli afferma . Un contributo estremamente rilevante al pensiero illuministico è dato da Voltaire anche sul terreno della riflessione storica . Ciò non soltanto perchè egli è autore di grandi opere come Il secolo di Luigi XIV (1751) e il Saggio sui costumi e sullo spirito delle nazioni (1756) , che costituiscono ottimi esempi di storiografia illuministica ; ma in quanto , in queste stesse opere , Voltaire è anche propugnatore di una filosofia della storia ( l’ espressione stessa è coniata da lui ) cioè di un’ indagine filosofica sul significato generale del processo storico nella quale il fondamento unitario dello sviluppo dell’ umanità è ritrovato nel concetto di progresso . La storia consiste in un graduale processo di incivilimento , di civilisation , dell’ umanità , a partire dalla condizione selvaggia fino alle quattro grandi espressioni della civiltà umana : l’ Atene di Pericle , la Roma di Cesare e Augusto , la Firenze dei Medici e la Francia di Luigi XIV . Il progresso non è quindi qualcosa di necessario e ininterrotto , ma conosce pause e involuzioni , come dimostra il periodo del Medioevo . Con ciò l’ illuminismo continuava , su un piano filosofico oltrechè storico-filologico , il programma bayliano di rivalutazione della scienza storica , sminuita dalla condanna cartesiana , anche se ancora permangono pregiudizi storiografici (come , appunto , la svalutazione dell’ età medioevale) che saranno eliminati solo dalla storiografia romantica .
RIASSUNTO DI CANDIDO
Il racconto (che potete leggere in versione integrale cliccando qui ) si compone di 30 brevi capitoli e presenta una rapida struttura lineare, scandita dalle tappe del viaggio del protagonista. La narrazione si può dividere in 3 parti : cacciata dal castello e fuga di Candido verso il Nuovo Mondo , soggiorno nell’Eldorado, ricerca di Cunegonda e ritorno nel Vecchio Mondo fino al giardino di Costantinopoli.
CAPITOLO I : Nel castello di Thunder-ten-tronckh vivono felici e beati Candido , madamigella Cunegonda, figlia del barone, e Pangloss, insegnante di “metafisico-teologo-cosmoscemologia” e convinto dall’inizio alla fine che le cose non possono essere in altro modo : perchè , siccome tutto é creato per un fine , tutto é necessariamente per il migliore dei fini . Cunegonda, scoperto Pangloss tra i cespugli con la cameriera , ne imita subito l’esperienza abbracciando Candido dietro un paravento. Sorpresi dal signor Barone, Candido é cacciato a pedate nel sedere dal migliore dei castelli possibili.
CAPITOLO II – III : Candido si scontra subito con l’atrocità del mondo . Morto di fame e di stanchezza , é arruolato a forza tra i Bulgari e costretto a suon di bastonate a fare gli esercizi militari della celebre armata di Federico II . La battaglia tra Avari (Francesi) e Bulgari (Prussiani) é un’immane carneficina , benedetta dal canto del Te deum . Candido non trova niente di meglio che fuggire scavalcando montagne di cadaveri , tra villaggi bruciati e membra palpitanti . Si rifugia in Olanda dove sperimenta il fanatismo di un ugonotto e la pietà di un anabattista che lo accoglie e lo aiuta. Incontra poi un pezzente sfigurato dalla sifilide.
CAPITOLO IV : Il pezzente é Pangloss che , sopravvissuto alla distruzione del castello operata dai soldati bulgari , trova tuttavia il coraggio di giustificare il suo male come cosa indispensabile nel migliore dei mondi . I due si imbarcano insieme all’anabattista benefattore alla volta di Lisbona.
CAPITOLO V – VI : Descrizione di alcune catastrofi naturali : la tempesta, il naufragio e il terremoto. La tempesta uccide il buon anabattista, mentre i malvagi si salvano. Il terribile terremoto di Lisbona miete 30000 vittime innocenti . Pangloss e Candido finiscono nelle mani dell’Inquisizione che cerca eretici per esorcizzare la sciagura con un autodafè. Pangloss é impiccato e Candido fustigato. Lo stesso giorno , la terra trema di nuovo. A Candido si avvicina misteriosamente una vecchia.
CAPITOLO VII – X : La vecchia conduce Candido da Cunegonda . Questa, violentata e sventrata dai Bulgari, che avevano messo a ferro e a fuoco il castello, non era morta, come invece aveva raccontato Pangloss. Venduta a un banchiere ebreo , che la divide con il grande Inquisitore, aveva assistito all’autodafè e , riconosciuto Candido, se lo era fatto condurre a casa. Sorpreso dall’ebreo don Issacar e poi dall’Inquisitore , Candido uccide entrambi. Cunegonda , la vecchia e Candido fuggono di gran carriera su tre cavalli andalusi. A Cadice si imbarcano su una nave che trasporta truppe contro i gesuiti del Paraguay . Sulla nave si fa un gran discutere sul male e sulla felicità. La vecchia principia il racconto della sua vita.
CAPITOLO XI – XII : Tutti e due i capitoli sono occupati dalle disgrazie della vecchia. Questa digressione consente a Voltaire di denunciare le violenze e le oscenità perpetrate quotidianamente ai danni delle donne. Alla fine del tragico racconto della vecchia, Candido é sconcertato e vorrebbe fosse presente il savio Pangloss , poichè si sente abbastanza forte per muovergli qualche rispettosa obiezione .
CAPITOLO XIII – XIV – XV : Arrivati a Buenos Aires , Cunegonda é accolta dal governatore , di cui diventa la favorita , ma Candido, perseguitato dalla giustizia, é costretto a fuggire. Guidato dal servo Cacambò , passa nel regno dei gesuiti: Quel governo é cosa mirabile … Los padres son tutto, i popoli niente . Candido ritrova qui il fratello di Cunegonda . Ferito nell’orgoglio di casta appena il giovane manifesta l’intenzione di sposarne la sorella, egli colpisce Candido. Questi lo ammazza e ne indossa gli abiti , fuggendo prima che sia scoperto il delitto.
CAPITOLO XVI : Candido in una bella prateria vede due scimmie inseguire due fanciulle nude . Preso da pietà , uccide gli animali , convinto di salvare la vita delle fanciulle, ma in realtà ne provoca la disperazione: ne ha ucciso gli amanti. Candido e Cacambò si inoltrano nella foresta e qui, durante il sonno, sono catturati dagli Orecchioni in guerra con i gesuiti , che hanno preso le loro terre. Stanno entrambi per finire in pentola, quando Cacambò convince la tribù che Candido non solo non é gesuita, ma ne ha appena ucciso uno. Liberati, ricevono dagli indigeni ogni sorta di onore.
CAPITOLO XVII – XVIII : Affranti e affamati, dopo aver percorso montagne e precipizi, si abbandonano alla corrente di un fiume che li porta tra rocce scoscese nel paese dell’Eldorado. E’ il regno della felicità, dove non esistono denaro, nè violenza , nè tribunali, nè preti. I due passano di meraviglia in meraviglia, ma dopo un mese , pur felici, decidono di non esserlo più e di chieder licenza a sua maestà . Carichi di oro, essi ripartono alla ricerca di Cunegonda.
CAPITOLO XIX : Candido e Cacambò incontrano nella colonia olandese di Surinam un negro senza una mano e senza una gamba , mutilato dallo sfruttamento dei proprietari bianchi di piantagione. A questo prezzo mangiate zucchero in Europa , esclama lo schiavo denunciando i costi sociali del lusso europeo. Un mercante olandese deruba poi Candido, il quale si convince che se tutto va bene, tutto va bene ad Eldorado, e non nel resto della terra . Candido, incaricato Cacambò di riscattare Cunegonda, dà a questi appuntamento a Venezia. Disperato per la malvagità umana, cerca come compagno di viaggio il più infelice uomo della regione. Entra così in scena Martin, il filosofo pessimista , tutto l’opposto di Pangloss.
CAPITOLO XX – XXI : Martin, durante il viaggio verso l’Europa, espone a Candido il suo pessimismo manicheo , secondo cui esistono due princìpi , il bene e il male, Dio e il Diavolo che si contendono l’universo; la terra è caduta sotto il dominio del male. Subito si imbattono in una battaglia navale, dove trovano la morte centinaia di innocenti.
CAPITOLO XXII – XXIII : Candido desidera conoscere Parigi, ma resta deluso. Cade vittima dell’imbroglio di un abate che lo deruba. Si imbatte nel fanatismo clericale, nella passione sfrenata del gioco, nella vacuità dei letterati. Raggiunge l’Inghilterra, ma non vi sbarca nemmeno , disgustato dall’esecuzione dell’ammiraglio Byng, fucilato dagli Inglesi perchè ha commesso l’errore di essere stato sconfitto dai Francesi.
CAPITOLO XXIV – XXV : Candido a Venezia non ritrova Cunegonda, ma Paquette, la vecchia amante di Pangloss, divenuta prostituta. Trova anche la sazietà e il disgusto. Il senatore Procurante, ricco, intelligente, ha tutto, ma non é felice. Tutto lo annoia.
CAPITOLO XXVI – XXX : Candido e Martin incontrano sei monarchi spodestati . Anche i re , dunque , sono in balìa del destino . Cacambò arriva a Venezia, ma é ridotto in schiavitù. I tre si imbarcano per Costantinopoli, dove anche Cunegonda é divenuta schiava di un avventuriero. Sulla nave Candido riconosce in due forzati incatenati ai remi il filosofo Pangloss. che era stato male impiccato, e il redivivo baronetto gesuita, fratello di Cunegonda. Candido li riscatta entrambi e tutti quanti giungono in Turchia dove, sulle rive della Propontide , trovano Cunegonda, brutta e invecchiata. Liberata, anch’ella, insieme alla vecchia, si stabilisce con il resto della compagnia in una piccola fattoria.
MONTESQUIEU

Charles-Luis de Secondat , barone di Montesquieu, era figlio di Jacques de Secondat, barone di Montesquieu (1654-1713) e di Marie- Françoise de Pesnel, baronessa di la Brède (1665-1696): nacque da una famiglia di magistrati appartenenti alla cosiddetta nobiltà di toga, nel castello di la Brède, nei pressi di Bordeaux. Montesquieu fu sempre fiero del nome che portava. [1] Dopo aver frequentato il collegio di Juilly e seguito gli studi di diritto, divenne nel 1714 consigliere del parlamento di Bordeaux. Nel 1715 sposò Jeanne de Lartigue, una giovane di religione protestante proveniente da una ricca famiglia di recente nobiltà che gli portò una grossa dote. Alla morte dello zio nel 1716 ereditò una vera fortuna, con la carica di Presidente del parlamento di Bordeaux e la baronia di Montesquieu. Abbandonate le cariche appena possibile, si interessò al mondo ed al divertimento. In quell’epoca l’Inghilterra s’era appena costituita in monarchia costituzionale in seguito alla Gloriosa rivoluzione (1688 – 1689) e si era unita alla Scozia nel 1707 per formare la Gran Bretagna. Nel 1715 il Re Sole era morto dopo un lunghissimo periodo di regno e gli era succeduto un re più debole. Queste trasformazioni nazionali lo influenzarono molto e ad esse si riferirà sovente nelle sue opere. La sua passione per le scienze lo condusse ad esperimenti scientifici (anatomia, botanica, fisica, etc.). Egli scrisse su questi argomenti tre comunicazioni scientifiche: Les causes de l’écho, Les glandes rénales et La cause de la pesanteur des corps[2]. Quindi orientò la sua curiosità verso la politica e l’analisi della società attraverso la letteratura e la filosofia. Nel 1721 pubblicò anonimamente ad Amsterdam le “Lettere persiane” che conobbero un notevole successo. Nel 1726 Montesquieu vendette la sua carica per pagare i suoi debiti ma conservò prudentemente il diritto ereditario su di essa. Dopo la sua elezione nella Académie française (1728) si dedicò ad una serie di lunghi viaggi attraverso l’Europa: Austria, Ungheria, Italia (1728), Germania (1729), Olanda ed Inghilterra (1730) nella quale soggiornò più di un anno. In questi viaggi si occupò attentamente della geografia, dell’economia della politica e dei costumi dei paesi che visitava. Nel 1735 era stato iniziato alla Massoneria in Inghilterra [3]. Di ritorno al castello de la Brède, nel 1734, pubblicò una riflessione storica intitolata Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence (Considerazioni sulle cause della grandezza dei romani e della loro decadenza), coronamento dei suoi viaggi, e raccolse numerosi documenti per preparare l’opera della sua vita: De l’esprit des lois (Lo spirito delle leggi). Pubblicato in forma anonima nel 1748, grazie anche all’aiuto di Mme de Tencin, questo capolavoro ebbe un successo enorme. Esso stabilisce i principi fondamentali delle scienze economiche e sociali e concentra tutta la sostanza del pensiero liberale. Il libro ebbe un successo particolare in Gran Bretagna. A seguito degli attacchi che il suo scritto subì, Montesquieu pubblicò nel 1750 la Défense de l’Esprit des lois (Difesa dello spirito delle leggi). Dopo la pubblicazione del Lo spirito delle leggi Montesquieu fu circondato da un vero e proprio culto. Egli continuò i suoi viaggi in Ungheria, in Austria ed in Italia ove soggiornò un anno e nel Regno Unito ove si fermò per un anno e mezzo. Afflitto dalla quasi totale perdita della vista, riuscì a partecipare comunque all’Enciclopedia. Morì a causa di una forte infiammazione. Il suo capolavoro filosofico è Lo spirito delle leggi , che vide la luce nel 1748 . Anche dopo la pubblicazione , continuò a rielaborare l’ opera fino al 1755 , anno in cui morì . Uno scritto giovanile di Montesquieu , Le lettere persiane del 1721 , presenta i caratteri consueti a molte opere appartenenti al primo illuminismo , in cui la critica alla società è ancora celata dalla finzione letteraria : in questo romanzo epistolare si immagina un gruppo di persiani in visita a Parigi che descrivono tramite lettere ai loro corrispondenti iraniani vita e costumi di una società cattolica e assolutistica , con sguardo distaccato , nella loro nuda oggettività : l’ ovvio e il quotidiano diventano l’ assurdo e il grottesco e il lettore viene abituato all’ ottica del relativismo culturale : la Francia e l’ Europa non sono più il centro , ma solo un angolo del mondo ; ciò che a noi europei pare banale e ovvio perchè ci siamo abituati , agli Iraniani sembrerà ridicolo e bislacco . Una simile operazione , naturalmente , la si potrà compiere con un cinese o con un pellerossa . Ma nelle successive Considerazioni sulle cause della grandezza dei Romani e della loro decadenza (1734) , sia pure in uno stile ancora brioso e letteralmente efficace , Montesquieu muta registro . Alla critica del costume subentra un’ analisi critica della storia romana , nella quale l’ autore non si limita alla ricostruzione filologica (in questo anzi consegue risultati talvolta dubbi) , ma tenta di ricercare i princpi politici e sociali che spiegano tanto lo sviluppo tanto la decadenza di Roma . Se nelle Considerazioni la spiegazione dei fatti socio-politici mediante princìpi generali era applicata al caso specifico della storia romana , nel maturo Spirito delle leggi essa viene generalizzata , dando luogo alla costruzione di una vera e propria scienza delle società : Infatti , Montesquieu – che è stato da taluni considerato l’ iniziatore della moderna sociologia – intende ritrovare le sue cause generali che presiedono allo sviluppo delle diverse istituzioni socio politiche , pur non dimenticando il carattere specifico delle singole nazioni e dei singoli momenti storici . Per realizzare questo disegno egli individua tre forme di governo , distinte sia in base al al numero di coloro che detengono il potere sia in base al modo in cui esso viene esercitato . A ciascuna di queste forme di governo corrisponde un principio , inteso nel duplice senso di fattore originario e di elemento costitutivo , al quale esse devono mantenersi fedeli se vogliono conservarsi a lungo . Nel governo repubblicano – distinto a sua volta in democratico e aristocratico – il potere è ritenuto da più persone (rispettivamente tutti o alcuni cittadini) ed è esercitato in conformità alla legge : il suo principio è la virtù . Nel governo monarchico il potere è detenuto da uno solo , ancora in conformità alla legge : il suo principio è l’ onore. Nel governo dispotico il potere è tenuto da uno solo , ma è esercitato in modo arbitrario : il suo principio è la paura . Montesquieu , pur non nascondendo le sue simpatie per la soluzione monarchica di tipo costituzionale (sul modello inglese) , ritiene che non si possa stabilire in assoluto quale di queste tre forme di governo sia la migliore . La validità di ciascuna di esse è relativa al popolo cui si applica . L’ intento di di Montesquieu non è quindi quello di indicare un ordine preferenziale , ma piuttosto di ricercare la serie delle condizioni – sociali , geografiche , giuridiche ecc. – necessarie perchè ciascuna forma di governo , con il suo principio , possa svilupparsi e mantenersi . L’ insieme di questi rapporti (il clima , il territorio , le istituzioni ecc.) è ciò che egli chiama spirito delle legggi . Montesquieu si preoccupa anche di determinare la condizione generale per il mantenimento della libertà politica , la quale condizione può valere indifferentemente per le forme di governo repubblicana – cioè democratica o aristocratica – e monarchica (al dispotismo non si può applicare , poichè il suo principio , la paura , esclude la libertà) . Essa consiste nella divisione dei poteri – legislativo , esecutivo , e giudiziario – che Montesquieu aveva visto realizzata nella costituzione inglese . La teoria della divisione dei poteri era stata concepita già da Locke limitatamente ai primi due poteri (per Locke il terzo potere non era quello giudiziario , ma quello fededrativo , e dipende dal potere esecutivo) e perfezionata successivamente da Henry Saint-John Bolingbroke (1678-1751) , con il quale Montesquieu venne in contatto nel suo viaggio in Inghilterra . Attraverso Montesquieu essa entra definitivamente nel patrimonio politico e culturale francese ed europeo .
DENIS DIDEROT

VITA E OPERE
Denis Diderot nasce il 5 ottobre 1713 a Langres, una cittadina di provincia, da una famiglia borghese benestante. Dopo aver studiato presso il collegio gesuita della città, si trasferisce a Parigi per iscriversi all’Università, da cui esce con il titolo di “magister artium” nel 1732. Privo di un preciso indirizzo di carriera, si adatta ai più diversi lavori, dallo scrivano pubblico al precettore, frequentando, come molti altri giovani bohémien, i salotti e i caffè in cui circolano le idee illuministiche e libertine. Qui conosce un altro provinciale come lui, Jean Jacques Rousseau, con cui costruisce un intenso quanto burrascoso rapporto. Studia greco e latino, medicina e musica, guadagnandosi da vivere come traduttore. Nel 1745 traduce il “Saggio sulla virtù e sul merito” di Shaftesbury, dei quale ammira le idee di tolleranza e di libertà. Sotto questa influenza si collocano i “Pensieri filosofici” (“Pensées philosophiques”) del 1746, di intonazione deista, “La sufficienza della religione naturale” (“De la suffisance de la religion naturelle”) e “La passeggiata dello scettico” (“La promenade du sceptique”), del 1747, aspramente critici verso la superstizione e l’intolleranza. Risale al 1748 il romanzo libertino “I gioielli indiscreti” (“Les bijoux indiscrets”) e al 1749 la “Lettera sui ciechi ad uso di coloro che vedono” (“Lettre sur les aveugles à l’usage de ceux qui voient”) di intonazione sensista e materialista. Già questa prima rassegna di titoli (cui vanno aggiunti anche alcuni saggi di matematica) lascia intravedere due caratteristiche fondamentali della personalità intellettuale di Diderot, vale a dire la vastità dei suoi interessi (che spaziano dalla filosofia alla biologia, dall’estetica alla letteratura) e la flessibilità dei generi di scrittura da lui praticati, particolarmente congeniale al carattere mobile, aperto e dialogico del suo pensiero. Incarcerato a Vincennes per taluni di questi scritti, giudicati sovversivi, Diderot trascorre cinque mesi di prigionia piuttosto blanda, dal 22 luglio al 3 novembre 1749. Nel frattempo è incominciata anche la grande avventura dell’ “Encyclopédie”, che lo occuperà instancabilmente per il successivo quindicennio: di quest’opera Diderot sarà il più infaticabile artefice, scorgendo in essa una irrinunciabile battaglia politica e culturale e sostenendola pressoché da solo, dopo la defezione di d’Alembert nel 1759. Viceversa, Diderot non darà in genere circolazione pubblica ai propri scritti, molti dei quali rimarranno quindi del tutto sconosciuti al di fuori della ristretta cerchia dei philosophes , per venire pubblicati solo dopo molti decenni dalla sua morte (alcuni addirittura in questo secondo dopoguerra). Appartengono a questo periodo (la pubblicazione dell’enciclopedia si concluderà definitivamente solo nel 1773) altre importanti opere: ricordiamo i fondamentali saggi filosofici “L’interpretazione della natura” (“De l’interpretation de la nature”, 1753: si tratta di aforismi di stile baconiano di concezione ateistica) e il “Sogno di d’Alembert” (Rêve del 1709), i romanzi “La monaca” (“La religeuse”, 1700) , “Giacomo il fatalista” (“Jacques le fataliste”, 1773), il dialogo “Il nipote di Ranieau” (“Le neveu de Raineau”, 1762), le opere teatrali “Il figlio naturale” e “Il padre di famiglia” nonché il trattato “La poesia drammatica” (“La poésie drammatique”, 1757-58 ). La vita privata di Diderot è intensa, libera, irta focalizzata intorno a centri affettivi di grande importanza: la famiglia (si era sposato nel 1743 con una corniciaia, Antoinette Champion detta Nariette, avendo dal matrimonio una figlia amatissima) e, a partire dal 1756, la amica e amante Sophie Volland. Di quest’ultima relazione ci resta un epistolario di grande valore, oltre che biografico, letterario e storico. Nel 1773 Diderot si reca a Pietroburgo, dove stende per l’imperatrice Caterina II diversi progetti di riforma della società e dell’istruzione. Un durissimo colpo per la morte di Sophie il 22 febbraio 1784. Il 31 luglio dello stesso anno il filosofo muore a Parigi.
PERCORSO TRA LE OPERE
Filosofo e scrittore, nato da famiglia piccolo-borghese, Diderot (Langres 1713-Parigi 1784) venne messo a studiare dai gesuiti prima a Langres, poi al collegio d’Harcourt di Parigi. Destinato alla carriera ecclesiastica, preferì l’avvocatura cui si dedicò però, conclusi gli studi, solo per pochi anni (1732-34). Condusse vita da bohémien, che gli inimicò il padre e gli alienò la sia pur modesta pensione che questi gli passava; il matrimonio con una donna del popolo, Anne-Antoinette Champion, contribuì ad alimentare il disaccordo con la famiglia, che neppure la nascita della figlia, la futura M.me de Vandeul, poté appianare. Tra i numerosi impegni per guadagnarsi da vivere (lezioni private, traduzioni, rifacimenti di opere scientifiche), Diderot aveva intanto pubblicato una Epître in versi e la traduzione della “Storia della Grecia” di Temple Stanyan. Sono le premesse di quella che sarà la sua vocazione letteraria di poligrafo originalissimo e spesso paradossale, che troveranno conferma nella libera traduzione dell’ “Inquiry Concerning Virtue or Merit ” di Shaftesbury, le cui tesi lo rafforzano nell’idea di separare i precetti morali da ogni influsso divino per conservare loro una base puramente umana. Sarà questo un punto fermo nell’opera di Diderot, riconfermato dalla scoperta fatta da un gruppo di critici nei numerosissimi inediti del Fondo Vandeul. La maggior parte delle sue opere uscì postuma: in vita, tra i suoi scritti più noti, pubblicò soltanto “Les pensées philosophiques” (1746), che per la loro arditezza (condanna dei dogmi e dei culti) vennero date al fuoco per mano del boia, “Les bijoux indiscrets” (1747), libro erotico-satirico, la “Lettre sur les aveugles à l’usage de ceux qui voient” (1749), che gli valse tre mesi di carcere a Vincennes per le idee professate a proposito di Dio e della Natura, la “Lettre sur les sourds et les muets” (1751), anonima, come i precedenti scritti, “Les pensées sur l’interprétation de la nature” (1754). Scrisse anche due mediocri lavori teatrali: “Le fils naturel” (1757) e “Le père de famille” (1758), seguiti dagli “Entretiens sur le fils naturel” e dal “Discours sur la poésie dramatique” (1758). Incapace di dare ordine alla sua vita, anche per le grosse difficoltà economiche in cui si dibatteva, nel 1763 ottenne l’aiuto di Caterina II di Russia che gli acquistò la sua biblioteca, lasciandogliene l’uso e nel 1773, anche per ringraziarla, egli si recò, invitato da lei, a Pietroburgo e vi rimase circa un anno, postillando di osservazioni il nuovo codice e proponendo un piano di riforma scolastica (“Observations sur le Nakaz”, pubblicate in parte nel 1899 e complete nel 1921). Rientrato a Parigi, per altri dieci anni, pur scrivendo ininterrottamente, fu il più seducente conversatore dei principali salotti letterari del tempo, ammirato sia dagli amici di M.me d’Épinay, sia da quelli del barone d’Holbach. Le sue idee filosofiche si ritrovano tanto nelle opere, quanto nella vastissima corrispondenza, e persino nelle opere altrui, come nella “Histoire des deux Indes” del Raynal, di cui scrisse numerosi frammenti. Materialista convinto, fedele alle leggi della “natura”, Diderot è soprattutto un “seminatore di idee”, che daranno frutto assai tardi. Le sue relazioni sui biennali Salons parigini di pittura, tranne una, quella del 1759, furono pubblicate sul finire del secolo XVIII e nel XIX. Si tratta di corrispondenze critiche che Diderot indirizzò all’amico Grimm (ivi compresi gli “Essais sur la peinture”, scritti nel 1765-66), che rivelano in lui il padre della critica d’arte moderna. Il “Supplément au voyage de Bougainville”, scritto nel 1772, apparve come gli “Essais” nel 1796. Il “Rêve de d’Alembert”, scritto nel 1769, fu stampato nel 1830 e consente di collocare Diderot tra i precursori del trasformismo scientifico. Nel 1796 vengono contemporaneamente pubblicati due romanzi: “La Religieuse” (La monaca), scritto nel 1760, che è un atto di accusa contro la vita conventuale del secolo XVIII e che il Manzoni avrà presente per la monaca di Monza dei “Promessi Sposi”, e “Jacques le fataliste et son maître” (Giacomo il fatalista e il suo padrone), dove alla trama si sostituisce il dialogo tra servo e padrone, sulle loro storie d’amore, che stanno a dimostrare come in realtà nell’ampio concetto di natura venga a essere superata ogni antinomia. Nel 1823 apparve “Le neveu de Rameau” (Il nipote di Rameau), tradotto dal tedesco, e solo nel 1891 G. Mondal scoprirà il manoscritto originale. È questo il capolavoro letterario di Diderot, in cui tutta la sua vivacità dialettica erompe, come fuoco d’artificio, in una serie di paradossi che coinvolgono filosofia, uomini, arte, musica, morale e i nemici dell’ “Encyclopédie”. Lo stesso “Paradoxe sur le comédien” (Paradosso sul commediante), scritto nel 1773, apparve solo nel 1830 e getta le basi dell’estetica intellettualistica. Documento notevole, infine, per la conoscenza dell’uomo sono le lettere, soprattutto quelle dirette all’amata Sophie Volland, quelle a Naigeon, allo scultore Falconet, tutte riunite da poco tempo nell’ampia raccolta della “Correspondence”. Con la pubblicazione dei “Textes politiques” a cura di Yves Benot (1960), delle “Œuvres politiques” a cura di Paul Vernière (1963) e, specie, del “Commentaire alla Lettre sur l’homme et ses rapports” di Frans Hemsterhuis (da lui conosciuto all’Aia durante il suo viaggio di ritorno dalla Russia), commento scoperto e pubblicato solo nel 1964 e in cui sono confermati il suo monismo materialistico e il suo ateismo ben presenti nella “Réfutation d’Helvétius”, scritta nel 1773 e rimasta anch’essa inedita a lungo, Diderot venne a essere ampiamente rivalutato come pensatore politico. Il suo pensiero è più moderno del suo tempo. Sconfessata la concezione politica dell’Illuminismo, Diderot si stacca dalle idee di Voltaire per avvicinarsi a quelle di Rousseau sul filo della tesi ribadita nei “Mémoires pour Cathérine II”, in cui l’assolutismo illuminato è addirittura giudicato come il peggiore dei mali, tale da sprofondare in un sonno di morte chi a esso s’abbandona, poiché perde, nella totale fiducia in chi lo guida, il sentimento della libertà, così indispensabile a ogni progresso umano e sociale.
IL PENSIERO
Con Diderot (e con Voltaire) siamo alla base del pensiero illuminista. Un pensiero che ha avuto le sue evoluzioni nel tempo, ma mantenendo sostanzialmente fedele una coerenza etica di fondo. Diderot fu autore, oltrechè di romanzi e racconti, di un cospicuo numero di opere filosofiche che rimasero però spesso inedite per lungo tempo, con scarsa influenza sul pensiero illuministico del Settecento. Attraverso gli ambienti parigini in cui circolavano i testi filosofici clandestini, Diderot lesse gli inglesi (soprattutto Shaftesbury): nei “Pensieri filosofici” è infatti testimoniato l’iniziale deismo di Diderot, utilizzato (come in Voltaire) in polemica anti-cristiana. Ma già nella “Lettera sui ciechi” (1749) la concezione deistica di Diderot si evolve in senso spinoziano, portando ad un’identificazione di Dio con la natura (“Deus sive natura” era il motto di Spinoza) che esclude la presenza in quest’ultima di ogni causalità finale e, di conseguenza, rende inutile l’ipotesi di un Dio creatore, esterno alla natura stessa. Questa posizione è ulteriormente sviluppata in “Sull’interpretazione della natura” (1753): qui lo spinozismo diderotiano viene sviluppato in senso evoluzionistico; la materia, fornita autonomamente di movimento e sensibilità, è il principio dal quale derivano, per evoluzione progressiva, le diverse specie naturali. In questa tesi affiora la vicinanza di Diderot ad una concezione biologica della natura, sulla scia degli sviluppi che la biologia aveva avuto in Francia con scienziati del calibro di Buffon e de Maupertuis. Tutto ciò in contrapposizione alla più consueta interpretazione in termini fisico-meccanici, secondo il modello newtoniano che, sotto questo profilo, si inseriva nella precedente tradizione cartesiana. L’idea dell’evoluzione della specie dalla materia è, però, per Diderot soltanto un’ipotesi che funziona meglio della tradizionale concezione di un mondo dipendente da un creatore: la sua dimostrazione scientifica va al di là delle possibilità della conoscenza umana. E’ proprio questo carattere meramente ipotetico a distinguere la posizione filosofica di Diderot da quella dei materialisti contemporanei, con i quali egli entra in aperto conflitto (soprattutto nella “Confutazione di Helvétius”) accusandoli di aver fatto del materialismo una concezione dogmatica dell’universo. Negli ultimi suoi lavori, Diderot accantona anche quest’ipotesi, e i suoi interessi di “philosophe” si concentrano sulla determinazione di una “morale naturale”, giustificata dalla superiorità degli istinti naturali sui condizionamenti sociali. Le discussioni filosofiche di Diderot (come rivela il “Supplemento al viaggio di Bougainville”, 1772) vengono dunque a toccare il problema, fatto emergere da Rousseau ed assai discusso nella cultura dell’epoca, dei rapporti tra la condizione naturale o selvaggia e quella civile. Tra le varie cose, Diderot recupera il concetto di eclettismo: un concetto che, nella tradizione filosofica, ha quasi sempre avuto un significato negativo, e che viene spesso ancora oggi inteso come sinonimo di mancanza di originalità, di collazione piú o meno disorganica di materiali altrui. Eclettismo invece, per Diderot, significa fare i conti con la varietà della realtà senza volerla per forza appiattire nella omogeneità di un “sistema”; significa lavorare con metodo per trovare il nesso che esiste fra le “verità” isolate, e impegnarsi in questa ricerca in maniera sistematica, seguendo la strada tracciata dalla “libertà di pensiero”, “dall’esperienza e dalla ragione” e dalla quale è impossibile deviare.
Partito dalle note deiste dei “Pensieri filosofici” (“Pensées philosophiques”, 1744), Diderot giunse presto a posizioni materialistiche con la “Lettera sui ciechi per l’uso di quelli che vedono” (1749) e la “Lettera sui sordi e sui muti per l’uso di quelli che intendono e parlano” (1751). Fu proprio la “Lettera sui ciechi” a causargli l’imprigionamento a Vincennes. In questa lettera Diderot sviluppava una nuova concezione del mondo e dell’uomo, un metodo di analisi e una nuova teoria della conoscenza. E’ messo in discussione il concetto stesso di normalità: la diversità del cieco serve a Diderot per relativizzare il concetto di normalità e mettere in discussione molti luoghi comuni sullo sviluppo dell’intelligenza. Il cieco con cui dialoga possiede la ragione, la stessa degli altri uomini: ragione e intelligenza non si riducono a una combinazione di sensazioni: se empirismo e sensismo, di Locke e Condillac, fossero veri il mondo del cieco senza la facoltà di vedere sarebbe radicalmente diverso da quello del vedente: il che non è vero. Il cieco giudica come il vedente anche se attraverso modalità diverse. Le intelligenze possono svilupparsi in modo differenziato a seconda dei contesti culturali, educativi, sociali e fisici diversi. Diderot si serve dei ciechi per dimostrare come molte norme tradizionali e regole sono il prodotto di convenzioni sociali. Intravede l’utopia di un mondo e di una società costruiti su basi diverse. Il suo scopo è dimostrare che le nostre idee su dio e sulla morale non sono assolute ma relative alla nostra costituzione fisica, psichica e alla nostra educazione. Anche l’uso del dialogo, il dialogo di origine socratica, è indicativo della ricerca filosofica di Diderot. “La lettera sui sordi e muti” (1951) fu poi usata da Condillac per il suo “Trattato delle sensazioni”, e influenzerà i lavori dell’abate de L’Epée. Diderot prende l’esempio dei sordi e dei muti per spiegare l’origine e la formazione del linguaggio. Mostra come non esiste solo il linguaggio parlato ma anche quello mimico e gestuale, vede i linguaggi come mezzi di comunicazione, sviluppa l’idea della molteplicità delle forme comunicative. Parlando del teatro osserva come la ” lingua dei gesti è metaforica “. Analizzando la genesi della lingua francese, mostra come la lingua popolare, quella di Rabelais e di Montaigne, è più ricca e creativa di quella scritta codificata dai dotti. Scrisse alla voce ‘Filosofo’ dell’Encyclopédie: ” la grazia determina il cristiano ad agire, la ragione determina il filosofo “, mentre l’uomo è un essere sociale ( ” l’uomo è fatto per vivere in società “). Contro le superstizioni, i dogmi, gli idoli che tirannizzano lo spirito umano, scrive che ” filosofare è dare la ragione delle cose o per lo meno cercarla “. Filosofia è ” la scienza dei possibili “, occorre ricercare quello che può convenire in generale per tutti gli interessi umani e in che cosa consistono le differenze. Così giunge a ipotizzare un concetto di evoluzione differenziata, e si interessa di calcolo delle probabilità. La sua idea centrale è quella della combinazione dei possibili: la natura è un caos di forze, un insieme di contraddizioni e conflitti, di sviluppi potenziali. Di qui il superamento diderotiano del meccanicismo e del tradizionalismo statico. nella sua “Critica al libro ‘Dell’Uomo’ di Helvetius” scrive contro ” il governo arbitrario d’un principe giusto e illuminato ” che, anche se giusto e illuminato, abitua il popolo a obbedire al tiranno: ” toglie al popolo il diritto di deliberare, di volere o non volere, di opporsi anche alla sua volontà quando ordina il bene; perché questo diritto di opposizione […] è sacro: senza questo i soggetti assomigliano a un gregge di cui si disprezza il richiamo, con il pretesto che lo si porta nei grassi pascoli “. ” La società si di vide in due classi: una classe ristretta di cittadini che sono ricchi, e una classe molto numerosa di cittadini che sono poveri “: Diderot critica sfruttamento e sperequazione, vorrebbe una ripartizione più equa della ricchezza. Nell’ “Apologia dell’Abate Raynal” scrive contro ” i tiranni religiosi “, e aggiunge: ” il libro che amo e che i re e i loro cortigiani detestano è il libro che fa nascere i Bruti “: l’insurrezione è un dovere per un popolo oppresso, perché ” i mortali sono tutti uguali “. Per Diderot ” mai un uomo potrà essere la proprietà di un sovrano, un bambino la proprietà di un padre, una donna la proprietà di un marito, un domestico la proprietà di un padrone, un negro la proprietà di un colono. Dunque non possono esistere schiavi, neanche per diritto di conquista, ancora meno per acquisto e vendita. I Greci dunque sono stati degli animali feroci contro i quali i loro schiavi giustamente si sono ribellati. I Romani dunque sono stati bestie feroci […] “. Per questo principio Diderot condanna i massacri degli spagnoli in America Latina. Ma fa anche qualcosa in più. Nel 1766-1769 il navigatore francese Bougainvil le aveva compiuto un viaggio di circumnavigazione scoprendo numerosi arcipelaghi della Polinesia, e aveva poi raccontato la sua esperienza nel “Viaggio intorno al mondo” (1771), che Diderot aveva letto. Diderot scrive allora il “Supplemento al Viaggio di Bougainville” (1771) che è una critica radicale dei fondamenti culturali e etici della civiltà europea del tempo. Il testo è scritto nella forma del dialogo tra il vecchio saggio di Tahiti e Bougainville. Diderot denuncia l’etnocidio e l’etnocentrismo de gli europei, mentre nello stesso tempo presenta la comunità tahitiana come vicina allo ‘stato di natura’ (sullo sfondo c’è il mito del “buon-selvaggio”), basata sulla parità uomo-donna, sulla comunità dei beni, l’eguaglianza, la libertà sessuale e l’autogoverno. Nell’isola di Tahiti non esiste l’idea di peccato, la parità tra i sessi è totale, la donna è un essere libero e pensante come l’uomo e non può quindi essere la proprietà di nessuno. Il vincolo matrimoniale non è eterno ma consensuale, esso è ” il consenso di abitare in una stessa capanna, di dormire nello stesso letto, finché si sta bene insieme “: ” appena la donna diventa la proprietà dell’uomo, e il piacere sessuale è vi sto come un furto, nacquero delle virtù e dei vizi immaginari. In una parola, tra i due sessi, delle barriere “. ” Volete sapere la storia abbreviata di quasi tutta la nostra miseria? Eccola. Esisteva un uomo naturale. Hanno introdotto dentro questo un uomo artificiale, e si è alzata nella caverna una guerra continua che dura tutta la vita. Talvolta l’uomo naturale è il più forte, talvolta è travolto dall’uomo morale e artificiale. E nell’uno come nell’altro caso il povero mostro è lacerato, attanagliato, tormentato, steso sulla ruota. Gemendo senza sosta, continuamente infelice “. Invoca Diderot: ” piangete, infelici tahitiani! piangete dell’arrivo […] di questi uomini ambiziosi e cattivi […]. Un giorno torneranno […] per incatenarvi, sgozzarvi, assoggettarvi alle loro stravaganze e ai loro vizi, un giorno servirete sotto di loro, altrettanto corrotti, altrettanto vili, infelici come loro “. Fa dire al vecchio tahitiano: ” noi segniamo il puro istinto della natura. Tu hai tentato di cancellare dalla nostra anima il suo carattere. Qui tutto è di tutti, e tu ci hai predicato non so quale distinzione del tuo e del mio […]. Noi siamo liberi, ed ecco che tu hai piantato nella nostra terra il titolo della nostra futura schiavitù. Tu non sei né dio né un demonio: chi sei allora per fare degli schiavi? […] Tu hai progettato nel fondo del tuo cuore la rapina di tutto un popolo! Tu non sei schiavo, soffriresti piuttosto la morte che esserlo, e tu vuoi asservirci! Tu credi dunque che il tahitiano non sappia difendere la sua libertà e morire? […] Il tahitiano è tuo fratello. Voi siete due figli della natura: quale diritto hai su di lui che non abbia su di te? […] Lasciaci le nostre usanze, sono più sagge e più oneste delle tue, non vogliamo barattare quella che chiami la nostra ignoranza contro i tuoi inutili lumi. […] Siamo disprezzabili solo per non avere bisogni superflui? […] Insegni fin dove vuoi quello che chiami la comodità della vita, ma permetti a de gli esseri sensati di fermarsi se ottengono dai loro continui faticosi sforzi solo beni immaginari. Se tu ci persuadi a oltrepassare il limite del bisogno semplice, quando finiremmo di lavorare? Quando goderemmo? Abbiamo ridotto il più possibile le nostre fatiche annue e giornaliere perché niente ci sembra preferibile al riposo. Va nel tuo paese ad agitarti, tormentarti quanto vuoi: lasciaci riposare “. Alla fine della sua vita il vecchio filosofo si schierava con le colonie nordamericane in rivolta contro l’impero inglese, con la sua “Apostrofe ai ribelli d’America” (“Apostrophe aux insur gents d’Amérique”): parla di libertà, uguaglianza, virtù, indipendenza, scrive che per raggiungere felicità e libertà gli americani non dovevano abusare della prosperità, dovevano essere giusti nella ripartizione delle ricchezze, non tentare di soggiogare altri popoli. Scrisse Diderot, ne “L’autorità politica” ( dall’Enciclopedia):
” Nessun uomo ha avuto dalla natura il diritto di comandare agli altri. La libertà è un dono del cielo, ed ogni individuo della stessa specie ha il diritto di fruirne non appena è dotato di ragione. L’unica autorità posta dalla natura è la patria potestà; ma la patria potestà ha dei limiti e nello stato di natura cesserebbe non appena i figli fossero in grado di governarsi. Ogni altra autorità ha un’origine diversa dalla natura. A ben guardare, si potrà sempre farla risalire ad una di queste due fonti: o alla forza e alla violenza di chi se ne è impadronito, o al consenso di coloro che vi si sono assoggettati con un contratto stipulato o presunto tra essi e colui al quale hanno deferito l’autorità. Il potere acquisito con la violenza è mera usurpazione, e dura solo finché la forza di chi comanda prevale su quella di coloro che ubbidiscono; sicché, se questi ultimi diventano a loro volta i più forti e si scrollano di dosso il giogo, lo fanno con altrettanto diritto e giustizia di chi l’aveva loro imposto. La stessa legge che ha fondato l’autorità allora la distrugge: è la legge del più forte. Talvolta l’autorità impostasi con la violenza cambia natura: quando si regge per aperto consenso di coloro che si sono sottomessi; ma in questo caso rientra nel secondo caso che esaminerò; e chi se l’era arrogata, diventando allora principe, cessa di essere tiranno “.
D’ALEMBERT

Fisico, matematico e filosofo francese (Parigi 1717-1783), fra i maggiori esponenti del pensiero illuministico francese, Jean-Baptiste Le Rond (detto d’Alembert) occupa un posto importante nella storia della letteratura, della meccanica, di cui è considerato uno dei fondatori, ma soprattutto in quella della matematica, dell’astronomia e della filosofia. Figlio naturale di Madame de Tencin e del cavaliere Destouches, generale d’artiglieria, fu abbandonato sui gradini della cappella di Saint-Jean Le Rond, donde il suo nome. Affidato alla moglie di un vetraio, che riconoscerà sempre come sua vera madre, ebbe dal padre una piccola rendita con cui compì gli studi al Collège des Quatre Nations, fondato da Mazzarino e permeato di giansenismo: qui si dedicò allo studio del diritto e della teologia, che abbandonò ben presto per rivolgersi a quello della matematica. Le sue precoci pubblicazioni in questo campo gli valsero l’ingresso nel 1741, a soli 24 anni, all’Académie des Sciences; tra il 1743 e il 1751 scrisse una serie d’importanti opere scientifiche, culminate nella direzione (1747), assieme a Diderot, dell’Encyclopédie di cui scrisse il celebre Discours préliminaire (1751), l’articolo Genève, ispirato da Voltaire, di cui era amico e che gli valse le proteste di Rousseau (Lettre à d’Alembert sur les spectacles), oltre a numerosi articoli di matematica e fisica. Eletto nel 1754 membro dell’Académie Française, ne divenne nel 1772 segretario a vita, declinando l’invito di Federico di Prussia a presiedere all’Accademia di Berlino, sia perché non si riteneva degno di occupare un posto accademicamente superiore a quello di Eulero, il più grande matematico del tempo, sia per le polemiche e le inimicizie che una simile decisione avrebbe suscitato in Francia; con analogo rifiuto rispose a Caterina di Russia che gli voleva affidare l’incarico dell’educazione del granduca Paolo. Nel 1154 conobbe Julie de Lespinasse, alla quale fu legato da tenera amicizia fino alla morte di lei (1776); d’Alembert le sopravvisse pochi anni: morì sei anni avanti lo scoppio della rivoluzione di cui è considerato, assieme agli altri grandi illuministi, uno dei precursori. Le sue opere principali (raccolte negli otto volumi degli Opuscules mathématiques, 1761-80) sono: il Traité de dynamique (1743) in cui fonda la meccanica dei corpi rigidi sui tre principi dell’inerzia, della composizione dei movimenti e dell’equilibrio tra due corpi, esso contiene l’esposizione e numerose applicazioni del principio che porta il suo nome. Da quest’opera discendono il Traité de l’équilibre et du mouvement des fluides (1744), di fondamentale importanza per lo sviluppo dell’idrodinamica, i cui problemi d’Alembert riprende in memorie chiarificatrici del 1752 e 1770; la Théorie générale des vents (1745) e alcune memorie di argomento astronomico (tra cui Recherches sur la précession des équinoxes, 1749) dove stabilisce le equazioni del moto della Terra attorno al suo baricentro e affronta il problema dei tre corpi (legame tra le forze e i moti relativi del Sole, della Terra e della Luna). Nello sviluppo matematico di questi problemi di meccanica d’Alembert s’imbatté nell’equazione che porta il suo nome, di cui fornisce lo studio completo fino all’integrale generale, e nel teorema fondamentale dell’algebra, di cui dà la prima dimostrazione parziale. Il suo spirito illuministico si manifesta pienamente nel Discours préliminaire all’Encyclopédie nel quale, dopo aver esposto l’ordine secondo cui sono nate le diverse branche delle conoscenze umane, fornisce un quadro storico dell’evoluzione della cultura dal Rinascimento ai suoi tempi, con particolare interesse per le arti meccaniche e i loro artefici, gli artigiani e i tecnici, presupposto teorico alla rivoluzione borghese del 1789. In metafisica d’Alembert ritiene insolubili i problemi tradizionali di tale scienza, quali la natura dell’anima, il concetto dell’essere, l’unione dell’anima e del corpo; Dio sarebbe solo l’autore dell’ordine dell’universo e perciò affatto estraneo all’uomo. Nulla in comune hanno dunque la religione e la filosofia: la prima, da lui avversata, è vista come strumento per regolare i costumi del popolo; da qui perciò la sua tesi a suffragio di un catechismo laico avente come fine supremo l’utilità sociale; la seconda come manifestazione pura della ragione e quindi vera e sola ricerca efficace della verità. Fra le opere filosofico-letterarie sono da ricordare inoltre l’Essai sur la Société des gens de lettres (nei Mélanges, 1753) dove d’Alembert, che ebbe per motto “Liberté, vérité, pauvreté”, esalta l’indipendenza dello scrittore e la sua dignità umana; gli Eléments de philosophie (1759), dove espone la sua dottrina, che non si basa su alcun sistema, ma che è solo interpretazione, in tono minore, dell’utilitarismo di Bacone e filiazione del pensiero di Locke; l’imparziale Histoire de la destruction des Jésuites (1765).
Il Discorso preliminare fu composto da Jean-Baptiste Le Rond, detto d’Alembert (1717-1783), verosimilmente nel 1750 e apparve all’inizio del primo volume dell’Encyclopédie nel 1751. In esso sono esposti i princípi informatori della grande opera collettiva. Nella pagina che proponiamo alla lettura è sintetizzata una teoria della conoscenza fondata sulle tre facoltà della mente umana (memoria, ragione propriamente detta e immaginazione). Questa teoria della conoscenza spiega lo stato delle scienze (divise e autonome l’una dall’altra) e la necessità di unificarle.
Il sistema delle nostre conoscenze è costituito da diversi settori, alcuni dei quali hanno uno stesso punto di incontro; e, dato che non è possibile, muovendo da questo punto, percorrere contemporaneamente ogni strada, deve esserci una scelta determinata dalla natura dei differenti spiriti. é pertanto assai raro che una medesima persona proceda al tempo stesso in varie direzioni. Nello studio della natura gli uomini si sono all’inizio dedicati, quasi spontaneamente, a soddisfare i bisogni piú urgenti; ma, una volta pervenuti alle conoscenze meno necessarie, essi hanno dovuto distribuirsele, e procedere ognuno da parte sua con un passo all’incirca eguale. Pertanto diverse scienze sono state all’incirca contemporanee; ma nell’ordine storico dei progressi dello spirito si può abbracciarle soltanto successivamente. Lo stesso non avviene invece per l’ordine enciclopedico delle nostre conoscenze. Questo consiste nel riunirle nel piú piccolo spazio possibile, ponendo il filosofo al di sopra di questo vasto labirinto, in una prospettiva cosí elevata da poter considerare insieme le scienze e le arti principali, da poter vedere con un colpo d’occhio gli oggetti delle proprie speculazioni e le operazioni che può compiere su tali oggetti, e da poter distinguere i principali settori delle conoscenze umane, i punti che li separano e quelli che li uniscono, intravedendo anche, in qualche caso, i cammini segreti che li congiungono. […] Gli oggetti di cui la nostra anima si occupa sono oggetti spirituali od oggetti materiali; e la nostra anima si riferisce ad essi o mediante idee dirette o mediante idee riflesse. Il sistema delle conoscenze dirette può consistere soltanto nella collezione puramente passiva, quasi meccanica, di queste medesime conoscenze: esso è ciò che chiamiamo memoria. La riflessione è invece di due tipi, come si è osservato: essa ragiona sugli oggetti delle idee dirette, oppure li imita. Pertanto la memoria, la ragione propriamente detta e l’immaginazione costituiscono le tre maniere differenti in cui la nostra anima opera sugli oggetti dei propri pensieri. Non intendiamo qui per immaginazione la facoltà di rappresentarsi gli oggetti – poiché questa non è altro che la memoria stessa degli oggetti sensibili, la quale sarebbe in continua attività se non fosse agevolata dall’invenzione dei segni: noi intendiamo l’immaginazione in un senso piú nobile e piú preciso, cioè come la capacità di creare mediante l’imitazione. Queste tre facoltà formano le tre distinzioni generali del nostro sistema, e i tre oggetti generali delle conoscenze umane: la storia, che si riferisce alla memoria; la filosofia, che è il frutto della ragione; le belle arti, che sorgono in virtú dell’immaginazione. Collocando la ragione prima dell’immaginazione, questo ordine appare ben fondato, e conforme al naturale progresso delle operazioni dello spirito: l’immaginazione è una facoltà creativa, e lo spirito comincia – prima di creare – ragionando su quello che vede e che conosce. Un altro motivo che deve indurci a porre la ragione prima dell’immaginazione è il fatto che in questa facoltà dell’anima si trovano riunite in qualche misura le altre due, e che la ragione vi si congiunge con la memoria. Lo spirito non crea e non immagina se non oggetti che siano simili a quelli che ha conosciuto mediante idee dirette e mediante le sensazioni: quanto piú esso si discosta da questi oggetti, tanto piú gli esseri che esso forma risultano bizzarri e meno gradevoli. Nell’imitazione della natura l’invenzione stessa è sottoposta quindi ad alcune regole; e queste costituiscono principalmente la parte filosofica delle belle arti, finora assai imperfetta – poiché essa può essere soltanto opera del genio, mentre il genio preferisce creare anziché discutere.
CONDILLAC

Etienne Bonnot , abate di Condillac ( 1714-1780 ) , nacque a Grenoble da una famiglia di giuristi, e, come il fratello maggiore, il famoso scrittore politico, abate di Mably, prese l’ordine sacro e divenne abate di Mureau. In entrambi i casi la professione era solo nominale, e l’intera vita di Condillac, con l’eccezione del periodo in cui fu tutore alla corte di Parma, si dedicò ai suoi studi. Le suo opere furono Saggio sull’origine delle conoscenze umane (1746), Trattato sui sistemi (1749), Trattato sulle sensazioni (1754), Trattato sugli animali (1755), un completo Corsi di studio (1767-1773) in 13 volumi, scritti per il giovane Duca Ferdinando di Borbone, nipote di Luigi XV, Il commercio e il governo, considerati l’uno relativamente all’altro (1776), e due lavori postumi, Logica (1781) e l’incompleto Linguaggio dei calcoli (1798). Nei primi giorni a Parigi venne in contatto con la scuola di Diderot. L’amicizia Rousseau, che durò fino alla morte, può essere dovuta in primo luogo al fatto che Rousseau era stato insegnante privato nella famiglia dello zio di Condillac, M. de Mably, a Lione. Grazie alla sua naturale attenzione e riservatezza, le amicizie di Condillac con i filosofi contemporanei non danneggiarono la sua carriera; egli comprese certamente la scelta della corte francese di mandarlo a Parma per educare il duca orfano, un bambino di sette anni, nel 1758. Nel 1768, dopo il suo ritorno dall’Italia, fu eletto all’Académie française, ma non partecipò alle riunioni dopo la sua elezione. Spese gli ultimi anni ritirandosi a Flux, una piccola proprietà che acquistò vicino a Beaugency, e vi morì il 3 agosto 1780 la riflessione di Condillac si incentra soprattutto sul problema gnoseologico , ossia sul problema della conoscenza , al quale egli fornisce la soluzione probabilmente più originale nell’ ambito dell’ illuminismo francese . Interamente dedicati alla problematica della conoscenza sono le sue due opere più importanti : il Saggio sull’ origine delle conoscenze umane ( 1746 ) e il Trattato delle sensazioni ( 1754 ) . Nel Trattato sui sistemi ( 1749 ) egli contrappone invece i sistemi filosofici che , secondo la regola newtoniana dell’ hypotheses non fingo , si basano solamente sui fatti accertati sperimentalmente , a quelli costruiti su princìpi generali , frutto di speculazione astratta : si ribadisce quindi la distinzione , tanto cara agli illuministi , tra spirito sistematico e spirito di sistema . Il punto di partenza di Condillac é ancora una volta il filosofo liberale inglese Locke . Egli infatti accetta sostanzialmente la dottrina lockiana delle idee , apportandovi però una correzione di fondamentale importanza : pur accettando la distinzione tra le idee di sensazione , che provengono direttamente dal mondo esterno attraverso i sensi , e le idee di riflessione , generate dal riflettere della mente sulle proprie operazioni , egli nega che la riflessione sia una fonte di conoscenza distinta dalla sensazione . Il riconoscimento da parte di Locke di una conoscenza indipendente dalla sensazione appare a Condillac come un residuo di innatismo cartesiano , appena velato dalla definizione della riflessione in termini di esperienza interna . La conseguenza inevitabile di questa riduzione é un sensismo gnoseologico assoluto : non solo le idee riflesse , ma tutte le operazioni spirituali ( la memoria , il giudizio , le forme più astratte del pensiero come quelle più complesse della vita emotiva ) non sono altro che sensazioni trasformate . Il meccanismo di questa trasformazione si spiega con il sentimento di piacere e di dolore che accompagna le sensazioni , e quindi con il fatto che esse appaiono favorevoli o contrarie alla soddisfazione dei bisogni fisiologici dell’ uomo . L’ associazione delle sensazioni con il piacere o il dolore , o con altre sensazioni che conducono al piacere o al dolore , é causa di comparazioni , di valutazioni , di reazioni e , infine , di abitudini nelle quali consiste tutta la nostra attività intellettuale e passionale . Per illustrare l’ assoluta continuità del processo di sviluppo che va dalla sensazione alle più complesse operazioni dello spirito , Condillac ricorre al celebre esempio della statua . Egli immagina l’ esistenza di una statua marmorea che , per quanto chiusa ad ogni penetrazione sensibile dall’ esterno ( visto che é di marmo ) , sia interiormente organizzata nel nostro stesso modo : essa sarà quindi fornita di uno spirito , di una res cogitans ( per dirla con Cartesio ) nettamente contrapposta alla materia estesa ( res extensa ) virtualmente capace di compiere le stesse operazioni dello spirito umano , anche se inizialmente del tutto privo di idee ( una vera e propria tabula rasa ) . Condillac immagina poi di aprire ad uno ad uno i cinque sensi , secondo l’ ordine che egli ritiene più adatto a spiegare l’ originarsi delle idee e delle operazioni sulle idee . Condillac inizia con l’ olfatto che , essendo il senso più povero di determinazioni , é quello che meno contribuisce alla definizione dei contenuti della conoscenza , per poi passare via via agli altri sensi . In questo modo la statua , che inizialmente non pensava e non desiderava nulla , sviluppa gradualmente tutte le operazioni psichiche che sono caratteristiche dell’ uomo . La condizione quindi perchè la statua possa pensare e volere é che in essa penetrino le sensazioni che risvegliano in essa le operazioni spirituali : fuori di metafora , l’ uomo stesso non sarebbe in grado di svolgere nessuna funzione psichica se il suo spirito non fosse progressivamente informato ed educato dalle sensazioni esterne . Nella dottrina gnoseologica di Condillac il tatto presenta una posizione di privilegio rispetto agli altri sensi . Finchè le informazioni sensibili che provengono alla statua sono limitate a questi ultimi , manca infatti un contatto diretto tra il soggetto che conosce e l’ oggetto che viene conosciuto . Le idee che provengono così allo spirito della statua hanno un contenuto rappresentativo , cioè consentono di descrivere l’ immagine di cose , ma non dimostrano ancora la realtà del mondo esterno . Soltanto attraverso il tatto , che consente di percepire l’ estensione e il movimento , la statua può distinguere se stessa da ciò che é diverso da sè . Attraverso di esso , infatti , la statua percepisce innanzitutto le parti di se stessa e la loro interazione reciproca , conseguendo così quel sentimento fondamentale che é la coscienza del proprio io , alla quale Cartesio arrivava col famoso dubbio . Successivamente , toccando gli altri oggetti e sentendo la loro solidità e resistenza , la statua potrà giungere all’ idea dell’ esteriorità di questi oggetti rispetto a se stessa .
JULIEN OFFRAY DE LA METTRIE

Nel periodo illuministico , accanto alle posizioni deistiche , troviamo anche alcuni strenui difensori dell’ ateismo e del materialismo : essi entreranno in contrasto non solo con i sostenitori della tradizione filosofica e religiosa , ma anche con i philosophes più moderati . Il caso più interessante é senz’ altro quello di Julien Offray de La Mettrie ( 1709 – 1751 ) , il quale studiò medicina prima a Parigi poi a Leida , in Olanda , dove fu allievo di Hermann Boerhaave , medico spinoziano sostenitore di un radicale meccanicismo fisiologico che avrebbe molto influito sul giovane La Mettrie ; grande nemico della Chiesa cattolica e della sua intolleranza universale , i suoi dogmi inaccettabili per la ragione , il suo appoggio ai regimi tirannici , il suo ruolo di divulgazione dell’ ignoranza e la sua superstizione più profonda , La Mettrie contribuì alla diffusione in Francia del pensiero scientifico di Boerhaave , con traduzioni dei suoi scritti e relative introduzioni . La Mettrie non tardò ad approdare a tesi fortemente materialistiche che trovarono una prima organica esposizione nella Storia naturale dell’ anima , del 1745 , e successivamente nella sua opera più famosa , l’ Uomo – macchina , del 1748 . Questo libro suscitò grande scalpore tanto che fu pubblicamente bruciato sul rogo e La Mettrie dovette fuggire in Prussia , accettando la protezione del sovrano imbevuto di razionalismo , Federico II , per evitare di fare la fine toccata a Giordano Bruno un secolo prima . Questo dimostra come in Francia non vi fosse ancora quella libertà di pensiero che invece si era gradualmente affermata in Inghilterra per culminare nell’ abolizione della censura . Il filosofo cui La Mettrie maggiormente si ispira , naturalmente , é l’ edonista Epicuro tant’ é che tra i suoi scritti , oltre a quelli già citati e a L’ uomo – pianta e L’ arte di godere , egli scrisse anche Il sistema di Epicuro , in cui si riallacciava alle tesi propugnate al grande filosofo greco . Nella Storia naturale dell’ anima La Mettrie parte dal presupposto dell’ infondatezza della distinzione effettuata da Cartesio un secolo prima circa tra res extensa ( la materia ) e res cogitans ( la spiritualità ) : se la materia é solo materia ( res extensa ) e l’ anima é solo anima ( res cogitans ) e materia e anima sono inconciliabili ( come dice Cartesio ) , che rapporto c’ é tra corpo e anima ? In altre parole , se sono due realtà tra loro così radicalmente distinte , come fa il corpo ad agire sull’ anima e l’ anima ad agire sul corpo ? Che agiscano l’ uno sull’ altro non si discute : quando con l’ anima decido di alzare il braccio e poi col corpo lo alzo é l’ anima che agisce sul corpo ; viceversa , quando metto la mano su una superficie calda , provo con l’ anima una scottatura . Ecco che allora Cartesio si trova di fronte ad un problema non da poco : due sostanze eterogenee , tra loro opposte , che nell’ uomo agiscono l’ una sull’ altra . Le realtà fisiche , poi , per Cartesio si comportano secondo schemi meccanici e deterministici , mentre invece l’ anima é libera di scegliere , gode del libero arbitrio ( l’ errore consiste proprio nella volontà ) : anche qui Cartesio deve far fronte a un grande problema che se non risolto può far vacillare l’ intero suo edificio del sapere . Cartesio deve far quindi incontrare il mondo fisico , meccanicistico e privo di libertà d’ azione con quello spirituale libero e immateriale . Diventa poi difficilissimo spiegare come l’ anima muova il corpo e viceversa visto che l’ anima , per definizione , é sostanza spirituale e non é riconducibile ad estensione : nell’ ottica meccanicistica cartesiana , ogni movimento é causato da urti fisici , ma come fa il corpo materiale ad urtare l’ anima immateriale per farla muovere a sentire il calore quando appoggiamo la mano su una superficie calda ? Come può esserci movimento per contatto tra una realtà fisica e una spirituale ? E’ una contraddizione parlare di movimento e di urti a riguardo dell’ anima . Ecco allora che Cartesio tenta di fornire una spiegazione ipotizzando proprio un contatto tra anima e corpo , una spiegazione non molto convincente già all’ epoca : nella cosiddetta ghiandola pineale avviene l’ incontro fatidico e misterioso tra le due res . Ma tutta la filosofia del 1600 non é altro che un tentativo di risolvere la problematica mal conclusa da Cartesio sul rapporto tra la res cogitans e la res extensa e perfino La Mettrie , nel 1700 , prova a risolvere la questione in modo analogo a come aveva fatto Hobbes : eliminando la res cogitans . Per Le Mettrie esiste solo la res extensa , la materia , mentre la res cogitans é solo una manifestazione della materia . Anche l’ anima , spiega La Mettrie , presenta gli attributi dell’ estensione e della materialità . Infatti , dal momento che non possiamo conoscere l’ intima essenza nè della sostanza estesa nè di quella pensante ( come aveva già dimostrato Locke ) , siamo autorizzati a pensare che anche la materia partecipi di quella sensibilità che Cartesio attribuisce esclusivamente all’ anima . Corpo e anima , entrambi materiali ( res extensa ) , sono quindi per La Mettrie strettamente interdipendenti , come é provato dal fatto che l’ alterazione delle condizioni fisiche ( per esempio , la febbre elevata : ricordiamoci che La Mettrie é medico ) comporta la diminuzione delle capacità intellettuali . Nella Storia naturale dell’ anima La Mettrie non negava l’ esistenza dell’ anima ( come indica lo stesso titolo dell’ opera ) , ma soltanto la sua immaterialità : l’ anima é materia poichè tutto ciò che esiste deve per forza essere materia e se l’ anima é materia significa che essa , come ogni altra cosa materiale , é destinata a perire . Nell’ Uomo macchina , invece , che é il suo capolavoro , egli , estendo il meccanicismo di Cartesio anche all’ uomo , rende assolutamente superflua l’ ipotesi dell’ anima , che in fondo già nelle teorie cartesiane sembrava un qualcosa di superfluo , aggiunto solo per non inimicarsi la Chiesa : quello che per Cartesio differenzia gli uomini dagli animali é proprio l’ anima , che però sembra più un elemento aggiuntivo che non fondamentale : gli animali , senz’ anima , vivono benissimo . Pare un elemento forzatamente aggiunto l’ anima tant’ é che poi nel 1900 un filosofo definirà adeguatamente la concezione cartesiana dell’ uomo : una macchina con uno spettro all’ interno : l’ uomo é una macchina esattamente come gli animali e in più rispetto ad essi si trova ad avere uno spettro ( l’ anima ) . Ma quest’ ipotesi dell’ anima nella macchina parve poco convincente fin dall’ inizio perchè in fondo il problema di come realtà materiale e spirituale entrino in contatto Cartesio lo risolve in modo poco convincente , quasi come se l’ anima nella ghiandola pineale si comportasse da corpo . Ecco allora che La Mettrie , eliminando radicalmente la res cogitans , non esita a dire che l’ uomo , come ogni altro animale , é soltanto una macchina che risponde alle rigide leggi del meccanicismo , é cioè un meccanismo che funziona in base alle proprietà intrinseche della materia stessa . D’ altronde Cartesio era arrivato a dire che gli animali fossero macchine e l’ uomo no avendo ipotizzato che una macchina imiti perfettamente un animale : chi non mi dice che l’ animale stesso non sia una macchina ? Con l’ uomo tutto é diverso perchè nessuna macchina potrà mai pensare razionalmente come fa l’ uomo ; oggigiorno però ci si avvicina sempre di più a macchine che imitano il ragionamento dell’ uomo e quindi il ragionamento di Le Mettrie , per molti versi , é più coerente di quello di Cartesio ( teniamo presente che l’ epoca in cui vive Le Mettrie é un’ epoca che va sempre più verso la rivoluzione industriale , caratterizzata dal brulicare delle macchine ) . Le leggi naturali che regolano il meccanismo dell’ uomo macchina non possono essere conosciute astrattamente , ma devono essere indagate sperimentalmente da scienze quali l’ anatomia e la fisiologia ( La Mettrie é medico ) . La sola differenza tra animali e uomini non é il fatto che gli uni non abbiano l’ anima e gli altri sì ( come aveva detto Cartesio , ma é la maggiore complessità strutturale della macchina uomo . Così come gli animali sono macchine più complesse rispetto alle piante e le piante sono macchine più complesse rispetto agli esseri naturali più semplici , l’ uomo é la macchina più complessa di tutte , ma é pur sempre una macchina : il fatto di essere una macchina e di agire secondo le rigide regole meccanicistiche comporta il fatto che non vi é libero arbitrio : l’ uomo non può scegliere come agire perchè tutto é dettato dalla fisica meccanicistica ; con Cartesio c’ erano sì le regole meccanicistiche che muovevano i corpi , ma nell’ ambito della res cogitans vi era il libero arbitrio : l’ anima può scegliere , é libera . Ma se l’ anima non c’ é e tutto é materia , allora viene a cadere anche la libertà : l’ uomo non piange perchè vuole piangere , ma piange perchè é stimolato a piangere : ad ogni imput corrisponde un output proprio come in una macchina : se suono il clacsono ad una macchina suona , se tiro la coda a un gatto miagola ( fin qui lo diceva anche Cartesio ) se percuoto un uomo piange ; tutto é dominato dal meccanicismo . L’ intera natura é ricondotta ad un unico principio , la materia fornita di sensibilità e movimento e le differenze tra macchina e macchina consistono solo nei diversi modi di funzionamento e nei diversi livelli di complessità dei meccanismi naturali . L’ uomo é in altri termini una sorta di orologio : costituisce un tutto unitario proprio come un orologio in cui tutti gli ingranaggi sono costruiti per servire a un unico scopo e la composizione meccanica della macchina ( i meccanismi sono giustapposti , ma mantengono una loro indipendenza ) consente la distinzione tra diversi ambiti di funzionamento : una parte della macchina si può guastare senza pregiudicare con ciò il funzionamento delle altre parti : Il corpo umano é un orologio , ma immenso e costruito con tanto artificio e abilità che se la ruota adibita a indicare i secondi si ferma quella dei minuti continua a girare e a compiere il suo corso , ed anche la ruota dei quarti d’ ora continua a muoversi . ( L’ uomo – macchina ) . Negli scritti a carattere morale La Mettrie sviluppa un’ etica edonistica che si ispira ad Epicuro : la natura stessa indica ciò che é bene per l’ uomo connettendolo con il piacere , che é sempre e solo materiale , anche se può assumere espressioni raffinate , come il piacere intellettuale ed estetico . L’ uomo non deve vivere nel timore di Dio proprio perchè Dio non esiste ! Esiste solo la materia e quindi Dio, che certo non può essere materia ( come invece aveva detto Hobbes ) non esiste , proprio come l’ anima .
CLAUDE-ADRIEN HELVÉTIUS

VITA E OPERE
Claude-Adrien Helvétius, (Parigi 1715-1771) filosofo francese, figlio del medico della regina Maria Lesczynska frequenta il collegio dei gesuiti Louis-le-Grand. Nel 1738 ottiene un posto di appaltatore delle imposte regie che gli frutta una rendita considerevole; ciò non gli impedisce di frequentare gli “spiriti illuminati” dell’epoca: a Cirey da Mme Emilie de Châtelet e dal suo ospite Voltaire, a Montbard da Buffon, a La Brède da Montesquieu; è in amicizia con l’ormai vecchissimo Fontenelle, col grammatico Du Marsais, con Maby, forse anche con Morelly (teorico di posizioni comunistiche) e col giovane Condillac; un po’ più tardi conosce d’Alembert e Diderot, e poi Holbach, Rousseau, Turgot, Quesnay; si forma in pratica alla scuola degli illuministi francesi assertori del “sensismo”; scrive una tragedia per il teatro andata perduta. Nel 1751 si dimette dalla carica di appaltatore delle imposte, conservando quella di “maître d’hôtel” della regina Maria Lesczynska; si sposa con Anne-Caterine de Ligneville, una giovane e colta nobile in difficoltà finanziarie, ed acquista due tenute: una a Lumigny ed una a Voré ove passa gran parte dell’anno; i mesi restanti li trascorre a Parigi in rue Sainte-Anne; i suoi ospiti abituali sono Saurin, Fontenelle, Duclos, Chastellux, Raynal, Marmontel, Saint-Lambert, e a volte Diderot e Rousseau; il giovedì si reca nel salotto di Holbach. Durante la “querelle des bouffons” parteggia con gli enciclopedisti per la musica italiana; durante i lunghi soggiorni in campagna cura le sue terre e, anche per l’interessamento della moglie, cerca di trovare nuove occasioni di lavoro per il crescente numero di piccoli proprietari in rovina e di braccianti disoccupati; dopo un primo sfortunato tentativo di istituire una fabbrica di merletti, riesce ad impiantare con un certo successo una manifattura per la tessitura di calze, fallisce invece più tardi nell’intento di sfruttare industrialmente il legname e i giacimenti di minerali ferrosi abbondanti nella regione dell’Orne e nella stessa sua tenuta di Voré. Nel 1755 muoiono Montesquieu e il padre di Helvétius che si dedica ormai completamente alla filosofia Nel 1757, con la scomparsa di Fontenelle si rescinde l’ultimo filo che ancora collega i “philosophes “col “grand siècle”. Nel 1758 esce “L’Esprit” (“Dello Spirito”; opera ferocemente attaccata dalle autorità civili ed ecclesiastiche per le idee sovversive ed eretiche che contiene): “Mandement de Mgr. l’Archevêque de Paris, portant condamnation d’un livre qui a pour titre “De l’esprit”” (Paris 1758, dispositivo della condanna di Christophe de Beaumont, lo stesso che nel 1762 condannerà l’Emile di Rousseau). “Mandement de Monseigneur l’Évêque de Soissons…” (Soissons & Paris 1759). “Dell’uomo” (postuma 1772). “Le bonheur” (postumo, poema scritto prima del 1751). “Oeuvres complètes d’Helvétius” (Paris 1795, in 14 voll., a cura del suo amico ed esecutore testamentario l’abate Pierre Louis Lefebvre de la Roche). “Helvetius, sa vie et son oeuvre. D’après ses ouvrages, des écrits divers et des documents inédits” (Parigi 1907, monografia di Albert Keim che si assunse il compito di “riabilitare”, di fronte alla cultura filosofica francese, il pensiero di Helvétius che solitamente veniva “sbrigato” con poche battute dalla storiografia letteraria – tipici in tal senso Demongeot e il Lanson – e dalle storie del pensiero politico-morale e filosofico in genere – salvo rare eccezioni: come il “Socialisme au XVIIIe siècle” di A. Lichtenberger e “Les moralistes français au XVIIIe siècle” di J. Barni). “Helvétius. A Study in Persecution” (Oxford 1965, di D.W. Smith).
IL PENSIERO
Claude-Andrien Helvetius, appartenente alla corrente dei cosiddetti filosofi “materialisti”, e si fa portavoce di un materialismo appena più dissimulato rispetto a quello di La Mettrie; nella sua celebre opera “Sullo spirito” (1758) (che suscitò reazioni durissime da parte della cultura tradizionalista, fino a causare la sospensione temporanea dell’ “Enciclopedia”, del cui ambiente Helvétius era frequentatore) egli dà un fondamento gnoseologico al proprio materialismo: sostenendo una dottrina della conoscenza di tipo sensistico (analoga a quella elaborata da Condillac), egli è del parere che tutte le idee provengano da due facoltà: la sensibilità , con cui noi possiamo ricevere le impressioni degli oggetti esterni, e la memoria , grazie alla quale conserviamo nello spirito la sensazione ricevuta. A differenza di Condillac, tuttavia, Helvétius sostiene che tale interpretazione sensistica della conoscenza escluda la possibilità di un’anima immateriale, e pertanto risolve, sia pure con qualche cautela dettata dall’autocensura, ogni attività dello spirito nella materia. Sulla base del proprio sensismo materialistico, Helvétius formula anche una morale di tipo utilitaristico , nella quale il riconoscimento dei moventi puramente dell’azione umana (il piacere e l’interesse) è congiunto al tentativo di trovare norme di comportamento massimamente generalizzabili. A tale scopo egli introduce appunto il criterio dell’utilità, il cui valore cresce in rapporto diretto il grado di generalità conseguito, che va dall’interesse individuale a quello dei gruppi particolari, dei popoli e così via, fino a comprendere l’universo intero. In sintonia con la tradizione libertina, che rimane sempre sullo sfondo, il materialismo francese si propone come una filosofia volta non già alla demolizione, quanto al consolidamento della morale, anche se quest’ultima non trova più il suo fondamento in Dio o nei valori spirituali, ma esclusivamente nella stessa costituzione materiale dell’uomo. Helvétius riconduce tutte le facoltà dell’anima alla sensazione. Il suo contributo risiede soprattutto nel fatto di mettere in rapporto l’esprit con le condizioni sociali e culturali, stabilendo uno stretto rapporto fra l’educazione, intesa come l’influenza dell’ambiente, e il morale, termine che indica gli aspetti psichici in generale. Il tratto che fa di Helvétius uno degli anticipatori della scienza dell’uomo è proprio quello della correlazione che egli stabilisce fra l’uomo e la società. Riconducendo l’anima alla sensazione e mettendo in rapporto l’ambiente e le strutture sociali, arriva ad una sintesi formulando un’interazione tra le condizioni in cui vive l’individuo e le convinzioni e i valori etici. Attraverso il meccanismo dell’associazione, dalle sensazioni arriva qualsiasi tipo di idea; allo stesso modo, dalla percezione di piacere o di dolore deriva ogni motivazione del comportamento. La formazione del pensiero non dipende solamente dalle esperienze dell’uomo, ma anche dalla propria struttura fisica e dalle facoltà che essa gli permette. Tutte le cose, in quanto conosciute, vengono tradotte in sensazioni o immagini; le idee quindi non sono nient’altro che le associazioni di queste sensazioni. Di conseguenza lo spirito è l’insieme delle conoscenze acquisite mediante l’esperienza. Da queste premesse derivano due importanti conseguenze:
1- la conoscenza umana non può mai andare oltre ciò che è oggetto di sensazione;
2- l’intelligenza o la capacità di riflessione sono pienamente riconducibili alla quantità e alla qualità delle esperienze sensoriali, cioè ai rapporti con l’ambiente.
Anche il giudizio, considerato tradizionalmente il fondamento di ogni conoscenza, è ricondotto alla sensazione. Un giudizio è, per Helvétius, un’immagine mentale, nella quale sono collegate sensazioni diverse. Anche la morale, così come la conoscenza, deriva interamente dall’esperienza, tramite un processo ben preciso: le valutazioni morali sono regolate da una sorta di meccanismo automatico, l’interesse individuale, che si esprime prima di tutto nella tendenza alla propria conservazione, ma investe ogni altro tipo di valutazione e di scelta. Le prime passioni dalle quali è determinato il comportamento umano sono quelle naturali, legate ai bisogni elementari e alle sensazioni del piacere e del dolore; derivano da queste le passioni artificiali, più complesse delle prime. A differenza delle passioni naturali, che sono comuni per tutti gli uomini, quelle artificiali dipendono dall’ambiente in cui si vive e dall’organizzazione politica in cui gli individui si formano. La società dunque determina la natura stessa dell’uomo, sia dal punto di vista cognitivo che morale. Helvétius considera l’ ambiente , l’ambiente storico-sociale, determinante per la formazione di un uomo, in seguito alle esperienze avute ed agli eventi vissuti. L’organizzazione sociale determina il tipo di uomo, la sua sensibilità, il modo di intendere il bene e il male. Di conseguenza tutti gli individui che vivono nella medesima società hanno una morale comune poichè sono tutti formati da cause simili. Da ciò deriva anche che le diverse società hanno differenti valori e ciò che è bene per l’una non lo è per le altre. La virtù non è arbitraria nè immutabile. Essa è funzionale al bene di una determinata società, relativamente alle sue condizioni materiali e all’organizzazione particolare che ha. Nessun costume, seguito da tutto un popolo, è irrazionale: se studiato attentamente, mostra sempre una ragion d’essere, in rapporto al contesto in cui è inserita. anche a livello collettivo, il criterio per distinguere il bene e il male è l’interesse: è definito “virtù” il comportamento del singolo che giova alla società del suo insieme, “vizio” ciò che la danneggia. Non tutti i costumi sono però virtù soltanto in quanto diffusi in una popolazione. Helvetius distingue le virtù vere, quelle cioè che svolgono una funzione sociale positiva, dalle virtù di pregiudizio, dannose o inutili per la collettività e derivanti da false convinzioni. L’analisi di Helvétius muove dal sensismo, sottolinea poi l’importanza dei fattori ambientali nella formazione dell’esprit, ricondotto a una dimensione storico-sociale, per approdare infine, come conseguenza di questo approccio, al riconoscimento della diversità culturale e della pluralità dei valori. Sapendo che Helvétius appartiene alla corrente materialista, considerando questo titolo (“Dello Spirito”) ci si potrebbe aspettare che si tratti di una dimostrazione del carattere materiale dello spirito, del carattere materiale dei processi di pensiero. Invece non è affatto così, non è in quest’ottica che viene presentato, bensì lo spirito è preso in considerazione nei suoi rapporti con la società, nei suoi rapporti con l’educazione, compreso lo spirito nel senso più corrente del termine, come nella locuzione: “avere spirito”. E attraverso questa esposizione apparentemente eclettica, ricca di riferimenti eruditi, nutrita di aneddoti e citazioni, che vengono introdotte all’interno delle frasi quelle espressioni che attestano inequivocabilmente il materialismo di Helvétius. Se si considerano tali espressioni (e il modo in cui vengono introdotte) si può giungere alla conclusione che Helvétius sia ancora largamente inserito nella tradizione libertina . I suoi procedimenti di scrittura, i suoi metodi di dissimulazione, di insinuazione sono tipicamente libertini. Quindi, sotto molti aspetti (malgrado l’importanza e il talento, anzi il genio di Helvétius), abbiamo a che fare con un pensiero che è ancora dipendente da questa antica tradizione. D’altra parte vi sono certamente in Helvétius (sempre sotto questa forma tanto prolissa quanto originale), delle critiche estremamente accese contro il regime politico, contro il regime sociale della Francia del suo tempo, (ovvero dell’Ancien régime), e quindi implicitamente egli ha anche una funzione negativamente rivoluzionaria. Resta inteso che l’opera di Helvétius, come quella di tutti i materialisti, nella misura in cui distrugge gli idoli o i pregiudizi, (o intacca le fondamenta della vecchia società) svolge per ciò stesso un ruolo rivoluzionario o pre-rivoluzionario. Ma in Helvétius non è presente alcun orientamento direttamente rivoluzionario, alcun appello alla rivoluzione, né alcuna ipotesi di una trasformazione rivoluzionaria della società. Helvétius è un uomo che fa ancora affidamento (come molti altri pensatori del suo tempo) su ciò che è stato chiamato, a torto o a ragione, il “dispotismo illuminato”, fa affidamento in ogni caso sui grandi di questo mondo, sui potenti, sui governanti per far progredire la società. E infatti nella prefazione alla sua opera postuma “Sull’uomo”, curiosamente egli dice: ” non c’è più niente da sperare in Francia “. Siamo nel 1772, a meno di vent’anni dalla Rivoluzione ed Helvétius da parte sua non conta su nessuno in Francia e aggiunge “ su chi potrebbe essere riposta la speranza? Sull’Austria forse o sulla Russia, contando forse sull’imperatore Giuseppe II o sull’imperatrice Caterina, su quei paesi insomma, poiché non credo che sulla Francia possano essere riposte delle speranze ”. Il che evidentemente è proprio l’opposto di un orientamento rivoluzionario.
LA LIBERTA’ NEL PENSIERO DI HELVETIUS
Helvétius si distacca decisamente dal coro, in dissenso anche con il suo illustre contemporaneo Rousseau, e soprattutto in evidentissima difformità da quanto andava maturando, in area tedesca, il grande Kant. Senza infingimenti e senza ipocrite mediazioni, egli sostiene che tutto ciò che di grande l’uomo riesce a compiere lo deve senza dubbio alla sua dimensione passionale, e che è la libertà il regno della passione. Senza passione (Helvétius ne è decisamente convinto) non maturano le grandi idee, non si formulano grandi progetti, non si compiono grandi imprese, e quindi non si eleva la condizione di civiltà di un popolo e dell’intera umanità. Ma alla passione è assolutamente indispensabile la libertà, come sua condizione di possibilità e ragione stessa d’esistenza. Di questo orientamento di pensiero, certo, c’è qualche significativa anticipazione, nella storia della filosofia. Hobbes, ad esempio, dà una visione indiscutibilmente nuova della vita passionale, ponendola a fondamento della condizione umana e dello stesso passaggio dell’uomo alla condizione civile. Nelle prospettive di questo tipo, il contrasto, pur sussistente, tra passività e attività, non autorizza nessuna concezione dualistica dell’uomo, né può essere piegata a giustificare la presunta opposizione tra corpo e anima, tra necessità e libertà; e pertanto, l’agire passionale non dev’essere considerato, ineluttabilmente ed esclusivamente, come un’anomala alterazione, una manifestazione patologica del comportamento. Ma, sulla base di tali presupposti, quale senso e quale valore vanno riconosciuti alla libertà? La libertà – Helvétius lo sostiene con vigore – è un bene inestimabile (De l’esprit, I, III), tant’è vero che l’umanità l’ha sempre tenuta in grande considerazione. Si guardi alla storia: non è forse vero che Bruto, così sensibile all’ intérêt public , colse addirittura nel parricidio un mezzo adatto à ranimer l’amour de la liberté , vedendo in esso l’unica concreta possibilità di salvezza per Roma e l’unico modo per impedirle di ricadere sous la Tyrannie des Tarquins ? D’altra parte, per Helvétius, non mancano neppure esplicite attestazioni ‘storiche’ di stima per l’eccellenza della libertà. Egli ricorda con una certa compiacenza quanto il saraceno Omar si dice abbia espresso, non senza enfasi, in riferimento all’uomo amoureux de la liberté : les Rois trembleront devant toi, toi seul ne craindras personne (De l’esprit, III, VI). L’illuminista tuttavia è convinto dell’esistenza di un inscindibile vincolo, nonché della inevitabile interazione tra, da una parte, la condizione di libertà, e, dall’altra, la vita pulsante e magari ardente dei sentimenti. Les siecles de liberté , rileva, sono sempre segnati dalla presenza di grands hommes , vale a dire sono inequivocabilmente caratterizzati da grandes passions e sono les seuls in cui tutti gl’individui di un popolo, di ogni livello e di qualunque condizione, sono sinceri admirateurs des sentiment nobles et courageux (De l’esprit, II, XIX). Si tratta di un circolo virtuoso: la libertà, per così dire, ‘libera’ i sentimenti, e questi, a loro volta, anche nella forma dei forti e magari furiosi coinvolgimenti emotivi, non solo destano e promuovono la stima pubblica e privata per la condizione di libertà, ma contribuiscono a mantenere le circostanze che assicurino la conservazione delle libertà di cui concretamente godono sia i singoli individui, che, per usare il termine helvetiano, la Nazione. Peraltro, all’incremento di libertà corrisponde un aumento di consapevolezza dei grandi ‘valori’, quelli capaci di suscitare entusiasmi, eccitare le intelligenze, ispirare iniziative; quelli per i quali vale la pena di spendere la propria vita magari fino al sacrificio; e pertanto all’incremento di libertà corrisponde non solo una crescita di umanità nell’individuo, ma anche un’accelerazione nel cammino delle società verso una più completa civilizzazione. Ma di quale libertà sta parlando l’illuminista? Su questo tema – Helvétius stesso lo ammette – non c’è chiarezza d’idee. Anzi, non c’è neppure un comune modo di sentire. Ed invano si cercherebbe, quindi, una base minima d’intesa. Del resto, basta osservare la storia della civiltà: quelles disputes … n’a point occasionné le mot de liberté? (De l’esprit, I, IV). Tanta difficoltà indurrebbe a supporre che sia la natura stessa dell’oggetto a renderlo inspiegabile. Che non sia un mistero? Una soluzione del genere è stata proposta – ricorda Helvétius – da Malebranche, “abile teologo” ma anche “tanto amico della verità”. La libertà – dice infatti Malebranche in “Prémotion physique” – è un mistero che ammutolisce: lorsqu’on me pousse sur cette question … je suis forcé de m’arrester tout court “. È una posizione che anche Helvétius giudica rispettabile. E non solo perché, se fosse generalmente condivisa, eliminerebbe alla radice ogni tentazione di vuota retorica sull’argomento, ma perché, quella che per Malebranche è una difficoltà sul piano ontologico, andrebbe più correttamente individuata come un insuperabile limite sul piano epistemologico. L’illuminista, insomma, non disdegna l’idea che sia l’oggetto stesso, di cui si fa discorso, ad imporre il silenzio: se si deve parlare della libertà come se fosse una ‘realtà’ in sé, dotata di una sua propria ‘consistenza’, in effetti non si ha cosa dire, o, che è lo stesso, ognuno ha il diritto di dire quel che vuole. Infatti si sta parlando di una pura astrazione. Ben diverso il caso in cui, abbandonando la regione delle fumose ed inconsistenti speculazioni, si affronti il problema della libertà come quello del concreto esercizio della cosiddetta ‘volontà libera’. Nessuno può permettersi il lusso e l’arroganza di dire quel che gli passa per la testa: occorre tenere nella dovuta considerazione ciò che ci offre l’esperienza, e bisogna inderogabilmente rispettare le esigenze della coerenza logica e della correttezza argomentativa. Ma rifuggire dalle astrazioni non rende più facile il compito della chiarificazione teoretica. Anche parlando di ‘volontà libera’ si può cadere in qualche grossolano errore. Helvétius sembra aver tesaurizzato la convinzione di Hobbes, per il quale, parlare di a free will , così come di a free subject , è cosa assurda tanto quanto parlare di “quadrilatero rotondo”; su questo argomento non si possono esprimere che “non-sense”, words without meaning (Leviathan). Il discuterne, per quanto diffusamente e articolatamente, non ci farà mai approdare alla certezza dell’esistenza di una “libera volontà”: from the use of the words free will, no liberty can be inferred of the will, desire, or inclination . La stessa dizione “libera volontà” è un abuse of words , uno di quegli abusi in cui facilmente s’incorre quando ci si dedica a questions of matters incomprehensible , un errore tipico di chi con troppa leggerezza discute di questions of abstruse philosophy (Leviathan, I, VIII). Anche per Helvétius, dunque, si cade banalmente nell’inverosimile, e addirittura nel paradosso, quando s’intende la libertà, appunto, come le pouvoir libre de vouloir ou de ne pas vouloir une chose . Tale definizione appare, a tutta prima, inattaccabile: sembra infatti perfettamente conforme all’esperienza che ogni uomo fa di sé. Ma l’assumere il termine dans une signification commune non offre garanzie di verità al proprio orientamento. Più precisamente, il pensare in accordo con la convinzione generale non mette al riparo dalle contraddizioni e, addirittura, non assicura neppure di avere una corretta idea dell’oggetto del discorso (De l’esprit, I, IV). E infatti: accettando per valida e per vera questa definizione si cadrebbe inevitabilmente in due insostenibili e ingiustificabili assurdità. Si affermerebbe anzitutto la possibilità di avoir des volontés sans motifs , vale a dire, addirittura, des effets sans cause . Inoltre si ammetterebbe che ogni uomo sia detentore persino del potere di volere o non volere il proprio bene, e che ciascuno possa porsi, di fronte ad esso, con atteggiamento di assoluta ‘indifferenza’ (De l’esprit, I, IV). Helvétius non si limita a contestare tale definizione per quello che esplicitamente dice, ma anche per quello che presuppone, vale a dire per l’antropologia, e in specie, per la psicologia che la fonda e la sostiene. Tale definizione, infatti, per lui è anzitutto ancorata ad un’erronea concezione dell’ attività dello spirito. Tutto fa capo alla nostra effettiva capacità di ‘sospendere la decisione’. Ora, comunemente si crede che il poter operare questa sospensione significhi essere in grado di prendere le distanze dall’oggetto rispetto a cui si deve deliberare, ovvero significhi poter esercitare, senza condizionamenti di sorta, quel rigore di giudizio che ci permetta di deliberare con ‘oggettività’ e quindi di decidere con vera oculatezza, in merito all’oggetto in questione. Detto in altri termini, il est encore des gens qui regardent la suspension d’esprit comme une preuve de la liberté . Ma si tratta di una concezione decisamente errata. Chi sostiene questa tesi, lo fa con eccessiva superficialità; infatti non si accorge che “la suspension” è altrettanto ‘necessitata’ quanto “la précipitation” nel campo del giudizio. Vale a dire, anche la sospensione è sotto il governo del desiderio del proprio benessere. Del resto è facile constatare, ad esempio, che spesso essa è l’effetto di una pregressa disavventura: lorsque, faute d’examen, l’on s’est exposé à quelque malheur, instruit par l’infortune, l’amour de soi doit nous nécessiter à la suspension (De l’esprit, I, IV). Tale tesi, inoltre, si fonda sulla equivoca ed illusoria idea della ‘deliberazione’. Anche in questo caso si parla, in effetti, di una cosa che non esiste. Si rifletta: noi parliamo di deliberazione lorsque nous avons, par exemple, à choisir entre deux plaisirs à peu près égaux et presque en équilibre . Si pensa alla scelta come l’esito di una valutazione razionale. Ma, in realtà, quel che diciamo ‘deliberazione’ non è altro che l”indecisione’, talvolta inevitabile, nel prendere partito, e molto spesso l’impossibilità quasi ‘tecnica’ di decidere. Sicché, nous croyons délibérer , ma in effetti non esercitiamo alcun atto razionale di decisione. Lo scegliere è dominato dall'”interesse”, che è l’unico criterio regolativo del comportamento umano; e l’interesse ci fa sempre ‘propendere’ per uno dei due poli dell’alternativa. E pertanto, la “délibération” non è altro che la lenteur avec laquelle, entre deux poids, à peu près égaux, le plus pesant emporte un des bassins de la balance . Ma allora, si può davvero parlare di ‘volontà libera’? Sul piano della vita pratica, ogni effetto ha sempre una sua causa determinata. Tutti gli atti di volontà sono sempre, inderogabilmente, l’esito dell'”amour de soi” e non possono aver luogo se non nel suo dominio. Ora, poiché l'”amour de soi” trova la sua piena e concreta espressione ne “le desir du plaisir”, questo rappresenta le principe de toutes nos pensées et de toutes nos actions ; e pertanto se ne deve concludere che a) tutti gli uomini tendent continuellement , e non possono non tendere, vers leur bonheur réel ou apparent ; b) e toutes nos volontés non sono altro, e non possono essere altro, che l’effet de cette tendance (De l’esprit, I, IV). E la libertà di cui Helvétius pare avere così grande considerazione? Da queste argomentazioni si dovrebbe ricavare, piuttosto, che, non potendo sussistere atti di volontà che non siano inscritti nell’orizzonte della ‘necessità’, non può esistere alcuna libertà. O quanto meno: se tout effet est nécessoire , allora on ne peut … attacher aucune idée nette à ce mot de liberté (De l’esprit, I, IV). Helvétius prende in considerazione una seconda definizione. Certo, on est nécessité à poursuivre le bonheur partout où on l’apperçoit ; tuttavia, ciò non implica inderogabilmente che siamo necessitati anche sur le choix des moyens que nous employons pour nous rendre heureux . Dunque, l’uomo può certamente essere concepito libero: la sua “libertà” consisterebbe nel suo potere di scegliere i mezzi ritenuti idonei ed adeguati al suo benessere. In base a questa definizione, però, l”uomo libero’ non sarebbe altro che l”uomo illuminato’. Ora, considerare “libre” come un puro e semplice “synonyme d’éclairé”, significa semplicemente commettere l’errore banale di confondre ces deux notions : le quali, invece, sono ben distinte tra loro e devono essere tenute accuratamente separate. Un errore che peraltro, quanto all’atto della scelta, comporta delle implicazioni, per così dire, inattese, e in certi casi addirittura risibili. Ad esempio, in base a tale definizione, si sarebbe indotti a concludere che si prenderà un parti meilleur ou moins bon solo se si conoscerà plus ou moins de procédure et de jurisprudence ! E addirittura si adotterà una scelta più o meno felice, nei propri affari, se si sarà assistiti par un Avocat plus ou moins habile “! La verità è che l’uomo è sempre definito dalla sensibilità fisica; quelque parti qu’il prenne , la sua decisione sarà sempre suggerita dal désir de son bonheur , che lo indirizzerà sempre verso quella soluzione che gli apparirà le plus convenable à ses intérêts, ses goûts, ses passions, et enfin à ce qu’il regarde comme son bonheur (De l’esprit, I, IV). Ma allora, come si potrà mai “philosophiquement expliquer” il problema della libertà? O, per dirla in termini più moderni, è possibile una fondazione teoretica della libertà? oppure bisogna rassegnarsi all’idea che essa non è altro che una bella quanto fragile fantasia? Helvétius chiama in gioco l’autorità di Locke. Se noi siamo il risultato dell’influenza che tutti i fattori ambientali, nel loro gioco interattivo, esercitano su di noi, vale a dire, se nous sommes disciples des amis, des parens, des lectures, et enfin de tous les objets qui nous environnent , allora il faut que toutes nos pensées et nos volontés soient des effets immédiats, ou des suites nécessaires des impressions que nous avons reçûës . E se ne deve ricavare che, poiché la nostra volontà non può mai esercitarsi in modo assolutamente incondizionato, on ne peut se former aucune idée de ce mot de liberté, appliqué à la volonté ! (De l’esprit, I, IV) Insomma, anche ponendo la questione della libertà in questi termini, in fondo ha ragione Malebranche: il faut la considérer comme un mystére . E si deve convenire, di conseguenza, che la Théologie seule peut discourir sur une pareille matiere . E naturalmente si dovrebbe anche ammettere, per quanto a malincuore, che un traité philosophique de la liberté ne seroit qu’un traité des effets sans cause (De l’esprit, I, IV). Oppure – prosegue l’illuminista, riprendendo la tesi degli Stoici nella forma in cui era stata diffusa, nell’ambiente culturale della sua Francia, da A.F. Deslandes, con la sua “Histoire critique de la Philosophie” – bisogna riconoscere che la liberté … est une chimere : se nous nous croyons libres , ciò accade solo faute de connoître les motifs, de rassembler les circonstances, qui nous déterminent à agir d’une certaine maniere (De l’esprit, I, IV). Comunque, se la nostra fede nella libertà è espressione della nostra ignoranza o della nostra incapacità intellettuale, bisogna necessariamente concludere che l’uomo non ha alcun potere di autodeterminarsi? Si provi pure a cambiare l’angolo prospettico d’osservazione. Si consideri il soggetto nella sua concreta ‘collocazione’ nel mondo. Rispetto a quanto già nell’antichità gli Stoici hanno indicato, secondo Helvétius, non muterà affatto il risultato circa la presunta libertà dell’uomo. Ne sont-ce pas plutôt les objets exterieurs, combinés de mille façons différentes, qui le poussent et le déterminent? . Certo, spesso la volontà agisce en conséquence d’un jugement . Ma questo non significa che la condotta sia guidata dalla ragione. Tale giudicare, insomma, non è un segno della libertà dell’uomo. Si tratta piuttosto, come illustra sempre Deslandes a proposito degli Stoici, d’un acte de l’entendement , in forza del quale il singolo individuo approda alla convinzione che telle chose est plus avantageuse à ses intérêts que toute autre . E quanto al valore e all’importanza di questo “giudizio”, basti considerare che esso non è assolutamente indispensabile; infatti il più delle volte si agisce indépendamment de cet acte . Insomma, lo si voglia ammettere o no, “les circonstances”, in cui un uomo concretamente si trova, di fatto necessariamente l’inclinent, le forcent à se tourner d’un certain côté : per cui il se flatte qu’il s’y est tourné librement, quoiqu’il n’ait pas pû vouloir se tourner d’un autre (De l’esprit, I, IV). Non a caso, in “De l’esprit”, Helvétius si riferisce agli Stoici; quella tesi fa buon gioco alle sue esigenze teoretiche. Difatti, essa viene ripresa in “De l’homme”, ma senza riferimento al Deslandes. Qui si parla del “dogme de la fatalité”, comune ai popoli orientali, e proprio degli Stoici. Per questi ultimi ciò che chiamiamo “liberté”, ovvero “puissance de délibérer”, non è altro che un sentiment de crainte ou d’espérance che si prova quando si deve prendre un parti du choix duquel dépend son bonheur ou son malheur . La “délibération”, dunque, non è ‘libera’, bensì è sempre l’effet nécessaire de notre haine pour la douleur et de notre amour pour le plaisir (De l’homme, VII, I). Poco più avanti, ritornando sul tema, aggiunge che, per gli Stoici, en son état naturel l’uomo cherche le plaisir et fuit la douleur ; questa è la legge che regola il suo comportamento; perciò en toutes ses actions, il est necessairement déterminé par le desir d’un bonheur apparent ou réel. L’homme n’est donc pas libre . E infatti – dice Helvétius, mescolando, in una intenzionale equivocità, il suo discorso a quello degli Stoici – la sua volontà è necessariamente l’effet de ses idées, par conséquent de ses sensations , tanto quanto la douleur est l’effet d’un coup . Si dice che l’anima agisce in base ad una scelta, che è l’esito di una deliberazione, la quale a sua volta è l’espressione di una volizione. E allora, quando è libero, l’uomo? In nessuna di queste fasi! Perché l’anima non è libera in nessuna di queste sue operazioni. Ognuna è determinata dalla precedente, e la prima è determinata dall’amor di sé; dunque il est évident, que la liberté n’existe ni dans la volonté actuelle, ni dans la délibération actuelle, ni dans le choix actuel, ni dans l’action actuelle . Pertanto, si ha un bel parlare della libertà! L’ame est-elle libre, si quand elle veut, quand elle délibere, quand elle choisit, quand elle agit, elle n’est pas libre? (De l’homme, VII). Ma allora, che cos’è quella libertà che l’uomo tanto ammira ed ama? E a che cosa si allude quando si parla di quella libertà che, secondo i credenti, lo stesso Salvatore lascia all’individuo? (De l’esprit, II, XXIII). E inoltre, che cosa si vorrà intendere, quando si parla della libertà dei popoli e degli Stati? Per soffermarsi appena su quest’ultimo punto, lo stesso Helvétius ricorda che negli Stati repubblicani “l’amour de la liberté”, insieme con “la haine des Tyrans”, e “l’amour de la Patrie”, costituiscono si je l’ose dire, des points de ralliement pour l’estime publique (De l’esprit, II, XIX); e per certi popoli , come quello inglese, la libertà rappresenta addirittura un motivo di fierezza perché ritenuta fondamento di virtù civili: cette liberté … renferme réellement le germe de tant de vertus (De l’esprit, II, XXII) . Certo, l’illuminista spiega pure che la libertà degl’inglesi, appunto, est moins le prix de leur courage qu’un don du hazard . Anzi essa n’est point le fruit de leur sagesse ; infatti egli la pone in relazione alle condizioni geografiche: “Tout Anglois sensé” non potrà non riconoscere che c’est à la position physique de son Pays qu’il doit sa liberté ; e che la forme de son gouvernement ne pourroit subsister telle qu’elle est en terre ferme, sans être infiniment perfectionnée ; e, quindi, che l’unique et légitime sujet de son orgueil se réduit au bonheur d’être né insulaire plutôt qu’habitant du continent (De l’esprit, II, XXII). Ma proprio la relazione, posta da Helvétius, tra la libertà degl’inglesi e la loro insularità ci offre qualche varco per una più piena comprensione. Quanto alla ‘libertà’ degl’Inglesi, egli sembra parlarne come di una situazione di ‘non-condizionamento’, favorita, appunto, dall’isolamento fisico della loro patria dall’Europa continentale. Una considerazione, questa, perfettamente coerente con un’indicazione, in merito alla libertà, che l’illuminista stesso ha offerto in “De l’esprit”. Che cosa deve intendersi col termine “libertà”? Non ci si perda dietro astratti filosofemi; ci si tenga vincolati alla nozione ‘corrente’ di uomo libero. Ebbene, l’homme libre est l’homme qui n’est ni chargé de fers, ni détenu dans les prisons, ni intimidé, comme l’esclave, par la crainte des châtimens (De l’esprit, I, IV). In sintesi: se lo si prende dans une signification commune , quella più immediata e più facilmente comprensibile, il termine “libertà” non indica altro, appunto, che l’assenza di freni, di limiti coercitivi e di determinanti condizionamenti esteriori. Non a caso Helvétius fa l’elogio della condizione ‘selvaggia’ dell’uomo, in cui la libertà è ‘piena’. L’état du Sauvage è decisamente préférable à celui du Paysan . Infatti il selvaggio non ha da temere la prison, la surcharge des Impôts, la vexation d’un Seigneur, le pouvoir arbitraire d’un sub-délégué ; egli non è humilié et abruti par la présence journalière d’hommes plus riches et plus puissans que lui ; egli vive sans Supérieur, sans servitude: plus robuste que le paysan, parce qu’il est plus heureux, il jouit du bonheur de l’égalité, et sur-tout du bien inestimable de la liberté si inutilement réclamée par la plupart des Nations (De l’esprit, I, III). Tuttavia, questa, offerta da Helvétius, della libertà come assenza d’impedimenti, è, evidentemente, un’indicazione di tipo “negativo”. Si tratta di una ‘libertà da’. Poteva bastare l’idea che l’uomo e lo Stato siano da considerarsi liberi solo in virtù dell’assenza di fattori ostacolanti e di elementi coattivi? D’altra parte, delineando in termini hobbesiani il passaggio dell’umanità allo stato civile, egli non esita a ricordare che la libertà ‘naturale’, in quanto propria di ciascun individuo, espone ogni singolo uomo alla lotta contro tutti gli altri ed alla minaccia permanente per la propria vita, al punto che i selvaggi, las de vivre dans une crainte perpétuelle , si risolvono a fare entr’eux des conventions , acconsentendo à perdre un peu de cette liberté qu’ils ont dans l’état naturel, et qui leur est nuisible (De l’esprit, III, IX). La libertà ‘naturale’, dunque, non è tutto; o meglio, la libertà come assenza di impedimenti, non è tutta la libertà. L’illuminista, insomma, non poteva fermarsi a questo primo approdo. In ogni caso, come si vede, Helvétius sembra far riferimento, simultaneamente, alle concezioni hobbesiana e rousseauiana del ‘selvaggio’. Ben si comprende però che le due concezioni, che Helvétius in qualche modo accosta, sono fondamentalmente contraddittorie. L”uomo secondo natura’ di Hobbes vive in una condizione di permanente ‘infelicità’, teso spasmodicamente ad assicurarsi la sopravvivenza in un ambiente fisico implacabilmente ostile: obiettivo che riesce a raggiungere soltanto col passaggio allo stato civile; mentre il ‘buon selvaggio’ di Rousseau vive contento di sé in un contesto naturale propizio al suo armonico sviluppo, e scivola in una condizione d’infelicità solo col ‘pactum unionis’ fondativo della società. E allora? Nella visione di Helvétius, forse, le due concezioni s’intersecavano in un punto per lui molto rilevante. Sia nell’un caso che nell’altro, era da considerarsi ‘libero’ l’uomo la cui volontà non è sottoposta ad alcun impedimento esterno. Poco importava che tale libertà fosse per l’uomo hobbesiano una sorta di condanna e per quello rousseauiano un bene primario. L’importante, per l’illuminista, era che, nel punto d’intersezione, comune ad entrambe le concezioni, si poteva immaginare un uomo ‘naturale’ costretto, sì, a lottare per conservarsi all’esistenza, ma detentore di quella libertà che costituiva un privilegio da conservare anche nello stato civile, sia pure con le inevitabili limitazioni implicate dal ‘pactum unionis’. Così si spiega perché egli affermi, echeggiando Rousseau, che la libertà, di cui ha tanta considerazione, è completa solo nella condizione selvaggia, e parallelamente affermi, riprendendo argomenti di Hobbes, che l’uomo non può vivere una sua vita piena nella condizione naturale, abbisognando delle leggi per una corretta relazione con i suoi simili. 9. Si diceva che per Helvétius la libertà ‘naturale’ non poteva essere tutto, non poteva rappresentare tutta la libertà. E infatti c’è un passo, relativo agli Stati dispotici, che sembra allargare l’orizzonte dell’indagine. In queste Nazioni, alcuni vivono “dans la mollesse”, altri “languissent dans la misere”; a questi ultimi, pungolati costantemente dal bisogno — che richiede solo di essere soddisfatto, e che domina totalmente e radicalmente l’esistenza di ogni singolo individuo –, non è consentito di elevare ses regards jusqu’à la liberté (De l’esprit, I, III). Che vorrà dire, l’illuminista, con questa espressione? A prima vista essa sembra semplicemente ribadire la concezione ‘negativa’ della libertà: dal momento che lo stato di bisogno è una condizione limitante, chi languisce nella miseria si trova in situazione di servitù; e quindi, negli Stati che consentono che una parte di popolo sia afflitta da necessità primarie non c’è uguaglianza dei cittadini nella libertà. Ma forse l’espressione nasconde dell’altro. La libertà, a cui si fa accenno nel brano in questione, sembra essere qualcosa di più che la semplice assenza di limiti: quasi un modo di vivere. ‘Elevare lo sguardo fino alla libertà’ sembrerebbe un modo sintetico per dire: ‘elevare il pensiero ad un modo più pienamente umano di concepire la vita, d’intendere e di concretare i rapporti col mondo e con gli altri’. Insomma l’espressione alluderebbe all’aspetto ‘positivo’ della libertà. Forse non è inopportuno ribadire che Helvétius ha in grande considerazione la cultura inglese, e nutre una sincera ammirazione per Hobbes. Certo, lo cita molto meno che Locke, ma ben se ne comprendono le ragioni. Le tesi helvetiane erano già abbastanza difficili da ‘metabolizzare’, per la cultura francese del Settecento, e non era proprio il caso che l’illuminista si esponesse come preda poco accorta agli attacchi dei nemici, manifestando il debito culturale nei riguardi di Hobbes. Dunque Hobbes può risultare di una qualche utilità nell’approfondimento della concezione helvetiana della libertà. Per Hobbes non esiste l’assoluto arbitrio nella scelta: né nello stato di natura, perché il comportamento è necessariamente sottoposto ai desideri e alle avversioni a cui lo indirizza il ‘conatus’, né nello stato civile, in cui l’uomo non solo resta nel dominio dell'”amor di sé”, ma è sottoposto ai vincoli stabiliti col ‘pactum subiectionis’ originario della società civile. Aggiunge, comunque, che ha senso parlare della libertà dell’uomo, ma come in riferimento ai ‘corpi’, ossia in termini di assenza d’impedimenti al movimento; per cui l’uomo libero è colui che non trova impedimento a fare le cose che desidera fare, e che è capace di fare; pertanto necessità e libertà non collidono né si escludono vicendevolmente, anzi sono compatibili; e ogni atto umano va inteso come libero quando non è impedito nell’ordine della ‘divina’ catena delle cause, ossia quando la volontà, che in esso si attua, non trova ostacoli ad esprimersi nell’ordine necessario della realtà (“Liberty and necessity are consistent”, dice Hobbes, in Leviathan, II, XXI). Non può non colpire che la prima parte dell’indicazione helvetiana dell’uomo libero come l’homme qui n’est ni chargé de fers, ni détenu dans les prisons, ni intimidé, comme l’esclave, par la crainte des châtimens è di sapore chiaramente hobbesiano. Hobbes, infatti, parlando della libertà dei sudditi, dice proprio che il termine libertà, preso in senso rigoroso, non significa altro che freedom from chains and prison (Hobbes, Leviathan, II, XXI). Egli fa tale affermazione in un contesto che testimonia l’esigenza, fortemente avvertita, di abbandonare ogni tentazione di scantonare dal campo proprio del discorso filosofico. Parlando in modo appropriato – dice Hobbes – “Liberty, or freedom” non significa altro che the absence of opposition , intendendo per opposizione tutti gli external impediments of motion ; inoltre aggiunge che, di tutte le “living creatures”, finché they are imprisoned, or restrained with walls or chains , siamo soliti dire che they are not at liberty to move in such manner as without those external impediments they would (Hobbes, Leviathan, II, XXI). Dunque molto verosimilmente Hobbes potrebbe essere stato uno degli ispiratori della concezione ‘negativa’ che Helvétius ha della libertà. Ma si è detto che l’illuminista non poteva e neppure intendeva fermarsi alla ‘libertà da’. E allora, qual è la sua ‘libertà di’? C’è un luogo del “De l’esprit” in cui Helvétius sostiene che la “liberté de l’homme” – la libertà per l’individuo – è l’exercice libre de sa puissance . Sembra una definizione tautologica ma, a ben vedere, ancora una volta il discorso dell’illuminista sembra riecheggiare la posizione teoretica di Hobbes. Il quale, riferendosi non più agli impedimenti esterni, bensì a quelli sussistenti in the constitution of the thing itself , ricordando che, in tal caso, siamo soliti parlare non di mancanza di libertà, bensì di mancanza di power, to move , asserisce che l’uomo – in quelle cose che, by his strength and wit , egli is able to do – è libero quando is not hindered to do what he has a will to (Leviathan, II, XXI). Sicché l’helvetiano exercice libre de sa puissance non è altro che l’hobbesiana capacità di fare, senza esserne inibiti o ostacolati o arrestati, ciò che si vuol fare e che rientra nelle cose che si è capaci di fare con la propria forza ed il proprio ingegno. Liberty of the man consisteth in this, that he finds no stop in doing what he has the will, desire, or inclination to do , aggiunge Hobbes (Leviathan, II, XXI). Siamo dunque alla ‘libertà di’. L’espressione helvetiana, insomma, non solo non è tautologica, ma acquista spessore e pregnanza proprio se considerata alla luce del discorso hobbesiano. Essa dunque, a ben vedere, raccoglie in sé il duplice aspetto, quello positivo e quello negativo, del concetto di libertà. Per un verso, non si dà libertà se non, come si è visto, in condizione di assenza di impedimenti; l’uomo libero è l’uomo che agisce senza i ceppi di una qualsivoglia “schiavitù”. Tuttavia, questa è una condizione necessaria, ma non sufficiente. Una tale libertà sarebbe una forma senza contenuto. Detto in altri termini, l’uomo privo di vincoli non è ancora un uomo veramente libero, o almeno, non è libero in quanto ‘uomo’. Perché lo sia, si richiede ch’egli possa, anzitutto, esercitare il potere proprio della sua natura individuale; inoltre, ch’egli goda dell’effettiva e concreta facoltà di compiere tutto ciò ch’è nelle sue possibilità. Dunque non è da ascriversi a mancanza di libertà l’impossibilità di compiere azioni fuori delle concrete opportunità offerte dalla nostra natura di esseri umani, o al di là delle nostre effettive capacità, e fuori dei poteri connessi alle concrete condizioni di esistenza. Mentre invece è da ritenersi non libero colui che è impedito a fare ciò che è in diritto di fare, è capace di fare, vuole fare, ed è in condizione di fare. È lo stesso Helvétius che lo spiega: Je dis ‘de sa puissance’, parce qu’il seroit ridicule de prendre pour une non-liberté l’impuissance où nous sommes de percer la nûe comme l’Aigle, de vivre sous les Eaux comme la Baleine, et de nous faire Roi, Pape, ou Empereur (De l’esprit, I, IV). Questa definizione sembra all’illuminista la più adeguata alla concreta realtà. Peraltro essa ha valore anche per le società, i popoli, gli Stati. Un popolo è davvero libero quando, senza i ceppi della tirannia, può esercitare tutto il proprio potere, può dare espressione a tutte le sue capacità, può portare alla luce tutte le sue potenzialità, può esercitare tutte le sue virtù. Proprio come ogni singolo cittadino è libero allorché può esplicare le sue capacità, esprimere le sue attitudini, dare libero corso al suo pensiero e alla sua inventiva, senza subire costrizioni o impedimenti ad opera di un governo dispotico. La liberté , dunque, comme la santé est un bien dont communément l’on ne sent le prix qu’après l’avoir perdu (De l’homme, IX, II). Ma, a questo punto, siamo ben oltre Hobbes.
PASSI TRATTI DALLE OPERE
Helvétius, attento studioso delle opere di Newton e della filosofia di Locke, sostiene le capacità intellettuali e le convinzioni morali dell’uomo derivano esclusivamente dalle sensazioni: l’intero mondo che circonda un individuo deve essere considerato il suo “maestro” e concorre alla formazione della personalità. Visti i limiti dell’intelletto umano, che non può conoscere tutto ciò che ci circonda, la nostra formazione appare in gran parte determinata dall’ignoto e dal caso.
Se per educazione si intende semplicemente quella che si riceve negli stessi luoghi, e da parte degli stessi maestri, essa risulta allora la medesima per un’infinità di uomini. Ma se a questo termine si attribuisce un significato piú autentico e piú esteso, comprensivo di tutto quello che coopera alla nostra istruzione, si può dire che nessuno riceve la stessa educazione. Infatti ognuno ha per propri maestri, per cosí dire, la forma di governo sotto la quale vive, i suoi amici, le sue amanti, la gente da cui è circondato, le sue letture, e infine il caso – cioè un’infinità di avvenimenti di cui, per la nostra ignoranza, non siamo in grado di scorgere la concatenazione e le cause. Questo caso ha una parte assai maggiore di quella che si ritiene nella nostra educazione. Esso pone certi oggetti sotto i nostri occhi, ed è quindi occasione delle idee piú felici; talvolta esso ci conduce alle piú grandi scoperte. […] La maggior parte degli avvenimenti deriva da piccole cause: noi le ignoriamo poiché la maggior parte degli storici le hanno ignorate anch’essi, oppure perché essi non hanno avuto occhio per percepirle. é pur vero che, a questo proposito, lo spirito può riparare alle loro omissioni: la conoscenza di certi princípi supplisce facilmente alla conoscenza di certi fatti. Perciò – senza arrestarci piú a dimostrare la parte esercitata dal caso in questo mondo – si deve concludere che, se sotto il nome di educazione si comprende in generale tutto ciò che contribuisce alla nostra istruzione, anche il caso deve necessariamente rientrarvi. Nessuno si trova infatti nello stesso concorso di circostanze, e nessuno riceve precisamente la medesima educazione. (Sullo Spirito, III, I)
Helvétius prende in esame la dimensione sociale, collettiva della morale, perché la considera piú adatta per comprenderne meglio la natura e constata che anche la collettività, come l’individuo, considera moralmente valido solo ciò che è in sintonia con il proprio utile.
Occorre però considerare non soltanto la probità relativa ad un privato o ad una piccola società, ma la vera probità, vale a dire la probità in rapporto alla collettività. Questa specie di probità è la sola che realmente abbia un merito, e che ottenga generalmente tale nome. Soltanto considerando la probità da questo punto di vista possiamo formarci idee precise dell’onestà, e trovare una guida alla virtú. Sotto questo aspetto si può affermare che la collettività, al pari delle società particolari, è determinata nei suoi giudizi unicamente dal motivo del proprio interesse; essa attribuisce la qualifica di oneste, grandi o eroiche soltanto alle azioni che sono utili nei propri riguardi. Ed essa concede la propria stima ad una certa azione non già in rapporto al grado di forza, di coraggio o di generosità necessario per eseguirla, ma in proporzione all’importanza di tale azione e al vantaggio che ne ricava. (Sullo Spirito, II, XI)
REIMARUS

“Una fede ragionevole nella Rivelazione è una cosa del tutto impossibile”.
REIMARUS Nel 1774, Lessing pubblica un’opera a cui pone il titolo di Frammenti dell’Anonimo di Wolfenbüttel. Nel pubblicarla, Lessing precisa che si tratta di un’opera che non ha scritto lui e dalla quale anzi dissente profondamente: l’ha pubblicata semplicemente perché l’ha ritenuta utile per lo sviluppo del dibattito filosofico sulla religione. Quest’opera si presenta come una vera e propria bomba che esplode nel panorama filosofico tedesco del Settecento, scuotendone le fondamenta. Il suo vero autore era Hermann Samuel Reimarus (Amburgo 22/12/1694 – 1/3/1768): egli studiò teologia e filosofia a Jena, divenne docente presso l’università di Wittenberg nel 1716 e nel 1720 compì un viaggio che lo portò in Inghilterra e in Olanda. Nel 1727 divenne docente di linguistica ebraica ed orientale ad Amburgo, dove la sua casa si trasformò in un vero e proprio cenacolo di intellettuali. Reimarus si era già fatto conoscere scrivendo un trattato significativamente intitolato Trattato sulle principali verità della religione naturale, pubblicato nel 1754: al cuore di quest’opera vi è una critica serrata del miracolo, concepito spinozianamente come atto assurdo perché contraddittorio con l’idea di un Dio creatore di un mondo perfetto. L’ardita conclusione a cui Reimarus giungeva nello scritto era la messa in discussione del concetto stesso di Rivelazione, rigettando in tal modo ogni possibile conciliazione fra la religione naturale e quella rivelata. La religione rivelata dev’essere buttata a mare come inutile orpello dogmatico. Ma Reimarus si spinse anche più in là, scrivendo successivamente un’opera potente come dinamite, già a partire dal titolo: Apologia in difesa degli adoratori razionali di Dio. Rendendosi però conto della radicalità dei temi affrontati, Reimarus non volle pubblicare l’opera, che verrà data alle stampe solo nel 1774, allorché Lessing – come abbiamo visto – la proporrà come imprescindibile punto di riferimento per un dibattito filosofico sulla religione. Nell’Apologia in difesa degli adoratori razionali di Dio, Reimarus fa propri gli assunti del deismo e li porta alle estreme conseguenze, spingendosi ben più in là dei deisti francesi e inglesi. Se i deisti avevano generalmente accusato le religioni positive di oscurità e di incomprensibilità, ora Reimarus supera decisamente le Colonne d’Ercole e arriva a sostenere che le religioni positive, dalla prima all’ultima, sono false e menzognere, perché poggianti su una fantomatica Rivelazione. Se si intraprende un’analisi razionale intellettualmente onesta, non si può infatti che rilevare un’insanabile conflittualità tra la religione naturale, poggiante sulla ragione, e la religione rivelata, che invece si basa su una Rivelazione che non ha nulla a che vedere con la ragione (e che anzi la ostacola). Cristo stesso, che era solo un uomo perfetto, non aveva altro intento se non quello di liberare gli uomini su questa terra: la sua divinizzazione fu un indebito gesto degli Apostoli. Per capire la portata dello scritto di Reimarus, ne riportiamo qualche passaggio significativo:
Una fede ragionevole nella Rivelazione è una cosa del tutto impossibile per quella che è di gran lunga la parte maggiore del genere umano; giacché in primo luogo devono essere diffusi a tutti quanti gli uomini l’annuncio e le notizie fondamentali della Rivelazione, e tradotti in tutte le lingue del mondo; ciascuno deve essere giunto all’età in cui si è pienamente in grado di comprendere; deve concepire in precedenza il desiderio di sottoporre a esame tale Rivelazione, e non essere trattenuto dal far ciò da nessun pregiudizio o da nessuna forza esterna; deve avere il libro a portata di mano e poterlo leggere e, una volta letto, comprenderlo e spiegarlo, e trarne fuori una dottrina con il solo aiuto della propria intelligenza; quindi, dopo di questo, giudicarne imparzialmente della verità del racconto, delle dottrine e del carattere divino delle profezie e dei miracoli, cosicché ciascuno, anche se gli potessero essere date in mano tutte le notizie fondamentali, dovrebbe in piú possedere dal canto suo la conoscenza di molte lingue, delle antichità, della storia, della geografia, della cronologia, e inoltre riflessione, perizia nell’esegesi, conoscenze filosofiche e altre scienze, acume ed esercizio della ragione, rigore e libertà di pensiero. E tutto ciò se egli non vuole credere ciecamente, ma se vuole veramente sapere che cosa, e a chi, e perché egli crede; ciò che, tra un milione di appartenenti a tutto il genere umano, può essere richiesto appena a uno. […] Una fede nella Rivelazione che si fondi su sufficiente ricerca e convinzione, o che si accontenti di ciò che genitori e maestri, catechismo e Bibbia dicono: nell’uno e nell’altro caso è chiaro che una Rivelazione, che tutti gli uomini e ogni singolo possano e debbano accettare senza alcuna possibilità di giustificazione, è cosa totalmente impossibile. Nella sua sapienza e bontà Dio, se vuol rendere beati tutti quanti gli uomini, non può rendere mezzo necessario e unico per la beatitudine ciò che alla grande maggioranza di essi è impossibile ad attuarsi; ne consegue che la Rivelazione non deve essere necessaria, né l’uomo deve essere fatto per la Rivelazione. Rimane quindi una unica via per la quale una cosa possa veramente diventare universale: la lingua e il libro della natura, le opere di Dio e le tracce della perfezione divina che in essa si mostrano chiaramente come in uno specchio a tutti gli uomini, ai dotti come agli indotti, ai barbari come ai Greci, agli Ebrei come ai cristiani, in tutti i luoghi e in tutti i tempi. (Apologia in difesa degli adoratori razionali di Dio, III, 20)
CHRISTOPH MARTIN WIELAND

Christoph Martin Wieland nasce a Oberholzheim, in Svevia, nel 1733, figlio di un parroco protestante; riceve una severa educazione pietistica. Iniziò la carriera letteraria a Zurigo sotto la guida di Johann Bodmer (1752-1754). Dopo le prime opere di intonazione pietistica, è il suo distacco clamoroso dal pietismo, l’appassionata adesione all’illuminismo, con un gusto ironico e sensuale della vita e della letteratura che ne fa la figura principale del rococò tedesco. Tornato in Svevia, a Biberach (1760), diviene segretario di cancelleria. Nel 1769 è chiamato a insegnare filosofia all’Università di Erfurt. Chiamato nel 1772 a Weimar per occuparsi dell’educazione dei figli della duchessa Anna Amalia, è presto deluso da tale esperienza. Dopo l’arrivo di Goethe a corte, con le stesse funzioni, decide di dedicarsi esclusivamente all’attività letteraria. Nel 1773 fonda e dirige (fino al 1799) la rivista «Der Deutsche Merkur», che dominerà a lungo l’ambiente letterario tedesco, educando “la Germania meridionale a scrivere bene” (Goethe).
Nell’ultimo trentennio della sua vita, Wieland è considerato superato dai giovani scrittori, di cui non condivide né tendenze né esaltazioni. Visse sostanzialmente isolato, limitandosi a un notevolissimo impegno di traduttore (Senofonte, Luciano di Samosata, Orazio, l’intero epistolario di Cicerone). Muore a Weimar nel 1813. Opere giovanili e influenzate dal pietismo sono le Lettere di defunti a amici superstiti (Briefe von Verstorbenen an hinterlassene Freunde, 1753) e Sentimenti di un cristiano (Empfindungen eines Christen, 1757).
Al periodo biberachiano, dopo la conversione all’illuminismo, risale l’im-portante traduzione in prosa di 22 drammi di Shakespeare (1762-1766) che segna l’inizio della fortuna di Shakespeare in Germania. Scrisse intanto opere di tono licenzioso e mondano, raffinate e ironiche parodie, dense di allusioni al presente: Le avventure di don Sylvio von Rosalva (Die Abenteuer des don Sylvio von Rosalva, 1764) imitazione del “Don Qujote” di Cervantes. I quattro Racconti comici (Komische Erzählungen, 1765), imitazione dei dialoghi di Luciano. Agathon (1766), romanzo pedagogico che fornisce un programma basato sull’armonia tra ragione e sentimento, e che fu il modello per il bildungsroman, il romanzo di formazione spirituale.
A Erfurt, Wieland portò a termine un poema pseudo-cavalleresco, Il nuovo Amadis (Der neue Amadis, 1771). Scrisse un altro romanzo pedagogico ambientato in una cornice da “Mille e una notte”, Lo specchio d’oro (Der goldene Spiegel, 1772) in cui esprime la convinzione che nell’educazione dei regnanti consiste l’unica speranza di felicità per i popoli.
Al periodo weimeriano appartengono i suoi due capolavori. Gli Abderiti (Die Abderiten, 1774), che poi rielaborò in seconda edizione nel 1781, è un romanzo satirico: sotto il velo trasparente della Grecia classica Wieland punzecchia amabilmente la Germania contemporanea. Poema cavalleresco in ottave, in dodici canti, è Oberon (1780), che rifonde in modo originale la materia shakespeariana del “Sogno di una notte di mezza estate”, e motivi del ciclo carolingio francese, in una delicata storia d’amore e di avventure. Dal poema nel 1826 Carl Maria von Weber trasse un omonimo melodramma. Il sottotitolo del poema di Wieland è «poema eroico romantico»: in realtà, di eroico e di romantico, intesi nell’accezione odierna, non c’è molto. «Romantico» qui significa in senso settecentesco avventuroso-romanzesco, con ampio spazio per il meraviglioso e il fantastico. Oberon re delle fate e sua moglie Titania hanno un ruolo importante nella vicenda del “Sogno di una notte di mezza estate” shakespeareiana, mentre a “La tempesta” è ispirato l’episodio centrale del poema. Entrambi i drammi erano stati tradotti da Wieland in prosa e pubblicati poco dopo il 1760, dando un notevole contributo alla diffusione di queste opere nell’area culturale tedesca. L’uso dell’ottava deriva dalla tradizione del poema cavalleresco italiano. Ma il vero nucleo del poema, tratto dal romanzo cavalleresco “Huon de Bordeaux”, è l’amore tra il leggiadro paladino e la bellissima Rezia, figlia del califfo di Bagdad, che egli rapisce, converte alla fede cristiana e battezza con il nome di Amanda. Huon è uno dei paladini di Francia alla corte di Carlo Magno, ma le sue vittorie sono ottenute più dai suoi riccioli d’oro che dal suo braccio. Circondato da una foresta di lance, si salva grazie al provvidenziale intervento magico di Oberon, non disinteressato all’amore tra i due: infatti solo dalla vittoria sulla fragilità umana di due perfetti amanti, Oberon potrà essere liberato dal giuramento che lo costringe a fuggire la moglie Titania. “Oberon” è un intrattenimento offerto a una società ancora in gran parte cortigiana e aristocratica. Tutto il dramma è concentrato nella necessità di resistere, per ragioni esclusivamente sociali, alla tentazione di realizzare anzitempo un amore altrimenti perfetto: Huon e Amanda devono giurare a Oberon di non consumare le nozze prima della consacrazione del legame, ma cadono in tentazione: di qui anni di castissime tribolazioni. Wieland narra con bonaria ironia le prove degli amanti. La sua ironia rende godibili sia le avventure di giganti sconfitti e di sultani beffati, sia il contenuto serio dei sentimenti. Il suo è un atteggiamento che definiremmo oggi borghese. Non per niente l’invocazione iniziale alla Musa dice: «Vieni, accomodati con noi su questo sofà | e […] raccontaci con agio | come tutto sia accaduto […]».
PIETRO GIANNONE
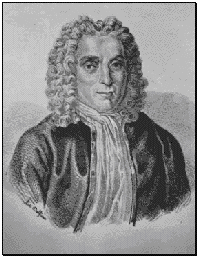
Nato ad Ischitella, vicino a Foggia, nel 1676, Pietro Giannone studia giurisprudenza a Napoli, manifestando anche interessi filosofici: conosce infatti le teorie di Cartesio, soprattutto attraverso la lettura di Malebranche, e quelle dei libertini, di Gassendi e di Locke. Costretto all’esilio a causa delle sue idee in materia religiosa, si reca prima a Vienna e in seguito a Ginevra, dove si converte al calvinismo. Attirato con un inganno in territorio piemontese, viene arrestato, e muore in carcere a Torino nel 1748.
Giannone deve la sua fama all’Istoria civile del Regno di Napoli, tradotta in inglese, francese e tedesco, e ammirata da intellettuali come Voltaire, Gibbon e Montesquieu. Sul piano filosofico, la sua opera più importante è invece il Triregno. Si possono ancora ricordare: I discorsi storici sopra gli Annali di Tito Livio, l’ Apologia dei teologi scolastici, l’ Istoria del pontificato di Gregorio Magno e l’ Ape ingegnosa.
Il tema fondamentale dell’ Istoria civile è costituito dalla lotta fra lo Stato e la Chiesa, ossia fra il Regno di Napoli e la Curia romana. L’opinione di Giannone a riguardo è drastica: l’unico a promuovere la civiltà ed il progresso è lo Stato, mentre la Chiesa coincide con il Male assoluto, ed è sempre causa di involuzione ed oscurantismo. Il cattolicesimo, nonostante finga di disprezzare la dimensione mondana, e si presenti come una religione portatrice di profondi valori etici, in realtà ha costruito e legittimato la propria esistenza soltanto su abusi, leggende ed inganni, mirando esclusivamente all’accumulo di ricchezze e potere; non a caso, tutte le istituzioni giuridiche dello Stato pontificio sono volte alla distruzione dell’ordine civile. Occorre quindi liberare l’autorità laica da ogni indebita ingerenza da parte della Chiesa.
Nel Triregno, Giannone espone una filosofia della storia, interpretando la religione come un fenomeno soggetto ad evoluzione. A suo parere, gli Ebrei conobbero soltanto un “regno terreno”, il cristianesimo propose l’ideale di un “regno celeste”, da raggiungere però dopo la resurrezione dei morti, mentre la Chiesa, a causa della sua avidità, ha fondato un “regno papale”. A tale proposito, Giannone scrive:
“…non solo i corpi, ma, quel che è più, anche le anime, i cuori e gli spiriti de’ sudditi si sottopose a’ suoi piedi e strinse fra ceppi e catene”.
Egli pensa che sia quindi necessario superare il male prodotto dallo Stato pontificio. Per fare ciò, e per attuare un concreto cambiamento, occorre esaminare la condizione umana attraverso lo studio della storia; grazie a quest’ultima, infatti, possiamo acquistare la piena consapevolezza di tutti i soprusi che gli uomini hanno subito da parte di altri uomini. Giannone auspica che lo Stato laico possa finalmente esprimere in pieno il suo potere, sottomettendo il Papato alla sua autorità, dopo aver tolto al clero tutti i beni. Occorre poi rilevare l’importanza che il filosofo attribuisce alla libertà: egli la intende come fondamento costitutivo di ogni etica giuridica e sociale, e ritiene che essa sia completamente negata dall’autoritarismo della Chiesa.
Particolare avversione contro le intromissioni delle autorità ecclesiastiche nelle questioni dello Stato è manifestata anche da tre giuristi come Francesco D’Andrea (1625-1698), Giuseppe Valletta (1636-1714) e Costantino Grimaldi (1667-1750), tutti seguaci di Cartesio.
ANTONIO GENOVESI

Nato nel 1713 a Castiglione, nel salernitano, Antonio Genovesi prende gli ordini religiosi nel 1737. Allievo di Giambattista Vico, insegna metafisica all’Università di Napoli a partire dal 1741; tredici anni più tardi diventa il primo titolare, in Europa, di una cattedra di “commercio e meccanica”. Muore a Napoli nel 1769.
A causa della pubblicazione degli Elementa metaphysicae mathematicum in modum adornata (1743-45), Genovesi è accusato di razionalismo e ateismo, perché l’opera risente dell’influenza di pensatori come Cartesio, Locke, Newton, Helvétius. Scrive anche il Discorso sopra il vero fine delle lettere e delle scienze, e affida le sue teorie di economia politica ai due volumi di Lezioni di commercio ossia di economia civile (1765-67), tradotti in spagnolo e tedesco. Compone anche una Logica (1766), che ottiene un notevole successo, ed un trattato di etica dal titolo Diceosina ossia filosofia del giusto e dell’onesto, uscito postumo nel 1776.
Genovesi rifiuta, in generale, l’atteggiamento antireligioso tipico degli illuministi, anche se difende ed auspica la distinzione tra potere civile e potere ecclesiastico. A suo parere, la Chiesa è infallibile soltanto in materia di fede; tuttavia, egli afferma che non si può “sbandire la divinità e la religione” perché, in un certo senso, “tutta la natura la vuole”.
Dopo aver dedicato i suoi studi a problemi metafisici e retorici, Genovesi inizia ad interessarsi di economia e di etica, soprattutto perché giunge alla convinzione dell’inutilità di tante ricerche accademiche, completamente avulse dai problemi concreti della realtà. La riflessione di Genovesi sull’economia è infatti orientata ad affrontare e superare la piaga dell’arretratezza. Egli ritiene che, per favorire il benessere e l’aumento dei consumi, sia necessario promuovere in ogni modo la cultura e la civiltà, ed è convinto che tutti i progressi vadano di pari passo con l’autonomia della ragione e con l’affermazione della libertà.
Genovesi pensa che anche i contadini e le donne abbiano diritto a un po’ di cultura, perché questa costituisce un mezzo indispensabile per realizzare l’ordine e l’economia nelle famiglie, e per lo sviluppo della civiltà in generale. Egli si preoccupa poi di esortare gli intellettuali ad approfondire “la cultura delle cose”, magari interessandosi di meccanica e di agraria, ed evitando di perdersi in vuote parole oppure in vane speculazioni metafisiche, che non possono condurre a risolvere i problemi concreti della società.
Genovesi attribuisce una notevole rilevanza al ruolo svolto dall’educazione nella formazione degli uomini; proprio per questo, ritiene fondamentale lo sviluppo delle scienze e delle arti, in aperta polemica con Rousseau, per il quale il cosiddetto “progresso” costituisce la fonte di tutti i mali che affliggono gli uomini. Genovesi esalta anche l’importanza del lavoro per il bene dei singoli e della società, denunciando la presenza di un numero eccessivo di proprietari assenteisti, di persone che vivono esclusivamente di rendita, di ecclesiastici, di medici e di avvocati; a suo parere, occorre invece aiutare concretamente coloro che lavorano e producono. Affronta poi molte altre questioni importanti, fra cui, ad esempio, i problemi del credito pubblico, dell’inflazione e della circolazione monetaria.
Per quanto riguarda la sua riflessione in materia morale, egli, ispirandosi alle dottrine utilitaristiche, tenta di conciliare l’etica con gli inevitabili mutamenti sociali prodotti dal progresso economico, tenendo anche conto delle conseguenze che comporta la diffusione del lusso.
ANTHONY COLLINS

A cura di Gigliana Maestri e Diego Fusaro
“Se agli uomini sono imposte limitazioni nel pensare su una scienza o su una parte di una scienza, devono essere ignoranti in proporzione a questa limitazione. E se poche persone si prendono talvolta un po’ di libertà e infrangono la costrizione stabilita, le loro riflessioni non saranno mai così perfette come sarebbero se tutti gli uomini fossero lasciati liberi e incoraggiati a pensare su tale materia” (Discorso sul libero pensiero).
COLLINS
Nato a Heston nel 1676, Anthony Collins, discepolo di Locke, pubblica una serie di opere destinate a suscitare aspre polemiche, e a causa delle quali è costretto a rifugiarsi, per un certo periodo, in Olanda. Il Saggio sull’uso della ragione risale al 1707, mentre il Discorso sul libero pensiero al 1713; scrive anche la Ricerca filosofica sulla libertà umana (1717), e il Discorso sui fondamenti e le ragioni della religione cristiana (1724). Collins muore a Londra nel 1729.
Sostenitore del deismo, egli ritiene che il libero pensiero consista nell’esaminare ogni teoria oppure ogni proposizione senza alcun preconcetto, e senza fare mai riferimento a presunti principi d’autorità. L’obiettivo che Collins si propone è duplice: da un lato, egli intende illustrare i caratteri e la necessità del libero pensiero, che appare indispensabile per l’avanzamento del sapere umano; da un altro lato, egli intende difendere i liberi pensatori dall’accusa, mossa dagli avversari, di essere corruttori dei costumi e della religione, oltre che destabilizzatori dell’ordine sociale. Scrive Collins:
“Per libero pensare intendo l’uso dell’intelletto nello sforzarsi di trovare il significato di qualsiasi proposizione, nel considerare la natura dell’evidenza a favore di essa o contro di essa, e nel giudicarla conformemente alla forza o debolezza di evidenza che essa mostra”.
Questa definizione implica il totale rifiuto di dottrine e opinioni contrarie ai dettami della ragione. Secondo Collins, anche le teorie e le credenze tipiche delle fedi religiose, spesso assurde e in contrasto con i più elementari principi razionali, devono essere sottoposte a indagine critica. In questo senso, egli non ha scrupoli nell’elencare quelle idee che ritiene prive di fondamento, come, ad esempio, il potere concesso ai preti di condannare o di salvare, l’adorazione di santi e reliquie, l’infallibilità di certe persone o dei concili. Pertanto, la critica che Collins muove (risentendo probabilmente dell’influenza di Pierre Bayle) all’infondatezza di molte tradizioni religiose assume anche una valenza politica, giacché entra inevitabilmente in polemica con le forme di potere, specialmente quello ecclesiastico, responsabili della mistificazione e dell’oscurantismo. Secondo il filosofo inglese, gli uomini credono a simili assurdità perché pastori protestanti e preti cattolici hanno impedito l’affermazione del libero pensiero, pretendendo così la rinuncia all’uso della ragione, che invece costituisce un dono da parte della divinità. Contro l’oscurantismo operato dalla religione, Collins afferma che, in realtà, per distinguere il vero dal falso, non esiste altro mezzo se non ricorrere alla razionalità, il cui esercizio è voluto da Dio stesso. Scrive l’autore a questo riguardo:
“Se gli uomini o trascurano di pensare, o giungono una volta ad esser persuasi che non hanno diritto a pensare liberamente, essi non solo non possono ottenere alcuna perfezione nelle scienze, ma devono, se vogliono avere delle opinioni, incorrere nelle più grandi assurdità immaginabili sia in teoria che in pratica. Quante assurde nozioni della divinità sono prevalse un tempo, non solo presso i pagani, ma anche presso i cristiani!”.
Collins sostiene che l’esame critico delle fedi religiose costituisce addirittura un vantaggio per le religioni stesse. Infatti, chi abbraccia una qualsiasi confessione, senza alcuna riflessione razionale e soltanto sottomettendosi ad un principio d’autorità, dimostra di essere disposto ad accettare anche un’altra fede, qualora essa gli sia proposta sempre da un’autorità. Il filosofo si rivela poi fortemente critico a proposito delle profezie e dei miracoli, considerati o falsità oppure allegorie: ad esempio, la resurrezione di Cristo è concepita come un’invenzione dei suoi discepoli. Eliminando la credenza nei miracoli e nelle profezie, non si offende la religione, ma anzi la si libera dalla superstizione e la si innalza a una nuova e più alta purezza.
Nella Ricerca filosofica, Collins attribuisce all’uomo una “necessità morale”. Partendo dal fatto che gli esseri umani possiedono intelligenza e sensibilità, egli giunge ad affermare che essi sono determinati ad agire dalla ragione e dai sensi. Tuttavia, ciò non implica una mancanza di libertà: l’uomo non è soggetto ad una necessità “assoluta”, meccanica e fisica, perché questo genere di necessità riguarda solo gli oggetti privi di sensazione e di intelligenza (si pensi, per esempio, agli orologi). Secondo Collins, un simile determinismo psicologico non è contrario alla morale, ma ha il pregio di mostrare come le azioni umane siano guidate da moventi razionali, e, in tal senso, può costituire un mezzo per “salvare” la morale stessa, che altrimenti ricadrebbe nell’arbitrio incontrollabile.
Collins viene duramente attaccato da Richard Bentley (1662-1742), che lo accusa d’incapacità nell’indagine biblica a causa di una scarsa padronanza della filologia. Al contrario, Thomas Woolston, estimatore e seguace di Collins, riprende i temi della sua critica in materia religiosa nei Sei discorsi sui miracoli. Costretto al pagamento di una multa e a scontare un anno di prigione, Woolston muore in carcere nel 1733.
FILIPPO BUONARROTI

La giovinezza, le esperienze di Corsica ed Oneglia
F. BUONARROTI
Tra i primi in Italia ad accettare i nuovi principi proclamati e posti in essere dalla Rivoluzione Francese fu Filippo Buonarroti.
Egli nacque a Pisa l’11 novembre 1761 da una famiglia appartenente al ramo Buonarroti-Simoni, un ramo collaterale dei Buonarroti cui era appartenuto Michelangelo.
Come ha ben rilevato il Cantimori , il periodo toscano fu molto importante per la formazione ideologica del Buonarroti [1]: infatti è negli anni della prima giovinezza e dell’Università di Pisa che il Buonarroti iniziò ad avviarsi verso positure politicamente radicali.
I professori pisani Sarti e Lampredi gli fecero conoscere gli autori illuministi e fra questi egli prediligeva Rousseau, Helvetius, Mably e Morelly, vale a dire quelli che avevano una maggiore carica innovatrice.
Tali scrittori avvicinarono il Buonarroti a posizioni egualitaristiche e talvolta addirittura comunistiche [2]: ovviamente egli ancora non pensava a trasporre quelle concezioni dal piano ideologico-culturale a quello politico-sociale (la sollecitazione definitiva a ciò gli giungerà dalle esperienze che farà in seguito, soprattutto da quelle rivoluzionarie). Inoltre è probabile che già dal 1787 il Buonarroti fosse entrato nella massoneria e che da tale ambiente avesse recepito qualche influsso; ma la sua cultura si fondò soprattutto sugli autori sovracitati, tanto che il suo sistema di pensiero venne costruito sulle tematiche proposte da essi: insomma il Buonarroti, nel periodo toscano, acquisì quel bagaglio culturale che lo spronerà all’azione rivoluzionaria e sarà un suo tratto distintivo all’ interno del mondo degli stessi rivoluzionari.
Allo scoppio della Rivoluzione Francese, il Buonarroti lasciò la Toscana e si trasferì in Corsica per abbracciare la causa rivoluzionaria; la Corsica gli appariva non solo come la terra delle lotte del Paoli, ma anche come l’isola che aveva suscitato l’ammirazione di uno dei suoi numi tutelari, il Rousseau, il quale scorgeva in essa e nel suo popolo libertà, innocenza, temperanza. Infatti, alla fine del Settecento, tale regione presentava un assetto economico precapitalistico, con proprietà terriere estremamente suddivise ed equamente ripartite, cosicché la maggioranza degli isolani aveva, seppur ridotto, un appezzamento di terra. L’assenza di capitali, la primitività dei metodi produttivi, lo sminuzzamento dei fondi, la sobrietà dei costumi: questi erano gli elementi che caratterizzavano l’ ambiente còrso di allora: “non si avevano quasi tracce di grandi trasformazioni agricole; nel regime agrario dell’ isola era evidente la relativa eguaglianza dei possessi fondiari, data l’enorme diffusione di queste minuscole proprietà”.
Per Buonarroti, imbevuto com’era di teorie egualitarie settecentesche, l’isola aveva dunque un valore esemplare, costituiva, con il suo egualitarismo già abbozzato, un terreno propizio per una azione politica: “l’astratto, utopistico modello dell’eguaglianza dei beni, desunto dai tradizionali archetipi delle repubbliche dell’antichità, diventa così, per questo rivoluzionario, un fine concreto da raggiungere, al quale la Corsica è incomparabilmente più vicina d’altri paesi”.
In Corsica, Buonarroti ricoprì degli incarichi presso il Consiglio generale di Corte e fu membro della Società degli Amici della costituzione e della società degli Amici del popolo; inoltre insegnò diritto pubblico in un liceo e pubblicò il settimanale “Giornale patriottico della Corsica”, il primo periodico rivoluzionario scritto in italiano, il cui “Discorso preliminare” è interessante in quanto contiene alcuni motivi tipici del pensiero buonarrotiano quali l’affermazione di una società agricola egualitaria e della religione naturale, la condanna del commercio e della industria, l’esaltazione del principio rousseauiano della volontà generale come indiscutibile fondamento della comunità politica.
L’esperienza della Corsica è molto importante perché è indice sia della presa di coscienza, da parte del Buonarroti, della necessità di adottare misure non solo politiche ma anche economiche e sociali per la realizzazione di una società più equa, sia del suo iniziale egualitarismo che, col passare del tempo, si consoliderà sempre di più ed approderà anche a convinzioni comunistiche. La comprensione del Buonarroti della congiura degli Eguali passa attraverso l’esperienza còrsa: “fu la realtà dell’isola a fargli sentire l’attualità concreta, programmatica di quelle che fino ad allora erano state generiche posizioni illuministiche. La questione còrsa nel Settecento, prima di essere politica, era economica e sociale…questo…spiega l’evoluzione del pensiero buonarrotiano”.
Inoltre non bisogna dimenticare che in questo periodo prende rilievo un altro tratto caratteristico del Buonarroti: l’importanza della educazione. Egli già caldeggiava l’idea di una educazione comune da affidarsi allo stato, alla nazione, affiancata da una attività di propaganda, svolta da filosofi e virtuosi, finalizzata alla diffusione dei buoni princìpi quali la libertà, l’eguaglianza, la fraternità, l’amore della patria. Tuttavia, la questione non doveva risolversi come un aspetto meramente tecnico di pubblica istruzione, ma doveva essere inscindibilmente connessa con una generale riforma dei costumi e delle istituzioni, cioè doveva essere una parte integrante di un’unica, grande rigenerazione umana. Le utopie settecentesche dovevano farsi realtà.
All’esperienza còrsa segue il primo viaggio del Buonarroti a Parigi: egli, infatti, nella rottura avvenuta tra il Paoli e la Convenzione, si schierò dalla parte della Convenzione e accusò il Paoli di tradimento nell’opuscolo La conjuration de Corse.
Nella capitale francese, il Buonarroti, dopo aver chiesto e ottenuto la cittadinanza francese, frequentò il club dei giacobini e conobbe Robespierre: il robespierrismo attecchì nella sua personalità e, per vari aspetti, orientò le linee delle sue convinzioni politico-sociali. In Robespierre, il Buonarroti vedeva un alfiere della battaglia per l’eguaglianza, ed aderì alla sua politica proprio perché la considerava fondata sulla decisa rivendicazione di eguaglianza sociale. Egli, come Robespierre e altri rivoluzionari, scorgeva nei violenti contrasti sociali di allora una lotta sociale di classe, una guerra tra il ricco ed il povero, tra l’opulento e l’indigente; gli eventi rivoluzionari svolsero una funzione propulsiva per la radicalizzazione dei suoi princìpi democratici e per il suo parteggiare per la creazione di sistemi politico-sociali eversivamente innovatori: il Buonarroti e gli altri rivoluzionari pensavano che era il momento di porre in essere una politica coraggiosa e vigorosa, di svolgere fattualmente i postulati teorici degli autori settecenteschi. In sostanza, c’era la netta e nitida convinzione dell’affermazione di un estremo egualitarismo e della realizzazione di istanze non ancora comunistiche, ma molto simili e vicine ad esse. Questo, che Galante Garrone ha definito “trapasso ideologico e pratico”, lo si evince chiaramente nell’esperienza di Oneglia, città ligure conquistata dai Francesi ed in cui il Buonarroti venne nominato commissario rivoluzionario nell’aprile 1794.
Egli lavorò subito al sistema amministrativo dividendo il territorio in distretti e ponendovi a capo degli agenti rivoluzionari, con funzione di polizia e di esecuzione degli ordini amministrativi, assistiti, ovviamente, da ufficiali segretari. In campo economico, il Buonarroti dovette conciliare l’aiuto ai bisognosi con le esigenze belliche dei Francesi: infatti, tutti i territori da essi conquistati dovevano, in qualche modo, contribuire al sostentamento dell’esercito. Comunque, il Buonarroti prese delle misure che hanno un chiaro e netto significato sociale: imposizioni ai ricchi, distribuzione a buon prezzo del grano ai poveri, censimento dei ricchi e delle loro rendite nonché degli indigenti da soccorre, vendita dei beni mobili ed immobili di coloro che avessero osteggiato la repubblica, applicazione del maximum dei prezzi per non rovinare le risorse del paese, lotta contro i falsi assegnati, ecc.; tutto ciò era un riverbero dell’istanza giacobina di alleviare le condizioni dei derelitti, di sfamare i miseri.
Grande importanza, come nell’esperienza còrsa, fu data dal Buonarroti all’educazione. Vennero istituiti Comitati di Istruzione e scuole primarie e secondarie per una formazione gratuita, popolare, laica e democratica. Se per quanto concerne la scuola primaria il Buonarroti aveva un precedente nella legge Bouquier, per la scuola secondaria non aveva un modello cui rifarsi: è proprio per questo che il decreto buonarrotiano del 25 brumaio (15 novembre) che istituì, oltre all’insegnamento primario, quello secondario, rappresenta un consistente passo in avanti rispetto alla situazione dell’istruzione francese. Interessante è notare che il Buonarroti, per questa scuola, richiese delle opere tra le quali figuravano quelle del Rousseau, del Mably, del Condillac: ulteriore dimostrazione, se ancora ve ne fosse bisogno, che quegli scrittori settecenteschi avevano formato ideologicamente il Buonarroti e ne continuavano ad orientarne il pensiero; l’azione buonarrotiana sarà sempre audacemente tesa ad approssimarsi il più possibile ai princìpi di quegli autori. Non è poi da trascurare il fatto che il Buonarroti provvide a delle pubblicazioni presso due tipografie.
Ad Oneglia vennero istituiti Comitati di Sorveglianza ed un Tribunale rivoluzionario per combattere i nemici della rivoluzione e della repubblica, e le decadarie che, pur nell’affermazione di rispetto della libertà di culto, si cercava di supportare. Inoltre la politica svolta dal Buonarroti ad Oneglia va ricordata anche per l’aspetto italiano: infatti nel suo quadro di riscatto dell’umanità in termini rousseauiano-robespierristici, trovava posto anche l’amore per la patria che lo porterà a ricoprire un ruolo di notevole importanza nel Risorgimento italiano. Grazie al Buonarroti, la vallata di Oneglia fu un centro di raccolta di profughi politici italiani, che vennero utilizzati, insieme ad alcuni Còrsi, nell’amministrazione e nell’istruzione locale; Oneglia, in sostanza, fu un primo crogiuolo del sentimento unitario italiano.
Al sopraggiungere del 9 termidoro dell’anno II (27 luglio 1794) il Buonarroti era, dunque, in piena attività politico-sociale. La reazione termidoriana pose fine alla dittatura ed alla vita di Maximilien Robespierre e si scatenò contro i suoi più stretti collaboratori e i clubs giacobini: la rivoluzione era stata ricondotta su binari borghesi. Nonostante ciò, non ci fu l’automatica ed immediata cessazione del governo buonarrotiano ad Oneglia, che, anzi, continuò per un po’ più di sette mesi. Infatti il Buonarroti, sebbene fosse giacobino ed avesse ricevuto quell’incarico dalle autorità giacobine, non era ritenuto un personaggio particolarmente pericoloso per il corso degli eventi della realtà francese di allora. “La sua azione era rimasta provinciale…si era fatto strada da sé, non aveva ambizioni, se non quella di servire la causa rivoluzionaria”: tale doveva apparire il Buonarroti ai termidoriani, cioè uno dei tanti agenti disseminati al di là dei confini, un piccolo elemento di un grande ingranaggio. In realtà “non era neppure prevedibile quanto sarebbe stato pericoloso trasferirlo a Parigi, sia pure in stato d’arresto. Chi poteva immaginare che proprio l’italiano Commissario di Oneglia raccogliendo l’eredità ideale di Massimiliano Robespierre, ne avrebbe fatto una leva per il risorgimento delle forze sociali e politiche…?”.
Il Buonarroti, quindi, continuò lo stesso indirizzo egualitario, rinvigorendo la propaganda ed adoperandosi, in particolare, per una determinata azione antifeudale: decretò, infatti, la confisca del feudo di Balestrino appartenente al marchese Del Carretto, cittadino genovese. Ciò fornì ai termidoriani parigini il pretesto per sbarazzarsi del Buonarroti che, già il 6 dicembre 1794, consapevole dello iato politico tra lui e le autorità termidorine, aveva rassegnato le proprie dimissioni: il Comitato di sorveglianza, il 4 marzo 1795, ne dispose l’arresto e, così, il toscano venne tradotto a Parigi e rinchiuso nella prigione del Plessis, ricevendo, soltanto il 29 giugno 1795, la motivazione del suo arresto, avvenuto in quanto partigiano della politica robespierristica e sospettato di aver rappresentato una minaccia per persone e proprietà di Genova e della Svizzera.
Tutto ciò dimostra come il Buonarroti fosse un convinto sostenitore del purismo giacobino, ritenesse giustissime e validissime le convinzioni politiche, morali e sociali di Robespierre il quale, quindi, era per lui il politico della virtù: questo assume maggior rilievo di significatività se si pensa che una figura come quella del Babeuf, detto Gracco, per un certo periodo di tempo, pur riconoscendo la pregnanza politica e sociale dell’azione robespierristica, si schierò apertamente dalla parte dei termidoriani.
L’importante esperienza politica di Oneglia era terminata: in un paese militarmente occupato, economicamente dissestato dalla guerra e fra popolazioni ostili, l’azione di governo del Buonarroti fu sempre caratterizzata dal costante rifarsi a princìpi egualitari, dalla continua volontà di migliorare le condizioni di chi viveva nella miseria.
Nel Plessis il Buonarroti incontrerà il Babeuf, ed insieme diventeranno il binomio portante della congiura degli Eguali.
2. La congiura degli Eguali
In carcere, il Buonarroti meditò sul corso della rivoluzione, sulla struttura dei gruppi politici che si erano affrontati per egemonizzare lo stesso movimento rivoluzionario, sul rapporto di questi gruppi politici con le masse popolari delle città e delle campagne, sulle cause del fallimento del regime giacobino e sul susseguente riflusso reazionario; è proprio sulla base di questa riflessione politica che egli arrivò alla convinzione che la rivoluzione dovesse essere conclusa con l’instaurazione di un sistema egualitaristico e comunistico, all’idea della creazione di una società egualitaria fondata sul comunismo: quindi il Buonarroti era passato da una posizione giacobino-robespierristica ad una comunistico-egualitaria, si era reso conto che per lavorare alla causa del mondo bisognava abolire la proprietà privata, generatrice della divisione tra ricchi e poveri, detentori del potere e governati sfruttati.
Inoltre, in carcere Buonarroti conobbe Babeuf, Bodson, Debon ed i seguaci del Robespierre perseguitati dalla reazione termidoriana, con i quali interloquiva appassionatamente su tematiche politico-rivoluzionarie, tanto che il Plessis divenne un focolaio di cospirazione. Ma le linee del pensiero buonarrotiano erano comunistiche già prima dell’incontro con il Babeuf, la struttura comunistica della riflessione buonarrotiana si era già solidamente articolata in modo autonomo rispetto a quello del Babeuf: in sostanza, Buonarroti e Babeuf erano approdati, indipendentemente l’uno dall’altro, a posizioni comunistiche prima che le loro convinzioni ideologiche confluissero e produssero la vicenda degli Eguali.
Babeuf ebbe una giovinezza caratterizzata da bisogni economici: l’indigenza dei contadini piccardi in mezzo ai quali viveva dovette avergli fatto anelare ancor di più quelle utopie egualitarie e comunistiche tratteggiate da Rousseau, Mably e Morelly. Infatti il Babeuf, come il Buonarroti, era convinto che i principi formulati da quegli scrittori settecenteschi dovesse costituire il fondamento di una nuova società: “ …tutte le ampollose citazioni storiche e filosofiche di cui infarcisce la sua prosa…non dissimulano la sorgente di esperienza viva, di osservazione della realtà sociale, da cui trae le sue appassionate affermazioni ”. Il pensiero di Babeuf, all’origine, non è, ovviamente, comunistico: egli, infatti, caldeggiava, nel 1797, una legge agraria che ridistribuisse i terreni in modo egualitario e, legge agraria, secondo lui, equivaleva ad eguaglianza di fatto. Tale idea, pur contenendo potenziali sviluppi comunistici, non era ancora improntata ad un vero e proprio comunismo, bensì ad un egualitarismo. Anche nel 1792 e nel 1793 la riflessione del Babeuf non giunge a convinzioni comunistiche, nonostante che si radicalizzò sempre di più sotto la spinta degli eventi rivoluzionari: insomma, postulazioni egualitarie ma non già comunistiche.
La fine dell’esperienza robespierristica fu, da lui considerata come un evento politicamente non sfavorevole: Robespierre, che pure nel 1791 gli era sembrato un politico consapevolmente orientato verso la legge agraria, aveva instaurato una tirannide, e la conclusione di questa avrebbe, nelle sue speranze, portato ad un governo regolare capace di garantire a tutti la libertà. Per questo, Babeuf si schierò tra i termidoriani seppur di sinistra: ma ben presto, di fronte al perdurare della miseria dei lavoratori ed alla abolizione termidoriana del maximum e di tutte quelle leggi con cui i Montagnardi avevano cercato di arginare l’ingordigia borghese per una maggiore equità sociale, il Babeuf ritornò sui suoi passi: si era accorto che la reazione termidoriana non aveva costituito il preludio al regno della libertà, bensì l’instaurazione di un regime schiettamente borghese; iniziò, allora, da parte del Babeuf, il riavvicinarsi alla politica robespierristica, distinguendo nell’incorruttibile due uomini, uno tiranno, l’altro paladino dell’aiuto ai bisognosi: la piega assunta dagli avvenimenti rivoluzionari gli fece abbandonare le sue ultime prevenzioni nei confronti del Robespierre, tanto che ne diventò un sempre più caldo e convinto ammiratore. Il Babeuf, poi, non si limitò ad aderire agli orientamenti politici robespierristici, ma, capì che bisognava andare oltre il compromesso giacobino tendente ad allearsi con le masse popolari rispettando la proprietà: l’evoluzione del pensiero del Babeuf, proprio come la riflessione buonarrotiana, avvenne in senso comunistico, si trattò, cioè, per loro, di elaborare comunisticamente il robespierrismo, di considerare gli indirizzi robespierristici come base per una radicale rivoluzione politico-sociale volta ad una fondazione comunista. In definitiva, la riflessione del Babeuf, così come quella del Buonarroti, è un avvicinarsi ad asserzioni comunistiche.
Da ciò si evince che quando il Buonarroti ed il Babeuf si incontrarono al Plessis, il loro assetto ideologico era sostanzialmente comunistico, prevedeva l’abolizione della proprietà privata e la comunità dei beni; e si ricava anche come ben si intendessero i due.
Babeuf e Buonarroti si influenzarono reciprocamente: il vigoroso e focoso temperamento del primo, come ha ben detto il Cantimori, rinfocolò ulteriormente, come se ve ne fosse bisogno, la voglia del secondo di lottare per una società comunista, mentre il Buonarroti sottolineò al francese l’importanza di rivestire i suoi scritti con citazioni dottrinali illuministiche, in modo da presentarsi, così, come continuatore degli autori settecenteschi.
Dopo le violente repressioni termidoriane delle insurrezioni democratico-popolari dell’aprile-maggio 1795 e della rivolta realista del 5 ottobre dello stesso anno, il Direttorio non volle rompere del tutto con le forze di sinistra e, pertanto, concesse la libertà ai democratici che si trovavano in prigione; tra gli amnistiati figurarono il Buonarroti, il Babeuf, il Darthé e molti altri che sarebbero stati i protagonisti della congiura degli Eguali. Tale momentanea “distensione” nei rapporti con il Direttorio permise anche l’apertura, a Parigi, della società popolare del Panthéon, che proprio grazie al Buonarroti, che la presiedette varie volte, si trasformò ben presto in un centro di opposizione alla politica termidoriana.
È in questo periodo, tra l’altro, che il Buonarroti pubblicò un opuscolo su come porre fine alla guerra vandeana, a noi non giunto, ed un altro, anonimo, La paix perpétuelle avec les Rois, in cui sosteneva la formazione di repubbliche sorelle intorno alla Francia, fondate anch’esse sui princìpi rivoluzionari. Oltre che nel Pantheon, che venne sciolto per ordine del Direttorio, e tale ordine venne eseguito dal Bonaparte, l’attività di lotta politica del Buonarroti si esplicava anche in un altro comitato segreto, costellato di idee di comunione dei beni e lavori e finalizzato ad una insurrezione contro il regime direttoriale, di cui però non faceva parte il Babeuf, che militava in un altro gruppo di azione politica comunque con gli stessi scopi; in un secondo tempo, il 30 marzo 1796, si arrivò alla fusione di questi due gruppi in un unico comitato direttivo segreto, che venne detto “Direttorio segreto di salute pubblica”, in cui, oltre ovviamente ai nomi del Buonarroti e del Babeuf, spiccavano quelli di Darthé, Debon, Antonelle, ecc. .
È utile affermare, inoltre, che il Buonarroti, contemporaneamente all’organizzazione dell’insurrezione degli Eguali, si dedicò anche all’azione italiana: già nel periodo di Oneglia, come si è detto sopra, egli era stato il punto di riferimento per i patrioti italiani; ora teneva contatti con i patrioti italiani esuli a Parigi e con il nucleo patriottico di Nizza per elaborare un piano rivoluzionario ed unitario dell’Italia. Il Buonarroti, si fece interprete del giacobinismo italiano, e, nonostante che non fosse assolutamente un filotermidoriano, pose all’attenzione del ministro degli Esteri Delacroix un progetto politico di rivoluzione nazionale italiana, da inquadrarsi in una rivoluzione europea scaturente da quella francese.
Nell’organizzazione della congiura degli Eguali, pur essendo il Babeuf un primus inter pares, una figura preminente, vigeva un’atmosfera democratica: tutte le decisioni erano prese in base al principio di maggioranza, la responsabilità di esse era collegiale ed i compiti venivano ripartiti. Ci fu una strettissima collaborazione tra il Babeuf ed il Buonarroti, come dimostra il fatto che, per la redazione dell’Atto insurrezionale, il rivoluzionario francese chiese consigli a quello toscano, che li fornì, tanto che, in tale documento, di cui erano stati stampati migliaia di esemplari al momento dell’arresto, sembra di rintracciare lo stile armonico e equilibrato del Buonarroti, la sua puntualità composta e generosa di considerazioni.
Il Buonarroti aveva il compito di elaborare i decreti del governo rivoluzionario e la palese testimonianza di ciò si ritrova nella constatazione che i vari decreti riguardanti l’insurrezione, come, ad esempio, quello sulla vestizione dei poveri, sono tutti di suo pugno: “egli era…il redattore dei decreti, degli atti costitutivi, degli scritti ufficiali del comitato”. Oltre a ciò, il Buonarroti era incaricato di reclutare gli uomini sui quali poter contare per l’azione rivoluzionaria, in quanto le esperienze di Corsica ed Oneglia gli avevano affinato il senso della realtà, il tatto nel riconoscere i temperamenti dei rivoluzionari. Infatti il Buonarroti, ed in generale tutti i congiurati, solevano avere la tendenza a strutturare in anticipo non solo i mezzi per instaurare il nuovo regime egualitario-comunista, ma anche l’attività politico-sociale di esso.
Al Buonarroti spetta anche l’attribuzione della elaborazione di due importanti scritti: l’Analyse de la doctrine de Babeuf e la Réponse à M. V. . Essi sono notevolmente rilevanti in quanto contengono le tematiche essenziali della dottrina egualitaria, ci fanno cogliere il contributo del Buonarroti al babuvismo, il suo orientamento ideologico al tempo stesso della congiura, oltre che, la reciproca influenza e l’intensa collaborazione tra lui e il Babeuf.
L’Analyse de la doctrine de Babeuf venne diffusa a Parigi circa un mese prima che la congiura venisse scoperta, nel momento in cui il Babeuf ed i suoi compagni iniziavano ad attirare sempre più l’attenzione di chi aveva sostenuto la politica giacobina e degli strati di operai e di artigiani. “La Repubblica del Bonheur commun, concedente a tutti il suffragio con la costituzione del ’93, il dovere del soccorso dello Stato agli indigenti da essa proclamato, i provvedimenti economici del Terrore (requisizioni, calmieri, leggi contro gli accaparratori e l’aggiotaggio, monopolio del commercio estero), parvero corrispondere all’aspirazione verso una più vera eguaglianza, l’eguaglianza di fatto”.
L’intenzione dei congiurati, con la circolazione di tale scritto, era proprio quella di divulgare il più possibile la dottrina egualitaria. Il Buonarroti, sempre con il proprio caratteristico stile, dotò l’incipiente azione rivoluzionaria di una giustificazione ideologica: la dottrina del Babeuf viene analizzata attraverso i concetti di autori prerivoluzionari, quali, ovviamente, il Rousseau, il Mably ed il Morelly, proprio come il toscano aveva più volte consigliato al francese.
Comunque non ci sono roventi punte polemiche, come se il Buonarroti avesse voluto dimostrare che la dottrina del Babeuf non costituiva un pericolo, bensì un coronamento logico dei concetti trattati dagli scrittori illuministi; tuttavia, nonostante la sua moderazione e sobrietà, l’Analyse de la doctrine de Babeuf provocò scalpore, ed il Direttorio termidoriano non riuscì ad impedirne la larga diffusione nei sobborghi, l’affissione ai muri: questo era il primo scritto che il comitato segreto di salute pubblica metteva in circolazione tra il popolo, dato che il Manifesto degli Eguali di Sylvain Maréchal, violento nelle sue asserzioni, non aveva trovato l’unanimità dei consensi dei congiurati.
Più infuocata si presenta l’espressività della Réponse à M. V., diffusa pochi giorni dopo l’Analyse de la doctrine de Babeuf. All’ex convenzionale repubblicano Marc Vadier, che in una lettera al Babeuf aveva messo in dubbio la possibilità d’attuazione dell’eguaglianza di fatto, il Buonarroti, questa volta, però, con la collaborazione del Babuf, tanto che lo scritto risulta essere una compenetrazione dei sostanziali motivi dei due cospiratori, replicò affermando la sua fiducia rispetto all’instaurazione di un sistema egualitario: “se la lotta impegnata su questo punto supremo della rigenerazione umana è sostenuta dagli amici della libertà con lo stesso ardore che essi impiegarono un tempo a combattere l’impalcatura della feudalità e della monarchia, nessun dubbio che la caduta del barbaro sistema della proprietà privata non riconduca presto sulla terra la felicità dell’età dell’oro e della fraternità di fatto, che l’ambizione e la cupidigia hanno assolutamente bandita dalla nostra mostruosa società”. Il Buonarroti, oltre naturalmente ad insistere costantemente sul legame fra le ideologie settecentesche e gli eventi rivoluzionari, sostiene che una società egualitario-comunista è fondata sulla comunanza dei beni e dei godimenti: i beni prodotti dal lavoro comune di tutti i cittadini validi, proporzionalmente alle loro capacità ed attitudini, dovranno essere raccolti in depositi pubblici e distribuiti equamente. Inoltre tale società ha connaturata una intrinseca grandezza razionale distruttrice delle molle dell’interesse egoistico e produttrice di amore, virtù, solidarietà e fratellanza. La Réponse à Marc Vadier è importantissima perché c’è una sostanziale equivalenza fra ciò che essa contiene e ciò che espone la Cospirazione per l’eguaglianza detta di Babeuf: infatti quello che il Buonarroti robustamente dipanerà nell’opera del 1828, pur particolarizzando, perfezionando, cesellando la sua posizione ideologica, anche arricchendola con gli ammaestramenti delle esperienze successive al 1796, ha i suoi fondamentali precedenti proprio nello scritto elaborato con la collaborazione del Babeuf.
Si è detto ormai varie volte che le premesse teoriche del babuvismo sono da ricercare nella tradizione illuministica: tuttavia i babuvisti non si limitarono a riproporre aridamente la strutturazione dei concetti settecenteschi, ma la rinverdirono, rinvigorendola. Il motivo teorico diventava nei babuvisti, grazie anche alla temperie rivoluzionaria, una passione politico-morale: ad esempio, ciò che gli illuministi asserivano circa la comunità dei beni era dai più considerato come una sorta di vagheggiamento utopistico, un’innocente divagazione letteraria; con i babuvisti tutto ciò si tramutava in materiale sovversivo, in quanto facevano calare le astratte postulazioni sull’effettuale terreno politico. Babeuf, Buonarroti e gli altri congiurati avevano una tendenza ad estrinsecare, a dare concreta effettuazione alle forme teoriche settecentesche, a tradurle in misure politico-sociali: in sostanza, si trattava, per essi, di uscire dall’utopia per entrare nella concretezza della realtà storica.
L’egualitarismo del Buonarroti è un egualitarismo livellatore: egli non nega l’esistenza dei talenti individuali, ma conferisce al sistema egualitario-comunista la funzione di destinarli non al vantaggio personale, bensì all’utilità sociale; le arti, le scienze come ogni conquista del sapere umano sono messe al servizio di tutti, gli artisti, gli scienziati contribuiscono, come del resto ogni cittadino, al bene comune. Si ha una generale cooperazione finalizzata alla felicità comune e l’eguaglianza, estirpando i vizi morali, sfocia nel consolidamento del primato della collettività. Tutto ciò che gli uomini producono di buono e di fecondo viene messo in funzione del benessere generale.
Gli Eguali, nonostante che nel 1791 il Babeuf era stato propenso a stabilire un’equazione tra una legge agraria, che portasse ad un’equa distribuzione delle terre, e l’eguaglianza di fatto, asseriscono esplicitamente il loro non schierarsi dalla parte della legge agraria bensì da quella della proprietà comune della terra, della comunità dei lavori, dei beni e dei godimenti; infatti, e qui si avverte chiaramente l’influsso del Mably sugli Eguali, qualunque siano i criteri egualitari mediante i quali vengano ripartiti i terreni, col passare del tempo, data la naturale diversità delle persone umane, la disuguaglianza prenderà il posto dell’eguaglianza: a ciò si può ovviare soltanto attraverso la comunità dei beni, l’organizzazione collettiva dell’esistenza, che, per gli Eguali, si identifica con l’eguaglianza di fatto. Ecco alcuni dei punti attraverso i quali il Buonarroti voleva istituire la società egualitaria e comunista:
1. riunire tutte le ricchezze nelle mani della repubblica;
2. far lavorare tutti i cittadini validi, ciascuno secondo le sue capacità e le sue attuali abitudini;
3. utilizzare i lavori, avvicinando quelli che sono complementari l’uno dell’altro, ed imprimendo un nuovo indirizzo a quelli che sono effetto unicamente dell’attuale ingorgo della ricchezza;
4. raccogliere continuamente nei depositi pubblici tutti i prodotti della terra e dell’industria.
Dunque, la società egualitario-comunista sperata dal Buonarroti è una società in cui si ha il trionfo della frugalità, della temperanza, della probità e della concordia. Tutto ciò sembra sgorgare da una filantropia, da un umanitarismo che vuole andare in contro alle esigenze degli umili, dei poveri, dei bisognosi. “La considerazione dell’uomo nel cittadino, dell’uomo colla sua esistenza fisica, i suoi bisogni naturali, la sua aspirazione alla felicità… il dovere del soccorso dello Stato agli indigenti…”: è ciò la motivazione all’azione del Buonarroti, del Babeuf e degli Eguali.
Elemento tipico degli Eguali, in particolar modo del Buonarroti, è poi la nozione di virtù, intesa come dedizione alla patria o più in generale alla causa del bene, e come fratellanza umana: la politica senza la virtù scade in una mera tattica per soddisfare avidamente i bisogni di alcuni, nell’interesse egoistico, e, dunque, essa deve essere incessantemente surrogata dalla virtù. Se si vuole che la comunità sociale sia fondata sul monolite di saggi princìpi, è necessario che la virtù presieda ad ogni azione e misura politico-sociale.
Per quanto riguarda la tematica del lavoro, il Buonarroti dichiara esplicitamente che il lavoro deve essere comune e che nessun cittadino valido, a meno che non vi siano adeguati e legittimi motivi, può sottrarsi ad esso; però il lavoro non doveva perdurare così come si presentava al rivoluzionario toscano e agli Eguali, cioè come oppressione per le masse popolari, il lavoro non doveva più essere quella realtà economica che faceva sì che vi fossero ampi strati della popolazione affaticati ed alcuni oziosi: esso, per gli Eguali, si configurava come un’attività che, in quanto egualmente ripartita tra i cittadini validi ad essa, ed in quanto produttrice di beni utili per tutti, e di cui tutti avrebbero potuto giovarsi, avrebbe portato con sé una carica di soddisfazione e piacere tanto che gli uomini non avrebbero più voluto rinunciarvi, “ …si vuole che i differenti lavori siano ripartiti in maniera da non lasciare ozioso un sol uomo valido; si vuole che l’aumento del numero dei lavoratori garantisca l’abbondanza pubblica, pur diminuendo la fatica individuale; si vuole che, in cambio, ciascuno riceva dalla patria di che provvedere ai bisogni naturali ed al più piccolo numero di bisogni artificiali che tutti possono soddisfare”, “lavoro, che, saggiamente ed universalmente distribuito, diverrebbe, nel nostro sistema, un’occupazione dolce e divertente, alla quale nessuno avrebbe voglia o interesse a sottrarsi”. In questo quadro, si inseriscono i discorsi relativi all’industria e alle macchine: la dottrina degli Eguali, che, quindi, non è puramente agraria, ed anticipa la fisionomia della letteratura socialista dell’Ottocento, non sostiene la negazione dell’industria attraverso la sua abolizione, bensì prende atto di tale realtà produttiva, e cerca di ovviarne le possibili degenerazioni attraverso la raccolta in depositi pubblici e l’equa distribuzione dei prodotti industriali. L’industria, per i congiurati, è una fonte economica che, in quanto tale, una volta instaurato il regime comunitario, non porterà alla concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi, bensì, accrescerà il benessere collettivo; anzi il Babeuf ed il Buonarroti si dimostrarono ben disposti verso misure potenzianti l’industria, conferenti ad essa un maggiore impulso produttivo. Lo stesso dicasi per le macchine: in un periodo storico in cui l’inizio della fioritura dell’industria implicava la sempre più frequente applicazione delle macchine, il Buonarroti pensava che gli operai e gli artigiani non dovessero nutrire sentimenti ed avere atteggiamenti di odio e rancore nei riguardi di quelle, perché esse, in un sistema egualitario-comunista, verrebbero impiegate in modo da diminuire la fatica ed aumentare il tempo risparmiato. In sostanza, per quel che concerne l’industria e le macchine, ciò che nella società borghese contribuisce allo sfruttamento dei lavoratori, nel mondo dell’egualitarismo comunista diventerebbe strumento per migliorarne le condizioni sociali.
Gli Eguali, poi, sono anche critici del commercio e della moneta: il commercio è contrario ad un governo che sia fondato su princìpi egualitari, porta al disfrenarsi di una selvaggia concorrenza che va a danneggiare le masse lavoratrici, è un elemento che dissolve la società; la moneta, così come l’oro, nel regime egualitario e comunista, dovrà essere meno ricercata della sabbia e della pietra. In ciò, il Buonarroti, il Babeuf e i congiurati, pur riallacciandosi alle argomentazioni settecentesche, traevano spunto dalle vicende politico-sociali del tempo: a fianco della indubbia derivazione illuminista, v’è il rifarsi ai concreti eventi rivoluzionari.
A tutto ciò è inscindibilmente legato l’acceso discorso babuvistico sulle distinzioni tra ricchi e poveri, tra la “nuova aristocrazia” e il “partito plebeo” come li definiva il Babeuf. Anche per quanto inerisce a questo aspetto ideologico, il babuvismo riecheggia la letteratura settecentesca: Helvetius, Rousseau, Mably ed altri avevano esplicitamente denunciato le condizioni oppressive in cui si trovavano le masse popolari, chiaramente commiserato gli operai, i contadini, i piccoli artigiani, i salariati agricoli; però, come sostiene Galante Garrone, non parlavano a nome del popolo, non ne affermavano la rivolta rivoluzionaria. Il Buonarroti, il Babeuf e gli Eguali, invece, connettevano la loro azione anche alle proteste della fame, alle insurrezioni dovute al carovita: “l’influenza che sul Babeuf e sul Buonarroti naturalmente ebbe la rivoluzione, con l’improvviso scatenarsi delle masse alla ribalta della vita politica, …l’accentuarsi della miseria e le prime rivendicazioni enunciate in nome degli artigiani, dei proletari, dei contadini”. La rivoluzione, oltre ad avere i suoi fondamenti teorici, doveva far leva sulle umili classi lavoratrici, doveva sprigionare la forza delle masse popolari. I poveri lavoratori, sono considerati, dalla dottrina babuvistica, come una sorta di successori degli schiavi dell’antichità e dei servi della gleba del Medioevo: le loro condizioni di miseria e di sfruttamento ne sono il comune denominatore. Tale concezione avrà poi profonda risonanza nella riflessione socialista ottocentesca, come dimostrano, ad esempio, il fatto che Louis Blanc affermi che il proletariato, pur avendo più dignità dei servi, ha meno sicurezza rispetto ad essi, e la stessa concezione materialistica della storia. Le masse lavoratrici oppresse è come se non avessero patria, tanta è la loro indigenza. La storia, per i babuvisti, è una lotta, un contrasto tra ricchi e poveri, tra classi sfruttatrici e sfruttate e la rivoluzione non è che l’evidente ulteriore dimostrazione di ciò; la democrazia di cui essi parlano non è una astratta democrazia, una mera repubblica, bensì una democrazia concretamente sociale, una democrazia sostanziale: in ciò il babuvismo potrebbe davvero essere ritenuto una radice politica del marxismo. A ciò contribuisce anche il fatto che il Buonarroti, Babeuf e gli Eguali contrapponevano alla libertà e all’eguaglianza formali quelle di fatto ed economiche: i bisognosi non vogliono libertà ed eguaglianza soltanto nominali, bensì anche effettive, fattuali, per migliorare le proprie condizioni politico-sociali, il popolo non anela a speculazioni in proposito ma ad una realtà sociale connotata dalla libertà e dall’eguaglianza reali, a livello di prassi. Sono, poi, di notevole interesse altri due nuclei concettuali del babuvismo: l’educazione ed il cosmopolitismo. I babuvisti sostenevano l’importanza di un’educazione che protendesse le persone a prendere coscienza di se stesse, che le spingesse ad acquisire consapevolezza delle proprie condizioni; l’eguaglianza è sia il criterio in base a cui strutturare il sistema formativo, sia il fine dell’educazione stessa: case comuni d’educazione avrebbero dovuto formare i giovani ai lavori che più si addicevano loro e ad essere utili al benessere collettivo; dunque, l’educazione non era un ambito a sé stante, ma una fondamentale componente dell’ingranaggio volto a stabilire solidamente una nuova società democratica per il bene dell’umanità. Lo slancio cosmopolitico babuvista sfocia direttamente dal sentimento umanitario: l’umanità è al di sopra delle patrie, e l’amore di essa va al di là di ogni confine nazionale. L’uomo empiricamente universale di cui parla Karl Marx sembra annoverare, tra i suoi precedenti, anche questa calorosa solidarietà universale dei babuvisti. Per il Buonarroti, che si rendeva conto delle varie realtà delle nazioni e, pur interessandosi sempre della situazione italiana, era orgoglioso della sua patria adottiva, in questo quadro che presenta tinte universalistiche, un ruolo determinante spetta alla Francia: infatti, per la fondazione di una grande comunità umana in cui non vi siano più particolarismi d’ogni genere, è importante che il popolo francese porti il suo contributo con il proprio esempio e la propria saggezza politica, anzi esso ha il dovere di appoggiare e difendere gli altri popoli nelle rivendicazioni tendenti alla libertà; tale palingenesi, però, si badi bene, non doveva essere perseguita ed imposta con la forza militare delle guerre espansionistiche, ed è proprio per questo che il rivoluzionario toscano ripudierà con orrore le conquiste napoleoniche, che, dal suo punto di vista, rappresenteranno un travisamento delle idee giacobino-montagnarde. Quindi, il cosmopolitismo con accenti di fratellanza del Buonarroti, proprio per non corrompersi in un imperialismo, è, in sostanza, un’espressione di un robusto e consapevole ideale umanitario indissolubilmente correlato a motivi egualitari: “L’internazionalismo, come logico corollario della rivoluzione sociale, la solidarietà di tutti i popoli per la conquista dell’eguaglianza, era l’ideale che il babuvismo avrebbe tramandato alle correnti socialiste dell’ottocento”. Un altro punto centrale della ideologia babuvista è rappresentato dalla dittatura rivoluzionaria: i babuvisti ritenevano che essa fosse il solo mezzo necessario per continuare ciò che il Robespierre aveva attuato nella sua politica, per instaurare il sistema egualitario. All’interno del comitato rivoluzionario alcuni sostenevano la dittatura di una sola persona, altri quella di alcune persone. I primi, ovviamente, si rifacevano alla figura del Robespierre che veniva sempre più assumendo tratti quasi mitici: egli, per quest’ala babuvistica, era stato un carismatico capo interprete delle esigenze del popolo, un valoroso difensore dei bisognosi. I fautori della dittatura individuale volevano, dunque, un nuovo Robespierre. Tra questi vi era anche il Buonarroti che, da quando aveva conosciuto Robespierre, l’aveva sempre considerato il campione dell’eguaglianza. Invece tra i congiurati sostenitori di una dittatura di pochi individui c’era il Babeuf che, come giustificazione alla sua posizione, addusse il fatto che più persone sarebbero state meno influenzabili di una sola, ed avrebbero evitato una degenerazione dispotica in senso personale; inoltre, con una pluralità di rivoluzionari, non sarebbe sorta la questione del più virtuoso tra essi. Comunque sia gli uni che gli altri affermavano la provvisorietà della dittatura rivoluzionaria, la straordinarietà e la transitorietà di un potere di alcuni virtuosi rivoluzionari che non avrebbe più avuto ragione di essere una volta che la società egualitario-comunista fosse stata fondata stabilmente. Dopo varie discussioni interne, nel comitato prevalse la seconda tendenza: “nessuna dittatura individuale, dunque, ma dittatura dell’autorità insurrezionale”. La dittatura di cui parlano i babuvisti non è assolutamente la dittatura di classe del proletariato di Marx ed Engels, però in essa inizia già a profilarsi un significato classistico; infatti tale dittatura deve concretizzare la sua azione in favore di una classe, quella, naturalmente, dei sanculotti poveri, della massa popolare, contro i ceti ricchi ed aristocratici. Come inferisce Galante Garrone, non si tratta ancora della teorizzazione della dittatura del proletariato, ma di quella in favore del proletariato. Tale concezione babuvista, che ha i prodromi ideologici negli autori settecenteschi, verrà recepita dal Blanqui, e, attraverso di esso, giungerà al marxismo in cui, poi, si appoggerà al movimento operaio. Tutte queste energiche idee, però, non trovarono estrinsecazione per una società egualitario-comunista: la congiura venne scoperta il 10 maggio 1796 ed il Buonarroti, il Babeuf e gli altri rivoluzionari vennero arrestati. L’Alta corte di giustizia di Vendòme, il 25 maggio 1797, condannò a morte il Babeuf ed il Darthé ed alla deportazione a vita il Buonarroti ed altri sette congiurati: era la fine di un comitato rivendicante una società completamente democratica, di un gruppo rivoluzionario che si era dedicato alla motivazione egualitaristica, di un sovversivo tentativo di affrancare gli oppressi, di un’appassionata esperienza politico-sociale volta alla lotta per il bene comune.
3. Il periodo risorgimentale
Il Buonarroti venne rinchiuso nel forte di Cherbourg e vi rimase tre anni in attesa della deportazione in Guaina, che, però, non avvenne: infatti, il Bonaparte, divenuto nel frattempo primo console, autorizzò una mitigazione della pena e, quindi, il trasferimento dei babuvisti nell’isola di Oléron, dove essi vissero non più in stato di detenzione, ma di confino. Il Buonarroti, nel febbraio 1803, venne trasferito a Sospello, nelle Alpi Marittime, e da qui, nel giugno 1806, in seguito alle sue insistenti richieste, a Ginevra, ormai territorio francese. A Sospello, ma soprattutto a Ginevra, il Buonarroti riprese a tessere i legami con l’ambiente politico esterno; il periodo ginevrino (1806-1823) è rilevante per quanto concerne la sua attività settaria: “rimasto sempre fedele agli ideali del ’96, negli anni ginevrini e per tutto il resto della sua esistenza dedicò le energie migliori all’attività volta ad avvicinare la realizzazione della società degli eguali”. Il Buonarroti era sempre, come sostiene Onnis Rosa, il motore delle cospirazioni e delle lotte per la libertà; il contesto politico, caratterizzato dapprima dall’impero napoleonico, e poi dai regimi poliziesco-reazionari della Restaurazione, richiedeva di agire nell’ombra, nel retroscena: “scoperta la cospirazione di Babeuf, giustiziati o privati della libertà i principali capi, di fronte alla nuova situazione storico-politica che i decenni successivi presenteranno prima col forte potere consolare ed imperiale e poi con la Restaurazione, agli assertori del vecchio ideale giacobino, o più in generale liberale-democratico, non resta altra via se non quella di ripiegare latomisticamente nel chiuso dell’attività settaria ”. Proprio questa necessità di un’azione sotterranea determinò la diffusione delle sette segrete. Già dal soggiorno a Sospello il Buonarroti entrò in contatto con la setta segreta antibonapartista dei Filadelfi: egli ne fu un membro autorevole ma non il capo. Tale setta si fuse, più tardi, con quella degli Adelfi nell’unica Adelfia: di essa il rivoluzionario toscano, da figura in secondo piano, diventò il capo e protagonista. Intorno al 1818 l’Adelfia si trasformò nella Società dei Sublimi Maestri Perfetti, che poi, a sua volta, tra il 1828 ed il 1830, verrà trasformata nel Mondo. Le ricerche del Saitta sono importantissime per conoscere tali sette; i Sublimi Maestri Perfetti non avevano, come l’Adelfia, una organizzazione orizzontale, bensì verticale, erano un “ordine” nel senso che presentavano una gerarchia di gradi e non di funzioni. I gradi erano tre e caratterizzati dal progressivo possesso del piano politico: vi era, quindi, un crescendo di dottrine e di autorità, un andare dal basso verso l’alto. In questa scalare diversificazione del contenuto programmatico, l’adepto del primo grado, detto sublime maestro perfetto, sosteneva l’esistenza di Dio e dell’immortalità dell’anima, il principio della carità universale, dell’eguaglianza e della libertà, il patto sociale; il secondo grado, il cui adepto era detto sublime eletto, conosceva e proclamava la sovranità popolare, la elettività e la temporaneità delle cariche, il tirannicidio: quindi i dirigenti intermedi rappresentavano posizioni democratico-rivoluzionarie; il terzo grado, del quale non conosciamo la denominazione dell’adepto, rappresentava il vertice della setta, ed era a conoscenza ed affermava che tutto ciò che c’è di non buono nel mondo deriva dalla divisione della terra: esso, dunque, per ritornare a quella sorta di età dell’oro precedente la distruzione della struttura collettiva primitiva, caldeggiava la fondazione di una società comunista. L’adepto può passare da un grado all’altro guadagnandosi la fiducia dei capi che, comunque, rimangono ignoti a tutti: sono essi che muovono i vari settari. Il Buonarroti non si limitava ad agire nella Società dei Sublimi Maestri Perfetti, o in seguito, nel suo Mondo: infatti egli aveva istituito altre sette secondarie che, movendosi in libertà, non sapevano della loro diretta dipendenza dalla principale organizzazione buonarrotiana. Il Buonarroti, perciò, con questo sistema di federazioni, aveva una costellazione insurrezionale che avvolgeva le nazioni della Santa Alleanza. In tal modo, ad esempio, i congiurati lombardi del conte Gonfalonieri non erano dei legami che li univano all’ex compagno del Babeuf. Inoltre il Buonarroti, affinché la sua rete rivoluzionaria fosse il più possibile presente nelle varie realtà politiche, esplicò anche un’attività di penetrazione nelle altre sette: è il caso dell’inserirsi di cospiratori buonarrotiani nella carboneria italiana. Infatti, quando questa società segreta, dal Mezzogiorno iniziò a diffondersi anche nelle Marche e nelle Romagne, il Buonarroti iniziò ad interessarsi alla sua attività e riuscì ad infiltrare la sua organizzazione in essa, ed è proprio per questo che in essa venne introdotto un terzo grado e che vendite carbonare vennero stabilite in ambiti, come quello lombardo piemontese, in cui l’organizzazione buonarrotiana era fiorente. Quest’azione buonarrotiana di far entrare i suoi orientamenti politici in altre associazioni segrete riguardò non solo l’Italia, bensì anche altre nazioni europee: infatti, elementi buonarrotiani si ritrovano anche, grazie alla collaborazione dell’amico del Buonarroti Gioacchino Prati, nella setta degli Indipendenti in Svizzera ed in Germania e nella carboneria francese. Come asserisce il Saitta, tale articolazione settaria buonarrotiana, se da un lato, con le sue varie diramazioni, rappresentava un pericolo per i regimi poliziesco-reazionari di allora, dall’altro aveva una certa fragilità dovuta al fatto che, per i pochi capi a conoscenza dei reali piani politici, non era semplice controllare masse di congiurati, tra cui, poi, potevano anche scoppiare contrasti. Comunque, per il Buonarroti, il fine della sua organizzazione era quello di rappresentare una palestra per quella filosofia che avrebbe dovuto migliorare gli uomini e la società, di essere uno strumento di lotta contro i regimi oppositori dell’eguaglianza del comunismo. Il fallimento dei moti napoletano e piemontese del 1820-1821, che, naturalmente, non furono esclusivamente moti buonarrotiani, ruppe le fila del settarismo politico: il Buonarroti tentò di spronare il settarismo consolidando i rapporti con varie figure dello scenario dell’associazione segreta; inoltre, sempre a tal fine, il cospiratore toscano inviò in Italia l’Andryane. Quest’ultimo, però, venne scoperto, provocando, così, la preoccupazione dell’Austria che fece pressione sulle autorità elvetiche affinché il Buonarroti venisse espulso da Ginevra: era la fine del periodo ginevrino. Il Buonarroti, allora, si recò a Bruxelles e vi stabilì la sua residenza aprendo, dunque, il periodo dell’esilio belga ( 1824-1830 ). In Belgio, il Buonarroti svolse una vera e propria attività di direzione della vendita centrale della carboneria francese a Bruxelles sotto il nome di Camille, collaborò costantemente con alcuni giovani liberali belgi, Louis De Potter, Alexandre Delhasse, Félix Temmerman, i fratelli Colignon, i quali erano fortemente avversi al controllo olandese sulla provincia del Belgio, e rimase in stretto contatto con i protagonisti della Rivoluzione Francese, come Vadier, Barère, Camion ed altri che avevano trovato rifugio nel regno dei Paesi Bassi; inoltre egli riuscì ad inserire nella sua tela d’azione politica anche due importanti figure francesi: il democratico Charles Teste ed il marchese Marc d’Argenson, un carbonaro poi diventato babuvista. Alcuni amici dell’esule toscano lo tennero informato sulle varie ideologie socialiste che si stavano profilando sul panorama europeo: è il caso di Robert Owen. Alle idee ed alle esperienze americane di tale personaggio inglese, vero e proprio precursore del socialismo, il Buonarroti guardava con simpatia ed affetto, restando però piuttosto scettico sul fatto che un sistema egualitario potesse essere costruito soltanto con la forza dell’esempio: infatti,come si è detto sopra, a ciò, per un irriducibile giacobino-babuvista come il Buonarroti, si sarebbe potuto giungere solo attraverso la presa del potere politico. Più critico l’ex compagno del Babeuf si dimostrò, invece, nei confronti di Claude-Henri de Saint-Simon, in quanto il socialista francese voleva fondare una società egualitaria non attraverso l’abolizione della proprietà, bensì mediante la sospensione dell’eredità e la dittatura dei tecnici e dei dotti. Il fatto saliente del periodo belga è l’opera Conspiration pour l’Egalitè dite de Babeuf, la cui pubblicazione nel 1828 fu resa possibile anche grazie all’aiuto finanziario del De Potter: “il periodo dell’esilio belga… avrà come momento centrale la pubblicazione di quella Conpiration pour l’égalité che, riproponendo le esperienze dei congiurati del ’96, indicava al campo delle forze politicamente più avanzate la prospettiva dell’edificazione di una società comunista come una dei possibili sbocchi della lotta rivoluzionaria in Europa ”. Tale opera aveva un doppio fine: infatti voleva, da un lato, rappresentare una sorta di veritiera testimonianza su ciò che la vicenda degli Eguali era realmente stata, dall’altro, proporre l’ideologia comunistico-egualitaria non solo ad un nucleo di cospiratori, bensì a tutta l’opinione pubblica democratica e a quei ceti in cui l’azione diretta del rivoluzionario toscano non era pervenuta. Ecco cosa il Buonarroti afferma nella prefazione di questo scritto: “un momento prima della nostra condanna, sui banchi dell’alta corte di Vendome, mentre la scure aristocratica stava per colpirli, Babeuf e Darthé ricevettero da me la promessa di vendicare la loro memoria, pubblicando una esposizione esatta delle nostre comuni intenzioni… D’altronde, è giusto che il partito democratico sia finalmente conosciuto nella sua vera luce… sono rimasto convinto che l’eguaglianza da loro vagheggiata è la sola istituzione idonea a conciliare tutti i veri bisogni, a ben dirigere le passioni utili, a contenere quelle dannose, e a dare alla società una forma libera, felice, pacifica e duratura ”. Le tematiche ideologiche della Conspiration pour l’Egalitè dite de Babeuf sono quelle tipiche del babuvismo: eguaglianza di fatto, comunione dei beni e dei lavori, virtù politica, nuova concezione del lavoro, critica alla distinzione tra ricchi e poveri, agricoltura, industria, macchine al servizio del miglioramento delle condizioni del popolo, educazione, sentimento umanitario, cosmopolitismo, dittatura rivoluzionaria. Qui ci interessa evidenziare l’atteggiamento storiografico che emerge dall’opera buonarrotiana in quanto la Conspiration pour l’égalité conteneva infatti un’interpretazione della rivoluzione che può considerarsi il punto di partenza della storiografia di tendenza democratica. Come nel periodo termidoriano era sorta l’interpretazione in senso liberale della rivoluzione, così aveva avuto origine anche quella di matrice giacobina: quest’ultima venne raccolta e sistemata dal Buonarroti, il quale pose la questione sociale in termini di lotta di classe. Egli, infatti, sosteneva l’esistenza di un conflitto tra il sistema degli interessi particolaristici e quello amico dell’eguaglianza, tra il sistema dell’egoismo e quello del bene comune, e, nella sua opera, pur non essendoci, ovviamente, una piena delineazione della lotta classistica quale criterio storiografico, c’è tuttavia una notevole caratterizzazione degli antagonismi delle forze politiche riverberanti le varie classi sociali. In questo quadro Robespierre viene ritenuto un rivoluzionario virtuoso che aveva combattuto per la libertà e l’eguaglianza, gli aristocratici e i monarchici un gruppo intento a difendere i suoi privilegi dinastici, la Gironda una compagine politica tra la nobiltà ed i lavoratori che non voleva che la rivoluzione approdasse ad un regime veramente democratico-popolare, la massa dei lavoratori una forza esprimente i bisogni e le rivendicazioni degli indigenti, l’impero napoleonico come il rafforzamento della reazione termidoriana. Quindi, gli spunti interpretativi in direzione classista che permeano il lavoro buonarrotiano, ne fanno una radice della concezione storiografica marxista. Dopo la rivoluzione parigina del luglio 1830, il Buonarroti, nonostante lo sbocco orléanista, tornò a Parigi, che,considerava ancora il fulcro da cui avrebbe dovuto diffondersi il movimento rivoluzionario: qui si ha quella che il Saitta ha definito “una vera e propria biforcazione della sua attività”, cioè egli portò avanti sia un’azione clandestina, cospiratoria, sia un’azione sul piano legale nei confronti dei poteri costituiti e dell’opinione pubblica per la conquista del suffragio universale, dell’abolizione delle imposte indirette da sostituire con un’imposta progressiva, di misure santuario. Per quanto riguarda quest’attività alla luce del sole, uno strumento importantissimo fu costituito dalle Società popolari, che, inizialmente erano tollerate dal governo: la Société des Amis du Peuple, la Aide toi e la Société des droits de l’homme e du citoyen, in cui il Buonarroti e gli uomini più vicini alle sue convinzioni ideologiche, come, ad esempio, Charles Teste, Voyer d’Argenson ed Auguste Blanqui, facevano circolare opuscoli e pamphlets sostenenti idee egualitarie; tali società, pertanto, erano “pervase dalle concezioni buonarrotiane, che si contaminavano e si mescolavano con quelle delle altre scuole socialiste; rispetto alle quali, tuttavia, il neogiacobinismo e il neobabuvismo si distinguevano perché portavano il socialismo sul terreno della lotta politica e proponevano la conquista del potere e la fondazione della democrazia conseguente… come la sola via per giungere alla soluzione della questione sociale”. Nonostante che ritenesse la Francia la nazione guida, il Buonarroti, da quando era ritornato a Parigi, lavorò, mediante un’allacciatura di rapporti con il fuoriuscitismo italiano a Parigi, Ginevra, Londra ed in altre città in cui vi erano esuli della penisola italiana, ad un’azione in direzione dell’Italia: infatti si stabilivano alleanze tra i vari gruppi di italiani all’estero, anche se essi avevano idee distanti tra loro; “si assisteva alla nascita di una serie di comitati e di società che cercavano di dare una qualche organizzazione alle… forze dell’esulato”. Lo scopo di una piattaforma politica per un’attività insurrezionale in Italia fece appianare le divergenze teoriche, i particolarismi ideologici: a Parigi, nel 1831, venne fondata una sorta di federazione delle varie società patriottiche, la Giunta liberatrice italiana, tra i cui componenti venne scelto un Direttorio liberatore composto dal Buonarroti, dal Mirri e dal Salfi. Questi due organismi politico-rivoluzionari, caratterizzati da affermazioni repubblicane ed unitarie per il paese italiano, però, si sfaldarono: la Giunta liberatrice italiana a causa del fallimento del tentativo di spedizione armata contro la Savoia, a cui, peraltro, il Buonarroti non era assolutamente favorevole; il Direttorio liberatore a causa della eterogeneità ideologica dei suoi membri, in quanto accanto all’egualitarismo comunista buonarrotiano, che tra l’altro suscitava diffidenze, v’erano anche aperture al liberalismo. Il Buonarroti, prima di rassegnare le proprie dimissioni, pubblicò, nel marzo 1831, a Parigi, l’opuscolo Riflessioni sul governo federativo applicato all’Italia: “è questo uno scritto vigorosamente critico verso la concezione federale”, a cui si contrappone l’idea buonarrotiana della preferenza per un modello unitario; emergono in esso, come sostiene il Saitta, motivi robespierristi e babuvisti asserenti la sovranità popolare e l’eguaglianza come garanzie di una società totalmente democratica.
[1]Nel 1773 Filippo fu allievo presso la scuola della celebre Badia fiorentina dei Benedettini Cassinesi ed in particolare scolaro di Bernardo de Rossi, con cui rimarrà in corrispondenza almeno fino al 1794. Nel 1778 venne fatto cavaliere di Santo Stefano ed iniziò a frequentare i cosi di giurisprudenza laureandosi l’8 giugno 1782, giorno in cui, anche, si sposò con la contessina Elisabetta Conti; ma nel 1794 andrà a convivere con Teresa Poggi che poi sposerà avvalendosi della legislazione rivoluzionaria francese.
[2] Ricordiamo che, laureatosi, il Buonarroti, per guadagnarsi da vivere, si dedicò al commercio di libri importando dalla Francia opere illuministiche e libertine: ma una perquisizione della polizia pose fine a questa sua attività.
COLIN MACLAURIN

A cura di Gigliana Maestri
MACLAURIN
Figlio di un pastore della Chiesa presbiteriana, Colin Maclaurin nasce in Scozia, a Kilmodan, nel 1698. Rimasto orfano e affidato alle cure di uno zio, entra all’Università di Glasgow a soli undici anni, e subito manifesta una particolare predisposizione per lo studio della matematica. Non a caso, nel 1717 è nominato professore di matematica al Marischal College dell’Università di Aberdeen, e in seguito, a partire dal 1725, ottiene la cattedra di matematica all’Università di Edimburgo, soprattutto grazie all’appoggio di Isaac Newton, di cui s’impegna a divulgare le dottrine. Maclaurin compone la Geometria organica, sive descriptio linearum curvarum universalis, il Treatise of Fluxions, il Treatise of Algebra, e il manuale An Account of Sir Isaac Newton’s Philosophical Discoveries. Impegnato ad estendere gli interessi scientifici e pratici della “Medical Society”, Maclaurin si distingue nell’organizzazione della difesa di Edimburgo durante la rivolta giacobita. Muore nel 1746.
Nel Treatise of Fluxions, Maclaurin intende fondare in modo logicamente rigoroso il calcolo infinitesimale di Newton; nel Treatise of Algebra, invece, egli si occupa soprattutto dei “sistemi lineari” e del “calcolo dei determinanti”. Come matematico, elabora una formula nota con il nome di “Eulero-Maclaurin”, che, nel calcolo infinitesimale, collega l’integrale e le somme.
Maclaurin appartiene a quella seconda generazione di newtoniani che intende affrontare le conseguenze metafisiche della scienza di Newton sul piano dell’osservazione sperimentale, piuttosto che sulla base dei soli principi. Interessato all’interpretazione dell’eredità newtoniana, soprattutto per quanto riguarda le sue conseguenze in ambito religioso, egli è l’interprete più rappresentativo del teismo sperimentale scozzese. Nell’Account, a proposito della prova dell’esistenza di Dio, scrive:
“Il semplice argomento per l’esistenza di Dio, chiaro a tutti e dotato di irresistibile persuasione, è quello che discende dall’arte manifesta e dall’adattamento reciproco delle cose che incontriamo in ogni parte dell’universo. Qui non c’è bisogno di ragionamenti minuziosi o sottili: un’arte manifesta suggerisce immediatamente un artefice. Esso ci colpisce come una sensazione e i ragionamenti artificiosi in contrario possono confonderci, senza però scuotere la nostra credenza. Nessuna persona, per esempio, che conosca i principi dell’ottica e la struttura dell’occhio, può credere che sia stato formato senza abilità in questa scienza…”.
Secondo Maclaurin, il cosiddetto “argomento del disegno” (design argument) a sostegno dell’esistenza di Dio, argomento privilegiato da Locke, da Newton e dal teismo sperimentale in genere, dimostra sia l’esistenza sia gli attributi divini.
Maclaurin intende poi risolvere il contrasto tra scienza cartesiana e scienza newtoniana su base rigorosamente sperimentale, e su questa stessa base partecipa alla disputa sulla “misura delle forze” contro i leibniziani. Sempre nell’Account, egli pone una distinzione netta tra i sistemi elaborati dai filosofi e le teorie degli scienziati, fondate sull’osservazione e sull’esperimento. Maclaurin attribuisce la graduale e lenta nascita della scienza della natura all’opera di Copernico, Keplero, Galileo e Francesco Bacone, mentre ritiene che i vari sistemi speculativi, proposti da Cartesio in poi, siano fondati soltanto sulle idee e sull’immaginazione, in aperta violazione del senso comune e in contrasto con l’osservazione dei fenomeni. Ad esempio, egli critica i cartesiani e i materialisti britannici perché “per il gusto di spiegare ogni cosa mediante il meccanicismo, sono stati indotti a escludere dall’universo tutto ciò che non fosse materia e movimento”. Maclaurin condanna poi Berkeley per aver sostenuto che esistono soltanto percezioni e spiriti che le percepiscono, e critica Hume perché, portando alle estreme conseguenze il pensiero di Berkeley, non ammette neppure gli spiriti, ma soltanto le percezioni. Inoltre, Maclaurin polemizza anche con Baxter in quanto, trascurando “gli anelli intermedi nella catena delle cause”, risolve “affrettatamente ogni principio nella immediata influenza della causa prima, danneggiando la bellezza della natura”, e ponendo così fine “alle nostre ricerche sulla parte più sublime della filosofia”.
Ancora nell’Account, prima di esporre i concetti fondamentali dei Principia newtoniani, Maclaurin ristabilisce quelle nozioni del senso comune che, a suo parere, la “cattiva filosofia” ha messo erroneamente in discussione. Perciò, egli si ricollega a Locke nel sostenere che siamo certi della nostra esistenza e delle nostre idee in base alla coscienza interna, e che questa medesima coscienza ci garantisce del fatto che esistono cause o poteri al di fuori di noi, e che su di noi agiscono. D’altra parte, la nostra mente è conscia della propria attività nel riflettere sulle idee, nel ragionare su di esse, nel comporle e nel classificarle; da ciò, dall’influenza degli oggetti esterni sulla mente e dal corso della natura acquistiamo con facilità le idee di causa ed effetto. Probabilmente, in questa volontà di affermare la validità della relazione causale, si può leggere anche una critica a Hume, per il quale invece noi non percepiamo mai una reale “connessione necessaria” tra due oggetti, ma tale connessione è soltanto un’impressione della nostra mente, ossia la determinazione della mente a passare da un oggetto ad un altro, da un’idea all’altra.
In generale, Maclaurin assume il sistema newtoniano come paradigma della ricerca filosofica, e considera il “senso comune” norma e limite della “buona filosofia”. Polemizza poi contro il misticismo neoplatonico per ridimensionare certe interpretazioni dello Scolio generale dei Principia di Newton, interpretazioni che, a suo parere, ne travisano il rapporto fra Dio e l’universo, subordinando così la fisica alla metafisica.
INDIETRO
JEAN MESLIER

A cura di Enrico Gori
“Desidero, e sia l’ultimo e più ardente mio desiderio, che l’ultimo re venga strangolato con le budella dell’ultimo prete” (Testamento).
VITA E OPERE
MESLIER
Considerato da molti studiosi e simpatizzanti successivi il precursore e ideatore della Rivoluzione Francese, Jean Meslier nasce a Etrépigny, nella regione di Champagne a pochi chilometri dalle Ardenne, nel 1664 da una famiglia agiata di mercanti di stoffe. Nel 1689, a 25 anni viene messo in seminario. Jean non si oppone alla volontà dei genitori, ha una buona conoscenza teologica, avendo fatto gli studi in istituti parrocchiali, e la vita ecclesiastica gli permetterà di leggere tranquillamente. Divenuto parroco del paese, studia Epicuro, Lucrezio, Montaigne, Cartesio, ma soprattutto il moralista Fénelon, dalla cui Dimostrazione dell’esistenza di Dio fatta tramite le meraviglie della Natura trarrà i principali argomenti nella sua virulenta critica alla religione. La vita trascorre senza incidenti, finché, dopo un litigio con il signorotto locale, Jean, addolorato dalla tracotanza del nobile, decide di lasciarsi morire di fame. Nel 1724, sentendosi vicino alla morte, comincia a stendere le sue memorie. Nel 1729 finisce il suo testamento, destinato ad avere una storia travagliata. Nel 1733 l’inedia lo porta alla tomba, a 69 anni. Quando morì, il suo sostituto trovò nel suo appartamento tre lettere piene di invettive antireligiose e di rancore verso quella religione e quella nobiltà che succhiava il sangue ai suoi amati parrocchiani, poveri contadini.
IL PENSIERO
Propugnatore di un ateismo senza concessioni e di una utopia anarco-comunista ante litteram, Jean Meslier non lascia molto spazio a dubbi: il suo Testamento, quello vero, poiché Voltaire, nel 1735 lo pubblicò adattandolo alle sue esigenze deiste, è l’opera di chi ha visto per quarant’anni i soprusi di un clero e di una nobiltà sempre più esigenti nei confronti dei contadini francesi. La tesi sostenuta dal curato è molto semplice: se la nobiltà è il risultato della brutalità e della tirannia, la religione, insieme di assurdità, non potrà che essere generata dalla paura di cui si serve la nobiltà per imporre il proprio potere. Conseguenza naturale, la religione e la tirannia si appoggiano reciprocamente. Come avviene questo? Il Cristianesimo, con la sua insistenza sulla sofferenza, la povertà e il dolore e la sua condanna del piacere ha anestetizzato gli uomini, legittimando i soprusi del Re (ricordiamo che al tempo regnava il Re Sole) e della nobiltà, ragionamento ripreso poi direttamente da Nietzsche. Tutti gli uomini sono uguali, e la terra che lavorano appartiene a loro. Preti e nobili sono solo parassiti fannulloni e ipocriti. Quella del nostro autore è anche un’esplicita professione materialista: tutti i cambiamenti dell’uomo non sono che “fermentazioni”, ed è ridicolo attribuire tutto a un Dio, se già la Natura è eterna e perfettamente regolata, tesi, questa, cara a de Sade. Che il popolo si sollevi, allora, perché la terra produce abbastanza per tutti. Il testamento si chiude con l’estrema affermazione materialista: “presto non sarò più niente; i morti non hanno nulla di cui preoccuparsi. Presto non sarò più niente”.
L’OPERA
Il Testamento di Jean Meslier fu presumibilmente il testo antireligioso più conosciuto e letto del XVIII secolo: Diderot lo conosceva bene e fece sue alcune frasi che gli valsero il carcere; il barone d’Holbach lo pubblicò insieme al Buon senso, opera la cui paternità fu a lungo attribuita allo stesso Meslier, pur essendo in realtà del Barone. L’edizione andò perduta e non se ne seppe più nulla: l’unica fonte era quella, abbondantemente riveduta ed emendata, di Voltaire. Il testo originale venne pubblicato nel 1864 in Olanda. Quali amputazioni e correzioni apportò Voltaire al Testamento? Manca tutta la parte politica, utopica, e così la parte bio-meccanicista, rimpiazzata dalle puntualizzazioni fatte dal Meslier sulle contraddizioni religiose, sebbene non ci sia dato di sapere se e quanto Voltaire abbia messo mano lì, dato che anche Jean Meslier conosceva bene le Scritture.
MARTIN KNUTZEN
A cura di Alessandro Sangalli
Martin Knutzen (1713-1751), filosofo tedesco, fu allievo di Alexander Baumgarten e maestro di Immanuel Kant. Nel 1733, assunse l’incarico di professore di logica e metafisica all’Università di Königsberg (oggi Kaliningrad). Seguace della scuola wolffiana-razionalista, si dedicò con molto interesse alle scienze matematiche e naturali, in particolare alla fisica e all’astronomia. Lo studio delle teorie di Newton lo indusse a mettere in discussione la dottrina leibniziana della “armonia prestabilita”, alla quale sostituì quella della causalità meccanica e del movimento fisico, chiarendo e portando a compimento una tendenza per certi versi già rintracciabile nella filosofia di Christian Wolff: troviamo espressa questa posizione nel Systema causarum efficientium del 1745. Com’è noto, la dottrina dell’armonia prestabilita era servita a Leibniz per risolvere il problema dell’accordo reciproco tra le monadi una volta postulate l’autosufficienza e l’incomunicabilità di questi enti semplici. Knutzen non può che rifiutare una simile prospettiva, che rende quantomeno critico il concetto di causa efficiente tanto caro al sistema newtoniano, cui Knutzen stesso si richiama: l’universo di Newton è infatti semplice e uniforme, e ammette solo cause necessarie e riconoscibili, senza mai ipotizzare forze occulte e misteriose come spiegazioni di fenomeni naturali (hypoteses non fingo). Tra i suoi scritti ricordiamo inoltre: Insignis algebrae usus et praestantia in perficiendo intellectu del 1738, Commentatio philosophica de humanae mentis individua natura del 1741, Prova filosofica della verità della religione cristiana del 1742 (scritta in tedesco) ed Elementa philosophiae rationalis seu logica specialis, more geometrico demonstrata del 1746.
Parlando di Knutzen non ci si può esimere dal nominare il suo grande allievo Immanuel Kant e dal dire qualcosa circa il loro rapporto intellettuale. Sicuramente, l’uomo che ebbe la maggiore influenza sulla formazione scientifico-filosofica di Kant fu proprio Martin Knutzen. Uniti da una comune fede religiosa di fervido spirito pietistico, i due furono uniti da un rapporto molto stretto, un rapporto in cui l’allievo imparò tantissimo dal maestro. Knutzen iniziò il discepolo allo studio della filosofia, del diritto naturale, della matematica, della fisica, dell’astronomia, della meccanica e dell’ottica: in particolare, indirizzò Kant allo studio di Newton. L’interesse e la passione che il nostro nutriva per le scienze e naturali influirà sull’opera di Kant, che dedicherà la sua terza critica alla ricerca di una conciliazione tra l’autonomia della dimensione spirituale (noumenica) e la materialità meccanica di quella fisico-naturale (fenomenica): Knutzen stesso aveva cercato per tutta la vita il modo di conciliare il sistema di Wolff con le nuove teorie scientifiche di Newton. Dal punto di vista pratico, la ricchissima biblioteca scientifica di Knutzen costituì un prezioso punto d’appoggio per la stesura del primo scritto di Kant, il saggio fisico-matematico Pensieri sulla vera valutazione delle forze vive (1746).
BOULANGER

A cura di Maura Millet
Cenni biografici
Nicolas Antoine Boulanger1 nasce a Parigi l’11 novembre del 1722; dopo aver condotto senza brillanti risultati studi classici, si dedicò allo studio della matematica e all’architettura, esercitando poi la professione di ingegnere (militare e civile). Lo stretto contatto con la natura, a cui la sua stessa occupazione lo portava ad avere, lo condusse ad avviare numerose ricerche intorno alla storia naturale: «il vit la multitude de substances diverses que la terre recèle dans son sein, et qui atteste son ancienneté et la suite innombrables de ses révolutions sous l’astre qui l’éclaire […] il ramassa du bois, des pierres, des coquilles»2. Tuttavia gli studi naturali a cui amava dedicarsi non sono da imputarsi esclusivamente a un suo spiccato spirito scientifico, ma vanno piuttosto interpretati come punto di partenza, come materiale di base da cui condurre osservazioni e giungere a conclusioni intorno alla storia dell’uomo e della società.
Della breve vita di Boulanger sappiamo che tra il 1753 e il 1754, durante i suoi soggiorni parigini, frequentò la casa di Mussard in cui incontrò Rousseau e Prévost. Dal 1755 iniziò a intrattenere stretti rapporti con il barone d’Holbach, che avrebbe poi curato le edizioni delle opere di Boulanger. L’«ingénieur des ponts et des chaussées», affascinato dalla storia degli uomini e della società, morì a soli 37 anni, il 16 settembre del 1759, a causa di una «maladie grave» che lo afflisse per tutta la vita.
Oltre che una partecipazione piuttosto frammentaria al lavoro dell’Encyclopédie, a cui contribuì con la voci déluge, corvée e probabilmente société, le principali opere a cui lavorò sono le Recherches sur l’origine du despotisme oriental, edita postuma nel 1761 e L’Antiquité dévoilée par ses usages, apparsa anch’essa dopo la morte di Boulanger, nel 1766. In giovane età si dedicò alla stesura di una Histoire d’Alexandre le Grand. Vanno ancora ricordati gli scritti su Esopo, San Pietro, Enoch e i trattati di storia naturale sui corsi d’acqua della Loira e della Marna.
L’Antiquité dévoileée
Prima di procedere all’analisi del testo, per cogliere quale sia l’immagine che Boulanger fornisce del mondo antico, è necessario prima inquadrare l’opera ed esporre la curiosa teoria sul diluvio, senza cui si rischierebbe di travisare il pensiero dell’autore.
Va innanzitutto rilevato come a partire dalla metà del XVIII secolo la discussione intorno alla storia naturale dell’uomo fosse particolarmente viva, tanto che numerosi studiosi del tempo si dedicarono alla stesura di cosmogonie (più o meno fantastiche); Voltaire stesso fu affascinato dalla discussione sull’origine della terra, sul diluvio e sui fossili. Alla base di tutto ciò si può indubbiamente rintracciare un forte intento antibiblico; si cercava infatti di affiancare e sostituire una genesi naturale alla Genesi biblica.
L’opera di Boulanger ha risentito dell’influenza degli studi biblici e mitologici di un gruppo di orientalisti che ruotava intorno alla famiglia Fourmont: il nucleo del loro pensiero sosteneva che «in tutte le leggende antiche si doveva poter ritrovare, sepolta sotto l’involucro mitologico la verità storica quale essa era stata rivelata dalla Bibbia»3. I Fourmont, in particolare il primo della famiglia, Étienne, fu attratto dalla leggende antiche sul diluvio; è inoltre curioso sottolineare come tra la carte di Claude Fourmont si rinvennero degli appunti intitolati Idée informe sur les livres sybilllins, problematica che appassionava Boulanger e a cui dedicò un libro dell’Antiquité.
Appare a questo punto fruttuoso indagare quale fosse la posizione di Boulanger circa il diluvio. Gli scritti di storia naturale a cui lavorò sono andati perduti, tuttavia dalle sue opere si evince con chiarezza la sua teoria sul diluvio, fatto storico la cui certezza scientifica, secondo Boulanger, non può essere negata. «Douter de la réalité de ces faits, ce serait démentir la nature qui a dressé elle-même en tout lieux des monuments qui les attestent. Ainsi la révolution qui a submergé une portion de notre globe pour en mettre une autre à découvert, ou ce que l’on a nommé le deluge universel, est un fait que l’on ne peut récuser»4. La verità di questa affermazione trae conferma da tre elementi: dall’universalità di questa tradizione, infatti in tutte le lingue e in ogni storia dei popoli antichi si narrano grandi catastrofi naturali; in secondo luogo, dal progresso delle nazioni e dal perfezionamento progressivo delle arti registrati dopo questi cataclismi; infine dalle conferme scientifiche, infatti l’occhio attento dello scienziato riconosce nella conformazione della terra, della crosta, dei fossili e delle conchiglie il segno evidente di antiche «révolutions physiques».
Il diluvio in quanto fatto naturale rimarrebbe privo di interesse se non si leggesse in esso il punto d’innesco della storia dell’uomo: infatti Boulanger intravede in questo grande sommovimento della natura l’avvio della storia della società umana, si ha dunque una stretta interdipendenza tra vita della natura e vita degli uomini: «ces révolutions physiques ont donné lieu à des renouvellements dans la société humaines. […] L’istant de ces anciennes révolutions est en effet l’instant précis où l’on doit remonter pour parvenir à la naissance de nos sociétés actuelles»5. Oltre all’intento storiografico con cui Boulanger si impegna a ricostruire la storia delle origini dell’uomo moderno, si deve apprezzare lo studio di ordine socio-psicologico; l’autore si propone infatti di cercare le conseguenze morali e le impressioni che i cataclismi naturali abbiano potuto provocare sugli uomini: «ces impressions, elles ont dû nécessairement influer sur la conduite des hommes, sur leurs idées, sur les démarches des sociétés renouvellées, et même sur celles de toutes les société qui par la suite sont dérivées des premières. […] j’ai vu écrit dans la nature que l’homme a été vivement affecté et profondément pénétré de ses malheurs, […] j’ai vu qu’il est devenu triste, mélancolique et religieux à l’excès […] j’ai reconnu que cette première position de l’homme qui a renouvellé les sociétés est la vraie porte de notre histoire, et la clef de toutes les enigmes que les usages et les traditions proposent»6. Anna Minerbi Belgrado ravvisa proprio in questo tentativo di ricostruire la storia degli uomini come l’insieme delle reazioni scatenate da un evento d’eccezione, di dimensioni non comprensibili e non dominabili, il carattere più specifico e originale dell’opera di Boulanger. Solo Gian Battista Vico esaltò l’emotività (in questo caso si tratta di un’emotività stravolta) quale radice della storia7.
Il diluvio segna dunque il punto di rottura e il momento di svolta che sta alla base di qualsiasi manifestazione religiosa, politica e sociale. In relazione a quanto detto, l’impianto filosofico di Boulanger appare essere estremamente unitario, rischiando spesso di cadere in forzature che una teoria monocausale può comportare.
L’analisi che Boulanger si propone di condurre prende le mosse dallo studio delle tradizioni, dei miti e delle feste, «les usages»8 appunto, delle società antiche. Si chiarifica così anche il significato del titolo dell’opera: L’Antiquité dévoilée par ses usages. Attraverso lo studio e la comparazione «des usages des anciens» Boulanger si propone di scoprire e svelare l’Antiquité. Il sostantivo ‘antichità’ va qui inteso con un’accezione decisamente più vasta di quanto non significhi per noi: «pour lui [Boulanger] l’antiquité c’est le passé tout entier, de l’humanité tout entière». Il participio passato dévoilée sembra in qualche modo far eco all’opera le Christianisme dévoilé, in cui il participio dévoilé rinvia al significato di démysthifié (il titolo dell’opera potrebbe anche non essere stato attribuito dall’autore, ma dall’editore, il barone d’Holbach, che curò la pubblicazione dell’opera)9.
Non tanto la conoscenza arida dei fatti e dei costumi, ma piuttosto le cause che li hanno prodotti e soprattutto ciò che Boulanger chiama l’«esprit», ossia lo spirito che li ha resi possibili, muovono l’interesse dell’autore. Ogni sezione del testo è infatti dedicata all’analisi dell’«esprit» che animava i popoli dell’antichità nelle sue diverse forme: nel primo libro si occupa dell’«esprit commémoratif», ponendo in luce come i popoli abbiano istituito delle ricorrenze particolari per mantenere vivo il ricordo del diluvio; nel secondo libro mette in evidenza il carattere triste e lugubre che accompagna ogni festività nel mondo antico, questo è l’«esprit funèbre». Nel terzo libro Boulanger si sofferma sull’«esprit mystérieux», ossia sui misteri, gli enigmi e i secreti dei popoli antichi che altro non si proponevano che di nascondere verità pericolose che avrebbero potuto disturbare l’ordine sociale. Il quarto libro pone in rilievo l’«esprit cyclique»: l’umanità, fin dall’antichità, fu spinta a studiare e calcolare quale potesse essere la durata del mondo, associando la fine di ogni periodo cronologico (anno, secolo) a idee e credenze apocalittiche. Nel quinto libro sono le feste e le cerimonie istituite nel corso dell’anno, dei mesi e dei giorni a essere esaminate: l’«esprit liturgique». Infine Boulanger pone in coda alla sua opera una dissertazione sugli effetti fisici e morali del diluvio10.
I misteri, il progresso e la religione
In ogni popolo dell’antichità, fatte salve le popolazioni del Nord Europa e delle Americhe11, si rintracciano dei «mystères», ossia dei riti e dei culti religiosi segreti, il cui autentico contenuto era riservato esclusivamente agli iniziati e celato al popolo.
Accanto alle cerimonie segrete, riservate agli iniziati12, si accompagnava sempre una parte pubblica, destinata a coinvolgere tutto il popolo. Come in ogni altra celebrazione, le divinità erano l’oggetto del culto pubblico che si strutturava in tre fasi: in un primo momento si commemorava la storia del dio, così come la mitologia la rappresentava, ricordandone le avventure, i combattimenti, le vittorie e le disfatte. Nei due momenti successivi, si poneva in rilievo il ruolo degli dei nell’opera di incivilimento dell’uomo, celebrandoli come «créateurs des sociétés et comme les inventeurs des arts utiles»13. Il popolo ringraziava la divinità per aver dato all’uomo la conoscenza delle arti, grazie a cui la vita miserabile e selvaggia degli antenati era stata superata, e ne celebrava la gloria per avergli donato l’arte della politica e della legislazione. È interessante notare come tutti questi momenti sono caratterizzati dal binomio tristezza-allegria; da un lato la narrazione di episodi tragici della vita della divinità e il ricordo della miseria degli avi, dall’altro la gioia per la condizione presente e la credenza che le sofferenze della divinità siano state funzionali alla loro immortalità: «la tristesse était tempérée par la joie et la joie par la tristesse»14.
A questo punto appare fondamentale ricostruire lo spirito e le motivazioni segrete dei culti misterici. Svelare al popolo la falsità degli dei, «lui dire que ses dieux n’étaient que de faux dieux»15, non avrebbe comportato alcun pericolo per la stabilità e la perpetuazione della società. «Il ne fallait pour cela qu’aider les progrès des connaissances, et de dégager aux yeux du vulgaire la divinité des nuages qui l’obscurcissaient»16. Ancora, si potrebbe sostenere che i misteri avessero voluto nascondere il racconto delle antiche catastrofi naturali avvenute sulla terra; tuttavia la storia del diluvio era ben conosciuta anche dal popolo. Un’altra motivazione della segretezza che aleggiava intorno a questi culti poteva essere ravvisata nelle pratiche spesso barbare e indecenti che accompagnavano i riti; ma queste usanze che avrebbero giustamente potuto essere nascoste, erano tuttavia tollerate e in uso in molte altre cerimonie.
Per cercare di penetrarne il segreto dei misteri appare necessaria la consultazione di fonti antiche. In Plutarco appare scritto: «tous les mystères ont rapport à la vie future et l’état de l’âme après la mort ; […] nous sommes instruits de ces grandes vérités que l’âme est incorruptible». Cicerone scrive: «ce sont les mystères de Cérès qui nous ont appris à mourir avec l’espoir d’un avenir plus heureux». Ancora, «Platon a dit qu’on apprenait dans les mystères que la vie n’est qu’un lieu de passage»17. E in molti altri autori (Aristofane, Diogene, Euripide, ecc.) si ritrovano questo genere di affermazioni che associano i culti misterici a una vita dopo la morte. La nozione dell’immortalità dell’anima non sembra tuttavia oscura al popolo che dai racconti dei poeti18 conosceva il Tartaro, i Campi Elisi, l’Acheronte, Minosse, Radamanto ed Eaco. «Les peuples et les initiés aux mystères connaissaient également une vie future ou un autre état après la mort; mais les peintures fabuleuses et contradictoires que l’on avait faites de cet état, faisaient que depuis long-temps le peuple n’y croit plus; […] les initiés au contraire y croyaient toujours, parce qu’ils en avaient des idées plus pures et plus raisonnables»19. Non si perviene ancora a capire quale possa essere la vera motivazione della segretezza dei misteri.
In relazione a quanto detto in precedenza, si può intuire che alla base vada collocata l’esperienza diluviana; infatti, secondo Boulanger, solo nell’uomo reduce delle catastrofi naturali e nelle manifestazione della natura si potrà cogliere il nocciolo della questione. Gli uomini sopravvissuti al diluvio conducevano una vita selvaggia e nomade; solo con il tempo e la casualità iniziarono a crearsi alcuni nuclei stabili di uomini e progressivamente il ricordo dei cataclismi si affievolì; tuttavia solo con l’intervento della politica e della religione si iniziò a dirigere il culto in modo da renderlo conveniente ai bisogni della società, andando così a creare delle pratiche religiose segrete. «L’institution des mystères doit donc être regardée comme un des plus grands ressorts qui après avoir lié l’homme à la société et l’avoir rendu agriculteur, le fixa dans sa demeure et forma des nations policées. […] En un mot, c’est par les mystères que l’homme s’est trouvé heureux et policé»20. Per far dimenticare all’uomo le spaventose e tristi immagini che lo assediavano, si rendeva necessario celare agli individui verità sconvenienti, instaurando la pratica dei misteri. Si può dunque affermare che l’antichità abbia fatto un uso politico-civile della religione, per stabilire unasocietà salda e priva di disordini. Ma ciò che ancor più colpisce è che alla base della costituzione della religione si ravvisa una motivazione naturale; infatti si pone alla «radice di ogni religione il ricordo del diluvio, di un fatto naturale cioè, ancora oggi constatabile dalla ragione osservatrice e scientifica dell’uomo»21.
Tuttavia non era tanto la memoria del diluvio a voler essere bandita, quanto piuttosto «la science de l’avenir» che non va ricondotta esclusivamente al dogma dell’immortalità dell’anima e della vita futura, che, benché facesse parte dei misteri, era ormai nota ai più. Dalle parole di Dionigi di Alicarnasso, Boulanger risale al vero segreto dei culti misterici: «les mystères avaient non seuleument rapport aux anciens malheurs de l’univers dont le peuple savait au moins une partie, mais encore qu’on y annoncait ses malheurs à venir; et c’était là ce qui rendait la science de l’avenir dangeureuse et nuisible à la société»22. La dottrina segreta dunque rivelava agli iniziati l’origini del mondo, ma soprattutto ne profetizzava la fine, annunciando la venuta di un dio distruttore e rinnovatore dell’universo. Una tale credenza, venata da pensieri apocalittici, si dimostrava estremamente pericolosa, dal momento che ostacolava e impediva la costituzione di società in grado di prodigarsi e lavorare per il benessere futuro.
A questo punto appare importante fare qualche precisazione circa la nozione di progresso23, uno degli elementi di maggior interesse e di rilievo filosofico nel pensiero di Boulanger. A partire dall’esperienza del diluvio sono due i filoni che percorrono paralleli la storia dell’umanità: l’uno è quello religioso, l’altro quello della ragione, intima compagna del progresso umano. Boulanger imputa alla religione una grave colpa, quella di aver introdotto una concezione ciclica del tempo, permeata sull’idea di un cosmo autodistruggentesi periodicamente24: «sia che la concezione ciclica si fondi sugli astri, sia che assuma un aspetto apocalittico predicando imminente il chiudersi del ciclo cosmico, sempre essa è di ostacolo alla vita civile, alla vita stessa dell’uomo»25, al progresso stesso dell’umanità. L’idea di un ciclo cronologico e umano colloca le sue origine naturali e storiche nel diluvio («les hommes ont été si vivement frappés de la destruction de leur ancienne demeure, que non-seulement ils en ont long-temps conservé le sovenir, mais encore qu’ils ont cru qu’ils avaient une nouvelle destruction à craindre»26); il suo centro psicologico va invece individuato nel mito dell’età dell’oro. Le avversità e i disagi non farebbero che originare negli uomini la credenza che la loro sia l’età del ferro e che sia dunque imminente una grande rivoluzione che condurrà a un nuovo inizio e con esso a una nuova età dell’oro. La grande intuizione di Boulanger fu quella di scorgere l’opposizione che sussiste, non solo tra ragione e religione, ma soprattutto tra religione e storia, che può scaturire soltanto con il nascere di una politica e un atteggiamento coscientemente umano. «Soltanto quando l’uomo, dopo aver guardato i cieli e gli inferni, ha finalmente rivolto lo sguardo […] al presente, alla terra, all’immediato, l’uomo ha dato inizio alla sua civiltà»27. La religione, dimensione totalizzante per l’uomo post-diluviano, gli aveva impedito di lavorare per conseguire la felicità terrena; solo sganciandosi dalla concezione ciclica e ponendo nell’uomo il fulcro della sua azione il progresso civile si è reso possibile. L’instaurazione dei misteri e dell’agricoltura pose indubbiamente le prime basi della società umana. La vicinanza di spirito con l’operato di quegli uomini antichi che diedero inizio alla civiltà, consente a Boulanger di istituire un confronto con l’illuminismo, teso a cercare i mezzi per garantire la vita sociale dell’uomo e il suo benessere, perseguendone la felicità: «notre temps est à quelques égards semblable à celui des premiers inventeurs de la police. Les esprits sont, comme eux, occupés à chercher les moyens de rendre les hommes plus sociables et plus heureux»28. Si scorge tuttavia un limite insito in questa concezione del progresso che va ravvisato proprio nell’idea di natura di Boulanger; egli che tanto combatte l’idea ciclica nella sua forma religiosa e apocalittica, la mantiene alla base della sua nozione di natura. Infatti il diluvio, che è alla base della ricerca di Boulanger, è identificato con il vocabolo ciclico per eccellenza, ossia «révolution»29.
Appurato le stretto legame che sussiste tra progresso e culti misterici, tra storia e religione, riprendiamo l’argomentazione di Boulanger che trattando la problematica dei misteri, non poteva non considerare i libri sibillini: quale sia l’origine storica di questi testi non è nota, ma non è tanto la collocazione storica che interessa e affascina Boulanger, quanto l’aura di sacralità che nell’antichità li avvolgeva. I testi antichi non sono purtroppo pervenuti, ma dalla lettura delle opere redatte in epoche successive, opportunamente depurate di alcuni elementi, si coglie molto bene quale dovesse esserne lo spirito; sembrerebbe che nella sostanza le «Sybilles payennes» e le «Sybilles modernes» non differiscano. Affini ai misteri, le Sibille altro non erano che libri apocalittici che profetizzavano catastrofi future tanto nella politica tanto nella natura. Lo spirito funebre e apocalittico che le caratterizza va ancora una volta ricondotto al ricordo delle catastrofi a cui il mondo fu sottoposto; Boulanger ipotizza che ogni popolazione abbia prodotto testi apocalittici «parce qu’ils avaient été enfantés par les impressions générales faites sur tous les hommes par des malheurs communs et généraux»30. I libri sibillini venivano consultati solo in casi eccezionali, quali potevano essere le guerre, le invasioni o il verificarsi di fenomeni naturali straordinari. La vista infatti di eclissi, comete o meteore era fonte di grandi sconvolgimenti e timori, da imputarsi al ricordo, seppure talvolta inconscio, del diluvio. In ogni popolazione questi avvenimenti eccezionali erano sempre accompagnati da feste e usanze la cui vera motivazione venne progressivamente celata da simboli, allegorie e favole, dimenticando il male che ne era all’origine. Per gli antichi, le cui conoscenze astronomiche erano piuttosto limitate, le eclissi, così come le comete, erano dei segni del cielo, presagio di sconvolgimenti naturali o politici. Proprio questo progressivo oscuramento e il conseguente fraintendimento delle motivazioni originarie, può essere individuato come unico elemento dinamico della filosofia della storia di Boulanger.
La sua prospettiva può essere infatti ricondotta a un impianto sostanzialmente unitario che colloca all’origine di tutto, come causa diretta o remota, il grande trauma del diluvio. In questa prospettiva appare difficoltoso individuare momenti di trasformazione e di svolta se non nella radicale perdita della consapevolezza circa i caratteri e i motivi delle istituzioni originarie31. Questa problematica è messa chiaramente in luce nel libro quarto in cui si occupa dell’«esprit liturgique»; la vita di tutte le popolazioni antiche era scandita da festività e celebrazioni che accompagnavano la fine e l’inizio di ogni nuovo ciclo cronologico e la cui essenza più profonda si perdeva nella notte dei tempi. Tratto comune di queste feste era dato dal binomio tristezza-allegria; la radice lugubre va certamente ricondotta all’esperienza del diluvio, che si tramutava progressivamente in gioia e serenità per il rinnovamento raggiunto. Boulanger propone un ampia rassegna delle feste presso i popoli antichi, analizzando le peculiarità della feste solari e quelle lunari per giungere a ribadire come all’origine di queste ricorrenze vadano collocate motivazioni di matrice psicologica. «Les usages de tous les peuples du monde expliqués les uns par les autres, ramènent constamment à l’esprit primitif; chaque déclin d’année devait rappeller aux hommes que le monde avait été autrefois détruit et bouleversé, qu’il devait encore être détruit de nouveau, que cette fin serait peut-être la même que celle du période qui allait se terminer, et qu’il fallait s’y preparer en appaisant la divinité. Ce plan était conforme aux idées religieuses des hommes échappés aux malheurs de la terre; mais l’abus qu’on en fit tant en bien qu’en mal l’avait enseveli chez tous les peuples sous un amas monstrueux de fables et de chimères»32.
La discussione intorno all’«esprit liturgique» si collega a filo diretto con problematiche di tipo religioso, che stanno sullo sfondo del pensiero di Boulanger. L’atteggiamento religioso ha accompagnato e modellato tutta la storia dell’umanità; in questa prospettiva religione e storia si compenetrano. Alla base di ogni religione si pone il ricordo del diluvio, di un fatto naturale dunque: in questa motivazione di ordine naturale del fenomeno religioso33 si può indubbiamente ravvisare lo spirito illuministico che anima Boulanger. La religiosità dei popoli antichi era venata da credenze essenzialmente apocalittiche34, fondata sul dogma che predicava l’avvento di un temibile giudice e il rinnovarsi della catastrofe primigenia, in buona sostanza ciò che i misteri si proponevano di nascondere al popolo. Proprio su questo dogma si innesta la storia civile e politica dell’uomo: «religione e politica si identificarono completamente nel passato dell’uomo»35, tanto che la vita sociale ha avuto come prima e unica base la teocrazia, ossia il governo di Dio sulla terra. Le società primitive vissero con gli occhi rivolti al cielo, realizzando una società integralmente religiosa: nelle Recherches sur l’origine du despotisme, proprio «l’assunzione del modello del governo dell’universo da parte di un Essere supremo anche per il mondo umano» appare essere l’errore politico fondamentale, che Boulanger intende mettere in luce per renderne immune la politica del presente36. Con il passare del tempo, questo spirito teocratico e apocalittico si affievolì, celandosi progressivamente. Gli uomini, che iniziarono a poco a poco a vivere in società, conservarono solo gli usi della primitiva società religiosa, senza mantenerne vivo lo spirito. Qui si innesta il meccanismo dell’idolatria per cui gli oggetti simbolici, originariamente destinati a ricordare in tutta innocenza le catastrofi naturali, furono divinizzati, nonché del politeismo per cui gli antichi avrebbero personalizzato e divinizzato ogni segno simbolico. Avvenne così il passaggio dalla divinità all’uomo: prima attraverso le monarchie teocratiche e i regni degli eroi, immersi ancora in un’aura magica e mitologica, poi con il dispotismo orientale, discendente diretto delle antiche teocrazie. I governi repubblicani sembrerebbero infrangere questo retaggio teocratico, ma, a una analisi più attenta, si perviene a ben altra conclusione. «La teocrazia, non aveva soltanto lasciato tracce nei culti e nelle istituzioni religiose sia di Atene, sia di Roma, ma aveva continuato a permearne anche le istituzioni politiche, che avevano il loro centro portante nella nozione di eguaglianza come essenza della libertà». I membri delle repubbliche erano tutti uguali, tutti re, legislatori e sudditi, ma in realtà questa uguaglianza rimaneva formale: «le système républicain […] fuiait le despotisme et partout le despotisme fut sa fin». La radice teocratica che sta alla base del governo repubblicano è data dal fatto che l’uguaglianza che ne è il fondamento è per il cielo e non per la terra. In relazione a quanto detto, la soluzione migliore è fornita dal governo monarchico. Non a caso Boulanger lavora alla stesura di un’opera in cui tratteggia i contorni della figura di Alessandro il Grande, illustre modello di un potere monarchico forte e stabile. È interessante notare come Boulanger, sulla scia del gusto e delle tendenze dell’epoca, alla fine del trattato Histoire d’Alexandre le Grand proponga un confronto tra il re macedone e Cesare, evidenziando pregi e difetti dell’uno e dell’altro. Fatta omissione della sua eccessiva e smodata emotività, Alessandro Magno costituisce un modello di coraggio, di conoscenza e di magnanimità, mai più riscontrabile nella storia, benché tante volte perseguito. Cesare stesso ne fu affascinato: «Alexandre fut pour César ce qu’Achille avait été pour Alexandre. […] Mais l’ambition était mieux placée dans Alexandre, né roi, que dans César, né particulier. Pour sortir de cette égalité, il a commis mille injustices dans l’Empire Romain; il n’y a pas un seul citoyen à qui il n’ait fait la plus grande de toutes les injustices, puisqu’il lui a ravi la liberté, le plus précieux de tous les biens»37. Nell’ottica di Boulanger, Cesare incarna il tiranno che, sotto il velo repubblicano, trama per raccogliere ricchezze e poteri; la morte violenta di Cesare non fu che la fine “naturale” a cui poteva andare incontro: «comme il s’était fait tyran, il eut le sort des tyrans et mourut de la mort qui leur est ordinaire»38.
In conclusione, l’analisi di Boulanger costituisce un caso particolare di analisi storico-politica; partendo da una comparazione cognitiva sul piano delle pratiche e delle credenze religiose, giunge infatti a illustrare e a inquadrare istituzioni e forme politiche. In particolare, di notevole interesse è l’analisi delle istituzioni repubblicane di cui ne sottolinea la negatività, ricondotta alle erronee basi religiose che le fondavano. La metodologia di ricerca adottata rappresenta uno sforzo di riflessione sulle forme politiche che va al di là del confronto esclusivamente politico39.
Le favole di Esopo?
Non stupisce scorgere tra gli scritti di Boulanger un trattato intitolato Esope fabuliste. Ou dissertation sur les incertitudes qui concernent les premiers écrivains de l’antiquité40; l’interesse che Boulanger rivolge alle favole e ai miti dell’antichità è un aspetto che sin dalle pagine dell’Antiquité dévoilée viene evidenziato. «Les traditions dédaignées»41 rivestono un’importante funzione storica e sono spesso l’unico tipo di fonte che ci permette di ricostruire la storia dell’uomo post-diluviano; infatti, secondo Boulanger «l’histoire de l’homme se partage naturellement en deux portions: l’une voilé par la nuit des temps contient les premiers pas des sociétés naissantes, l’autre plus connue et plus lumineuse montre à découvert ces société toutes formées»42. Il punto di discrimine viene fissato da Boulanger intorno al 538 a.C., anno in cui Ciro fonda la monarchia di Persia, destinata a sopravvivere fino all’avvento di Alessandro nel 330 a.C.; «le sixième siècle avant notre ère est le premier qui commence à être vraiment historique. […] je regarde [cette année] comme l’époque du monde historique»43. La monarchia persiana è infatti l’unica di cui possiamo ricostruire l’intera vicenda storica, dall’origine e dalla sua fondazione, fino alla disfatta e al crollo (Boulanger dedica uno scritto alla figura di Alessandro Magno, in cui ricostruisce le sue vicende biografiche, politiche e militari). Gli avvenimenti storici che si collocano a monte del VI sec. a.C. sono dunque immersi in un’atmosfera incerta e con contorni sfumati. «Ces fables ou ces énigmes sont les seuls monuments qui nous restent des premiers temps; nous n’en avons point d’autres et l’on ne peut se dissimuler qu’ils sont respectables à quelques égards par leur universalité. […] Je me determine donc à faire usage de ces traditions dédaignées; bien plus je ne veux me servir que d’elles pour remplir les vides de l’histoire et pour porter quelques lumières dans les epaisses ténèbres qui enveloppent encore le berceau des sociétés naissantes»44.
Il testo in esame prende le mosse dall’analisi dell’Iliade e si interroga circa la storicità di Omero, la cui esistenza risulta spesso essere immersa nella mitologia. Boulanger, rivisitando la scansione cronologica della storia greca sulla base della bellezza e del gusto proprio dell’Iliade, generalmente considerata figlia di un periodo buio, presuppone che il poema epico vada collocato in un secolo luminoso e prospero di cui la lingua dell’Iliade non sarebbe altro che lo specchio e a cui avrebbe seguito un lungo periodo di declino e ignoranza che avrebbe disperso tutte le produzioni del passato fino al tempo della presa di Babilonia da parte di Ciro.
Come Omero, anche Esopo ricade nella stessa aura d’incertezza; il problema risulta però spostato dall’ambito cronologico a quello spaziale: non è tanto l’epoca in cui Esopo vada collocato, quanto le sue origini a dover essere chiarite. Appoggiandosi su fonti storico-letterarie e talvolta su interpretazioni etimologiche ardite, Boulanger attraverso una lunga serie di ragionamenti giunge a sostenere che il personaggio che i Greci erano soliti chiamare Esopo altro non sarebbe che il saggio Lochman d’Oriente; ma ancora, si evince che quest’ultimo e il re ebraico Salomone (figlio di re Davide) sarebbero la medesima persona: «Salomon avec Lochman, et Lochman avec Esope. Ces trois sages n’en feront donc nécessairement qu’un, puisque leurs gestes et leurs ouvrages étant déjà les mêmes, leurs noms ou leurs surnoms ne sont que des synonimes»45. Proseguendo l’indagine si perviene a cogliere una sostanziale similitudine tra Salomone e Giuseppe (figlio di Giacobbe e Rachele): «enfin, après avoir vu que ce Salomon se confond dans Joseph, il reste nécessairement à rechercher si ce merveilleux cercle ne pourrait point se fermer par d’autres rapports inconnus et cachés entre Joseph lui-même et nos deux fabulistes [Esope et Lochman]»46. Boulanger propone un parallelo tra la vita di Esopo e quella di Giuseppe da cui si scorge una sostanziale uguaglianza. Unica macchia sembrerebbe essere il racconto degli ultimi giorni dei due personaggi; Esopo, al contrario di Giuseppe, muore di morte violenta. Ma, dietro questa differenza Boulanger scorge degli elementi analoghi che lo conducono a sostenere la tesi secondo cui tutte le popolazione della terra avrebbero tratto dalla Scrittura le proprie favole e racconti per poi trasformarli: «tous les peuples de la terre se sont appropriés les dépouilles du peuples de Dieu»47. Dunque, in relazione a quanto detto, solo Salomone e Giuseppe dovrebbero essere gli autentici redattori dei racconti morali che all’inizio attribuivamo a Esopo. Tuttavia allargando la prospettiva, Boulanger nota come il nome Salomone fosse largamente usato nell’antichità, fin dai tempi più remoti; il figlio di re Davide non sarebbe altro che la storicizzazione di uno dei tanti Salomone relegati alla dimensione favolistica. La conclusione di tale argomentazione conduce a sostenere che sin dall’antichità circolavano opere di morale di cui se ne ignora l’origine e da cui sono proliferati altri racconti e miti: «ce n’est plus qu’à l’antiquité en général que nous pouvons attribuer les différens ouvrages. […] Tout ceci nous représente pour l’Asie le même tableau que nous avons considéré chez les Grecs à l’occasion d’Homère»48. L’antichità tutta, fino all’epoca di Ciro, fu insomma caratterizzata dal medesimo quadro, di confusione e di imprecisioni: «confusion» che si manifesta in un’alternanza di periodi bui e d’ignoranza e altri luminosi e di grandi conoscenze. «Imaginons enfin que cette confusion arrive plusieurs fois, que l’histoire se change en mytologie et que la mytologie redevient encore fable, et que la fable se corrompt elle même, ce sera là la solution de toutes les énigmes qui se sont montrées dans cet ouvrage, et le vrai tableau de tous les siècles qui dans l’Asie comme dans l’Europe ont précédé l’epoque de Cyrus»49.
Permane ancora un problema: per quale motivo dall’Oriente siano giunti alla modernità i racconti morali e non le cronache storiche. Boulanger imputa questa mancanza alle grandi rivoluzioni che da sempre interessarono l’Asia: l’instabilità politica non poteva che causare la distruzione o quanto meno generare una confusione negli annali. Per quanto riguarda i libri morali, Boulanger ravvisa nell’Oriente uno spiccato gusto per la morale e vista l’impossibilità di avere una legislazione e un governo stabili, la morale costituiva una sorta di «législation générale et constante». «C’est la nature de la morale enfin, qui combinée avec le caractère des Orientaux et leur genre de gouvernement, nous a conservé les livres qui en ont traités, et qui sont vraisemblablement les anciens livres du monde»50. Boulanger affianca alla sua tesi una considerazione di tipo valutativo, per certi versi sconcertante e poco in linea con lo spirito illuminista: l’Oriente costituisce sì la culla di tutte le conoscenze, ma non è mai riuscito, a detta dell’autore, a emanciparsi da questo stadio infantile. L’Europa sembrerebbe invece essere il luogo privilegiato per compiere questo salto: «Europe! […] Votre destinée est d’être la partie pensante de toute l’humanité. […] Hâter donc l’approche de cet âge heureux par de nouveaux progrès dans les arts et dans les sciences, […] ne regardez plus cette Asie que comme une nourrice qui a donné à ses élèves les premiers éléments de la morale, en les amusant et les trompant d’un autre côté par des rêveries et des contes d’enfants»51.
In conclusione, tanto in Esope fabuliste tanto nell’Antiquité dévoilée, si intravede nella favola un importante mezzo per indagare l’antichità, per coglierne lo spirito e, forse, per chiarificare fonti storiche molto tarde e confuse. La favola, il mito e gli «usages», che Boulanger usa per scoprire l’«antiquité», diventano il veicolo privilegiato per indagare una memoria inconscia.
Note
1. Le notizie che abbiamo a disposizione intorno alla vita di N. A. Boulanger sono state ricavate da una lettera di D. Diderot, premessa all’Antiquité dévoilée par ses usages. Anche se non ci è dato sapere in quale occasione i due intellettuali si conobbero, dalla lettera appare evidente che fossero in stretto contatto, tanto che Diderot scrive: «J’ai été intimement lié avec lui». Alcuni dati sono stati inoltre ricavati da P. Sadrin, Nicolas-Antoine Boulanger ou avant nous le deluge, The Voltaire foundation, Oxford, 1986.
2. D. Diderot, Précis sur la vie et les usages de Boulanger, in Œuvres, volume 1, Slatkine Reprints, Genève, 1971, p. 5.
3. Cfr. F. Venturi, L’antichità svelata e l’idea di progresso in N. A. Boulanger (1722-1759), Gius. Laterza & figli, Bari, 1947, pp. 14-15.
4. N. A. Boulanger, L’Antiquité dévoilée par ses usages, Avant-propos, in Œuvres, volume 1, Slatkine Reprints, Genève, 1971, p 16.
5. N. A. Boulanger, L’Antiquité dévoilée par ses usages, Avant-propos, cit., pp. 11, 17.
6. Ivi, pp. 13, 19.
7. Cfr. A. Minerbi Belgrado, Sulla “filosofia della storia” di Nicolas-Antoine Boulanger, in Studi settecenteschi, volume 1, Bibliopolis, 1981, p. 65. Il rapporto tra Boulanger e Vico risulta piuttosto problematico; l’abate Galiani accusò addirittura di plagio Boulanger: l’Antiquité in cui non viene mai citato il nome dello scrittore napoletano altro non sarebbe che una riproduzione deformata della Scienza Nuova. Tuttavia a un’analisi più attenta, pur riconoscendo un’affinità di tematiche, non si può rintracciare una comunanza di soluzioni. (Cfr. F. Venturi, L’antichità svelata e l’idea di progresso in N. A. Boulanger (1722-1759), cit., pp. 124-140).
8. Coutumes, pratiques consacrées (Petit Larousse illustré, Paris, 1917).
9. Cfr. P. Sadrin, Nicolas-Antoine Boulanger ou avant nous le deluge, cit., p. 141.
10. Cfr. N. A. Boulanger, L’Antiquité dévoilée par ses usages, Avant-propos, cit., p. 26.
11. Bisogna tenere presente che Boulanger pone sullo stesso livello i popoli dell’antichità, delle Americhe e dell’Africa: «Il est encore une autre sorte d’antiquité que nous avons consultés […] en Afrique, en Amérique et dans les extrémités de l’Asie. […] Les usages de ces peuples sont un excellent supplément à ceux de notre antiquité». L’assenza di pratiche misteriche presso queste popolazioni fu, secondo Boulanger, fonte di danni e di pericoli. A riprova del ruolo fondamentale che hanno avuto questi culti nella costituzione della società umana, Boulanger racconta una pratica in uso presso i messicani che, alla fine di ogni secolo, in attesa della fine del mondo, distruggevano mobili e utensili, giudicati ormai inutili (N. A. Boulanger, L’Antiquité dévoilée par ses usages, Avant-propos, cit., pp. 30-31).
12. Si potrebbe instaurare un’analogia tra l’atteggiamento che gli antichi adottavano nei confronti dei «mystères» e l’idea che circolava presso alcuni illuministi secondo cui era opportuno mantenere riserbo e prudenza intorno alle proprie tesi, se non tra la cerchia dei propri amici. Lo stesso Boulanger, non pubblicando nessuno dei suoi scritti, si schierò in qualche modo a favore di questa prospettiva. Nella premessa alle Recherches sur l’origine du despotisme oriental, scrive: «j’aurais bien voulu écrire pour mes citoyens et pour le genre humain, mais sur cette matière je n’ai pu écrire que pour moi […] pour ne point produire de très grands maux en voulant produire de très grands biens» (cfr. F. Venturi, L’antichità svelata e l’idea di progresso in N. A. Boulanger (1722-1759), cit., pp. 5-6).
13. N. A. Boulanger, L’Antiquité dévoilée par ses usages, volume I, cit., p. 272.
14. Ivi, p. 276.
15.Ibidem.
16. Ivi, p. 277.
17. Ivi, pp. 281-282.
18. Si capisce fin d’ora come nella prospettiva di Boulanger sia importante utilizzare come materiale di studio i miti e le favole, sotto cui si celano verità.
19. N. A. Boulanger, L’Antiquité dévoilée par ses usages, volume I, cit., p. 288.
20. Ivi, p. 292.
21. F. Venturi, L’antichità svelata e l’idea di progresso in N. A. Boulanger (1722-1759), cit., p. 26.
22. N. A. Boulanger, L’Antiquité dévoilée par ses usages, volume I, cit., p. 297.
23. Cfr. F. Venturi, L’antichità svelata e l’idea di progresso in N. A. Boulanger (1722-1759), cit., pp. 55-65.
24. Diderot era affascinato dalla teoria di Boulanger che legava le prime manifestazioni religiose dei popoli antichi e «les révolutions physiques»; Diderot cercò di creare un nesso tra l’idea del ciclo naturale e il processo creativo dell’umanità, ma alla base egli poneva una diversa concezione della natura: «Boulanger si era limitato alla constatazione fisica e scientifica del diluvio e si era fermato di fronte al problema del ritorno di un simile fenomeno, per non infirmare le sue idee sul progresso. Diderot può ammettere invece una serie infinita di “révolutions”, poiché vedeva nella natura l’incarnazione stessa della vitalità e dell’evoluzione, di cui il progresso umano non gli pareva che una parte. […] Le catastrofi naturali non erano che dei momenti di una evoluzione generale, come le catastrofi sociali lo sono per il progresso dell’uomo» (Cfr. F. Venturi, L’antichità svelata e l’idea di progresso in N. A. Boulanger (1722-1759), cit., p. 77).
25. F. Venturi, L’antichità svelata e l’idea di progresso in N. A. Boulanger (1722-1759), cit., p. 56.
26. N. A. Boulanger, L’Antiquité dévoilée par ses usages, volume II, cit., p. 26.
27. F. Venturi, L’antichità svelata e l’idea di progresso in N. A. Boulanger (1722-1759), cit., p. 60.
28. Ivi, p. 63.
29. Cfr. F. Venturi, L’antichità svelata e l’idea di progresso in N. A. Boulanger (1722-1759), cit., pp. 64-65.
30.N. A. Boulanger, L’Antiquité dévoilée par ses usages, volume I, cit., p. 365.
31. Cfr. A. Minerbi Belgrado, Sulla “filosofia della storia” di Nicolas-Antoine Boulanger, cit., p. 71.
32. N. A. Boulanger, L’Antiquité dévoilée par ses usages, volume II, cit., p. 253.
33. Fabry d’Autrey concorda con Boulanger circa l’idea del diluvio come punto di partenza della storia umana, ma secondo il critico il diluvio altro non sarebbe che un miracolo religioso, un fatto unico e inspiegato. Boulanger, nemico del dogma cattolico, ricadeva dunque nella necessità di far rientrare nel suo schema proprio la religione. Fabry d’Autrey scrive: «Les incrédules […] ont tant disserté, ils ont fait tant de recherches, […] qu’ils viennent enfin de prouver évidemment la religion qu’ils voulaient anéantir». Va piuttosto sottolineato come Boulanger abbia cercato di esplorare un ambito che l’illuminismo aveva lasciato nell’ombra, introducendo un nuovo dialogo tra religione e ragione, tra religione e storia (Cfr. F. Venturi, L’antichità svelata e l’idea di progresso in N. A. Boulanger (1722-1759), cit., 79).
34. Che il fenomeno religioso si spieghi solo in riferimento al dominio di una reazione emotiva quale la paura, pone Boulanger sostanzialmente sullo stesso piano di Condillac e D’Holbach, e ancor prima di Hobbes e Spinoza (Cfr. A. Minerbi Belgrado, Sulla “filosofia della storia” di Nicolas-Antoine Boulanger, cit.).
35. F. Venturi, L’antichità svelata e l’idea di progresso in N. A. Boulanger (1722-1759), cit., p. 36.
36. Cfr. G. Cambiano, Comparazione e modelli nelle immagini settecentesche dell’antichità.
37. N. A. Boulanger, Histoire d’Alexandre le Grand, in Œuvres, volume VI, Slatkine Reprints, Genève, 1971, p. 401.
38. Ivi, p. 410.
39. Ivi, p. 223.
40. Benché Diderot lo testimoni, non si è sicuri che questo testo sia stato redatto da Boulanger; l’ipotesi più accreditata sostiene che sia uno scritto giovanile dell’autore. Esope fabuliste permane tuttavia in un’aura di mistero, dal momento che alla fine dello scritto si trova la strana data: Fait l’an de l’histoire 2295, che ha fatto pensare a un possibile legame di Boulanger con la massoneria.
41. L’interesse nei confronti di miti e favole non è una prerogativa esclusiva di Boulanger. Sono infatti numerosi gli autori che se ne occupano: Fontenelle, nella sua Origine des fables, tenta di ricostruire la dimensione psicologica e culturale entro cui ebbero origine le favole, Le Clerc e Bannier cercarono di istituire un legame tra mito e storia.
42. N. A. Boulanger, L’Antiquité dévoilée par ses usages, Avant Propos, cit., pp. 20-21.
43. N. A. Boulanger, Esope fabulite. Ou dissertation sur les incertitudes qui concernent les premiers écrivains de l’antiquité, in Œuvres, volume IV, Slatkine Reprints, Genève, 1971, pp. 258, 260.
44. N. A. Boulanger, L’Antiquité dévoilée par ses usages, Avant Propos, cit., p. 25.
45. Ivi, p. 271.
46. Ivi, p. 279.
47. Ivi, p. 286.
48. Ivi, p. 299.
49.Ibidem.
50. N. A. Boulanger, Esope fabulite, cit., p. 301.
51. Ivi, p. 305.
ETIENNE-GABRIEL MORELLY

A cura di Diego Fusaro
Etienne-Gabriel Morelly, nato nel 1717 (la data della morte resta incerta), fu un importante filosofo e scrittore politico francese del XVIII secolo. Nel 1753 diede alle stampe un poema in quattordici canti ferocemente criticato per le sue idee innovative: il Naufrage aux iles flottantes ou la Basiliade (Naufragio alle isole galleggianti o la Basiliade). In quest’opera, che si inscrive nel filone del genere utopistico, Morelly descrive uno stato organizzato sul principio del comunismo, inteso come una più giusta forma di esistenza e di vita pubblica. E in effetti per tutta la vita Morelly non fece altro che declinare in modi diversi la sua idea di una società strutturata comunisticamente, intendendola come progetto da realizzarsi. In questo senso, l’istanza comunistica morellyana si fonde con quella – tipicamente illuministica – di riorganizzazione della società in base ai principi della ragione. In un’altra opera, destinata a godere di maggiore fortuna e curiosamente a lungo attribuita a Denis Diderot, il Code de la nature (Codice della natura, 1755), Morelly ripercorre il tema della società giusta e comunisticamente strutturata: egli muove dal presupposto che le leggi di natura sono buone perché sono al contempo leggi di Dio e della ragione (senza che tra i due ambiti sussista alcuna contrapposizione) e, in virtù di tale presupposto, si propone di costruire un nuovo sistema sociale che impedisca all’uomo di diventare malvagio quale invece è – secondo un tema che viene codificato nel modo più efficace, oltre che più noto, dalla riflessione di Rousseau – nella società esistente, in cui a dominare è l’egoismo, frutto dell’esistenza della proprietà privata. Nella nuova società – argomenta Morelly – deve essere abolita la proprietà privata, poiché essa è la scaturigine dell’egoismo e dell’avidità, i due principali mali che dilaniano la società esistente. Da questi due mali derivano tutti gli altri. Sicché, eliminando quelli, verranno poi anche meno tutti gli altri e si avrà un vero e proprio “paradiso in terra”; espressione che, a tutta prima, potrebbe sembrare fuorviante, se adoperata per un autore illuminista; ma che in realtà ben adombra il carattere fortemente religioso – di una religione, ben inteso, del tutto secolarizzata – che innerva il progetto morellyano (ma il discorso potrebbe, forse, essere esteso a ogni altro progetto di tipo comunista, non da ultimo a quello “scientifico” di Marx ed Engels, secondo quanto suggerito – tra gli altri – da Karl Löwith in Meaning in History). Riattivando un’utopia vecchia quanto la Repubblica di Platone (e già a sua volta riattivata, per altro, da un Tommaso Moro con Utopia o, con un timbro più marcatamente teocratico, da Tommaso Campanella con La città del sole), Morelly sostiene che nella “società giusta” nessuno dovrà possedere se non gli oggetti di uso immediato, il mantenimento dei cittadini sarà a carico della Società a cui tutti contribuiranno secondo le loro possibilità ai bisogni generali grazie a una organizzazione sistematica del lavoro. Infine, lo stato dovrà prendersi cura dei fanciulli indirizzandoli presto a un lavoro manuale: un aspetto interessante dell’utopia morellyana, che ne mette bene in luce il retroterra illuministico, è la sua avversione alla metafisica, intesa come un retaggio della superstizione del passato. In forza di questa idiosincrasia per la metafisica, Morelly si spinge a sostenere che nella società comunista i fanciulli devono essere indirizzati al lavoro manuale e tenuti a debita distanza della sirene ammalianti della metafisica. Pensatore vigoroso e originale, Morelly, per il suo pensare la società comunistica nei termini di un’utopia da realizzare o, se preferiamo, di un ideale a cui dare cittadinanza nelle pieghe del reale, può essere con diritto inteso uno degli iniziatori di quel “socialismo utopistico” tratteggiato nelle pagine del Manifesto del partito comunista di Marx ed Engels: anch’egli, come più tardi faranno Saint-Simon, Fourier e Owen, immagina una società giusta (e comunisticamente strutturata) da realizzare. Certo, il suo – proprio perché le sue radici affondano nell’immaginazione e non nel “movimento reale della storia”, per utilizzare un’altra espressione marx-engelsiana – resta un utopismo astratto, incapace di fare presa sulla realtà. Ma il fatto stesso che egli vagheggi con tanta forza una società “altra” già racchiude in sé – proprio come sarà per Saint-Simon, Fourier e Owen – fortissimi elementi di critica sociale indirizzati contro la reale società del suo tempo. In altri termini – e qui sta sicuramente il merito dell’opera di Morelly –, se anche il suo progetto resta utopico e irrealizzabile, la sua denuncia delle ingiustizie della società reale, sospesa tra egoismo e avidità, resta di una potenza (e di un’attualità) straordinaria. Non è certo un caso che il movimento egualitario di François Noel Babeuf si richiamerà esplicitamente alla sua opera.
GABRIEL BONNOT DE MABLY

Gabriel Bonnot de Mably nacque a Grenoble il 14 marzo del 1709 e morì a Parigi il 2 aprile del 1785. La sua opera è sospesa tra «riflessione filosofica» e «critica sociale». Vissuto in una famiglia della nobiltà parlamentare, fu amico del filosofo Condillac, teorico del «sensismo». Mably ha denunciato i limiti del «dispotismo legale» (Doutes proposés aux philosophes et aux économistes sur l’ordre naturel et essentiel des sociétés politiques , 1768), e ha criticato con impeto il sistema politico inglese, accusandolo di subordinare il potere legislativo all’esecutivo. Il suo nom,e è legato soprattutto al suo progetto utopico di rinnovamento della società su nuove basi comunistiche. In questo senso, come Morelly, egli può essere con diritto considerato uno dei fondatori di quel “socialismo utopistico” tratteggiato nelle pagine del Manifesto del partito comunista di Marx ed Engels: anch’egli, come più tardi faranno Saint-Simon, Fourier e Owen, immagina una società giusta (e comunisticamente strutturata) da realizzare. Certo, il suo – proprio perché le sue radici affondano nell’immaginazione e non nel “movimento reale della storia”, per utilizzare un’altra espressione marx-engelsiana – resta un utopismo astratto, incapace di fare presa sulla realtà. Ma il fatto stesso che egli vagheggi con tanta forza una società “altra” già racchiude in sé – proprio come sarà per Saint-Simon, Fourier e Owen – fortissimi elementi di critica sociale indirizzati contro la reale società del suo tempo. In particolare, il pensiero di Mably è percorso da un’aspra polemica contro la società d’Ancien Régime, di cui denuncia le ingiustizie e – rivelandosi in ciò figlio del suo tempo – il carattere intrinsecamente irrazionale. Nella sua opera, comunismo e illuminismo si coniugano armoniosamente, essendo la società comunisticamente strutturata il modello di esistenza sociale più giusto e più razionale. Anch’egli, come Morelly e secondo un topos che deve la sua fortuna soprattutto all’opera di Rousseau (benchè fosse stato tematizzato per la prima volta da Platone nella Repubblica ), ravvisa la scaturigine dei mali che affliggono la società presente nella proprietà privata : è da essa che nascono l’egoismo, l’avidità e l’invidia, da cui poi discendono tutti gli altri mali (sociali e individuali) che costellano la società. La ragione impone pertanto di abolire la proprietà privata e di ristrutturare su basi comunistiche la società: solo per questa via diventa possibile risanare la società stessa e la vita dei singoli individui. E alla luce di queste consioderazioni che Mably difende apertamente, nei suoi scritti, la soppressione della proprietà privata e l’attuazione dell’uguaglianza degli uomini. Il progetto comunistico di Mably trova espressione soprattutto in due scritti: Observations sur l’histoire de France (Osservazioni sulla storia della Francia ), del 1765, e De la législation ou Principe des lois (Della legislazione o principio delle leggi ), del 1776. Va segnalato che, in Mably, il progetto «futuro-centrico» di una società comunista da attuare nell’avvenire si fonde con l’ammirazione per il passato, e in particolare per la società spartana: egli, infatti, prova sincera ammirazione per la virtù e per la frugalità dell’antica Sparta – intesa, non senza forzature, come prima forma di società comunista della storia –, intesa come modello da raggiungere. In questo modo, il futuro a cui aspira Mably si configura come un ritorno al passato, concepito come più giusto e migliore rispetto al presente. Il modello della vita giusta e del cittadino virtuoso è, agli occhi di Mably, l’antico Focione, alla cui figura egli dedica l’opera del 1763 intitolata Entretiens de Phocion sur le rapport de la morale et de la politique (Discorsi di Focione sul rapporto tra la morale e la politica ). In definitiva, se anche il progetto di palingenesi della società umana tratteggiato da Morelly resta utopico e irrealizzabile (non da ultimo perché si richiama a una Sparta idealizzata e mai esistita storicamente), ciò non di meno – e qui sta il punto fondamentale – la sua denuncia delle ingiustizie della società reale, sospesa tra egoismo e avidità, resta di una potenza (e di un’attualità) straordinaria. Secondo le riflessioni marx-engelsiane del Manifesto del partito comunista , il «socialismo utopistico» pecca di astrattezza e, per l’appunto, di utopismo, ma al tempo stesso è in grado di denunciare e di criticare le ingiustizie della società presente, mettendo a nudo le contraddizioni e le storture di cui è intessuta.
LOUIS-SÉBASTIEN MERCIER

Louis-Sébastien Mercier nacque a Parigi il 6 giugno del 1740 e morì nella capitale francese il 25 aprile del 1814. Autore oltremodo prolifico, deve la sua celebrità soprattutto alle due opere Tableau de Paris e l’An 2440, pubblicate prima dello scoppio della Rivoluzione francese. Cresciuto in una famiglia della piccola borghesia francese, decide ben presto di dedicarsi all’attività di scrittore. Viene nominato docente di retorica a Bordeaux, ma dopo non molto tempo decide di ritornare a Parigi. Nel 1781, Mercier comincia a pubblicare i due primi volumi del suo lavoro Tableau de Paris, opera che offre un affresco impareggiabile dei costumi del tempo. Negli anni a venire, continuerà a lavorare alacremente al suo scritto Tableau de Paris, che – una volta pubblicato – consterà di più di mille capitoli e di ben 12 volumi. Compone anche numerose opere teatrali e politiche. Il 1770 vede la pubblicazione dell’Anno 2440, un romanzo utopico originalissimo, in cui si specchia, per molti versi, l’età illuministica nel suo complesso. In collaborazione con Gabriel Brizard, François Henri Stanislas de L’Aulnaye e Pierre Prime Félicien Le Tourneur, Mercier pubblica – tra il 1788 e il 1793 – le opere complete di Jean-Jacques Rousseau, in 37 volumi. Allo scoppio della Rivoluzione francese, Mercier collabora attivamente a diversi giornali, soprattutto agli Annali patriottici, destinati a propagare le idee rivoluzionarie. In forte disaccordo coi Giacobini, che critica duramente sulla testata girondina Chronique du mois, Mercier ridicolizzerà lo stesso Robespierre: quando questi paragonerà i Giacobini ai Romani, Mercier risponderà: «non, vous n’êtes pas des Romains, vous êtes l’ignorance personnifiée!» («no, voi non siete dei Romani, voi siete l’ignoranza personificata!»). Politicamente, si mantenne su posizioni moderate: in qualità di membro della Convenzione, votò contro l’esecuzione di Luigi XVI : Durante il Terrore giacobino, venne imprigionato: fu rilasciato dopo la caduta di Robespierre, che Mercier ebbe modo di definire «Sanguinocrate». Altre opere importanti di Mercier sono le seguenti: Essai sur l’art dramatique (1773); Néologie ou Vocabulaire (1801); Le nouveau Paris (1799); Histoire de France (1802); Satire contre Racine et Boileau (1808). A questi vanno poi aggiunte le opere teatrali, tra le quali ricordiamo: Jean Hennuyer (1772); La Destruction de la ligue (1782); Jennval (1769); Le Juge (1774); Natalie (1775); La Brouette du vinaigrier (1775). Da tutti questi scritti affiora una profonda avversione verso i filosofi (soprattutto contro Voltaire); l’unico a cui Mercier guarda con simpatia è Rousseau, al cui pensiero si ispira ne L’anno 2440. È soprattutto in quest’opera che bisogna cercare il pensiero di Mercier. Si tratta di un romanzo filosofico che si inscrive nel filone dell’utopia: si immagina che un uomo – di cui non si dice il nome – discuta animatamente con un amico filosofo circa la giustizia di Parigi. Dopo la discussione, l’uomo sprofonda nel sonno: si risveglierà solo nel… 2440! La Parigi del 2440 è in tutto e per tutto migliorata: il sistema della giustizia è stato ripensato, lo spazio pubblico riorganizzato, il clero è sparito (e così pure le prostitute, la schiavitù, le tasse, il caffè, il tabacco, il the, gli eserciti), gli eccessi di ricchezze e povertà sono stati soppressi, ovunque domina la razionalità, secondo un sogno tipicamente illuministico. Ciò non di meno, la differenza tra ricchi e poveri continua a sussistere (in questo senso, l’utopia di Mercier non può certo essere qualificata come comunistica). L’anno 2440 è un’opera innervata dal pensiero illuminista: non solo, né soprattutto, per lo spirito anticlericale e antisuperstizioso; è uno scritto fortemente illuministico soprattutto per l’idea che essa propugna del futuro, inteso come uno spazio aperto in cui si attuerà un progresso illimitato. Nella Parigi del 2440 tutto è migliorato, la società è andata incontro a un inarrestabile progresso. Secondo un’idea tipicamente illuministica, la verità sta nel futuro: il passato è costellato da errori e da superstizione. Illuministica è anche l’idea – centrale ne L’anno 2440 – di un progetto politico da realizzare al fine di razionalizzare una società, di per sé, non ancora pienamente razionale. Ma l’aspetto che, più di ogni altro, rende originale e illuministica l’opera di Mercier è il particolare tipo di utopia che essa tratteggia: essa è significativa nell’ambito della letteratura dell’utopia perché è la prima, nel filone inaugurato dall’opera cinquecentesca di Tommaso Moro (Utopia), a porre l’utopia lontana nel tempo e non nello spazio, come era stato fatto fino ad allora da Moro stesso e successivamente da Tommaso Campanella ne La città del sole e da Francesco Bacone ne La nuova Atlantide: da Moro a Bacone il modello della società utopica è situato in uno spazio altro, in un altrove lontano ma contemporaneo (spesso insulare, per sottolineare maggiormente l’idea dell’incontaminato isolamento di quella società). Con Mercier l’utopia diventa ucronia: da non-luogo diventa non-tempo. La sua città ideale, infatti, non è situata in una città lontana e difficilmente raggiungibile; al contrario, la città al centro dell’opera di Mercier è la stessa Parigi, considerata però a distanza di secoli, in un futuro remoto e gravido di progresso. Si assiste così allo spostamento dalla proiezione spaziale a quella temporale, in un tempo futuro: a motivare tale spostamento è l’idea di un progresso a cui la storia sarebbe necessariamente destinata. Il progresso – la grande ideologia dell’Illuminismo – è il vero protagonista dell’opera di Mercier e della sua – secondo le parole di Rheinart Koselleck – «temporalizzazione dell’utopia» ( Verzeitlichung der Utopie). Il pensatore francese proietta nel futuro un modello di società giusta e razionale, convinto che nel percorso temporale che separa il 1700 dal 2440 il processo storico lo andrà necessariamente realizzando. A ben vedere, viene così inaugurato un modo di concepire la storia che si ritroverà, mutatis mutandis, anche in Karl Marx e nel suo «socialismo scientifico». È interessante ricordare che lo stilema narrativo impiegato da Mercier si trovi già in un’opera (purtroppo andata perduta) dell’antico Varrone, intitolata Sexagesis: in quest’opera, Varrone – precorrendo l’utopia di Mercier – immagina che un ragazzo sprofondi nel sonno e si risvegli sessant’anni dopo, trovando una Roma profondamente cambiata in peggio, sottoposta a un degrado morale incontenibile. Se per Mercier – figlio dell’Illuminismo – il futuro reca con sé progresso e miglioramenti di varia natura, per il latino Varrone – ma il discorso potrebbe in certa misura essere esteso a buona parte del pensiero antico – dal futuro non ci si deve aspettare altro che decadenza e regresso.
JOHANN SALOMON SEMLER

Johann Salomon Semler (1725-1791) fu un allievo di Baumgarten che passò alla storia per aver congedato una volta per tutte il vecchio metodo ermeneutica di stampo “logico-sistematico” per fare spazio all’indagine storica pura. Mentre Baumgarten era ancora vivo, Semler, a Halle, teneva lezioni di ermeneutica e prendeva pubblicamente posizione contro il “vecchio metodo”, consistente – lo ricordiamo – nel suddividere e nell’organizzare sistematicamente, tramite distinzioni di tipo scolastico, il contenuto della Sacra Scrittura. Ora, un simile metodo è per Sempler del tutto inadeguato e deve essere sostituito con un metodo che tenga conto delle effettiva natura degli scritti biblici, considerando la Bibbia non già come una totalità unitaria e in sé compiuta, ma, piuttosto, considerandola nelle sue differenze, e più precisamente nelle differenze che affiorano nei diversi libri di cui essa è composta. Tali differenze sono di varia natura: linguistiche, storiche, critiche. L’unità della Scrittura – fino ad allora assunta come presupposto indubitabile – viene da Semler dardeggiata nella sua celeberrima opera Abhandlung von freier Untersuchung des Kanons: suddivisa in quattro parti, l’opera venen data alle stampe tra il 1771 e il 1775. non bisogna più leggere la Bibbia nella sua totalità – spiega Semler –, ma bisogna piuttosto – secondo un insegnamento già prospettato da Turretini – indagare sui singoli libri di cui è composta la Bibbia e, per di più, condurre tale indagine con gli stessi princìpi interpretativi con i quali si interpretano tutti gli altri scritti profani. Ed è proprio sulla base di quseti presupposti metodologici che Semler studia i singoli libri del Nuovo Testamento, alla luce del loro carattere “locale”, vale a dire delle specifiche condizioni storiche che ne hanno accompagnato, a suo tempo, la genesi. In questo modo, egli sottolinea con enfasi l’elemento temporale, che si esprime con forza in ciascun libro del Nuovo Testamento. Traspare inoltre dalla teoria di Semler l’influenza generale dello “spirito del tempo” – l’Illuminismo –, che tanto aveva insistito sul problema del riconoscimento delle opinioni umane e delle loro ineliminabili differenze: il problema delle differenze è, come già abbiamo detto, centrale nel metodo semleriano. Semler insiste anche, a più riprese, sulla differenza tra il compito interpretativo e il compito dogmatico, nel tantino di spezzare il circolo in cui si era mossa l’ermeneutica protestante fin dai tempi di Flacio. L’attenzione all’uso linguistico e l’autonomia del metodo storico come princìpi interpretativi ponevano tuttavia a Semler seri problemi: tra questi, il maggiore riguardava la difficoltà di distinguere, all’interno dei testi biblici, la parte riconducibile alle conoscenze, alle opinioni e alle credenze umane, da quella in cui a esprimersi erano direttamente le verità rivelate. Dove e come si può tracciare il confine tra i due ambiti? Secondo Semler, lo si può tracciare tramite il criterio che permette di distinguere quel che è posto al servizio del divino. Nell’additare questo criterio, però, Semler lasciava al libero gioco della soggettività interpretante il compito di tracciare quel confine. Ma in questo modo – e sarà lo stesso Dilthey a rinfacciarglielo – voltava le spalle a uno degli scopi che aveva egli stesso dichiarato di voler perseguire a tutti i costi: ossia la chiara distinzione, tramite il ricorso al metodo dell’interpretazione storica, tra il nucleo fondamentale e costante della religione e il variare prospettico (e potenzialmente infinito) delle opinioni umane.
JOHANN AUGUST ERNESTI

Johann August Ernesti (1707-1781), con le sue tesi in ambito ermeneutico, influenzò in maniera radicale l’ermeneutica successiva, dandole un’impronta indelebile. L’opera di Schleiermacher sarebbe, ad esempio, impensabile senza il contributo di Ernesti. Non a caso, Schleiermacher iniziò a insegnare a Halle nell’autunno del 1804 muovendo dal testo ernestiano Institutio interpretis Novi Testamenti. Il grande merito di Ernesti fu, tra i tanti, quello di introdurre nella cultura del suo tempo la lezione della filologia olandese, che si era già liberata da un pezzo dai condizionamenti teologici e aveva affermato come propria base scientifica lo studio grammaticale. Soprattutto tramite lo sviluppo di questo filone, e in particolare tramite lo studio comparato delle lingue condotto tramite il confronto etimologico, Ernesti arrivò a teorizzare la necessità di interpretare i testi tenendo conto esclusivamente dell’uso linguistico dei vari autori. Ma in che cosa consiste, in concreto, l’ “uso linguistico” a cui allude Ernesti? Non lo si può comprendere senza fare riferimento alla convinzione, diffusissima nel Settecento, secondo la quale il significato dei termini fosse convenzionale e che, per ragioni di economia, una stessa parola potesse ricoprire una pletora di significati. Ciò avrebbe portato con sé alla costituzione, all’interno di una stessa lingua, di cerchie linguistiche differenti, entro le quali l’uso delle parole sarebbe stato determinato da circostanze di carattere temporale, educativo, culturale, politico, sociale, religioso, e così via. Su questa base comune si sarebbe poi venuta a innestare la personalità del singolo autore, senza che tale componente individuale di arricchimento linguistico spazzasse comunque via l’elemento comune, su cui sarebbe stato possibile costruire l’interpretazione. Il compito ermeneutica dell’interprete sta allora, per Ernesti, nell’intendere ogni testo, ogni passaggio dell’autore da interpretare da un punto di vista grammaticale, considerando solo come strumenti ausiliari tutti gli altri elementi, che prima avevano avuto al contrario un peso decisivo, come ad esempio la natura dell’oggetto indagato, gli scopi perseguiti dal testo, ecc. Ernesti andò anche elaborando un metodo che consisteva nell’esame dell’aspetto grammaticale e, ancor più, lessicale del testo, fatto oggetto di attenta osservazione allo scopo di cogliere “che cosa ciascuna parola in una data epoca, in un dato autore, in una data forma del discorso significhi”. È su questo problema che Ernesti credeva di poter fondare l’intera ermeneutica, giacché i principi di quella disciplina, dai quali soltanto potevano poi essere inferite le regole, non erano per lui altro se non il prodotto di un’opera di astrazione praticata sulle osservazioni. Con questa acuta – benché unilaterale – attenzione per l’empirico, Ernesti veniva in questo modo a fondare quella che in seguito avrebbe ricevuto il titolo di “ermeneutica occasionale”, poiché fondata su osservazioni singole e prive di quell’aspetto sistematico che avrebbe pi contraddistinto l’ermeneutica di Schleiermacher. Per quel che riguarda la concreta applicazione di questi principi generali, appena enunciati, Ernesti distingue oculatamente tra l’interpretazione grammaticale e quella allegorica.
PAUL HEINRICH DIETRICH D’HOLBACH

La natura, voi dite, è del tutto inesplicabile senza un Dio. In altri termini, per spiegare ciò che capite ben poco, avete bisogno di una causa che non capite affatto.
Con Paul Heinrich Dietrich barone d’Holbach (1723-1789) , nato in Germania ma naturalizzato francese, il materialismo raggiunge la sua espressione più organica e dottrinaria. Holbach é una delle figure più dinamiche della cultura illuministica in Francia: il suo salotto parigino e il suo castello di Grandval furono punto di incontro dei più importanti esponenti della cultura settecentesca, sia francese (diderot, Helvètius, Turgot) sia straniera (Hume, Smith, Beccaria) ; scrisse molte voci per l’Enciclopedia, il manifesto degli illuministi e pubblicò , come Voltaire, molti testi della letteratura filosofica clandestina o opere dei deisti inglesi che , per via della radicalità delle loro tesi, non erano stati tradotti e diffusi sul suolo francese. La sua stessa opera principale, il Sistema della natura (1770) , fu condannata al rogo per il materialismo apertamente difeso in essa. Holbach sostiene , infatti , una rigorosa identificazione della natura con la materia , pervenendo ad una concezione rigorosamente meccanicistica e deterministica: la natura é un gran tutto regolato da leggi deterministiche e composto da materia in movimento e in trasformazione continui. . Di conseguenza anche l’uomo é concepito come un essere puramente fisico , che sottostà, come tutti gli altri enti naturali, alle leggi necessarie della natura materiale: la negazione della libertà umana é totale in Holbach. L’uomo non é libero di volere, ma é spinto ad agire dall’amor di sè, che é il corrispettivo morale di quella forza che agisce su tutti gli esseri naturali, cioè della gravitazione. Il suo temperamento individuale é il risultato di cause fisiche e chimiche che cominciano ad agire fin dalla sua esistenza prenatale. L’azione dell’uomo é determinata dalla ricerca della felicità , la quale viene definita anch’essa in termini puramente fisici e materiali, come piacere duraturo. Nelle sue ultime opere, soprattutto nella Politica naturale (1773) e nella Morale universale (Morale universelle) (1776) egli sviluppa le conseguenze etico-politiche del suo radicale materialismo . Riprendendo le tesi eudemonistiche consuete nel pensiero illuministico che volevano la felicità per il maggior numero possibile di persone, Holbach vede nella felicità la finalità sia dell’agire individuale, sia dell’organizzazione politica . Ogni istituzione che impedisca il conseguimento di tale fine naturale perde con ciò stesso la sua legittimità , sia che essa abbia carattere politico (come nel caso del despotismo) sia che essa abbia carattere religioso (come nel caso dell’organizzazione ecclesiastica). Holbach prospetta quindi la possibilità di una società di atei , nella quale il riferimento a Dio e ai valori soprannaturali viene sostituito dal riconoscimento di una legge della natura (e della materia) che, prescrivendo la felicità di ciascun uomo, prefigura un ordine socio-politico universale. E d’altronde Holbach non può che approdare all’ateismo più radicale, sono le sue stesse tesi filosofiche a condurlo a tale concezione: riducendo tutto a materia e abolendo ogni forma di spiritualità, ecco allora che Dio, l’ente spirituale e immateriale per eccellenza, viene a cadere: non può esistere. E Holbach non arriva alla conclusione hobbesiana della materialità di Dio, ma , più semplicemente, ne nega l’esistenza. Celebre é la sua espressione sprezzante nei confronti del Dio cristiano e , più in generale, di ogni forma di divinità: Se Dio é dappertutto,é anche in me, agisce con me, sbaglia con me, offende Dio con me, combatte con me l’esistenza di Dio . Ma Holbach non si limita a rifiutare l’esistenza di un Dio-persona come quello cristiano, bensì non accetta neanche quello dei deisti, il Dio-orologiaio, la cui esistenza sarebbe dimostrata soltanto dall’ordine e dalla legalità della natura: si tratta per il barone di un’ipotesi assurda che non aggiungerebbe nulla alla natura stessa, che non é effetto del “caso”, ma di una concatenazione di cause ed effetti. Con Holbach appare nel modo più evidente come, all’interno dell’Illuminismo francese, l’ipotesi materialistica si trasformi in una concezione del mondo e della realtà , ovvero in una vera e propria metafisica . Se dunque i materialisti francesi condividono con l’illuminismo l’esigenza di dare una spiegazione scientifica della realtà , essi finiscono però col sostituire alla vecchia metafisica spiritualistica o dualistica una nuova metafisica materialistica , cioè un sistema costruito a tavolino sulla base di princìpi astratti. L’uomo per Holbach é prodotto dalla natura e sottoposto alle sue leggi e l’idea del Dio orologiaio che con la sua intelligenza avrebbe creato il tutto va scartata : é solo un’illusione antropomorfica , é l’uomo che immagina Dio e i suoi comportamenti a propria somiglianza. Naturalmente Holbach sostiene la mortalità dell’anima: se la natura é materia vivente , lo é anche il pensiero; se in natura tutto nasce e tutto muore , si crea e si distrugge , così é anche per lo spirito umano. Quella che Cartesio aveva chiamato res cogitans , ossia la spiritualità e il pensiero, vengono da Holbach ricondotte a res extensa , ovvero a pura materialità e corruttibilità.
CONDORCET

L’uomo non diverrà certo immortale, ma la distanza tra il momento in cui comincia a vivere e l’epoca comune nella quale naturalmente, senza malattie, senza accidenti, prova la difficoltà di esistere, non può forse aumentare di continuo? (Abbozzo)
CONDORCETJean-Antoine-Nicolas-Caritat, marchese di Condorcet, nasce a Ribemont, Aisne il 17 settembre 1743. Fu uomo politico, economista, matematico e filosofo. Amico di Turgot, venne da questi nominato “ispettore delle monete” (1775); era in buoni rapporti anche con Jean-Baptiste D’Alembert (col cui appoggio venne eletto all’Académie française nel 1782), con gli enciclopedisti in generale, e in particolare con Voltaire. Fu uno dei pochi grandi illuministi a vedere il compiersi degli avvenimenti della Rivoluzione francese, alla quale partecipò attivamente, schierato col partito girondino; ma la sua ostilità rispetto a Robespierre e al progetto di costituzione del ’93 gli valse la proscrizione. In seguito a un tentativo di fuga venne incarcerato. Morì misteriosamente in prigione, forse suicida, a Bourg-La-Reine, nei pressi di Parigi, il 29 marzo 1794. L’interesse principale di Condorcet fu la matematica (Sul calcolo integrale, 1765; Saggi di analisi, 1768), considerata anche in vista delle sue possibili applicazioni alle scienze sociali e morali, al fine di individuare costanti in un mondo fino allora considerato soggetto a variazioni imprevedibili (Saggio sull’applicazione dell’analisi alla probabilità delle decisioni prese a maggioranza di voti, 1785 e Quadro generale della scienza che ha per oggetto l’applicazione del calcolo alle scienze politiche e morali, postumo). In economia aderì alle teorie fisiocratiche, esposte nello scritto Riflessione sul commercio dei grani (1768). La sua opera più celebre è l’Abbozzo di un quadro storico dei progressi dello spirito umano, prospetto di un’opera più vasta e incompiuta della quale restano solo parti frammentarie pubblicate postume nel 1795. Anche se composto nel momento in cui Condorcet assisteva al proprio fallimento personale, l’Abbozzo di un quadro storico dei progressi dello spirito umano presenta intatto l’ottimismo rivoluzionario del suo autore. Nella rivoluzione Condorcet scorge infatti la conferma della verità del progresso; sotto l’influenza di questa nuova temperie storica e culturale, egli concepisce il progresso come un avanzamento necessario e indefinito. La storia viene suddivisa in dieci epoche. Le prime nove sono la puntuale ricostruzione dell’avanzamento storico già realizzatosi che, al di là delle differenze che distinguono le singole epoche (dalla Grecia classica alla Rivoluzione), è caratterizzato da due fattori costanti: la vittoria della libertà sul dispotismo e quella della ragione sull’errore e sull’impostura religiosa. L’ultima epoca (la decima) riguarda il futuro e prevede l’ulteriore, indefinito progresso dell’umanità in tre direzioni: a) l’eliminazione delle disuguaglianze tra le nazioni; b) l’estensione dell’eguaglianza in seno ai singoli popoli; c) il perfezionamento della stessa natura umana.
Schema dell’Abbozzo di un quadro storico dei progressi dello spirito umano
Scritto in condizioni disperate (in clandestinità, pochi mesi prima del suicidio in carcere), il Saggio di un quadro storico dei progressi dello spirito umano resta l’espressione più audace ed esemplare di una concezione della storia come progressivo trionfo della ragione. “La natura non ha posto alcun limite al perfezionamento delle facoltà umane”, scrive Condorcet, che vede nella storia un’inarrestabile marcia verso il progresso, il rischiaramento, la sconfitta della superstizione e dell’ignoranza. Si tratta di una concezione che sarebbe stata poi sottoposta a innumerevoli critiche e revisioni, ma che ebbe una funzione dirompente nello scalzare la visione cristiana della storia come processo di degradazione e di perdita.
INDICE
Introduzione
Avvertenza
Saggio di un quadro storico dei progressi dello spirito umano
Prima epoca: Gli uomini sono riuniti in tribù
Seconda epoca: I popoli pastori. Passaggio da questo stato a quello dei popoli agricoltori
Terza epoca: Progressi dei popoli agricoltori fino all’invenzione della scrittura alfabetica
Quarta epoca: Progressi dello spirito umano in Grecia fino alla divisione delle scienze verso il secolo d’Alessandro
Quinta epoca: Progressi delle scienze dalla loro divisione fino alla loro decadenza
Sesta epoca: Decadenza dei lumi, fino alla loro restaurazione verso il tempo delle Crociate
Settima epoca: Dei primi progressi delle scienze verso la loro restaurazione nell’Occidente, fino all’invenzione della stampa
Ottava epoca: Dall’invenzione della stampa fino ai tempi in cui le scienze e la filosofia scossero il giogo dell’autorità
Nona epoca: Da Cartesio fino alla formazione della repubblica francese
Decima epoca: progressi futuri dello spirito umano
Passi tratti dalle opere di Condorcet
Ma, se si considera questo stesso svolgimento nei suoi risultati, relativamente agli individui che esistono nello stesso tempo in uno spazio dato, e se lo si segue di generazione in generazione, esso ci offre allora lo schema generale dei progressi dello spirito umano. Tale progresso è sottoposto alle stesse leggi generali che osserviamo nello sviluppo delle facoltà dei singoli individui, poiché è il risultato di tale sviluppo, considerato nello stesso tempo in un gran numero di individui riuniti in società. Ma il risultato che ogni istante presenta dipende da quello risultante dagli istanti precedenti; e influisce su quello dei tempi che ancora devono venire.[…]
[Condorcet, Abbozzo di un quadro storico dei progressi dello spirito umano]
Tutto ci dice che stiamo arrivando all’epoca di una delle grandi rivoluzioni della specie umana. Chi può meglio rischiararci su ciò che dobbiamo attenderci da essa? chi ci può offrire una guida piú sicura per condurci nell’intimo del suo sviluppo se non il quadro delle rivoluzioni che l’hanno preceduta e preparata? Lo stato attuale dei lumi ci dice che essa sarà felice; ma non è forse anche vero che ciò sarà possibile soltanto a condizione che noi sapremo servirci di tutte le nostre forze? E, affinché la felicità che essa promette sia acquistata ad un prezzo meno caro, affinché essa si espanda con piú rapidità in un piú ampio spazio, affinché essa sia piú completa nei suoi effetti, non abbiamo bisogno di studiare nella storia umana quali ostacoli dobbiamo ancora temere, quali mezzi abbiamo per superarli?
[Condorcet, Abbozzo di un quadro storico dei progressi dello spirito umano]
ROUSSEAU

LA VITA, LE OPERE E LA FORMAZIONE CULTURALE
Jean Jacques Rousseau nacque a Ginevra nel 1712 ed ebbe un’infanzia difficile : la madre morì di parto e il padre dovette ben presto lasciare la città. Il giovane Rousseau ricevette l’appoggio di Madame de Warens, una dama svizzera al servizio del re di Sardegna, che gli fece da matrigna e da amante. Durante questo periodo – in cui soggiornò ad Annecy (nella Savoia), Torino, varie località della Svizzera, Chambery – esercitò diversi mestieri e completò la sua formazione intellettuale con numerose letture. Separatosi da Madame de Warens, arrivò a Parigi ed entrò in contatto con gli Enciclopedisti. Scrisse parecchi articoli per la famosa Enciclopedia, tra cui alcuni di carattere musicale : si dilettava infatti anche di composizione, ed un suo melodramma fu persino rappresentato a Versailles, alla presenza del re. Nel 1757 interruppe i suoi rapporti con gli Enciclopedisti e si ritirò a Montmorency, dove scrisse La nuova Eloisa (1761), il Contratto sociale (1762), l’Emilio (1762). Poiché queste opere furono condannate sia dalle autorità parigine che ginevrine, si rifugiò a Neuchâtel, in un territorio svizzero ma soggetto al re di Prussia. Si trasferì per un po’ anche in Inghilterra, a Londra, su invito di Hume, ma poco dopo i rapporti fra i due pensatori di guastarono e Rousseau se ne tornò in Francia. Si ritirò, a causa delle cattive condizioni di salute, ad Ermenonville, dove morì nel 1778, dopo aver scritto un’autobiografia, che intitolò Confessioni. Il saggio che darà una certa notorietà a Rousseau fu il Discorso sulle scienze e sulle arti (1750), che egli aveva scritto in seguito ad un concorso indetto dall’Accademia di Digione sul tema: “La rinascita della scienza e delle arti ha contribuito a corrompere o a purificare i costumi?”. Il breve scritto di Rousseau, che otterrà il primo premio, rivelò una personalità originale, con una forte determinazione ad andare al cuore dei problemi e desiderosa di rinnovamento e di rigenerazione radicale della società. In apparenza, l’assunto del giovane Rousseau sembrava sostenere che le scienze e le arti non hanno contribuito al progresso bensì al regresso della civiltà, fiaccando gli animi e distogliendoli dal perseguimento delle più autentiche virtù civili e sociali. In realtà, il Discorso non criticava né la cultura né il sapere in sé. Li criticava solo nella misura in cui, tradendo la loro più vera missione, essi non operavano per il miglioramento dell’umanità, rendendosi talora persino complici del rammollimento dei costumi. Non dimentichiamo le responsabilità politiche che scienze ed arti hanno avuto (ed hanno) nello sviluppo del dispotismo repressivo degli Stati moderni. Rousseau vagheggia invece la polis dell’antichità, cioè è convinto che la mirabile armonia tra individuo e comunità, tra cultura e politica che fu un tempo di Atene e Sparta, dovrebbe essere il traguardo ambìto anche delle nazioni moderne. Molto più controllato, anche se altrettanto radicale, è il Discorso sull’origine della disuguaglianza tra gli uomini (1754), che Rousseau scrisse per un altro concorso, sempre bandito dall’Accademia di Digione. Egli esordisce dicendo che l’uomo di natura non è tanto un essere buono quanto un essere dotato di tendenze e istinti positivi. Per natura l’uomo è solo aperto al rapporto intersoggettivo ed è solo sollecitato, dall’istinto di perfettibilità, al proprio perfezionamento. Rousseau non confonde lo stato di natura con la mitica Età dell’Oro o col Paradiso Perduto; non crede che esso fosse il luogo o lo stato o la sorgente di tutti i beni e di tutti i valori. E soprattutto per lui lo stato di natura “non esiste più, forse non è mai esistito e probabilmente non esisterà mai”. Esso è dunque piuttosto una ipotesi, un paradigma valutativo e non qualcosa di reale. Riguardo poi l’origine della vita sociale, Rousseau non la identifica tanto con l’istituzione di un patto o di un contratto quanto con una rete assai più complessa di inclinazioni, bisogni, sentimenti. L’essenza della socialità è dunque cosa positiva : ciò che non è certo è che il suo sviluppo sia altrettanto positivo. Anzi fin dall’inizio l’egoismo, la brama di potere, il complicarsi delle relazioni generano il male e il conflitto sociale, che è anche conflitto umano. Ma Rousseau vuole fare un discorso politico ed individuare una causa cui concretamente imputare l’origine del male di cui sopra. Questa causa viene identificata con l’istituzione della proprietà privata. La proprietà privata produce infatti una disuguaglianza economica che tende rapidamente a coincidere con una disuguaglianza sociale e politica. Chi possiede, ha anche il potere. Il potere, in una spirale perversa, genera altro potere. L’élite dei proprietari è quella stessa che costituirà il sistema giuridico: un sistema iniquo perché finalizzato alla autoconservazione della forza e dell’autorità e alla perpetuazione della disuguaglianza. Nel 1762 Rousseau pubblica il Contratto sociale. In quest’opera si respira un’ansia di emancipazione per cui egli vorrebbe trasformare la realtà : creare una società libera ed egualitaria per rigenerare l’umanità. Il problema più arduo è mediare tra due realtà che Rousseau ritiene assolutamente certe e oggettive : da un lato che l’uomo è e deve restare libero; dall’altro che la società implica un ordine e quindi delle rinunce. Rousseau ritiene che sia possibile trovare una soluzione ripensando alla genesi della società. Il filosofo inglese Hobbes aveva affermato che solo una cessione generale di tutti i poteri da parte di tutti gli individui garantiva la tutela dell’uguaglianza tra i membri della società. Anche Rousseau parla di una alienazione totale, di ciascun associato, con tutti i suoi diritti, alla comunità. Egli pone però l’accento sul momento della comunità. In altre parole, per Rousseau l’uomo è persona e la società è un corpo vivente; la salute della società dipende dall’essere dei singoli cittadini; si deve perciò puntare ad una integrazione cooperante tra uomini e società (da ciò deriva anche la strettissima connessione, nell’opera di Rousseau, tra la riflessione sociopolitica e quella psicologico-antropologico-pedagogica, come vedremo tra breve nell’Emilio). Infatti solo individui opportunamente rigenerati permetteranno una radicale trasformazione della società. Secondo Rousseau, i cittadini, pur alienando tutti i loro diritti alla comunità, che ne ricava un massimo di autorità, restano liberi. E restano libri non solo in quanto acquistano uno stato di assoluta uguaglianza reciproca tutelata dalla legge, ma anche in quanto partecipano attivamente alla vita comunitaria, in quanto gestiscono direttamente il potere politico. Rousseau ha compreso, con grande acume, che una delle possibili matrici della illibertà risiede proprio nella delega del potere da parte del complesso dei cittadini ad un gruppo di essi. Tale delega appare a Rousseau comunque dannosa. La sovranità andrebbe attribuita invece al solo io comune del popolo. Solo il popolo è il legittimo titolare del potere. In più, il popolo può bensì affidare per motivi di convenienza pratica la gestione degli affari pubblici ad appositi deputati, ma costoro non devono essere considerati in alcun modo i depositari di una sorta di potere separato. L’ideale politico delineato da Rousseau si incarna in una comunità di non grandi dimensioni, in cui il cittadino sia, insieme, governato e governante (dietro tutto ciò c’era forse il modello di Ginevra). Ma un modello politico del genere è concretamente realizzabile? Rousseau risponde che l’uomo non è solo istinto, mera volizione egoistica e cieca; egli è anche ragione, coscienza, riflessione. Perciò può riuscire a guardare al di là del proprio perimetro soggettivo, a cogliere valori più ampi, a partecipare ad istanze che lo trascendono, pur restando anche sue proprie istanze. Questa capacità gli consente di ascoltare una volontà che non è la sua semplice volontà individuale, ma è la cosiddetta volontà generale. Essa è la voce della collettività, l’espressione degli interessi socialmente costituiti, la prospettiva rivolta costantemente all’utilità generale. essa è un’espressione di noi stessi, del nostro essere uomini. Obbedendo alla volontà generale, l’uomo obbedisce pertanto a se stesso, anzi, alla parte più razionale e morale di se stesso; per questo una tale obbedienza pone in essere la sola libertà degna di questo nome. In breve, l’uomo è propriamente tale solo in quanto è cittadino che coglie ed accetta le esigenze profonde e razionali della società. Nello stesso anno in cui è pubblicato il Contratto sociale, esce anche l’Emilio, e non a caso. L’opera delinea infatti un modello di uomo senza il quale il modello di società delineato nel Contratto sociale non poteva neppure essere pensato. L’educazione si configura per Rousseau come quell’intervento attraverso cui si può plasmare un’umanità capace di vivere, anzi di convivere, secondo i dettami della giustizia e della ragione. Prima che all’istruzione di un fanciullo e alla preparazione di un adulto o, meglio, di un cittadino, Rousseau punta alla formazione di un uomo : “Vivere è il mestiere che gli voglio insegnare. Uscendo dalle mie mani, egli … sarà prima di tutto un uomo : tutto quello che un uomo dev’essere, egli saprà esserlo, all’occorrenza, al pari di chiunque : e per quanto la fortuna possa fargli cambiare condizione, egli si troverà sempre nella sua” (cfr. Emilio, libro 1°). Il principio-guida dell’opera di Rousseau è costituito da una libertà ben guidata, non da una libertà capricciosa e disordinata. A tale scopo l’itinerario e l’ideale educativo deve essere graduale e rispettoso dei vari stadi di sviluppo. In primo luogo, il precettore non deve considerare il fanciullo come un adulto in miniatura : “La natura vuole che i fanciulli siano fanciulli prima di essere uomini. L’infanzia ha certi modi di vedere, di pensare, di sentire del tutto speciali; niente è più sciocco che voler sostituire ad essi i nostri”. Rispettando tale sviluppo, dalla nascita ai dodici anni, bisogna badare all’esercizio intelligente dei sensi. Da qui l’esigenza di educare il fanciullo a sviluppare liberamente il bisogno di muoversi, di giocare, di conoscere il proprio corpo. E’ il periodo della cosiddetta educazione negativa, la quale consiste “non già nell’insegnare la virtù e la verità, ma nel garantire il cuore dal vizio e la mente dall’errore”. Tale principio deriva dall’assunto che non vi è perversità nel cuore umano, che la deviazione e il vizio vengono dall’esterno. I vizi presi nell’età della prima formazione, quella che va appunto dalla nascita ai dodici anni, non saranno più sradicati : occorre perciò proteggere in ogni modo Emilio dalle influenze negative dell’ambiente, favorendo invece lo sviluppo delle sue inclinazioni naturali. L’educatore pianificherà ogni cosa affinché Emilio compia da sé le scoperte che costituiscono la sua conoscenza del mondo. Anche l’obbedienza, in questo periodo, sarà ottenuta con la pura autorità, senza discussione : “Adoperate la forza con i fanciulli e la ragione con gli uomini”. Dai dodici ai quindici anni occorre sviluppare l’educazione intellettuale, orientando l’attenzione del ragazzo verso le scienze, dalla fisica alla geometria all’astronomia, attraverso un contatto diretto con le cose, allo scopo di cogliere le regolarità e le necessità della natura; si collegherà inoltre ogni conoscenza ad un’utilità riconoscibile dal ragazzo, che ricostruirà poi da sé i principi delle scienze. Dai quindici ai ventidue anni è il momento dell’educazione morale, sociale e religiosa. L’educazione alla virtù farà di Emilio un “uomo morale” : e la moralità consisterà nel sapere disciplinare le passioni, seguendo il lume della ragione e la voce della coscienza. Da ultimo, l’educazione politica preparerà Emilio alla vita sociale : imparerà a distinguere il giusto dall’ingiusto e agirà secondo l’accordo della sua volontà con quella generale della comunità. Potrà così diventare un buon cittadino ed un buon marito e padre (conoscerà Sofia, la sua futura sposa). L’ideale etico-religioso di Rousseau in quest’opera è esposto nel quarto libro, nella famosa Professione di fede del vicario savoiardo. Le verità fondamentali in cui tutti credono sono due : l’esistenza di un essere supremo e l’immortalità dell’anima. Rousseau dice di rifiutare la dottrina del peccato originale e la salvezza soprannaturale e propone invece una “professione di fede puramente civile, di cui spetta al sovrano fissare gli articoli”. Tali articoli sono le due verità dette prima con in più “la santità del contratto sociale e delle leggi”, e l’aggiunta di un dogma negativo, l’intolleranza. “Bisogna tollerare – sostiene Rousseau – tutte quelle religioni che a loro volta tollerano le altre, fintanto che i loro dogmi non contengano niente di contrario ai doveri del cittadino. Ma chiunque osi dire che fuori della Chiesa non c’è salvezza, dev’essere espulso dallo Stato”.
Il Contratto Sociale di Jean-Jacques Rousseau
Un altro tema però ci introduce al Contratto Sociale, quello dell’importanza delle istituzioni politiche ( prefazione al Narcisse) , in cui R. si accorge che alcuni dei vizi da lui analizzati per l’uomo sociale in realtà vengono per un uomo mal governato….qui avremo il passaggio per francese dalla morale alla politica . Dunque vediamo come il termine preciso istituzioni si sostituisce a quello di società. Il punto chiave di questo passaggio è nell’introduzione al Narcisse:”Tutti quei vizi non appartengono tanto all’uomo, quanto all’uomo mal governato”. Cos’ bisogna porsi il problema del governare visto che un popolo sarà ciò che il suo governo lo farà essere. Così R. decide di scrivere le Institutions Politiques, dove un R. legislatore si occupo, innanzitutto dei popoli come governabili (indispensabili in questo caso saranno tutti gli esempi sui popoli antichi; questo confronto gli permetterà di mostrare come le istituzioni politiche valgono quanto gli uomini che esse avranno saputo formare. Gli “uomini illustri” di Plutarco non sarebbero esistiti senza le sublimi istituzioni dei popoli antichi, mentre gli uomini moderni devono in gran parte la loro corruzione alla stoltezza e all’inettitudine delle loro istituzioni. Questo confronto è stato fatto nel Discours sur les sciences et les arts mtre nel discours sur l’inegalitè il confronto oppone l’uomo selvaggio a quello civilizzato.
Qui le istituzioni ad essere in possibilità di ricevere aiuto dal testo sono quelle giovani o particolarmente meritevoli, o non troppo radicate nella perdizione di un certo tipo di società (Polonia), ma anche per le altre è possibile salvare i loro individui; a ciò vediamo molto legato L’Emile con le sue massime di educazione utili per salvare dalla perdizione il cittadino mal governato.
Uno dei progetti maggiori della carriera filosofica di R. è Istitutiones politiques opera di enorme respiro che egli stesso aveva auspicato come opera che gli avrebbe dato la fama. La sua attività letteraria si disperderà costantemente, al contrario per esempio di Montesquieu che riuscirà nell’ Esprit des lois proprio grazie alla sua costanza di lavoro. L’opera fu concepita nel 1743-4, ma iniziò a prendere vita solo nel 1754, mentre si potrebbe anche pensare che il manoscritto abbia avuto inizio a Ginevra nel 1756. Alcuni dei suoi concetti nascono prima, ad esempio la sovranità di cui rileviamo tracce già nella dedica introduttiva al Discours sur l’inegalitè. Le sue idee nascono dalle letture e dalle esperienze; R. non è stato partecipe della vita politica del suo stato nella sua epoca ma è stato un ottimo osservatore, di uomini e istituzioni del suo tempo. Lo stampo dell’opera però è politico, dunque va preso in considerazione il fatto che le letture di R. furono determinanti nella sua stesura: egli citava spesso Platone ma conosceva anche Aristotele; tra i moderni era conoscitore di Machiavelli, Bodin, Hobbes, Grozio, Pufendorf, Barbeyrac, Locke, oltre agli autori contemporanei, tra cui spicca Montesquieu. Non denota nemmeno particolare rispetto per i suoi predecessori, visto che li ingiuria quando li confuta e li passa sotto silenzio quando utilizza loro pensieri.
1. Nessun uomo ha l’autorità naturale sul proprio simile. Ne consegue che nessuna autorità può essere legittima, se è istituita o se viene esercitata senza il consenso di coloro che vi sono sottomessi.
2. L’autorità (sovranità) politica risiede essenzialmente nel popolo. Essa è inalienabile e il popolo non può affidarne l’esercizio a nessuno. Il singolo che rinunci alla sua libertà, rinuncia nello stesso tempo alla sua qualità di uomo. Così, un popolo che rinunci all’esercizio della sovranità con un patto di sottomissione, si annulla con quest’atto; ci sarebbero solo un padrone e degli schiavi. Le leggi sono l’espressione della volontà generale, e quando un uomo sostituisce la sua volontà a quella di un popolo, non c’è più un’autorità legittima ,ma un potere arbitrario. Poiché la legge non è che la dichiarazione della volontà generale, è chiaro che, nel potere legislativo, il popolo non può essere rappresentato.
3. Il governo o l’amministrazione dello Stato è solo un potère subordinato al potere sovrano ed è, nelle mani di coloro che lo detengono, un semplice mandato. Il governo cerca costantemente di sottrarsi all’autorità legislativa e tende a sostituire la propria volontà a quella del popolo nella amministrazione dello Stato. Quando ci riesce il patto sociale è infranto, ed i cittadini sono costretti, ma non obbligati ad obbedire.
La monarchia di cui parla R. lascia sovrano il popolo , dunque il potere del re è quello di far rispettare la volontà del popolo, dunque, la forma di governo appare più simile ad una democrazia che ad una monarchia. Egli è però il primo a rifiutare la sovranità del re. L’unico governo sano per R. è la democrazia spesso accompagnata dal nome di repubblica, mentre dove il re ricoprirà ancora cariche pubbliche non si rassegnerà mai a far esercitare le leggi, ma tenterà sempre di togliere la sovranità al popolo ed esercitarla a suo profitto.
Il cittadino resta libero se si sottomette alla volontà generale, che è anche la sua. Ciò è possibile solo se il cittadino fa astrazione dal suo io individuale per integrarsi totalmente nella città. La volontà generale esiste solo in uno stato composto di cittadini: non esiste nella monarchia, dove ci sono sudditi. Da qui la necessità per il legislatore di trasformar l’uomo in cittadino attraverso l’educazione pubblica, di “darlo interamente allo Stato”.
Invece di distruggere l’uguaglianza naturale, il patto fondamentale sostituisce al contrario un’uguaglianza morale e legittima a quel tanto d’inuguaglianza fisica che la natura aveva potuto mettere tra gli uomini; questi pur potendio essere disuguali per forza o per ingegno, divengono tutti uguali per convenzione e diritto.
I singoli vedono il bene che non vogliono: la collettività vuole il bene che non vede. Tutti hanno ugualmente bisogno di guida, c’è dunque necessità di un legislatore.
VII: DEL LEGISLATORE
Ci vorrebbero degli dei per dare le leggi agli uomini. Ma mentre il principe è un operaio che fa muovere la macchina, il legislatore è il meccanismo che crea la macchina. Egli bisognerà di sostituire un‘esistenza parziale e morale all’esistenza fisica e indipendente che tutti noi abbiamo ricevuto dalla natura, bisogna che annulli le forze naturali dell’uomo e gliene dia altre; e tanto più riuscirà a sostituire certe forze , tanto più tale Stato sarà stabile e sicuro. Il legislatore dovrà essere estraneo a magistratura e sovranità, poiché egli sarà una carica unica dello Stato, è un funzione singolare e superiore che non ha niente di comune con l’autorità umana (perché se chi comanda sugli uomini non deve comandare sulle leggi, neanche chi comanda sulle leggi devo comandare sugli uomini). Chi redige le leggi non ha né deve avere alcun diritto legislativo, e il popolo stesso non può, anche se lo volesse, spogliarsi di questo diritto incomunicabile, poiché solo la volontà generale deve avere il potere di obbligare i singoli. Il legislatore,non potendo adoperare né la forza né il ragionamento (visto che egli individuo dovrà trovare il giusto per i bisogni della collettività, dunque fare ricorso ad un intelletto superiore ed ad una razionalità sublime), deve ricorrere ad una autorità di altra specie: è l’autorità divina di cui dovrà farsi interprete e le cui decisioni dovranno essere messe nella bocca degli immortali. Non bisogna dunque concludere che la politica e la religione abbiano nel nostro mondo un oggetto comune, ma che, all’origine delle nazioni, l’una serve di strumento all’altra.
VIII: DEL POPOLO
Il saggio fondatore dello Stato deve, come il buon architetto, testare le sue fondamenta, dunque deve capire se il popolo possa sopportare certe leggi. Ogni popolo può sopportare un certo tipo di leggi a seconda del suo retaggio. Vi è per ogni popolo un periodo di maturità in cui possono essere inciviliti e controllati con leggi; ogni popolo ha bisogno di un’analisi per capire i suoi tempi, e dove questa analisi si s sbagli o il tempo propizio passi via, la libertà non sarà recuperabile, o il governo sarà pessimo (Pietro I zar di Russi, che fa inglesi e tedeschi quando ancora non ha fatto i russi).
IX: DEL POPOLO (SEGUITO)
Come ogni uomo ha una dimensione massima naturale, ogni Stato deve avere una giusta estensione, ed ogni corpo politico ha un Maximum di forza che non deve oltrepassare. I sudditi avranno meno benevolenza per il sovrano, le province con esigenze diverse berranno accomunate erroneamente alle stesse leggi, lo Stato si farà sentire sempre meno con la lontananza. Vi sono molte buone ragioni per estendersi e molte buone restringersi, un buon governante deve saperle cogliere e utilizzarle sempre a buon vantaggio del popolo.
X: DEL POPOLO (SEGUITO)
Gli uomini fanno lo Stato ed è il suolo a nutrire gli uomini: questo rapporto dunque deve essere tale per cui la terra basti al sostentamento dei suoi abitanti, e per cui vi siano tanti abitanti quanti la terra possa nutrirne. In questa proporzione sta il Maximum di forza di una data quantità di popolazione. Naturalmente dovrà anche prevedere, il principe lo stato futuro della sua popolazione, ovvero si dovrà basare sulla fertilità delle donne ed alle quantità di cibo consumate. Tutti questi parametri vanno rivisti in caso di guerra, per le difficili situazioni cui essa conduce, e vanno riconsiderati anche in luce del territorio che si considera.
XI:DEI DIVERSI SISTEMI DI LEGISLAZIONE
I maggiori beni in assoluto, solo la libertà e l’uguaglianza . La forza delle cose tenderà sempre a distruggere l’uguaglianza, ma la forza delle leggi dovrà tendere sempre a conservarla. Oltre che dalle regole che valgono per tutti, ogni Stato deve essere mantenuto da qualche causa che lo ordina in maniera particolare e rende la sua legislazione adatta soltanto ad esso. Come suggerisce Montesquieu le leggi devono cercare di rettificare principi naturali, se troppo si distanziano da essi non saranno che instabili e renderanno instabile anche il governo.
XII: DIVISIONE DELLE LEGGI
Il rapporto del tutto col tutto (del corpo politico con se stesso) è fondamentale per regolamentare bene uno Stato. Le leggi che regolano questo rapporto saranno leggi politiche. La seconda relazione fondamentale è quella dei membri tra di loro o con il corpo interno (ogni cittadino dovrà essere molto indipendente rispetto agli altri cittadini ma molto dipendente rispetto allo Stato): queste saranno le leggi civili. Infine vi sarà una terza relazione, quella della disobbedienza e della pena: da essa nasceranno le leggi criminali. A queste si unirà un ultimo tipo di legge che albergherà nel cuore dei cittadini e che formerà la vera spina dorsale dello Stato: i costumi, le consuetudine e l’opinione.
Libro terzo
I: DEL GOVERNO IN GENERALE
Ogni azione libera ha due cause che concorrono a produrla: l’una morale, cioè la volontà che determina l’atto, l’altra fisica, cioè la forza che la esegue. Il corpo politico ha gli stessi motori: la volontà come potere legislativo, la forza come potere esecutivo. Occorre dunque la forza pubblica un agente che la riunisca e la traduca in un atto secondo le direttive della volontà generale, che renda possibile comunicazione tra lo Stato e il corpo sovrano, che faccia nella persona pubblica ciò che l’unione dell’anima e del corpo fa nell’uomo.
Che cos’è dunque il governo? Un corpo intermediario istituito tra i sudditi e il corpo sovrano con la loro reciproca corrispondenza, incaricato della esecuzione delle leggi e del mantenimento della libertà sia civile e politica. I membri di questo corpo si chiamano magistrati o Re, cioè ai governatori: è il corpo intero prende il nome di principe. Il governo riceve dal corpo sovrano gli ordini che dà al popolo; affinché lo Stato siano il giusto equilibrio occorre che vi sia uguaglianza tra il potere del governo preso in sé stesso, e il potere dei cittadini, che sono da un lato sovrani e dall’altro sudditi. Il potere di legge di un cittadino diminuisce all’aumentare del numero dei cittadini. Quindi quanto meno le volontà particolari si riferiscono alla volontà generale tanto più deve aumentare la forza repressiva. Dunque il governo deve essere più forte man mano del popolo diventa più numeroso. Di conseguenza quanto più forza deve avere il governo per tenere a bada il popolo, tanto più deve averne a sua volta il corpo sovrano per tenere a bada il governo. Naturalmente lo Stato esiste per sé stesso, mentre il governo non esiste che per il corpo sovrano. Perché il corpo del governo abbia un’esistenza, una vita reale che non distinguono il corpo dello Stato, gli occorre un io particolare, ovvero delle assemblee, dei consigli, un potere di deliberare di risolvere, dei diritti, dei titoli, dei privilegi che appartengono esclusivamente al principe.
II: DEL PRINCIPIO CHE COSTITUISCE LE DIVERSE FORME DI GOVERNO
Il corpo dalla magistratura può essere composto da un numero più o meno grande di membri. Dunque, più i magistrati sono numerosi, più il governo è debole. Nel magistrato possiamo distinguere tre volontà: le volontà propria dell’individuo (tendente al vantaggio personale), la volontà comune dei magistrati (che si riferisce vantaggio del principe), la volontà del popolo o volontà sovrana, che è generale sia rispetto lo stato considerato come tutto, sia rispetto il governo considerato come parte del tutto. In una legislazione perfetta la volontà particolare deve essere nulla; la volontà di corpo proprio del governo molto subordinata; e per conseguenza la volontà generale o sovrana sempre dominante regola unica di tutte le altre. Di conseguenza se in un governo il potere nelle mani di un solo uomo, la volontà particolare e la volontà di corpo sono perfettamente riunite, e per conseguenza quest’ultima raggiunge il più alto grado d’intensità possibile. Ora, siccome l’uso della forza di prendere il grado di volontà, e la forza assoluto del governo non può variare, ne segue che il più attivo dei governi è quello di uno solo.
Al contrario, uniamo il governo l’autorità legislativa; facciamo dal corpo sovrano il principe, e di tutti cittadini altrettanti magistrati: allora la volontà di corpo, confusa con la volontà generale, non avrà maggiore attività di essa, e lascerà alla volontà particolare tutta la sua forza: così il governo, sempre con la stessa forza assoluto, sarà al suo minimum di forza relativa o di attività.
È certo anche che il disbrigo degli affari diventa più lento quante più persone siano incaricate; così si lascia troppa prudenza e non si concede abbastanza alla fortuna; si lascia sfuggire l’occasione a forza di deliberare si perde spesso il frutto della deliberazione. Ma da tutto ciò deriva che il rapporto tra i magistrati il governo dev’essere inverso del rapporto tra i sudditi e il corpo sovrano; cioè, più lo Stato si ingrandisce, più il governo deve restringersi, in modo che il numero dei capi diminuisca in proporzione all’aumentare del popolo. R. ci dice che si parla solo della forza relativa e non della rettitudine del governo: perché al contrario, quanto più numerosi siano i magistrati, tanto più la volontà del corpo si avvicinerà alla volontà generale; mentre sotto magistrato unico questa stessa volontà di corpo non è che una volontà particolare. Così si perde da un lato ciò che si può guadagnare dall’altro, e l’arte del legislatore sta nel saper fissare il punto, in cui si combinino la forza e la volontà di governo nel rapporto più vantaggioso per la Stato.
III: DIVISIONE DEI GOVERNI
Il corpo sovrano può fare depositario del governo tutto il popolo o la maggior parte di esso: questa forma di governo è la democrazia.
Oppure si può restringere la magistratura nelle mani di una minoranza: questa è un’aristocrazia.
Infine si può concentrare tutto il governo nelle mani di un magistrato unico: questa terza forma nella più comune e si chiama monarchia.
Può risultare da queste tre forme combinate una moltitudine di forme miste, di cui ciascuna moltiplicarle per tutte le forme semplici. Non esiste una forma di governo migliore in assoluto ma ognuna da considerare valutare, intorno alla situazione di cui è reggente.
IV: DELLA DEMOCRAZIA
Chi fa la legge sa meglio di ogni altro in quale modo debba essere seguita; sembrerebbe quindi la migliore forma di governo è la democrazia in cui potere esecutivo è unito legislativo: ma proprio questo rende questo governo insufficiente per certi aspetti, perché le cose che devono essere distinte non lo sono, e il principe e il corpo sovrano, essendo la stessa persona non formano che un governo senza governo. L’abuso delle leggi da parte del governo è un male minore della corruzione del legislatore, inevitabile conseguenza del particolare. Un popolo che governasse sempre bene non avrebbe bisogno di essere governato.
Apprendere il termine la sua rigorosa accezione, non è mai esistita una vera democrazia, ne esisterà mai; adesso si richiederebbe uno stato molto piccolo, una grande semplicità di costumi, una grande uguaglianza dei gradi e nelle fortune; infatti Montesquieu pone alla base della Repubblica le virtù. Esso sarà il governo più esposto alle guerre civili delle agitazioni interne. R. apostrofa che “ se vi fosse un popolo di dei, esso si governerebbe democraticamente. Un governo così perfetto non conviene gli uomini”.
V: DELL’ ARISTOCRAZIA
Abbiamo in questo caso due persone morali ben distinte: il governo e il corpo sovrano; e di conseguenza due volontà generali, una rispetto tutti cittadini, l’altro soltanto per i membri dell’amministrazione. Le prime società si governarono aristocraticamente; i giovani credevano senza difficoltà all’autorità dell’esperienza: dei preti, di anziani, di senato, di geronti. Via via che l’inuguaglianza istituzionale del sopravvento sull’inuguaglianza naturale, la ricchezza e la potenza furono preferite all’età, l’aristocrazia divenne elettiva. Vi sono tre specie di aristocrazia: naturale, elettiva, è ereditaria. La prima dei popoli semplici ,la terza era peggiore di tutti governi, la seconda è il migliore, è l’aristocrazia propriamente detta. Qui magistrati saranno scelti per elezione, che andrà ben regolamentata onde non cadere in dinastie ereditarie; inoltre le pratiche governative si svolgeranno più velocemente e lo Stato sarà rappresentato all’estero da pochi esperti senatori, e non da un’ignota moltitudine. Essa chiede meno condizioni meno virtù della democrazia, ma richiede la moderazione nei ricchi e lo spirito di adattamento dei poveri, perché sembra che un’uguaglianza rigorosa sarebbe rimessa fuori posto.
VI: DELLA MONARCHIA
A differenza delle altre amministrazioni in cui un essere collettivo rappresenta un individuo, in questa un individuo rappresenta un essere collettivo. Un difetto essenziale e inevitabile, che metterà sempre il governo monarchico al disotto di quello repubblicano, e che mentre in quest’ultimo il voto pubblico non innalza quasi mai nei primi posti che uomini illuminati capaci, coloro che arrivano all’apice delle monarchie sono il più delle volte piccoli imbroglioni, piccoli bricconi, piccoli intriganti. Le dimensioni dello Stato monarchico devono essere commisurata le capacità di chi lo governa, infatti bisognerebbe che un regno si estendesse o si restringesse secondo il valore del principe. L’inconveniente più sensibile del governo di uno solo è la mancanza di quella successione continua che forma nelle altre due specie di governo un legame ininterrotto. Quando si cerca di dare costanza questo governo si incappa spesso nell’ereditarietà che costituisce la rovina di questo governo.
VII: DEI GOVERNI MISTI
Non esistono governi semplici; il governo semplice è il migliore in sé per il solo fatto di esser semplice; ma quando il potere esecutivo non dipenda abbastanza dal legislativo, cioè quando il rapporto tra il principe e il corpo sovrano sia più grande di quello tra popolo del principe, bisogna rimediare a questo difetto di proporzione dividendo il governo.
VIII:COME OGNI FORMA DI GOVERNO NON SIA ADATTA AD OGNI PAESE
Le libertà, non essendo un frutto di tutti i climi, non è alla portata di tutti popoli. Quanto più aumenta la distanza tra il popolo e il governo, tanto più i tributi diventano onerosi: così nella democrazia il popolo è meno gravato; nell’aristocrazia maggiormente; nella monarchia porta il più gran peso. Quindi convengono rispettivamente a stati poveri o piccoli, a stati di media ricchezza ed a stati opulenti..
IX: DEI SEGNI DI UN BUON GOVERNO
Il numero e la popolazione. Non andate dunque cercare altrove questo segno così discusso. A parità di condizioni, il governo sotto il quale, senza mezzi estranei, senza naturalizzazioni, senza colonie, il paese sia popolato e i cittadini si moltiplichino maggiormente, è infallibilmente il migliore.
X: DELL’ABUSO DEL GOVERNO E DELLA SUA TENDENZA A DEGENERARE
Come la volontà particolare agisce senza tregua contro la volontà generale, così il governo fa uno sforzo continuo contro la sovranità. Più lo sforzo aumenta più la costituzione si altera; e vista l’assenza di una volontà di corpo che bilanci quella del principe ,il principe opprimerà e il patto sociale sarà rotto.
Il governo degenera in due modi fondamentali: quando si restringe, o quando lo Stato si dissolve. Si restringe quando passa da un grande numero uno più piccolo cioè dalla democrazia all’aristocrazia, dall’aristocrazia alla monarchia; bisognerà quindi ricaricare e stringere la molla man mano che essa ceda: altrimenti lo Stato che essa sostiene cadere dei rovina. La dissoluzione può presentarsi in due modi: quando il principe non amministra più lo Stato secondo le sue leggi, ed usurpa il potere sovrano; lo stesso caso si presenta quando i membri del governo usurpano separatamente il potere che devono esercitare solo collettivamente.
Quando lo Stato si dissolve, l’abuso di governo, qualunque esso sia, viene chiamato anarchia. La democrazia degenera in oclocrazia, l’aristocrazia in oligarchia,la monarchia in tirannide. Secondo la definizione corrente, un tiranno è un re che governa con violenza e senza riguardo alla giustizia e alle leggi. Secondo la definizione più precisa un tiranno è un privato che si trova all’autorità regia senza averne diritto, al di là del suo bene o male governare la sua autorità non è legittima. Il tiranno è usurpatore dell’autorità regia, il despota è l’usurpatore del potere sovrano: tiranno è colui che chiama a sé contro le leggi il potere di governare secondo le leggi; il despota è colui che si mette al di sopra delle leggi stesse. Dunque il tiranno può non essere despota, ma il despota sempre tiranno.
XI: DELLA MORTE DEL CORPO POLITICO
Il corpo politico come il corpo umano inizia a morire già dalla nascita e porta in sé stesso le cause della sua distruzione. Il principe della vita politica è nell’autorità sovrana. Il potere legislativo è il cuore dello Stato, il potere esecutivo né è il cervello, che dà il movimento a tutte le parti. Il cervello può essere colpito da paralisi e l’individuo vivere ancora, ma non appena il cuore ha cessato di funzionare, l’animale è morto. Le leggi spesso sopravvivano allo stato e sono rispettate dal corpo sovrano, che nonostante possa rifiutarle non lo fa.
XII: COME SI MANTENGA L’AUTORITA’ SOVRANA
Il corpo sovrano non agisce che per mezzo delle leggi, espressioni della volontà generale; il corpo sovrano non può agire se il popolo non è radunato. Il popolo romano censito 4 milioni di uscire a riunirsi mai meno di una volta ogni due settimane.
XIII: COME SI MANTENGA L’AUTORITA’ SOVRANA
C’è bisogno di assemblee fisse, sempre seguite; ogni assemblea che non sia stata convocata da magistrati preposti deve essere considerata illegittima perché l’ordine stesso di adunarsi deve essere emanato dalla legge. L’autorità sovrana non si deve dividere deve rimanere una, non deve lasciarsi governare da una sconfitta, il territorio deve essere popolato in maniera uniforme e non si devono comprendere troppe città grandi.
XIV: COME SI MANTIENE L’AUTORITA’ SOVRANA
Durante l’assemblea la giurisdizione del governo è sospesa, perché dove si trova il rappresentato non vi sono più rappresentanti. Ma a volte tra autorità sovrana e il governo arbitrario si introduce un potere intermedio, di cui occorre parlare.
XV: DEI DEPUTATI O RAPPRESENTANTI
Nel momento in cui il servizio fuori della comunità cessa di essere l’interesse primo dei cittadini, ed essi preferiscono servire con la loro borsa anziché con la loro persona, lo Stato è già prossimo rovina. Date denaro e ben presto avrete catene. La finanza è una parola da schiavo e nel vero Stato non è conosciuta. L’intiepidimento dell’amor di patria, l’attività dell’interesse privato, l’immensa estensione degli stati, l’abuso di governo hanno fatto escogitare l’espediente dei deputati o rappresentanti del popolo nelle assemblee della nazione. È ciò che in certi paesi si offre chiamare il terzo Stato. La sovranità non può essere rappresentata, per la stessa ragione per cui non può essere alienata. Ogni legge che non è stata ratificata direttamente del popolo non dovrebbe essere legge. La idea di rappresentanti deriva dal governo feudale. È chiaro che nel potere legislativo il popolo non può essere rappresentato, ma può e deve esserlo nel potere esecutivo.
XVI: COME L’ISTITUZIONE DEL GOVERNO NON SIA UN CONTRATTO
Essendo i cittadini tutti uguali in base ad un contratto sociale, quello che tutti debbono fare deve poter essere stabilito da tutti, mentre nessuno ha il diritto di esigere che un’altra faccia quello che non fa gli stesso. Ora è proprio questo diritto, indispensabile per far vivere e muovere il corpo politico, che il corpo sovrano da al principe istituendo il governo. Molti sostengono che questo sia un patto tra il popolo e i capi che esso si dà, contratto con cui le parti si obbligherebbero una a comandare, l’altra a ubbidire. È assurdo che un corpo sovrano si dia un superiore e il contratto che si stipulerebbero sarebbe un atto particolare, sarebbe illegittimo. Non vi è che un contratto nello stato, quello dell’associazione e questo non esclude ogni altro.
XVII: DELL’ISTITUZIONE DEL GOVERNO
L’atto d’istituzione del governo è composto di due atti: l’istituzione della legge, l’esecuzione della legge. Col primo il corpo sovrano stabilisce che vi sarà un corpo di governo costituito in questo o in quella forma (è un atto di legge). Con il secondo il popolo nomina i capi che saranno incaricati del governo costituito, è una funzione della legge è conseguenza di essa. Come si può avere un atto di governo prima che il governo esista? Perché questo atto si fa con una subitanea conversione della sovranità in democrazia, di modo che senza cambiamento sensibile e con una nuova relazione di tutti rispetto tutti, i cittadini divenuti magistrati, passano dagli atti generali agli atti particolari, e dalla legge all’esecuzione.
XVIII: PER PREVENIRE LE USURPAZIONI DEL GOVERNO
Il principe facendo credere di usare solo i suoi diritti, può facilmente estenderli, e porre ostacoli, col pretesto della tranquillità pubblica, alle assemblee destinate a ristabilire l’ordine; in tal modo approfitta di un silenzio che egli stesso impedisce di rompere, per supporre in suo favore il consenso di coloro che la paura fa tacere e per punire coloro che parlano. Le assemblee periodiche sono adatte a prevenire o almeno differire questa disgrazia queste assemblee devono sempre aprirsi con la votazione separata di due proposte da considerarsi insopprimibili:” se piaccia al governo sovrano conservare la presente forma di governo” e “se piaccia al popolo lasciare l’amministrazione coloro che ne sono attualmente incaricati”.
Libro Quarto
I: LA VOLONTA’ GENERALE E’ INDISTRUTTIBILE
Spesso dei cittadini eruditi confondono gli altri con parole o macchinazioni politiche, rendendo instabile il patto che sta alla base del l’istituzione sociale. Quando lo Stato si avvicina alla rovina,la volontà generale non sussiste che come una forma vana e illusoria, diventa muta come se lo Stato non fosse mai esistito e tutti i cittadini divengono guidati da segreti motivi.
Da ciò però la volontà non è distrutta, rimane costante ,inalterabile e pura; ma è subordinata ad altre volontà che prevalgono su di essa.
II: DEI SUFFRAGI
È dunque il modo in cui si trattano gli affari generali a determinare lo stato della volontà generale; più l’accordo regna nelle assemblee, cioè più si avvicinano all’unanimità, più la volontà generale è dominante. L’unanimità l’abbiamo quando accade che i cittadini, caduti in schiavitù, non hanno più libertà né volontà . Allora la paura dell’adulazione ne cambiano i suffragi in acclamazioni, non si delibera più, si adora o si maledice. Da ciò dobbiamo stabilire i principi di base con i quali si devono regolare il modo di contare i voti e quello di confrontare i pareri. Non vi è che una sola legge che per sua natura esiga un consenso unanime; è il patto sociale; perché l’associazione civile è l’atto più volontario del mondo. Quando al momento da stipulazione del patto vi fossero degli oppositori, la loro opposizione non invaliderebbe il contratto, ma impedirebbe loro di esserne compresi: sono stranieri tra i cittadini. Una volta che lo stato è istituito, il consenso consiste nella residenza; abitare il territorio significa sottomettersi alla sovranità. Il cittadino si sottometterà anche le leggi votate suo malgrado ; essi voteranno non l’approvazione della legge, ma la sua conformità alla volontà generale; è come se si rendesse necessaria una votazione fatta per e con la volontà generale, e non con la volontà del singolo cittadino. Due principi possono regolare i rapporti tra unanimità e uguaglianza: uno è che le deliberazioni sono importanti e gravi, quando più il parere dominante deve avvicinarsi all’unanimità; l’altro, che più l’affare trattato esige celerità, più si deve restringere la differenza prescritta nella divisione dei pareri (ne le deliberazioni che bisogna concludere immediatamente una differenza di un solo voto può bastare); che prima di questa regole molto adatta alle leggi, la seconda ai provvedimenti particolari.
III: DELLE ELEZIONI
Due sono i modi di eleggere il principe e i magistrati: la scelta è la sorte. Montesquieu suggeriva che la sorte è nella natura delle democrazie vista l’ambascia d’ogni cittadino la speranza di servire la patria. Riflettendo sulla funzione di governo e non di sovranità dell’elezione, la sorte sarebbe il migliore dei criteri visto l’onere che essa attribuisce. La sorte sarebbe ottima per la democrazia dunque se non fosse che non esiste nessuna reale democrazia.
Quando si ricorre sia alla scelta che alla sorte, la prima deve essere su dei posti che richiedono capacità specifiche, l’altra quelli dove basti il buon senso, la giustizia, l’integrità, perché in uno stato ben ordinato esse sono comuni a tutti cittadini. Nel governo monarchico non c’è posto per i suffragi né per la sorte.
IV: DEI COMIZI ROMANI
Dopo la fondazione di Roma, una repubblica nascente, cioè l’esercito fondatore, composto di Albani, Sabini e stranieri, fu diviso in tre classi, che da questa divisione presero il nome di tribù; ciascuna di queste tribù suddivise in dieci curie e ogni curia in decurie, alla testa delle quali si misero curioni e decurioni. Si trasse inoltre dalle tribù un corpo di cavalieri chiamato centuria; l’organizzazione è dunque solo militare. E’ come se fosse stata istituita per dare alla piccola Roma una costituzione adatta alla capitale del mondo. Visti i rapporti troppo mutevoli nel numero delle varie tribù, Servio decise di cambiare divisione basandola sui luoghi di città occupati da ogni tribù. Esse divennero quattro con i nomi dei colli di Roma che occupavano, proibendo inoltre a ogni cittadino della tribù di vivere nel territorio di un’altra. A queste quattro tribù urbane aggiunse inoltre 15 tribù rustiche , abitanti della campagna, divise in altrettanti cantoni. Il numero di 35 tribù rimase inalterato fino alla Repubblica; al contrario di ciò che si può immaginare le tribù rustiche ottennero sempre più onori, grazie alle loro attività dello stato semplice e civilmente utile dei suoi cittadini, le tribù urbane erano quelle meno stimate. Il principio però fu spinto oltre e divenne un abuso di costituzione: i censori lasciarono trasferire arbitrariamente cittadini da una tribù all’altra, così la distinzione saltò e non si potevano distinguere i membri di ciascuna. Così le tribù urbane, che vivevano vicine e quindi avevano maggiore capacità di unione vendettero lo stato a coloro che non disdegnavano di comprare i suffragi delle canaglie che li componevano. Nel momento in cui Servio dovette applicare un’altra suddivisione agli abitanti di Roma, non si parlò più di curie e di tribù viste che esse, ora totalmente civili, avevano perso ogni valore militare; allora si procedette alla divisione del popolo romano in 6 classi distinte in base alla quantità dei beni posseduti. Servio cercò di dare un assetto militare a questa riforma inserendo servizi di leva e assemblee presso il Campo di Marte . La suddivisione di queste classi influì sul modo di scegliere i soldati.
Le assemblee convocate legittimamente si chiamavano comizi e si distinguevano in : comizi per curie , comizi per centurie , comizi per tribù. I comizi per curie erano istituzioni di Romolo; quelli per centurie di Servio; quelli per tribù dei tribuni del popolo. Le leggi e l’elezione dei capi non erano le sole cose sottoposte al giudizio dei comizi: dato che il popolo romano aveva usurpato le più importanti funzioni del governo , le sorti dell’intera Europa erano decise nelle sue assemblee.
Romolo istituendo le curie mirava a controllare il senato per mezzo del popolo e il popolo per mezzo del senato. Diede dunque al popolo tutta l’autorità del numero per bilanciare la potenza e le ricchezze dei patrizi, ma lasciò ai patrizi una posizione privilegiata in virtù dell’influenza che i loro clienti esercitavano sulla maggioranza dei votanti ( R. ci dice che questo sistema non creò mai abusi , tuttavia la stoia non lo ha seguito ) . Sotto la repubblica le curie non potevano rispondere alle esigenze del senato (visto che esse erano plebee mentre il senato patrizio ) né a quelle dei tribuni ( che sebbene plebei erano a capo di cittadini agiati) ; così caddero in discredito.
La divisione per centurie era favorevole alla aristocrazia che possedendo 98 delle 193 centurie che formavano tutto il popolo romano, se tutte esse fossero state d’accordo,non si sarebbe necessitato di continuare i suffragi anche presso le altre classi. Questo strapotere era mitigato con 2 mezzi: appartenendo di solito i tribuni, e sempre un gran numero di plebei alla classe dei ricchi , essi bilanciavano l’influenza dei patrizi in questa prima classe . Il secondo mezzo era di far votare le centurie secondo un ordine estratto a sorte ( praerogativa) , in modo da far votare ogni centuria un giorno diverso e da togliere così l’autorità dell’esempio al censo, per darlo alla sorte secondo il principio della democrazia ciò era buono anche perché le classiche votavano per ultime vedevano già il lavoro del candidato provvisorio; il pretesto della rapidità abolì questo uso.
I comizi tributi erano il consiglio del popolo romano, il senato non aveva nemmeno il diritto di assistervi (R. sostiene ingiusto e contro la volontà generale non lasciare agli altri cittadini , per altro impotenti su questi comizi,la possibilità di assistervi) .
I comizi tributi erano dunque favorevoli al governo popolare , quelli centuriati all’aristocrazia ,quelli curiati viaggiavano verso la tirannia. È certo che tutta la maestà del popolo romano si trovava nei comizi centuriati , i soli ad essere completi ( visto che in quelli curiati mancavano le tribù rustiche e nei comizi tributi il senato e i patrizi ).
I suffragi erano raccolti da un cancelliere che a mano scriveva i voti espressi ad alta voce : la maggioranza dei voti di ogni tribù determinava il suffragio della tribù ; la maggioranza di quelli di tutte le tribù determinava il suffragio del popolo ; e così delle curie e delle centurie. Questa usanza era buona quando l’onestà regnava tra i cittadini, infatti quando il popolo si corruppe il voto acquistò segretezza; Cicerone attribuisce in parte a questo cambiamento la rovina della repubblica, R. pensa invece che il non aver fatto abbastanza cambiamenti simili accelerò la perdita dello stato, poiché non bisogna voler governare un popolo corrotto con le stesse leggi che convengono a un popolo onesto. Si passò al voto scritto su tavolette e organizzato da ufficiali incaricati la cui fedeltà fu sempre sospetta .
V:DEL TRIBUNATO
Nel momento in cui la proporzione esatta tra le parti costitutive dello stato si altera, si istituisce una magistratura speciale che funge da termine medio tra il principe e il popolo e tra il principe e il corpo sovrano : esso sarà il tribunato, e avrà il compito di tutelare le leggi e il potere legislativo. Esso non è parte dello stato e non deve avere alcuna porzione del potere legislativo né di quello esecutivo : il suo potere è più grande, non può far nulla , ma può impedire tutto . Il tribunato è il più fermo appoggio di una buona costituzione ma ,per poco che abbia più forza di quanta ne debba avere , travolge ogni cosa e, usurpato il potere esecutivo, degenera in tirannia. Il tribunato si indebolisce, come il governo, con la moltiplicazione dei suoi membri.
Il miglior mezzo per prevenire le usurpazioni di tale corpo, potrebbe essere quello di non renderlo permanente, ,a di stabilire intervalli durante i quali resti soppresso.
VI : DELLA DITTATURA
L’inflessibilità delle leggi può renderle perniciose e causare per loro mezzo la rovina di uno stato. Esse non provvedono a consolidare le istituzioni politiche per migliorare l’efficienza della legislazione fino al punto di togliersi il potere di sospenderne l’effetto è sbagliato. Non bisogna mai fermare il sacro potere delle leggi se non quando si tratta della salvezza della patria. In questi casi si provvede alla sicurezza pubblica con un atto particolare che ne affida l’incarico al più degno: questo incarico si può dare in due modi, secondo la specie del pericolo.
Se per rimediare basta aumentare l’attività del governo lo si concentra su uno o due dei suoi membri: non si altera l’autorità delle leggi ma solo la forma della loro amministrazione. Se il pericolo è tale che le leggi possano ostacolare la difesa contro di esso, si nomina un capo supremo che fa tacere tutte le leggi e sospende l’autorità sovrana. Tale magistrato può fare tutto ma non le leggi.
Agli inizi della repubblica si dovette ricorrere spesso alla dittatura, per la giovinezza dello stato, e non si temeva che un dittatore potesse abusare della sua autorità né che egli tentasse di conservarla oltre il termine stabilito. Era più spesso il pericolo dello svilimento del magistrato in carica che non quello dell’abuso a far deplorare l’uso indiscreto di tale magistratura; usando spesso questa magistratura si perde il rispetto per il suo potere.
Verso la fine della repubblica a Roma si fece ricorso alla dittatura con una prudenza non meno irragionevole della leggerezza con cui prima se ne abusava. I timori erano spesso infondati visto che le catene di Roma non sarebbero state fabbricate in Roma stessa ma nei suoi eserciti ( Silla , Cesare). Questo causò loro grandi sbagli come il non aver permesso ad un dittatore di disperdere la congiura di Catilina.
VII : DELLA CENSURA
Come la dichiarazione della volontà generale si fa per mezzo della legge, così la dichiarazione del giudizio pubblico si fa per mezzo della censura; l’opinione pubblica è quella specie di legge di cui il censore è ministro, e la applica ai casi particolari . Il tribunale censoriale è l’espressione delle opinioni del popolo , che nascono dalla sua costituzione; sebbene la legge non regoli i costumi , è la legislazione che li fa nascere; quando la legislazione si indebolisce, i costumi degenerano: la censura può conservare i costumi ma non ristabilirli.
La censura conserva i costumi impedendo alle opinioni di corrompersi.
VII : DELLA RELIGIONE CIVILE
Molti popoli ebbero in origine gli dei come re; dal solo fatto di mettere Dio alla testa di ogni società politica derivò che vi furono tanti dei quanti popoli; così dalle divisioni nazionali risultò il politeismo e da ciò l’intolleranza teologica e civile, che naturalmente sono un’unica cosa. Le guerre religiose non accadevano perché ogni stato avendo un culto proprio come un proprio governo, non distingueva i suoi dei dalle sue leggi ; le regioni degli dei erano fissate dai confini delle nazioni. I popoli si assoggettavano oltre che al dominio alla religione dei vincitori ; ma quando gli ebrei , assoggettati dai re di babilonia e di Siria vollero ostinarsi a riconoscere nessun altro dio oltre il loro , questa ribellione contro il vincitore attirò su di loro le persecuzioni. Infine quando i romani ebbero diffuso il loro impero avvolte imponendo i loro dei , altre volte adattandoli a quelli dei vinti i popoli del vasto impero si trovarono ad avere un’unica religione, piena di dei, il paganesimo.
L’avvento di Gesù separò il sistema teologico dal sistema politico, fece si che lo stato cessasse di essere uno, dovendosi confrontare con l’idea di un regno dell’altro mondo. Ciò che i pagani avevano temuto accadde: Il preteso regno dell’altro mondo , sotto un capo visibile divenne il più violento dispotismo di questo mondo; da questo duplice potere venne un perpetuo conflitto di giurisdizione che ha reso impossibile ogni buon ordinamento negli stati cristiani. Nel caso di Maometto il sistema politico si conservò sotto i suoi califfi e successor,i ma gli arabi divenuti fiorenti , civili, fiacchi e vili , furono soggiogati dai barbari e ricominciò la suddivisione dei due poteri.
Il re di Inghilterra e lo zar di Russia si sono proclamati capi della chiesa , dunque suoi ministri , hanno acquistato non il diritto di cambiarla ma il potere di conservarla; dovunque ora il clero costituisce un corpo esso è padrone e legislatore nel suo ambito. Di tutti gli autori cristiano Hobbes è il solo che abbia individuato il male e il rimedio e che abbia osato di ricondurlo all’unità politica , ma dovette accorgersi che lo spirito dominatore del cristianesimo era incompatibile col suo sistema , e che l’interesse del prete sarebbe stato sempre più forte di quello dello stato.
Si potrebbero facilmente confutare le opinioni di Bayle e Warburton dei quali uno pretende che la religione sia utile al corpo politico mentre l’altro sostiene che il cristianesimo ne sia il più saldo appoggio. Al primo si potrebbe provare che mai uno stato fu fondato senza una religione come base; al secondo che la legge cristiana molto più nociva che non utile alla salda costituzione dello stato.
La religione può anch’essa esprimersi in due specie : la religione dell’uomo e quella del cittadino. La prima è limitata al culto puramente interiore del dio supremo , è la pura e semplice religione del vangelo , il vero teismo , e ciò che si può chiamare il diritto divino naturale. L’altra professata in un solo paese dà ad esso i suoi dei i suoi padroni tutelari ; essa ha dogmi, riti e culto prescritto da leggi : fuori dalla nazione che la segue tutto è infedele, straniero, barbaro. Tali furono le religioni dei primi popoli ai quali si può dare il nome di diritto divino civile o positivo.
Vi è una terza specie di religione , che dando agli uomini 2 legislazioni , 2 capi , 2 patrie, li sottomette a doveri contraddittori, ne impedisce loro di poter essere contemporaneamente devoti e cittadini ( religione dei Lama , Giapponesi , Cristianesimo romano).
Della terza specie non vale la pena di mostrare la manifesta cattiveria ( tutto quello che rompe l’unità speciale è sbagliato ; tutte le istituzioni che mettono l’uomo in contraddizione con se stesso sono sbagliate ) .
La seconda è buona in quanto riunisce il culto divino e l’amore delle leggi e insegna ai cittadini che servire lo stato significa servire il dio tutelare. È una teocrazia nella quale il principe è unico pontefice e i magistrati unici sacerdoti. Però è cattiva in quanto fondata sull’errore e sulla menzogna inganna gli uomini , li rende creduli, soffoca il vero culto con un vano cerimoniale. Inoltre diventando esclusiva e tirannica rende un popolo sanguinario e intollerante .
Rimane il cristianesimo del Vangelo, non quello d’oggigiorno, che non avendo nessun legame con il corpo politico , lascia alle leggi la sola forza che esse traggono da se stesse. Inoltre, invece di far si che il cuore dei cittadini si affezioni allo stato, lo distacca da esso, come da tutte le cose di questo mondo: non esiste niente di più contrario allo spirito sociale.
R. dice che una società cristiana non sarebbe più una società di uomini e non sarebbe la società più forte, né la più durevole: a forza di essere perfetta essa mancherebbe di coesione; il suo vizio distruttore sarebbe nella sua stessa perfezione. Per questo tipo di stato un uomo con qualche astuzia e l’arte di farsi valere si potrebbe impadronire dell’autorità pubblica facendosi depositario del potere di dio; per cacciare l’usurpatore bisognerebbe quindi usare violenza e spargimento di sangue, che mal si accorda con la mitezza del cristianesimo.
È quindi quasi assurdo dire repubblica cristiana: il cristianesimo non predica che servitù e dipendenza, il suo spirito è troppo favorevole alla tirannia perché questa non ne approfitti sempre; i veri cristiani sono fatti per esser schiavi. Interessa allo stato che ogni cittadino abbia una religione che gli faccia amare i suoi doveri , ma i dogmi di questa religione non interessano né lo stato né i suoi membri se non in quanto questi dogmi si riferiscano alla morale e ai doveri che colui che la professa è tenuto a compiere verso gli altri .Vi è dunque una professione di fede puramente civile della quale spetta al corpo sovrano fissare gli articoli, i sentimenti di socialità senza i quali è impossibile essere buon cittadino o suddito fedele. I dogmi della religione civile devono essere pochi , semplici, enunciati con precisione : l’esistenza della divinità potente , benefica, intelligente, previdente e provvida , la vita futura , la felicità dei giusti, il castigo dei malvagi , la santità del contratto sociale e delle leggi; ecco i dog,mi positivi . Uno solo è il dogma negativo : l’intolleranza. Non si distingue l’intolleranza teologica dall’intolleranza civile : è impossibile vivere in pace con delle persone credute dannate , amarle sarebbe odiare il dio che le punisce; di conseguenza dovunque è ammessa l’intolleranza teologica, è impossibile che essa non abbia qualche effetto civile.
IX : CONCLUSIONE
R. rimanda ad un’altra opera, ipotetica, il diritto delle genti , il commercio, il diritto di guerra e le conquiste , il diritto pubblico, le leghe, i negoziati, i trattati , le relazioni estere dello stato.
DE SADE

A cura di Alfio Squillaci
DE SADE”Capolavoro dell’infamia e del vizio”, come ha scritto Maurice Blanchot, la vita del “divin marchese” è quella di un “colpevole di puro e semplice libertinaggio “. Sade riconosce l’aspetto morboso della sua esperienza nella lettera che indirizza a sua moglie, dal torrione di Vincennes, il 20 febbraio 1791: «Sì, sono un libertino, lo riconosco: ho concepito tutto ciò che si può concepire in questo ambito, ma non ho certamente fatto tutto ciò che ho concepito e non lo farò certamente mai. Sono un libertino, ma non sono un criminale né un assassino.»
Un eterno prigioniero
Nato in una vecchia famiglia provenzale tra i cui antenati si annovera la Laura cantata dal Petrarca, Donatien-Alphonse-François (conte de Sade) entra nel prestigioso collegio dei gesuiti Louis-le-Grand (1750 -1754), quindi è interno al collegio di Cavalleria reale. Nominato capitano, partecipa alla guerra dei Sette Anni (1756 -1763). Congedato dopo il trattato di Parigi, sposa Renée de Montreuil (17 maggio 1763) con «l’approvazione della famiglia reale» ma ben presto un ordine di cattura (29 ottobre 1763) lo fa internare al torrione di Vincennes “per deboscia reiterata”. Il destino di Sade, ormai, è segnato. La sua singolare personalità si palesa mentre, nello stesso tempo, è fatto segno di una reputazione inquietante. Le sue relazioni multiple, il suo libertinaggio dichiarato (mentre quello dei membri della sua casta, non meno outré, è invece saggiamente tenuto nascosto) gli valgono numerose incarcerazioni. Nel 1768 scoppia l’affaire Rose Keller, un’operaia ridotta alla mendicità che scappa dalla finestra di una casa a Arcueil dove Sade vive. La donna si lagna in paese di essere stata sequestrata quindi fustigata. Sade è arrestato e condanna-
to. Nel 1772, a Marsiglia, dove vive con il suo servo Latour, è accusato di flagellazione, d’omosessualità e d’utilizzo di pillole avvelenate. Quattro prostitute, lamentanti dolori intestinali, accusano Sade di sodomia. Nuovo soggiorno in prigione, ma evade e viaggia in Italia sotto il nome di conte de Mazan. Nel 1774, M.me de Montreuil, la suocera, lo fa rinchiudere a Vincennes. Sembra agli studiosi di oggi che la gravità dei delitti di Sade sia stata esagerata; se ne commettevano altrettali all’epoca, e non hanno valso ai loro autori la maledizione che ha colpito Sade. Quindi l’ostilità di M.me de Montreuil può essere considerata determinante. Si noterà, inoltre, che le relazioni di Sade con la moglie erano buone, come è provato dalla sua corrispondenza con lei. Nel 1784, il prigioniero è trasferito alla Bastiglia, quindi a Charenton. È durante questo periodo che scrive Le cento venti giornate di Sodoma o la scuola del libertinaggio (1785) e Justine o le sventure della virtù (1787). Liberato (1790), pubblica Justine (1791). Arrestato nuovamente, è ristretto in diverse prigioni o manicomi (Madelonnettes, Carmes, a Saint-Lazare e infine Picpus). Un’altra volta liberato, pubblica La filosofia nel boudoir (1795), Aline e Valcour (1795), La nuova Justine (1797), I crimini dell’amore (1800). Queste opere fanno scandalo e l’autore “di Justine malfamata” è imprigionato anche dal regime bonapartista, inizialmente a Sainte-Pélagie, a Bicêtre, infine a Charenton, dove muore in miseria in mezzo ai malati di mente, nel 1814. Nella sue ultime volontà, ammirevole, ribadisce la sua ferma intenzione di non lasciare alcuna traccia del suo passaggio sulla terra e chiede di essere sepolto nel parco della sua proprietà, senza alcuna iscrizione.
Uno spirito libero
Erede del “naturalismo” di Diderot e di Rousseau (ossia di una filosofia conforme alla natura), Sade, «lo spirito più libero» (Apollinaire), ha spinto questa filosofia fino alle sue estreme conseguenze. Se ne è servito a giustificare l’espansione senza limiti dell’individuo. «Se la natura disapprovasse le nostre inclinazioni, » proclama uno dei personaggi, « non ce le ispirerebbe.» È vero anche che il materialismo e l’ateismo di Diderot e di d’Holbach, volgarizzati e ridotti a parole d’ordine automatiche, sono invocati a giustificazione dei suoi excès e supplices . Molto distante dalla preoccupazione del barone d’Holbach di disancorare sì la morale dalla teologia e tuttavia di porre le fondamenta di un ateismo virtuoso (il Barone pensa, a differenza del Marchese, che se Dio è morto non tutto è possibile) Sade nega, nel suo sistema erotico-funerario, ogni chance a qualsiasi morale, come s’è visto, ma anche ogni spiraglio all’esercizio libero e gioioso del sesso (e sarà quanto gli rimprovererà, non certo sul versante di una morale qualsiasi, quel grande, ilare, immoralista e pornografo che è Retif de la Bretonne).
Quindi il vizio e la crudeltà prendono in Sade le dimensioni della pazzia e del mito. La sua opera può ispirare orrore e anche un po’ di noia per l’infinita, stilizzata e “teatralizzata” ritualità erotico-pornografica, ma proiettando, senza freni, nell’ossessione della scrittura le sue ossessioni ed i suoi fantasmi, Sade ha però portato agli psicologi un documento eccezionale sugli stati della mente e sulle sue perversioni, ed i surrealisti hanno riconosciuto in lui il simbolo dell’uomo che insorge contro tutti i divieti. Il “pensiero” di Sade ha anche un carattere politico, cosa che lo avvicina a tutta la corrente dei libertini, così vigorosa nel XVIII° secolo e in quello precedente. Sade che vuole riconciliare Eros e natura (« Tutto è nella natura», sostiene ), si è opposto al deismo come anche all’Essere supremo di Robespierre il quale voleva fondare un nuovo ordine mentre Sade, che non ne voleva alcuno, lo accusa di voler soffocare la rivoluzione totale, che deve essere anche quella dei costumi. È ciò che esprime nel suo testo famoso, “Francesi, ancora uno sforzo!”, incluso nella Filosofia del boudoir. Lo spirito del crimine si collega in Sade ad un sogno sproporzionato della negazione, di ogni negazione: il suo progetto distruttivo supera infinitamente gli uomini. Se l’uomo “sadico” sembra singolarmente libero nei confronti delle sue vittime, da cui dipendono i suoi piaceri, la violenza verso queste vittime va al di là delle stesse e non mira che a verificare freneticamente l’atto distruttivo stesso con il quale «ha ridotto Dio ed il mondo a nulla» (Maurice Blanchot). La facilità del crimine è irrisoria. L’atto distruttivo è semplice. Ma il mondo dove l’uomo sadico avanza è un deserto. All’alba delle Cento venti giornate, il duca di Blangis dice alle donne reclutate per il piacere di quattro libertini: «Siete rinchiuse in una cittadella impenetrabile, nessuno sa dove vi trovate, siete sottratte ai vostri amici, ai vostri genitori, siete già morte al mondo.»
Una morale del vizio
Sade ha introdotto nel romanzo una nuova dimensione che vuole «dare il vizio sempre e ovunque trionfante e la virtù vittima delle sue pretese e rinunce (…) seguendo il punto di vista di dispensare una delle lezioni più sublimi di morale che l’uomo abbia ancora ricevuto: ed era, si converrà, di pervenire allo scopo seguendo una strada poco seguita fino ad oggi.» Così Sade, che vuole provare che la virtù è la sola ragione della disgrazia di Justine, fa alternare le scene di orge (successione di stupri, di incesti, di mostruosità sessuali) con “dissertazioni morali”. Jean Paulhan ha sottolineato questo modo dell’accumulo ripetitivo e rituale, che fa pensare «ai libri delle grandi religioni».
CHRISTIAN THOMASIUS

Quando non venga fatto risalire a Leibniz , l’ illuminismo tedesco è generalmente ricondotto a Christian Thomasius (1655-1728) . Più precisamente si è convenuto di far iniziare l’ illuminazione tedesca dal 1694 , anno in cui Thomasius prese a insegnare alla nuova università di Halle , che sarà un prestigioso punto di riferimento culturale per l’ età dei lumi in Germania . Provocando grande scandalo , Thomasius tenne le sue lezioni in tedesco anzichè in latino , così come in tedesco sono scritte le sue opere più importanti come l’ Introduzione alla dottrina della ragione del 1691 e la Introduzione alla dottrina dei costumi ( cioè all’ etica ) del 1692 . L’ uso del tedesco nelle lezioni universitarie rivestiva un significato analogo a quello avuto dal suo più illustre antecedente storico : la traduzione della Bibbia da parte di Lutero . Non solo veniva messa in questione una inveterata tradizione di scuola , ma si garantiva l’ accesso alla cultura da parte di un più vasto pubblico, sottolineando così la funzione pratica e sociale della filosofia : l’ idea divulgativa é indubbiamente dominante in tutto l’ illuminismo . Della prima fase del pensiero di Thomasius , nella quale egli opera all’ interno del giusnaturalismo abbiamo un’ importante opera , i Fundamenta iuris naturae et gentium , del 1705 . Il giusnaturalismo consiste nell’ ammettere l’ esistenza di uno ius naturae , un diritto inscritto nella natura stessa delle cose , contrapposto allo ius positum ( diritto positivo , nel senso di posto , stabilito dai singoli Stati ) : Thomasius , sulle orme del latino Cicerone ( vedi il De officiis ) distingue tra 3 valori fondamentali : l’ honestum , lo iustum e il decorum , cui corrispondono le tre attività umane della morale , del diritto e della politica . L’ honestum , il cui principio é ” fa’ a te stesso ciò che vuoi che gli altri facciano a se stessi ” , si risolve nell’ ambito della coscienza interiore ; lo iustum , ” non fare agli altri ciò che non vuoi che altri facciano a te ” , riguarda invece i rapporti tra gli individui e prevede una serie di obblighi e divieti cui ciascuno é costretto ad ubbidire da una legge coercitiva ; il decorum , ” fa’ agli altri quello che vuoi che altri facciano a te ” , concerne ancora le relazioni esteriori tra gli individui , ma prescrive comportamenti non già imposti dalla legge , ma dettati solo dalla convenienza . I tre princìpi obbediscono tuttavia a un’ unica finalità , che é insieme la destinazione dell’ uomo : quella di vivere il più lungamente e il più felicemente possibile . Più tardi egli si allontana dalla scuola del diritto naturale , ma rimane sempre fedele all’ assunto , già dichiarato nelle opere giusnaturalistiche , della priorità della volontà sull’ intelletto e , conseguentemente , della vita pratica sull’ attività speculativa . Le “astrazioni metafisiche” dei grandi sistemi filosofici , come quelli di Spinoza e Leibniz , gli rimangono estranee , anche perchè egli riconosce che la conoscenza umana trova un limite invalicabile nell’ esperienza . Più che elaborare sistemi concettuali , la filosofia deve quindi occuparsi dei problemi etici e tradursi in uno strumento di orientamento razionale per la condotta dell’ uomo . La morale di Thomasius , che risente anche di influenze pietistiche , si impernia sull’ amore del prossimo , che egli considera il carattere fondamentale dell’ uomo . Thomasius nutrì anche interessi per la storia della filosofia , al pari del padre Jakob , maestro di Leibniz . Attraverso di essa è possibile emanciparsi dalle singole posizioni filosofiche e assumere una posizione eclettica , che consenta di scegliere il meglio da ciascuna di esse . Questi suggerimenti vengono ripresi da un seguace di Thomasius , Jakob Brucker , autore di una delle più importanti storie della filosofia dell’ età moderna , intitolata appunto Historia critica philosophiae , per sottolineare l’ intento , in essa presente , di prendere le distanze dalle ricostruzioni scolastiche della filosofia , che obbedivano a un preciso punto di vista interpretativo .
A cura di Chiara Mangiarini
Christian Thomasius nacque l’1 gennaio 1655, morì il 23 settembre 1728.
Entrambe le date paiono emblematiche : nell’anno della sua nascita vennero, infatti, pubblicate le prime due opere di storiografia filosofica (History of philosophy di Thomas Stanley e Historia philosophica di Gorge Horn), disciplina che egli contribuì a rinnovare radicalmente, rendendola scienza “moderna”; nell’anno della sua morte, invece, si svolse in Germania l’ultimo processo per l’accusa di stregoneria, contro la quale Christian si era battuto per la quasi totalità della sua vita intellettuale.
La famiglia di Thomasius aveva alle spalle una lunga e prestigiosa tradizione giuridica. Il padre di Christian, Jacob, era un illustre professore presso l’Università di Lipsia, alla quale questi poté dunque accedere già all’età di 14 anni, e conseguirvi, tre anni dopo, il titolo di Magister philosophiae. Nel 1679 si laureò in giurisprudenza; successivamente intraprese la carriera universitaria tenendo libere lezioni.
Già a partire dal suo primissimo ingresso in ambito universitario, nelle vesti di professore, Thomasius diede importanti segnali di quel suo spirito innovatore e controtendenza, che lo animava, e che lo portò, più tardi, a venir individuato come l’incominciatore, assieme a Wolff, dell’Aufklärung tedesco ed europeo. Primo fra tutti tenne lezioni in lingua tedesca anziché latina: una rivoluzione che portò alcuni studiosi ad accostarlo a Lutero, che, in ambito religioso, aveva fatto lo stesso; primo fra tutti tenne lezioni a carattere seminariale, permettendo all’insegnamento di levarsi gli abiti un po’ dismessi del discorso accademico, e agli studenti di accostarsi allo studio in maniera non più semplicemente passiva, ma critica e partecipe.
Nei primi anni del ‘700 fondò, con l’amico pietista Francke, la rinomata università di Halle, di cui fu prima docente e successivamente direttore.
La filosofia eclettica
Ciò che caratterizzò più vividamente il pensiero di Thomasius fu la sua aperta opposizione alla filosofia aristotelica e all’ortodossia luterana, imperanti nella Germania del XVII sec. Egli si schierò contro la tradizione, contro gli errori sui quali questa si era ormai irretita, e, soprattutto, contro la sua totale chiusura rispetto ai novatores, rispetto a quei filosofi (per lo più non tedeschi) che avevano rivendicato la loro libertas philosophandi, tentando di liberarsi dalle catene dello sterile ossequio all’autorità.
L’aperta ostilità che il paese tedesco mostrava verso questi innovatori è ben evidenziata dalle parole di un illustre professore, Jacob Thomasius, proprio il padre del nostro Christian: “Non placent mihi navationes. Sed non displicet unquam antiquitatis notitia”.
Dal confronto col pensiero di suo padre, muove i primi passi l’elaborazione della dottrina dell’autore.
Jacob Thomasius fu un aristotelico di dura convinzione, che mai abbandonò la sua pregiudiziale rispetto alla cultura del suo tempo. Nonostante la sua ferrea posizione, però, questi si distinse un poco rispetto agli accademici suoi contemporanei, avendo tentato, seppur esilmente, di instaurare un dialogo con le nuove tendenze filosofiche che si stavano sviluppando in Europa: dichiarò infatti che fosse necessario studiare le differenti dottrine e le connessioni che fra di esse venivano ad instaurarsi. Ma se apparentemente tale presa di posizione può far pensare ad un atteggiamento non tanto dogmatico quanto si è illustrato, è bene evidenziar subito che l’autore propose un dialogo di tal genere al solo scopo di render ancor più evidente come la filosofia aristotelica fosse l’unica che rispondesse in maniera adeguata ai criteri di verità, come la filosofia aristotelica fosse sempre e comunque l’inveramento di ogni dottrina sviluppatasi in tempi antichi e moderni. Insomma, veniva proposto un confronto coi moderni, che però rimaneva tutto favorevole alla filosofia aristotelica.
Il lieve spiraglio di luce a cui Jacob permise l’apertura, lo studio delle diverse dottrine, fu successivamente fatale alle sue posizioni dogmatiche: da questo, il suo allievo Leibniz, e ancor più suo figlio Christian, presero spunto per inaugurare una nuova tendenza rivoluzionaria: la filosofia eclettica.
L’eclettismo è una ricerca della verità, libera dall’appartenenza ad una “setta” filosofica, libera, cioè, dai pregiudizi o dall’ammirazione di un filosofo assunto ad autorità.
Il filosofo eclettico è colui che, formatosi autonomamente dei principi e dei criteri di verità, sceglie, fra le opinioni degli autori a cui si accosta, quelle che più si conciliano con questi principi, tentando di ricreare quell’unità filosofica originaria dispersasi nelle diverse scuole.
Una filosofia di tal genere implica una ricerca continua sulla realtà e poggia sull’allargamento e il potenziamento dell’esperienza umana. E’ un edificio in perenne costruzione, un complesso di conoscenze sempre mutevole, e, per dirlo con le parole di Thomasius: “è preferibile avere una nave in grado di navigare, anche se spesso rinnovata nelle sue parti, piuttosto che tenersi sempre la stessa, tutta sconnessa e piena di falle”.
Dato il costante confronto con le dottrine da lui incontrate, il filosofo eclettico dovrà essere, anzitutto e necessariamente, uno storico della filosofia. Per questo, dovrà provvedere alla stesura di testi illustranti le filosofie ed il loro succedersi nella storia, senza alcun “filtro” interpretativo, sia esso aristotelico, platonico o di altro genere.
Sulla scorta di tali istanze, la storiografia filosofica ricevette una forte spinta, che provvide ad una sua revisione contenutistica e metodologica. Fondamentali in tal senso, poiché rispondevano a quest’appello, furono le opere di Bayle, di Heumann e del grande Brucker.
Inteso dunque come la filosofia eclettica sia un far pensiero autonomo, slegato dal settarismo del primo ‘600, si comprende bene l’appello a pensare con la propria testa che Christian Thomasius fece risuonare nella sua prima opera completa: Introductio ad philosophiam aulicam (1688). Qui il plauso ai cosiddetti novatores, si estesa a tutti coloro i quali intendevano – o avevano inteso – adottare il dubbio cartesiano in senso eclettico anziché scettico, applicandolo non solo in ambito scolastico – “di studio” -, ma in ogni attività pratica dipendente da luoghi di interazione umana, come, ad esempio, l’ambito giuridico del diritto.
La teoria dello spirito e la morale
La lotta contro il dogmatismo settario portata aventi da Thomasius proseguì attraverso la pubblicazione di due periodici: i Monatsgespräche (1688, 1689) prima, Storia della saggezza e della stoltezza (1693) poi. Qui cominciò a prender forma la teoria dello spirito thomasiana, tutta incentrata sul confronto col pensiero di Cartesio. La filosofia dei cartesiani, infatti, non solo era il tipico esempio di sudditanza ad un’autorità (Cartesio) contro la proposta esigenza di una ricerca della verità che si avvalesse di un criterio di giudizio autonomo, ma si faceva anche portavoce di una dottrina pericolosa che esaltava eccessivamente l’intelletto, trascurando il suo imprescindibile legame coi sensi e con il corpo umano. L’analisi di Thomasius qui proposta è un tipico esempio di applicazione dell’eclettismo ad una dottrina filosofica. Il cartesianesimo aveva ben riconosciuto la proprietà distintiva dell’uomo nel pensiero e il suo collegamento con il corpo, individuandone la sede nella ghiandola pineale. Tuttavia aveva ritenuto che la res cogitans potesse sussistere anche indipendentemente dalla res extensa, e che quindi il cervello fosse un organo esclusivamente attivo. Riprendendo la tipica espressione scolastica “nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu”, Thomasius affermava, invece, la passività del cervello rispetto ai sensi, senza i quali esso non avrebbe potuto agire correttamente (e d’altra parte – diceva il Nostro – la ghiandola pineale non avrebbe potuto, da sola, contenere tutti i pensieri dell’uomo).
La dimostrazione di questo assunto risiedeva in una constatazione immediata: l’attività sensoriale (per la quale il nostro autore coniò il termine Sinnligkeit –sensibilità -, di fondamentale importanza per tutta la successiva tradizione filosofica tedesca) non ingannava mai, a differenza dell’intelletto che, nel giudizio, poteva esser condotta dalla “precipitazione” (il pregiudizio) e non tener conto delle condizioni. La sensibilità condizionava, cioè, l’attingimento stesso della verità, per cui una conoscenza che non prendesse in considerazione le informazioni fornite dai sensi sarebbe stata “oscura”, o addirittura erronea: la ragione consiste nella capacità di riconoscere il bene e il male. Bene è ciò che la favorisce, male ciò che la indebolisce. I sensi, nel loro compito di trasmettere gli impulsi degli oggetti esterni (quelli che appunto favoriscono o indeboliscono la ragione), svolgono dunque un ruolo fondamentale. I sensi, oltre che necessari, sono buoni.
Queste riflessioni avevano trovato spunto nell’opera di Poiret, il cui pensiero era stato esposto ed approfondito da Thomasius in una della pubblicazioni del periodico Storia della saggezza e della stoltezza.
Poiret aveva profondamente criticato la svalutazione della conoscenza passiva da parte di Cartesio, frutto di quello stesso pregiudizio che il filosofo francese aveva inteso debellare. Secondo Poiret, la conoscenza passiva si traduceva addirittura in un’esperienza diretta e viva della realtà perché proveniva direttamente da Dio; l’opera della ragione sarebbe stata una semplice organizzazione dei dati forniti dall’esperienza.
Una tale posizione ridimensionava drasticamente le pretese della ragione e, conseguentemente, delle scienze. Al loro posto, in opposizione, assumevano importanza amore e volontà.
La ragione, infatti, consiste nella capacità non solo di riconoscere il bene e il male, ma anche di scegliere fra l’uno e l’altro. Il pensiero è connesso non solo ai sensi, ma anche alla volontà, anzi, muove dagli uni per dirigersi verso l’altra.
L’argomento gnoseologico veniva dunque ad intersecarsi con quello etico-morale, trattato da Thomasius nelle opere Einleitung zur Sittenlehre (1692) e Ausubung der Sittenlehre (1696).
L’influenza di Poiret è, anche qui, molto evidente: ricalcando il pensiero dell’autore francese, Thomasius formulava il presupposto secondo il quale l’uomo si trova costantemente in uno stato insuperabile di peccato. Tale assunto, secondo il Nostro, era stato trascurato da Cartesio, il quale allora aveva ritenuto possibile mitigare le passioni grazie all’opera dell’intelletto. L’intellettualismo cartesiano, tutto incentrato sulle facoltà meramente attive dell’uomo, non aveva tenuto conto di quelle passive, fondamentali. Se dunque (come abbiamo già visto) l’intelletto era attivo nelle deliberazioni, ma passivo nelle percezioni, così anche la volontà era attiva nelle inclinazioni, me passiva rispetto alle passioni. Passioni e percezioni, in quanto passive, assumevano carattere di necessità, quindi, di inestirpabilità .
Un’affermazione del genere provocò non pochi malumori nel ceto intellettuale tedesco: tale posizione si traduceva infatti con la negazione del libero arbitrio, il quale rappresentava invece un elemento fondamentale della cristianità ortodossa. In effetti la conclusione a cui Thomasius era giunto suscita anche a noi lettori moderni qualche perplessità; tuttavia è giusto registrare il tentativo, seppur esile e non troppo convincente, che l’autore propose per tentare di risollevare gli esiti di una morale profondamente negativa. All’impetuosità delle passioni dominanti bisognava opporre passioni opposte, così da mitigarle, almeno nelle loro manifestazioni esteriori.
E’ evidente che una tale soluzione è insoddisfacente, tant’è vero che anche Thomasius giocò come ultima carta la grazia divina, unica forza in grado di redimere l’uomo, di attuarne il cambiamento, di convertirlo spiritualmente.
Contro la “filosofia universitaria”, che voleva l’intelletto in grado di “corrompere e migliorare la volontà”, Thomasius propose anche un’argomentazione di tipo fisico, contenuta nel Saggio sull’essenza dello spirito (1699): “l’attività dell’intelletto opera solo ed unicamente nel cervello. Al contrario la volontà, quando fa qualcosa, esegue la sua azione, che pur comincia nel cuore, sempre al di fuori del cuore”. L’attività dell’intelletto, cioè, è sempre relegata ad un ambito teorico “cerebrale”, che, a differenza della volontà, non intacca la pratica, né promuove il cambiamento. Ed anzi, è proprio solo grazie alla volontà che l’intelletto può cominciare ad agire. A questo punto diviene assolutamente comprensibile il fondamentale di Ausubung der Sittenlehre: “la volontà è una forza delle anime umane molto più nobile che il pensiero dell’intelletto”.
A tale argomento si riallaccia la lotta di Thomasius contro le pene imposte agli eretici. Il concetto fondamentale di partenza era quello secondo cui la fede non è opera dell’intelletto: le sue radici non risiedevano nel cervello, bensì nel cuore e, conseguentemente, nella volontà.
L’idea cartesiana (ma, si potrebbe anche dire, l’idea di tutta la cristianità cattolica medievale) della “fede cerebrale” era, secondo il nostro, profondamente errata: una dottrina non rendeva beati. Le scissioni religiose si erano compiute a causa di dispute e disaccordi riguardo a cavilli filosofici che nulla avevano a che vedere con l’amore divino (non intellettuale). Non era raro, allora, imbattersi in personalità considerate sante da alcune confessioni religiose ed eretiche da altre. Ma l’eresia risponde solo a condizioni spirituali, non già intellettualistiche. Se poi l’eresia era cosa spirituale, la sua punizione avrebbe dovuto essere di tipo spirituale, non giuridica o politica. Meglio ancora, era auspicabile che la professione di una fede diversa (in fondo l’eresia altro no era che il “dissenso dalla religione dominante”) venisse permessa e tollerata, giacché l’ideale della mitezza altro non era che conformità ai criteri della rivelazione e della ragione.
La lotta contro i processi per stregoneria
L’impegno intellettuale contro le accuse e le punizioni per “eresia” ben presto si estese anche a tutte quelle credenze – ancora molto radicate nel popolo tedesco e decisamente sfruttate a lor favore dai membri della Chiesa – riguardo alla pratica della stregoneria. La Germania fu infatti la terra che ospitò il maggior numero di roghi e che attuò le torture più atroci nei confronti di migliaia di donne innocenti.
Come scrisse il gesuita tedesco Spee in un suo testo pubblicato anonimo nei primi anni del ‘600, il Cautio criminalis, seu de processibus contra saga, la causa di tale scempio poteva essere individuata nella mancanza di un controllo centrale, di una regolamentazione precisa che vincolasse le scelleratezze degli inquisitori, i quali, per di più, erano spesso persone corrotte e che sfogavano contro donne innocenti i loro istinti più bassi. A tale argomentazione, dobbiamo aggiungere due ulteriori elementi fondamentali: il vantaggio che la Chiesa traeva dalla disseminazione del terrore, che le permetteva di mantenere un governo assoluto sul popolo, e il pesantissimo contributo che diedero diversi intellettuali, i quali, con argomentazioni dettagliate (seppur discutibili), avevano permesso la diffusione di sciocche credenze e pregiudizi banali anche negli strati più colti – o, quantomeno, più istruiti – della popolazione. Il peso della loro opera appare infatti tanto più evidente se si considera che lo stesso Thomasius, che così fieramente vi si oppose, ne era stato in un primo momento influenzato, movendo i primi suoi passi nel “mondo della magia” da una posizione del tutto opposta a quella che ci potremmo aspettare.
Nel 1694 fu proposto all’università di Halle il caso di Barbara Labarenzin, una giovane accusata di eresia, a seguito di una “confessione” estorta sotto tortura da un’altra donna, successivamente bruciata viva come strega. Thomasius, che per la prima volta si trovava ad affrontare un caso del genere, e che, per sua stessa ammissione, era ancora molto “prevenuto nell’opinione comune sull’essenza delle streghe”, formulò una relazione in cui riportava che “bisognasse colpire l’inquisita (…) per la colpa di stregoneria”. Contrariamente alle sue aspettative, però, i suoi colleghi, chiamati anch’essi a esprimersi sul caso, avevano invece ritenuto in blocco che, in mancanza di prove concrete, la poveretta andasse immediatamente rilasciata.
L’accaduto lasciò Thomasius profondamente addolorato ed irritato “con se stesso”, per esser caduto nei pregiudizi di autorità contro i quali si era sempre battuto. A partire da quell’episodio, allora, s’impegnò profondamente affinché altri non compissero lo stesso errore. L’impegno thomasiano affinché venisse decretata la fine dei processi per stregoneria fu del tutto originale. Ormai si stavano facendo sempre più accesi i dibattiti riguardo alla possibilità, per le streghe, di lievitare in aria, trasformarsi in animali, accoppiarsi col demonio. Gli studi sull’eventualità che gli spiriti (soprattutto maligni) potessero entrare in contatto con gli esseri umani, si estendevano anche a questioni non più solo teologiche o demonologiche. Ma se Thomasius da qui attinse per dar forma articolata alla sua argomentazione, è ben più importante evidenziare come egli si concentrò maggiormente sugli aspetti giuridici della faccenda. Elemento comune di partenza per tutti coloro i quali si apprestavano a dimostrare o confutare l’esistenza delle streghe era il cosiddetto “patto” che questa ultime avrebbero dovuto stipulare col demonio per poi compiere i loro prodigi. Al riguardo, Thomasius evidenziava come tale patto non avrebbe avuto alcuna utilità per i due contraenti: gli uomini (sebbene, purtroppo, determinando il sesso del maggior numero dei condannati, dovremmo dire: le donne) avrebbero potuto procurarsi quanto desideravano (ricchezza, potere.) “con lieve fatica ed astuzia”, “con mezzi consentiti e senza l’aiuto del diavolo”. Di contro, ammesso che l’ignoranza e la pigrizia umana spingessero a tentare vie “alternative” per soddisfare le proprie brame, il patto non avrebbe avuto alcuna utilità nemmeno per il demonio: a che gli sarebbe servito? Le anime corrotte già erano al suo servizio e quelle buone non ne sarebbero state minimamente intaccate. Se tuttavia una tale argomentazione poteva ancora sollevare obbiezioni fra gli irriducibili dell’inquisizione, quella che egli propose poco successivamente non lasciava alcuna possibilità di appello: il demonio era spirito e, come le parole di Cristo nel vangelo di Luca avevano ben reso evidente, lo spirito non possedeva né carne né ossa. Ora, una relazione col diavolo che non fosse di tipo “corporeo”, giuridicamente, non provava nulla: giuridicamente un patto (che sarebbe stato, dunque, necessariamente) tacito, non esiste. Gli unici rapporti che gli uomini potevano intrattenere col demonio erano di tipo spirituale, morale, per questo, non penalmente rilevanti e punibili. Satana altro non era stato che, da una parte, l’asylum ignorantiae nel quale riversare tutte quelle questioni che la ragione umana non era in grado di comprendere (come, ad esempio, le allucinazioni, intese, a quel tempo, come manifestazione del demonio), dall’altra, la scusante che aveva permesso agli animi corrotti della Chiesa di perpetrare il loro scempio vergognoso.
L’opera di Thomasius, unita a quella di pensatori quali Bekker o il succitato Spee, provocò una forte reazione all’interno dei gruppi culturali. Non è infatti senza significato che, sebbene l’ultimo processo alle streghe si svolse nel 1728 – anno della morte del Nostro – , il 13-XII-1714, il re di Prussia, Federico Guglielmo I, emanò un editto nel quale, sottoponendo all’approvazione del re ogni decisione rispetto alle streghe (come auspicato proprio da quei tre intellettuali di cui abbiamo fatto il nome), decretava, di fatto, il compimento di un’epoca di roghi e terrore.
Bibliografia essenziale:
Mario Longo, Historia Philosophia Philosophica, edizione I.P.L., Milano 1986.
Francesco Tomasoni, Christian Thomasius, edizione Morcelliana, Brescia 2005.
CHRISTIAN WOLFF

A cura di Renzo Grassano
Christian Wolff nacque a Breslavia il 24 gennaio 1679. Nel 1706 fu nominato professore ad Halle. Fu certamente l’esponente più significativo dell’illuminismo tedesco, che deve gran parte della sua originalità, rispetto a quello inglese, francese ed italiano, alla forma logica in cui sono fatti valere i problemi e le relative soluzioni. Nel 1723, Wolff fu destituito dall’incarico per decreto del re di Prussia Federico Guglielmo I a seguito di un reclamo avanzato dai suoi colleghi di orientamento pietista. Senz’altro motivo, secondo l’Abbagnano, che la pubblicazione di un libro: Discorso sulla filosofia pratica dei Cinesi. In quest’opera Wolff aveva osato collocare Confucio tra i profeti, come grande saggio dell’umanità. Dopo l’insediamento sul trono di Federico II, Wolff venne però reintegrato nel 1740 e potè insegnare fino alla morte, sopraggiunta nel 1754. “L’ opera di Woff – scrive l’Abbagnano – ebbe su tutta la cultura tedesca un’influenza straordinaria. In un primo periodo scrisse in tedesco; in secondo periodo in latino, volendo parlare come ‘precettore di tutto il genere umano’.” Bisogna infatti comprendere che il latino non veniva considerato come una lingua morta, ma come una lingua internazionale conosciuta dai dotti, mentre il tedesco sembrava a Wolff un ostacolo alla diffusione del suo pensiero. In realtà, grazie a questa sua produzione bilingue, Wolff divenne il sistematore della terminologia filosofica tedesca. Secondo Kant, Wolff rappresentò il culmine di quel realismo dogmatico e metafisico iniziato fin dai tempi di Aristotele e proseguito anche in epoca moderna, in particolare da Leibniz. In realtà, Wolff fu soprattutto un illuminista. Scopo della filosofia e del sapere stesso è quello di illuminare l’uomo in modo tale da renderlo capace di usare appieno le sue facoltà intellettuali. La filosofia ha uno scopo pratico: la felicità umana, la quale, secondo la vecchia dottrina aristotelica è anche un’etica basata su un’attività contemplativa e di ricerca, contrapposta ad una vita attiva e dedita unicamente ad accumulare tesori e beni materiali. Wolff dice chiaramente che la felicità umana si ottiene raggiungendo una conoscenza chiara e distinta del mondo e delle cose. Per questo occorre la libertà filosofica, che si esprime anche attraverso la libertà di manifestare pubblicamente il proprio pensiero. Decisamente contrario ad ogni ipocrisia, Wolff disse che la mancanza di libertà d’espressione e di insegnamento ci costringerebbe a difendere come vere opinioni comunemente tramandate, mentre la pensiamo diversamente. Secondo Wolff, la “filosofia è la scienza dei possibili in quanto tali” e delle “ragioni per cui i possibili si realizzano”. Ovviamente, Wolff intende per possibile ciò che non implica contraddizione. Alla base della logica di Wolff stanno come per Leibniz il principio di non contradizione ed il principio di ragion sufficiente. Tuttav ia, questo secondo principio è dimostrabile a partire dal primo, non ha quindi carattere assiomatico, non è un postulato visibile solo per la sua evidenza. Per Wolff, il principio di non contraddizione è criterio di verità e diventano vere le proposizioni la cui negazione risulti contraddittoria. Si può osservare, a questo proposito, che la distinzione, introdotta da Leibniz, tra verità di ragione e verità di fatto viene praticamente annullata: tutte le verità filosofiche sono verità di ragione, cioè verità necessarie. Esitono, tuttavia, occorre precisarlo, delle proposizioni contingenti che, secondo Wolff, possono essere negate senza contraddizione. Questo dipende dalla concezione più radicale di Wolff secondo la quale la stessa filosofia dovrebbe strutturarsi secondo il metodo matematico. La filosofia deve pertanto darsi le definizioni esprimenti l’essenza delle cose stesse, deve trovare gli assiomi esprimenti i nessi fondamentali tra le cose, e indica re i teoremi deducibili dagli assiomi e dalle definizioni in grado di rappresentare le verità dimostrabili more geometrico, secondo una concatenazione necessaria. Solo in tal modo, secondo Woff, la filosofia non sarà solo l’eterna domanda sull’essere e sul perchè, ma anche una risposta alle domande. Wolff, su questo terreno, denuncia il carattere cartesiano ( e spinoziano) delle proprie influenze. “Nel metodo filosofico non bisogna far uso di termini che non siano stati chiariti da un’accurata definizione, né bisogna ammettere come vero alcunchè di non sufficientemente dimostrato; nelle proposizioni bisogna determinare con pari cura il soggetto e il prdicato e il tutto deve venire oridanto in modo che siano premesse quelle cose in virtù delle quali le seguenti sono comprese e giustificate.” (Logica, §139) Anche per Wolff, la filosofia prima, cioè l’ontologia (scienza dell’ente in quanto ente), ha per oggetto lo studio delle daterminazioni ch e appartengono a tutti gli enti, sia sotto determinate condizioni, sia in assoluto. Wolff definisce trascendentali i predicati più universali in quanto, per esprimere determinate proprietà delle cose, trascendono le singole categorie. Un esempio sono termini quali identico e diverso, simile e dissimile. Anche per esprimere i modi delle cose occorre far ricorso a predicati trascendentali quali possibile ed impossibile, determinato ed indeterminato. L’ontologia viene posta da Wolff tra le scienze teoriche, è da quindi da distinguersi rigorosamente da un’altra filosofia, che viene definita filosofia pratica. Altre forme di scienze teoriche sono la cosmologia razionale, la psicologia razionale e la teologia razionale. La cosmologia razionale si occupa delle proprietà del mondo in generale, cioè della totalità degli enti contingenti, collocati nello spazio e nel tempo. Wolff, a differenza di Leibniz, concepisce il mondo come una grande macchina creata da Dio per l’uomo. Tutto ciò che accade ha dunque per fine l’uomo. Compito della psicologia razionale è di studiare l’anima, una sostanza semplice ed immortale, distinta dal corpo, depositaria delle capacità percettive sia al livello sensitivo (piano delle percezioni confuse) sia al livello intellettivo (piano delle percezioni distinte). Wolff rifiuta quindi la dottrina leibniziana delle monadi mirante a superare la distinzione tra anima e corpo. La teologia razionale, o naturale, studia l’esistenza di Dio e dei suoi attributi. L’esistenza di Dio è provata da Wolff da tre argomenti: l’ontologico, derivato da Cartesio; il cosmologico, che partendo dalla contingenza del mondo sostiene la necessità di un ente non contingente ma eterno; la prova teleologica, che ricava dall’ordine finalistico (il mondo esiste per noi) la necessità di un ordinatore. Wolff distinse nettamente teologia razionale e rivelazione biblico-cristiana, asserendo che i contenuti di questa vanno oltre le possibilità della ragione, risultano in parte contraddittori, e sono decisamente contrari alle leggi di natura, come i miracoli. Di questi dice che non derivano dalla saggezza di Dio, ma dalla sua potenza. La filosofia pratica, per Wolff, comprende etica, politica, diritto, economia. Se lo scopo della filosofia è rendere migliore l’uomo, la filosofia pratica è certamente la parte più importante della filosofia. Le basi dell’etica wolffiana sono molto diverse da quelle poste da Leibniz. Essa viene dedotta, ma avrebbe valore anche se Dio non esistesse, pertanto viene dedotta da un assioma: il bene è tale di per sé, non perchè Dio ce lo ha insegnato. Le norme etiche sono quindi fondate sull’uomo, ed hanno l’uomo per fine. Sono riassumibili in un unico precetto:”Fa quello che contribuisce alla perfezione tua, della tua condizione, e del tuo prossimo, e non fare il contrario.” Secondo Wolff, tutto ciò che concorre alla perfezione umana è già posto nella su a natura. Il concetto di perfezione è desunto da quello di progresso del singolo e della società. Wolff concepisce questa evoluzione come necessaria, asserendo che sarà tanto più possibile quanto più la società sarà in grado di riformarsi in modo razionale, consentendo a ciascuno la libertà, ed il modo di rendersi utile al progresso degli altri. Anche nel campo del diritto, Wolff afferma il primato del diritto naturale, asserendo che sarebbe meglio ricavare dalla natura umana le norme che regolamentano l’agire. Il diritto all’uguaglianza di fronte alla legge è uno dei principi fondamentali. la società civile è concepita da Wolff come conseguenza di un contratto tra gli uomini, basato sulla mutua cooperazione ed avente per fine il comune benessere. Tuttavia, Wolff, rimase monarchico. Il miglior governo non poteva che essere quello di una monarchia illuminata, alla maniera di Federico II.
BAUMGARTEN
Il più illustre dei seguaci della scuola di Christian Wollf fu Alexander Gottfried Baumgarten (1714-1762). Egli è autore di una Metaphysica (1739) che si presenta sostanzialmente come un compendio in mille paragrafi della filosofia di Wollf e fu adottata da Kant come manuale per le sue lezioni universitarie. La fama di Baumgarten è però legata soprattutto alla Aesthetica (1750-1758), che fa di lui il fondatore dell’estetica tedesca e uno dei massimi rappresentanti dell’estetica del Settecento. Del resto, lo stesso termine “estetica” è stato introdotto da Baumgarten. La metafisica è da lui definita come “scienza delle qualità delle cose, conoscibili senza la fede”. Alla metafisica precede la teoria della conoscenza, che il filosofo tedesco designò per primo, nella storia del pensiero, col termine “gnoseologia”. La gnoseologia si divide in due parti fondamentali: 1) l’estetica, che concerne la conoscenza sensibile; 2) la logica, che riguarda invece la conoscenza intellettuale. L’originalità della riflessione di Baumgarten risiede nel rilievo che egli ha dato alla conoscenza sensibile, la quale, lungi dall’essere intesa come semplice grado preparatorio e subordinato alla conoscenza intellettuale, è dotata di un valore intrinseco, diverso e slegato da quello della conoscenza logica. Tale valore intrinseco è il valore poetico. I risultati cardinali cui perviene l’estetica di Baumgarten sono principalmente due: in primis, il riconoscimento del valore autonomo della poesia e, in generale, dell’attività estetica, ossia di un valore che non si riduce alla verità tipica della conoscenza logica. In secundis, il riconoscimento del valore di un atteggiamento o di un’attività umana che era ritenuta inferiore e dunque la possibilità di una più completa valutazione dell’uomo nella sua interezza. Questo secondo aspetto fa di Baumgarten uno dei più ragguardevoli esponenti dello spirito illuministico: l’estetica è da lui definita come la “scienza della conoscenza sensibile” ed essa viene determinata anche come “teoria delle arti liberali, gnoseologia inferiore, arte del bel pensare, arte dell’analogo della ragione” (Estetica, par.1). il fine dell’estetica è “la perfezione della conoscenza sensibile in quanto tale” e questa perfezione è la bellezza. Per questo motivo, a cadere fuori dal dominio dell’estetica sono, da un lato, quelle perfezioni della conoscenza sensibile che sono così nascoste da rimanere per noi sempre oscure, dall’altro quelle che non possiamo conoscere se non mediante l’intelletto. Il dominio dell’estetica ha un limite inferiore rappresentato dalla conoscenza sensibile “oscura” ed un limite superiore rappresentato dalla conoscenza logica “distinta”. Al dominio dell’estetica, pertanto, competono soltanto le rappresentazioni chiare ma confuse. La bellezza, come perfezione della conoscenza sensibile, è universale, ma di un’universalità diversa rispetto a quella della conoscenza logica, giacché astrae dall’ordine e dai segni e realizza una forma di unificazione meramente fenomenica. La bellezza delle cose e dei pensieri deve tuttavia essere distinta da quella della coscienza e da quella degli oggetti e della materia: le cose brutte possono essere bellamente pensate e le cose belle pensate in modo brutto. Baumgarten ritiene che la facondia, la grandezza, la verità, la chiarezza, la certezza e, per dirla in una parola, la “vita della conoscenza”, possano concorrere a formare la bellezza. In una nota, così egli definisce la perfezione: “se più elementi ,assunti contemporaneamente, costituiscono la ragion sufficiente di una sola cosa, allora vuol dire che essi si accordano fra di loro, e questo medesimo accordo è la perfezione”.
GOTTHOLD EPHRAIM LESSING

All’ illuminismo scolastico dei wolfiani e dei loro diretti oppositori fa riscontro una diversa e più libera forma di illuminismo professata da filosofi più o meno ” occasionali ” o ” mondani ” ( Philosophen für die Welt ) , come essi stessi amarono chiamarsi , o denominati anche ” filosofi popolari ” . Sono scrittori liberi dalla tecnica e dal gergo della scuola , sono menti inquiete , nelle quali germinano intuizioni nuove : da essi viene riscoperto Spinoza e tratto dall’ oblìo . Influenzati da Rousseau , essi immetteranno così nell’ illuminismo tedesco quella vena di sentimento che troverà nell’ anima tedesca la condizione di un più rigoglioso sviluppo e darà origine al movimento romantico . Il più importante degli illuministi mondani è Gotthold Ephraim Lessing : egli nacque nel 1729 nella famiglia di un parroco luterano a Kamenz , piccolo borgo di uno dei distretti più poveri della Sassonia ; dopo gli studi ginnasiali si immatricolò nel 1746 all’ università di Lipsia , per volere del padre , alla facoltà di teologia . Ma gli stimoli alla sua formazione intellettuale gli provennero assai più dalla Lipsia dei commercianti e librai , e soprattutto dal mondo culturale che gravitava intorno alle compagnie teatrali . Sono , fino al 1748 , gli anni delle sue prime commedie e degli inizi della sua lunga polemica contro gli invecchiati indirizzi letterari della tradizione . Dal 1748 al 1759 ( salvo un soggiorno a Wittenberg e un viaggio in Olanda ) è a Berlino dove assorbe la cultura illuministica , si lega in amicizia a Nicolai e Mendelssohn , collabora a riviste di critica letteraria e viene precisando le proprie posizioni di teorico dell’ estetica e di filosofo della religione . Con il dramma Miss Sara Sampson ( 1755 ) , una tragedia di ambiente borghese , dà al teatro tedesco un indirizzo ideologico innovatore . Seguono permanenze a Breslavia , nuovamente a Berlino fino al 1766 , poi ad Amburgo , infine l’ ufficio a Wolfenbüttel , accettato per fame , di bibliotecario del principe di Brunswick . Sono anni segnati dal trattato Laocconte ovvero sui confini fra la poesia e la pittura ( 1766 ) , nel quale le diversità fra le arti viene fondata sulla specificità espressiva dei loro mezzi tecnici ; dalla commedia Minna von Barnhelm ( 1767 ) di robusta coscienza borghese ; e dalla Drammaturgia d’ Amburgo ( 1767-69 ) , un organo letterario che doveva sorreggere a livello di teoria l’ attività del Teatro nazionale amburghese . Lessing vi elaborerà in forma compiuta una vera e propria teoria letteraria generale , modernissima , in cui riprese e unificò temi che aveva cominciato ad affrontare fin dagli anni ’50 . L’ ultimo decennio della sua vita , nell’ isolamento di Wolfenbüttel dove l’ intonaco della biblioteca cadeva a pezzi , fu una quotidiana battaglia contro le meschinità di censura e le angherie di controllo che ebbe a subire da parte del principe . Nel 1771 diventa membro della loggia massonica di Amburgo , nel 1772 esce la tragedia borghese antitirannica Emilia Galotti . Nel 1774-77 pubblica i Frammenti di un anonimo , in realtà parti di un manoscritto clandestino del deista radicale , Reimarus , e li correda di commenti i quali vedono nelle religioni positive , e quindi anche nel cristianesimo , nient’ altro che momenti storici dello sviluppo della ragione umana . Seguirono furibondi attacchi da parte dell’ ortodossia protestante e un divieto del duca di Brunswick a Lessing di far stampare ” cose sulla religione ” . In questo clima egli affidò le sue convinzioni etiche , ormai di rottura rispetto alle religioni rivelate , non solo al dramma Nathan il saggio ( 1779 ) in cui le istanze umanistico-laiche dell” illuminismo tedesco si esprimono al livello ideologico più maturo , ma anche a due opere uscite anonime : lo scritto Ernst e Falk . Dialoghi per massoni ( 1778-80 ) , esaltazione di una massoneria ideale concepita come strumento di rigenerazione morale della società e il trattato Educazione del genere umano ( 1780 ) che approfondisce l’ interpretazione storicistica delle religioni , completato un anno prima della morte a Wolfenbüttel , avvenuta esattamente nel 1781 . Egli godette di grande fama , dovuta anche al fatto che , oltreché filosofo , fu autore drammatico di successo : all’ interno della sua produzione letteraria si possono ricordare opere come Emilia Galotti , Minna von Barnheim e Nathan il saggio . Lessing si occupò di religione dapprima in una serie di scritti minori , tra cui il Cristianesimo della ragione (1753) e Sull’ origine della religione rivelata (1755) . Il senso generale di queste opere è la difesa della religione naturale , fondata sulla ragione , e la critica di quella positiva , che nasce dalla necessità di appoggiare il potere politico su una religione pubblica . Un’ esposizione letteraria di questa posizione è contenuta nel dramma Nathan il saggio , in cui l’ ebreo Nathan racconta al Saladino la favola dei tre anelli di cui soltanto uno dovrebbe essere autentico . I tre anelli simboleggiano le tre grandi religioni monoteistiche : il giudaismo , il cristianesimo e l’ islamismo . In realtà tutti e tre gli anelli sono soltanto l’ imitazione di un anello originario andato perduto : la vera religione naturale e razionale . Ma la riflessione più matura di Lessing su questi temi è conseguita nell’ Educazione del genere umano del 1780 , dove l’ analisi della religione è congiunta alla formulazione di una filosofia della storia . In quest’ opera Lessing assume una posizione di mediazione tra coloro che difendevano la validità della rivelazione e la sua autonomia dalla religione razionale ( come Wolff ) e coloro che escludevano la legittimità di ogni forma di religione rivelata ( come Reimarus ) . Lessing accetta la rivelazione , ma ne rifiuta il carattere soprannaturale , facendola coincidere con l’educazione progressiva del genere umano ad opera della ragione . Egli sostiene infatti che la rivelazione è per il genere umano ciò che l’ educazione è per il singolo uomo : in entrambe i casi lo scopo finale è quello del completo perfezionamento dell’ uomo : vi è piana corrispondenza tra lo sviluppo del singolo e quello della specie . Entrambi possono giungere alla loro destinazione finale solamente tramite un processo di perfezionamento , che nell’ individuo si configura come educazione , nel genere umano come rivelazione . Ma la rivelazione non è qualcosa di soprannaturale , che si contrapponga radicalmente alla naturalità e alla razionalità dell’ educazione individuale . Essa non è infatti altro che lo sviluppo della ragione dell’ umanità , dal momento in cui essa , come il singolo bambino , intravede il vero soltanto attraverso la sollecitazione della sensibilità ( per mezzo dell’ idea di un premio o di un castigo immediati ) a una fase conclusiva in cui essa esplica in piena autonomia , come avviene nell’ uomo maturo , tutte le sue facoltà conoscitive : Non la verità di cui ci si crede in possesso , ma il sincero sforzo per giungervi determina il valore dell’ individuo … l’ illusione del possesso rende pigri e presuntuosi ; solo la ricerca tiene desti ed insonni . Se Dio tenesse nella sua destra tutta la verità e nella sua sinistra il solo eterno impulso verso la verità con la condizione di dover andare errando per tutta l’ eternità e mi dicesse : ” scegli ! ” , io mi precipiterei umilmente alla sua sinistra dicendo : ” Padre , ho scelto ! La verità pura non è che per te solo ! : il valore della vita è da Lessing ravvisato nel tendere stesso alla verità , quello che Platone aveva accostato all’ eros . Ed è questo sentimento di sapore romantico che lo attrae verso Spinoza , verso l’ idea dell’ unità profonda di tutti gli esseri , che sarà tipica della fase conclusiva del pensiero del filosofo tedesco : l’ individualità , egli dice , via via che ascende verso le fasi più alte del suo sviluppo , si dilata fino a includere l’ universale , fino a farsi tutt’ uno con esso . In questo quadro interpretativo Lessing , sulla scia di Giambattista Vico , articola lo sviluppo del genere umano in tre età , che corrispondono a tre livelli di coscienza religiosa e morale . La prima età è quella del giudaismo , nella quale l’ educazione morale degli uomini , che si trovano ancora nell’ infanzia dell’ umanità , è imposta mediante premi e castighi immediati e sensibili . La seconda età coincide col cristianesimo : Doveva venire un pedagogo migliore , e strappar di mano al bambino il libro elementare ormai superato . E venne Cristo . Il cristianesimo , infatti insegno’ il valore della purezza del cuore , della coscienza interiore, la superiorità dello spirito sull’ esteriorità : il premio e la punizione non sono più di ordine sensibile , ma vengono differiti nella vita oltre la morte . A queste due epoche deve ora far seguito una terza età , che Lessing , richiamandosi consapevolmente a Gioacchino da Fiore , chiama l’ età del nuovo Vangelo eterno . In questa pura età dello spirito , nella quale verità non ha più bisogno di rivelazione ma viene conosciuta direttamente dalla ragione , diventano superflui premi e castighi , sensibili o spirituali che siano : in essa l’ uomo farà il bene per il bene e non perchè premiato da arbitrarie ricompense . Nell’ ultima fase della sua vita tuttavia Lessing si avvicinò , probabilmente attraverso la lettura di Shaftesbury , al panteismo di Spinoza . In una lettera di Jacobi a Mendelssohn del 1783 ( che suscitò un vasto dibattito nella cultura contemporanea ) si dice che Lessing , un anno prima di morire , avrebbe sostenuto : I concetti ortodossi della divinità non fanno più per me : io non riesco a gustarli . En kai pan : “uno e tutto” Io non so nient’ altro . Lessing si occupò ampiamente anche di estetica , come dimostrano opere quali il Laocoonte , del 1766 , o la Drammaturgia di Amburgo , degli anni 1767-69 . Egli sostiene che la bellezza non deriva da un particolare tipo di sensibilità ( come in Baumgarten e in Mendelssonh ) , ma dall’ unità dell’ azione drammatica , che conferisce armonia e coerenza interna all’ opera d’ arte , secondo l’ insegnamento di Aristotele ( il quale aveva tuttavia individuato tre canoni della tragedia : l’ unità di tempo , l’ unità di luogo e l’ unità di azione ) . Anche per quanto riguarda il fine dell’ arte drammatuca Leissing riprende la tradizione aristotelica , sostenendo che il dramma deve descrivere non già che cosa ha fatto questo o quel singolo uomo , bensì che cosa farà ogni uomo di un certo carattere in certe circostanze , attribuendo così alla tragedia un valore universale e di catarsi delle passioni .
MOSES MENDELSSOHN

Moses Mendelssohn (1729-1786) è il massimo rappresentante di quella che è passata alla storia come filosofia popolare tedesca. Tale indirizzo filosofico prese le mosse nel momento in cui – nel 1745 – Federico II convocò alla presidenza dell’Accademia prussiana delle Scienze lo scienziato francese Maupertius: questi – in perfetta sintonia col programma di Federico II – le diede una svolta decisamente filo-francese, il che contribuì notevolmente all’affermarsi nell’area tedesca di una viva attenzione per le tematiche proprie dell’illuminismo anglo/francese, fino ad allora poco sentito nell’area germanica. In particolare, venne dato gran peso alla problematica etico/sociale, religiosa e, in generale, antropologica (già Thomasius aveva spinto, a inizio secolo, in tal direzione), fino ad allora in secondo piano rispetto a quella gnoseologica e teoretica. Si venne così a costituire la “filosofia popolare”, così detta perché, in perfetta concordanza con le istanze dell’illuminismo francese, si proponeva un discorso filosofico meno specialistico e, pertanto, accessibile ad un più vasto pubblico (anche questo aspetto rientrava nel programma di diffusione culturale portato avanti dall’illuminismo francese). In questo clima fiorì la produzione filosofica di Mendelssohn, le cui opere principali sono le Lettere sulle sensazioni (1755), il Trattato sull’evidenza delle scienze metafisiche (1764), il Fedone o sull’immortalità dell’anima (1767), Gerusalemme o sul potere religioso e sul giudaismo (1783), Aurora o sull’esistenza di Dio (1785). Nato a Dessau nell’Anhalt da famiglia ebraica non particolarmente agiata, egli compì con grandi sacrifici studi autodidattici a Berlino, ove rimase per tutta la vita. Nel frattempo egli si dedicò con assiduità all’attività pubblicistica e a quella commerciale in un’enorme fabbrica di seta di cui diventò in seguito contitolare. Verso l’illuminismo egli intrattenne un rapporto alquanto promiscuo, mostrando un’entusiastica apertura verso la sua ala moderata (condividendo l’esigenza della tolleranza), ma una netta chiusura verso l’ala radicale (pervenuta al laicismo o, in certi casi, all’ateismo). Mendelssohn strinse poi un’amicizia con Nicolai e con Lessing: con il primo aderì attivamente a diverse riviste, col secondo collaborò negli studi di estetica; in particolare, nelle sue Lettere sulle sensazioni (1755) e nelle Considerazioni sulle fonti e connessioni delle belle arti e scienze (1757) in cui si avverte una certa influenza da parte dell’empirismo inglese, era affiorata qualche apertura verso una teoria che valutasse in modo positivo la sensibilità. La dottrina estetica elaborata da Mendelssohn ruota intorno alla facoltà del sentimento: la percezione del bello deriva da una facoltà che si distingue sia dalla ragione sia dalla volontà; tale è, appunto, il sentimento, che Mendelssohn – in sintonia con quanto sosteneva Bamgarten – connette con la sensazione, concependolo come una rappresentazione sensibile chiara ma confusa (ovvero non distinta). Per questa via, egli può con Baumgarten propugnare l’autonomia dell’estetica. Per molti aspetti, tuttavia, Mendelssohn rimase saldamente legato alla teologia tradizionale: nei tre dialoghi Fedone o sull’immortalità dell’anima (1767) egli sostiene l’immortalità dell’anima con argomenti desunti dal Fedone platonico e opportunamente rivisitati alla luce delle istanze cristiane. In particolare, il pensatore tedesco vi afferma che, di fronte all’essenza spirituale dell’uomo – suo vero essere e ponte verso la comprensione di Dio -, l’esistenza umana corporea e sensibile ha un significato assolutamente negativo. Con queste argomentazioni Mendelssohn, più che sciorinare riflessioni originali, riprende le affermazioni a suo tempo fatte da Leibniz sul valore negativo, in sede metafisica, della sensibilità; del resto egli aveva palesemente preso le difese di Leibniz contro Voltaire nelle Conversazioni filosofiche del 1755. Carattere decisamente tradizionale ha anche il trattato Gerusalemme o sul potere religioso e sul giudaismo: l’opera si configura come un recupero del tutto anti-illuministico dell’intero patrimonio biblico, definito come una “legislazione rivelata”: Mendelssohn obietta all’amico (ormai defunto) Lessino che lo scopo della Provvidenza è il progresso dell’uomo singolo, non dell’umanità nel suo insieme. L’atteggiamento teologico assunto da Mendelssohn raggiunge poi l’apice nelle Ore mattutine o lezioni sull’esistenza di Dio (1785), ove viene addirittura ripresa l’antica prova ontologica – di marca anselmiana – dell’esistenza di Dio. Gli interessi di Mendelssohn si appuntano soprattutto sulla problematica religiosa: egli è convinto che l’esistenza di Dio sia razionalmente dimostrabile e che sia al contempo difendibile un panteismo di tipo spinoziano. Ad accogliere l’interesse di Mendelssohn sono anche i rapporti tra religione e potere: la religiosità ha sede nella coscienza umana e, di conseguenza, non può in alcun caso rivestirsi di alcun potere ecclesiastico o civile. Ne segue che lo Stato deve non già farsi sostenitore di una religione contro l’altra, bensì difendere la più totale libertà di coscienza, separando nettamente le sue funzioni (riguardanti la felicità terrena dei suoi cittadini da quelle ecclesiali (riguardanti invece la felicità futura, la salvezza). Il tema della tolleranza – caro a tutti gli Illuministi – ritorna con particolare vigore in Mendelssohn, che dedica gli ultimi anni della sua vita alla lotta contro le discriminazioni e i pregiudizi gravanti sulla vita sociale degli ebrei. Provando a tracciare un bilancio dell’operato filosofico mendelssohniano, potremmo dire che esso – anfibio tra l’accettazione e il rigetto dell’illuminismo e delle battaglie da esso condotte – trovi un innegabile limite nel costante timore di spingere l’ideale dell’emancipazione (che permea l’opera di Mendelssohn) fino in fondo, oltrechè nella scarsa coscienza di metodo filosofico. Sull’altro versante, l’inestimabile pregio della sua filosofia risiede nell’infaticabile opera di divulgazione in termini piani e di senso comune delle idee illuministiche (o, meglio, delle idee illuministiche moderate e non radicali). Particolarmente interessanti e connessi alle tematiche illuministiche sono, ad esempio, gli appelli alla tolleranza religiosa lanciati nella Gerusalemme
PIETRO VERRI

BIOGRAFIA
Pietro Verri, discendente da una delle più nobili e importanti famiglie milanesi, dotato di grande intelligenza e di una rara capacità di rinnovarsi per la sua geniale sete di conoscere e di sapere, nacque a Milano il 12 dicembre 1728 da Gabriele, magistrato di notevole carisma, presidente del Senato milanese negli ultimi anni della sua vita, e da Barbara Dati di condizione aristocratica; compie i suoi primi studi nei Collegi dei Gesuiti di Monza e Brera e li proseguirà prima nella scuola pubblica di sant’Alessandro, retta dai Padri Barnabiti, nel Collegio nazareno di Roma (che più tardi paragona con orrore all’esperienza avuta nei sordidi accampamenti imperiali durante la guerra dei Sette Anni), e infine a Parma nel Collegio dei Nobili, retto dai Gesuiti; nel 1741 nascerà il fratello Alessandro, col quale dividerà interessi culturali vari e vasti e che lascerà una traccia profonda nell’ambito dell’Illuminismo milanese. Tornato in famiglia nel 1748, fin dall’anno seguente cominciano i suoi contrasti con la famiglia, soprattutto col padre, un alto funzionario governativo (era vicario di provvisione nella capitale lombarda), a causa della sua relazione con Maria Vittoria Ottoboni Boncompagni, moglie del duca Gabrio Serbelloni, mentre intraprende la carriera di magistrato, ottenendo l’incarico di “protettore dei carcerati” e partecipa contemporaneamente all’accademia dei “Trasformati” col titolo di “Abitatore Disabitato”. L’anno successivo pubblica la di poesie satiriche dal titolo La Borlanda impasticciata, servendosi d’un linguaggio derivante dall’uso maccheronico e storpiato di varie lingue. Del 1753 il padre, che era stato nominato reggente del Supremo Consiglio d’Italia, si reca a Vienna e si fa accompagnare dal figlio nella speranza che la momentanea lontananza potesse contribuire a troncare il legame con la duchessa Serbelloni; ma al ritorno il suo distacco dalla famiglia si accentua perché prosegue la relazione amorosa che diventa più intima, anche se per poco tempo ancora. Con la Serbelloni si interessa di attività teatrali e traduce le opere di Philippe Nericault Destouches, scrivendo anche una particolare introduzione sulla scena comica; nello stesso periodo prende posizione a favore della riforma goldoniana Abbandonato dalla Serbelloni nel 1754 attraverso un periodo di crisi, durante il quale non trascura comunque gli studi. Nel 1757 pubblica un almanacco dal titolo Il gran Zoroastro, ossia predizioni astrologiche per il 1758, tratte da un manoscritto di pietra e dall’egiziano in volgare favella per la pubblica utilità tradotte, scritto secondo l’uso del tempo, in tutti i linguaggi possibili, dal greco al dialetto milanese, in cui mette alla berlina i vizi della società aristocratica milanese con i suoi scandali e le sue superstizioni, con un tono ferocemente avverso al clero, ai nobili e ai pregiudizi popolari. Ripete la pubblicazione l’anno seguente, un’edizione per il 1759, in cui attenua certi toni violenti e sarcastici; ne pubblicherà un terzo nel 1762 intervenendo a favore di Cesare Beccaria nella polemica contro il marchese Carpani. Un ultimo Gran Zoroastro per l’anno bisestile 1764, verrà pubblicato l’anno seguente. Tra il 1759 e il 1760 viaggia tra Vienna (dove partecipa a una guerra contro la Prussia, nel reggimento Clerici, dopo aver ottenuto il brevetto di Capitano), Dresda, ancora Vienna per ritornare infine a Milano, dove pubblica un trattato Sul tributo del sale nello stato di Milano ed uno Sulla grandezza e decadenza del commercio di Milano, allo scopo di attirare su di sè l’attenzione delle autorità regie mostrando le sue attitudini a ricoprire un incarico nella pubblica amministrazione. Sulla questione monetaria ed economica tornerà nel 1762 pubblicando a Lucca il Dialogo tra Fronimo e Simplicio sul disordine delle monete nello Stato di Milano. Insieme al fratello Alessandro fonda nel 1761 l’Accademia dei Pugni, che in qualche modo continua l’esperienza degli almanacchi già pubblicati, soprattutto il primo: è un ritrovo “piuttosto insolito anche in quell’età fiorentissima di accademie e di circoli, dominato com’era da intenzioni mondane e culturali, oziose e insieme coraggiosamente progressive”, ed era stata chiamata così proprio per rendere meglio l’idea dello spirito aggressivo e spregiudicato che animava i suoi iscritti sia nelle discussioni private che nei dibattiti pubblici. Sempre nel 1761, in un momento di generale crisi dei periodici eruditi, fonda, insieme al fratello Alessandro (A), all’abate Alfonso Longhi (L), a Cesare Beccaria (B), al matematico e fisico Paolo Frisi (X), a Luigi Lambertenghi (NN), Giuseppe Visconti di Saliceto (G), (collaboratori furono anche Giuseppe Colpani (GC), Pietro Secchi(S) e Sebastiano Franci (F) – tra parentesi abbiamo messo le lettere iniziali con cui hanno segnato i loro articoli), la rivista “Il Caffè”, che comincia le sue pubblicazioni nel giugno 1764 uscendo con una cadenza di dieci giorni e durerà fino al maggio 1766: due anni ricchi di animazione culturale e di contributi originali di idee. La rivista viene così chiamata perché si finge di trascrivere le conversazioni, le discussioni e i racconti che venivano narrati in una bottega da caffè, di proprietà di una certo Demetrio, un greco saggio e di intelligenza pronta che si era trasferito a Milano. Nell’editoriale così scrive il Verri a nome di Demetrio: “in essa bottega chi vuol leggere trova sempre i fogli di novelle politiche… in essa bottega chi vuol leggere trova per suo uso il Giornale Enciclopedico e l’Estratto della Letteratura Europea e simili buone raccolte di novelle interessanti, le quali fanno che gli uomini che in prima erano romani, fiorentini, genovesi o lombardi, ora sieno tutti presso a poco europei; in essa bottega v’è di più un buon atlante, che decide le questioni che nascono nelle nuove politiche; in essa bottega per fine si radunano alcuni uomini, altri ragionevoli, altri irragionevoli, si discorre, si parla, si scherza, si sta sul serio; ed io, che per naturale inclinazione parlo poco, mi son compiaciuto di registrare tutte le scene interessanti che vi vedo accadere, e tutt’i discorsi che vi ascolto degni da registrarsi; e siccome mi trovo d’averne già messi in ordine vari, così li do alle stampe col titolo “Il Caffè”, poiché appunto son nati in una bottega da caffè”. I maggiori collaboratori saranno proprio Pietro Verri (con 37 articoli) e il fratello Alessandro, ma il più celebre è senz’altro Cesare Beccaria, che vi pubblicherà “Dei delitti e delle pene”, un trattato che gli darà risonanza europea e verrà letto nei più famosi salotti di Parigi, di Mosca e di altre città europee. Sul piano di una ricerca in qualche modo filosofica ed esistenziale pubblica anonimo a Livorno un libretto, intitolato Discorso sulla felicità o Meditazioni sulla felicità, definito da qualcuno come il manifesto dell’illuminismo lombardo, in cui, talvolta in consonanza col pensiero illuministico francese (e di Rousseau in particolare), sviluppa il tema del contratto sociale mediante il quale l’individuo rinuncia a parte della sua libertà per delegare allo Stato la sicurezza della collettività, delineando un’etica laica e spregiudicata, nella quale troviamo prima di tutto l’accettazione dei propri privilegi insieme all’espressione della volontà e quasi all’obbligo di usarli per il bene comune; poi l’analisi dei piaceri e dei dolori su una visione non religiosa, ma materialistica, dell’esistenza, insieme all’analisi dell'”ambizione”, considerata come la più funesta ma anche la più benemerita fra le passioni. L’opera si conclude con un breve saggio sulla storia umana, interpretata come progresso spezzato continuamente da catastrofi e periodi di decadimento, per cui il processo di civilizzazione è da intendersi come un percorso non indolore anche se le esperienze accumulate devono essere interpretate come un arricchimento dell’umanità. Incaricato di redigere un progetto di riforma amministrativa per Milano riguardo all’appalto dei tributi, nel 1764 comincia la sua collaborazione colle autorità austriache. La passione con cui si dedica alla riforma del sistema tributario scatena le ire dei “fermieri”, cioè dei privati ai quali era data in appalto la riscossione delle imposte, che notoriamente taglieggiavano la popolazione. Il piano di riforma, criticato aspramente sulla Frusta Letteraria dal Baretti, incontra il favore dell’Imperatrice Maria Teresa d’Austria, nonostante le idee illuministiche spesso estremistiche dell’autore. Pietro Verri è un esempio convincente di questa figura di intellettuale calato nella vita civile; nel 1768 scrive le Memorie storiche sull’economia politica dello Stato di Milano (destinate ad essere pubblicate postume nel 1804) e l’anno successivo scrive le Riflessioni sulle leggi vincolanti il commercio dei grani, allineato sulle posizioni delle teorie fisiocratiche che avversavano la limitazione imposta dai dazi doganali in materia di derrate alimentari, che verrà pubblicato solo nel 1797, l’anno della sua morte. Per il Verri il 1770 è un anno particolarmente importante; sul piano personale ottiene un particolare successo quando viene chiamato a far parte nel della Giunta per la riforma fiscale, nella quale si batte per l’abolizione degli appalti privati nella riscossione delle imposte, eliminando i privilegi dei “fermieri”: il governo asburgico stabilisce il passaggio delle imposte indirette alla gestione pubblica e nel contempo allontana dalla Commissione delle Riforme il Verri che rimane deluso e irritato, anche se la sua “carriera” come funzionario non viene interrotta; nel 1772 viene nominato vicepresidente del supremo consiglio per l’economia e successivamente nel 1780 presidente del Consiglio Camerale (sforzandosi di riorganizzare meglio l’apparato fiscale), succedendo al conte Gian Rinaldo Carli, che pur lo aveva avversato aspramente qualche anno prima, ma col quale si era successivamente riconciliato, e infine nel 1783 “Consigliere Intimo Attuale di Stato” e sempre nello stesso anno gli viene concessa l’alta onorificenza di “Cavaliere di Santo Stefano”. Soppresso nel 1786 il Consiglio Camerale, ritornerà a vita privata, dopo essersi reso conto che le maniere riservategli dall’Imperatore divenivano sempre più fredde, anche a causa dell’invidia dei suoi nemici a corte e dei suoi detrattori, che avevano insinuato nell’animo di Giuseppe II “il sospetto che il di lui zelo fosse interessato, e che egli col favor popolare cercasse quasi una indipendenza: Si fece nascere una gelosia di lumi e di ingegno, quasi che egli volesse soverchiare e tutto sconvolgere a suo talento. La diffidenza fece moltiplicare gli ostacoli alla sua carriera, per modo che trovavasi non di rado costretto a disperdere la sua attività in una continua difesa personale… Ecco perché annojato, alla fine chiese egli stesso di essere liberato dal peso di amministrare, e questo era quello che si bramava che egli facesse”. Sempre nel 1770 redige la prima stesura delle Osservazioni sulla tortura, l’opera per cui viene più spesso ricordato, a partire da Alessandro Manzoni per la stesura della Storia della colonna infame. Fin dal 1764 aveva abbozzato alcune idee su questo orribile abuso. Ne esiste infatti un cenno nel celebre almanacco pubblicato in quell’anno nel punto in cui parla del mal di milza. L’opera viene rielaborata nel 1777, e per rendere più efficace la forza del suo ragionamento porta come esempio di delitto impossibile e confessato attraverso l’uso eccessivo della tortura, l’episodio delle unzioni venefiche cui si attribuì la peste che desolò Milano nel 1630. L’opera verrà pubblicata solo postuma, nelle serie di volumi dedicati agli “Economisti classici, parte moderna, vol. XVIII”, anche perché suo padre era Presidente di quel collegio che centoquarantasette anni prima aveva dato un così atroce esempio di ignoranza e di crudeltà nel legale assassinio di tanti innocenti e si credette che la stima nei riguardi del Senato potesse restar macchiata per la diffusione dell’antica infamia; per rispetto del padre, si pensa che il Verri non diede alle stampe il libro. Intanto si diffondono in Europa nuove idee che egli enuclea nelle Meditazioni sull’economia politica (1771) che esaltano la libera iniziativa e prospettano l’ideale di un sistema statale in cui avrebbe dovuto essere garantita la felicità al maggior numero possibile di cittadini, i migliori dei quali avrebbero dovuto essere chiamati a ricoprire i più elevati uffici pubblici: siamo, come si può notare, più all’interno dell’utopia illuministica che dell’analisi razionale della realtà quotidiana ed economica oltre che politico-amministrativa. Nel 1776 sposa la nipote Marietta Castiglioni, di molti anni più giovane, dalla quale avrà l’anno dopo la figlia Teresa; in occasione della nascita della bambina scrive i Ricordi alla figlia, confidenze privatissime, non destinate alla pubblicazione. Successivamente avrà un secondo bambino, di nome Alessandro, come il fratello, che morirà prestissimo, seguito presto anche dalla madre. Il 13 luglio 1782 si risposa, prendendo in moglie Vincenzina Melzi, che amò sempre teneramente, dalla quale ebbe “numerosa prole” che allietò gli ultimi anni della sua vita. Nel 1781 pubblica i Discorsi sull’indole del piacere e del dolore, che erano già usciti separatamente (il primo nel 1773), in cui stabilisce la teoria che il piacere consiste nella cessazione del dolore. Nel 1783 dà alle stampe la Storia di Milano, dopo una diligente ricerca delle antiche memorie milanesi, soprattutto sul piano economico, un’opera che riceve il plauso anche delle autorità viennesi, soprattutto del Principe Kaunitz che in una lettera del 4 settembre di quell’anno ebbe a scrivere: non dubito che l’opera avrà tutto quel merito che si può sperare dall’erudizione dell’autore, guidato da uno spirito filosofico e superiore alla maniera di pensare comune a’ compilatori di simili storie, e per lo più privi di sana critica”. Nei dieci anni che seguirono il suo ritiro a vita privata, compare sulla scena pubblica solo nel 1790, in occasione della pubblicazione dei Pensieri sullo stato politico del Milanese nel 1790, in occasione della morte di Giuseppe II, rimettendo in discussione le sue idee politiche ed economiche. Nel 1796 l’entrata di Napoleone in Milano e la creazione di un organo municipale gli dettero un ultimo momento di celebrità, perché fu chiamato a far parte della Municipalità, impegnandosi col solito ardore; ma quasi un anno dopo, nella notte del 28 giugno 1797, proprio durante una riunione nella sala della Municipalità, morirà per un improvviso attacco apoplettico, a sessantotto anni. La moglie gli farà erigere un monumento accanto al sepolcro che egli stesso si era preparato nella cappella gentilizia della sua villa di Ornago.
IL PENSIERO
Il centro più importante dell’Illuminismo italiano fu Milano, dove una schiera di scrittori si riunì intorno ad un periodico, Il Caffè, che ebbe vita breve ma intensa (1764-1765). Il giornale, che ebbe come modello lo “Spectator” inglese, fu diretto dai fratelli Pietro e Alessandro Verri e vi collaborò, fra gli altri, Cesare Beccaria. Particolarmente curioso è il titolo di tale testata giornalistica: fu chiamata “Caffè” perché i suoi membri si riunivano a lavorare e ad impaginare in una fabbrica dismessa, ove un tempo si produceva, appunto, il caffè; ma, accanto a questo primo significato “di facciata”, ce n’era un altro. Infatti, non era forse il caffè quella bevanda che teneva svegli gli uomini, impedendo loro di sprofondare nel sonno o di rimanere assorti in esso? Il riferimento era – ovviamente – a chi viveva nei dogmatismi di vario genere, rifiutandosi di aprire gli occhi sul mondo e di indagare con la ragione, accostata appunto al caffè per la sua capacità di “svegliare” gli individui. Non è un caso che, in quegli stessi anni, Kant riconoscesse a Hume il merito di averlo destato dal “sonno dogmatico”. Se Alessandro Verri fu letterato e storico, Pietro Verri fu filosofo ed economista dalle spiccate qualità: il suo fu – secondo l’espressione di Luperini – un Illuminismo nobiliare ed utilitaristico. Verri partecipò attivamente a “Il Caffè” (con ben trentasette articoli). Egli rappresenta il tentativo più coerente in Italia di instaurare una collaborazione con il potere politico delle monarchie illuminate. In alcuni suoi scritti (“Meditazioni sulla felicità”, 1763; “Discorso sull’indole del piacere e del dolore”, 1773), Verri importò in Italia le posizioni di Helvétius e di Condillac, fondando sulle sensazioni e sulla ricerca dell’utile (ossia del piacere) le basi di ogni attività umana. L’idea di fondo che aleggia negli scritti verriani (e che mette in luce il suo debito verso la filosofia sensista francese) è che la vita umana sia padroneggiata dal dolore e che il piacere altro non sia se non i momenti di cessazione del dolore stesso (una tesi, questa, che ritroviamo in Schopenhauer e in Leopardi). Anche l’arte, come altre forme di illusione, favorisce tale sospensione del dolore attraverso la sua azione sui sensi. In questa prospettiva, l’arte nasce dal bisogno di aggiungere piaceri alla vita e, poiché – secondo l’insegnamento platonico del “Gorgia” – il piacere non è pensabile se non in riferimento al dolore (provo piacere a bere perché così vinco il dolore della sete), l’arte dovrà presentarsi come abile alternanza di dolori ben calibrati e di immediati piaceri che pongano ad essi fine. Solo in tal modo all’uomo è concesso di distrarsi dai “dolori innominati” da cui trae origine il bisogno stesso dell’arte.
“La grand’arte consiste a sapere con tanta destrezza distribuire allo spettatore delle piccole sensazioni dolorose, a fargliele rapidamente cessare, e tenerlo sempre animato con una speranza di aggradevoli sensazioni, in guisa tale ch’egli prosegua ad essere occupato degli oggetti proposti, e terminatane l’azione, richiamandosi poi la serie delle sensazioni avute, ne veda una schiera di piacevoli, e sia contento di averle provate. A tal proposito io osservo che sarebbe intollerabile una musica, se non vi fossero opportunamente collocate e sparse delle dissonanze, le quali cagionano una sensazione disgradevole e in qualche modo dolorosa. Cosí nella poesia dei versi aspri distribuiti sapientemente a tratto a tratto cagionano una sensazione disgustosa, e rapidamente la fanno cessare armoniosi e sonori versi […] Bisogna che le cose belle sieno a una certa distanza le une dalle altre, distanza o di luogo o di tempo, in guisa tale che abbia luogo fra una sensazione e l’altra d’intromettersi il dolore.” (Discorso sull’indole del piacere e del dolore, cap. IX).
Verri sostiene il principio che tutte le sensazioni – piacevoli o dolorose – dipendono dalla speranza e dal timore. La dimostrazione di questa tesi è condotta dapprima per ciò che riguarda il piacere e il dolore morale, riportati ad un impulso dell’anima verso l’avvenire. Il piacere del matematico che ha scoperto un nuovo teorema deriva, per esempio, dalla speranza dei piaceri che lo aspettano in avvenire, dalla stima e dai benefici che la scoperta gli apporterà. Il dolore per una disgrazia è similmente il timore dei dolori e delle difficoltà future. Poiché la speranza è per l’uomo la probabilità di vivere nel futuro meglio che nel presente, essa suppone sempre la mancanza di un bene ed è perciò il risultato di un difetto, di un dolore, di un male. Il piacere morale non è che la rapida cessazione del dolore ed è tanto più intenso quanto maggiore fu il dolore della privazione o del bisogno. Il bene supremo per l’uomo è qui, come nell’Illuminismo, la felicità, una felicità intesa però – come la troviamo in Beccaria e in Bentham – non come individuale, bensì come estesa al maggior numero possibile di persone: riaffiora, in qualche misura. il concetto di eutimia ed atarassia delle filosofie antiche. Questa teoria di Pietro Verri sarà, inoltre, molto apprezzata dallo stesso Kant. Lo scopo della società è quello di favorire la massima utilità possibile per il maggior numero di soggetti: deve cioè accrescere il piacere pubblico e scemare il dolore. In campo economico, Verri scrive le “Meditazioni sull’economia politica” (1771) e si può notare come, in tale ambito, il suo pensiero tenda ad evolversi, sfuggendo a schemi fissi: partito da un iniziale mercantilismo, si avvicinò a moderate posizioni fisiocratiche (particolarmente in voga nell’età dei Lumi), passando anche da un’iniziale fiducia in un governo di stampo assolutistico assistito dai filosofi alla preferenza per la monarchia costituzionale (seguendo il modello dell’Inghilterra). Anche la storia non esulò dai suoi poliedrici interessi: oltre ad una “Storia di Milano” (1783), egli compose le celeberrime “Osservazioni sulla tortura”, di carattere storico/giuridico: uscite solo nel 1804, sette anni dopo la morte del grande illuminista milanese, in esse si affronta la riflessione sui fatti milanesi del 1630 che videro torturati e condannati due presunti “untori”, del tutto innocenti. Lo scopo, più che l’illustrazione degli effetti reali che la tortura produsse “all’occasione delle unzioni malefiche alle quali si attribuì la pestilenza che devastò Milano”, era l’ottenimento dell’abolizione della tortura stessa, dopo che Maria Teresa d’Austria l’aveva mantenuta in vita, seppur a livelli minimi, in tutta la Lombardia. Nel pamphlet verriano vengono pertanto riportati gli interrogatori a cui furon sottoposti i presunti untori.
“Da questo esame solo ne ricaverà chi legge l’idea precisa della maniera di pensare e procedere in quei disgraziatissimi tempi…Il metodo col quale si procedette allora fu questo: si suppose di certo che l’uomo in carcere fosse reo. Si forzò a comporre un romanzo e nominare altri rei; questi si catturarono e sulla deposizione del primo si posero alla tortura. Sostenevano l’innocenza loro, ma si leggeva ad essi quanto risultava dal precedente esame dell’accusatore, e si persisteva nel tormentarli sinché convenissero d’accordo”.
La conclusione del Verri sul panorama offerto dalle varie “inquisizioni” è davvero sconsolata e l’atteggiamento di Verri è comprensivo nei confronti dei giudici solo nella misura in cui essi erano costretti, secondo lui, ad attuare delle regole che appartenevano ad un sistema ingiusto di giurisprudenza. Quello della giustizia era un problema particolarmente sentito nell’età dei Lumi: anche Beccaria se ne occupò attentamente e il frutto di tale attenzione è il suo celebre “Dei delitti e delle pene”, in cui dimostra come la tortura e la pena di morte siano due pratiche barbariche che si oppongono totalmente ai dettami della ragione, da Beccaria intesa come autentica guida della condotta umana. Attraverso le attente analisi dei processi contro gli untori del 1630, Verri dimostra su quali assurdi pregiudizi (e la critica ai pregiudizi costituisce il cuore della riflessione illuministica) si fondi la pratica della tortura a fini giudiziari, ancora in uso a quei tempi. Smontati gli indizi sulla base dei quali fu pronunciata la terribile condanna degli untori, Verri mette in luce l’inaffidabilità e l’ingiustizia del sistema giudiziario attraverso cui si pervenne alla condanna. Viene abilmente mostrata – con un argomentare da scienziato – l’inefficacia della tortura al fine di scoprire la verità, poiché – egli fa notare – gli “untori” del 1630 confessarono sì le proprie colpe, ma solamente per sottrarsi alle atroci sofferenze fisiche inferte loro dai giudici. Assodata la mancata utilità giudiziaria della tortura, Verri si sofferma anche sull’aspetto etico della questione, cercando di dimostrare che “quand’anche la tortura fosse un mezzo per iscoprire la verità dei delitti, sarebbe un mezzo intrinsecamente ingiusto”. Il ragionamento verriano è di una semplicità stupefacente e si basa su due assunti basilari: la tortura è, in ogni caso, una crudeltà, poiché se colpisce un colpevole certo, gli infligge sofferenze non necessarie; e se colpisce un colpevole solo probabile, rischia di abbattersi contro un possibile innocente. E poi la tortura è eticamente inaccettabile e contro natura, poiché costringe gli accusati a rinunciare alla istintiva (naturale e sacrosanta) difesa di sé, facendosi accusatori e traditori di se stessi.
“Se è certo il delitto, i tormenti sono inutili, e la tortura è superfluamente data, quando anche fosse un mezzo per rintracciare la verità, giacché presso di noi un reo si condanna, benché negativo. La tortura dunque in questo caso sarebbe ingiusta, perché non è giusta cosa il fare un male, e un male gravissimo ad un uomo superfluamente. Se il delitto poi è solamente probabile, qualunque sia il vocabolo col quale i dottori distinguano il grado di probabilità difficile assai a misurarsi, egli è evidente che sarà possibile che il probabilmente reo in fatti sia innocente; allora è somma ingiustizia l’esporre un sicuro scempio e ad un crudelissimo tormento un uomo, che forse è innocente; e il porre un uomo innocente fra que’ strazj e miserie tanto è più ingiusto quanto che fassi colla forza pubblica istessa confidata ai giudici per difendere l’innocente dagli oltraggi. La forza di quest’antichissimo ragionamento hanno cercato i partigiani della tortura di eluderla con varie cavillose distinzioni le quali tutte si riducono a un sofisma, poiché fra l’essere e il non essere non vi è punto di mezzo, e laddove il delitto cessa di essere certo, ivi precisamente comincia la possibilità della innocenza. Adunque l’uso della tortura è intrinsecamente ingiusto, e non potrebbe adoprarsi, quand’anche fosse egli un mezzo per rinvenire la verità”. (cap. XI)
Molti e interessanti sono anche gli scritti di carattere familiare e privato, tra cui spicca un epistolario ricco e appassionante e un “Manoscritto da leggersi alla mia cara figlia Teresa”, nel quale l’infanzia viene presentata in termini piuttosto simili a quelli dell’ “Emile” di Rousseau, con l’attenzione rivolta alla felicità dei bambini e alla loro innata ricchezza, ma con un maggior senso (rispetto a Rousseau) della responsabilità educativa affidata alla famiglia e alla società, in grado di distruggere o favorire le potenzialità dei ragazzi.
CESARE BECCARIA

VITA E OPERE
Dei delitti e delle pene , l’ opuscolo pubblicato nel 1764 da Cesare Beccaria é indubbiamente il testo più noto dell’ intero illuminismo italiano ; ed é anche il più importante , se si considera la sua fortuna in Europa e la sua influenza sui pensatori successivi . In esso convergono alcune delle idee sociali più significative della nuova cultura che andava affermandosi , espresse in uno stile raffinato e limpido al tempo stesso , un modello di esposizione per i nuovi filosofi . Interessante é il fatto che quando venne pubblicata l’ opera , l’ autore aveva appena 25 anni e che quel successo restò l’ unico nella sua lunga carriera di scrittore e filosofo : tutti gli altri suoi scritti sono pressapoco sconosciuti . Cesare Beccaria nacque a Milano nel 1738 da una famiglia ricca e nobile e a vent’ anni si laureò in Legge presso l’ Università di Pavia . Le nozze del 1761 con Teresa Blasco , di condizioni umili , portarono alla rottura con la famiglia e fu solo grazie all’ intervento di Pietro Verri , al quale intanto Beccaria si era avvicinato , che potè in seguito avvenire la riconciliazione . Il carattere riservato e riluttante di Cesare Beccaria , tanto nelle vicende private quanto nelle pubbliche , ebbe nei fratelli Verri , e soprattutto in Pietro , un fondamentale punto d’ appoggio e di stimolo . Alle frequentazioni con Pietro , non a caso , é ispirata la prima opera edita da Beccaria , il trattato Del disordine e de’ rimedi delle monete nello stato di Milano nel 1672 , uscito a Lucca nel 1762 appunto . Con questo scritto Beccaria prendeva una netta posizione in una delicatissima questione finanziaria , entrando così in polemica con i conservatori . Nello stesso anno , poi , gli nacque la figlia Giulia , la futura madre di Alessandro Manzoni . Isolate e sporadiche furono le collaborazioni di Beccaria alla rinomata rivista ” Il Caffè ” , ma tutte di altissimo valore teorico . L’ adesione alle idee degli illuministi francesi , da Montesquieu a Diderot a Rousseau , e la collaborazione intensa con Pietro Verri dovevano dare i loro frutti e li diedero con la pubblicazione del capolavoro di Beccaria , Dei delitti e delle pene . Lo scritto venne dato alla stampa nel 1764 a Livorno , presso lo stesso editore che pochi anni dopo avrebbe pubblicato la prima edizione italiana dell’ Enciclopedia di Diderot e D’Alembert . Beccaria preferì far comparire come anonimo l’ opuscolo , temendo ripicche personali e ritorsioni e , infatti , parecchie furono le reazioni di condanna , soprattutto da parte della Chiesa cattolica , che nel 1766 inserì l’ opera nell’ Indice dei libri proibiti , senza però arrivare a bruciarla pubblicamente , come invece era stato fatto per l’ Uomo macchina di La Mettrie . Tuttavia Beccarie ottenne anche molti pareri favorevoli : in Italia il libro fu strenuamente difeso dai fratelli Verri sul ” Caffè ” e in Francia i philosophes più prestigiosi lo tradussero e salutarono come un vero e proprio capolavoro , Voltaire in primis . Questo gli fruttò l’ invito ad andare a Parigi , dove arrivò in compagnia di Alessandro Verri nell’ ottobre del 1766 . Ma il suo carattere schivo e riservato gli rese sgradevole l’ accoglienza festosa dell’ ambiente parigino , mentre la nostalgia dell’ amata Milano e della famiglia lo inducevano ad un rapido rientro in patria , interpretato un pò da tutti come una sorta di fuga inspiegabile . Questo fece vacillare i suoi rapporti con i fratelli Verri , che gli rinfacciarono l’ indolenza e il carattere provinciale : finiva così la fruttuosa collaborazione col gruppo degli illuministi lombardi . Dal 1769 Beccaria occupò per due anni la cattedra di Economia civile presso le Scuole Palatine di Milano ( e , una volta morto , verranno pubblicati gli Elementi di economia pubblica ) . Dal 1771 fini alla morte ( avvenuta il 28 novembre 1794 ) si dedicò alla carriera amministrativa , dando il suo apporto alla politica riformista della monarchia asburgica che regnava su Milano . Nel 1770 intanto aveva pubblicato le Ricerche intorno alla natura dello stile , in cui riprendeva le riflessioni comparse sulla rivista ” Il Caffè ” : il pensiero sensista é applicato a meglio comprendere i meccanismi tramite i quali si svolge la comunicazione umana , e in particolare quella letteraria . Beccaria in ambito letterario si schiera in favore di una letteratura rinnovata nello stile , fedele al bisogno di esprimere concetti concreti ( cose ) secondo procedimenti razionali . Anche Cesare Beccaria , come Pietro Verri , concepiva la cultura in termini utilitaristici , ossia quale strumento di intervento concreto sulla realtà con il fine di migliorare le condizioni materiali di vita degli uomini : e qui emerge tutto il suo spirito illunministico , il quale a sua volta mutua la concezione utilitaristica da Francesco Bacone e dal suo ” sapere per potere ” . Il tema di Dei delitti e delle pene , propostogli da Pietro Verri , ben si apprestava ad affrontare da un punto di vista specifico e circoscritto la questione della giustizia , e dunque della politica e della società , e infine del rapporto tra società e benessere . Per questa ragione , attaccando apertamente il comportamento dei vari stati intorno alla questione della giustizia , Beccaria metteva in discussione l’ intero assetto del quale quel comportamento era espressione , finendo con l’ adombrare , nelle proposte di un rinnovamento giudiziario , una società fondata su valori interamente alternativi .
DEI DELITTI E DELLE PENE
Dei delitti e delle pene é diviso in 42 brevi capitoli , ognuno dei quali tratta un aspetto specifico della questione dibattuta . Lo scopo dell’ opera nel suo insieme é di dimostrare l’ assurdità e l’ infondatezza del sistema giuridico vigente . Beccaria non esita a farlo passare come un sistema puramente repressivo e rappresentato nei suoi ingiustificati rituali di violenza . Invece di essere al servizio della giustizia , il sistema giudiziario si rivela finalizzato ad un mostruoso meccanismo di potere e di soprusi , dietro il quale si profila l’ ingiustizia che caratterizza l’ intera società che lo esprime . Non il benessere , ma la sofferenza della maggior parte dei cittadini é infine il risultato di una struttura così irrazionale . In particolare Beccaria tuona contro la pena di morte , vertice di inciviltà gestito dallo stato , e contro le pratiche di tortura , inutili e anzi spesso fuorvianti rispetto alla verità e comunque a loro volta barbare . Gli argomenti addotti da Beccaria sono grosso modo gli stessi , davvero difficili da confutare , che ancora oggi vengono ripetuti contro la prosecuzione di pene capitali e di torture : la tortura é quell’ orrenda pratica con la quale si sottopone il presunto colpevole a parlare ; ma se il compito della giustizia é di punire chi commette ingiustizia , la tortura fa l’ esatto opposto perchè colpisce tanto i criminali quanto gli innocenti , cercando di costringerli con la forza ad ammettere atti da loro non compiuti ; e poi sotto tortura anche un innocente finirà per confessare reati che non ha commesso pur di porre fine al supplizio . La tortura poi é ingiustificata perchè si applica ancor prima della condanna : Un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice . E, paradossalmente, con la tortura l’innocente é posto in peggiore condizione che il reo: infatti l’innocente se viene assolto dopo la tortura ha subito ingiustizia, ma il reo ci ha solo guadagnato, perchè é stato torturato ma , non avendo confessato, é risultato innocente e si é salvato dal carcere! Dunque l’innocente non può che perdere e il colpevole può guadagnare, nel caso in cui venga assolto. Ancora più complessa é la questione della pena di morte , ossia della vendetta istituzionalizzata : Beccaria riconosce la validità della pena di morte in Stati particolarmente deboli in cui i criminali fanno ciò che vogliono . Però nel 1700 , con il progressivo rafforzarsi degli Stati tramite l’ assolutismo illuminato , la pena di morte diventa assolutamente inutile : se lo Stato é forte , allora punirà senz’ altro il criminale , il quale , sapendo che agendo in quel modo verrà punito , non infrangerà la legge : egli non la infrangerà anche in assenza della pena di morte ; secondo Beccaria occorrono pene miti , ma che vengano sempre applicate : se la pena é minima , ma il criminale sa che dovrà scontarla e non potrà farla franca , allora non infrangerà la legge : la pena di morte diventa quindi assurda e inutile proprio perchè lo Stato é forte , capace di punire i criminali . L’ importante é che le pene vengano sempre apllicate , altrimenti il cittadino corretto e rispettoso della legge , vedendo che i trasgressori la fanno franca e non vengono puniti dalla legge , comincerà ad odiare la legge stessa e a trasgredirla anch’ egli , proprio perchè si sentirà preso in giro dallo Stato che vara leggi e poi non le fa applicare . A sostegno della sua battaglia contro la pena di morte , Beccaria porta un altro argomento : la pena , per definizione , ha due funzioni : 1 ) correggere il criminale per riportarlo sulla retta via ; 2 ) garantire alla società la sicurezza , già a suo tempo propugnata da Hobbes . Ma la pena di morte ( pur rendendo più sicura la società ) , evidentemente , non può certo correggere il criminale , in quanto lo fa fuori : la risoluzione del tutto sta , per riagganciarci a quanto detto , nello Stato forte e autoritario che impone pene miti , ma garantisce la loro applicazione ; allo stesso anche l’ ergastolo non corregge il criminale ed é , a mio avviso , ancor peggio della pena di morte , la quale si pone come obiettivo il liberare la società di un delinquente ; l’ ergastolo , invece , si pone come obiettivo esplicito il correggere il criminale : ma a che serve tenerlo tutta la vita in carcere ? Che correzione può avere ? Va senz’ altro notato come la pena di morte , che era sempre stata una sorta di spettacolo per il popolo che si riuniva nelle piazze per assistere ai pubblici squartamenti , nel 1700 cominci a risultare odiosa al popolo : é il sentimento decantato da Rousseau che entra in gioco . Tuttavia la critica di Beccaria mossa al sistema giudiziario é intrecciata con quella mossa alla Chiesa : se é vietato il suicidio , come può essere legittimata l’ omicidio tramite la pena di morte ? Questa inutile prodigalità di supplicii, che non ha mai resi migliori gli uomini, mi ha spinto ad esaminare se la morte sia veramente utile e giusta in un governo bene organizzato. Qual può essere il diritto che si attribuiscono gli uomini di trucidare i loro simili? Non certamente quello da cui risulta la sovranità e le leggi. Esse non sono che una somma di minime porzioni della privata libertà di ciascuno; esse rappresentano la volontà generale, che è l’aggregato delle particolari. Chi è mai colui che abbia voluto lasciare ad altri uomini l’arbitrio di ucciderlo? Come mai nel minimo sacrificio della libertà di ciascuno vi può essere quello del massimo tra tutti i beni, la vita? E se ciò fu fatto, come si accorda un tal principio coll’altro, che l’uomo non è padrone di uccidersi, e doveva esserlo se ha potuto dare altrui questo diritto o alla società intera? . Così inizia la critica sistematica di Beccaria contro la pena di morte ; non é in assoluto nella storia la prima volta che si muove una critica alla pena di morte , ma é la prima volta che contro di essa vengono mosse obiezioni radicali e sistematiche . Questa critica alla pena di morte indica una svolta nel senso comune , svolta che ebbe anche innegabili effetti pratici : per esempio nel 1786 Pietro Leopoldo aboliva in Toscana la pena di morte . La prima argomentazione contro la pena di morte é che essa non é legittima. La tesi a sua volota si divide in due punti: in primo luogo, essa offende il diritto che nasce dal contratto sociale , stipulato per garantire la sicurezza degli individui contraenti, non per deprivarli della vita. In secondo luogo, la pena di morte é contraria al diritto naturale secondo il quale l’uomo non ha la facoltà di uccidere se stesso e non può quindi conferirla ad altri. Dopo aver dimostrato che la pena di morte non é legittima, ossia che non é un diritto, Beccaria passa alla seconda argomentazione, per cui essa non é necessaria: anche questa si articola su due livelli: in primis, si dimostra che la pena di morte non é necessaria laddove regnino ordine politico e sicurezza civile; in secondo luogo si dimostra che essa non esercita una sufficiente funzione di deterrenza relativamente a furti e a delitti. La dimostrazione di questa tesi é empirica: le impressioni più profonde non sono quelle intense ma brevi (la pena di morte) , bensì quelle più deboli ma di lunga durata (il carcere). Beccaria critica anche la religione accusandola di agevolare il delinquente nelle sue ree intenzioni, confortandolo con l’idea che un facile quanto tardivo pentimento gli assicuri comunque la salvezza eterna. Ma se la pena di morte non é un diritto e non é un deterrente, essa é anche inutile: lo Stato, infliggendo la pena di morte, dà un cattivo esempio perchè infatti da un lato condanna l’omicidio e dall’altro lo commette, ora in pace ora in guerra. Ma Dei delitti e delle pene non si limita a criticare lo stato di cose presente , benchè questo aspetto risulti decisivo in prospettiva storica ; in effetti Beccaria non manca di avanzare la proposta di una nuova dimensione giudiziaria , secondo la quale lo Stato non ha il diritto di punire quei delitti per evitare i quali non ha fatto nulla : la vera giustizia consiste nell’ impedire i delitti e non nell’ infliggere la morte . In tal modo viene posto il problema della responsabilità sociale dei delitti commessi , introducendo una concezione del tutto nuova della giustizia e dei doveri dello Stato , nonchè dei rapporti tra società e singolo . Beccaria propone inoltre delle punizioni che non siano vendette , ma risarcimenti , tanto del singolo verso la collettività quanto di questa verso il criminale : le pene devono pertanto , come dicevamo , essere socialmente utili e ” dolci ” , volte al recupero e non alla repressione . Un altro elemento decisivo dell’ opera é la distinzione tra reato e peccato . Il reato risponde ad un sistema di leggi liberamente concordato tra gli uomini : innegabile é l’ influenza su Beccaria di Rousseau e delle sua concezione della società come contratto ; dunque il reato deve essere definito in un’ ottica laica e terrena , storica e immanente . In questo modo viene rifiutata l’ identificazione tradizionale tra diritto divino e diritto naturale , di cui i sistemi legislativi sarebbero l’ espressione diretta . Viene , anzi , smascherato l’ interesse di potere che si nasconde dietro a una tale concezione . Questa laicizzazione della giustizia é anche la più forte ragione del rifiuto della pena di morte : era infatti proprio arrogandosi il diritto di esprimere insieme la legge umana e la legge divina che gli Stati potevano condannare a morte un presunto colpevole , quasi come se fosse Dio stesso a punirlo. Certo Beccaria ha piena coscienza della difficoltà che ha il popolo di comprendere le leggi, tanto più che ciascun uomo ha il suo punto di vista, ciascun uomo in differenti tempi ne ha un diverso , ed é per questo che condanna l’oscurità delle leggi, scritte in una lingua straniera al popolo , convinto che se tutti potessero intenderne il significato il numero dei delitti e dei reati diminuirebbe notevolmente. Le leggi devono essere accessibili a tutti, tutti hanno il diritto di conoscerle e , di conseguenza , di rispettarle; ma Beccaria sa bene che ai suoi tempi le cose non vanno così e che in realtà la maggior parte delle leggi non sono che privilegi, cioè un tributo di tutti al comodo di alcuni pochi. Egli é altresì convinto che il fine delle pene non é di tormentare ed affliggere un essere sensibile, nè di disfare un delitto già commesso, bensì il fine dunque non é altro che d’impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini. E Beccaria non esita a tuonare contro le accuse segrete che portano gli uomini a mascherare i propri sentimenti e ad errare smarriti e fluttuanti nel vasto mare delle opinioni: bisogna dare al calunniatore la pena che toccherebbe all’accusato! Con le accuse segrete, infatti, basta avere in antipatia una persona, magari la più onesta che ci sia, per farla andare in carcere con false accuse infondate. Assurdo per Beccaria é anche il giuramento, proprio perchè non ha mai fatto dire la verità ad alcun reo e poi mette l’uomo nella terribile contradizione, o di mancare a Dio, o di concorrere alla propria rovina. Il giuramento é inutile, perchè non avvengano delitti basta solo che il delinquente colleghi automaticamente l’idea di delitto a quella di pena : compiuto il delitto egli otterrà inevitabilmente una pena; ed é proprio per questo che occorre la prontezza della medesima, perchè il lungo ritardo non produce altro effetto che di sempre più disgiungere queste due idee: il criminale, compiendo un delitto e non vedendosi punito, finirà per non associare più il delitto alla pena. Fatto sta che la pena deve sempre e comunque essere dolce, ma in ogni caso va applicata proprio perchè la certezza di un castigo, benchèmoderato, farà sempre una maggiore impressione che non il timore di un altro più terribile, unito colla speranza dell’impunità.
FERDINANDO GALIANI

Ferdinando Galiani nacque a Chieti nel 1728, educato a Napoli, nel 1751 si impose all’attenzione degli studiosi d’economia con la pubblicazione del trattato “Della moneta”. Nel 1759-1769 visse a Paris come segretario dell’ambasciata napoletana. In questi anni entrò in contatto con gli ambienti illuministici, fu amico di Diderot, scrisse l’altro importante saggio di economia “Dialoghi sul commercio dei grani” (Dialogues sur le commerce des bleds, 1770) di indirizzo anti-fisiocratico, e in cui sostenne che l’applicazione delle teorie liberiste doveva commisurarsi sulle condizioni oggettive dell’economia dei singoli paesi. Tornato a Napoli (dove morirà nel 1787) continuò i suoi studi scrivendo varie cose (tra l’altro: Descrizione della spaventosa eruzione del Vesuvio, 1779; Del dialetto napoletano, 1779; Vocabolario delle parole del dialetto napoletano, 1789; Sui doveri dei principi neutrali verso i principi belligeranti e di questi verso i neutrali, 1782). Collaborò forse con G.B. Lorenzi alla stesura per l’opera buffa “Socrate immaginario” (1775) musicato da Paisiello. Un posto a parte occupa il ricco epistolario, pubblicato in varie raccolte postume. Prosatore brillante, in italiano e in francese, ha un illuministico disprezzo per il vuoto accademismo, ma senza la fiducia ottimistica nella ragione. Galiani è una figura che appartiene più all’Illuminismo francese che all’italiano. L’ abate Ferdinando Galiani fu per dieci anni (1759-1769) segretario dell’Ambasciata del Regno di Napoli a Parigi e dominò i salotti intellettuali della capitale francese con il suo spirito e il suo brio. Galiani fu specialmente un economista. Il suo trattato Della moneta (1751) è diretto a criticare la tesi del mercantilismo che la ricchezza di una nazione consista nel possesso dei metalli preziosi. Le sue idee filosofiche, non esposte in forma sistematica, ma gettate qua e là come motti di spirito, sono contenute nelle Lettere (scritte in francese) e sono in tutto conformi alle idee dominanti nell’ambiente francese in cui Galiani è vissuto. Nei filosofi i quali affermano che tutto è bene nel migliore dei mondi, Galiani vede degli atei patentati che, per paura di essere arrostiti, non hanno voluto terminare il loro sillogismo. Ed ecco qual è questo sillogismo. “Se un Dio avesse fatto il mondo, questo sarebbe senza dubbio il migliore di tutti; ma non lo è, neppur da lontano; dunque non c’è Dio”. A questi atei camuffati bisogna rispondere, secondo Galiani, nel modo seguente: “Non sapete che Dio ha tratto questo mondo dal nulla? Ebbene, noi abbiamo dunque Dio per padre e il nulla per madre. Certamente nostro padre è una grandissima cosa, ma nostra madre non vale niente del tutto. Si prende dal padre, ma si prende anche dalla madre. Ciò che vi è di buono nel mondo viene dal padre e ciò che vi è di cattivo viene dalla signora nulla, nostra madre, che non valeva gran che” (Lett. all’Abate Mayeul, 14 dicembre 1771).
GAETANO FILANGIERI

Terzogenito del principe di Arianiello, Gaetano Filangieri (Cercola 1752 – Vico Equense 1788) a 19 anni scrive Pubblica e privata educazione (poi rifuso nella Legislazione). Avvocato nel 1774 per volere dei suoi, si dedica invece che alla professione allo studio della riduzione della legislazione ad unità di scienza normativa, previa stesura di Aforismi politici (da Plotone ad Aristotele in sostanza). Dei 7 libri progettati per la Scienza della legislazione (opera che attaccava dalle fondamenta i privilegi feudali dei baroni) uscirono nell’80 le norme generali, nell’83 il diritto e la procedura penale, nell’85 il libro sull’Educazione. L’opera fu messa all’Indice nel 1784, ma Franklin gli chiese più volte consiglio per la Costituzione americana, Goethe lo ammirò e da lui apprese il pensiero di Giambattista Vico). Usciva postumo, nell’anno della sua morte, l’indice e una parte del quinto libro sulla Legislazione. Spariti durante i saccheggi del 1799 i manoscritti de Nuova scienza delle scienze e Istoria civile e universale perenne. Al di là dello stile “concionatorio” (Fausto Nicolini, Enciclopedia Italiana, sub voce), è pratico e rigoroso insieme nelle proposte di riforma (quasi tutte attuate durante la repubblica francese e il periodo napoleonico specie per la procedura penale e per la riforma della istruzione pubblica all’interno di una visione platonica e rousseauiana). Il suo è un illuminismo giuridico che corrisponde solo formalmente alla vichiana visione razionalistica dei contemporanei Galiani e Cuoco. Infatti il suo astorico e ottimistico razionalismo, basato sul modello della monarchia illuminata- paternalistica, tiene presente il dover essere ma trascura il vichiano “considerare gli uomini non quali dovrebbero essere ma quali realmente sono”. Era convinto che la sola riforma della legislazione avrebbe portato alla “riforma” dell’umanità e all’instaurazione della felicità attraverso una “rivoluzione pacifica” guidata dal monarca. Benjamin Constant operò un largo commento alla vulgata francese (1821) della “Scienza”. In una Napoli snervata dal lusso e dall’ozio degli aristocratici e straziata dalla povertà e dallo sfruttamento del popolo, Gaetano Filangieri rappresentò la voce riformatrice dell’Illuminismo. Principe di Arianello, Filangieri fu uno dei massimi giuristi e pensatori italiani. Costretto sin dall’infanzia a partecipare alla carriera militare, nel 1766 divenne alfiere del reggimento Sannio. Tre anni dopo, nel 1769, lasciò finalmente l’esercito per seguire la sua profonda vocazione intellettuale. Da allora si dedicò anima e corpo agli studi storici, economico-giuridici e letterari. Laureatosi in legge nel 1775, pubblicò in quello stesso anno una serie di riflessioni politiche, in cui difendeva una disposizione del re Carlo II che mirava ad eliminare gli arbitri del ceto forense. Nel 1777 divenne Gentiluomo di Camera del Re e poco dopo Ufficiale nel “Real Corpo du Volontare di Marina”. Contemporaneamente elaborò la sua grande opera: La Scienza della Legislazione pubblicata dal 1780 in sette volumi ed ispirata al principio secondo il quale una buona legislazione deve avere per fondamento la Ragione e deve corrispondere alla realtà socio-economica in cui nasce. Peraltro, nella “Scienza”, Filangieri affermava l’esigenza di una codificazione delle leggi e di una riforma progressiva dalla procedura penale, individuando i mali storici del Regno di Napoli negli abusi feudali, nella ripartizione non equa delle proprietà terriere, nell’eccessiva ricchezza del clero e nella tristi condizioni di vita delle classi meno abbienti. Infine, riconosceva come obiettivi precipui da raggiungere ai fini di un rimodellamento in senso illuministico dello Stato Borbonico: il rafforzamento dei poteri del sovrano illuminato, la creazione di un vasto ceto di piccoli proprietari terrieri, l’uguaglianza civile, la libertà commerciale, un’imposta unica sul prodotto netto e l’affermazione del principio dell’educazione pubblica per tutti i cittadini del regno. La sua opera fu tradotta in inglese, in francese, in tedesco, in spagnolo e rappresentò una delle fonti ispiratrici del pensiero e dell’opera del ceto liberale e progressista meridionale. Dalla riforma della legislazione, Filangieri si attende il progresso del genere umano verso la felicità e l’educazione del cittadino. Ispirato da questa fiducia ottimistica nella funzione formatrice e creatrice della legge, il Filangieri delinea il suo piano di legislazione. Nel quale è notevole una difesa dell’educazione pubblica, difesa che muove dal principio che solo essa può avere uniformità di istituzioni, di massime e di sentimenti e che per ciò soltanto la minor parte possibile dei cittadini va lasciata all’educazione privata.
EDMUND BURKE

VITA E OPERE
Edmund Burke nasce a Dublino, in Irlanda, il 12 gennaio 1729 da padre anglicano e da madre cattolica: con il fratello Richard viene educato da anglicano perché possa, in futuro, intraprendere la carriera pubblica; la sorella, invece – com’era costume nell’Irlanda del tempo -, riceve un’educazione cattolica. Ma l’ambiente cattolico in cui de facto vive, gli studi coltivati e la stessa appartenenza etnica contribuiscono a creare in lui quello che è stato definito “stampo di pensiero cattolico”. Dal 1743 al 1748 studia arti liberali al Trinity College di Dublino formandosi su autori classici greci e latini: Cicerone (106-43 a. C.) e Aristotele (384-322 a. C.) esercitano sul futuro parlamentare un’influenza profonda come maestri, rispettivamente, di retorica e di pensiero – lo stesso Burke verrà poi considerato uno dei massimi prosatori di lingua inglese – e di filosofia politica. Nel 1750, a Londra, studia diritto al Middle Temple: presto però, stanco del pragmatismo materialista e della metodologia meccanicista di cui è impregnato l’insegnamento, contrariando il padre, l’abbandona e si dà alla carriera letteraria. Ma, con il tempo, il futuro statista acquisisce comunque una seria conoscenza del diritto europeo continentale e di quello britannico, dalla romanistica al Common Law. Estimatore e conoscitore del diritto naturale antico e moderno, approfondisce il pensiero di Cicerone e degli stoici latini, e, fra i moderni, quello di Richard Hooker (1553-1600), che considera come la massima fonte del diritto canonico dell’epoca della Riforma protestante. Questi, pastore anglicano autore di The Laws of Ecclesiastical Polity, detto “il Tommaso d’Aquino della Chiesa anglicana”, continua, in parte e a certe condizioni, la tradizione filosofica scolastica nell’Inghilterra dopo lo scisma della prima metà del secolo XVI. Altra fonte importante della formazione e poi del pensiero burkiani è la catena dei grandi giuristi britannici, da sir Edward Coke (1552-1634) a sir William Blackstone (1732-1780) – autore dei Commentaries on the Law of England -, passando per i giurisperiti moderati, favorevoli all’incruenta “Gloriosa Rivoluzione” inglese del 1688. Peter J. Stanlis – uno dei massimi studiosi statunitensi viventi del pensiero burkiano – scrive: “È importante notare che la sua erudizione giuridica, comprendente le tradizioni del diritto naturale, del diritto delle genti, del Common Law inglese, del diritto penale e dei precedenti consuetudinari nel diritto positivo, ne imbevvero e ne informarono la filosofia politica, il senso dell’Europa come grande commonwealth di nazioni con un’eredità morale e giuridica comune e la fiducia nel cammino della tradizione lungo la storia”. Nel maggio del 1756 l’anglo-irlandese pubblica il primo scritto, anonimo: A Vindication of Natural Society, un pamphlet che deride la filosofia libertina e deista allora in voga. Il 12 marzo 1757 sposa Jane Nugent. Nell’aprile dello stesso anno dà alle stampe A Philosophical Inquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful. In quest’opera dedicata all’estetica, indaga le fondamenta psicologiche dell’arte e ricusa l’idea di esse come semplice prodotto di rigide regole teoretiche, anticipando aspetti importanti del pensiero filosofico della maturità. Nei mesi precedenti era apparso anche l’anonimo An Account of the European Settlements in America, testo forse redatto da Will Burke – un parente di Edmund -, nel quale sono stati individuati numerosi apporti del pensatore anglo-irlandese. L’opera ottiene un buon successo e contribuisce a incrementare l’attenzione britannica sull’America. In essa, l’anonimo autore simpatizza con l’idea di libertà politica espressa dalle Colonie britanniche, mettendo in guardia i propri compatrioti circa la pericolosità di certe misure commerciali troppo restrittive. Il 9 febbraio 1758 Jane Burke dà alla luce il figlio Richard, che morirà nel 1794. Nel medesimo anno, Burke comincia a dirigere l’Annual Register, una corposa rassegna che, dal 1759, si occupa di storia, di politica e di letteratura, prima solo britanniche, poi anche europee continentali, e che egli dirige, anche collaborando, fino al 1765. Fra il 1758 e il 1759 scrive Essay towards an Abridgment of the English History – interrotto a re Giovanni Plantageneto, detto Senzaterra (1167-1216) -, un’opera pubblicata postuma nel 1811. In questo stesso periodo Burke inizia a frequentare Samuel Johnson (1709-1784), l’eminente letterato tory, cioè del “partito del re”: nonostante la diversità delle loro opinioni politiche, fra i due intercorreranno profonde stima e amicizia. Nel 1759 diviene segretario privato e assistente politico di William Gerard Hamilton (1729-1796), un suo coetaneo già attivo in Parlamento. La redazione dei Tracts Relative to the Laws against Popery in Ireland – scritti frammentari pubblicati postumi nel 1797 – risale all’autunno del 1761, durante un soggiorno irlandese. Dopo la separazione da Hamilton, il pensatore anglo-irlandese si lega a Charles Watson-Wentworth, secondo marchese di Rockingham (1730-1782), divenendone presto segretario. Questi, il 10 luglio 1765, viene nominato primo ministro da re Giorgio III di Hannover (1738-1820) benché il sovrano sia assai riluttante ad affidare l’incarico a un whig, cioè del “partito del Parlamento”. Eletto nel medesimo anno alla Camera dei Comuni, Burke vi diviene presto la guida intellettuale e il portavoce della “corrente Rockingham” del partito whig, la quale, peraltro, ha solo brevi successi politici fra il 1765 e il 1766 e di nuovo, per pochi mesi, nel 1782. Burke siede dunque nei banchi dell’opposizione per la maggior parte della propria carriera politica ed è durante questa seconda fase della sua esistenza che lo statista-pensatore pubblica le opere più note, fra cui Thoughts on the Causes of the Present Discontents nel 1770, Speech on the Conciliation with the Colonies nel 1775, Reflections on the Revolution in France nel 1790, Thoughts on the French Affairs e Appeal from the New to the Old Whigs nel 1791, nonché le Letters on a Regicide Peace, concluse nel 1796. Il 9 luglio 1797 Burke muore nella sua casa di campagna di Beaconsfield, in Inghilterra.
IL PENSIERO
Gran parte dell’attività pubblica burkiana è impegnata a difendere da un lato la Chiesa anglicana dagli attacchi dei “liberi pensatori” e dei riformisti protestanti radicali, dall’altro i cattolici e i dissenzienti protestanti, lesi nei propri diritti dalla politica assolutistica del governo londinese. Ragione di quest’azione politica non è un concetto “latitudinario” di libertà religiosa, ma una visione d’insieme della natura umana e dei rapporti fra lo Stato, i corpi sociali intermedi e i singoli individui minacciati dall’assolutismo moderno. Obiettivo di Burke è garantire uguali diritti a tutti i sudditi britannici, ovunque si trovino e qualunque fede religiosa professino: diritti concreti, acquisiti storicamente in virtù della secolare tradizione costituzionale e consuetudinaria britannica – i “benefici” -, e – a partire dal 1789 francese non a caso in aspra polemica, fra l’altro, con le “libertà inglesi” – contrapposti alle astrazioni illuministico-razionalistiche della Loi e del “diritto nuovo”. Lo statista diviene e rimane celebre per quattro “battaglie parlamentari”. La prima, a tutela dei diritti costituzionali tradizionali dei coloni britannici in America, si oppone alla tassazione arbitraria, imposta dal governo londinese, e difende l’autentico significato della Costituzione “non scritta” britannica. Con lungimiranza, Burke si accorge della miccia che tale politica va innescando nella polveriera nordamericana e fa di tutto per allontanare lo spettro della perdita delle Colonie. Mai favorevole all’indipendenza che queste dichiarano nel 1776, una volta scoppiato il conflitto armato fra esse e la Corona britannica, egli giudica gli eventi come una “guerra civile” interna all’Impero – non una rivoluzione -, presto sanabile. La seconda battaglia parlamentare è quella condotta contro l’amministrazione pubblica, che impedisce questa volta ai sudditi irlandesi di fruire dei diritti costituzionali britannici, anche se in tema di libertà religiosa Burke non riesce ad avere altrettanto parziale successo in difesa dei compatrioti cattolici. In terzo luogo, lo statista chiede la messa in stato d’accusa di Warren Hastings (1732-1818), governatore generale dell’India britannica, per il suo malgoverno, ma non è ascoltato. La sua azione decisa comporta comunque qualche moderato successo e, soprattutto, è di monito – poco ascoltato – per il futuro. L’impero dove mai tramontava il sole crollerà infatti più per l’ottusità di certi suoi governanti che non per altre ragioni. L’ultima tenzone parlamentare burkiana ha a tema la Rivoluzione francese. Nelle “Reflections on the Revolution in France” (“Riflessioni sulla Rivoluzione francese”) – una delle opere più commentate e influenti della storia inglese moderna, pubblicata poco dopo la “presa della Bastiglia”, il 14 luglio 1789 -, l’uomo politico anglo-irlandese intuisce, analizzando le premesse filosofiche che aveva visto dipanarsi lungo i decenni precedenti, l’intero corso degli eventi rivoluzionari, dal regicidio alla dittatura militare napoleonica, stigmatizzandone la natura. Per lui, la Rivoluzione costituisce l’avvento della barbarie e della sovversione di ogni legge morale e di ogni consuetudine civile e politica. Sull’interpretazione di tale evento, del resto, lo stesso partito whig si spacca, insanabilmente diviso fra i new whig liberali di Charles James Fox (1749-1806) e gli old whig guidati appunto da Burke, i quali finiscono per stringersi in lega politica con i tory di William Pitt il Giovane (1759-1806). Proprio alla difesa burkiana del “commonwealth cristiano d’Europa”, a cui la Francia giacobina e atea si è sottratta e contro il quale essa combatte accanitamente – Burke afferma che, negli anni della Rivoluzione, la Francia autentica risiede all’estero -, si deve quell’appoggio parziale che, in alcuni momenti, il governo britannico fornisce alla causa contro-rivoluzionaria francese. Il lume della filosofia politica burkiana è, infatti, la difesa dell’ethos classico-cristiano, fondamento della normatività che il pensatore ravvisa nelle consuetudini giuridiche e culturali del suo paese, parte della “società delle nazioni” cristiane europee. Il rapporto burkiano fra diritto naturale morale e istituzioni civili vede queste ultime come tentativo storico di incarnare il primo, secondo una logica che unisce morale personale e morale sociale. La “filosofia del pregiudizio” – ossia della tradizione e della consuetudine storica – è la grande arma del “common sense” britannico burkiano. Nella sua rilettura revisionista della Rivoluzione francese, la requisitoria di Burke contro i pericoli di dispotismo insiti nei progetti che vogliono ricostruire l’uomo comincia ad apparire quanto mai profetica. La descrisse come “la crisi più stupefacente mai avvenuta al mondo”. Coerentemente con i suoi antichi princìpi le si oppose, mentre i suoi alleati di un tempo, coerenti o no con i loro, la sostennero. La sua posizione “antirivoluzionaria” lo “trasformò” in conservatore contro i suoi antichi princìpi al punto da immaginare che nel XIX secolo si sarebbe trovato più a suo agio nel partito dei Tories, che in quello dei Whigs ormai trasformato in partito liberale. Nella sua polemica contro la Rivoluzione, Burke elogia il sistema politico inglese perché “in giusta corrispondenza e simmetria con l’ordine del mondo”, mentre la preoccupazione per il fanatismo della ragione, che potrebbe distruggere tutti i vincoli sociali, lo portò a voler difendere la religione statuita , per poter così difendere la società statuita.
“Non escluderei del tutto le alterazioni, ma anche se dovessi mutare, muterei per preservare, grave dovrebbe esser l’oppressione per spingermi al mutamento. E nell’innovare, seguirei l’esempio dei nostri avi, farei la riparazione attenendomi il più possibile allo stile dell’edificio. La prudenza politica, un’attenta circospezione, una timidezza di fondo morale più che dovuta a necessità, furono tra i primi principi normativi dei nostri antenati nella loro condotta più risoluta”. (Riflessioni sulla Rivoluzione francese).
Le critiche di Burke, dunque, non sono indirizzate solo alla rivoluzione francese , ma alla rivoluzione in sé, che pretende di interrompere l’evoluzione della storia di una nazione; non solo al giacobinismo che dominava in Francia nell’anno II della repubblica, ma al giacobinismo come categoria politica. Scrive ancora Burke, nelle sue “ Riflessioni sulla Rivoluzione francese”:
“Fare una rivoluzione è una misura che prima fronte richiede una giustificazione. Fare una rivoluzione significa sovvertire l’antico ordinamento del proprio paese; e non si può ricorrere a ragioni comuni per giustificare un così violento procedimento. […] Passando dai princìpi che hanno creato e cementato questa costituzione all’Assemblea nazionale, che deve apparire e agire come potere sovrano, vediamo qui un organismo costituito con ogni possibile potere e senza alcuna possibilità di controllo esterno. Vediamo un organismo senza leggi fondamentali, senza massime stabilite, senza norme di procedure rispettate, che niente può vincolare a un sistema qualsiasi. […] Se questa mostruosa costituzione continuerà a vivere, la Francia sarà interamente governata da bande di agitatori, da società cittadine composte da manipolatori di assegnati, da fiduciari per la vendita dei beni della Chiesa, procuratori, agenti, speculatori, avventurieri tutti che comporranno una ignobile oligarchia , fondata sulla distruzione della corona, della Chiesa, della nobiltà e del popolo. Qui finiscono tutti gli ingannevoli sogni e visioni di eguaglianza e di diritti dell’ uomo. Nella “palude Serbonia” di questa vile oligarchia tutti saranno asorbiti, soffocati e perduti per sempre.”
Secondo Russell Kirk (1918-1994) – uno dei “padri” della rinascita burkiana statunitense contemporanea -, il pensatore anglo-irlandese appartiene al “partito dell’ordine”: egli, infatti, è figura rappresentativa di quel legittimismo patriottico britannico accorto, che unisce fedeltà e critica costruttiva, e che si riassume nell’espressione conservatrice “opposizione di Sua Maestà”, antitetica a quella rivoluzionaria di “opposizione a Sua Maestà”. L’influenza di Burke si esercita su pensatori importanti come Joseph de Maistre (1753-1821) e su numerosi autori di area culturale anglosassone, francese e tedesca; ma, soprattutto, dà origine a quello che, nel mondo di lingua inglese, prende il nome tecnico di “pensiero conservatore”, inteso come opposizione consapevole al mondo nato con il 1789 francese e con la filosofia rivoluzionaria che lo ha ispirato e mosso. Burke, certo del prossimo successo dei giacobini anche in terra inglese, vuole che la località della propria inumazione sia tenuta segreta, per paura che i nemici possano un giorno giungere a dissacrare il luogo del riposo delle spoglie mortali del loro primo e radicale avversario.
L’ INCHIESTA SUL BELLO E SUL SUBLIME
L’indagine “Sul sublime” si era per la prima volta affacciata sullo scenario letterario quando un autore anonimo – presumibilmente nel I secolo d.C. – aveva composto in greco un’opera “Sul sublime” (Peri uyou), in cui si era sforzato di ravvisare quelle che -a suo avviso – erano le 5 “fonti” (phgai) da cui il sublime promanava. L’Anonimo sul sublime, tuttavia, si limitava a parlare di “sublime letterario”, un sublime che non investiva l’ambito della natura ma si arrestava alle pagine dei libri (così come brano sublime, ad esempio, egli ci riporta il componimento di Saffo) e non è un caso ch’egli scorga le cinque fonti nel a) concepire pensieri elevati, b) nel paqoV, c) nelle figure retoriche, d) nell’ingegno espressivo, e) nell’elevatezza stilistica. Ora, a parecchi secoli di distanza dall’anonimo, Burke ritorna su questo problema – a sua volta ripreso da Kant – che tende a fare di lui un autore pre-romantico, che tende a sfuggire dal secolo dei “Lumi”: a tale tematica, egli dedica il suo celebre scritto “Inchiesta sul bello e sul sublime”, in cui come cause del sublime individua il terrore, l’oscurità, la potenza, la privazione, la vastità, l’infinità, la difficoltà, la magnificenza. Cominciando dal “terrore”, nessuna passione, come la paura, priva con tanta efficacia la mente di tutto il suo potere di agire e di ragionare. Poiché, essendo il timore l’apprensione di un dolore o della morte, agisce in modo da sembrare un dolore reale, tutto ciò, quindi, che è terribile alla vista è pure sublime, sia che la causa della paura alla grandezza delle dimensioni oppure no (vi sono molti animali che, sebbene non siano affatto grossi, sono tuttavia capaci di suscitare l’idea del sublime, come i serpenti velenosi). Per rendere poi un oggetto molto terribile, sembra in generale necessaria l’oscurità. Quando conosciamo l’intera estensione di un pericolo, quando possiamo abituare a essa il nostro sguardo, gran parte del timore svanisce: la notte, è comune a tutti, aumenta il nostro terrore; le nozioni di fantasmi e folletti, sui quali nessuno può formulare delle idee chiare impressionano gli animi di chi crede nelle favole popolari. Al terzo posto sta poi la potenza: il dolore è sempre inflitto da un potere superiore, poiché non ci sottomettiamo mai al dolore spontaneamente. La potenza trae la sua sublimità dal terrore a cui va unita, ogni volta che la forza è soltanto utile e viene usata a nostro beneficio o per il nostro piacere, non è mai sublime: un bue è un essere di grande forza, ma è una creatura innocente e per nulla pericolosa; per questo l’idea di un bue non è per niente sublime. L’idea di un toro, invece è grandiosa, ed esso trova sovente posto in descrizioni sublimi e in nobili paragoni. Successivamente, è la volta della privazione: tutte le privazioni sono grandi perché tutte terribili: il vuoto, l’oscurità, la solitudine e il silenzio. Per quel che riguarda la vastità, l’estensione è o in lunghezza o in altezza o in profondità. Di queste la lunghezza colpisce meno. Allo stesso modo l’altezza è meno grandiosa della profondità; infatti siamo maggiormente impressionati nel guardare giù da un precipizio che nel guardare verso l’alto un oggetto di uguale altezza. Come il grado estremo della dimensione è sublime, così il grado estremo della piccolezza è pure sublime. Quando noi osserviamo l’infinita divisibilità della materia, quando seguiamo la vita animale in esseri piccolissimi e pure organizzati e la scala dell’esistenza che ancora diminuisce, rimaniamo stupiti e confusi ai miracoli della piccolezza. Passando poi all’infinità, vi sono pochissime cose che per loro natura sono infinite, ma non essendo l’occhio capace di percepire i limiti di molte cose, sembra che esse siano infinite e producono gli stessi effetti che se realmente lo fossero. Ogni volta che nel nostro pensiero ritorna con frequenza un’idea, essa viene ripetuta ancora molto tempo dopo che la prima causa ha cessato di agire: ad esempio dopo una lunga successione di rumori, come può essere una cascata, l’acqua ancora rumoreggia nella nostra immaginazione molto tempo dopo che i primi rumori hanno cessato di esistere. L’Infinito di Leopardi si muove – in qualche misura – in questa prospettiva. Passando alla difficoltà, quando un’opera sembra abbia richiesto un’immensa forza e fatica per essere compiuta, l’idea che ne abbiamo è grandiosa. Stonehenge non offre quanto a disposizione di masse o a decorazione alcunché di ammirevole; ma quegli immensi rozzi macigni di pietra ritti e messi l’uno sull’altro spingono il pensiero all’immensa forza necessaria per tale lavoro. Anzi la rozzezza dell’opera accresce questo motivo di grandiosità, mentre esclude l’idea di arte. Infine, la magnificenza: una grande profusione di cose, splendide o pregevoli in se stesse, è magnifica. Il cielo stellato, sebbene cada frequentemente sotto il nostro sguardo, suscita sempre un’idea di grandiosità, che non può essere dovuta a qualcosa che si trovi nelle stelle stesse considerate. separatamente. La causa sta certamente nel loro numero. Il disordine apparente aumenta la grandiosità, poiché l’aspetto dell’ordine è altamente contrario alla nostra idea di magnificenza. Ma, esaminate le “cause” del sublime, resta da chiarire in che cosa esso si distingua, propriamente, dal bello: Kant dirà (nella “Critica del Giudizio”) che il bello è dettato da un libero gioco delle facoltà intellettive, per cui al vedere un bel paesaggio proviamo piacere perché è come se esso si adeguasse spontaneamente alle nostre categorie intellettive; per il sublime, invece, Kant (che aveva in mente il cielo stellato, le catene montuose, il mare in tempesta) intende qualcosa di ambiguo, che desta al contempo piacere e senso di smarrimento: l’oggetto in questione (vuoi il mare in tempesta, vuoi il cielo stellato o le montagne) non si adegua spontaneamente a noi e alle nostre facoltà conoscitive, ma ci incute timore perchè manifesta la sterminata grandezza e la sterminata potenza della natura di fronte alla sterminata piccolezza e impotenza dell’uomo; mentre il bello è univocamente positivo, il sublime è positivo e negativo al tempo stesso. Ora Burke così si esprime:
“Nel chiudere questa visione d’insieme della bellezza sorge naturale l’idea di paragonarla col sublime, e in questo paragone appare notevole il contrasto. Gli oggetti sublimi sono infatti vasti nelle loro dimensioni, e quelli belli al confronto sono piccoli; se la bellezza deve essere liscia e levigata, la grandiosità è ruvida e trascurata; la bellezza deve evitare la linea retta, ma deviare da essa insensibilmente; la grandiosità in molti casi ama la linea retta, e quando se ne allontana compie spesso una forte deviazione; la bellezza non deve essere oscura, la grandiosità deve essere tetra e tenebrosa; la bellezza deve essere leggera e delicata, la grandiosità solida e perfino massiccia. Il bello e il sublime sono davvero idee di natura diversa, essendo l’uno fondato sul dolore e l’altro sul piacere, e per quanto possano scostarsi in seguito dalla diretta natura delle loro cause, pure queste cause sono sempre distinte fra loro, distinzioni che non deve mai dimenticare chi si proponga di suscitare passioni”. (E. Burke, Inchiesta sul Bello e il Sublime)
BIBLIOGRAFIA
The Writings and Speeches of Edmund Burke, a cura di P. Langford, Oxford, Clarendon Press 1981- , vols I, II, III, V, VI, VIII, IX (deve essere completata in 12 volumi).
Works and correspondence of the Right Hon. Edmund Burke, London, Rivington 1852, vols I-VIII.
The correspondance of Edmund Burke, a cura di Thomas W. Copeland, Cambridge University Press 1958-1976, vols I-X.
The parliamentary history of England from the earliest period to the year 1803, a cura di William Cobbet, London, Hansard 1816, vols XVI-XXXI.
A note-book of Edmund Burke, a cura di V.S. Somerset, Cambridge, Cambridge University Press, 1957. “The Reformer”, n. 1-13, January-april 1748, in, A.P.I. Samuels, The early Life Correspondence and Writings of The Rt. Hon. Edmund Burke, Cambridge University Press 1923. “Annual Register”, 1758-1790.
Further reflections on the Revolution in France, Indianapolis, Liberty Press 1992.
A Vindication of Natural Society or a view of the Miseries and Evils Arising to Mankind fron Every Species of Artificial Society (1756), Indianapolis, Liberty Press 1982.
A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful (1757), London, Routledge and Kegan 1958.
Pre-Revolutionary Writings, Cambridge University Press 1993.
|
1729 |
Edmund Burke nasce nella
casa paterna di Arran Quay a Dublino, figlio secondogenito di Richard
Burke, avvocato e procuratore, e di Mary Nagle, figlia di Patrick Nagle
di Ballyduff nella contea di Cork. |
|
|
|
|
1741 |
Trascorre gli anni della
fanciullezza a Ballyduff, presso la famiglia della madre, perché la
salute cagionevole soffre del clima poco salubre di Dublino. |
|
|
|
|
1742 |
Insieme ai fratelli
Garret e Richard è’ inviato alla scuola tenuta dal quacchero Abraham
Shackleton a Ballitore, nella contea di Kildare |
|
|
|
|
1744 |
E’ immatricolato al
Trinity College di Dublino, dove si reca immediatamente a proseguire gli
studi. Vive ancora con la famiglia paterna per circa due anni, fino a
quando ottiene una borsa di studio (giugno 1746), che gli permette di
andare a vivere nel college. |
|
|
|
|
1747 |
Fonda, insieme a tre
amici, il “Club”, o “Academy of Belles Lettres” da cui deriverà,
più tardi la famosa College
Historical Society. |
|
|
|
|
1748 |
Esce il primo numero di
“The Reformer”, una rivista letteraria settimanale diretta,
pubblicata e scritta quasi per intero da Edmund Burke. Dal 28 gennaio al
21 aprile 1748 ne usciranno tredici numeri, uno per ogni giovedì. |
|
|
|
|
1750 |
Lascia Dublino per Londra, dove inizia gli studi
di legge al Middle Temple . Li interrompe ben presto
e, rotti di conseguenza i rapporti con il padre, vive di giornalismo e
lavora per editori londinesi. |
|
|
|
|
1756 |
Pubblica A vindication of natural society: or a wiew of the miseries and evils
arising to mankind from every species of artificial society (
Rivendicazione della società naturale, ovvero una rassegna delle
miserie e dei mali provenienti all’umanità da ogni sorta di società
artificiale). L’opera è un’imitazione satirica delle idee e
dello stile di lord Bolingbroke. Burke applica alla società civile gli
stessi argomenti usati da Bolingbroke contro la religione rivelata e,
così facendo, mostra indirettamente la pericolosità e la follia di
voler razionalizzare istituzioni sociali e morali. Pubblica A philosophical inquiry into the origin of our ideas of the sublime
and the beautiful (Ricerca filosofica sull’origine delle nostre idee
del sublime e del bello), che incontra grande successo immediato e
provoca vasta e duratura eco anche all’estero. |
|
|
|
|
1757 |
Sposa Jane Nugent,
figlia di un medico irlandese probabilmente conosciuto da Burke durante
una cura a Bath. Jane Nugent è cattolica, ma si converte alla religione
del marito. Escono i primi fogli
dell’Abridgement of the history
of England (Sommario della storia d’Inghilterra). Scrive, o contribuisce a
scrivere, An account of the
European settlements in America (Rapporto sulle colonie europee in
America). |
|
|
|
|
1758 |
Nascita del figlio
Richard. Firma un accordo con
l’editore Robert Dodsley, impegnandosi a pubblicare ogni anno l’”Annual
Register”, una rassegna dei principali eventi politici e culturali
dell’annata. Continua ad occuparsi
della redazione della rivista fino al 1788, ed i primi numeri risultano
scritti quasi per intero da lui. Nascita del figlio
Christopher, che muore in età infantile. |
|
|
|
|
1759 |
Esce il primo numero
dell’”Annual Register”. Lord Charlemont lo
presenta a Lord William Gerard Hamilton, di cui Burke accetta di
divenire segretario. |
|
|
|
|
1761 |
Burke si reca in Irlanda
con Hamilton, che è stato nominato segretario di lord Halifax,
luogotenente in Irlanda. |
|
|
|
|
1763 |
Burke torna
dall’Irlanda con Hamilton, che gli fa assegnare una pensione annua in
riconoscimento dei suoi servigi. Burke accetta, a condizione che il
lavoro presso Hamilton gli lasci tempo libero per continuare a scrivere;
probabilmente intende completare l’Abridgement
of the history of England. |
|
|
|
|
1764 |
Il Dott. Johnson, fonda
il Literary Club, al quale
aderisce anche Burke. |
|
|
|
|
1765 |
Venuto a contrasto con
Hamilton per le eccessive pretese da questi accampate sul suo tempo,
Burke rompe ogni rapporto con il suo protettore e rinuncia alla
pensione. Il Parlamento approva lo
Stamp Act. Immediate reazioni in America. Ministero di lord
Rockingham, di cui Burke diviene segretario. |
|
|
|
|
1766 |
Apertura della sessione
parlamentare. Burke fa il suo primo ingresso ai Comuni. Revoca dello Stamp Act. Le dimissioni da
segretario di Stato del duca di Grafton, provocano la caduta del
gabinetto Rockingham. Burke preferisce passare all’opposizione con
Rockingham. Scrive A short account of a late short administration (Breve rapporto su una
recente breve amministrazione) in difesa delle azioni compiute da
Rockingham durante i pochi mesi del suo governo. Si reca in Irlanda per
qualche tempo. |
|
|
|
|
1769 |
Burke pubblica le Observationes
on a late publication intituled “The present state of the nation”(Osservazioni
su una recente pubblicazione intitolata “Lo stato presente della
nazione”), in risposta ad un pamphlet
del partito di Grenville. Nel Public
Advertiser compare la prima di una serie di violente lettere contro
il governo, firmate Junius. La
singolare felicità dello stile, che sembra somigliante a quello di
Burke, fa sì che esse vengano attribuite a lui. Più tardi l’evidenza
ne indica l’autore in sir Philip Francis, un membro del partito Whig.
E’ comunque accertato che Junius
non era Burke. |
|
|
|
|
1770 |
Burke pubblica Thoughts
on the cause of the present discontents (Pensieri sulle cause dei
presenti malcontenti). |
|
|
|
|
1771 |
L’assemblea
provinciale di New York nomina Burke agente di quella colonia. |
|
|
|
|
1773 |
Si reca in Francia e
soggiorna brevemente a Parigi. |
|
|
|
|
1774 |
Pronuncia in Parlamento
un discorso per la soppressione del dazio sul tè imposto all’America. Questo discorso è da
lui pubblicato nello stesso anno, col titolo: Speech
on American taxation (Discorso sulle tasse in America). Burke è nominato
candidato a Bristol dove, accettata la nomina, è eletto il 3 novembre.
Nel ringraziare dell’elezione pronuncia un discorso (Speech
at the conclusion of the poll). |
|
|
|
|
1775 |
Presenta al Parlamento
la propria mozione per addivenire sollecitamente ad una conciliazione
con le colonie, in un discorso che pubblica il 22 maggio dello stesso
anno: Speech on conciliation with
America. |
|
|
|
|
1778 |
Burke si esprime
apertamente a favore di una proposta di legge per mitigare le
restrizioni commerciali imposte all’Irlanda dalla politica fiscale
inglese. Sostiene una proposta per la revoca di alcune discriminazioni
imposte ai cattolici. Il suo comportamento gli
aliena simpatie dei propri elettori di Bristol, città commerciale,
ferocemente gelosa dei propri privilegi ed ostile ad ogni misura che li
infirmasse. In una lettera dell’aprile indirizzata al presidente della
corporazione dei mercanti di Bristol, Burke si difende dall’accusa di
non tenere a cuore gli interessi dei propri elettori: “Preferisco
recarvi dispiacere che danno”. |
|
|
|
|
1780 |
Presenta ai Comuni un
disegno di legge, volto ad assicurare una maggiore indipendenza del
Parlamento dall’influenza regia mediante una riduzione delle cariche e
degli uffici civili a disposizione del re. Si tratta in sostanza di un
tentativo di stroncare le clientele dalle radici, privando il re e il
governo dei mezzi necessari a procurarsi con la corruzione dei
sostenitori. (Speech
on presenting to the house of Commons a plan for the better security of
the indipendence of Parliament and the economical reformation of the
civil and other estabilishments). Il progetto di riforma di
Burke, nella sua moderazione, è forse un tentativo di opporre una
soluzione moderata alle richieste affiorate nel corso delle agitazioni
del 1779-80 in cui era stato chiesto di indagare “sulle vere cause
della decadenza dell’impero britannico, sullo sciupìo di denaro e
risorse”. Nelle elezioni
dell’autunno perde il seggio di Bristol ma è rieletto per Malton. |
|
|
|
|
1781 |
Il suo disegno per la
riforma economica è bocciato in Parlamento. |
|
|
|
|
1782 |
Morte di Rockingham, cui
succede lord Shelburne. Burke, Fox e Sheridan rifiutano di collaborare
con lui e passano di nuovo all’opposizione. |
|
|
|
|
1785 |
Burke pronuncia quello
che è il più grande dei suoi discorsi contro Hastings (governatore
della Compagnia delle Indie in Bengala dal 1772), quello sui debiti del
Nababbo di Arcot (Speech on the
Nabob of Arcot debts). |
|
|
|
|
1790 |
In un discorso sul
bilancio preventivo militare (Speech
on the army estimates) Burke manifesta pubblicamente la propria
riprovazione per la Rivoluzione francese. Escono le Riflections on the Revolution in France (Riflessioni sulla Rivoluzione francese). |
|
|
|
|
1791 |
Pubblica le Letter
to a member of the national
Assembly (Lettera ad un membro
dell’Assemblea nazionale) in risposta ad alcuni appunti mossigli a
proposito delle Riflessioni sulla
Rivoluzione francese. Pubblica il Appeal
from the new to the old Whigs (Ricorso
dai nuovi agli antichi Whigs). Nell’autunno scrive i Thoughts
on French affairs (Pensieri
sulle cose di Francia), in cui auspica la formazione di una
coalizione antifrancese. |
|
|
|
|
1795 |
Il duca di Bedford,
lamenta che la pensione a Burke sia stata concessa senza autorizzazione
parlamentare e in piena violazione del piano di riforma economica. Burke ritorce l’accusa
nella Letter to a noble Lord (Lettera
ad un nobile Signore). |
|
|
|
|
1796 |
Pubblicazione delle
prime due lettere contro la conclusione di una pace con la Francia (Letters
on a regicide peace). Fonda a Tyler’s Green House, nei pressi di
Penn, Buckinghamshire, una scuola per i figli degli emigrati francesi. |
|
|
|
|
1797 |
Burke
muore a Beaconsfield. Fox propone che venga sepolto a Westminster
a spese dello Stato, ma si preferisce ottemperare alle sue disposizioni
e seppellirlo senza pompa nella chiesa di Beaconsfield. Pubblicazione postuma della Terza lettera sulla pace regicida. |
IMMANUEL KANT

LA VITA E IL PERIODO PRECRITICO
Kant opera negli ultimi decenni del Settecento in Germania, in un’epoca per molti versi di transizione tra illuminismo e romanticismo. Risente di questa fase di transizione e, pur collocandosi a pieno titolo nell’illuminismo (di cui è l’ultimo e il massimo esponente), molti aspetti del suo pensiero sono già romantici. Rilevante è il fatto che egli operi in una realtà come quella tedesca che, per la sua collocazione ‘provinciale’ dal punto di vista culturale e politico, vede il penetramento di un illuminismo diverso da quello degli altri Paesi, un illuminismo più sfumato, il cui aspetto rivoluzionario di netta rottura e di critica verso il passato risulta smorzato. Che l’illuminismo in Germania sia più sfumato che altrove, lo si può facilmente evincere dall’uso che i tedeschi continuano a fare del latino, nella altre nazioni europeee ormai sostituito dalle lingue nazionali, atte a divulgare il più possibile la cultura e le scoperte filosofiche. Un altro aspetto che contraddistingue la realtà tedesca dalle altre in Europa è il fatto che, in ambito filosofico, in Germania non c’è la rottura definitiva con la metafisica, nè tantomeno il distacco degli intellettuali dalle università: Kant stesso sarà per tutto il corso della sua vita professore universitario. Si può dire, in altri termini, che la Germania di quegli anni è di gran lunga meno rivoluzionaria di molti altri Paesi, quali la Francia o l’Inghilterra; Kant è per molti versi un pensatore rivoluzionario, tanto da essere talvolta paragonato a Robespierre; eppure, letto in trasparenza, molti sono in lui gli aspetti conservatori: egli si presenta, più che come pensatore radicalmente rivoluzionario, come pensatore che cerca di dare una sistemazione definitiva alla culturta moderna . Kant accetta con entusiasmo le novità subentrate nella cultura moderna, cercando di dar loro una veste definitiva; quest’operazione egli la attuerà soprattutto con la scienza newtoniana: la filosofia di Kant è, infatti, per molti aspetti un tentativo di fondare filosoficamente la scienza di Newton e questo dimostra che egli non è un conservatore, ma anche che è meno rivoluzionario del previsto. La vita di Kant , interamente dedicata all’insegnamento universitario, è diventata quasi proverbiale per i pochi avvenimenti che la caratterizzano. Due però sono le tappe fondamentali che la segnano: la prima, risale a quando Kant rivendicò apertamente la libertà di pensiero, in opposizione con la censura che aveva avuto da dire sul suo scritto sulla religione costruita nei limiti della sola ragione. In Kant la libertà di pensiero è un tema centrale , che trova la sua massima trattazione nella Risposta alla domanda: che cosa è l’illuminismo? (1784) . In questo trattatello (che è il vero e proprio testamento spirituale dell’illuminismo), Kant definisce l’illuminismo come ‘ l’uscita dell’ uomo dallo stato di minorità che egli deve imputare a se stesso ‘ , quasi come se l’uomo non fosse ancora del tutto divenuto maggiorenne sul piano intellettuale, cioè capace di usare la propria ragione. Kant, riprendendo le tematiche tipicamente illuministiche della lotta ai pregiudizi, spiega che gli uomini, fino a quel momento, non hanno dovuto fare lo sforzo di pensare da soli perchè c’era chi lo faceva per loro: essi si sono dunque ridotti ad accettare le opinioni elaborate dagli altri senza vagliarle con la propria ragione. La minorità che ha caratterizzato fino ad allora l’uomo è interamente imputabile all’uomo stesso, che non ha avuto il coraggio nè la voglia di sapere; l’illuminismo è quindi un fatto di volontà e il suo motto è ‘ abbi il coraggio di servirti della tua propria ragione! ‘. A questo punto, però, Kant (e qui si vede come egli sia per molti aspetti conservatore) distingue tra uso pubblico e uso privato della ragione : l’uso pubblico è quello che io faccio in qualità di libero cittadino, quello privato è invece quello che faccio nell’esercizio specifico di determinate funzioni. Come soldato impegnato in guerra, ad esempio, dovrò limitarmi ad obbedire, senza esprimere la mia disapprovazione (uso privato della ragione); quando però non sono più nelle vesti di soldato, ma in quelle di cittadino, posso liberamente esprimere la mia disapprovazione e tutte le obiezioni che desidero (uso pubblico della ragione); allo stesso modo, se un gruppo religioso mi paga per tenere la messa, io devo limitarmi ad eseguire e non mi è concessa la libertà di esprimere le mie riserve in merito a quella dottrina religiosa; come libero cittadino, invece, posso esprimere il mio disappunto e le mie perplessità. Nei due casi appena esaminati, non vi è alcuna violazione dell’obbedienza: ho libertà di parola, ma devo obbedire (anche se non approvo); e Kant tesse le lodi di Federico II, il sovrano imbevuto di razionalismo, il cui atteggiamento può così essere riassunto: ‘puoi pensare quello che vuoi, ma devi obbedire ai miei ordini’. Tuttavia Kant si accorge con grande acutezza che spesso la distinzione tra fatti e parole non è così facilmente operabile: il soldato che obbedisce agli ordini, ma li critica va oltre la libertà di espressione e raggiunge la fattualità, creando una situazione psicologica che favorisce la disobbedienza agli ordini: in questo modo, le parole diventano fatti. Kant riconosce dunque due limiti alla libertà di espressione: il primo è quello che risiede nella distinzione tra uso pubblico e uso privato della ragione, e il secondo è invece quello riguardante i casi in cui la libertà d’espressione non è del tutto legittima (come nel caso del soldato che obbedisce ma critica). L’altra tappa fondamentale della vita di Kant è legata all’atteggiamento assunto nei confronti della Rivoluzione francese: si narra che i concittadini di Kant regolassero i loro orologi in base alle sue passeggiate, che avvenivano immancabilmente in determinati orari, e che una sola volta egli mancò all’appuntamento: quando seppe della presa della Bastiglia. Anche quando la Rivoluzione prese una piega radicale, Kant restò coerente: non rinunciò mai a considerare la Rivoluzione come positiva per la storia dell’umanità e il popolo francese come il primo popolo che si era finalmente dato un regime del tutto degno del genere umano. Stranamente però nel giudicare la Rivoluzione e l’annosa questione della legittimità della ribellione, Kant sostenne che di fronte ad un’autorità legittimamente costituita la ribellione fosse illegittima; tuttavia questo non gli impedì di giudicare positivamente i contenuti del regime nato dalla Rivoluzione una volta che esso era nato: la Rivoluzione è stata illegittima, secondo Kant, perchè contro un governo legittimamente costituito, ma, una volta che essa c’è stata, non si possono non riconoscere i valori fortemente positivi scaturiti dal nuovo regime. Anche in merito a questo strano atteggiamento verso la Rivoluzione emerge la questione della libertà di pensiero: non c’è il diritto di opporsi ad uno stato costituito legittimamente, ma c’è il diritto di schierarsi, in qualità di liberi cittadini, a favore della Rivoluzione, una volta che essa ha preso il via. Tutto questo si collega ancora ad un altro opuscolo kantiano, dedicato alla politica e intitolato Per la pace perpetua : in esso, Kant ipotizza la possibilità di realizzare una pace perpetua, cioè di trovare un sistema di equilibrio internazionale che garantisca una volta per tutte la fine delle guerre. Kant non ipotizzava una sorta di unico stato mondiale, anzi, guardava con sospetto la cosa perchè in fondo la sua è una posizione liberale. Piuttosto, egli propone di creare una sorta di federazione mondiale degli Stati, a partire dall’Europa per poi coinvolgere l’intero mondo. In questo senso, Kant può essere considerato il teorico dell’Europa Unita. E’ interessante il fatto che egli scorga nella Francia repubblicana (per repubblicano Kant intende uno Stato in cui i cittadini prendano parte al governo) il punto di riferimento per questa confederazione: il ragionamento che porta il pensatore tedesco a scegliere la Francia e più in generale un Paese repubblicano è questo: Kant è convinto che in fondo i sovrani han sempre fatto le guerre come varianti dello sport della caccia, senza rimetterci molto; se si vuole davvero ottenere una pace perpetua, è necessario che a scegliere se fare la guerra o meno sia chi ne paga le conseguenze, ovvero il popolo: se spettasse ad esso la decisione, non vi sarebbero mai guerre, sostiene Kant. Quest’osservazione kantiana, però, non è del tutto corretta e nasce soprattutto in virtù dell’ottimismo illuministico che si respirava in quegli anni: il Novecento ha chiaramente mostrato come i popoli (pur pagandone le conseguenze) si lascino facilmente trascinare in guerra, a differenza di quel che pensava il filosofo tedesco. Piuttosto importante è la vita intellettuale di Kant : egli ebbe una prima formazione di stampo pietistico. Il pietismo è quella corrente protestante che, nata nel Seicento, si caratterizza per un intenso senso della spiritualità e per un rigorismo morale molto marcato: e sia il rigorismo sia l’interiorità spirituale sono due connotazioni fortissime nella filosofia di Kant; uno dei suoi testi più famosi (la Critica della ragion pratica ) è dedicato all’etica ed è evidentemente ispirato al pietismo. Nella formazione culturale del giovane Kant ebbero peso parecchi pensatori: va subito precisato che Kant non è un autore precoce (come saranno invece gli autori romantici: Schelling, ad esempio, a 25 anni aveva già scritto le sue opere più importanti), bensì giunge alla piena maturazione del proprio pensiero in età avanzata. Pur avendo composto parecchi scritti in gioventù, è solo con la Critica della ragion pura (1781), composta quando aveva ormai circa sessant’anni, che Kant raggiunge la maturità del suo pensiero. Tutto ciò che aveva scritto prima non è altro che una lunga e laboriosa preparazione a questo. La sua filosofia, del resto, viene solitamente suddivisa in due periodi, facendo riferimento alla stesura della Critica della ragion pura : il periodo che viene prima di quest’opera è definito ‘precritico’. A caratterizzare questo lungo periodo di maturazione filosofica, sono le continue oscillazioni dovute alle diverse influenze filosofiche che agiscono su Kant. Di esse, due sono quelle che si fanno più sentire: si tratta dell’empirismo e dell’innatismo. Nella metà del Settecento, in Germania, l’influenza di Leibniz era ancora fortissima, grazie anche alla diffusione e alla sistematicizzazione del suo pensiero operata da Wolff: e proprio queste due istanze, leibniziane e di sistematicizzazione, le ritroviamo in Kant; soprattutto l’idea di sistematicizzare è fortissima nel pensatore tedesco, quasi ossessiva, tanto che qualcuno ha detto che si tratta quasi di una gabbia che cristallizza il suo pensiero: sì, perchè se prendiamo la Critica della ragion pura noteremo in essa una sistematicità esasperata, ricercata; addirittura alle altre due grandi critiche (la Critica della ragion pratica e la Critica del giudizio ) egli tenterà di conferire la stessa sistematicità. Detto questo, Kant deriva da Leibniz parecchie concezioni, delle quali una resta fissa, assolutamente intoccabile: si tratta di un’istanza innatista sul piano gnoseologico, un rifiuto a pensare che tutto possa derivare solo dall’esperienza; come diceva Leibniz stesso, non c’è nulla nel nostro intelletto che prima non sia passato dall’esperienza, fatta eccezione per l’intelletto stesso. Naturalmente il materiale della conoscenza lo riceviamo dal’esperienza, ma a rielaborarlo è l’intelletto, che esula del tutto dall’esperienza stessa. Leibniz aveva avuto il merito di riconoscere, almeno embrionalmente, che le strutture con le quali organizziamo le conoscenze sono innate; la soluzione all’annoso problema del conflitto tra empirismo e innatismo la darà Kant, in modo definitivo: la materia della conoscenza deriva dall’esperienza, ma la forma della conoscenza è a priori. Kant mutua quindi da Leibniz l’istanza innatistica, pur depurandola: dal soggetto deriviamo le forme della conoscenza, dai sensi deriviamo invece i contenuti. Questo vuol dire che Kant (sostenendo che il materiale dela conoscenza derivi dall’esperienza) non attinge solo dall’innatismo leibniziano, ma anche dall’empirismo lockiano. Da Locke egli eredita anche il criticismo nei confronti degli strumenti conoscitivi a nostra disposizione, ponendosi il quesito: fin dove può arrivare la mia ragione? Locke diceva che la ragione è l’unico lume di cui possiamo avvalerci per illuminare il mondo, ma si tratta comunque di una luce limitata, che non può gettar luce su ogni cosa: ma la limitatezza di queso mezzo non autorizza a porre ad esso dei limiti esterni (quale la fede). Essendo l’unico strumento a disposizione, il lume della ragione è l’unico che abbia il diritto di indagare sui suoi stessi limiti, che non le sono comunque imposti dall’esterno. La ragione non è onnipotente, ma ha dei limiti intrinseci: questo distingue l’illuminismo dal razionalismo cartesiano, che, vedendo la ragione come onnipotente, scivolava, paradossalmente, nell’irrazionalismo al pari della religione: come la religione non ha fede nella ragione, così il razionalismo ha fede in essa, senza però indagare sui limiti che essa presenta. La Critica della ragion pura è proprio, come il Saggio sull’intelletto umano di Locke, un tentativo della ragione umana di riflettere su se stessa, un tentativo che per molti versi conclude il discorso avviato a suo tempo da Cartesio sul metodo da adottare: che mezzi ha a disposizione la ragione per conoscere? E fin dove si possono spingere tali mezzi della ragione? Ad indagare sui limiti della ragione deve essere la ragione stessa. Ma Kant, oltrechè dell’influenza di Locke e di Leibniz, risente anche di quella di Newton e di Hume: la filosofia di Kant (almeno nella sua parte teoretica, ossia nella Critica della ragion pura ), come accennato, si configura come tentativo di fondare filosoficamente la scienza moderna, la cui paternità è riconducibile soprattutto a Newton. A quest’ultimo spetta il merito di aver unificato in una sola legge (legge di gravitazione universale) quelle che in Keplero e Galileo erano leggi distinte: Keplero aveva elaborato le tre leggi sull’orbita ellittica dei pianeti, Galileo, invece, aveva formulato la legge di caduta dei gravi. All’epoca di Kant la formulazione scientifica di Newton è all’avanguardia perchè si configura come una formulazione pienamente matura del meccanicismo: ormai il meccanicismo cartesiano, rigurgitante di errori, è sorpassato. Cartesio, del resto, aveva respinto l’attrazione a distanza dei pianeti e dei corpi perchè puzzava troppo di animismo e rischiava di inficiare l’impianto meccanicistico, il quale implica invece un’azione per contatto. Le teorie di Newton, che proponevano, con la legge di gravitazione universale, un’attrazione reciproca dei corpi, erano state viste dai cartesiani come un infamante allontanamento dal meccanicismo, noi le vediamo invece come la sua forma più matura. E Kant, sotto questo profilo, la pensa come noi. A testimonianza del suo stretto rapporto con la scienza newtoniana va indubbiamente ricordato lo scritto, datato 1775, intitolato Storia universale della natura e teoria del cielo : in esso, Kant avanza l’ipotesi della nascita dell’universo a partire dalla formazione nello spazio di una nebulosa di materia, secondo le leggi di Newton; quest’opera testimonia, tra l’altro, grandi comptetenze scientifiche, perchè sarà poi riformulata dall’astronomo La Place e prenderà il nome di ipotesi Kant-La Place. Vi è poi un altro testo fondamentale, risalente al periodo precritico, che testimonia la vicinanza a Newton e, al tempo stesso, la presa di distanza da Leibniz: Newton e Leibniz avevano avuto due diverse concezioni del tempo e dello spazio. Per il pensatore inglese, il tempo era qualcosa di assoluto, cioè di indipendente dal soggetto che conosce e dagli oggetti immersi nello spazio stesso; anche se non vi fossero cose nè soggetti percepienti lo spazio, quasi come un enorme contenitore, continuerebbe ad esistere; per esso (dato da 3 coordinate, cioè tre numeri ciascuno dei quali dà un’informazione: non possono esserci al tempo stesso due oggetti ad occupare lo stesso spazio) è anzi indifferente che vi siano al suo interno soggetti e cose. La concezione di Leibniz, per molti versi più vicina a quella della fisica novecentesca, vuole sia il tempo sia lo spazio come inesistenti in assoluto, ma dipendenti dagli oggetti stessi: spazio e tempo per Leibniz non sono altro che le relazioni tra le realtà materiali esistenti: lo spazio è la relazione della coesistenza fra le cose, e il tempo della successione delle cose. Concettualmente per Leibniz prima ci sono le cose, poi il tempo e lo spazio, perchè ne sono relazioni (e una relazione deve per forza sussistere tra cose già esistenti): pur dipendendo dalle cose, spazio e tempo non dipendono per Leibniz dal soggetto, in quanto non hanno carattere meramente soggettivo. Per Newton è l’esatto opposto: prima ci sono lo spazio e il tempo, poi tutto il resto. E Kant, nel periodo precritico, scrive un opuscolo in cui prende le difese di Newton, servendosi, nella sua dimostrazione, dell’analisi degli oggetti simmetrici: la mano destra e la mano sinistra, pur essendo simmetriche (cioè avendo una relazione interna tra le parti uguale, ma capovolta), non sono congruenti (cioè non occupano lo stesso spazio); ne consegue che se lo spazio fosse soltanto la relazione delle parti di un oggetto, lo spazio occupato dalla mano destra e dalla sinistra (la cui relazione interna è uguale, seppur capovolta) dovrebbe essere uguale, ma così non è: infatti (ed è evidente nel caso delle mani) dove c’è la stessa relazione, non c’è lo stesso spazio, ovvero il rapporto tra le parti non è lo spazio. Il che spiega chiaramente che la relazione delle parti non fa lo spazio , come invece sosteneva Leibniz, ma che lo spazio è prima delle cose stesse, come voleva Newton. Nella fase critica, però, Kant, pur non rinnegando la sua adesione alla tesi di Newton, opererà una modifica: è vero che lo spazio e il tempo sono assoluti e indipendenti dagli oggetti, di cui sono anzi la condizione di esistenza, spiegherà, ma è altrettanto vero che essi sono in qualche modo dipendenti dal soggetto. Tra i vari pensatori che influiscono su Kant vi è pure l’ inglese Berkeley , il quale sosteneva che essere vuol dire essere percepiti: anche nel caso in cui non vi fossero più gli uomini, le cose continuerebbero ad esistere perchè percepite da Dio; Berkeley conferiva così alla propria filosofia una sfumatura idealistica (negando l’esistenza autonoma delle cose). Quando Kant scriverà la Critica della ragion pura , molti vedranno erroneamente in essa una banale riproposizione delle tesi esposte a suo tempo da Berkeley: il che spinse Kant ad effettuare una rivisitazione dell’opera in cui confutava l’idealismo e prendeva le distanze da Berkeley. Oltre a Berkeley, Kant risente anche dell’influenza di Hume , a tal punto che egli riconoscerà al pensatore scozzese il merito di averlo destato dal suo sonno dogmatico. Quest’espressione, divenuta celebre, dà quasi l’idea di un’illuminazione improvvisa arrivata dalla lettura dei testi humeani, i quali hanno svolto su Kant una funzione anti-dogmatica, l’hanno cioè destato da quel sonno che l’aveva portato ad accettare in maniera acritica alcuni punti fermi della metafisica e del comune modo di pensare: Hume aveva mostrato che la nozione di sostanza e di causa, da tutti accettate come evidenti, in realtà non erano poi così ovvie: chi mi dice che il mondo sia effettivamente un insieme di sostanze tra loro legate da rapporti causali? Non posso dimostrarlo razionalmente, ma ne sono certo per via della credenza immediata dettata dalla mia stessa natura di uomo, la quale mi invita ad accettare le nozioni di causa e sostanza, secondo Hume. Una volta svegliato da Hume, Kant ne prenderà poi le distanze perchè convinto che sebbene infondate razionalmente, le nozioni di causa e sostanza, a differenza di quanto credeva il pensatore scozzese, possano essere fondate dalla ragione. Certo, Hume ha perfettamente ragione a dire che le nozioni di causa e sostanza non sono ovvie, ma, detto questo, bisogna spingersi oltre, provando, con un percorso originale, a fondarle. E a proposito è interessante ricordare uno scritto kantiano (di tutti forse il più piacevole alla lettura) risalente al 1766, intitolato I sogni di un visionario chiariti con i sogni della metafisica . Lo spunto per quest’opera sorge in occasione di un fatto contingente: una conoscente aveva chiesto a Kant il parere a riguardo di un bislacco personaggio di allora, dalle idee strane e, a quanto sosteneva, capace di entrare in contatto col mondo sovrasensibile e spirituale. Kant ne approfitta e scrive questo libercolo, effettuando un capovolgimento ironico (evidente a partire dal titolo), quasi a dire che quel personaggio è un fanfarone che vuole andare al di là dell’esperienza sensibile allo stesso modo in cui spesso la metafisica ha costruito castelli in aria, cercando illegittimamente di andare oltre l’esperienza: i sogni della metafisica vengono dunque accostati a quelli del fanfarone e ritenuti dei puri vaneggiamenti. Questo testo costituisce l’apice della polemica kantiana verso la metafisica, una polemica che trova appunto in Hume il suo massimo eroe. Questa posizione di insofferenza verso la metafisica nel periodo critico si attenuerà e, sebbene Kant continuerà a ritenere erronea la pretesa della metafisica di spiegare ciò che è al di là del mondo fisico, tuttavia egli spiegherà che si tratta di una pretesa innata nella natura dell’uomo stesso, il quale sente l’esigenza di porsi queste domande e di rispondere ad esse. Dirà che alcune idee metafisiche (ad esempio Dio) hanno una certa funzione nella conoscenza (ad esempio, non posso conoscere Dio, ma l’idea di Dio mi aiuta a capire molte altre cose), e che esse, sebbene inaccessibili alla conoscenza, per altri versi sono accessibili al campo morale ed etico (ad esempio, Dio non lo posso conoscere, ma nell’etica, scegliendo come comportarmi, mi baso sul concetto di Dio). A quegli anni risale anche un’altra opera kantiana, che segna il distacco di matrice humeana dalla metafisica: L’unico argomento possibile per una dimostrazione di Dio (1763) . Qui Kant distrugge la classica argomentazione ontologica di Anselmo da Aosta: Anselmo aveva dimostrato l’esistenza di Dio partendo dal concetto stesso di Dio, inteso come l’essere perfettissimo, e spiegando che Dio, la cosa più perfetta di ogni altra, per essere tale non può mancare di esistenza; l’esistenza, in quanto perfezione, per Anselmo fa parte dell’essenza, e un concetto (pura essenza) privo di esistenza, non può essere perfetto. Ma Kant confuta quest’argomentazione, sostenendo che l’esistenza non può a nessun titolo far parte dell’essenza ; il concetto di una cosa, sia che essa esista sia che non esista, non varia e l’esistenza è come se si aggiungesse dall’esterno: il concetto di giraffa è perfetto di per sè, anche se le giraffe non esistessero. Kant si avvaleva di un esempio: certo i 100 talleri che ho in tasca sono diversi dai 100 talleri che io penso, già solo perchè con quelli in tasca posso fare acquisti, ma non è una differenza di essenza, non è, come credeva Anselmo, che i 100 talleri esistenti siano più perfetti e abbiano più valore dei 100 talleri pensati; non è vero che una cosa esistente è più grande della medesima cosa pensata come se inesistente. L’esempio dei 100 talleri rende bene l’idea perchè, se come dice Anselmo ciò che esiste vale di più ed è più grande di ciò che è solo pensato, avendo 100 talleri in tasca, pensando quei talleri, dovrei averne in mente meno, solo 90, ad esempio, perchè una cosa solo pensata vale meno di una esistente. Così facendo, Kant smonta la prova anselmiana e mostra che i 100 talleri, sia che esistano sia che non esistano, hanno la stessa essenza. L’esistenza è invece qualcosa che si aggiunge dall’esterno, è la posizione (l’essere posto) di qualcosa: esiste ciò che è dato o può essere dato nell’esperienza di qualcuno: l’essenza di libro non cambia a seconda che il libro esista o meno, e posso dire che il libro esiste perchè mi è dato all’esperienza (visiva, tattile, etc.). Ne consegue che all’esistenza di qualcosa si arriva sempre dall’esperienza, mai dall’essenza, e quindi Anselmo ha sbagliato credendo di poter dimostrare l’esistenza di Dio partendo dalla sua essenza. In L’unico argomento possibile per una dimostrazione di Dio , Kant, smontata la prova ontologica, spiega che vi è un solo argomento per dimostrare l’esistenza di Dio, e tale argomento si basa appunto sull’esperienza: si tratta della dimostrazione (‘del principio di ragion sufficiente’) data a suo tempo da Leibniz. Non vi è nulla che avvenga senza un motivo: ne consegue che si deve trovare un qualcosa che si spieghi da solo, che sia motivo di se stesso e che faccia derivare da sè tutto il resto: si tratta di Dio. Successivamente Kant rifiuterà quest’argomentazione, ma manterrà valida la critica alla prova di Anselmo, spiegando anzi, nella Critica della ragion pura , che tutte le prove dell’esistenza di Dio sono riconducibili alla prova di Anselmo; ma se essa è falsa, anche tutte le altre (che da essa derivano) lo sono. In effetti la prova della dimostrazione dell’esistenza di Dio addotta da Kant in quest’opera è molto discutibile, e lui stesso se ne rende conto, a tal punto che, sul finale dell’opera sull’unico argomento possibile, troviamo scritto: ‘ se è necessario convincersi dell’esistenza di Dio, non è altrettanto necessario che la si dimostri ‘. Nel 1770 Kant pubblica un’opera di fondamentale importanza nel suo percorso filosofico: si tratta della Dissertazione del 1770 sulla forma e i princìpi del mondo visibile e intellegibile: l’importanza di questo scritto risiede nel fatto che esso segna il periodo di transizione da fase precritica a fase critica; dopo averla pubblicata, Kant non scriverà più nulla di significativo per 11 anni: egli sente l’esigenza di riflettere prima di pubblicare qualcosa di davvero importante. Possediamo delle lettere kantiane risalenti a quel periodo in cui il pensatore tedesco spiega di essere impegnato nella preparazione di una grande opera, la Critica della ragion pura , che comporrà, nel 1781, in due soli mesi . Dalle lettere, è interessante notare, emerge che Kant aveva pensato a realizzare un’unica opera in cui illustrare i concetti che invece poi inserirà in due opere distinte, la Critica della ragion pura (dedicata alla gnoseologia) e la Critica della ragion pratica (dedicata alla praticità). Nelle lettere Kant non accenna minimamente a quella che sarà la terza grande critica, la Critica del giudizio (dedicata all’estetica): non riteneva infatti l’estetica suscettibile di trattazione critica. Esiste poi un Opus postumum , una raccolta di riflessioni kantiane pubblicate postume, in cui emergono alcune sfumature del suo pensiero, in particolare a riguardo di quella che Kant chiamerà la ‘cosa in sè’: in questi scritti essa tenderà a subire delle modificazioni. Tornando alla Dissertazione del 1770 , quel che emerge in essa e che sarà presente, seppur in modo diverso, nel periodo critico è la distinzione tra fenomeno e noumeno. Fenomeno (dal grecofainomenon , ciò che appare ) è ciò che appare, è l’oggetto dell’esperienza sensibile, mentre noumeno (dal greco noumenon ciò che è pensato ) è ciò che viene pensato, il possibile oggetto del pensiero. Questa distinzione rievoca quella operata a suo tempo da Platone tra sensibile e intellegibile, anche se in realtà, per Platone, si trattava di una distinzione tra due diversi oggetti del pensiero (una cosa era il cavallo, un’altra l’idea di cavallo e altra cosa era conoscere la prima rispetto alla seconda: si poteva conoscere una realtà a livello sensibile o pensandola con l’intelletto), per il Kant della Dissertazione, invece, si tratta di due livelli graduali: prima conosco la cosa come appare (conoscenza fenomenica), poi come effettivamente è (conoscenza noumenica). Ed è solo la conoscenza intellettuale (noumenica) che mi fa vedere come la cosa è realmente. In un secondo tempo, Kant introdurrà il concetto di ‘cosa in sè’ come sinonimo di noumeno: parla di cosa in sè perchè si tratta della cosa non in riferimento alla mia attività conoscitiva, ma slegata, a sè stante. Tuttavia la differenza lampante tra il Kant della Dissertazione e quello della Critica della ragion pura sta nel fatto che nel 1770 egli, influenzato dal platonismo, è pienamente convinto della conoscibilità della cosa in sè, mentre nel periodo critico la dichiarerà inconoscibile. E’ ben evidente che la posizione kantiana nella Dissertazione è diametralmente opposta a quella assunta ne I sogni di un visionario , dove intendeva la metafisica come un puro vaneggiamento: nella Dissertazione Kant dice invece che posso vedere le cose come mi appaiono, ma, platonicamente, posso anche coglierne col pensiero l’essenza stessa (la cosa in sè). Il Kant della Ragion pura, invece, proclamerà l’inconoscibilità della cosa in sè asserendo che la nostra conoscenza si ferma al fenomenico. Esaminando la Dissertazione, però, è interessante notare che Kant, imbevuto di platonismo, introduce l’idea che la forma della conoscenza fenomenica sono lo spazio (per il mondo esterno: tutto quel che è fuori di me, lo percepisco nello spazio) e il tempo (per il mondo interiore: la successione dei miei stati interni). Qui Kant concepisce lo spazio e il tempo in maniera differente rispetto alle nozioni leibniziane e newtoniane, spiegando che essi non hanno esistenza oggettiva (come pretendeva Leibniz) e non sono assoluti, indipendenti dalle cose in essi immerse e dai soggetti conoscenti (come voleva Newton): per Kant spazio e tempo sono realtà soggettive , che non appartengono agli oggetti e al noumeno, ma al nostro modo di conoscere gli oggetti e al fenomeno. Essi appartengono dunque alle forme della conoscenza sensibile (fenomenica), fanno parte non della natura delle cose in sè, ma della natura del nostro modo di percepire: percepiamo, infatti, le cose nello spazio e nel tempo. Ma dobbiamo prestare attenzione a non farci ingannare dal linguaggio kantiano: egli per oggettivo intende sì qualcosa di opposto al soggettivo, un qualcosa che non dipende dal soggetto ma è a sè stante (il noumeno), tuttavia in Kant il termine ‘oggettivo’ è spesso sinonimo di ‘universale’: ad esempio, spazio e tempo sono soggettivi, nel senso che non appartengono alle cose come sono in sè, ma alle cose come appaiono a noi; detto questo, però, Kant dice anche che la nostra conoscenza delle cose nello spazio e nel tempo è oggettive, ha cioè valenza universale, vale per tutti i soggetti umani. Dire che la conoscenza fenomenica è oggettiva sembra un paradosso, perchè il fenomenico è soggettivo, non attinge la cosa oggettivamente come è in sè: però, avendo tutti gli uomini la stessa struttura mentale, allora conoscono le cose, sostanzialmente, tutti nella stessa maniera, che non è oggettiva nel senso che attingono la cosa in sè, ma è oggettiva nel senso che tutti la percepiscono fenomenicamente allo stesso modo: quando, ad esempio, parlo della penna, nessuno può cogliere il noumeno, ma dicendo ‘la penna è qui’ tutti mi capiscono perchè hanno le mie stesse strutture mentali. Così si spiega dunque perchè per Kant la conoscenza fenomenica è oggettiva (universale), grazie al fatto di essere soggettiva : avendo tutti noi gli stessi strumenti per conoscere le cose in modo soggettivo (nello spazio e nel tempo), si tratta però di una conoscenza universale, cioè oggettiva; il che ci permette di comunicare. Protagora diceva che l’ uomo é misura di tutte le cose e questa espressione può anche significare che l’ uomo in quanto tale (il genere umano) conosce le cose come gli appaiono e non può fare altrimenti. Ora, quest’ interpretazione rispecchia molto bene il pensiero di Kant: il genere umano conosce le cose come appaiono (fenomenicamente), ossia ciascuno le conosce soggettivamente, come appaiono a lui; ma tuti gli altri uomini, dotati delle stesse strutture mentali, le conoscono soggettivamente allo stesso modo: si tratta allora di una conoscenza soggettiva (fenomenica: basata sull’apparenza), ma oggettiva (universale, uguale per tutti gli uomini). Ad accomunare Protagora e Kant è poi il fatto che per entrambe l’uomo può conoscere (e non può fare altrimenti) le cose come gli appaiono, quasi come se avesse davanti agli occhi delle lenti colorate non rimuovibili che gli fanno vedere il mondo in un determinato modo. Tuttavia, il Kant della Dissertazione è pienamente convinto che si possa conoscere anche il noumeno, accanto al fenomeno: vale a dire, che se la conoscenza fenomenica avviene attraverso il filtro dello spazio e del tempo e ci fa vedere le cose non come sono, ma come appaiono, tuttavia esiste la conoscenza noumenica, che ci fa cogliere le cose in sè, come oggetti del pensiero. Nella Critica della ragion pura , invece, spiegherà che è conoscibile solo il fenomeno e che in realtà, mentre lo spazio vale solo per il mondo esterno, il tempo, invece, oltre a valere nell’interiorità, vale anche per l’esterno: infatti anche le percezioni esterne diventano qualcosa di interiore a me (quando vedo un libro blu, è una sensazione di qualcosa di esterno, ma come sensazione è interna, perchè il blu entra nella mia testa, nel mio interno: e qui regna il tempo). Sempre nella Critica della ragion pura , Kant spiega che non si possono conoscere le cose in sè, ma le si possono comunque pensare: penso alla penna conosciuta fenomenicamente, la percepisco e la inquadro intellettualmente: rifletto sul fatto che al di là della penna c’è la penna in sè, da cui derivano tutti gli elementi sensibili, e sebbene io possa pensarla, tuttavia non posso conoscerla, perchè dovrei avere un concetto privo di contenuto della penna, senza relazioni con altre cose: dovrei avere il noumeno.
LA CRITICA DELLA RAGION PURA
Nella Dissertazione , dunque, (e qui sta la differenza rispetto alla Critica della ragion pura) vi è una netta contrapposizione tra conoscenza sensibile e conoscenza intellettuale, sebbene si tratti comunque di due diversi modi di conoscere il medesimo oggetto: esso viene conosciuto fenomenicamente sotto il profilo dell’apparenza, filtrato cioè dallo spazio e dal tempo (che non appartengono alle cose in sè, ma appartengono alle cose come fenomeni). Tuttavia, essendo spazio e tempo uguali per tutti gli uomini, tutti vedono le cose nella medesima maniera, in modo oggettivo (ossia universale). Tuttavia la posizione del Kant della dissertazione si riveste di ambiguità nel momento in cui prospetta la conoscenza della cosa in sè, del noumeno, che sarà invece respinta nella Critica della ragion pura . Per il Kant del periodo critico, conoscere sarà pensare, sì, ma pensare qualcosa di dato dall’esperienza: dove non c’è esperienza non c’è conoscenza. Pare del resto evidente che una cosa, per essere pensata e conosciuta, deve prima essere percepita empiricamente; tuttavia l’esperienza non basta, non c’è conoscenza senza il pensiero: raccolti i dati sensibili, essi devono essere riorganizzati dall’intelletto. Ecco dunque che quei due diversi livelli conoscitivi (intellettuale e sensibile) vengono per così dire ricompattati: nè l’esperienza nè il pensiero, da soli, danno la conoscenza; per pervenire ad essa sono necessari i dati sensibili e l’intelletto che li riorganizzi. Ecco perchè ‘ senza l’intelletto la nostra conoscenza sarebbe cieca e senza l’esperienza sarebbe vuota ‘. Kant non riconosce più, nel periodo critico, una netta distinzione tra conoscenza sensibile e conoscenza intellettuale perchè ciascuno di questi due pezzi, se non abbinato all’altro, è inutile. La conoscenza che deriva dall’organizzazione dei dati sensibili da parte dell’intelletto resta comunque fenomenica (mai noumenica), in quanto l’intelletto non è più una fonte autonoma di conoscenza (come era nella Dissertazione); tuttavia la nozione di conoscenza fenomenica assume ora una diversa coloritura: essa implica la collaborazione tra sensi, impiegati nella raccolta dati empirici, ed intelletto, impiegato nell’organizzazione di tali dati; ne consegue che pensare significa unificare , ossia riorganizzare i dati dell’esperienza con l’intelletto. Tuttavia Kant si avvede che non è solo la sensibilità ad avere le sue forme (spazio e tempo), come invece credeva ai tempi della Dissertazione : anche l’intelletto organizza il materiale sensibile attraverso delle forme, che Kant chiama categorie; ecco dunque che nella conoscenza fenomenica opera anche l’intelletto, la cui competenza, invece, nella Dissertazione era riservata esclusivamente alla conoscenza noumenica. Questo non toglie che la conoscenza resti fenomenica, e anche se la cosa in sè posso pensarla, non per questo posso conoscerla. Il contenuto della cosa in sè, però, spiega Kant, é vuoto ed inaccessibile. Tutti questi concetti, pilastri del suo sistema filosofico, Kant li illustra nella Critica della ragion pura (1781) , il suo capolavoro, con la cui pubblicazione prende il via il periodo critico. Esso viene così definito per via dei titoli delle tre grandi opere che lo caratterizzano (le 3 critiche, della ragion pura, della ragion pratica e del giudizio); in origine, però, la terza critica (quella del giudizio) non era prevista, e le prime due dovevano avere un titolo diverso da quello con cui ci sono giunte: si sarebbero infatti dovute intitolare Critica della ragion pura teoretica e Critica della ragion pura pratica . Bisogna ora spendere due parole sul motivo di questi titoli, in cui compare il termine ‘critica’ che dà appunto il nome a questa seconda fase del pensiero kantiano. Il termine ‘critica’ si riconduce inevitabilmente al vocabolario della temperie culturale allora in atto, l’illuminismo, il quale tendeva appunto ad avere con la ragione un approccio critico: la ragione per gli illuministi è l’unico baluardo conoscitivo a disposizione dell’uomo, ed è però uno strumento che presenta degli evidenti limiti. Per evitare che la ragione compia passi, per così dire, più lunghi della gamba e rischi di impelagarsi in questioni che non può risolvere nè le competono, è opportuno giudicare (in grecokrinw vuol appunto dire giudicare: da qui l’aggettivo ‘critico’) sulle sue facoltà e sui suoi limiti. L’assillante quesito volto a scoprire che cosa possa conoscere la ragione e fin dove possa spingersi è presente a partire dalle opere seicentesche (il Novum organum di Bacone, il Discorso sul metodo di Cartesio, il SAggio sull’intelletto umano di Locke) e trova nel Kant della Ragion pura la massima espressione. Egli sostiene che la filosofia debba rispondere a tre quesiti: 1 ) che cosa posso sapere? (e Kant risponde a questa domanda nella Critica della ragion pura ), 2 )che cosa posso fare? (e Kant risponde nella Critica della ragion pratica ), 3 ) cosa posso sperare? (e risponde in ambedue le opere appena citate, sostenendo che è legittimo sperare nell’esistenza di Dio e nell’immortalità dell’anima). Occorre dunque avere un approccio critico con la ragione, giudicandone i limiti ed i difetti: ecco allora che Kant istituisce un vero e proprio tribunale della ragione , dove la ragione é allo stesso tempo imputato e giudice : imputato nel senso che si indaga su quali siano i suoi limiti e il suo campo di applicabilità , giudice nel senso che é proprio lei che indaga e giudica se stessa. In tribunale però non si discutono solo le questioni di fatto, ma anche quelle di diritto: dopo aver spiegato che l’imputato ha agito in quel determinato modo, occorre chiedersi se egli ne aveva il diritto. Non si tratta dunque di indagare sulla ragione esclusivamente per quel che ha fatto, ma anche se aveva o meno il diritto di farlo. Nelle prime pagine della Critica della ragion pura , Kant riprende le tre domande poc’anzi citate cui è tenuta a rispondere la filosofia, e le riformula sotto forma di tre sottodomande: a ) come è possibile una matematica pura? b ) come è possibile una fisica pura? c ) come è possibile una metafisica come scienza ? Con l’ultimo quesito, il pensatore tedesco si chiede se sia possibile una metafisica come scienza e, nel caso lo sia, come debba funzionare. Con le prime due domande, invece, Kant non si chiede se sia possibile una matematica o una fisica pura (poichè egli non nutriva dubbio alcuno sulla fisica matematizzata di Newton), ma come sia possibile, secondo quali modalità. Che siano scienze ‘possibili’, del resto, lo dimostrano i grandi risultati a cui esse hanno portato: Kant dà quindi per scontato che siano possibili e passa direttamente a chiedersi come lo siano. Sarà poi nell’ Ottocento e nel Novecento che la fisica e la matematica verranno messe in discussione e nasceranno le geometrie non euclidee. Per quel che riguarda la metafisica, anche in virtù dei dubbi sollevati da Hume, occorre invece chiedersi in primis se essa sia possibile, e, in caso affermativo, come lo sia. Alla domanda se sia possibile una metafisica come scienza Kant fornisce una risposta articolata e, per molti versi, ambigua, spiegando che la metafisica è un impulso innato nella natura umana: tale natura non si accontenta delle cose fisiche, ma ha bisogno di andare al di là di esse. Kant descrive quest’atteggiamento proprio dell’uomo servendosi di un’immagine: come quando in riva al mare vediamo all’orizzonte la distesa marina più in alto rispetto a quanto non sia, e pur sapendo che si tratta di un’illusione ottica, non per questo smettiamo di vederla più in alto, allo stesso modo sappiamo che la metafisica è una fantasticheria, ma non per questo cessiamo di cedere ad essa, presi da un impulso innato nella nostra natura. Kant quindi riconosce che l’uomo, per sua inclinazione naturale, tende alla metafisica, e vede questa tendenza come positiva; ciononostante, la ragione deve vigilare e deve fare in modo che questa tendenza ad andare al di là del mondo fisico non degeneri in una pretesa. Ma la questione inerente alla metafisica come scienza non si risolve qui: se intendiamo la metafisica in senso letterario come un oltrepassamento delle cose fisiche, allora essa non è possibile come scienza; ma il termine ‘metafisica’ può anche avere un significato più sfumato e se alla parola conferiamo questo significato, allora una metafisica come scienza è possibile. Sembra dunque che Kant sia il grande distruttore della metafisica (specialmente quando nega ogni possibilità di conoscere la cosa in sè), come Robespierre lo era del regime in vigore prima della Rivoluzione francese, ma in realtà il pensatore tedesco può anche essere considerato come il rifondatore della metafisica, colui il quale le diede fondamenti validi smantellando quelli vacillanti su cui fino ad allora era poggiata. Aristotele aveva inteso la metafisica (che lui chiamava ‘filosofia prima’) con una duplice valenza: in primis, per metafisica intendeva lo studio delle cose che stanno al di là del mondo fisico, al di là del mondo fenomenico avrebbe detto Kant (e il filosofo tedesco boccia l’ipotesi che una metafisica di questo genere possa essere una scienza), in secundis, però, metafisica era anche lo studio delle caratteristiche generali dell’essere (l’ontologia). Ecco allora che l’idea di una metafisica come scienza delle strutture generali dell’essere non va scartata, se però non la intendiamo come studio delle strutture dell’essere in sè (poichè il noumeno è inconoscibile), ma come studio delle caratteristiche dell’essere che appare a noi, fenomenicamente. Viene rifiutata, dunque, da Kant la metafisica come scienza delle leggi dell’essere in sè, ma viene accettata come scienza dello studio delle leggi dell’essere fenomenico, così come ci appare : del resto le leggi della realtà così come ci appare siamo noi a stabilirle, non nel senso che decidiamo noi come vada il mondo, ma nel senso che le leggi generali del funzionamento della realtà empirica come ci appare derivano dal nostro modo di concepire la realtà . Sì, perchè il nostro approccio con la realtà è soggettivo, in quanto filtrato dalle forme dell’intelletto e dei sensi, ma è oggettivo nel senso che è comune a tutti gli uomini: proprio in virtù di questa oggettività, esistono leggi generalissime della realtà riconosciute da tutti gli uomini, quale ad esempio la causalità: l’idea di fondo che nel mondo esistano rapporti di causa ed effetto rigidamente determinati, per cui ogni fenomeno è causato da un altro fenomeno ed è a sua volta causa di un terzo fenomeno. Queste legge generalissime derivano, secondo Kant, dal nostro modo di conoscere la realtà: come lo spazio e il tempo sono le forme della sensibilità, così le categorie sono le forme dell’intelletto. Proprio la causalità è una delle 12 categorie riconosciute dal pensatore tedesco ed è uno dei modi in cui l’intelletto inquadra ed organizza il materiale sensibile ricevuto filtrato dal tempo e dallo spazio. Se la causalità e le altre categorie non riguardano il mondo come è in sè, ma come ci appare, allora vuol dire che siamo in grado di descrivere un insieme di leggi generali che regolano il mondo: ne consegue che possiamo descrivere le strutture generali dell’essere fenomenico (e non noumenico, che resta inconoscibile), anzi, le possiamo conoscere con la massima certezza perchè abbiamo imposto noi tali leggi: Kant dirà che le possiamo conoscere a priori , ossia prima e indipendentemente dall’esperienza, perchè non ci derivano dall’esperienza, ma sono le leggi stesse che il nostro intelletto impone all’esperienza. Ogni cosa la pensiamo attraverso le 12 categorie (le strutture dell’intelletto) e la percepiamo attraverso lo spazio e il tempo: dunque il mondo che ci circonda è l’insieme del materiale derivatoci dall’esperienza (e che a sua volta deriva dalla cosa in sè, pensabile ma non conoscibile) e filtrato dallo spazio e dal tempo, poi riorganizzato attraverso le 12 categorie: ecco che così abbiamo quel che ci sta intorno. Il mondo quindi sarà costituito da un materiale (le sensazioni, i sensi, ecc) e dalle forme della sensibilità (spazio e tempo) e dell’intelletto (le 12 categorie), che però gli abbiamo dato noi. Quando parliamo di leggi generali della realtà, quindi, non ci riferiamo al materiale della conoscenza, ma alla forma, perchè esse sono la forma della conoscenza: è evidente che la legge di causalità (una delle svariate leggi dell’essere) è una delle forme in cui inquadriamo il materiale, il quale esula dalle leggi generali dell’essere. Ne consegue che, essendo le leggi generali della realtà leggi della realtà come appare a noi, allora le leggi dell’essere fenomenico ci sono perfettamente conoscibili, proprio perchè sono le leggi generalissime che imponiamo alla realtà fenomenica a priori, prima e indipendentemente dalla realtà: ad esempio, ancor prima di entrare in una stanza vuota sappiamo a priori, senza sperimentarlo, che qualsiasi cosa che eventualmente troveremo sarà nello spazio, così come, messa per la prima volta una pentola piena d’acqua sul fuoco, a priori sappiamo che l’accensione della fiamma sarà la causa di qualcosa perchè il principio di causalità ci dice a priori che ogni cosa ne causa un’altra; solo a posteriori (dopo averlo sperimentato) però potremo effettivamente sapere che cosa causi la fiamma accessa sotto la pentola, ma a priori potevamo già dire che qualcosa l’avrebbe causato (perchè a monte rispetto all’esperienza sappiamo già che il mondo è un insieme di rapporti di causa ed effetto): lo scienziato, del resto, non si chiede se succederà qualcosa (perchè lo sa a priori), ma cosa succederà. Ecco quindi che Kant affronta le tematiche su cui si era arrovellato Hume: come si fa a tirar fuori la causalità dall’esperienza? Per Hume non era possibile: il fatto che ci siamo bruciati ogni volta che abbiam messo la mano sul fuoco, non permetteva secondo Hume di tirar fuori la causalità, perchè in fondo non c’è nulla che ci garantisca che ci bruceremo di nuovo quando metteremo la mano sul fuoco: il nostro concetto di causalità si basa, secondo il pensatore scozzese, sull’abitudine, ossia sull’essere certi che A causa B perchè ogni volta che abbiam visto A, abbiamo visto anche B. Kant dà ragione a Hume: il concetto di causalità non lo possiamo tirar fuori dall’esperienza; la causalità l’abbiamo per Kant già nella testa, ha dimensione innatistica: quale effetto deriverà da quella causa lo possiamo solo sapere dall’esperienza, ma che ci sarà una causa lo so a priori. Non è quindi il fatto che io veda due cose in rapporto di causa ed effetto che mi dà il concetto di causalità , ma è il fatto che io abbia insito in me il concetto di causalità che mi rende possibile l’esperienza, cioè il vedere le due cose in rapporto di causalità: concettualmente, prima c’è il concetto di causalità, poi l’esperienza. E, in questo capovolgimento del discorso di Hume, Kant dà per l’ennesima volta ragione a Newton: riprendendo l’immagine della stanza buia, prima c’è lo spazio, e poi, eventualmente, le cose immerse in esso: lo spazio è assoluto, a priori. Però per Kant non esiste oggettivamente lo spazio, è una forma della nostra conoscenza e proprio per questo è a priori, in quanto dipendente dalle forme sensibili soggettive. Ritornando alla questione di partenza, la metafisica (intesa non come scienza delle cose al di là del mondo fisico, ma come scienza delle leggi dell’essere) come scienza è possibile, perchè le strutture della realtà fenomenica le conosciamo perfettamente, perchè siamo noi a imporle, anzi, paradossalmente, si identificano con la nostra mente e con le sue strutture. Ed è proprio in virtù di questa identificazione che Kant impiega la parola metafisica con un terzo significato. Pubblicata la prima edizione della Critica della ragion pura (cui ne seguirà una seconda in cui dissiperà le perplessità e i fraintendimenti), scrive una versione semplificata della Ragion pura, intitolata Prolegomeni ad ogni metafisica che vorrà presentarsi come scienza : se in futuro la metafisica vorrà ancora presentarsi come scienza, bisogna prima chiarire alcuni cose; così suona il titolo. Fa subito capire che Kant non è distruttore della metafisica, ma anzi, ha un rapporto privilegiato con essa; egli si è sempre dichiarato innamorato della metafisica, e non vuole abbandonarla: per alcuni versi, come abbiamo visto, riesce anche a renderla possibile come scienza delle strutture generali della realtà (purchè sia del fenomeno). Kant arriva a definire metafisica l’indagine che lui sta conducendo, l’indagine preliminare sulle strutture della mente umana: sì, perchè se la metafisica come scienza delle leggi generali della realtà è possibile e tali leggi coincidono con la nostra mente (la realtà fenomenica è come la pensiamo), cioè le leggi della realtà sono le leggi del pensiero, ne consegue che possiamo designare col nome di metafisica anche l’analisi che noi facciamo delle strutture delle leggi del pensiero (proprio perchè esse coincidono con le leggi generali della realtà fenomenica, che chiamiamo appunto ‘metafisica’) . Nella Critica della ragion pura Kant fa un uso frequentissimo dell’aggettivo trascendentale , di matrice Scolastica; egli dice: ‘ chiamo trascendentale quella conoscenza che non si occupa degli oggetti in sè, ma del nostro modo di conoscere gli oggetti, in quanto questo modo deve essere possibile a priori . L’indagine non verte dunque sugli oggetti, ma sul modo in cui noi li conosciamo, proprio in quanto questo modo deve essere possibile a priori. E’ la premessa e condizione di fondo perchè l’esperienza rigorosa si possa fare: debbo già avere il concetto di causalità per poterci costruire un’esperienza che sia rigorosa, sulla scia della scienza newtoniana. Ma dato che dall’esperienza non può derivarmi il concetto di causalità (come ha acutamente notato Hume), esso può derivarmi solo dall’ammissione di forme a priori in cui inquadrare l’esperienza: è solo ammettendo che esista nella struttura della mia mente il concetto di causalità che l’esperienza del mondo potrà essere rigorosa. Kant impiega il termine trascendentale, da un lato, per definire l’indagine da lui svolta sulle forme a priori della conoscenza e tutte le partizioni della Critica della ragion pura (estetica trascendentale, logica trascendentale, dialettica trascendentale), ma, dall’altro lato, per aggettivare le forme stesse della conoscenza. Usa però diverse espressioni per designare le forme della conoscenza: spesso le definisce ‘pure’, perchè analizzate in sè in quanto pure, depurate dall’esperienza, senza materiale sensibile all’interno: per intenderci, una cosa è lo spazio in quanto tale, un’altra cosa è lo spazio riempito di oggetti; una cosa è sapere che c’è la causalità, un’altra è la causalità applicata all’esperienza, al fuoco e alla pentola: e si intitola Critica della ragion pura in questo senso, cioè come giudizio sulla ragione depurata dall’esperienza). Altre volte Kant le definisce ‘a priori’ le forme, esse sono cioè condizioni che vengono prima dell’esperienza. Infine, e qui arriviamo al dunque, le chiama trascendentali: con questo termine egli intende una via di mezzo tra il trascendente platonico (le idee) e l’immanente aristotelico (le forme); da notare, però, che Kant impiega termini tipici della metafisica (materia, forma) in ambito gnoseologico, proprio in quanto concepisce la conoscenza come una costruzione che necessita di materia (i dati sensibili) e di forma (le 12 categorie più lo spazio e il tempo). Il termine trascendentale viene quindi adoperato nella sfera gnoseologica: Kant si chiede se le forme della conoscenza siano immanenti o trascendenti, se derivino dall’esperienza e se ad essa siano applicabili o se siano trascendenti e applicabili a qualcosa al di là dell’esperienza, e risponde che esse sono trascendentali, ovvero non derivano dall’esperienza, ma contemporaneamente non si può dire che siano legittimamente applicabili al di là dell’esperienza : non possono trascendere l’esperienza, ma non derivano da essa. Fin dalle prime pagine della Critica della ragion pura Kant prova ad individuare quale sia la domanda cui è tenuta a rispondere la ragion pura ed esamina, in termini generali, la risposta a tale quesito. Arriva alla conclusione che le varie domande che si era posto (sono possibili una matematica pura, una fisica pura e una metafisica, come scienze?) sono sintetizzabili in un solo interrogativo: come sono possibili dei giudizi sintetici a priori ? Kant ravvisa infatti tre diversi tipi di giudizio: i giudizi analitici a priori (quelli che Hume e Leibniz avevano chiamato, rispettivamente, ‘relazioni tra idee’ e ‘verità di ragione’) : sono giudizi analitici a priori quelli in cui si cerca di far emergere il predicato tramite un’analisi (ossia una scomposizione) dei concetti del soggetto; la sentenza ‘il triangolo ha 3 lati’ è un giudizio analitico a priori, in quanto è implicito nel concetto di triangolo il fatto di avere tre lati: nel dire che il triangolo ha 3 lati non si aggiunge qualcosa al soggetto, anzi, lo si estrae da esso. Vengono detti analitici perchè implicano un’analisi tutta interna al concetto del soggetto, e a priori perchè non derivano nè dipendono dall’esperienza, ma sono veri ancor prima di essa. E il fatto di essere a priori ne garantisce, secondo Kant, la necessità e l’universalità. Hume aveva a suo tempo insistito (e Kant gli dà ragione) che dall’esperienza in quanto tale, la necessità non viene mai fuori: sulle esperienze posso fare affermazioni, ma tali affermazioni non avranno mai carattere di assoluta necessità: dire che il fuoco causa il bruciore della mano posta su esso, è frutto dell’esperienza, ma non c’è nulla, a rigor di logica, che mi garantisca che la prossima volta che metterò la mano sul fuoco proverò bruciore; è solo un fatto di esperienza, nel senso che ogni volta che ho messo la mano sul fuoco mi sono bruciato, e dunque, sono convinto (per abitudine) che rimettendola, mi brucerò di nuovo. Da ciò che deriva dall’esperienza io non riesco ad avere oggettività, universalità e necessità. Gli analitici a priori hanno una loro oggettività (dire che il triangolo ha 3 lati è assolutamente corretto, universale e necessario) proprio perchè a priori. Accanto agli analitici a priori ci sono i giudizi sintetici a posteriori (che Hume e Leibniz avevano chiamato, rispettivamente, ‘materie di fatto’ e ‘verità di fatto’) che altro non sono se non i giudizi dell’esperienza. Sono detti a posteriori perchè vengono dopo l’esperienza, e sintetici perchè aggiungono qualcosa al concetto del soggetto. Kant si avvale di un’efficace immagine per illustrarli: i corpi. Se dire che un corpo occupa dello spazio è un giudizio analitico a priori perchè lo evinco dall’analisi del concetto del soggetto stesso (il corpo) senza bisogno di far uso dell’esperienza (perchè è già contenuto nel concetto stesso di corpo), dire che un corpo è pesante è un giudizio sintetico a posteriore perchè non rientra nel concetto di corpo l’avere un peso ma deriva, a posteriori, dall’esperienza attraverso la sintesi, cioè attraverso la costruzione di qualcosa di nuovo intorno al soggetto (il corpo). Infine Kant introduce i giudizi sintetici a priori (assenti in Hume e Leibniz) per far fronte all’aporia in cui era incappato Hume: il pensatore scozzese, infatti, si era accorto che nè i giudizi analitici a priori nè quelli sintetici a posteriori sono sufficienti. Sì, perchè gli analitici a priori sono assolutamente certi, ma assolutamente tautologici, non dicono cioè nulla di nuovo, che non fosse già presente nel soggetto; i sintetici a posteriori, invece, arricchiscono la nostra conoscenza perchè, tramite l’esperienza, ci dicono qualcosa di nuovo, che in partenza non era presente nel soggetto, ma hanno il difetto di non fornire assoluta oggettività, universalità e necessità. A questo punto, fatta crollare la metafisica, Hume si fermava perchè non riusciva a proseguire; Kant invece vuole andare avanti e si dimostra meno critico del previsto. Egli infatti accetta come scontata la validità oggettiva della scienza newtoniana e, in particolare, della conoscenza umana: non si chiede nemmeno se siano possibili aa matematica, la fisica e la conoscenza umana, ma si chiede direttamente come, in che modo, siano possibili, convinto che possibili lo siano. In altri termini, Kant è certo che sia possibile una scienza assoluta e proprio per questo non si accontenta di quanto ha detto Hume, il quale era pervenuto alla conclusione che la sostanza e la causalità fossero indimostrabili razionalmente e si basassero su una convinzione psicologica dettata dall’abitudine. La domanda kantiana ‘come è possibile la conoscenza umana?’ implica un’ulteriore domanda, ‘come sono possibili giudizi sintetici a priori?’: sì, perchè solo con gli analitici a priori e coi sintetici a posteriori non c’è via d’uscita, si ha una conoscenza certa ma tautologica con i primi, e una conoscenza ricca ma non assoluta coi secondi. E Kant vuole invece una conoscenza ricca e varia, ed ecco che tira in ballo i giudizi sintetici a priori, l’unione dei due precedenti giudizi. Del resto la scienza di Newton, di cui Kant si professa strenuo difensore, ha la pretesa di essere costituita da giudizi allo stesso tempo sintetici e a priori, perchè pretende di costruire (con l’abbinamento di esperienza ed inquadramento razionale della medesima) una scienza che contemporaneamente arricchisca di conoscenze nuove e che le fornisca non in termini probabilistici (come era per Hume), ma oggettivi, necessari e universali, validi sempre e per chiunque. In Hume questa esigenza di una conoscenza certa era assente perchè gli analitici a priori davano una conoscenza certa ma tautologica, mentre i sintetici a posteriori ne davano una ricca ma incerta: la certezza della conoscenza nel pensatore scozzese era meramente psicologica, basata sull’abitudine (ogni volta che ho messo la mano sul fuoco mi son bruciato, quindi in base a questa ‘abitudine’ sono convinto che se la rimetto mi ribrucio), ed esulava del tutto dalla razionalità. E proprio la razionalità della conoscenza è l’obiettivo cui mira Kant: la certezza della conoscenza non deve solo essere psicologica (basata sull’abitudine), ma fondata in modo preciso. Ne consegue che i giudizi che fanno davvero la scienza devono per forza essere, al tempo stesso, sintetici (devono dirmi qualcosa di nuovo) e a priori (non derivati dall’esperienza , ma ad essa precedenti, puri, non soggetti ad essere confermati e smentiti il giorno dopo). D’altronde Hume sbagliava agli occhi di Kant già nel ritenere che i giudizi matematici fossero analitici, mere relazioni tra idee, del tutto tautologici: per Hume svolgere un’espressione algebrica voleva dire prendere il concetto, analizzarlo, ed estrarne le conseguenze, con l’ovvio risultato che l’intera matematica finiva per essere nient’altro che un’enorme tautologia. Per Kant, invece, i giudizi matematici sono inevitabilmente sintetici: quando mi trovo di fronte all’espressione 7+5=12 non è vero che analizzo i concetti di 7 e di 5 e ne estraggo il 12 come relazione tra idee; al contrario, 7+5 è un materiale di lavoro, un’indicazione dell’operazione che devo svolgere. Ne è un fulgido esempio il fatto che i bambini contino servendosi di oggetti materiali, come ad esempio le palline: le raggruppano e le affiancano una alla volta e, una volta sommate, ottengono il risultato. Ed è quello che, secondo Kant, facciamo anche noi mentalmente. Ora, è evidente che un’operazione di questo genere non rientra nell’ambito delle relazioni tra idee, dei giudizi analitici a priori. Si tratta di un’operazione sintetica, di costruzione (e non di analisi), ma nessuno si sognerebbe per questo di considerarla a posteriori, come derivata solo e soltanto dall’esperienza, sebbene si usino materialmente delle palline: ciascuno di noi considera le verità matematiche del tipo 7+5=12 come assolutamente certe, e le certezze (come visto) derivano dagli analitici a priori. Del resto le verità matematiche non possono derivare dall’esperienza, nè tantomeno essere da essa smentite: se un prestigiatore infila prima 7 e poi 5 palline in un recipiente e, mostrandoci il contenuto, non vediamo 12 palline, abbiamo la certezza che c’è stato un trucco, nessuno penserebbe mai che possano essere più o meno di 12. Questo vuol dire che se anche l’esperienza ci fa vedere che 5+7 non dà 12, noi continuiamo ad essere certi che 7+5 dia 12; tutto questo dimostra l’a-priorità (sono giudizi certi, non derivati nè sconfessabili dall’esperienza) e la sinteticità (sono giudizi costruiti nel corso della dimostrazione). E’ dunque possibile una matematica pura, certa, razionale che funziona in base ai giudizi sintetici a priori; ma è possibile anche una fisica pura, basata sui giudizi sintetici a priori? Kant dice di sì e lo dimostra avvalendosi del principio della causalità. Esso consiste nel sapere che ogni fatto è causato da un altro fatto, ed è lui stesso causa di un altro: Hume aveva detto che tale principio non era un giudizio nè analitico a priori (nel concetto di causa non è insito quello di effetto) nè sintetico a posteriori (se, messa la mano sul fuoco, mi brucio una o due volte non ve la metterò più, per via di una certezza psicologica, derivata dall’abitudine che ogni volta che ho messo la mano sul fuoco mi sono bruciato e ho maturato la certezza che il bruciore è causato dal fuoco; ma non posso avere la certezza razionale che il fuoco causi il bruciore perchè non c’è nulla che mi garantisca che la prossima volta mi brucerò la mano mettendola sul fuoco). Ma Kant non è d’accordo e sostiene che anche la causalità sia un giudizio sintetico a priori: sintetico perchè nel concetto di causa non è implicito quello di effetto (non è dunque un analitico), ma a priori perchè ancor prima dell’esperienza so già che la mia azione causerà qualcosa: così lo scienziato si chiede non se la sua azione sortirà un effetto, ma quale effetto, poichè nella sua testa è già presente la certezza che il fatto è stato causato e sarà causa di qualcosa (ma di cosa?): sarà poi l’esperienza che mi dirà di cosa sarà causa, riempiendo questa forma della conoscenza insita nel mio intelletto. Anche la fisica, dunque, nei suoi princìpi generalissimi, è costituita da giudizi sintetici a priori, non derivati dall’esperienza: anzi, ne sono il fondamento, perchè posso indagare attraverso l’esperienza su quale causa ha sortito quell’effetto proprio perchè ho già nella mia testa il concetto di causalità. I giudizi fisici sono dunque sintetici (perchè non analitici), e a priori (perchè non derivati dall’esperienza: l’idea che un fatto ne causa un altro è già presente in me, ancor prima che io lo constati empiricamente). La matematica e la fisica ci danno dunque conoscenze nuove (sono giudizi sintetici) e certe (sono giudizi a priori, non smentibili dall’esperienza). Resta da rispondere alla domanda: ‘come, in che modo, sono possibili i giudizi sintetici a priori?’ La risposta Kant la fornisce sostanzialmente in quella che lui definisce ‘ rivoluzione copernicana del pensiero ‘. Per spiegare il movimento dei pianeti, Copernico aveva cambiato il punto di vista, trasferendolo dalla Terra al Sole e aveva in questo modo dato un’interpretazione corretta; anche Kant, sulle orme di Copernico, attua un radicale cambiamento di punto di vista, convinto che guardando le cose dalla nuova posizione esse risultino più facilmente spiegabili. La rivoluzione che Kant attua, però, è meramente gnoseologica: la maniera tradizionale di interpretare la conoscenza è sempre stata quella di concepirla come un’assimilazione del soggetto all’oggetto, quasi come se la mente fosse uno specchio che diventa uguale alla realtà che su essa viene riflettuta o come se fosse la cera che prende la forma del sigillo (l’oggetto) impressole. Questa concezione era valida sia per gli empiristi sia per gli innatisti; il ragionamento che spinge Kant a respingere questo approccio con la conoscenza e a stravolgere il punto di vista è questo: se la conoscenza deve essere rigorosa (come pretende la scienza newtoniana e come crede Kant), ebbene Hume ci ha insegnato che non può esserlo nell’esperienza, perchè negli oggetti non può essere ravvisato tale rigore e l’esperienza sarà sempre e comunque modificabile da ulteriori esperienze . Ora, per Hume la conoscenza poteva essere solo probabilistica, proprio perchè nell’oggetto non vi è il rigore auspicato dalla scienza; ma Kant vuole che essa sia rigorosa, e di conseguenza, non potendo trovare tale rigore nell’oggetto, sposta il punto di vista sul soggetto. La certezza della conoscenza la si può avere solo ipotizzando che essa non giri attorno all’oggetto, ma al soggetto: dunque non sarà più il soggetto ad essere modificato dall’oggetto, ma, viceversa, sarà l’oggetto ad essere modificato dal soggetto. In questo modo si spiega perchè per Kant il carattere oggettivo (universale e necessario) della conoscenza derivi dal suo carattere soggettivo: nella nostra testa abbiamo strutture conoscitive soggettive, ma essendo esse uguali in tutti gli uomini, garantiscono che la conoscenza sia oggettiva, cioè universalmente valida. Ne consegue che dobbiamo ipotizzare che quel che conosciamo è un’organizzazione che noi uomini impartiamo al materiale conoscitivo datoci dall’esperienza, cosicchè non conosciamo le cose come sono in sè, ma le conosciamo tutti allo stesso modo. Dunque è il soggetto a costruire l’oggetto , e non viceversa: è il soggetto che riceve il materiale dell’esperienza filtrato dal tempo e dallo spazio e che lo costruisce in base alle sue forme mentali. Tuttavia, Kant non è certo un idealista alla Berkeley, bensì è convinto che il materiale della conoscenza derivi dalla realtà (dalla cosa in sè), anche se filtrato dalle forme sensibili e da quelle intellettuali. Dunque l’oggetto è costruito dal soggetto, e proprio in virtù di questo processo costruttivo si tratta di una conoscenza oggettiva (universale). Gli idealisti di inizio ‘800 diranno che la realtà esiste solo nella misura in cui è prodotta dal soggetto: Kant non vuol certo dire questo, per lui le cose non le creo io, esistono indipendentemente da me come cose in sè; io non le produco, ma le costruisco per me; e gli altri le costruiscono come me perchè hanno strutture mentali analoghe. La posizione di Kant, come accennato, fu erroneamente intesa come berkeleyana, ma Kant spiegò di non essere affatto idealista, sottolineando che la cosa in sè esiste indipendentemente ed è immodificabile: il mio processo di costruzione dell’oggetto riguarda il fenomenico, non il noumeno; del resto costruisco l’oggetto con il materiale dell’esperienza in ambito fenomenico, e non dal nulla (come era e sarà per gli idealisti). Esaminiamo ora la partizione della Critica della ragion pura : dicevamo che essa è caratterizzata da un’estrema, quasi esasperata, sistematicità, tanto da voler sembrare più sistematica di quanto non sia in realtà: alcune problematiche del pensiero kantiano, se si entra nel dettaglio scavando a fondo, si scopre che non sono così ben chiarite come vorrebbe far credere il pensatore tedesco. La Critica della ragion pura si divide in: DOTTRINA TRASCENDENTALE DEGLI ELEMENTI e DOTTRINA TRASCENDENTALE DEL METODO. Nella Dottrina degli elementi Kant vorrebbe, come aveva fatto Locke, individuare gli elementi costitutivi della ragion pura; nella Dottrina del metodo, invece, vuole dare, in base all’analisi degli elementi della ragion pura, un metodo all’operatività della ragione. In realtà, poi, la Dottrina del metodo occupa solo un sesto dell’opera perchè, descrivendo gli elementi nella Dottrina degli elementi, finisce per descriverne anche il funzionamento, che in teoria avrebbe dovuto spiegare solo nella Dottrina del metodo. La Dottrina degli elementi si suddivide, a sua volta, in ESTETICA TRASCENDENTALE e LOGICA TRASCENDENTALE ; e quest’ultima, a sua volta, si divide in ANALITICA TRASCENDENTALE e DIALETTICA TRASCENDENTALE. Infine, l’Analitica si divide in ANALITICA DEI CONCETTI e ANALITICA DEI PRINCIPI. Riassumiamo la partizione in uno schema:
DOTTRINA TRASCENDENTALE DEGLI ELEMENTI – DOTTRINA TRASCENDENTALE DEL METODO: la DOTTRINA DEGLI ELEMENTI si divide poi in
1 ) ESTETICA TRASCENTALE – LOGICA TRASCENDENTALE : la LOGICA si divide poi in
2 ) ANALITICA TRASCENDENTALE – DIALETTICA TRASCENDENTALE : l’ANALITICA si divide poi in
3 ) ANALITICA DEI CONCETTI – ANALITICA DEI PRINCIPI
Esaminiamo ora l’Estetica e la Logica: la parola ‘estetica’ viene intesa nella Critica della ragion pura in modo singolare: a quei tempi si stava diffondendo in ambito filosofico l’uso della parola estetica come la intendiamo noi oggi, come filosofia che riguarda la categorie del bello; in questa accezione la usa anche Kant stesso nella Critica del giudizio , dove si occupa appunto del bello e del brutto. Ma nella Critica della ragion pura, dove non si occupa nè del bello e del brutto ( Critica del giudizio ) nè del bene e del male ( Critica della ragion pratica ), bensì si occupa del vero e del falso, per estetica egli intende, riprendendo il termine nel suo significato etimologico, ‘sensazione ‘. Dunque l’ Estetica trascendentale si occuperà dell’ aisqhsis , della parte sensibile della conoscenza, quella parte cioè che si occupa della conoscenza che viene prima di quella intellettuale; ‘trascendentale’ perchè si occupa delle forme sensibili presenti in noi in modo innato, ma applicabili solo all’esperienza. La Logica trascendentale si occupa invece dell’intelletto, del logoV ,dell’elaborazione mentale dei dati sensibili compiuta dall’intelletto; ‘trascendentale’ perchè studia le forme dell’intelletto. A questo punto, poi, Kant distinguerà tra un uso legittimo e un uso illegittimo dell’intelletto: il grande errore della metafisica, ai suoi occhi, risiede nella pretesa di usare l’intelletto anche dove non c’è disponibilità di materiale sensibile; dei sensi, invece, non si può fare un uso illegittimo, in quanto essi non possono andare al di là di nulla. Con le categorie dell’intelletto, invece, ci si trova di fronte a forme non derivate dall’esperienza, ma l’intelletto si illude di poterle usare al di là dell’esperienza proprio in quanto non derivano da essa. La dimostrazione stessa dell’esistenza di Dio poggia su questa falsa pretesa: a furia di applicare il principio di causalità nel mondo, l’intelletto finisce per volere adoperare tale principio (che non deriva dall’esperienza) anche al di là di essa. E così arriva ad applicare il principio di causalità a Dio stesso. Ecco allora che quando l’intelletto vuole costruire conoscenze senza l’apporto dell’esperienza, finisce per creare concetti vuoti, privi di contenuti empirici. Proprio dai due diversi usi, legittimo e legittimo, che si possono fare dell’intelletto deriva la suddivisione della Logica trascendentale in Analitica trascendentale (che studia l’uso legittimo delle categorie e dell’intelletto, ovvero in abbinamento all’esperienza) e Dialettica trascendentale (che invece studia l’uso illegittimo dell’intelletto, il risultato a cui tale uso porta e le precauzioni da prendere per prevenirlo). Nell’Analitica trascendentale si serve della parola ‘intelletto’ per designare l’intelletto impiegato nel suo uso legittimo, mentre nella Dialettica trascendentale designa col nome di ‘ragione’ l’intelletto impiegato in modo illegittimo, in modo meta-empirico. Ecco dunque che il termine ‘ragione’, che nel titolo Critica della ragion pura era sinonimo di ‘mente’, passa qui a caricarsi di un valore negativo. Kant desume da Aristotele i termini Analitica (l’uso legittimo dell’intelletto) e Dialettica (l’uso illegittimo dell’intelletto): lo Stagirita, infatti, definiva ‘analitica’ la sua logica, mentre designava col termine ‘dialettica’ la logica più debole, quella che partiva da basi incerte. Con Kant, è importante ricordarlo, si assiste ad una metamorfosi della nozione di ‘intelletto’ ( verstand in tedesco): a partire da lui, infatti, esso viene inteso come la facoltà che mira a conoscere il finito, mentre la ragione ( vernunft in tedesco) è intesa come la facoltà che mira a conoscere l’infinito . Tuttavia, se il puntare all’infinito della ragione per Kant è del tutto illegittimo, esso diventa legittimo per i Romantici e, soprattutto, per Hegel. Esaminiamo ora le varie parti della Critica della ragion pura , partendo dall’ ESTETICA TRASCENDENTALE : essa riguarda la sfera sensibile della conoscenza, le cui forme sono lo spazio e il tempo. Tra le varie considerazioni che si possono subito fare, la prima è che spazio e tempo non si trovano sullo stesso livello: il tempo è, secondo Kant, più importante perchè mentre lo spazio è esclusivamente la forma della sensibilità esterna (le cose che percepisco fuori di me), il tempo è la forma sia della sensazione interna (la percezione dei miei stati interni), sia della forma esterna: quando percepisco nello spazio qualcosa che è a me esterno, paradossalmente esso viene interiorizzato ed io lo percepisco dentro di me, sotto l’influsso del tempo. Infatti, percepiamo la successione dei fenomeni fisici che avvengono nello spazio proprio in virtù dell’azione del tempo, entro il quale li percepiamo. Kant definisce sia lo spazio sia il tempo con il nome di intuizioni pure , ossia intuizioni a priori, sganciate dall’esperienza: se per noi ‘intuizione’ dà l’idea di una conoscenza che scavalca la ragione (e così è anche per i Romantici), storicamente (dal Medioevo fino a Kant) per intuizione si intende qualsiasi forma di conoscenza immediata e proprio perchè immediata Kant non la concepisce come uno scavalcamento della ragione, ma semplicemente come conoscenza sensibile priva di mediazioni. Ecco dunque che l’oggetto dei sensi è l’intuizione, dal momento che colgo l’oggetto senza mediazioni . Resta però da chiarire quali siano per Kant gli oggetti dei sensi. Un libro, per lui, non è un oggetto dei sensi, ma è già il risultato di un processo di unificazione di dati semplici (il blu, la forma parallelepipedo, la composizione atomica, ecc); il libro è dunque un oggetto di esperienza, e non dei sensi; oggetti dei sensi saranno invece il blu del libro o la forma parallelepipedo del libro, quelle che Locke aveva chiamato ‘idee semplici’ e che unificate con l’intelletto mi danno appunto il libro. Le intuizioni, dunque, vengono secondo Kant ricevute (e qui dà ragione a Locke) dalle nostre facoltà sensibili in modo puramente passivo: in questa parte della conoscenza, qualcosa che esiste fuori ed indipendentemente da noi agisce in qualche modo sui nostri organi di senso trasmettendoci alcune sensazioni, che sono il risultato dell’azione dell’oggetto sul soggetto. Ed è in questo modo che percepisco in modo del tutto passivo il blu del libro, come azione dell’oggetto libro su di me, soggetto percipiente; tuttavia l’oggetto (la cosa in sè) io non lo conosco, proprio come per Locke non potevo conoscere la sostanza. Tuttavia, se per Locke non potevo conoscere la ‘cosa in sè’ (che lui chiamava ‘sostanza’) ma di essa potevo conoscere le qualità che le inerivano (il blu, ad esempio), per Kant non posso nè conoscere la cosa in sè, nè le qualità che le ineriscono: il blu che ricevo passivamente con gli organi di senso, appartiene al mondo fenomenico, non alla cosa in sè, lo ricevo cioè filtrato dallo spazio e dal tempo. La passività con cui riceviamo i dati sensibili non implica che li si ricevano non filtrati dalle forme della sensibilità (spazio e tempo). L’esempio che porta Kant in merito è quello delle lenti colorate. Immaginiamo di avere sugli occhi delle lenti amovibili: riceviamo i dati sensibili dall’esterno ma, non potendoci togliere le lenti, li vediamo irrimediabilmente modificati, sotto colorazioni che non appartengono a loro. Così è per lo spazio e il tempo: tutte le cose che vediamo e percepiamo, sono irrimediabilmente filtrate dallo spazio e dal tempo, i quali ci impediscono di vedere la cosa in sè, proprio come le lenti non ci fanno vedere le cose come sono in realtà. Tuttavia Kant non si dimostra poi molto critico e dà per scontato che lo spazio e il tempo non appartengano alle cose in sè: non c’è nulla, in fin dei conti, che ci vieti di ritenere che essi appartengano alla cosa in sè. Kant, riscontrando che spazio e tempo sono forme a priori della nostra conoscenza (ossia li abbiamo nella testa ancor prima di fare una qualsivoglia esperienza) , si sente autorizzato a sostenere che non appartengano alla cosa in sè, mentre in realtà si sarebbe legittimamente autorizzati a dire che potrebbero non appartenerle come appartenerle; quando del resto ho sugli occhi delle lenti verdi, non c’è nulla che mi autorizzi a dire che quello che per via delle lenti vedo verde, poi in realtà non sia per davvero verde: non posso saperlo. Fatta questa precisazione, proseguiamo nell’analisi dell’Estetica: spazio e tempo sono dunque intuizioni pure, cioè oggetti di conoscenza immediata e a priori. Per Kant, sarà invece conoscenza mediata quella riguardante tutto ciò che è il risultato di un’unificazione operata dall’intelletto: il libro (unificazione del colore blu alla forma parallelepipedo, ecc), la casa (unificazione del colore giallo alla forma parallelepipedo), e così via. Sarà invece una conoscenza immediata quella che non implica un’unificazione dell’intelletto.Che esistano intuizioni empiriche, singoli dati immediati dell’esperienza (come la percezione del blu) è evidente; le intuizioni, è altrettanto evidente, sono sempre dati singoli e proprio in questo si distinguono dai concetti, i quali implicano che ci sia un insieme di dati unificati sotto un comune denominatore, sotto un unico ‘cappello’. Per esempio, si può citare il concetto di uomo: che rapporto sussiste tra il concetto di uomo e i singoli uomini? Kant definisce questo rapporto di ‘ sussunzione ‘ spiegando che i singoli uomini sono sussunti sotto il concetto di uomo; essi non fanno parte di tale concetto, ne sono solo esempi, ossia casi particolari. Il concetto di uomo, invece, è generale, una percezione che mi permette di pensare contemporaneamente tutti gli uomini, che di esso sono casi particolari. Ma la domanda che si pone Kant a questo punto è: lo spazio e il tempo sono concetti? No, sono intuizioni, ma non sono empirici, bensì a priori: sono dunque intuizioni a priori. Non sono nell’esperienza, ma la fondano; del resto, Kant si chiede, che rapporto c’è tra i singoli spazi e lo spazio? Forse che, come nel caso del concetto di uomo, gli spazi sono singoli casi dello spazio? No, di certo, ne sono parti. Il che vuol dire che lo spazio e il tempo non sono concetti, ma realtà singole divisibili in parti. Ma proprio in quanto realtà singole, sono intuizioni, non derivate dall’esperienza, ma a priori (sono cioè puri). Detto questo, Kant allarga il discorso e dice che lo spazio e il tempo sono i fondamenti, rispettivamente, della geometria e dell’aritmetica , riportandosi all’assillante quesito: come sono possibili una matematica e una fisica pure? L’aritmetica e la geometria, spiega Kant, sono possibili proprio perchè esistono lo spazio e il tempo come intuizioni pure: abbiamo detto che i giudizi matematici sono a priori, ma sintetici, cioè dicono cose assolutamente certe e ‘nuove’, arricchenti. Lo stesso vale per il tempo e per lo spazio: essendo puri (a priori), tutto ciò che sarà fatto nello spazio e nel tempo godrà di assoluta certezza e rigore. Se fossero concetti (e non intuizioni), potrei da essi derivare analiticamente (cioè come relazione tra idee, senza costruzioni) alcune cose, così come dal concetto di uomo posso derivare che i singoli uomini (supponendo di non averne mai visto uno) avranno le braccia, le gambe e gli occhi: non saprò di che colore saranno gli occhi, ma saprò con certezza, estraendolo dal concetto stesso di uomo, che li avranno. Quella riguardante i concetti è una concezione a priori, ma analitica: conosco il concetto di uomo prima di aver visto un uomo in carne ed ossa, tuttavia quel che tale concetto mi dice, pur dicendomelo con estremo rigore, non è arricchente, è una tautologia. L’aritmetica e la geometria, invece, per Kant non sono deduttive e tautologiche, non tiro fuori concetti da concetti: quando conto, costruisco il numero, così come costruisco le figure geometriche. L’aritmetica è costruita nel tempo (prendo mentalmente l’unità e l’aggiungo), mentre la geometria è costruita nello spazio (traccio figure in esso), ma anche nel tempo: il che implica che si possa applicare l’aritmetica alla geometria; lo posso fare proprio perchè hanno in comune l’essere nel tempo. Il fatto che spazio e tempo siano intuizioni e non concetti permette a Kant di applicarli all’aritmetica e alla geometria: se fossero stati concetti, cioè dotati di analiticità oltrechè di a-priorità, sarebbero stati inaccostabili all’aritmetica e alla geometria, caratterizzate dalla sinteticità. Oltre ad aver spiegato che sono possibili una matematica e una fisica pure come giudizi sintetici a priori, Kant risponde anche all’interessante quesito: come mai possiamo applicare la matematica al mondo fisico ? Se i Pitagorici e Platone avevano risposto a tale domanda sostenendo che la matematica è applicabile al mondo fisico perchè i numeri (esistendo in sè e non essendo il frutto della nostra immaginazione) fanno parte di tale mondo, e se con Galileo fisica e matematica erano diventate un binomio indisgiungibile (tanto da diventare impossibile una fisica senza matematica, come invece la intendeva Aristotele), Kant, nell’attuare la sua riforma copernicana, inverte il discorso: la matematica, la geometria e l’aritmetica sono costruite nelle forme pure della mia conoscenza, ma essendo il mondo da me conosciuto puramente fenomenico (filtrato cioè dallo spazio e dal tempo), non c’è nulla di strano se applico ad esso la matematica e la geometria, che io stesso ho costruito nello spazio e nel tempo: il mondo fenomenico al quale applico la matematica è inquadrato nello spazio e nel tempo, proprio come la matematica e la geometria. E’ ovvio che la matematica sia applicabile al mondo fenomenico; tuttavia non posso sapere se essa lo sia al mondo noumenico, della cosa in sè. Fatte queste considerazioni, Kant asserisce che tempo e spazio sono ‘ empiricamente reali, ma trascendentalmente ideali ‘, riprendendo la distinzione tra oggettivo e soggettivo: tempo e spazio appartengono oggettivamente alla realtà, purchè la concepiamo in termini fenomenici: essi, cioè, appartengono alle cose viste fenomenicamente, non alle cose in sè. Ecco perchè se parliamo di cose fenomeniche, spazio e tempo sono reali, esistono davvero, mentre se parliamo di cose in sè, essi sono ‘ideali’, cioè non sono veri, non esistono. Spazio e tempo, come Kant ha già ampiamente illustrato, appartengono al soggetto e al mondo fenomenico che il soggetto si crea. Passiamo ora all’analisi dell’ Analitica trascendentale dei concetti : la Logica (il cui studio verte sull’intelletto) si suddivide in Dialettica (uso illegittimo dell’intelletto) e Analitica (uso legittimo dell’intelletto); e quest’ultima è incentrata sul tentativo di rispondere alla domanda ‘come è possibile una fisica pura?’. Se la sensibilità riceve passivamente i dati sensibili, all’intelletto spetta unificarli: pensare vuol dire unificare. Se la sensibilità ha a che fare con le intuizioni (pure, come lo spazio e il tempo, ed empiriche, come i dati che riceviamo nello spazio e nel tempo), l’intelletto deve invece vedersela con i concetti, anch’essi suscettibili di a-priorità o di empiricità. L’intelletto si distingue dai sensi, in primo luogo, per il fatto di essere una funzione attiva e non immediata: unifica i dati ricevuti passivamente dai sensi. Saranno concetti empirici quelli che nascono dall’unificazione di dati dell’esperienza: ad esempio, il concetto di uomo deriva dall’unificazione di dati sensibili, esula dall’a-priorità. Il concetto di uomo è un concetto generale, dato dall’unificazione di tanti uomini in un concetto unico, di cui tutti gli uomini sono casi particolari; ma accanto a questo tipo di concetto generale, Kant riconosce anche come concetto l’uomo in carne ed ossa che mi sta davanti. A differenza di Platone (per cui ‘concetto’ era l’uomo pensato, mentre l’uomo che mi trovo davanti era un dato della sensibilità), Kant riconosce come concetti sia l’uomo pensato (concetto generale), sia l’uomo materiale che mi sta davanti (concetto particolare) , in quanto anch’esso è il frutto di un’unificazione di dati sensibili (il colore della pelle, degli occhi, la forma a uomo, ecc) in un concetto (l’uomo). In altri termini, quel che mi è dato nei sensi sono solo i singoli dati sensibili (il colore della pelle, degli occhi, la forma ‘uomo’, ecc), mentre l’uomo che mi sta davanti è già l’unificazione elaborata dall’intelletto di tali dati sensibili. Ecco dunque che per Kant l’intelletto può tanto unificare dati sensibili (per darmi l’uomo che mi sta davanti) quanto concetti (i vari uomini che ho visto per darmi il concetto generale di uomo). Accanto ai concetti empirici vi sono i concetti puri , che Kant chiama anche ‘categorie’ o ‘forme dell’intelletto’: essi sono le forme attraverso le quali unifichiamo i dati della sensibilità. Così come le intuizioni sono i filtri attraverso i quali filtriamo passivamente i dati sensibili, le categorie sono ‘scatole vuote’ in cui unifichiamo i dati arrivati all’intelletto attraverso il filtraggio passivo delle intuizioni. La categoria di sostanza sarà quella forma dell’intelletto in cui unifico i singoli dati sensibili per ottenere il libro che fenomenicamente mi sta davanti; lo stesso valga per la categoria della causalità. Dunque, con lo spazio e col tempo i dati sensibili venivano passivamente ricevuti, con le categorie vengono invece unificati : se spazio e tempo erano filtri passivi, le categorie (o ‘concetti puri’) sono delle ‘funzioni’, degli strumenti con cui l’intelletto lavora: anzi, esso non è altro che l’insieme delle categorie. Sì, perchè l’intelletto unifica i dati in tanti modi e ciascuno di essi è proprio una delle 12 categorie. Interessante è poi il termine ‘categoria’, che Kant (come con i termini ‘analitica’ e ‘dialettica’) mutua da Aristotele, pur cambiandone il significato: lo Stagirita illustrava le categorie e le loro funzioni sia nella Metafisica sia nella Logica, in quanto convinto che le strutture della realtà e del pensiero fossero identiche (forse proprio perchè il nostro intelletto fa comunque parte della realtà ed è soggetto alle sue leggi); Aristotele spiegava, infatti, il principio di non-contraddizione spiegando ora che non è possibile che la stessa cosa abbia due caratteristiche contradditorie, ora che non è possibile che il pensiero predichi contemporaneamente due cose opposte, sottolineando appunto l’identità tra strutture dell’intelletto e della realtà. Ecco allora che per lui le 10 categorie erano i 10 modi fondamentali dell’essere, ma anche i 10 modi fondamentali di predicare l’essere, di dire che qualcosa è (il termine ‘categoria’, del resto, vuol proprio dire ‘predicato’). Ora, Kant è pienamente d’accordo con Aristotele sul fatto che le strutture della nostra mente coincidano con quelle della realtà , ma, a differenza dello Stagirita, lo dimostra razionalmente, servendosi sempre dell’inversione di rapporti creata dalla rivoluzione copernicana. Il mondo fenomenico che noi conosciamo, spiega Kant, è costruito da noi attraverso il nostro pensiero (tramite le categorie), ed è dunque ovvio che le leggi del nostro pensiero saranno le stesse che governano il mondo. Le 12 categorie che determinano le leggi del nostro pensiero passano così a determinare anche le leggi del mondo fenomenico: esse diventano dunque al tempo stesso strutture fondamentali del nostro pensiero e della realtà (fenomenica). Ecco dunque che la categoria di sostanza è una forma (un ‘concetto puro’, a priori, che sta prima dell’esperienza) della mia mente, ma nel mondo fenomenico vi sono sostanze. A questo punto, Kant introduce due forme di deduzione delle categorie, la ‘deduzione metafisica’ (una sorta di rassegna delle categorie) e la ‘deduzione trascendentale’ (una sorta di discussione delle categorie). Non bisogna farsi trarre in inganno dalla parola ‘deduzione’: se nella ‘deduzione metafisica delle categorie’ riveste il significato più ovvio e più familiare di derivazione di dati di fatto da altri dati di fatto, essa viene invece ad assumere, nella ‘deduzione trascendentale delle categorie’, un significato desueto, di stampo giudiziario: la deduzione trascendentale è cioè la dimostrazione non di un fatto ( quid facti ), ma della legittimità di un fatto ( quid juris ). Non c’è nulla da dimostrare sul fatto che io applico le categorie (le forme dell’intelletto) al materiale sensibile, è ovvio: se vedo la sostanza libro davanti a me è proprio in virtù dell’unificazione dei dati sensibili attraverso le categorie; occorre piuttosto dimostrare se sia un’azione legittima o meno. Ed ecco dunque che affiora la domanda centrale della Critica della ragion pura : la nostra conoscenza ha un valore o è una grande illusione? L’applicazione delle forme mentali (categorie) alla realtà è legittima o no? La ragione è chiamata a giudizio a difendere la propria attività. Nel dimostrare come e perchè è legittimo l’uso delle categorie nell’ambito dell’esperienza, Kant dimostrerà anche, implicitamente, che l’applicazione di tali categorie al di là dell’esperienza è illegittima. E così Kant, dopo aver in precedenza spiegato che è possibile una ‘matematica pura’ tramite la formulazione di giudizi sintetici a priori, risponde positivamente alla domanda ‘come è possibile una fisica pura?’ : la scienza newtoniana è applicabile alla realtà ed è assolutamente certa perchè le leggi del nostro pensiero sono le stesse che governano la realtà . Tuttavia Kant risponde negativamente alla domanda ‘è possibile una metafisica pura?’ : le categorie, pur essendo a priori (non derivandoci cioè dall’esperienza) non sono applicabili al di là di essa: ne consegue che una metafisica pura è inattuabile. Detto questo, Kant dà per scontato che le forme dell’intelletto, in quanto funzioni unificatrici, ci permettano di esprimere giudizi, ossia di formulare proposizioni: i giudizi, infatti, non sono altro che un atto di unificazione. Quando dico ‘la penna è sul tavolo’, ho unificato con l’intelletto la sostanza penna e il fatto di essere sul tavolo. Dunque in ogni giudizio entra in gioco, tramite le categorie, l’intelletto. Ora Kant ritiene che le categorie in azione nei giudizi siano le stesse che costituiscono gli oggetti, quasi come se le categorie agissero in due modi diversi: se dico ‘l’uomo è un animale’, è chiaro che sto facendo una predicazione relativamente alla sostanza ‘uomo’; però la categoria di sostanza entra in gioco anche nel costituire il singolo oggetto, il libro ad esempio, dato dall’unificazione dei dati sensibili. In altre parole, per Kant ogni categoria ha due ruoli, uno di tipo trascendentale (della categoria di sostanza sarà il costituire il libro come oggetto), l’altro di tipo logico (della categoria di sostanza sarà il cosituire i giudizi di sostanza , come ‘l’uomo è un animale’). Siccome le categorie hanno due ruoli distinti, ne deriva che se mi pongo la domanda ‘quali e quante sono le categorie’, per rispondere basterà individuare i tipi di giudizio: e ad ogni tipo di giudizio corrisponderà, ovviamente, una determinata categoria. Per ogni modalità di giudizio ci sarà una categoria : ecco che questa è la deduzione metafisica delle categorie. Ci sarà dunque una tavola avente 12 giudizi, affiancata da un’altra avente 12 categorie.
TAVOLA DEI GIUDIZI:
1 ) QUANTITA’ : universali , particolari , singolari
2 ) QUALITA’ : affermativi , negativi , infiniti
3 ) RELAZIONE : categorici , ipotetici , disgiuntivi
4 ) MODALITA’ : problematici , assertori , apodittici
TAVOLA DELLE CATEGORIE:
1 ) QUANTITA’ : unità , pluralità , particolarità
2 ) QUALITA’ : realtà , negazione , limitazione
3 ) RELAZIONE : inerenza e sussistenza ( substantia et accidens ) , causalità e dipendenza ( causa ed effetto ) , comunanza ( azione reciproca tra agente e paziente )
4 ) MODALITA’ : possibilità-impossibilità , esistenza-inesistenza , necessità-contingenza
Ma perchè sono divisi in 4 gruppi? Ad ogni tipo di giudizio corrisponde una categoria, abbiam detto, dunque dovrebbero essere 12 gruppi, e non 4. In realtà, ogni giudizio appartiene non ad una tipologia di giudizio, ma a 4 tipologie di giudizio; ogni giudizio avrà dunque la sua caratteristica relativa, rispettivamente, alla quantità, alla qualità, alla relazione e alla modalità. Ogni singolo giudizio appartiene contemporaneamente a 4 tipologie diverse a seconda se lo guardiamo dal punto di vista della quantità, della qualità, della relazione o della modalità. In concreto, vuol dire che il singolo giudizio ‘l’uomo è un animale’ rispetto alla categoria della quantità è un giudizio universale (tutti gli uomini sono animali, non alcuni), sotto la categoria della qualità è affermativo (mi dice cosa è, non cosa non è), sotto la categoria della relazione non è ipotetico o disgiuntivo (non mi dice ‘l’uomo o è questo o è quell’altro’). Ogni giudizio avrà dunque 4 caratteristiche che lo definiscono. Le categorie sono in azione nei giudizi: in essi l’intelletto unifica appunto grazie alle categorie. Per chiarire in che senso i giudizi contengano le categorie, è opportuno soffermare l’attenzione sui Prolegomeni : in essi Kant distingue tra giudizi di sensibilità e giudizi empirico-oggettivi . Prendendo in mano una penna e dicendo che in questo momento ho una serie di percezioni (colore, forma, ecc) e che contemporaneamente ho anche la sensazione di peso, mi trovo di fronte ad un giudizio di sensibilità; ho davanti a me due gruppi di percezione (la forma, il colore, ecc da una parte, e il peso, dall’altra) e li percepisco contemporaneamente. Se invece dico che la penna è pesante, le cose cambiano: mi trovo di fronte ad un giudizio empirico-oggettivo. Certo, il ‘materiale’ rimane lo stesso, perchè appunto i dati sono gli stessi (l’insieme di percezioni che danno la penna più l’insieme di quelle che danno il peso); tuttavia diversa è la forma. Nel primo caso (giudizio di sensibilità) sto facendo affermazioni su di me, soggettive (sono io che percepisco questo e quest’altro), che non riguardano gli altri; nel secondo caso (giudizio empirico-oggettivo), invece, vi è un carattere oggettivo, in quanto il riferimento è alla penna (e non al soggetto) e riguarda oggettivamente tutti (la penna è infatti pesante per tutti). Dunque, pur essendo identica la materia, cambia la forma del giudizio; e questo cambiamento è dovuto al fatto che in un giudizio è presente la categoria, nell’altro no. Infatti, dire che la penna è pesante è un giudizio di categoria sotto la forma ‘substantia et accidens’ (mi dice che la penna è e ne predica la pesantezza), mentre dire che io percepisco il colore e la forma e poi la pesantezza è un giudizio che esula dall’oggettività, proprio perchè sganciato dalle categorie. Sono le categorie stesse, infatti, proprio perchè presenti a priori nella mente di tutti, che trasformano in oggettivo quel che è soggettivo. E, venendo al dunque, la deduzione metafisica è proprio una sottrazione in cui ad un giudizio oggettivo-empirico sottraggo i dati sensibili (giudizio di sensibilità), ottenendo così la categoria . Ritorniamo all’esempio della penna: al giudizio ‘la penna è pesante’ sottraggo i dati sensibili (il colore, la forma, ecc) ed ottengo la categoria di sostanza. In molti casi la terza categoria è una sintesi delle prime due: prendiamo il caso del 2° gruppo, delle qualità dei giudizi; i giudizi possono essere affermativi (è una penna), negativi (non è una penna) e infiniti (questa è una non-penna). Il caso infinito, è evidente, è una sorta di sintesi degli altri due, in quanto esclude una possibilità (non è una penna) e ne lascia aperte altre (potrebbe essere un libro o un quaderno). E così Kant può finalmente chiarire le questioni lasciate aperte da Hume: le categorie non sono traibili dall’esperienza, ma ne sono le condizioni a priori; non potrò mai dedurre la categoria di causalità dal fatto che messa la mano sul fuoco, esso ha causato bruciore alla mia mano, perchè sarà sempre smentibile da una nuova esperienza; tuttavia capisco che il fuoco causa bruciore alla mia mano proprio in virtù della categoria di causalità insita a-prioristicamente nella mia testa. Dunque la fisica newtoniana è possibile proprio perchè la si costruisce all’interno delle forme a priori e nessuna conoscenza potrà mai realizzarsi se non inquadrata in quelle forme. Siamo infatti noi che diamo la forma al materiale ricevuto passivamente dai sensi e tale forma sarà valida oggettivamente, ovvero per tutti, perchè tutti abbiamo tali forme. Detto questo, però, Kant deve ancora spiegare come siano possibili ‘giudizi sintetici a priori’: con la deduzione metafisica, Kant ne ha in parte dato una spiegazione, illustrando come essi non diano un sapere tautologico (e quindi non siano analitici, bensì sintetici), ma arricchente (come quando faccio un esperimento, non so esattamente che risultato avrò, ma so che un risultato ci dovrà essere), e come siano a priori, cioè puri, oggettivi, universali e necessari, a monte dell’esperienza. Ora, dopo aver illustrato come siano possibili e come di fatto noi li utilizziamo, Kant deve però spiegare se essi siano legittimi: ed è proprio quello che fa con la deduzione trascendentale delle categorie . Ai dati di fatto dell’esperienza noi applichiamo le categorie: le applichiamo anche nel più banale giudizio che formuliamo. Ma è una cosa legittima? Siamo autorizzati o agendo in tal modo deformiamo la realtà? La posta in gioco è alta: conoscenze acquisite in migliaia di anni potrebbero andare in fumo se risultasse un’azione illegittima l’applicazione delle categorie. Kant chiarisce subito che la deduzione, ovvero il processo per verificare la legittimità, non era necessario nel caso dello spazio e del tempo perchè si trattava di una ricezione passiva di dati sensibili, in cui non si poteva scegliere se applicare o meno lo spazio e il tempo come forme a priori; si era costretti ad applicarli e non si poteva fare diversamente. Con le categorie, siamo invece di fronte ad un’attività unificatrice dell’intelletto sull’esperienza, e occorre dunque capire se sia lecito o meno agire in tal modo. Kant spiega però che se arriveremo a dimostrare che, così come non è necessaria la deduzione per lo spazio e per il tempo (proprio perchè non si danno percezioni se non nello spazio e nel tempo), anche per quel che riguarda l’intelletto, se i dati sensibili ci vengono dati direttamente nell’intelletto, il gioco è fatto. Certo, almeno in apparenza, sembra proprio che il dato sensibile non ci sia dato nelle categorie, nel pensiero, ma nei sensi: il pensiero sembra essere un qualcosa che si aggiunge dopo e opera sui dati sensibili unificandoli. Ma Kant riesce a dimostrare che quanto detto per spazio e tempo è valido anche per il pensiero: i dati sensibili non possono esserci dati se non nel pensiero . L’essere inquadrati dal pensiero fa infatti parte dello stesso dato sensibile, spiegherà Kant, e non ha dunque senso chiedersi se sia un’azione legittima l’applicazione delle categorie, proprio perchè è inevitabile. Dimostrato questo, si sarà risolto il problema. Ma, come sappiamo, per Kant non c’è vera conoscenza se prima dell’attività intellettuale non vi è la raccolta dati sensibili; quanto detto, diventa ora il simmetrico: non ci può essere raccolta dei dati sensibili se non c’è il pensiero, nel senso che ogni dato sensibile è già inquadrato nel pensiero , il quale non interviene in un secondo tempo, come Kant sosteneva prima. Riuscendo a dimostrare che i dati sensibili sono sempre già inquadrati dal pensiero, si cadrà dunque in un caso del tutto analogo a quello dello spazio e del tempo. Nell’impostare quest’ardua dimostrazione, Kant introduce il concetto di Io penso , centrale nella sua filosofia: avrebbe potuto chiamarlo ‘Io’ o ‘Pensiero’, ma preferisce l’espressione ‘io penso’, e spiegheremo perchè. Ora, l’Io penso è la funzione del pensare e, in quanto tale, è la funzione unificatrice (pensare = unificare). Kant si chiede: dico che i dati della sensibilità ci son dati passivamente e poi, in un secondo tempo, interviene l’intelletto ad unificarli; ma appena ci son dati (prima che intervenga l’intelletto ad unificare), non può esservi già una forma di unità? Quando sono davanti alla penna, prima che intervenga la categoria di sostanza dico che percepisco il colore, la forma, ecc e insieme la pesantezza, ma non vi è ancora una forma di unità? Certo che c’è, fa notare Kant; un elemento di unità c’è per forza, e sono io soggetto che ho i due gruppi di percezioni. Ancor prima che entri in gioco l’intelletto ad unificare, i dati sensibili hanno già una sorta di unità per il fatto di essere l’insieme dei dati sensibili da me percepiti : essi sono ricondotti ad un unico orizzonte, sono i dati che percepisco io. Del resto, se non fossero in qualche modo unificati, non potrei nemmeno dire che sono i dati delle mie percezioni. Hume aveva fatto notare che l’Io non è altro che un fascio di percezioni, e che se svuotassimo la testa di ogni contenuto non resterebbe più nulla: per il pensatore scozzese, infatti, non siamo ‘cose che pensano’, soggetti che pensano altre cose, ma siamo esclusivamente questi pensieri unificati in un fascio. Kant riprende il ragionamento humeano e si accorge che se è vero che siamo un fascio di percezioni, è anche vero che ci deve essere un qualcosa che tiene insieme tale fascio, proprio come in una fascina i legni son tenuti insieme dalla fascina appunto. Dunque le nostre percezioni, ancor prima che su di esse lavori l’intelletto con le sue categorie, sono ricondotte ad un unico orizzonte. Bisogna pertanto ammettere che esista qualcosa che fa sì che tale orizzonte esista, così come ci deve essere qualcosa che tiene insieme la fascina di legni per evitare che essi si disperdano. D’altronde, se ricevessimo le percezioni in modo ‘rapsodico’, come dice Kant, non potremmo a rigore nemmeno dire che sono nostre percezioni, perchè dire che sono nostre implica che siano già ricondotte ad un unico orizzonte. Ci deve dunque essere un qualcosa che costituisca tale orizzonte che unifica; se è vero che pensare è unificare, è allora altrettanto vero che unificare è pensare. A tenere insieme le nostre percezioni è dunque il pensiero, il lavoro del nostro intelletto e delle sue categorie. Il pensiero è dunque già in azione nei dati della sensibilità. E’ quindi legittimo l’uso delle categorie? Sì, perchè il dato sensibile ci viene già dato inquadrato dall’intelletto, e di conseguenza non possiamo fare a meno di applicare le categorie, il che vuol dire che l’uso di esse è per forza legittimo. Già, perchè le nostre percezioni sono da noi sentite come nostre, inquadrate in un unico orizzonte, il che implica che ci debba essere un qualche elemento di unità e, come Kant ha più volte spiegato, a conferire unità alla conoscenza è sempre e soltanto l’intelletto, il quale si trova ad operare sui dati sensibili immediatamente, nel momento stesso in cui ci vengono forniti. Il punto fondamentale del ragionamento kantiano è che le nostre sensazioni, anche le più disparate, sono già un dato unitario, allora in esse opera fin dall’inizio l’intelletto, il solo capace di dare unità, e ne consegue che l’uso delle categorie è legittimo proprio perchè non si potrebbe non applicarle, così come legittimi sono lo spazio e il tempo. L’unità primordiale che mi consente di dire che tutte le percezioni che ho sono mie, radunate sotto un unico orizzonte, Kant la definisce unità qualitativa , proprio per distinguerla dalla categoria di unità: Kant sta infatti parlando non già dell’unità conferita dalla categoria, bensì di quella propria delle sensazioni, forniteci inevitabilmente inquadrate dall’intelletto, ed è per questo che la definisce ‘qualitativa’. E così Kant risolve il problema della deduzione trascendentale delle categorie, facendo venir meno la netta distinzione tra sensibilità e intellettualità e spiegando che, propriamente, la sensibilità la riceviamo già inquadrata dall’intelletto, mai da sola, quasi come se il pensiero fosse già intrinseco ai dati sensibili che riceviamo (fenomenicamente). Tuttavia, con l’argomentazione poc’anzi esposta, Kant risponde anche ad un’altra domanda, forse anche più importante della precedente: infatti, dimostrando che l’applicazione delle categorie è legittima ai dati della sensibilità, Kant dimostra anche il simmetrico, ovvero che tale applicazione è illegittima al di là dei dati dell’esperienza . Sì, perchè con la complessa argomentazione con cui ha spiegato che il pensiero nella sensibilità è già, per così dire, a casa sua, e che le categorie sono applicabili alla sensibilità proprio perchè i dati sensibili ci vengono forniti già inquadrati dall’intelletto, Kant ha spiegato che il contrario non può essere: le categorie sono applicabili al mondo sensibile, ma non al di là di esso. Le categorie, pur essendo concetti puri caratterizzati da assoluta a-priorità, sono talmente legate alla sensibilità, che non appena si sganciano da essa e vanno oltre divengono inapplicabili. L’applicazione delle categorie al di là dell’esperienza è illegittima, ma ciò non toglie che l’uomo le abbia indebitamente applicate per secoli al di là dell’esperienza: il caso più clamoroso è quello della dimostrazione di Dio effettuata da Aristotele. Lo Stagirita aveva giustamente notato che ogni cosa è stata causata da un’altra, però, ad un certo punto, usciva dalla sfera dell’esperienza per trovare in Dio la causa ultima di tutte le cose, apllicando la categoria di causalità al di là dell’esperienza. Tutta la Dialettica trascendentale sarà proprio dedicata alla dimostrazione di questo errore che si protrae da secoli e che è innato nell’uomo: Kant addurrà diversi esempi di indebita applicazione meta-empirica delle categorie. Sempre nella Dialettica trascendentale, però, Kant tratta anche la questione dell’ Io penso , quello che può essere considerato l’attore del processo di unificazione (unità qualitativa) dei dati sensibili. E’ opportuno spendere due parole sul perchè Kant lo chiami ‘io penso’, ricorrendo ad un verbo, anzichè limitarsi a chiamarlo ‘io’, con un sostantivo, come aveva fatto Cartesio. Il motivo è molto semplice ed è strettamente connesso all’inapplicabilità delle categorie ad una sfera meta-empirica. L’io penso, quello che è l’attore dell’unificazione qualitativa e che rende legittima l’applicabilità delle categorie, per definizione non può essere anche oggetto di unificazione: dire che l’Io penso, infatti, è il soggetto di un’attività di pensiero e di unificazione e, proprio per questo motivo, non può anche essere oggetto di tale unificazione, proprio come l’occhio, che vede tutto ciò che gli sta attorno, non può vedere se stesso. L’Io penso unifica tutto, ma non può applicare la sua attività categoriale a se stesso; il che porta Kant a negare l’applicabilità delle categorie al soggetto pensante e, in particolare, della categoria di sostanza. Non siamo dunque autorizzati a parlare del soggetto come di una ‘sostanza’, come invece aveva fatto Cartesio trasformando la funzione del pensare in una cosa (‘la cosa pensante’). Come si fa, del resto, a trasformare una funzione in una cosa? E’ assolutamente illegittimo; ne consegue che la funzione del pensare non è una sostanza e che, dunque, il soggetto non è una ‘cosa pensante’. Siamo di fronte ad una situazione paradossale, in cui al dualismo noumeno-fenomeno si aggiunge un nuovo elemento, l’Io penso. Infatti, potrò parlare di me stesso come fenomeno: Locke ci ha insegnato che esistono un senso esterno (lo spazio) e uno interno (il tempo) e che nel tempo percepiamo una serie di fenomeni interni, quelli che Cartesio attribuiva alla ‘cosa pensante’ (pensieri, volizioni, ecc) e come dati della sensibilità possono essere oggetti delle categorie, anche di quella di sostanza. Però questo processo è valido solo ed esclusivamente a livello fenomenico: è dunque legittimo parlare di una ‘cosa pensante’ che fa una serie di cose (pensa, percepisce, ecc) nell’ambito di un’unità, l’io fenomenico. Ed ecco che quindi noi siamo fenomeni di noi stessi, non ci vediamo come siamo realmente, ma come appariamo a noi stessi , come insieme di percezioni, pensieri, ecc unificati in un io. Non può dunque essere vero che quando ci rivolgiamo a noi stessi operiamo in un campo sicuro ed assolutamente certo, come credeva Agostino e la tradizione cristiana a lui successiva. Non conosciamo la nostra essenza, non ci conosciamo noumenicamente, ma solo come appariamo a noi stessi, ovvero fenomenicamente: ci arrivano i dati sensibili dall’esterno, li unifichiamo ed elaboriamo l’idea di spirito e di anima come unione di queste percezioni. Certo, a monte c’è la cosa in sè, il noumeno, ed abbiamo una nostra essenza ben definita che, paradossalmente, ci resta oscura, ma da cui deriva, in qualche misura, ciò che di noi conosciamo. All’io noumenico e all’io fenomenico si aggiunge poi l’ Io penso , qualcosa di molto diverso dagli altri due. Non è fenomenico perchè l’io fenomenico è il risultato dell’unificazione di percezioni e l’Io penso è soggetto della funzione del pensare, ma non oggetto, unifica senza essere unificato; e non è noumenico perchè non è la cosa in sè. Anzi, a rigore, sia l’io fenomenico sia l’io noumenico sono due cose (cosa in sè e cosa come appare), mentre l’Io penso no, è una funzione, è la funzione dell’unificare le percezioni sensibili che riceviamo, e ridurlo a ‘cosa’ vorrebbe dire incappare nell’errore commesso da Cartesio. Detto questo, è bene specificare che le singole categorie sono anch’esse funzioni, sono attive, sono i diversi modi di unificazione di cui dispone l’intelletto: più precisamente, l’Io penso non è altro che l’insieme delle funzioni categoriali . Ciascuna delle diverse maniere di unificazione dell’Io penso è una categoria. Ma, fa notare Kant, una cosa per essere conosciuta deve essere pensata e percepita; l’Io penso in sè è pensabile, sì, ma non percepibile, perchè non è materiale sensibile; ne consegue, dunque, che esso non è conoscibile. Riprendendo la tradizione leibniziana, Kant chiama anche l’Io penso ‘ appercezione trascendentale ‘ in quanto esso trasforma le percezioni passive in appercezioni, ovvero percezioni dotate di autocoscienza, percezioni che sappiamo essere nostre. La Logica trascendentale (in cui rientra tutto il discorso sulle categorie finora condotto) si divide in Analitica dei concetti (categorie) e dei princìpi (i giudizi sul mondo derivati dall’applicazione delle categorie, ovvero la fisica pura). Illustrata l’analitica dei concetti, Kant, prima di passare a quella dei princìpi, introduce lo schematismo trascendentale in cui si descrivono gli schemi trascendentali puri. Esso riguarda non l’applicabilità delle categorie, ma la loro concreta applicazione. Essendo le categorie differenti dai dati sensibili, come è possibile che concretamente si possano applicare le singole categorie ai dati della sensibilità? Cosa è che mi permette di applicare la categoria di causalità ad una determinata situazione empirica? Occorre trovare un qualcosa che faccia fronte all’eterogeneità tra categorie e sensibilità e Kant lo trova ipotizzando l’esistenza di una facoltà intermedia, un terreno comune a categorie e sensibilità, e la chiama immaginazione , intesa come la facoltà di produrre ‘immagini’, schemi intermedi tra categorie e sensibilità (cioè trascendentali appunto) . Gli ‘schemi trascendentali’, frutto dell’immaginazione, sono determinazioni del tempo secondo regole: ecco che Kant, quel qualcosa di intermedio che stava cercando, l’ha trovato nell’individuazione delle condizioni temporali di una determinata situazione empirica che consentano l’applicabilità di una categoria anzichè un’altra. ‘ Lo schema della categoria di causalità è la successione nel tempo ‘, dice Kant: applico concretamente la categoria di causalità quando mi trovo davanti ad una successione nel tempo di determinati fenomeni. Quando, nel tempo, ho messo la mano sul fuoco e mi sono bruciato ogni volta che la mettevo, ecco che ho applicato la categoria di causalità. Allo stesso modo, ‘ lo schema della categoria di sostanza è la permanenza nel tempo ‘. Kant trova dunque qualcosa di omogeneo, che vada bene sia alle categorie sia alla sensibilità, proprio perchè lo schema è una regola di applicazione delle specifiche categorie (e in quanto regola è omogeneo all’intelletto, poichè la regola sussume sotto di sè i casi particolari) e il criterio di tale regola sono le situazioni temporali (e il tempo è omogeneo alla sensibilità, ne è una forma), la successione per la causa e la permanenza per la sostanza. Si tratta dunque di una ‘regola’ che sussume sotto di sè i casi particolari e che costruisco in base alle situazioni temporali. E’ da notare che torna anche qui a manifestarsi la superiorità del tempo sullo spazio, sulla quale peraltro Kant aveva già insistito: è nel tempo che si costruisce la regola. A ben pensarci, però, questo discorso sembra del tutto analogo a quello di Hume: in effetti, per molti aspetti è simile, ma si differenzia per molti altri. Mentre per Hume la sostanza era la permanenza nel tempo, per Kant la permanenza è la condizione temporale per l’applicabilità della categoria di sostanza; lo stesso per la successione nel tempo. Causalità e sostanza, per Kant, restano concetti a priori, nei quali inquadriamo i dati dell’esperienza. Per Hume la causalità e la sostanza erano a posteriori, derivabili solo dall’esperienza, e, in quanto tali, non erano oggettive, ma sempre smentibili da una nuova esperienza. Per Kant causalità e sostanza sono concetti puri, a priori; non c’è solo la successione e la permanenza nel tempo, è una categoria a priori. La causalità la applicherò non a qualsiasi situazione empirica, ma solo in presenza di regolare successione temporale. L’oggettività garantita dall’a-priorità, è bene ricordarlo, è meramente fenomenica, sganciata dall’ambito noumenico. Passiamo ora ad esaminare l’ Analitica trascendentale dei princìpi : essa rappresenta la conclusione della prima parte della Critica della ragion pura , quella che è solitamente definita ‘parte costruttiva’, incentrata sulla spiegazione di come l’intelletto conosca legittimamente la realtà fenomenica. La seconda parte ruota invece attorno alla Dialettica trascendentale ed è generalmente nota come ‘parte distruttiva’, in quanto in essa Kant indica cosa non si deve fare. La soluzione cui Kant perviene nell’Analitica dei princìpi è la celebre rivoluzione copernicana, di cui già abbiamo parlato: le leggi della natura altro non sono che le leggi del nostro pensier, dal momento che è esso stesso a costruire la realtà fenomenica secondo le sue leggi. Non è dunque l’oggetto che modifica il soggetto, ma viceversa. E’ il pensiero che costruisce con l’ Io penso , unificando la realtà. Le verità a priori che l’intelletto rinviene nella natura sono sempre e solo, dunque, quelle che lui stesso ha messo in essa: l’intelletto assurge così a vero e proprio legislatore della natura. E i princìpi che danno il nome all’Analitica altro non sono che le leggi generalissime della natura: non già le leggi empiriche (traibili dall’esperienza) come le leggi dei gas, bensì le leggi generali a priori che il nostro intelletto pone alla realtà. Tali leggi generali, proprio perchè a priori, stanno a monte dell’esperienza: ad esempio, ancor prima di effettuare esperienze concrete, saprò già che avrò dei rapporti di causa-effetto (legge generalissima) e sarà l’esperienza a dirmi effettivamente a quella data causa quale effetto seguirà. E la fisica pura sulla quale Kant indaga è proprio l’insieme di questi princìpi puri, o leggi generalissime che dir si voglia. Come già accennavamo, Kant ammette la possibilità di una metafisica, se per metafisica intendiamo un’ontologia generale delle leggi che reggono la realtà: la metafisica in questa accezione è possibile e si identifica con lo studio di questi princìpi generalissimi che presiedono all’andamento della realtà. Kant distribuisce questi princìpi in 4 gruppi, proprio perchè 4 sono i gruppi delle categorie: i princìpi, infatti, spiega Kant, derivano in qualche modo dalle categorie. Il primo gruppo dei princìpi è dato dagli assiomi dell’intuizione : hanno come princìpio che ‘ tutte le intuizioni sono quantità estensive ‘. Sono ‘assiomi’ nel senso che sono dati a priori e riguardano le intuizioni, ovvero le percezioni sensibili. Qualsiasi intuizione noi abbiamo, nota Kant, avrà sempre una quantità, una grandezza. Questo gruppo di princìpi, quindi, deriva direttamente dalla 1° categoria, quella di quantità. Tali assiomi, in poche parole, ci dicono questo: pur non sapendo esattamente a quali grandezze ci troveremo di fronte, noi sappiamo già a-prioristicamente che nel fare esperienze nel mondo ci imbatteremo in grandezze; sarà poi l’esperienza a dirci quali saranno di preciso tali grandezze. Il secondo gruppo di princìpi è dato dalle anticipazioni della percezione , che poggiano sul presupposto che ‘ in tutti i fenomeni il reale che è oggetto della sensazione ha una qualità intensiva, cioè un grado ‘. Queste ‘anticipazioni’ ci dicono anticipatamente cose sulle percezioni prima ancora di avere tali percezioni. So già in anticipo, dunque, che tutti i fenomeni (oltre alla ‘quantità estensiva’ degli assiomi dell’intuizione) avranno, paradossalmente, una quantità relativa alla qualità: una sensazione di colore, infatti, pur essendo una qualità, sarà più o meno intensa, ovvero la sua qualità sarà suscettibile di una ‘quantità’, di un grado più o meno intenso. Pur non sapendo di preciso quali intensità avrò nelle esperienze, saprò già a-prioristicamente che qualche grado ce l’avrò: sarà poi l’esperienza concreta a dirmi esattamente come saranno tali ‘gradi’. Il terzo gruppo è dato dalle analogie dell’esperienza , il cui principio generale è ‘ l’esperienza è possibile solo mediante una rappresentazione di una connessione necessaria delle percezioni . Sappiamo a priori che vi sono leggi rigorose della natura, poichè essa non è che l’insieme delle leggi del nostro pensiero, le quali (in quanto a priori) sono oggettive e necessarie, dunque rigorose. Le leggi specifiche, poi, sarà l’esperienza a darcele, andando a riempire coi dati sensibili gli schemi a priori. In altri termini, l’esperienza del mondo è possibile solo in quanto esso si configura come un insieme di leggi necessarie. A questo punto, Kant risponde ad una domanda fondamentale, sulla quale il mondo filosofico si era sempre interrogato: dai Presocratici in poi si era data per scontata l’esistenza di un principio della realtà, sebbene nessuno fosse stato in grado di dimostrarlo razionalmente. Kant dice che non c’è bisogno alcuno di dare una dimostrazione empirica di tale principio proprio perchè esso non deriva dall’esperienza, ma dalle leggi del pensiero da noi imposte alla natura. Il ‘principio’ (che si basava poi sull’idea che nulla si crea, nulla si distrugge e tutto si trasforma) è semplicemente una legge di funzionamento del nostro pensiero, non esiste nella realtà noumenica, nel mondo come è in sè. Il quarto gruppo, infine, è dato dai postulati del pensiero empirico in generale : so a priori che qualunque cosa troverò nel mondo sarà o possibile (è possibile se inquadrabile negli schemi della nostra conoscenza) o reale (quando non solo è coerente con le leggi del nostro pensiero, ma è anche presente effettivamente nella realtà empirica, e non solo nel pensiero) o necessaria (se le condizioni dell’esperienza implicano quel determinato dato di fatto: se qualunque esperienza implica quel dato di fatto, allora esso è necessario). Sarà in altri termini necessaria se dimostrabile in base ad una legge universale della natura. A questo punto Kant distingue tra ‘ natura guardata da un punto di vista materiale ‘ ( natura materialiter spectata ), ovvero l’insieme delle cose che ci circondano, in ultima istanza l’intera realtà fenomenica, e ‘ natura guardata da un punto di vista formale ‘ ( natura formaliter spectata ): la natura vista ‘formalmente’ sta a monte di quella vista ‘materialmente’ (empiricamente) ed è la natura vista con le leggi generalissime del nostro pensiero . Queste leggi generalissime, spiega Kant, saranno giudizi sintetici a priori: ad esempio, il giudizio di causalità è a priori perchè assolutamente necessario e sintetico perchè il concetto di effetto non è già presente implicitamente nel concetto di causa, ma devo ‘costruirlo’. Per avere una fisica pura sono dunque necessari i giudizi sintetici a priori, dotati di assoluta rigorosità (sono a priori) e capaci di dare conoscenze nuove, non tautologiche (sono sintetici). Ed essi ci sono nella natura (fenomenica), poichè è il nostro stesso intelletto ad attribuirglieli: le leggi rigorose che governano il nostro pensiero le ritroviamo anche nella natura, il che rende possibile una fisica pura, assolutamente rigorosa. Dunque la natura guardata da un punto di vista formale, ovvero attraverso le leggi generalissime che regolano il mondo, non è altro che la fisica pura, che Kant ha dimostrato possibile. La natura guardata da un punto di vista materiale, invece, comprenderà sì le forme generalissime della realtà, ma, accanto ad esse, vi saranno anche i dati sensibili. Detto questo, possiamo passare all’analisi della Dialettica trascendentale : se l’Analitica trattava l’uso legittimo dell’intelletto nel mondo empirico, la Dialettica si occupa invece del suo uso illegittimo meta-empirico. ‘Dialettica’ è per Kant questo uso indebito dell’int dell’intelletto, mentre invece ‘dialettica trascendentale’ é l’analisi critica che egli fa della dialettica. L’intelletto come facoltà che mira a conoscere il finito Kant lo chiama ‘intelletto’ appunto, mentre la facolta dell’intelletto che punta a conoscere l’infinito, la totalità, la chiama ‘ragione’: si tratta dunque di usi diversi della stessa facoltà. L’intelletto riguarda una conoscenza finita e limitata all’esperienza (come ad esempio: da che causa deriva questo specifico effetto?), mentre la ragione è una vana pretesa di raggiungere l’infinito. Kant aveva costruito la deduzione metafisica delle categorie partendo dai giudizi, poichè ogni giudizio è dato dall’unione del predicato e del soggetto; ora, egli si pone il problema di tirar fuori le forme della conoscenza razionale, della ragione: accanto alle intuizioni pure (forme della sensibilità) e ai concetti puri (forme dell’intelletto) avremo ora anche le idee (forme della ragione). Le idee sono, in altri termini, i concetti puri della ragione e Kant dà loro il nome di idee ispirandosi a Platone. Come per Platone le idee erano per le cose sensibili modelli da imitare senza mai poter essere raggiunti, anche per Kant esse sono concetti di assoluta perfezione gnoseologica, proprio perchè implicano totalità (l’infinito). Tali concetti, spiega Kant, sono irraggiungibili dall’esperienza perchè essa non potrà mai ‘riempirli’ con i dati sensibili (come invece faceva con i concetti puri dell’intelletto) proprio perchè si tratta di concetti infiniti (ciò che è infinito non può essere ‘riempito’). L’esperienza, infatti, è sempre finita e non potrà dunque mai riempire concetti infiniti quali sono quelli della ragione. Tuttavia, se per Platone le idee erano concetti esistenti di per sè e legittimi, per Kant, al contrario, esse sono elaborazioni della mente umane alle quali non corrisponde mai pienamente l’esperienza sensibile. In definitiva, le idee sono il risultato dell’applicazione illegittima delle categorie al di là del mondo empirico . La conoscenza, infatti, è ‘percepire e pensare’, ma qui vado al di là, penso senza percepire, quindi non ho conoscenza. Come si tirano fuori queste idee? Come è la loro ‘deduzione metafisica’? Le idee saranno non 12 (come le categorie), ma 3, e Kant le tira fuori dalle tipologie dei sillogismi (e non dai giudizi, come aveva fatto per le categorie). Aristotele si era dedicato allo studio dei sillogismi categorici, quelli in cui le premesse erano categoriche (‘Socrate è uomo’: la premessa mi dice che una determinata cosa è così); gli Stoici avevano invece studiato i sillogismi ipotetici (se A, allora B) e disgiuntivi (o è A o è B); i giudizi ipotetici sono dunque quelli in cui la premessa è un giudizio ipotetico (se nevica, fa freddo; nevica, dunque fa freddo), i sillogismi disgiuntivi quelli in cui essa è un giudizio disgiuntivo. Kant li applica per tirar fuori le idee , muovendo dalla constatazione che mentre i giudizi si limitano a constatare il legame tra 2 fatti nella realtà e hanno carattere finito (se accendo il fuoco sotto la pentola, l’acqua in essa bolle), i sillogismi invece non danno nuova conoscenza, ma organizzano sistematicamente conoscenze già acquisite con i giudizi. Così, se i giudizi legano tra loro 2 fatti (predicato + soggetto), i sillogismi uniscono invece a 3 a 3 i giudizi: ogni sillogismo è infatti costituito da 2 giudizi (premesse) + 1 giudizio (conclusione). E ogni premessa di un sillogismo è considerabile come conclusione di un sillogismo: fin qui siamo di fronte ad un lavoro legittimo, fin tanto che i sillogismi si limitano a costruire una rete sempre più sistematica di giudizi. I sillogismi diventano invece illegittimi nel momento in cui vengono presi come strumenti di conoscenza: se ad esempio seguo la concatenazione causale nel mondo empirico e poi salto oltre (convinto che tutto sia effetto di una causa) e risalgo ad una causa incausata che causa tutto (Dio) sto effettuando un passaggio illegittimo; infatti non riorganizzo più conoscenze acquisite coi giudizi, ma ne costruisco di nuove. Questa pretesa illusoria della mente umana nasce dal fatto che le categorie sono trascendentali (non derivate dall’esperienza, ma applicabili solo e soltanto ad essa): la ragione sente che le categorie non nascono dall’esperienza e si illude pertanto di poterle applicare anche ad un terreno che non sia l’esperienza. Kant parla dunque di idee trascendentali, anche se forse è più corretto definirle trascendenti, perchè vanno oltre l’esperienza, nel vero senso della parola; Kant preferisce però chiamarle ‘trascendenti’ perchè in fondo, pur essendo concetti che vanno oltre il mondo fisico, sono pur sempre una forma di conoscenza: accanto ad un uso illegittimo, Kant ammetterà anche un uso legittimo delle idee. Dalle 3 tipologie di sillogismi, ciascuna delle quali rappresenta la pretesa di spingersi oltre unificando ulteriormente, deriveranno 3 idee trascendentali (anima, mondo e Dio) dalle quali, a sua volta, derivano le 3 pretese scienze su cui si era concentrato Wolff (psicologia razionale, cosmologia razionale e teologia razionale). Con la ragione, dunque, creiamo concetti infiniti (le idee) in modo del tutto illegittimo, perchè applichiamo le categorie metafisicamente, cercando di raggiungere la totalità infinita. Ci troviamo di fronte alla fallace pretesa di conoscere la totalità dei fenomeni: ma tale totalità, paradossalmente, non è più un fenomeno, poichè va al di là di quel che può essere frutto dell’esperienza; non essendo mai data la totalità dei fenomeni nell’esperienza, essa si colloca in un ambito meta-empirico, e non è più un fenomeno, bensì un noumeno. Così, per quanto strano possa sembrare, la totalità dei fenomeni è un noumeno. Ritornando ai sillogismi, quello categorico dà il concetto infinito di anima, quello ipotetico dà il concetto infinito del mondo e, infine, quello disgiuntivo dà il concetto infinito di Dio. Se applicassimo correttamente i sillogismi, non arriveremmo mai a tali concetti infiniti e la nostra conoscenza non ne ricaverebbe nulla di veramente nuovo, verrebbe solamente riorganizzata in modo sistematico; tuttavia siamo spinti per inclinazione naturale e per il fatto che le categorie sono trascendenti, a volerle applicare anche in una sfera metafisica, avvalendoci dell’apporto dei sillogismi come veri e propri mezzi per ampliare la nostra conoscenza, facendo con essi non più passaggi meramente logici, bensì passaggi illegittimi che esulano dall’esperienza. Esaminiamo a fondo ciascuno dei sillogismi: il primo è il sillogismo categorico , dato dall’unione di 3 giudizi categorici (e A e B) . Ogni giudizio categorico è costruito attraverso la predicazione di un attributo rispetto ad una sostanza: ‘Socrate è uomo’, ‘l’uomo è un animale’, ecc. In ciascun giudizio categorico, come abbiamo detto, c’è un termine che funge da soggetto e uno che funge da predicato, ma il predicato di quel dato giudizio può essere soggetto di un altro: ad esempio, nei due giudizi ‘l’uomo è un animale (predicato)’ e ‘ogni animale (soggetto) è un essere vivente’, la parola animale fa da predicato prima e da soggetto poi. C’è solo un caso in cui la cosa in questione può solo fungere da soggetto ed è il caso di quella che Aristotele chiamava ‘sostanza individuale’: Socrate, Gorgia, Anassagora, ecc. potranno sempre e soltanto essere soggetti di un giudizio, mai predicati. Potrò dire che ‘Socrate è uomo’, ma non potrò mai dire che ‘l’uomo (o qualsiasi altra cosa) è Socrate’. Tramite i sillogismi categorici risalgo la scala dei giudizi categorici e dovrei poter arrivare ad un soggetto che faccia, per così dire, da punto di partenza e che non possa essere predicato in nessuna proposizione: si arriva dunque, spiega Kant, ad un’idea (concetto puro della ragione) che sia soggetto senza essere predicabile di nessun altro giudizio. Tale idea è l’anima; e da essa deriva la presunta psicologia razionale, ovvero la pretesa di dire cose sull’anima. Stesso discorso vale per il sillogismo ipotetico , costruito con l’unione di 3 giudizi ipotetici: anche qui risalgo una scala (se A, allora B; se B, allora C; se C, allora D, ecc). Nella nostra esperienza creeremo effettivamente delle catene, magari anche parecchie, ma saranno pur sempre finite. Il salto meta-empirico lo si effettua invece passando ad esaminare la totalità della serie di cause ed effetti, pensando di poterla completare. E la totalità infinita dei rapporti di causa-effetto è proprio l’idea del mondo. Questa totalità infinita, però, non ci è mai data empiricamente, è il sillogismo che viene applicato in maniera meta-empirica e crea l’idea di mondo; da essa deriva la cosmologia razionale, ovvero la pretesa di dire cose sul mondo. Infine, abbiamo il sillogismo disgiuntivo , costruito coi giudizi disgiuntivi (o A o B): con tale sillogismo, scavalcando l’esperienza, potrei costruire il concetto di un qualcosa che abbia in sè tutte le possibilità positive. Ed è appunto in questo modo che nasce, secondo Kant (il quale qui riprende l’idea di coincidentia oppositorum ), l’idea di Dio, cioè ciò in cui tutte le alternative possibili possono stare insieme. Tale idea, però, è nettamente superiore rispetto alle due precedenti ed è per questo che Kant le attribuisce anche il titolo di ideale della ragion pura . A questo punto, Kant si sente in grado di affermare il teismo, ovvero il carattere di unitarietà e personalità di Dio (è uno ed è un Dio-persona): si tratta di un concetto a priori della mente umana. A livello logico, è evidente che nei concetti intensità ed estensione sono inversamente proporzionali: tanto più un concetto sarà ‘intenso’, ovvero ricco di dettagli, e tanto minore sarà l’ estensione, ovvero le cose sussunte da quel concetto. Il concetto di ‘vivente’ sussumerà sotto di sè un sacco di casi (uomini, animali, piante, ecc); se però aumento l’intensità dicendo ‘vivente razionale’, l’estensione dimuisce perchè non saranno più sussunti nel concetto di ‘animale razionale’ gli animali e le piante, ad esempio. Se accettiamo questo ragionamento, essendo Dio la sommatoria di tutte le alternative possibili, allora trattasi di un concetto infinitamente intenso; ma se un concetto più è intenso e meno è esteso, allora il concetto puro di Dio (che è intenso all’infinito) non può che sussumere un unico esemplare; dunque Dio è unitario. Dal momento che sussume sotto di sè anche intelligenza e pensiero, oltre all’infinità di altre qualità positive (essendo un concetto infinitamente intenso), allora Dio è un Dio-persona, perchè intelligenza e volontà sono caratteristiche che ineriscono ad una persona. Kant con questo ragionamento non ha dimostrato l’esistenza di Dio, ha solo lavorato intellettualmente sull’essenza. Illustrati i sillogismi, esaminiamo ora a fondo le tre idee che derivano dall’illegittimo uso che facciamo di essi. L’ idea di anima è data dalla presunta somma della totalità delle esperienze interne. Partendo dal fatto che abbiamo fenomeni interni ed essi sono attribuibili ad un’unica sostanza, perveniamo all’idea di anima. Si tratta di un’idea, perchè sta al di là dell’esperienza, non è quel che effettivamente percepiamo fenomenicamente, è in termini noumenici. Allo stesso modo, la somma della totalità dei fenomeni esterni è l’idea di mondo (idea perchè tale totalità non la cogliamo mai empiricamente, ma con uno slancio illegittimo dell’intelletto). L’idea di Dio, invece, è data dalla somma della totalità dei possibili oggetti immaginabili (fenomeni + noumeni). Tutte e 3 sono idee trascendentali, però Dio è anche ideale della ragion pura perchè è il punto di fuga di noumeni e fenomeni, è l’idea di un qualcosa cui tutta la realtà fa riferimento. E’ ‘ideale della ragion pura’ proprio perchè è ciò che si propone di studiare la ragione pura, sebbene esso giaccia al di là dell’esperienza. Ma, nel dettaglio, come nascono queste 3 idee? L’ idea di anima (ovvero l’idea di un io come sostanza) nasce, secondo Kant, da un paralogismo , ovvero da un sillogismo sbagliato. L’errore in questione è quello che Kant chiama, con un’espressione di forte sapore scolastico, quaternio terminorum (quaterna di termini). Il sillogismo è dotato di una premessa maggiore (con estremo + termine medio), di una premessa minore (con un altro estremo + termine medio) e una conclusione (1° estremo + 2° estremo). L’errore di cui parla Kant nasce quando si crede che il termine medio esista, ma in realtà non esiste, quando ad esempio chiamiamo con una stessa parola due cose diverse (per esempio la parola ‘pianta’). Nel caso dell’anima, la quaterna di termini sta nel fatto che la nostra mente inavvertitamente confonde il soggetto in senso gnoseologico con il soggetto in senso logico. L’espressione prima esaminata ‘Socrate è uomo’ presenta la sostanza individuale ‘Socrate’ che può essere solo soggetto. Kant riprende ora l’ Io penso : l’Io penso può essere solo soggetto (unifica senza essere unificato). L’errore che commettiamo sta in questo falso sillogismo (paralogismo): tutto ciò che è solo soggetto è sostanza, l’Io penso è solo soggetto, dunque l’Io penso è sostanza. L’origine dell’idea di anima, ovvero di ‘io come sostanza’, di sostanza cui ineriscono tutti i fenomeni interni, va ricercata in questa ipostatizzazione, cioè nella trasformazione in sostanza dell’ Io penso , che è in realtà solo una funzione (la funzione del pensare, appunto). Ecco dunque che, nel trasformare un’attività (il pensare) in una cosa (l’anima) commetto il paralogismo, ovvero il sillogismo illegittimo e sbagliato. L’errore nasce appunto dalla quaternio terminorum : ho usato la parola ‘soggetto’ in due diversi significati. Tutto ciò che è solo soggetto (grammaticalmente, cioè ciò che non è ‘predicato’) è sostanza, l’Io penso è soggetto (gnoseologicamente, cioè non ‘oggetto’: unifica come soggetto e non è oggetto dell’unificazione), dunque l’Io penso è sostanza. Così nasce l’idea di anima, dell’io come noumeno. Ammettere l’esistenza dell’anima come sostanza è premessa per una cosa importantissima: l’immortalità dell’anima. Essendo illegittimo parlare dell’anima come sostanza, allora sarà altrettanto illegittimo parlare razionalmente di immortalità di tale sostanza. Ciò non toglie che Kant fosse credente e che fosse convinto dell’immortalità dell’anima: dice solo che non la si può dimostrare. L’altra idea è l’ idea di mondo : a questo proposito, Kant imbandisce un discorso sulle antinomie della ragion pura. Le antinomie, egli spiega, sono 4 gruppi di affermazioni antitetiche, contradditorie fra loro, ma paradossalmente dimostrabili. Dunque, sia la tesi sia l’antitesi, sebbene siano contradditorie e tendano ad escludersi a vicenda, sembrano essere dimostrabili. La ragione cade dunque in una antinomia, poichè sembra poter dimostrare una cosa e anche il suo contrario. Le 4 coppie di affermazioni opposte (antinomie) sono le seguenti: 1)che il mondo sia finito oppure infinito nello spazio e nel tempo; 2) che esso consti di elementi ultimi oppure sia divisibile all’infinito; 3) che vi sia in esso una causalità libera oppure che tutto sia determinato in base a leggi naturali; 4) che esso dipenda da un essere necessario o che in esso tutto sia contingente. Va subito notato che le prime due antinomie sono diverse rispetto alle altre due, in quanto fanno riferimento a quantità (infinitezza/finitiezza e divisibilità all’infinito/divisibilità limitata), ovvero sono antinomie matematiche . Le ultime due, invece, illustrano il funzionamento del mondo (libertà/determinismo e necessità/contingenza) e prendono dunque il nome di antinomie dinamiche . Tale distinzione, tra matematiche e dinamiche, riguarda anche la soluzione del problema aperto dalle antinomie, ovvero la possibilità di dimostrare allo stesso tempo tesi e antitesi: nel caso delle matematiche, sia la tesi sia l’antitesi sono false, nelle dinamiche sono entrambe vere. Prendiamo il caso delle antinomie matematiche: nell’esperienza concreta, da un lato, possiamo allargare spazialmente e temporalmente la nostra conoscenza, per cui arriviamo a conoscere una parte del mondo, una quantità finita di fenomeni, e nulla ci impedisce di andare oltre questa quantità. Lo stesso vale per la divisibilità: quando dividiamo qualcosa, procediamo alla ricerca di componenti sempre più piccole della realtà fisica, così come i fisici dopo essere pervenuti al concetto di atomo come porzione ultima ed indivisibile della materia, hanno ulteriormente diviso scoprendo le particelle subatomiche. Ma fino a quando posso continuare a dividere? Ogni divisione sarà sempre finita, ma ciononostante potrò sempre farne una nuova. Nell’esperienza, dunque, ogni divisione effettiva o ogni effettiva estensione nello spazio e nel tempo è sempre finita, ma non c’è nulla che mi impedisca di poter ulteriormente dividere o estendere. Ed è proprio questo che è accaduto con la grande disputa sull’infinitezza o sulla finitezza del mondo: ci sono stati grandi pensatori che hanno dimostrato razionalmente la finitezza del mondo, e altri che ne hanno dimostrato altrettanto razionalmente l’infinitezza. Sembra dunque che la ragione sia scivolata in un paradosso, in un vicolo cieco: essa pare in grando di dimostrare al tempo stesso due cose contradditorie, che il mondo è finito e che è infinito. La soluzione che Kant dà a questa aporia, o ‘antinomia’, è molto semplice: sia la tesi (il mondo è finito) sia l’antitesi (il mondo è infinito) sono false, poichè muovono da un presupposto falso, cioè dall’idea di mondo. Tali antinomie della ragione dicono al tempo stesso che il mondo è finito e infinito nel tempo, nello spazio e nella divisibilità, ma il concetto (idea) di mondo è inaccettabile, poichè esso non è che la totalità di tutte le esperienze possibili e la totalità di tutte le esperienze, paradossalmente, non è un’esperienza, non può essere esperita. Ecco che il mondo, l’insieme dei fenomeni, è allora un noumeno, sta al di là dell’esperienza. E’ pensabile (come insieme di tutti i fenomeni), ma non conoscibile, poichè conoscere per Kant vuol dire pensare e percepire, e nel caso del mondo, lo penso nella sua totalità ma non lo percepisco (dunque non lo conosco). Infatti, il mondo come totalità infinita delle esperienze non posso riempirlo di materiale sensibile, proprio perchè il materiale sensibile sarà sempre finito e non potrà mai colmare un qualcosa di infinito come il mondo. Quindi, potrò sempre allargare la mia conoscenza, ma si tratterà sempre e solo di una serie di fenomeni legati in una certa maniera. L’errore delle antinomie matematiche sta nel credere di poter acquisire la totalità delle esperienze ; se potessi davvero conoscere effettivamente il mondo nella sua totalità e calcolare tutte le divisioni di cui è suscettibile, allora potrei dire che è infinito o finito, divisibile all’infinito o no. Ma non potendo esperire tale totalità (e quindi non potendo conoscere il mondo) non potrò mai predicarne con certezza nè l’infinitezza nè la finitezza. E’ dunque allo stesso modo sbagliato dire che il mondo sia infinito o che sia finito. Potrò solo legittimamente affermare il carattere indefinito del mondo nel tempo, nello spazio e nella divisibilità . Ogni divisione che farò sarà sempre finita, ma potrò fare sempre nuove divisioni, senza poter mai dire se ne posso fare in seguito di nuove o no, poichè non conosco il mondo nella sua totalità. Del resto, dire che è ‘indefinito’ vuol dire eliminare il concetto di mondo, poichè esso implicherebbe di avere la totalità delle esperienze, un numero ben definito, infinito o finito. Dunque, le antinomie matematiche si risolvono molto semplicemente nel dichiarare inconsistente il soggetto di tali affermazioni, ovvero l’idea di mondo. Tale idea non la possiamo usare per esprimere un’esperienza proprio perchè si pone al di là dell’esperienza; per questo, possiamo dire che ogni esperienza effettivamente realizzabile è sempre finita e che una volta date le esperienze finite, nulla ci vieta di fare un passo in più, di andare oltre. L’esperienza ha quindi carattere indefinito, è finita ma non è mai l’ultima. Le antinomie dinamiche non riguardano più la finitezza e l’infinitezza, ma la causalità. Esiste una causa deterministica o una ‘causa libera’ nel mondo? Il concetto di ‘causalità libera’ di cui parla Kant è, in poche parole, la possibilità di dare origine ex novo ad una nuova serie causale; se deterministicamente non c’è cosa che non sia causata e che a sua volta non causi nuove cose, la causalità libera prevede invece che per una decisione arbitraria possa nascere dal nulla una nuova serie causale. Prendo la penna e la sposto: deterministicamente, la mia mano si è mossa in seguito a meccanismi innescati nel mio cervello a causa del fatto che ho visto la penna; secondo la causalità libera, invece, si tratta di un gesto libero, incausato, con cui ho preso la penna, l’ho spostata, e ho dato il via ad una nuova serie causale. Ma questa causalità esiste, o vi è solo quella deterministica alla Cartesio? In definitiva, così come non conosco la totalità dei fenomeni del mondo, allo stesso modo non ne conosco la totalità delle cause/effetti. Se però nel caso delle antinomie matematiche sia tesi sia antitesi erano false, ovvero il mondo non era nè finito nè infinito, qui sia la tesi sia l’antitesi possono essere vere. Sembra molto strana la cosa, perchè più cose possono essere false (non è nè questo nè quest’altro: sarà qualcos’altro), ma pare molto più difficile che più cose possano, al tempo stesso, essere vere (è questo ed è quest’altro). Ci possono dunque essere al tempo stesso sia la causalità libera sia quella deterministica? Sembra che la ragione si sia nuovamente avventurata in un vicolo cieco, ma non è così. Noi conosciamo solo il mondo fenomenico, inquadrato nella categoria di causalità (ovvero conosciamo il mondo come insieme di cause ed effetti), e in esso possiamo constatare solo la causalità deterministica (dato A, si verifica per forza B) : questo perchè la categoria di causalità fa riferimento alla causalità deterministica (e non a quella libera) e, in virtù della rivoluzione copernicana, applichiamo le leggi del pensiero alla realtà, quindi la realtà fenomenica è retta dalla causalità deterministica. Come è dunque possibile che esista anche la causalità libera? Dobbiamo tenere presente che, accanto al mondo fenomenico in cui vi è solo la causalità deterministica, c’è anche il mondo noumenico, di cui non sappiamo nulla: che cosa mi vieta di pensare che lì viga la causalità libera? Lo stesso vale per la 4° antinomia (il mondo dipende da un ente necessario o in esso tutto è contingente?): nel mondo fenomenico tutto è contingente, cioè non c’è nulla che trovi in sè il motivo della propria esistenza (tutto c’è, ma potrebbe benissimo non esserci): un ente necessario non sarà mai dato nell’esperienza. Che cosa mi vieta, però, di ammettere l’esistenza di un ente necessario nel mondo noumenico? In questo modo Kant si riallaccia al grande problema seicentesco (sollevato da Cartesio) del rapporto tra necessità e libertà, tra anima e corpo, tra spiritualità e materialità. Come possono essere tra loro a contatto due realtà tanto diverse? L’unica soluzione era ridurre una realtà all’altra, e così Hobbes diceva che tutto era materia (negando l’esistenza autonoma della spiritualità), Leibniz che tutto era spirito (negando la materialità). Kant si chiede perchè mai ci si debba per forza porre il problema di incastrare tra di loro le due realtà ed è convinto che risulti molto più semplice asserire che a funzionare deterministicamente sia il mondo fenomenico, mentre a funzionare secondo la causalità libera sia il mondo noumenico. E in questo modo, riconoscendo l’esistenza di entrambe le realtà (cosa che Leibniz e Hobbes non avevano saputo fare) ed evitando un inquinamento reciproco (come invece aveva fatto Cartesio con la ghiandola pineale), Kant riconosce l’esistenza autonoma e distinta delle due realtà, libera e necessaria, ciascuna in un mondo distinto. E così il soggetto dell’antitesi (causalità necessaria/contingenza) è il mondo fenomenico, i cui enti non sono liberi, mentre il soggetto della tesi (la causalità libera/l’ente necessario) è il mondo noumenico, i cui enti sono liberi . Non posso sapere se per il mondo noumenico valga quel che vale per il fenomenico, ma posso benissimo ipotizzare che viga la libertà. Kant ha così risolto la questione delle antinomie e, inoltre, ha messo in luce che se in seguito per una via non conoscitiva saremo in grado di sostenere l’esistenza di un ente necessario e di una ‘causalità per libertà’ non saremo affatto in contraddizione, poichè sebbene il mondo fenomenico ci dica che le cose vanno diversamente, questo non ci vieta di applicare l’ente necessario e la causalità libera al mondo noumenico. Ed è proprio ciò che Kant farà nella Dialettica della Critica della ragion pratica , in virtù del terreno di non contradditorietà creato con la 3° e la 4° antinomia. Dopo aver trattato l’idea di anima e di mondo, esaminiamo ora meglio l’ idea di Dio . In L’unico argomento possibile per una dimostrazione di Dio , Kant aveva già smascherato la prova dell’esistenza di Dio data da Anselmo, la ‘prova ontologica’, sostenendo che in realtà l’unico argomento valido per dimostrare l’esistenza di Dio era quello che si basava sul presupposto che non vi è nulla che avvenga senza un motivo, con la conseguenza che si deve trovare un qualcosa che si spieghi da solo, che sia motivo di se stesso e che faccia derivare da sè tutto il resto. Ora Kant, pur continuando a non accettare la prova ontologica, non accetta neanche più quella da lui stesso formulata in L’unico argomento possibile per una dimostrazione di Dio , poichè implica l’illegittima applicazione della categoria di causalità alla sfera metafisica. L’esistenza di Dio, dice il Kant della Ragion pura, è indimostrabile. Così come la ragione si illude di poter dimostrare l’esistenza della ‘sostanza anima’ cui ineriscono tutti i fenomeni psichici, e la ‘sostanza mondo’, come totalità infinita dei fenomeni, allo stesso modo essa si illude di poter dimostrare l’esistenza di Dio, essenzialmente attraverso 3 prove, dice Kant. La 1° prova, che è poi la più antica e più umana (nonchè quella verso la quale Kant nutre maggiore simpatia) è quella fisico-teologica di Platone: dalla constatazione di un ordine e di un’armonia nel mondo ne deduco che vi deve essere un ordinatore (Dio). Di per sè, però, non dimostra l’esistenza di un Dio-creatore, ma solo di un Dio-ordinatore, e pertanto questa prova poggia su un’altra, quella cosmologica di Aristotele: ogni cosa mossa è per forza mossa da un’altra cosa, ne consegue che ci deve essere qualcosa che muove senza essere mosso (Dio). Questa prova, inaccettabile in quanto implicante un’applicazione metafisica della categoria di causalità, è secondo Kant del tutto uguale a quella ontologica , poichè vuole dimostrare che si deve per forza arrivare ad una causa incausata, ad un ente la cui essenza implica l’esistenza. L’essere incausato implica proprio che nulla (fuorchè la sua essenza) ne sia causa: ma dire che l’essenza è causa dell’esistenza vuol dire ricadere nella prova ontologica. Il succo del discorso è che tutte le prove dell’esistenza di Dio derivano da quella ontologica e sono inaccettabili proprio perchè inaccettabile è quella ontologica. E così si conclude la Dialettica trascendentale: risultano indimostrabili tutte le fondamentali affermazioni della metafisica (Dio, anima, libertà, ecc), anche se questo non toglie che ciò che non può essere nel mondo fenomenico, possa invece essere in quello noumenico. Con questo discorso sull’anima, su Dio e sul mondo, Kant ha dimostrato l’illegittimità dell’ uso costitutivo delle idee , ovvero di quell’uso volto a costituire la conoscenza. L’uso costitutivo delle categorie era legittimo, quello delle idee no. Oltre ad essere inutili nell’uso costitutivo, le idee sono addirittura pericolose, poichè pretendono di dimostrare l’esistenza di Dio e della libertà. E tuttavia Kant si accorge che è assurdo che la ragione sia dotata di una facoltà tanto ostile, addirittura pericolosa, e finisce per riconoscere un uso legittimo delle idee (ecco perchè son trascendentali e non trascendenti): anzi, esse ci son state date proprio affinchè ne facciamo tale uso. Quest’uso legittimo e importante delle idee Kant lo chiama uso regolativo delle idee . Kant ha spiegato che riceviamo passivamente nello spazio e nel tempo i dati sensibili e che li unifichiamo con l’attività categoriale dell’ Io penso ; dopo di che, le categorie ci permettono di formulare giudizi e concatenazioni di giudizi. Ecco allora che la nostra conoscenza è come un puzzle , i cui tasselli sono i dati sensibili e la cui attività (finita) di unificazione è data dall’intelletto unificatore; il puzzle però è infinito, mentre la nostra conoscenza è sempre finita. Abbiamo i tasselli sparsi qua e là e non sappiamo bene dove collocarli, senonchè nei puzzle c’è anche l’immagine generale del puzzle come dovrebbe essere una volta costruito. La funzione regolativa delle idee è analoga a quel disegno generale del puzzle che ci dà il quadro generale della situazione e in base al quale possiamo collocare le unificazioni parziali di pezzi (le conoscenze, sempre finite) al posto giusto. In altri termini, la funzione regolativa delle idee consiste nel dare il massimo di unità e di estensione possibile alla nostra conoscenza: l’idea di mondo non sarà mai completa, riempibile di dati dell’esperienza, però mi servirà a dire che qualsiasi singolo raggruppamento (finito) di fenomeni, io so già a priori (perchè l’idea è un concetto puro) che si colloca in unico sistema e quindi il mio obiettivo è di cercare di attaccare il più possibile all’infinito i vari pezzi già attaccati tra di loro gli uni agli altri (ed è proprio quel che fa la scienza); tenderò dunque a sistematicizzare all’infinito il mio sapere, a organizzare le mie conoscenze interne come se potessero essere attribuite ad un’unica sostanza (l’anima), oppure ad organizzare tutte le mie esperienze esterne come se appartnessero ad un unico mondo, o ancora ad organizzare tutte le mie conoscenze (interne + esterne) come se fossero effetti di un’unica causa (Dio). E’ ben diverso dire che bisogna agire come se appartenessero ad un unico orizzonte o ad un’unica sostanza (anima, mondo, Dio) dal predicare che effettivamente esistano tali cose. Le idee hanno dunque in Kant una funzione euristica, servono cioè a guidare l’indagine verso sempre maggiore unitarietà e sistematicità, come se si potessero attribuire tutti i fenomeni interni ad una sostanza (anima) e quelli esterni ad un’altra sostanza (mondo). Non è detto che io possa dire qualcosa dell’anima, ma essa mi serve per poter strutturare attorno a tale concetto i fenomeni interni. Ecco allora che le idee ‘regolano’, guidano verso l’unità e l’estensione, poichè il concetto di mondo, ad esempio, ci ricorda continuamente che i singoli aggregati di conoscenze sono pezzi finiti di conoscenza indefinitamente estensibili. Il concetto di mondo mi dice quindi che devo collegare tra loro tutti i fenomeni (unità), ma anche che tutti i fenomeni devono farmi allargare la conoscenza, collegandoli tra loro. Non posso conoscere l’idea di mondo, dunque, ma essa mi serve per conoscere, per estendere la conoscenza e per darle unità: ecco allora che le idee servono per conoscere ma non possono essere conosciute . E’ una sorta di punto di fuga ideale l’idea: convergo verso un punto, ma mi porta ad un processo di arricchimento infinito. Come per i medioevali, anche per Kant Dio resta il grande punto di riferimento della conoscenza, dunque, ma non Dio come ente, bensì Dio come idea presente nella mente umana: devo organizzare la mia conoscenza come se fosse stata prodotta da un unico ente (Dio), che garantisce l’unità del mondo e, con essa, quella della nostra conoscenza. Accanto alla valenza teoretica (conoscere la realtà), Kant dà alla ragione anche una valenza pratica: la ragione ci dà leggi di comportamento. E dell’uso pratico della ragione si occupa la Critica della ragion pratica .
LA CRITICA DEL GIUDIZIO
La terza grande opera filosofica di Kant è la Critica del Giudizio (1790). Nella traduzione italiana si trova quasi sempre la parola Giudizio con la ‘g’ maiuscola, per evidenziare che il giudizio in questione non è quello della Critica della ragion pura , sinonimo di proposizione ovvero di attività unificatrice. Il giudizio di cui parla ora Kant è la facoltà del giudicare, e non l’atto del giudicare, ovvero l’esprimere giudizi: all’inizio dell’opera, si attua un’ulteriore distinzione, spiegando che il giudizio in questione, oltre a non essere quello della prima Critica, non è nemmeno il giudizio determinante , bensì è quello riflettente . Giudizio determinante è quello in cui ci si inbatte predicando qualcosa in modo oggettivo, dicendo ad esempio che il libro è sul tavolo o che A è causa di B ; è definito giudizio determinante proprio perchè determina l’oggetto (il libro, A, ecc) dei giudizi. Al contrario, il giudizio riflettente , proprio della Critica del Giudizio , è la facoltà del giudicare che si estrinseca nei giudizi, senza determinare l’oggetto ma limitandosi ad interpretarlo: il giudizio riflettente non determina gli oggetti (come fa il giudizio determinante), ma li trova già determinati dall’applicazione delle categorie e non fa altro che riflettere su essi interpretandoli. Dunque, i giudizi con le categorie hanno funzione determinante, ma quando trovo l’oggetto già determinato dalle categorie mi limito ad interpretarlo, a riflettere sull’oggetto già costituito. La forma a priori in base alla quale si interpretano gli oggetti nel giudizio riflettente è il concetto di finalità, che, in sostanza, altro non è che una 4° idea di cui Kant non ha ancora parlato. Si tratta di un’idea in quanto è un concetto non dell’intelletto, ma della ragione, ovvero non può essere riempito di contenuto empirico. In base alle categorie, infatti, il mondo fenomenico può essere interpretato solo secondo il meccanicismo, e non riusciremo mai a trovare in esso il finalismo: ne consegue che il concetto puro di finalità è un’idea, che nel mondo fenomenico non potrà mai essere riempita di contenuti, ma in quello noumenico, definito anche da Kant regno dei fini , lo sarà. Un insieme di fenomeni non potrà mai pienamente soddisfare il concetto puro di finalità, ma, ciononostante, noi lo applichiamo a due ambiti distinti ma, secondo Kant, tra loro connessi: avremo dunque due tipologie di giudizio riflettente, il giudizio estetico e il giudizio teleologico . Il giudizio estetico è il giudizio sul bello, il giudizio teleologico (dal greco telos , fine ) è il giudizio sull’esistenza di finalità nel mondo biologico e naturale. Quando asserisco che il paesaggio che ho di fronte è bello formulo un giudizio estetico , quando invece dico che il cavallo ha gli zoccoli per camminare su terreni scoscesi formulo un giudizio teleologico. Da notare che qui Kant usa il termine ‘estetico’ nel senso comune, come ‘ciò che ha a che fare con il bello’, e non, come lo aveva usato nella Critica della ragion pura , con il significato di ‘ciò che ha a che fare con la sensibilità’. Dire che il paesaggio che ho di fronte è bello è un giudizio riflettente estetico e non teleologico perchè con esso non fornisco informazioni oggettive, mi limito ad applicare il concetto di bellezza ad un qualcosa e, così facendo, non determino nulla: il paesaggio che dico essere bello è già determinato come oggetto di conoscenza dalla categoria di sostanza, con la conseguenza che interpreto un oggetto che ho e che non determino; ad esso applico un giudizio estetico, scevro da informazioni oggettive e scientifiche, una mera riflessione su un giudizio già determinato. Anche il giudizio teleologico è riflettente, poichè ha a che fare con la finalità. Infatti, predica la finalità al mondo biologico e naturale, sostenendo che il cavallo ha gli zoccoli per camminare su terreni scoscesi o che piove perchè la vegetazione cresca . L’intera fisica aristotelica era di stampo teleologico, ma Kant è convinto che il giudizio teleologico non possa avere validità scientifica: la spiegazione del perchè il cavallo abbia gli zoccoli non potrà che risiedere nei fatti materiali e meccanici, cioè nei fatti che hanno portato il cavallo ad essere dotato di zoccoli, e non potrà essere trovata nella presunta finalità per cui li ha. Per Kant, dunque, l’unica via possibile resta quella della fisica meccanicistica di matrice newtoniana, dove, in parole povere, ogni fatto che sta dietro determina quel che sarà dopo e non, viceversa, dove è quello che verrà dopo a determinare quel che è prima, come nei giudizi teleologici: scientificamente sarà dunque scorretto dire che l’esigenza di poter camminare su terreni scoscesi ha fatto sì che il cavallo avesse gli zoccoli. Sarà invece corretto dire che, meccanicisticamente, determinati fatti hanno fatto sì che, con il processo causa-effetto, il cavallo avesse gli zoccoli. Resta ora da chiarire che tipo di rapporto vi sia tra i due giudizi riflettenti, estetico e teleologico: in primo luogo, sono entrambi riflettenti, interpretano cioè oggetti già determinati dalle categorie; in secondo luogo entrambi hanno a che fare con l’idea di finalità, sebbene nel giudizio teleologico si pretenda di coglierla nei rapporti che legano tra loro le varie parti di un ente biologico (gli zoccoli e il cavallo), mentre nel giudizio estetico si ha la pretesa di coglierla nel rapporto che si instaura tra il soggetto e l’oggetto. Infatti, secondo Kant, il giudizio estetico è un giudizio sul particolare tipo di relazioni che si instaurano tra il soggetto e l’oggetto, e non tra le sole parti dell’oggetto (come è invece nel teleologico). Di fronte ad un cavallo posso dire che ha gli zoccoli per camminare su terreni scoscesi (giudizio teleologico) o posso dire che è un bell’animale (giudizio estetico) , senza giudicare se gli zoccoli sono fatti per realizzare dei fini. Kant fa l’esempio del fiore: un botanico, osservandololo, dirà che tutte le parti che lo compongono (i petali, lo stelo, ecc) servono a qualcosa, sono in vista di un fine, una persona qualunque invece dirà semplicemente che il fiore è bello. A ben pensarci, se è evidente che nel giudizio teleologico vi sia la finalità, meno evidente è che essa sia presente nel giudizio estetico: Kant spiega che l’estetico è un giudizio in cui si rileva una sorta di finalità senza però poterla determinare a fondo. Una cosa, infatti, ci appare bella quando dà l’impressione che in essa vi sia una specie di progetto, che non sia stata fatta a caso, che ci sia cioè un fine in essa, sebbene non si sia in grado di definirlo (a differenza del giudizio teleologico). La differenza tra i due giudizi sta proprio nel fatto che nel teleologico si definisce perfettamente la finalità, mentre nell’estetico la si avverte soltanto . E’ interessante notare come Kant si accorga che i giudizi estetici siano formulabili tanto su cose naturali quanto su cose artificiali: fa notare che in entrambe i casi si avverte una sorta di finalità, tant’è che si è soliti dire, di fronte ad una cosa artificiale, che è talmente bella da sembrare vera e, di fronte ad una cosa naturale, che è talmente bella da non sembrare vera, quasi come se cogliessimo una sorta di progettualità in esse. Così, di fronte ad un bel paesaggio avremo l’impressione che esso sia il frutto del lavoro di un giardiniere e, di fronte ad un bel quadro, avremo l’impressione che si tratti di un qualcosa di reale. Di sfuggita, si può notare che Kant ha soprattutto in mente la bellezza naturale e poche volte fa riferimento a quella artificiale. Ricapitolando, una cosa è bella quando sembra manifestazione di un progetto, volta a realizzare un fine. Kant darà 4 definizioni del bello ed è interessante notare che in una di esse finirà per dire che è bello ciò che manifesta una finalità senza scopo: nel linguaggio kantiano, scopo è una finalità determinabile o già determinata, mentre finalità è una finalità vaga, non determinata nè determinabile. La finalità del giudizio estetico, del bello, è priva di scopo proprio perchè la si avverte ma non la si può determinare, mentre la finalità del giudizio teleologico è una finalità dotata di scopo , poichè riesco a determinarla, a dire effettivamente quali sono i fini delle cose che vedo. In origine Kant non aveva previsto la composizione della Critica del Giudizio in quanto restava esclusa dalla ragione e dai suoi due ambiti (teoretico e morale) la possibilità di fare una critica del gusto, del giudizio riflettente, poichè esso è fondato sul sentimento e non sulla ragione: una critica, diceva Kant, può essere costruita solo sulle facoltà razionali, tant’è che l’intero impianto delle prime due critiche si fonda sulla convinzione che le due esperienze, gnoseologica e morale, non si fondino sui sentimenti. Tuttavia Kant si rese conto che è senz’altro vero che il gusto ha a che fare con il sentimento e che il giudizio di bellezza non è nè teoretico nè pratico, ma fondato sul sentimento estetico; però si rese anche conto che il sentimento su cui si fonda il giudizio di bellezza deriva dal funzionamento delle nostre facoltà conoscitive . Partendo da questa considerazione, Kant riesce a spiegare una cosa molto particolare, ossia che i giudizi di bellezza non sono nè universali nè particolari . Che non siano universali è evidente, in quanto si fondano sui sensi e non sulla ragione: se dico che il libro è sul tavolo , si tratta di un’affermazione valida per tutti, perchè tutti hanno le categorie nelle loro strutture mentali; ma se dico che mi piace il gelato al cioccolato , si tratta di un’affermazione fondata sui sensi e quindi valida per me, magari per molti altri, ma non per tutti. Tuttavia i giudizi di bellezza, a ben pensarci, sono stranissimi: non mi sarà mai possibile dimostrare a qualcuno che una cosa è bella, ma, ciononostante, ho la convinzione, quasi la pretesa, dell’universalità della mia affermazione. Ecco dunque che affiora il carattere non universale ma neanche particolare di tali giudizi. Accanto ai giudizi puramente oggettivi (conoscitivi e morali) e soggettivi (di gusto: mi piace il gelato al cioccolato), vi saranno quelli estetici (giudizi di bellezza), che non sono nè soggettivi nè oggettivi. Del bello si può parlare, si può argomentare a favore della bellezza di una cosa, nutrendo sempre la pretesa che la nostra affermazione sia universale pur non potendolo dimostrare perchè si basa pur sempre su un sentimento. Questo sfumato carattere di ambiguità può essere spiegato in questo modo: i giudizi estetici si fondano sul sentimento (soggettività), ma derivano dall’applicabilità delle nostre categorie conoscitive (oggettività) . Ecco perchè Kant parlerà di universalità soggettiva . Come accennavamo, Kant dà 4 definizioni del bello, apparentemente in contrasto fra loro. Quattro erano i gruppi delle categorie e, se il giudizio estetico deriva in qualche misura dalle nostre facoltà conoscitive, non c’è nulla di strano se 4 sono anche le definizioni del bello. Kant compie un’argomentazione piuttosto complessa e, alla fine, ne desume la 1° definizione del bello: ‘ il gusto è la facoltà di giudicare un oggetto o un tipo di rappresentazione mediante un piacere, o un dispiacere, senza alcun interesse. L’oggetto di un piacere simile si dice bello ‘. In sostanza con questa prima definizione Kant dice che il bello è ciò che è oggetto di un piacere disinteressato . La 2° definizione invece recita: ‘ è bello ciò che piace universalmente senza concetto ‘, ovvero è bello ciò che piace a tutti, universalmente . La 3° dice invece: ‘ la bellezza è la forma della finalità di un oggetto, in quanto questa vi è percepita senza la rappresentazione di uno scopo ‘, ovvero è bello ciò che mostra una finalità non del tutto determinabile, priva di scopo. Infine, la 4° definizione dice che ‘ il bello è ciò che, senza concetto, è riconosciuto come oggetto di un piacere necessario ‘, ovvero che è bello ciò che è oggetto di un piacere necessario . Si possono analizzare insieme la 1°, la 2° e la 4° definizione: nella 2° e nella 4° tornano le nozioni di universalità e di oggettività, creando una sorta di contraddizione. Come fa una cosa a piacere a tutti (universalmente) e necessariamente? Ciò che piace, infatti, piace soggettivamente e accidentalmente, tant’è che sui gusti non si può discutere. In entrambe le formulazioni (la 2° e la 4°) Kant aggiunge la condizione senza concetto , facendo notare che nei giudizi di gusto non può nè deve essere in azione un concetto, altrimenti si tratterebbe di un giudizio oggettivo, di conoscenza, ovvero un giudizio determinante, e non riflettente. Il giudizio in questione è un sentimento e, come tale, non ha concetto, ma dato che tale sentimento di piacere deriva in qualche modo dall’applicazione delle facoltà conoscitive, allora sarà un piacere che, pur senza concetto, potrà aspirare ad avere una valenza universale e necessaria. Essendo un piacere sensibile e non un giudizio conoscitivo dovrà per forza essere senza concetto , non strettamente legato alle categorie. Nella 1° definizione Kant asserisce che è bello ciò che piace in modo disinteressato: anche qui ci troviamo di fronte ad un’aporia, poichè le cose non piacciono mai in modo disinteressato, ma sempre e solo nella misura in cui servono a qualcosa. Solo le cose a carattere morale o conoscitivo sono disinteressate: le cose sono così o è giusto fare così, senza che vi sia un ‘interesse’ affinchè lo siano. Ma per quel che riguarda il piacere, le cose mi piacciono nella misura in cui mi servono: un cibo, per esempio, mi piace nella misura in cui mi soddisfa l’appetito. I giudizi di gusto hanno dunque sempre a che fare con l’esistenza di qualcosa, fa notare Kant: mi piace il cibo nella misura in cui esiste o in cui potrebbe esistere, proprio perchè così posso usarlo. Però, a ben pensarci, i giudizi estetici sono disinteressati, dice Kant, poichè godono non dell’esistenza di qualcosa, ma della rappresentazione dell’esistenza di qualcosa: mi piace il cibo perchè posso mangiarlo, ma se mi trovo a pancia piena di fronte ad un bel piatto ben presentato, pur non usandolo per nutrirmi, posso darne un giudizio positivo, può piacermi e posso definirlo bello. Si tratta dunque di due giudizi diversi: mi piace il cibo per mangiarlo (interessato), mi piace il cibo perchè è bello, ben presentato (disinteressato). Quando dico che mi piace il formaggio, formulo un giudizio ben diverso rispetto a quando dico che mi piace il quadro dipinto del formaggio: nel primo caso ho l’esistenza e dunque il giudizio interessato, nel secondo caso ho la rappresentazione dell’esistenza e quindi il giudizio disinteressato. Nel caso del quadro del formaggio, il giudizio è slegato dall’esistenza ed è dunque disinteressato, non mi piace solo perchè mi serve. E proprio in quanto disinteressato, sganciato dall’esistenza effettiva della cosa in questione e dall’uso che posso farne, tale giudizio può aspirare ad essere universale e necessario. Ecco perchè la 1°, la 2° e la 4° definizione del bello sono tra loro connesse. Si può notare che i 4 gruppi delle categorie erano quantità, qualità, relazione e modalità; ora, ogni definizione del bello può essere confrontata, poichè in qualche misura ne deriva, alle categorie. La 1° definizione del bello, infatti, dice che esso è disinteressato (qualità), la 2° dice che è universale (quantità), la 4° dice che è necessario (modalità), e la relazione? Essa subentra con la 3° definizione del bello: la categoria di relazione più importante era quella di causalità ed ora entra in gioco una nuova causalità, quella di tipo finalistico. La 3° definizione, infatti, dice che una cosa è bella quando mostra una finalità senza scopo, ovvero una finalità non determinabile, che sfugge all’inquadramento in un concetto (il concetto di finalità). Proprio come nella 2° e nella 3° definizione si poneva la condizione di essere senza concetto , così adesso Kant impone pure nella 3° definizione l’assenza di concetto, in particolare del concetto di finalità. Con queste affermazioni Kant sottolinea il carattere di autonomia del giudizio estetico, il suo esulare sia dall’ambito teoretico sia dal morale: esso infatti non è nè un giudizio di verità, nè di moralità, nè teoretico nè pratico, poichè dire che una cosa è vera o è giusta è altra cosa rispetto al dire che è bella o brutta. I giudizi estetici, poi, emergono in altro modo rispetto a quelli morali e a quelli teoretici, anche se sono presentati da Kant come ponti tra il mondo fenomenico e quello noumenico. Questo aspetto è particolarmente importante e spiega perchè la Critica del Giudizio è l’opera kantiana che offre più aperture al Romanticismo. Se la Critica della ragion pura è dedicata al mondo fenomenico (poichè la conoscenza legittima ha a che fare solo con il mondo fenomenico) e la Critica della ragion pura è dedicata al mondo noumenico (poichè la morale si fonda sul mondo noumenico, mettendomi in contatto con esso, di cui è ratio cognoscendi ), la Critica del Giudizio , invece, può assurgere, a pieno titolo, a vero e proprio ponte tra i due mondi, noumenico e fenomenico . Nell’esperienza estetica e in quella teleologica, infatti, è come se avessimo l’impressione che elementi del mondo noumenico filtrassero in quello fenomenico, con percorsi di remota ascendenza platonica. L’idea del bello, diceva Platone, si trova in una posizione privilegiata, poichè è più evidente a livello sensibile: è l’unica cosa in sè che riesce a filtrare nel mondo fenomenico. Pertanto l’esperienza estetica e quella teleologica sembrano farmi cogliere nel mondo empirico elementi di quello noumenico, come se filtrasse ciò che soggiace alla realtà fenomenica: una cosa, infatti, è bella nella misura in cui mostra finalità, poichè mi dà l’impressione di cogliere elementi di quella finalità che in termini conoscitivi non posso mai legittimamente predicare, in quanto esula dalle categorie. E’ quasi come se cogliessi un barlume di finalità in quel mondo fenomenico, retto dalla rigida causalità di tipo meccanicistico. Ed è proprio per questo che la Critica del Giudizio costituisce un ponte tra i due mondi (un pò di mondo noumenico, tramite il bello, filtra in quello fenomenico) e dai Romantici fu giudicata la migliore delle tre. I Romantici, infatti, rifiuteranno tutte le cautele illuministiche di Kant, secondo le quali non si può mai attingere l’essenza profonda della realtà: essi vorranno cogliere l’ essenza più intima della realtà e, per realizzare questo fine, cercheranno nella natura non già leggi meccanicistiche, bensì princìpi vitalistici, quasi come se la natura, sulla scia di quanto aveva detto Aristotele, fosse vivente. In Kant, però, questa tenue apertura al Romanticismo non ha valenza conoscitiva, così come non l’avevano i postulati della ragion pratica, i quali, pur mettendomi in contatto col mondo noumenico, non potevano in alcun modo fondare la conoscenza. Quanto detto per i postulati della ragion pratica vale per i giudizi estetici e teleologici: per Kant non è legittimo costruire una fisica di stampo teleologico, l’unica via possibile è quella meccanicistica di ascendenza newtoniana, checchè ne pensino i Romantici. A questo punto, Kant spiega come nasca il giudizio estetico: esso scaturisce da un libero gioco delle facoltà , ovvero da un accordo spontaneo tra l’immaginazione e l’intelletto . Con questo, Kant vuole dire che vi sono situazioni in cui abbiamo l’impressione che il nostro oggetto empirico sia costituito in maniera tale da essere del tutto adatto alle nostre facoltà conoscitive. Di fronte a certi oggetti già determinati si ha quasi l’impressione, in virtù della loro armonia, che essi si adattino in modo spontaneo al lavoro unificatorio delle nostre capacità conoscitive, come se vi fosse appunto un accordo spontaneo tra l’immaginazione e l’intelletto. Ed è proprio questo che fa nascere il giudizio estetico: a farci provare piacere di fronte ad una cosa, a farcela sembrare bella, è questa specie di spontanea corrispondenza tra oggetto e categorie. Così come proviamo piacere a stare in un ambiente nè troppo caldo nè troppo freddo perchè tale situazione è particolarmente adatta alla nostra costituzione fisica, allo stesso modo proviamo piacere nell’osservare un oggetto che ci sembra particolarmente adeguato alle nostre categorie. Proprio in questo consiste il libero gioco delle facoltà , ovvero nel rendersi conto spontaneamente che l’oggetto che abbiamo di fronte calza a pennello con le categorie che costituiscono il nostro apparato gnoseologico. Si tratta di un piacere sensibile, ma che deriva da una sorta di gioco delle nostre categorie e proprio per questo il giudizio estetico non è nè universale nè soggettivo. Certo nel giudizio estetico non c’è una vera e propria applicazione delle categorie, c’è un gioco libero, uno svago delle categorie, le quali sono in azione in modo sfumato, vi è uno spontaneo adeguamento di immaginazione ed intelletto. Naturalmente, proprio perchè non scaturisce da un’apllicazione sistematica e rigorosa, il giudizio estetico non può aspirare ad essere un giudizio teoretico, come invece riterranno lecito fare i Romantici: per loro, in fin dei conti, l’artista finirà per cogliere la verità più dello scienziato. Ora si capisce benissimo perchè a suscitare il sentimento del bello sono gli oggetti con l’apparenza di progettualità intrinseca, di armonia, dotati di forma: di fronte ad un bel paesaggio abbiamo l’impressione che sia finto perchè ci sembra che qualcuno avente le nostre stesse facoltà conoscitive l’abbia posto lì apposta per noi; si tratta però di un’impressione, non di una verità oggettiva, come crederanno i Romantici. Tuttavia il ragionamento effettuato sul sentimento estetico funziona solo per l’arte in auge all’epoca di Kant, arte che, peraltro, stava già per essere superata: l’arte che possiamo giudicare bella in base al criterio kantiano è quella di forma, tant’è che per Kant l’elemento centrale nelle opere d’arte era il disegno (simbolo di formalità, oltrechè di razionalità) e non il colore. L’arte romantica tenderà già a sfuggire al discorso kantiano in quanto sempre più legata ai colori e staccata dal disegno. Accanto al giudizio estetico di bellezza, Kant riconosce anche, come oggetto del giudizio estetico, il sublime , il concetto che segna l’apice dell’avvicinamento di Kant al Romanticismo. Se bello è ciò che deriva dalla forma, dalla progettualità intrinseca, quando invece ci troviamo di fronte ad un oggetto che sfugge alla possibilità di inquadramento da parte delle nostre facoltà conoscitive (ovvero da parte dell’intelletto), quando cioè l’oggetto oltre a sfuggire alla possibilità di essere colto dai sensi perchè è sterminato sfugge anche all’intelletto perchè è infinito e può essere apprezzato dalla sola ragione (la facoltà dell’infinito), allora abbiamo a che fare col sentimento del sublime. La sensibilità e l’intelletto si perdono, non riescono a star dietro all’oggetto, e solo la ragione, come facoltà dell’infinito, tiene duro. Kant, come per le antinomie della ragion pura, distingue tra due tipi di sublime. Il sublime matematico è quel sentimento che si prova di fronte all’infinita grandezza (ecco perchè è matematico) della natura: Kant cita due esempi, il cielo stellato che sta sopra di noi e le imponenti catene montuose. Il sublime dinamico (dal greco dunamiV , potenza ) è quel sentimento che si prova di fronte non all’infinita grandezza della natura, ma di fronte alla sua infinita potenza. Kant fa, in merito, l’esempio del mare in tempesta. Sia nel sentimento che per oggetto ha il sublime dinamico sia per quello che ha il sublime matematico, l’oggetto in questione (vuoi il mare in tempesta, vuoi il cielo stellato o le montagne) non si adegua spontaneamente a noi e alle nostre facoltà conoscitive, ma ci incute timore perchè manifesta la sterminata grandezza e la sterminata potenza della natura di fronte alla sterminata piccolezza e impotenza dell’uomo. Pare dunque che il sublime sia un sentimento negativo, ma non è così: mentre il bello è univocamente positivo, il sublime è positivo e negativo al tempo stesso. Il dovere morale era positivo e negativo allo stesso tempo perchè ci faceva sentire inferiori per il nostro lato empirico, ma superiori per il lato razionale; allo stesso modo, il mare in tempesta ci fa sentire la nostra impotenza fenomenica, ma anche la nostra grandezza e superiorità sul piano razionale e noumenico. Il bello è finito, il sublime è infinito; il bello ha a che fare con l’intelletto, il sublime con la ragione. Contemplare il cielo stellato dà un sentimento di sublime, ci fa sentire inferiori all’infinita grandezza della natura, ma anche superiori in quanto razionali. Non può senz’altro sfuggire che vi sia una radice comune alla morale e al sentimento, cosicchè l’estetica presenta affinità con la morale: quando si parla di fini, infatti, si ha una sorta di sentimento di un finalismo della natura, di un’omogeneità tra noi e la natura, quasi come se la barriera che separa mondo fenomenico e mondo noumenico si facesse più sottile e ci permettesse di vedere un pò di più al di là del mondo fenomenico. Accanto al giudizio estetico c’è quello teleologico : esso presuppone l’attribuzione oggettiva di un finalismo a determinati oggetti di natura, una finalità con scopo, ovvero chiaramente determinabile (a differenza di quella del giudizio estetico). A proposito degli estetici, Kant specificava che si trattava di giudizi senza concetto ; nei teleologici, invece, esso è presente e altro non è che il concetto di finalità attribuibile alle cose che vediamo. La finalità è una sorta di 4° idea, poichè non è mai riempibile di esperienze sensibili. Tuttavia, Kant sembra imboccare una strada senza via d’uscita, collocandosi su un terreno a metà strada tra il meccanicismo seicentesco e settecentesco e il finalismo romantico. Infatti, Kant asserisce che le spiegazioni scientifiche sono sempre e soltanto di tipo meccanicistico, tuttavia è convinto che vi siano fenomeni fisici che non potranno mai essere totalmente risolti in termini meramente meccanicistici. Fa l’ esempio del filo d’erba e del verme: in una logica meccanicistica, dovrebbero ambedue poter essere spiegati in termini deterministici di causa-effetto, eppure una spiegazione di tal genere non sarà mai del tutto soddisfacente. Pare dunque che, se tutto è spiegabile meccanicisticamente, l’esistenza degli esseri viventi non è mai un fatto puramente meccanicistico, tende a sconfinare nel finalismo. Le spiegazioni di tipo finalistico-organicistico impereranno in età romantica con la conseguenza che si considererà come organismo anche ciò che sembra meno adatto a tali interpretazioni, ad esempio la politica (Hegel). Se per i meccanicisti alla Cartesio il tutto è in funzione delle parti come in un orologio (i cui ingranaggi possono benissimo funzionare da soli, ma senza di essi l’orologio non va avanti), per gli organicisti alla Hegel le parti sono in funzione del tutto come in un albero (in cui le radici e le foglie non possono vivere da sole, ma ciascuna può esistere solo se esiste il tutto). Ora Kant si colloca a metà strada tra le due interpretazioni, sostenendo che una spiegazione puramente meccanicistica non potrà mai soddisfare pienamente l’esistenza dell’albero e, più in generale, degli esseri viventi: ogni organismo, infatti, cerca di raggiungere uno scopo, mira ad un fine e tale finalità non è inquadrabile dalle categorie proprio perchè esse riconoscono solo la causalità meccanicistica. Sembra dunque che non ci sia via d’uscita, a meno che non si ammetta che il concetto di finalità sia un’idea e, accanto all’illegittima funzione costitutiva, le idee hanno la funzione regolativa. Ne consegue che dovrò guardare all’albero e ad ogni essere vivente come se fosse organizzato in termini finalistici. L’ammissione provvisoria del finalismo serve come guida per dare di volta in volta singole spiegazioni, le quali saranno sempre rigorosamente meccanicistiche: dovrò indagare minuziosamente e meccanicisticamente sulle varie parti del mondo biologico come se fossero organizzate finalisticamente. Dire che il cavallo ha gli zoccoli per camminare su terreni impervi e ha quattro gambe per correre più velocemente deve essere il punto di riferimento ideale per indagare correttamente quale processo meccanicistico ha fatto sì che il cavallo avesse gli zoccoli e quattro gambe. Del resto, quando pensiamo all’evoluzione dei viventi, la pensiamo sempre in termini finalistici (l’organismo si adatta a…), pur sapendo che le cose sono andate meccanicisticamente (c’è stato un errore genetico e gli individui che ne sono stati caratterizzati sono sopravvissuti, gli altri no). Guardiamo cioè ad un quadro generale di stampo finalistico per spiegare uno ad uno fatti meccanicistici.
JOSEPH PRIESTLEY
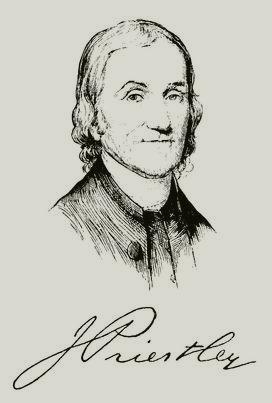
A cura di Alessandro Sangalli e Diego Fusaro
PRIESTLEYJoseph Priestley, pastore presbiteriano, chimico e filosofo, nacque nel 1733 a Fieldhead, nei pressi di Leeds. Nelle scuole superiori apprese il latino, il greco e imparò anche a stenografare. Sia grazie ai suoi insegnanti sia in veste di autodidatta divenne molto esperto in fisica, filosofia, algebra, matematica e in una grande varietà di lingue, tra cui antichi idiomi mediorientali e lingue moderne. Dopo quattro anni alla Dissenting Academy di Daventry, nel 1755 divenne pastore della piccola parrocchia di Needham Market, e lì scrisse “La dottrina biblica del Perdono”. Nel 1758 si trasferì a Nantwich, e nel 1761 divenne insegnante alla Warrington Academy, nel Lancashire. Ordinato prete nel 1762, si sposò l’anno stesso con Mary Wilkinson, l’unica figlia di un impresario siderurgico gallese. La reputazione di Priestley e i suoi contatti con il mondo intellettuale inglese crebbero durante tutto il decennio 1760: la sua “Chart of Biography” (1765) gli fece ottenere il dottorato in Legge presso l’Università di Edimburgo, mentre i suoi esperimenti sull’elettricità lo fecero diventare membro della Royal Society nel 1766. Mentre era a Warrington, si recava di frequente a Londra, dove incontrò Richard Price e John Canton. Divenne inoltre amico intimo di Benjamin Franklin, il quale incoraggiò sempre le sue attività, sia in campo scientifico che politico. Risultato di questo continuo incoraggiamento fu il progetto, da parte di Priestley, di scrivere una Storia degli esperimenti sull’elettricità. Egli sosteneva, infatti, che scrivere una Storia della Scienza sarebbe stato un lavoro molto utile, dal momento che un’opera simile avrebbe potuto mostrare in che modo l’intelligenza umana possa arrivare a scoprire e governare le forze della natura. Una Storia della Scienza avrebbe inoltre potuto illustrare il generale progresso dell’intero genere umano. In “Storia e stato attuale dell’elettricità, con esperimenti originali” (1767) Priestley descrive diversi fenomeni elettrici e trae una serie di proprie conclusioni sulla base del metodo scientifico. Il suo interesse per l’elettricità lo condusse anche in altri ambiti della scienza. Nel 1772 pubblicò “Storia e stato attuale delle scoperte nel campo dell’Ottica, della Luce e dei Colori” come primo volume di un’opera sulla storia della filosofia empirista, lavoro che gli fece guadagnare un invito a prestare servizio come astronomo nel secondo viaggio di James Cook. In seguito, a causa delle idee religiose e politiche di Priestley, l’invito fu però ritirato. Si occupò, inoltre, anche di questioni più strettamente filosofiche, specialmente del problema del rapporto mente-corpo: riprendendo un suggerimento di John Locke, Priestley considerava le proprietà mentali come il risultato, come l’emergenza della struttura organica del cervello e del sistema nervoso in generale. Egli non aveva naturalmente idea di come queste proprietà potessero emergere, ma sosteneva che le proprietà mentali dovessero essere postulate sulla base di prove sperimentali quali l’attrazione gravitazionale, l’affinità chimica e il magnetismo. L’abilità di Priestley nell’uso di apparecchi scientifici da laboratorio si dimostrò preziosa nei suoi studi sulle proprietà chimiche dei gas. Il suo metodo per produrre l’acqua gassata (chiamata “mephitic julep”), bevanda grazie alla quale egli sperava si sarebbe potuto prevenire lo scorbuto durante i lunghi viaggi per mare, è molto interessante, ma molto più significativa fu la sua scoperta di una varietà di gas fino ad allora sconosciuti. Nel 1772 presentò alla Royal Society lo scritto “Sui diversi tipi di gas” : fu proprio questo lavoro che fece crescere la sua reputazione di chimico. Due anni dopo, preparò la prima edizione di “Esperimenti ed Osservazioni sui diversi tipi di gas”, opera che ripubblicò molte altre volte fino al 1790. Portando avanti il lavoro di Joseph Black e James Cavendish, Priestley arricchì la conoscenza delle proprietà chimiche dei gas. Egli arrivò a distinguere nove diversi tipi di gas, solo tre dei quali erano precedentemente conosciuti dal mondo scientifico. Particolarmente importante fu la “dephlogisticated air” (aria infiammabile, cioè ossigeno), che egli riuscì a produrre il 1° agosto 1774 scaldando ossido di mercurio: divenne così chiaro che l’aria non era un Elemento. Priestley isolò l’ossigeno ed osservò la sua importanza nel processo di combustione, e in seguito furono soprattutto Cavendish e Lavoisier ad apprezzare l’importanza teorica del suo lavoro. Nel 1774 fu compagno di viaggio di Lord Shelburne in un tour europeo e pubblicò “Lettere ad uno scettico”. In patria fu successivamente marchiato come ateo, nonostante nella sua “Dissertazione sulla Materia e sullo Spirito” affermasse la speranza nella nostra resurrezione sulla base della Rivelazione. Fu nominato membro dell’Accademia Francese delle Scienze nel 1772 e della St. Petersburg Academy nel 1780; in quello stesso anno divenne anche pastore di una cappella a Birmingham. Gli anni di Birmingham furono per Priestley i più felici e produttivi della sua vita: egli poté infatti sia partecipare agli stimolanti incontri mensili della Società Lunare di Birmingham sia perseguire i suoi interessi in campo teologico. La sua “Storia delle prime opinioni circa Gesù Cristo” (1786) è sintomo di una rinnovata controversia religiosa, dal momento che questo scritto difendeva l’unitarismo ed attaccava alcune dottrine quali l’ispirazione divina delle Sacre Scritture, l’immacolata concezione, la Trinità e la remissione dei peccati. La sua risposta alle Riflessioni di Burke portò, nel 1791, alla distruzione della sua casa e del suo laboratorio da parte di una folla fedele al Re e alla Chiesa ufficiale, nemica di ogni idea progressista. Sia Burke che Lord North espressero la loro soddisfazione per gli sviluppi della faccenda, ma Priestley accettò questo affronto con stoica dignità. Preferì comunque trasferirsi a Hackney, dove insegnò Storia e Scienza al New College, sempre considerato da molti un elemento portatore di idee pericolose come il deismo e il repubblicanesimo. Fu inoltre successore di Richard Price nel ruolo di predicatore mattutino alla Gravel Pit Chapel. Nel 1792 l’Assemblea Nazionale Francese lo nominò cittadino ed egli, sebbene avesse declinato gli onori dovuti, fu anche eletto membro della Assemblée Nationale. In seguito, però, la guerra tra Francia e Inghilterra e l’esecuzione di Luigi XVI nel gennaio 1793 minarono la sua posizione. Nel 1794 Priestley e sua moglie si trasferirono in Northumbria, Pennsylvania, dove egli costruì una nuova casa e un laboratorio. Anche se non divenne mai un cittadino statunitense né prese parte alla vita politica della nazione, Priestley fu in rapporti d’amicizia sia con John Adams sia con con Thomas Jefferson: quest’ultimo vedeva Priestley come “una dei pochi uomini preziosi per tutto il genere umano”. Priestley morì il 6 febbraio 1804 in Northumbria e lì fu sepolto in un cimitero quacchero: gentile ed affabile, metodico e laborioso, Joseph Priestley era convinto che l’applicazione pratica della scienza potesse portare progressi materiali a tutto il genere umano. Fu uno dei più brillanti scienziati di tutto il XVIII secolo. Sebbene sostenesse la libertà politica e civile e scrisse anche interessanti saggi sull’argomento, egli non fu mai un leader del movimento radicale inglese per le riforme parlamentari; ciononostante, fu una delle vittime eccellenti dei movimenti conservatori degli anni Novanta del 1700. Nell’opera Disquisizioni sulla materia e sullo spirito (1777), Priestley recupera il cartesiano tema del rapporto intercorrente tra la res cogitans e la res extensa, pervenendo all’ardita conclusione che l’anima è materiale. Il pensiero stesso – nota Priestley –, lungi dall’essere una realtà spirituale, è soltanto una funzione materiale di quell’emntità del tutto materiale che noi tutti chiamiamo “anima”. Nonostante queste sue prese di posizione in favore del materialismo hobbesiano e l’abolizione della res cogitans, egli nutrì, come David Hartley, una sincera e profonda fede religiosa, accompagnata da una radicale avversione per l’ateismo dei materialisti francesi (d’Holbach, La Mettrie, Helvetius). La salvezza eterna promessa dalla religione dipende, più che un’impossibile spiritualità dell’anima, dalla finale resurrezione dei corpi. Di grande rilievo è poi la riflessione politica maturata da Priestley: a partire dal suo scritto Saggio sui primi princìpi del governo (1768), egli va sostenendo che lo scopo principale dello Stato è quello di promuovere il bene e la felicità degli uomini, in particolare del maggiorn numero possibile di uomini (tema squisitamente utilitaristico). Fu proprio grazie a queste acute riflessioni di Priestley che l’amico Thomas Jefferson fece sì che il “perseguimento della felicità” fosse sancito dalla Costituzione americana tra i diritti imprescindibili dei cittadini.
JOHN TOLAND

“Io penso di poter ora concludere che nessuna cosa è un mistero, solo perché non conosciamo la sua essenza, dal momento che essa non risulta conoscibile in sé, né mai pensata da noi: sicchè lo stesso esser divino non può essere considerato sotto questo aspetto più misterioso della più vile delle sue creature” (“Cristianesimo senza misteri”).
VITA E OPERE
TOLANDJohn Toland (1670-1722) ebbe un ruolo di rilevante importanza nella storia del panteismo; fu infatti il primo ad avere una concezione davvero particolare del panteismo, del quale inoltre coniò il termine. Egli aveva una visione prettamente scientifica e materialista, idealizzava l’unione di diverse società accomunate dalla religione panteista.
È significativo evidenziare cosa Toland stesso intendesse con il termine panteismo: ovvero che la sola divinità fosse l’Universo stesso. In seguito, furono aggiunte nei dizionari diverse definizioni che, talvolta con degli errori, crearono confusioni sul termine. Nonostante ciò, il significato fondamentale e originale che maggiormente si avvicina a tale pensiero è il “Panteismo Scientifico”.
Toland ebbe una carriera piuttosto travagliata, nacque nei pressi di Derry (nell’Irlanda del Nord) il 30 novembre 1670. Ebbe un’educazione religiosa-cattolica ma, all’età di sedici anni si convertì al Protestantesimo. Studiò in diverse città, passando per Glasgow ed Edimburgo e, successivamente, a Leida ed Utrecht. Dopo un ciclo di lezioni a Oxford, si stabilì a Londra nel 1695.
L’anno seguente pubblicò la sua prima e più famosa opera – Cristianesimo senza misteri –, un attacco frontale ai falsi culti delle immagini, paramenti, altari, processioni, rituali e al clero, tutte forme di culto che erano state aggiunte all’originaria e semplice dottrina di Cristo. Nella prima edizione, Toland restò cautamente nell’anonimato. In seguito all’inaspettato successo, legato fortemente allo scandalo provocato, Toland firmò il libro, attirando su di sé una catena di guai e di proteste da cui non si libererà per tutta la vita: il risultato fu che Toland venne via via emarginato dalla società Inglese.
Il suo libro fu duramente criticato, in Inghilterra se ne discusse parecchio fra i membri del Parlamento e fra i vescovi che si sentivano offesi (fu infatti condannato dal Grand Juri del Middlesex). Ritiratosi in Irlanda, Toland vi trovò le stesse critiche, se non maggiori. La Camera Irlandese, nel settembre 1697, stabilì che il libro fosse bruciato pubblicamente e che l’autore venisse arrestato e processato dal Procuratore Generale. Un amico di John Locke, William Molyneaux scrisse:
“Quest’uomo disperato, con la suo comportamento incauto, ha sollevato contro di lui una riprovazione così univarsale, che il solo fatto di aver parlato con lui per una sola volta potrebbe esser pernicioso”.
Ritornando in Inghilterra, solo e povero, Toland cercò di guadagnarsi da vivere trovandosi un protettore della famiglia reale e, per questo, sostenne la causa degli Hannover nei confronti della corona Inglese; tentò inoltre di influire sull’elettrice Sofia di Brunswick, ipotetica erede al trono, del favore della quale godette grazie alla mediazione di Leibniz. A lei sono indirizzate le celebri Lettere a Serena (1704).
A Brunswick e a Berlino tenne delle letture e fu coinvolto in dispute accademiche con Leibniz stesso.
Quando nel corso delle sue letture gli chiesero di riassumere il suo pensiero egli esordì in questo modo:
“Il sole è mio padre, la terra mia madre, il mondo è la mia patria e tutti gli uomini sono miei fratelli”.
Scrisse,inoltre, dei pamphlets per il Tory Robert Harleye; quando questi perse il potere, lo fece per i Whigs. Nel 1702, Toland dichiarò di appartenere alla Chiesa d’Inghilterra ma, il suo passato da notorio eretico e le sue disavventure politiche lo rendevano sospetto; ragion per cui non riuscì mai ad ottenere la fiducia di coloro ai quali aveva chiesto protezione. Il filo conduttore degli scritti di Toland è la difesa della libertà d’espressione, dei diritti civili e di un Cristianesimo illuminato. Il più delle volte, però, era costretto a scrivere trattati a pagamento nei quali non poteva esprimere le sue “vere” opinioni sulla religione. Trascorse il resto della sua vita in povertà e coperto da debiti, rovinato da investimenti nelle azioni dei Mari del Sud nel 1720. Questo fu un anno disgraziato per Toland, poichè iniziò a bere pesantemente ed a soffrire di calcoli biliari che a lungo andare lo portarono alla morte l’anno seguente.
IL PENSIERO
Poichè Toland doveva il più possibile nascondere il suo panteismo per non suscitare troppi scandali, non è chiaro quando per la prima volta adottò questo tipo di filosofia: forse all’epoca dei suoi primi giorni a Oxford, nel 1693-95. Nel suo ultimo anno lì, egli scrisse che tutte le cose sono riempite da Dio, e citò con entusiasmo l’asserzione di Strabone (Geografia, XVI, 2.25) che Mosè identificava Dio con l’universo:
“In accordo con lui, Dio è l’unica e sola cosa che comprende tutti noi e la terra e il mare-tutto ciò che noi chiamiamo cielo, universo, la natura di tutto ciò che esiste”.
Toland fu molto influenzato dal materialismo di Lucrezio, di cui lesse con interesse il De rerum natura La seconda e potente influenza esercitata su Toland fu quella del panteismo di Giordano Bruno. Nel 1698 Toland acquistò una copia rilegata della regina Elisabetta di quattro dialoghi di Bruno, e a partire da allora Toland divenne un entusiasta divulgatore delle idee di Bruno sia in Inghilterra che in Europa. Le idee di Toland erano una miscela di quelle di Lucrezio e di quelle di Bruno, non originali in dettaglio, ma originali se combinate insieme. A meno che noi non consideriamo Lucrezio stesso un panteista, è fuor di dubbio che Toland debba essere considerato il padre del panteismo scientifico moderno, il primo a combinare uno stretto materialismo con il rispetto per la scienza dei suoi tempi, con una religiosa venerazione dell’universo. Toland usò per la prima volta il termine “panteismo” nel 1705, senza alcuna spiegazione, nel titolo della sua opera Socinianism Truly Stated, by a pantheist. Nel 1710, in una lettera a Leibniz, egli fornì alcuni contenuti al termine quando affermò esplicitamente che “il panteismo crede che non esista nulla di eterno se non l’universo stesso” [14 febbraio 1710]. Ma solo nel 1720 che Toland chiaramente definì se stesso come panteista. In quell’anno, povero, indebitato, ignoto ai più, non avendo nulla da perdere, pubblicò il suo Pantheisticon, mettendo a punto la filosofia. Anche la pubblicazione del libro fu a suo modo segreta: fu pubblicato in latino, in modo da renderlo accessibile solo alle persone di cultura elevata. Fu stampato a sue spese e distribuito da Toland solo agli amici più fidati. In un’età di libertà di parola e di pluralismo religioso sarebbe troppo semplice considerare questi sotterfugi come segni di viltà: bisogna infatti ricordare che Toland viveva in un’epoca in cui le persecuzioni erano finite da pochissimo (ancora nel 1697 Thomas Aitkenhead era stato brutalmente messo a morte per aver messo in dubbio il dogma della trinità). La persecuzione sociale era ancora diffusa e Toland stesso aveva messo in pericolo la sua carriera con le sue critiche del Cristianesimo convenzionale. In questo suo lavoro Toland asserisce che l’Universo è costituito di sola materia, che contiene entro se stesso il suo proprio principio di movimento. L’Universo è infinito senza centro nè periferia, con un infinito numero di pianeti e stelle. Tutte le cose sono in continuo cambiamento, una “incessante rivoluzione di tutti gli esseri e forme esistenti” alle quali, dato un tempo infinito, tutte le combinazioni si potranno un giorno verificare. La mente umana e l’anima sono proprietà del cervello, che è anch’esso un organo materiale. Toland affermava che i panteisti avrebbero dovuto avere una doppia filosofia, una per uso pubblico e una per uso privato. In pubblico, essi avrebbero dovuto conformarsi alla religione stabilita dalla società nella quale vivevano. “Il Panteista non dovrebbe mai scontrarsi apertamente con la teologia, se da ciò può derivargli un danno”, scriveva nel Pantheisticon; e aggiungeva: “ma egualmente egli non dovrà rimanere in silenzio se dovesse avere l’occasione di parlare senza rischiare la vita”. Toland non disponeva di nessun piano per diffondere il panteismo fra le masse dei suoi tempi. Le masse ignoranti, egli sosteneva, avrebbero preferito farsi raccontare favole e miti piuttosto che la verità, mentre gli avidi di potere e i corrotti, sia nella Chiesa che nello stato, avrebbero sempre preferito fare i baciapile per conto di una religione formale al fine di ottenerne vantaggi personali. I Panteisti avrebbero dovuto condividere e discutere le loro idee al riparo da orecchie indiscrete, in ritrovi esclusivi solo per persone colte. Ogni club avrebbe dovuto avere un presidente che avrebbe dovuto essere a capo delle liturgie. I membri avrebbero dovuto essere morigerati da tutti i punti di vista e intrattenere seri dibattiti sulle loro opinioni. D’estate, avrebbero dovuto pranzare all’aria aperta, d’inverno ai raggi del sole o di fronte a un fuoco scoppiettante. La liturgia che Toland offriva era una pittoresca e malinconica combinazione di un breve credo, lodi degli antichi filosofi, la recita di odi di Orazio e frasi tratte da opere di Catone e Cicerone. L’inizio della cerimonia si svolgeva in modo alquanto comico, fra scene da romanzo di cappa e spada e alta filosofia. Sembra molto probabile che Toland non abbia mai organizzato una società specificamente panteista del tipo che egli ha descritto. Anche nel Pantheisticon stesso, egli lascia trasparire dei riferimenti a ciò:
“La gente mi può chiedere se davvero possa esistere una società come questa, o se è solo una finzione. Può anche darsi che sia così, ma se anche così fosse, cosa importa? Se anche non è vero, come minimo può essere di aiuto il solo pensare che così potrebbe essere”.
Abbiamo già accennato a come, il recupero del panteismo, coincida in Toland con la critica del Cristianesimo e si traduca in un deismo panteistico e critico, che rigetta il dogma del miracolo, la separazione della morale dalla religione, la riconduzione del nucleo religioso alla “verità rivelata”. Seguace della Ragionevolezza del Cristianesimo di Locke (il quale però rifiutò tale paternità spirituale), anche Toland, in sintonia con gli altri deisti inglesi (Collins, Tindal, ecc) si propone di ricondurre la religione ai dettami della ragione, epurandola da ogni aspetto che non si accordi con la ragione stessa. La tesi della “ragionevolezza del Cristianesimo” era usata da Locke in funzione apologetica: ora, Toland la usa invece in funzione polemica, ritenendo che sia necessario eliminare dalla Scrittura tutto quel che è irriducibile alla ragione, tutto ciò che è misterioso. Non esistono verità “al di sopra della ragione” che non siano anche “contrarie alla ragione”.
Ecco perché, in Cristianesimo senza misteri, egli critica la nozione di mistero inteso come realtà ultima che va al di là delle specie sensibili e conoscibili dalla ragione umana: egli recupera la distinzione lockeana tra “essenza nominale” (semplice sintesi, perfettamente conoscibile, delle qualità sensibili di una cosa) ed “essenza reale” (la sostanza che sta sotto alle qualità sensibili come loro principio metafisico). Quando si parla di misteri, dice Toland, ci si riferisce all’ “essenza reale”, che però sfugge sempre alla presa della ragione umana, la quale può conoscere solo le proprietà delle cose e mai la sostanza. Ma poiché è sufficiente conoscere le proprietà per avere una conoscenza adeguata (che fornisca cioè indicazioni pratiche senza per questo essere onnicomprensiva), ne segue che la rinuncia alla comprensione della sostanza delle cose si traduce in abbandono del concetto di mistero.
Toland sviluppa anche un nuovo criterio di esegesi biblica, individuando i due piani sui quali deve poggiare una corretta interpretazione delle Scritture: quello filosofico, che consente di mettere il Testo Sacro in relazione con la razionalità umana, e quello storico, legato, in particolare, alla conoscenza dei documenti e della tradizione della religione ebraica. A tal proposito, così scrive Toland:
“Chiunque fa una rivelazione, cioè chiunque ci informa di qualcosa che non sapevamo prima, deve parlare con parole comprensibili, e il fatto deve essere possibile. Questa regola si mantiene valida sia che l’autore della rivelazione sia Dio o l’uomo. Se consideriamo folle la persona che esige il nostro assenso a ciò che è evidentemente incredibile, come osiamo attribuire in modo sacrilego all’essere piú perfetto un difetto riconosciuto come tale in uno di noi? Per quanto riguarda i messaggi incomprensibili, non possiamo credervi per rivelazione divina, piú che per quella umana; infatti le idee che si formano delle cose sono i soli oggetti degli atti di credere, negare e approvare, e di ogni altra attività dell’intelletto: perciò tutte le cose rivelate da Dio o dall’uomo devono essere ugualmente comprensibili e possibili; e fin qui l’una e l’altra rivelazione coincidono. Ma esse sono differenti in questo, che per quanto la rivelazione dell’uomo presenti tali requisiti, egli può tuttavia ingannarmi riguardo alla verità del fatto, mentre ciò che a Dio piace di rivelarmi non è soltanto chiaro alla mia ragione (senza di che la sua rivelazione non potrebbe rendermi piú saggio), ma è anche sempre vero. Una persona ad esempio mi informa di aver trovato un tesoro: questo è chiaro e possibile, ma egli può facilmente ingannarmi. Dio mi assicura che ha formato l’uomo dalla terra: questo non soltanto è possibile a Dio, e molto comprensibile per me, ma è anche una cosa assolutamente certa, poiché Dio non è capace di ingannarmi come l’uomo. Dobbiamo dunque aspettarci lo stesso grado di chiarezza da parte di Dio e dell’uomo, ma una maggiore certezza da parte del primo che del secondo” (Cristianesimo senza misteri, Sez. II, Cap.II).
DAVID HARTLEY

A cura di Mai Saroh Tassinari
PRESENTAZIONE
David Hartley (1705-1757) è l’autore delle Osservazioni sull’uomo, la sua costituzione, il suo dovere e le sue aspettative (1749) – un compendio di ampio respiro sulla neurologia, la psicologia morale e la spiritualità (cioè, la nostra costituzione, il nostro dovere e le nostre aspettative). Le Osservazioni si guadagnarono devoti sostenitori in Inghilterra, in America e nell’Europa continentale, dove erano apprezzate sia per la loro scienza che per la loro spiritualità. In quanto scienza, l’opera basa la coscienza sulla neuro-fisiologia e la mente sul cervello. Su questa base, il concetto centrale di “associazione”, assai discusso tra filosofi e psicologi inglesi, è trattato a parte: il termine denomina dapprima il processo fisiologico che genera le “idee”, e in seguito i processi fisiologici per mezzo dei quali le percezioni, i pensieri e le emozioni si collegano e si fondono tra di loro. Conservando questo approccio fisiologico, Hartley offre una descrizione concettualmente nuova di come impariamo e compiamo azioni specifiche, una dimensione della natura umana, questa, che spesso viene tralasciata nelle opere di filosofia. In qualità di lavoro concernente la condizione spirituale dell’umanità, le Osservazioni proclamano la salvezza universale – la promessa che tutti, alla fine, diventeranno “partecipi della natura divina”. A questo proposito, il libro presenta un modello originale di crescita psicologica, che descrive come l’io si formi e si trasformi nella misura in cui acquisisce l’armonia con gli altri e con Dio, o, detto più semplicemente, nella misura in cui impara ad amare sia gli altri che Dio.
BIOGRAFIA
Figlio di un pastore anglicano, David Hartley nacque nel giugno 1705 presso Halifax, nello Yorkshire. Sua madre morì tre mesi dopo la sua nascita e suo padre quando David aveva quindici anni. Dopo aver conseguito la laurea e il dottorato al Jesus College di Cambridge, praticò medicina a Bury St. Edmunds (1730-35), Londra (1735-42) e Bath, dove morì il 28 agosto 1757. Si sposò due volte: nel 1730 con Alice Rowley, che morì nel 1731 nel dare alla luce il loro figlio David (1731-1813); e nel 1735 con Elizabeth Packer (1713-78), nonostante l’opposizione della assai abbiente famiglia di lei. La coppia ebbe due figli, Mary (1736-1803) e Wincombe Henry (1740-94). Anche se afflitto da calcoli alla vescica, Hartley visse una vita piena e attiva: praticò medicina, si impegnò nella ricerca matematica, cercò una cura per i calcoli, si dedicò a progetti intellettuali e filantropici e scrisse le Osservazioni sull’uomo.
REAZIONI ALLE OSSERVAZIONI SULL’UOMO
Nel diciottesimo e diciannovesimo secolo, le Osservazioni furono valutate molto positivamente dalle persone facenti parte dei circoli del dissenso religioso, del progresso scientifico e della riforma sociale. Nel 1774 Joseph Priestley, filosofo materialista ed eminente scienziato, scrisse che le Osservazioni “contengono una nuova e più ampia scienza” e promise che “il loro studio […] sarà come entrare in un nuovo mondo”. Aggiunse: “ritengo di essere io stesso maggiormente in debito nei confronti di questo unico trattato che verso tutti gli altri libri che ho mai letto; eccetto le Sacre Scritture”.
Priestley e gli altri Unitari diedero alle Osservazioni un posto centrale nel curriculum di studi delle università dissenzienti. (Per essere ammesso alle università di Oxford e Cambridge, uno studente doveva aderire alle dottrine della Chiesa di Inghilterra – una richiesta che escludeva gli Unitari, che non accettavano che Gesù fosse Dio; da qui il bisogno di avere delle istituzioni accademiche proprie). Da un resoconto, apprendiamo che in una di queste università dissenzienti gli studenti leggevano e analizzavano quest’opera per due ore, ogni mattina. Inoltre, negli ultimi anni del 1700, i radicali di Cambridge e Oxford ne possedevano anche loro delle copie.
Così le Osservazioni erano al centro di uno studio prolungato e di una elevata considerazione – secondo Prestley, questo era il libro più importante, dopo la Bibbia. Il poeta Samuel Taylor Coleridge, convertito all’Unitarismo Prestelyano a Cambridge, si fece ritrarre con una copia delle Osservazioni in mano e chiamò il suo primo figlio David Hartley Coleridge. Altri scrittori offrono simili testimonianze.
Mentre gli ammiratori di quest’opera la consideravano “una nuova scienza” della natura umana, i suoi critici – tra cui Thomas Reid, esponente della Scuola scozzese, e il Coleridge degli ultimi anni, non più il giovane radicale – la ritenevano concettualmente erronea e moralmente pericolosa. Ad esempio, Sir James Mackintosh, che pure lodò appassionatamente “lo straordinario valore del sistema di Hartley”, vedeva che nel suo credo la coscienza derivava dai processi neurologici un “errore […] più profondo e più sostanziale di qualsiasi altro”, che avrebbe sicuramente “avvolto tutta la natura nel buio e nella confusione”.
Durante il diciannovesimo secolo, James Mill, John Stuart Mill e William B. Carpenter (i quali avevano tutti studiato le Osservazioni in facoltà dissenzienti), assieme ad Alexander Bain, fondarono la scuola di pensiero nota come “psicologia associativa” e ritenevano che Hartley fosse stato il precursore della scienza che essi avevano sviluppato. Ad ogni modo, John Stuart Mill scrisse nella Prefazione all’edizione del 1869 dell’Analisi dei fenomeni della mente umana di suo padre che, in confronto, le Osservazioni non erano “nient’altro che un semplice abbozzo, anche se molto suggestivo”. Difficilmente questa dichiarazione poteva essere considerata come una raccomandazione a leggere il libro sul quale i Mill avevano trascorso così tante ore da studenti. Perché guardare il canovaccio, quando era disponibile il ritratto terminato?
Alla fine del XIX secolo, l’unitarianismo priestleyano, in quanto tradizione di pratica filosofica, era scomparso; i filosofi accademici, specialmente quelli educati nella Scuola scozzese del “senso comune” (la filosofia ufficiale insegnata, ad esempio, dagli Unitari che dirigevano Harvard), sapevano che le Osservazioni si basavano su di un errore di fondo, e gli psicologi associativi conservavano solo più un ricordo sbiadito del precursore della loro scienza. L’interesse iniziale per quest’opera, che a suo tempo era stata letta, analizzata, discussa nelle lezioni universitarie, citata in articoli e libri, era svanito. L’ultimo che si raffrontò con le Osservazioni in maniera approfondita fu William James nei suoi Principi di psicologia, e anche in questo caso a un lettore disattento potrebbe sfuggire tale riferimento.
Nel XX secolo, le Osservazioni sono rimaste al di fuori del curriculum filosofico: coloro che studiavano filosofia potevano seguire un cammino ben battuto, a partire dagli “empirici inglesi” fino a Kant, senza fermarsi a prenderle in considerazione. E anche se qualcuno lo avesse voluto, sarebbe stato difficile, perché dopo le edizioni del 1749, 1775, 1791, 1810 e 1834, e le traduzioni in francese (1755 e 1802), tedesco (1772) e italiano (1809), non ne vennero pubblicate altre. Oggi sono disponibili delle ristampe in brossura di edizioni precedenti, ma non esiste nessuna edizione critica moderna. Nel suo Secondo trattato sul governo, John Locke fece la celebre affermazione secondo la quale “il lavoro determina la proprietà”. È il lavoro delle persone nei campi della filosofia che definisce un testo filosofico in quanto “proprietà” – che ne delinea i confini e ne definisce il valore. Ma un’opera che è rimasta al di fuori dell’economia pedagogica della filosofia contemporanea, come le Osservazioni, dimora in una posizione ambigua. Se oggi una persona prendesse in mano questo libro, si ritroverebbe con un trattato riguardante una costellazione di argomenti. Come determinarne l’appartenenza? E come rispondere al quesito economico: qual è il suo valore? Per poter porre queste domande, immaginiamo come uno dei colleghi di Hartley, un Membro della Royal Society, possa aver reagito all’apparizione del libro nel 1749.
LE OSSERVAZIONI – UN PRIMO APPROCCIO
Un membro della Royal Society che avesse frequentato regolarmente la società londinese, sarebbe sicuramente stato a conoscenza di Hartley e avrebbe saputo che egli era uscito vittorioso da una controversia medica pubblica dieci anni prima, la quale aveva confermato la sua reputazione nei circoli medici sia in Inghilterra che sul continente. Hartley, con Stephen Hales, aveva ricercato la base chimica per ciò che essi ritenevano un rimedio popolare efficace per i calcoli della vescica – una condizione estremamente dolorosa e pericolosa che affliggeva Hartley stesso e molti altri, tra cui Benjamin Franklin. Durante la controversia, Hartley aveva pubblicato una descrizione rivelatrice delle prolungate e intense sofferenze che aveva sopportato mentre era sotto trattamento. Il membro della Royal Society sarebbe stato a conoscenza del fatto che questo orfano, figlio di un pastore dello Yorkshire, era divenuto un fisico di successo, che, in parte grazie a mecenati potenti (tra i quali la famiglia Cornwallis e il duca di Newcastle, che era anche primo ministro), in parte grazie al suo secondo matrimonio, era venuto in possesso di un considerevole patrimonio, e che si era dedicato a vari progetti filantropici, tra cui la pubblicazione del sistema stenografico ideato dal suo amico, John Byrom. Se il membro della Royal Society avesse conosciuto Hartley come amico, avrebbe saputo che era un matematico con uno speciale interesse per la statistica, un violinista dilettante e un vegetariano che credeva che gli animali avessero una “stretta relazione” con gli esseri umani. Lo avrebbe conosciuto nei panni di marito e padre (a differenza di Cartesio, Locke, Hume e Kant). Sarebbe stato al corrente del fatto che spesso soffriva di dolori atroci ed era in pericolo di vita a causa dei calcoli; e avrebbe saputo che era un uomo dal credo religioso profondamente anticonvenzionale. Prendendo in mano le Osservazioni, tale lettore avrebbe visto che il libro si presentava come scienza newtoniana – sia attraverso l’uso del termine “Osservazioni” nel titolo (cfr. due testi altamente innovatori, gli Esperimenti e osservazioni sull’elettricità di Franklin, 1751, e gli Esperimenti e osservazioni di diverso tipo sull’aria di Priestley, 1774), sia attraverso la struttura geometrica dei paragrafi e dei corollari che definiscono il testo. Se avesse sfogliato le sezioni introduttive, avrebbe visto che Hartley aveva scritto per un lettore già familiare con i concetti tecnici di, ad esempio, anatomia, fisiologia e di fisica speculativa dell’Ottica di Newton. Se il lettore si fosse spinto oltre le proposizioni iniziali, avrebbe incontrato elementi di un’altra tradizione, più antica: riferimenti al “perfetto auto-annullamento, e il puro amore di Dio”(2, par. 67) e citazioni di passaggi biblici riguardanti la promessa di diventare “partecipi della natura divina” (2 Pietro. 1.4). Tutte queste cose inseriscono Hartley negli ambiti del pietismo e del misticismo. In particolare, esse sono espressioni dell’“eterno vangelo” della salvezza universale, perché le Osservazioni prevedono il recupero di un’umanità caduta, frammentata e autoemarginata in un’umanità perfetta, in cui tutti, senza eccezione, saranno “membri del corpo mistico di Cristo” e in quanto tali diventeranno “nuovi insiemi di sensi e facoltà percettive gli uni per gli altri, in modo da accrescere a vicenda la felicità senza limiti” (2, par. 68; cfr. par. 35). Né l’approccio scientifico all’uomo, né la dichiarazione della salvezza universale erano di per sé originali. Si poteva trovare il primo nella letteratura medica e in Cartesio. Per trovare delle versioni del “vangelo eterno” si potevano considerare vari scrittori, tra i quali Peter Sterry, il cappellano di Cromwell, ne Un discorso sulla libertà d’arbitrio (1675), Jeremiah White, altro cappellano di Cromwell, ne La restaurazione di tutte le cose (1712), il visionario Jane Lead, il matematico Thomas Bayes, in Divina benevolenza (1731) e, sul continente, Charles Hector de Marsay. Ciò che contraddistingue le Osservazioni è la presenza simultanea di due approcci. Anche se Hartley afferma che l’intera persona è un “meccanismo”, soggetto allo studio scientifico, non è un ateo francese, né un La Mettrie (autore del noto L’uomo-macchina, 1748), ma una persona dalla profonda sensibilità religiosa; di conseguenza, proclama la salvezza universale, ma senza il misticismo allucinatorio di Lead o Marsay. Piuttosto, la dottrina è sorretta da un’applicazione del più recente pensiero scientifico. Se si considera il titolo intero: Osservazioni sull’uomo, la sua struttura, il suo dovere e le sue aspettative, si può comprendere come Hartley tenti di fornire una sintesi, mostrando che la “struttura” corporea, il “dovere” morale e le “aspettative” religiose convergono tutti allo stesso punto e quel punto consiste nel superamento dell’abisso tra paradiso e inferno. Si ricordi che Hartley, come altri Unitari, credeva che la divinità di Gesù e la sua espiazione dei peccati fossero dottrine che oscuravano la luce originale della Cristianità. In questo senso, una spiegazione della “salvezza” in quanto qualcosa di esterno e di immeritato non trova spazio all’interno del suo pensiero. Egli offre più che altro una descrizione scientifica di come siamo strutturati, sia fisicamente che psicologicamente, in modo da raggiungere, in ultima istanza, lo stato in cui siamo tutti “partecipi della natura divina, dando e ricevendo amore, santi e felici” (2, par. 56).
LA SCIENZA DELL’UOMO
La dimensione scientifica delle Osservazioni è in parte metodica e in parte sostanziale. In quanto al metodo, Hartley propone l’indagine scientifica dell’uomo. Come già notato, questo non è un fatto originale: i fisici avevano fatto la stessa cosa da decenni e c’erano degli esempi anche nelle Passioni dell’anima (1649) e nel Trattato sull’uomo (1664) di Cartesio, e nel Trattato sulla natura umana (1739-40) di Hume, pubblicato anonimamente (anche se non c’è nessuna prova che Hartley conoscesse Hume, o che Hume conoscesse Hartley). Ad ogni modo, ciò che contraddistingue le Osservazioni è che applicano la scienza newtoniana allo studio della natura umana.
Dovremmo assumere, scrive Hartley, che le “particelle costituenti” del corpo siano “soggette alle stesse leggi ingegnose” (1, par. 9) che regolano tutte le altre entità materiali. Le leggi ingegnose sono quelle che Newton aveva suggerito nella sua Ottica e che Stephen Hales (1677-1761, ricordato oggi come il padre della fisiologia delle piante e per la misurazione della pressione sanguigna) sviluppò ulteriormente nella teoria chimica nei suoi Saggi statici. Cartesio aveva precedentemente proposto un modello di fisiologia neurale, ma nell’Inghilterra degli anni attorno al 1740 la fisica dalla quale dipendeva questo modello sarebbe sembrata superata. Hartley, al contrario, presentò una “teoria delle vibrazioni” che spiegava in dettaglio come le “particelle costituenti” che costituiscono i nervi e il cervello interagiscono con l’universo fisico postulato da Newton – un mondo costituito da “forze di attrazione e repulsione”, e avente un minimo di materia solida. Per quanto riguarda la sostanza, Hartley scrive:
“Quindi, siccome le sensazioni sono mostrate alla mente dall’efficienza delle cause individuali […] mi sembra che le facoltà di generare delle idee e di plasmarle per mezzo dell’associazione, debbano anch’esse originarsi da cause individuali e di conseguenza ammettere una esplicazione dalle sottili influenze delle piccole particelle di materia le une sulle altre, non appena queste vengono comprese in maniera sufficiente” (1, par. 11).
Si noti il linguaggio: “cause individuali”, “generare” e “plasmare” idee “tramite l’associazione”. A differenza degli “psicologi associazionisti” successivi, come James Mill, Hartley non parte dalle idee in quanto entità soggettive già presenti empiricamente nella mente, per poi chiedere come siano relazionate tra di loro. Parte, invece, da dei processi neurologici e si chiede: in che modo tali processi generano e plasmano le nostre percezioni, le nostre emozioni, i nostri pensieri e le nostre azioni? Questo è un quesito per la neuroscienza, non una versione dell’empirismo filosofico e psicologico.
Se le reazioni di un sistema nervoso al suo ambiente fisico possono generare e plasmare un’idea, possono generarne altre, tutte. Così, “l’intera superstruttura delle idee e delle associazioni osservabile nella vita umana può […] essere basata su un fondamento piccolo quanto vogliamo” (1, par. 11). Per Hartley, questo fondamento è semplice: i nervi “vibrano” (a un livello molecolare, non come corde di violino), cambiano le loro frequenze o estensioni di vibrazione e trasmettono questi cambiamenti agli altri nervi. Ma grazie al vasto numero di connessioni associative tra i nervi e all’interno del cervello, questo meccanismo fondamentale genera tutte le complessità d’azione che osserviamo negli esseri viventi – sia animali che umani.
Il primo volume delle Osservazioni termina con un’affermazione audace: se un organismo “può essere rivestito dai tipi più semplici di sensazioni, può anche giungere a tutta quell’intelligenza da cui la mente umana è posseduta” (1, Conclusione).
Tale è un’espressione dell’“errore […] più profondo e più sostanziale di nessun altro” con cui Mackintosh accusava Hartley: quello di tralasciare “la distinzione primordiale e perpetua tra l’essere che pensa e la cosa che è pensata”. Cartesio aveva mantenuto questa distinzione postulando un dualismo di corpo e mente (e considerando gli animali come meri meccanismi senza coscienza e gli umani come esseri razionali e coscienti) e, come Hume e più tardi James Mill, l’aveva rispettata scrivendo a proposito dei contenuti delle menti consce e tenendosi alla larga dalla neurofisiologia. Ma Hartley ignora la distinzione tra “pensante” e “pensato” ed afferma che i processi neurologici generano la coscienza. Secondo lui, gli animali sono esseri consapevoli, dotati di sensazioni, e, nel caso di alcune specie neurologicamente complesse, dei loro peculiari tipi di intelligenza: per questo ribadisce il loro “stretto legame” con noi, legame che ci obbliga a “essere i loro guardiani e benefattori” e che è la ragione che ci impedisce di farli soffrire per il nostro svago o il nostro utile e di ucciderli per procurarci il cibo (1, par. 93; cfr. 2, par. 52). Ciò che ci separa dagli animali sono solo delle semplici differenze di tipo neuro-anatomiche. Correggendo Locke, Hartley è convinto che non esistano idee di riflessione, ma solo di sensazione. Si accetti il fatto che “tutta quell’intelligenza di cui la mente umana è posseduta” possa essere derivata da un organismo che possiede “i più semplici tipi di sensazione”, cosa ne segue? Per molti, una linea di pensiero “che avvolge tutta la natura nel buio e nella confusione”. Per altri, tra cui Prestley, la via per “entrare in un nuovo mondo” di scoperta scientifica libera dal dualismo di spirito e materia.
PERCEZIONE E AZIONE: IL RUOLO DELL’“IMPRESSIONE CONGIUNTA”
Il punto di partenza di Hartley è l’organismo vivente e più precisamente le “vibrazioni” fisiche presenti nel cervello, nel sistema nervoso e nell’universo con cui interagisce l’organismo. A questo punto, seguono due importanti considerazioni: la prima è che le sensazioni e le idee sono dei prodotti, non delle cose scontate, perciò richiedono una spiegazione; la seconda implica l’ammissione del fatto che gli organismi sono degli esseri attivi. Come altri animali, gli uomini si muovono, esplorano e interagiscono all’interno del loro ambiente; inoltre, diventano esperti nel compiere svariati tipi di azioni altamente specializzate come, ad esempio, suonare il violino. Le “idee” che gli umani hanno servono in gran parte per guidare tali pratiche. Riguardo la prima considerazione, anche se l’associazione è un concetto centrale nelle Osservazioni, non è solo un nome per definire il processo per cui semplici e discrete entità empiriche si congiungono tra di loro, ma indica anche il processo dell’associazione neurologica che genera le idee, incluse le nostre categorie della percezione. Nel paragrafo 11, Hartley afferma che “le idee, e le mini-vibrazioni, devono prima essere create […] per poi poter essere associate.” Aggiunge:
“Ma poi (cosa degna di nota) questo potere di plasmare le idee e le loro mini-vibrazioni corrispondenti, presuppone in ugual maniera il potere dell’associazione. Poiché, siccome tutte le sensazioni e le vibrazioni sono infinitamente divisibili rispetto al tempo e allo spazio, potrebbero non lasciare né tracce né immagini di se stesse, cioè nessuna idea o mini-vibrazione, a meno che le loro parti infinitesimali non vengano unite dall’impressione congiunta, cioè dall’associazione” (1, par. 11).
Affermando che “tutte le sensazioni e le vibrazioni sono infinitamente divisibili”, Hartley elabora un punto esposto da George Berkley nel suo Saggio riguardo una nuova teoria della visione, secondo il quale un ipotetico essere nato privo del senso del tatto e che possiede solo la vista non avrebbe nessun concetto dello spazio e sarebbe incapace di percepire un mondo ordinato geometricamente. Per tale essere, le sensazioni sarebbero “infinitamente” – cioè arbitrariamente – divisibili e nessuna “idea” stabile e ripetibile potrebbe essere originata da esse.
Hartley concorda con Berkley anche riguardo alla soluzione di questo problema: noi percepiamo un mondo coerente grazie alla generazione di “idee” (reazioni cognitive, semantiche e pragmatiche al mondo), la quale avviene attraverso l’associazione di sensazioni provenienti da modalità sensoriali distinte – la vista, l’udito e soprattutto il tatto. Come Berkley, Hartley descrive il tatto come “la fonte principale dell’informazione rispetto alle proprietà essenziali della materia” e come “la nostra chiave principale per la conoscenza del mondo esterno” (1, par. 30) e scrive: “diamo al tatto il nome di realtà e definiamo la luce come ciò che rappresenta”. La vista “può essere considerata, in accordo con l’osservazione di Berkley, come un linguaggio filosofico per le idee della sensazione.”
Un “linguaggio filosofico” è un linguaggio “senza nessun difetto, nessuna superficialità o equivoco” e ciò che rende la vista un “linguaggio filosofico” nei confronti del tatto è che i due si corrispondono: “le stesse qualità sono create per mezzo della luce per imprimere le vibrazioni nei nostri occhi e tali qualità corrispondono in gran parte a quelle create dal tatto, così da variare in accordo con le variazioni di queste ultime” (1, par. 30). Il tatto e la vista vanno di pari passo, senza nessun movimento mancato, diverso, o equivoco. È quindi l’associazione, la correlazione dei flussi della sensazione attraverso due (o più) modalità sensoriali, in modo che le sensazioni “varino in accordo con le variazioni” le une delle altre, che spiega perché abbiamo delle idee.
Invece, una persona i cui input visuali sono dissociati dagli altri sensi, e soprattutto dal moto e dal tatto, non può identificare in maniera coerente nessuna “idea visuale”; tale è la condizione di una persona che soffre di agnosia visiva.
Questa prima considerazione porta quindi in maniera del tutto naturale alla seconda, poiché sia Hartley che Berkley, prima di lui, trattano le azioni di un essere concreto, un essere vivente le cui capacità per la differenziazione sensoriale e la categorizzazione percettiva sono tutte impiegate nei repertori delle azioni che quell’essere compie, sia innatamente che attraverso l’apprendimento.
Per molti animali, i modi in cui i movimenti fisici variano con il variare degli stimoli visuali sono relativamente fissi: i gatti balzano sui topi (alcuni di pezza) e colpiscono le farfalle (o ombre che si muovono su una parete illuminata dal sole). Per gli esseri umani, grazie all’elasticità del cervello nel formare delle associazioni, ci sono molti modi in cui le “varietà” di una sensazione “variano a seconda del variare” di un’altra: alla vista delle note su di un pentagramma, le dita si muovono in una determinata maniera sopra la tastiera di un pianoforte, ma i musicisti esperti, alla vista delle note, odono la melodia nella loro mente.
Ma come spiegare ciò che fa il musicista, o qualsiasi professionista esperto? E come si può imparare a fare ciò?
LA GAMMA DELLE AZIONI: DA “AUTOMATICO” A “DECOMPLESSO”
Nelle Osservazioni, Hartley offre una trattazione concettualmente nuova dell’azione fisica – un argomento per lo più assente in altri trattati, o ricerche, sulla natura umana o sull’intelletto umano. Perfino nell’Analisi dei fenomeni della mente umana di James Mill, un’opera con un debito riconosciuto nei confronti di Hartley, l’azione fisica è trattata solo nell’ultimo capitolo, “La volontà”. Ma a un attento “osservatore dell’uomo”, dovrebbe essere ovvio che viviamo compiendo atti che dipendono da repertori di movimenti perfezionati, alcuni (come camminare) imparati nell’infanzia, altri (come suonare il pianoforte) più tardi nel corso della vita.
Hartley ha inventato due parole per descrivere i movimenti fisici: “automatico” e “decomplesso”. Ha formato l’aggettivo “automatico” da un nome già esistente, “automa”, per descrivere movimenti quali “i moti del cuore e il “movimento peristaltico delle viscere”. Tali movimenti “originariamente automatici” sono omeostatici: quando un cuore batte, l’alternarsi di contrazione e rilassamento è mantenuto e modificato in risposta alle esigenze dell’organismo (1, par. 19).
Segue alla discussione del movimento “originariamente automatico” questo teorema: “se una qualsiasi sensazione A, idea B, o movimento C viene associata […] con una qualsiasi altra sensazione D, idea E, o movimento F, ciò provocherà d, la semplice idea che appartiene alla stessa sensazione D, la stessa idea E, o lo stesso movimento F” (1, par. 20). Tramite l’associazione fisica o gli impulsi nervosi nel cervello, qualsiasi sensazione, idea, o movimento muscolare può diventare lo stimolo che provoca qualsiasi altra idea o movimento muscolare; per fare un esempio, il cuore di una persona batte più velocemente alla vista, al suono, o al pensiero di qualcosa che uno ha appreso a temere.
La formazione di tali nuove associazioni di stimoli alle reazioni fisiologiche significa che i movimenti “originariamente automatici” possono diventare dei movimenti “volontari” o “secondariamente automatici” (1, par. 21).
Un’azione è volontaria quando il suo stimolo è “un’idea, o uno stato d’animo […] che noi chiamiamo volontà” (1, par. 21). Per illustrare come le idee del tipo “la volontà di …” derivano da movimenti “originariamente automatici”, Hartley descrive come un bambino acquisisce il controllo motorio di parti e funzioni del suo corpo. I movimenti “originariamente automatici” vengono controllati per mezzo di una serie di sostituzioni dello stimolo iniziale. Un bambino afferra il dito che si trova nel suo palmo, poi il giocattolo che vede e poi afferra “al suono delle parole afferra, prendi, ecc.… alla vista della mano della bambinaia …” Queste e “altre innumerevoli circostanze simili […] indurranno il bambino ad afferrare fino a quando, alla fine, quell’idea, o stato d’animo, che possiamo definire come la volontà di afferrare, viene generata e associata a sufficienza con l’azione da produrla istantaneamente.”
È importante notare che, nella descrizione di Hartley, il compimento di un movimento volontario non è un processo a due fasi, con una “facoltà” esecutiva della Mente, la Volontà, che dapprima fornisce l’istruzione che poi il corpo esegue. Piuttosto, un movimento diventa volontario attraverso l’interazione dell’essere vivente con le “innumerevoli […] circostanze correlate” del suo ambiente e tale interazione causa una serie di sostituzioni dello stimolo iniziale. In questa luce, la “volontà” non denota nulla di concreto: è un termine usato per descrivere “un’idea, o uno stato d’animo” ed è un termine che la gente usa spesso per esprimere perplessità nei confronti di ciò a cui equivale lo “stato d’animo”. Hartley nota che gli adulti incominciano a considerare un bambino come dotato di volontà propria nel momento in cui incomincia a camminare, perché “il bambino, in alcuni casi, non cammina se non vuole, anche se le circostanze sono apparentemente le stesse di quando cammina. In questo caso la causa non palese del camminare, o del non camminare, è la volontà” (1, par. 77). Ma aggiunge: “un’attenta osservazione […] mostrerà sempre […] che quando i bambini fanno cose diverse, le circostanze reali, naturali o associate, sono proporzionalmente diverse, e che lo stato d’animo chiamato volontà dipende dalla differenza.”
Le sequenze di sostituzione trasformano le azioni originariamente automatiche in volontarie e questo processo continua fino a quando le azioni volontarie non diventano a loro volta ciò che Hartley definisce “secondariamente automatico”:
“Dopo che le azioni, che sono in tutto e per tutto volontarie, sono state rese tali da un tipo di associazioni, possono essere rese, da un altro tipo, dipendenti dalle più piccole sensazioni, idee e movimenti, talmente piccole che la mente le considera appena, o non ne ha quasi coscienza […]. Ne consegue che l’associazione non solo muta le azioni automatiche in volontarie, ma anche quelle volontarie in automatiche, poiché queste azioni […] sono da attribuire più al corpo che alla mente […]. Li chiamerò movimenti automatici del secondo tipo per distinguerli da quelli che sono originariamente automatici e da quelli volontari” (1, par. 21).
Si pensi a quando si impara a suonare uno strumento: dapprima si sviluppa un insieme di movimenti volontari, ma la bravura richiede che i movimenti siano secondariamente automatici.
Per i suoi critici, soprattutto Reid e il Coleridge più maturo, la dedizione di Hartley al “meccanicismo” mette in dubbio la “libertà della volontà” e quindi anche la responsabilità morale. Ma dove tali critici sono intenti ad affermare il controllo esecutivo dell’io adulto sul pensiero e sull’azione, l’interesse di Hartley è l’opposto: egli parte dal bambino e si chiede: come può un bambino acquisire il controllo dei processi originariamente automatici presenti nell’infanzia? Acquisire il controllo motorio delle proprie mani? Imparare a camminare e a ballare? A suonare uno strumento musicale? A trasformare gorgheggi e grida spontanee in un discorso articolato? I suoi critici lo accusano di ridurre l’essere umano a un “mero meccanismo”, ma da una prospettiva hartleyana, il “meccanismo” delle azioni “secondariamente automatiche” è una conquista, non un dato di fatto – ed è una conquista necessaria, se uno vuol vivere appieno la propria vita.
La maggior parte delle competenze umane, anche se eseguite volontariamente, si basa su vasti repertori di azioni secondariamente automatiche; tali performance non sono routine pre-stabilite e immutabili. Quando la gente suona la musica, aggiunge dei virtuosismi alla melodia e improvvisa, se è sufficientemente abile; nel fare ciò, le azioni che essa compie sono ciò che Hartley chiama “decomplesso”.
I lettori delle Osservazioni sicuramente erano familiari con i termini “decomporre” e “decomposto” – entrambe derivate dal tardo latino decompositus, una traduzione del greco parasynthetos – in cui il prefisso de- significa “ripetutamente” o “ulteriormente”. Probabilmente conoscevano anche la parola “complesso” dal Saggio riguardo l’intelletto umano di Locke: “chiamo Complesse le idee così costituite da diverse idee semplici messe assieme; tali idee sono la Bellezza, la Gratitudine, un Uomo, un Esercito, l’Universo”.
Note ad Hartley erano sia la distinzione di Locke tra “semplice” e “complesso”, sia gli esempi in cui il prefisso de- significava “ulteriormente”. Sull’analogia tra “comporre” e “decomporre”, scrisse che le idee e le azioni possono essere sia “complesse” che “decomplesse”. Nella sua teoria, le associazioni in un’azione o un’idea complessa sono sincroniche, mentre quelle in un’azione o un’idea decomplessa sono diacroniche: nel suonare il piano, toccare il tasto FA alla vista della nota FA è un movimento complesso, mentre suonare un componimento è un’azione decomplessa.
Gli elementi di un movimento complesso e secondariamente automatico sono strettamente correlati tra di loro. Al contrario, quelli in un’azione o idea decomplessa sono associati più liberamente (1, par. 12); questa libertà rende possibile includere un repertorio di movimenti secondariamente automatici in una varietà di movimenti decomplessi – le stesse note in un numero infinito di melodie. Hartley osserva anche che le persone trovano impossibile compiere azioni decomplesse – come suonare una melodia o dire una frase – al contrario.
Le azioni decomplesse si basano su diversi tipi di movimenti complessi, che implicano l’associazione di movimenti con percezioni in una o più modalità sensoriali: alla vista delle note nel pentagramma, o al suono dei toni musicali, il pianista tocca i tasti. Nella misura in cui una persona diventa abile in un tipo di azione decomplessa, la modalità sensoriale guida può cambiare. Quando si impara a danzare, osserva Hartley, in principio “l’alunno desidera guardarsi i piedi e le gambe, in modo da giudicare dalla vista se sono in una posizione giusta”, ma “per gradi apprende a giudicare dalle proprie sensazioni” (1, par. 77). In maniera simile, un musicista provetto suona l’arpa grazie alla “connessione di diverse parti complesse dei movimenti decomplessi” ( 1, par. 21).
Hartley improvvisò con il linguaggio in maniera da strutturare una nuova visione dell’azione umana. L’uso di una parola divenne … automatico. L’altra non entrò mai nell’uso comune. In una parola in cui “decomporre” significa “guastare”, questo era il destino. Tuttavia, manchiamo di una parola all’altezza di esprimere il concetto che delinea il termine “decomplesso”.
La descrizione di Hartley conferisce un’attenzione particolare alla dipendenza delle nostre capacità per l’intenzionalità, la flessibilità e l’innovazione delle nostre azioni decomplesse dai repertori di azioni che abbiamo reso secondariamente automatiche. La descrizione si incentra perciò su di un aspetto fondamentale: “tutte le nostre facoltà volontarie dipendono dalla memoria” (1, par. 90).
LINGUAGGIO E PENSIERO
Secondo Hartley, veniamo al mondo sapendo già compiere movimenti “originariamente automatici”; grazie all’attività del nostro cervello e dei nostri nervi, questi movimenti sono auto-regolatori e omeostatici, sensibili alle retroazioni del corpo e agli stimoli esterni. Poi, crescendo, acquisiamo il controllo volontario su alcuni dei nostri movimenti, perfezioniamo quelli che diventano secondariamente automatici e impariamo a compiere azioni decomplesse che ricorrono ai repertori delle componenti secondariamente automatiche. Secondo la teoria di Hartley della natura umana, il concetto di “associazione di idee” ha un ruolo centrale, ma gli esempi paradigmatici dell’associazione sono, in primo luogo, le “impressioni congiunte” che generano le “idee” (inclusi i movimenti complessi) e, in secondo luogo, i flussi continui di movimento che costituiscono le azioni decomplesse. Tali azioni decomplesse hanno una funzione centrale nelle vite che conduciamo e, cosa più importante, tra le azioni decomplesse si trovano anche le frasi che diciamo.
Il linguaggio è un’attività motoria altamente “decomplessa” che implica la consolidazione delle associazioni tra i suoni percepiti e quelli emessi e, per la persona colta, tra i segni percepiti ed emessi. Ulteriori connessioni devono essere fatte tra i suoni percepiti o emessi e le caratteristiche del mondo, soprattutto tra le azioni proprie e quelle altrui. L’approccio di Hartley è quasi l’opposto di quello di Locke, che scrive come se il linguaggio fosse un dizionario in cui ogni parola denota un idea già nota prelinguisticamente a chi parla e che sosteneva che “essendo le parole dei segni volontari, non possono essere segni volontari assegnati da chi parla a delle cose che non conosce […]. A meno che non abbia qualche idea propria, egli non può supporre che questi segni corrispondano alle idee che ha un’altra persona, né può usare alcun segno per esprimerle”.
Così, mentre Locke sembra affermare che gli individui prima hanno delle idee e poi si affidano al linguaggio per comunicarle agli altri, Hartley descrive un processo per cui, da bambini, borbottiamo, gridiamo e ascoltiamo, poi gradualmente acquisiamo il controllo dei nostri borbottii e delle nostre grida, che associamo con ciò che sentiamo, tocchiamo e facciamo e infine apprendiamo il significato di ciò che diciamo. Ancora una volta, il processo dell’associazione – che in questo caso consiste nell’attività di ascoltare e parlare, e più tardi in quella di leggere e scrivere – genera le idee: noi abbiamo delle idee perché usiamo il linguaggio in interazioni sociali concrete; non creiamo il linguaggio per esprimere delle idee che, in quanto individui, abbiamo già.
A questo proposito, si consideri l’affermazione di Hume secondo la quale se non siamo sicuri riguardo il significato di una parola “abbiamo bisogno di ricercare da quale impressione derivi tale idea” e il suo suggerimento di tralasciare le parole che mancano di tali derivazioni. Dal punto di vista di Hartley, questo è evidentemente un cattivo consiglio.
Infatti, per lui le idee complesse e decomplesse sono insiemi che non “hanno nessuna relazione con i loro componenti”. In modo particolare, “l’idea decomplessa che appartiene a ogni frase non è composta solo dalle idee complesse che appartengono alle parole presenti in essa” (1, par. 12). Il significato di un enunciato appartiene al tutto – al compimento di una specifica azione decomplessa in un contesto sociale e pragmatico. Inoltre, “sia i bambini che gli adulti apprendono le idee che appaiono in intere frasi per molte volte e in maniera sommaria e non aggiungendo le une alle altre le idee delle varie parole presenti in una frase.” Di conseguenza, i bambini e gli adulti non istruiti trovano difficile “separare le frasi nelle parole che le compongono” (OU 1, par. 80).
In questo modo, il significato delle frasi non è semplicemente deducibile da quello delle parole che le compongono e i significati di quelle parole non sono deducibili dalle “impressioni” alle quali si riferiscono. Quando i bambini incominciano a parlare enunciano delle “frasi” che, anche se corte (mamma!), costituiscono delle espressioni complete e significative, ma è solo quando imparano a leggere che realizzano che le frasi sono composte da singole parole. Con il tempo, le frasi aumentano in decomplessità nella misura in cui le persone partecipano alle attività della vita. Da adulti, si impiegano, nel parlare, una varietà di espressioni altamente decomplesse – tra le quali, ad esempio, quelle riguardano la pratica di una scienza o di una religione.
IL LINGUAGGIO COME ALGEBRA
Dopo aver affermato che il significato è una proprietà di espressioni complete, Hartley ribadisce subito dopo che le parole singole spesso mancano di significati definiti, tuttavia tale indefinitezza non è, secondo lui, un difetto, ma piuttosto una preziosa caratteristica del linguaggio. Egli scrive che il linguaggio è “una sorta di algebra”, e che l’algebra “non è nient’altro che un linguaggio […] particolarmente adatto per spiegare grandezze di ogni tipo” ( 1, par. 80).
La qualità algebrica del linguaggio è importante soprattutto nella pratica scientifica: come x e y in algebra, i termini scientifici quali le “vibrazioni” di Hartley o le “particelle” dei fisici contemporanei stanno per delle incognite, al confronto delle quali le corde vibranti e i granelli di sabbia non sono che delle libere analogie assai ingannevoli. La presenza di questi termini specifici è necessaria per la pratica della scoperta scientifica; gli scienziati li per discernere correlazioni e schemi che altrimenti potrebbero passare inosservati: “relazionare una quantità incognita corrisponde, in filosofia, all’arte di dare dei nomi […] e poi di inserire questi nomi […] in tutte le enunciazioni di un fenomeno, per vedere se, da un paragone di questi termini gli uni con gli altri, possa risultare qualcosa di definito in maniera, grado o mutua relazione” (1, par. 87).
In tale pratica scientifica, più algebriche – vale a dire libere da associazioni con le “impressioni” sensoriali – sono le parole, meglio è (in questo senso, “quark” è una brillante scelta). Perciò il consiglio di Hume di usare solo termini che si riferiscano a “impressioni” chiare, se seguito, condurrebbe la pratica della scienza a una stasi.
Ad ogni modo, l’utilità delle parole per esprimere delle incognite dipende dal loro uso appropriato nell’ambito di pratiche in via di sviluppo. Per esempi su come condurre una ricerca scientifica, Hartley si affida ai metodi matematici e ne include un’analisi esaustiva nel paragrafo 87 del volume I delle Osservazioni, intitolato: “Dedurre le regole per l’accertamento della verità e l’avanzamento della conoscenza dai metodi matematici che considerano la quantità”.
Una deduzione implica il raffronto dell’investigazione scientifica all’uso della regola dell’ipotesi errata in matematica: “in questo caso si ottiene una prima ipotesi che, anche se non accurata, si avvicina tuttavia alla verità. Dall’applicazione di questa alle equazioni si deduce una seconda ipotesi, che è più vicina alla verità di quanto non lo fosse la prima; da questa se ne deduce una terza e così via…”. Hartley aggiunge che “questo è il modo in cui l’innovazione scientifica viene portata avanti e gli scienziati sono consapevoli che è e deve essere così” (1, par. 87).
“Non elaboro ipotesi”. Così aveva scritto Newton nei Principia e Hartley replica direttamente: “è inutile obbligare un ricercatore a formulare delle ipotesi” ( 1, par. 87). Si ricordi che Hartley era un fisico praticante; sulla base di sintomi ambigui e di una conoscenza medica fallibile egli “elaborava delle ipotesi” ogni giorno nel fare delle diagnosi. Quindi, per lui, la questione riguarda il grado di fiducia che possiamo riporre nelle nostre ipotesi. Come facciamo a misurare quanto fosse lontana la nostra “prima ipotesi” dalla verità, se non sappiamo cosa sia la verità? E come possiamo misurare di quanto sia diminuito il margine d’errore della seconda e della terza?
A questo proposito, ciò che è più interessante nel paragrafo 87 è l’analisi della probabilità. Sembra che Hartley avesse fatto parte di un piccolo gruppo di matematici che leggevano, e capivano, dei documenti che fornirono dei contributi fondamentali alla teoria della probabilità di Abraham De Moivre (1667-1754) e Thomas Bayes (1792-61). De Moivre aveva sviluppato un teorema che permetteva di determinare il grado di convergenza tra la frequenza di eventi osservati e l’implicita percentuale di probabilità, per ogni numero finito di eventi; ma, ciò che era più importante, è che questo teorema forniva anche “la soluzione al problema opposto. Infatti, esso cerca di determinare le percentuali di probabilità che possono essere dedotte dagli esiti osservati e fornisce una (ancora dubbia) base per la deduzione statistica. Nella sua analisi della teoria della probabilità e di altri argomenti matematici, Hartley è interessato soprattutto ai metodi per passare dall’osservazione alla spiegazione, per valutare la verosimiglianza – la credibilità – delle ipotesi.
Egli, come Hume, pensava che la fiducia fosse in gran parte una questione di sentimenti. “L’assenso razionale” è una questione di forza dell’associazione tra una frase (o addirittura delle parole in essa!) e la parola “vero” (1, par. 86). “L’assenso pratico”, la volontà di una persona di agire, dipende dalla vividezza dell’affermazione, la quale può perfino far sì che “un evento interessante, ma probabilmente dubbio, o addirittura fittizio, […] appaia reale”, ottenendo in tal modo l’assenso razionale. (Hartley nota con sarcasmo che “la base dell’assenso è ancora la stessa. Qui descrivo solo il fatto.”) Ma non si accontentò di fermarsi qui, al livello di un esponente dello scetticismo urbano. La fiducia e l’assenso sono materia di sentimenti, sì, ma ci sono anche dei modi matematici di pensare alle probabilità della fiducia. (Quante sperimentazioni di un trattamento non testato per i calcoli alla vescica sono necessarie prima di raggiungere un livello minimo di fiducia nei risultati?) Da questo punto di vista, è giusto affermare che Hartley fu uno dei primi Bayesiani.
Un’altra conseguenza dell’approccio pratico e “algebrico” di Hartley al linguaggio riguarda la validità di linguaggi alternati. Nel linguaggio “popolare” che usiamo tutti i giorni, parliamo di scelte, intenzioni e risoluzioni, ma nel linguaggio “filosofico” delle Osservazioni, Hartley propose di pensare in termini di “necessità filosofica” – secondo la quale ogni azione “volontaria” è “generata da una circostanza correlata” ( 1, par. 70). Alcune persone non sanno che farsene di un tale tipo di discorso, perché ai loro occhi nega la libertà (e quindi l’esistenza) della volontà. Hartley ritiene che l’uso di due linguaggi incommensurabili, “popolare” e “filosofico”, non sia un problema, a patto che vengano usati separatamente e coerentemente: “difficoltà insormontabili insorgeranno” solo “se mescoliamo questi linguaggi” (2, par. 15), poiché entrambi funzionano solo nel proprio ambiente di pratica.
Hartley aveva un valido garante per questo suo approccio affermativo ai linguaggi nella sua formazione scientifica e matematica: Newton scrisse i Principia nel linguaggio della geometria, ma “i principi matematici della filosofia naturale” potevano ugualmente (e meglio?) essere espressi nel linguaggio “algebrico” del calcolo – per il quale c’erano vari segni grafici convenzionali. In maniera simile, Hartley sosteneva un nuovo tipo di “segni grafici” per la lingua inglese – la stenografia del suo amico John Byrom, che egli vedeva come una riforma che avrebbe reso il linguaggio scritto più simile a quello “filosofico”. Quando incominciò a lavorare alle Osservazioni, concepiva questo progetto come una dimostrazione del fatto che i linguaggi riguardanti “l’interesse personale”, “il bene comune” e “la volontà di Dio” erano modi diversi per dire la stessa cosa; il progetto si rivelò così molto più morale e religioso che scientifico.
LA PSICOLOGIA MORALE
Come già notato, Hartley riteneva che tutte le persone alla fine sarebbero diventate “partecipi della natura divina”, come prevedeva “l’eterno vangelo” della salvezza universale. Inoltre, egli cercava di mostrare che l’unione di tutta l’umanità nel “corpo mistico di Cristo” era un processo inerente alla nostra natura: la dinamica psicologica dell’associazione, che genera le nostre idee e perfeziona i nostri movimenti secondariamente automatici, ha anche “la tendenza di porre rimedio allo stato di coloro che hanno mangiato dell’albero della conoscenza del bene e del male, riconducendoli verso una condizione paradisiaca” (1, par. 14). La domanda è: in che modo l’associazione compie tutto ciò?
Per capire come sia possibile, dobbiamo analizzare in maniera più precisa (1) il concetto di associazione, (2) la nozione di Hartley di “trasferimento” e (3) le serie di orientamenti che l’associazione e il trasferimento generano. Nel fare ciò, dovremmo tenere a mente che molti di coloro che hanno studiato le Osservazioni nelle accademie dissenzienti sembrano aver valutato Hartley soprattutto in quanto teorico e modello morale, a causa della sua descrizione del cammino di trasformazione morale.
(1) Abbiamo già ricordato la collaborazione di Hartley con il suo amico Hales per scoprire una cura per i calcoli alla vescica. In accordo con Newton, Hales credeva che le “forze di attrazione e repulsione” fossero alla base della natura fisica e attraverso vari esperimenti chimici dimostrò che le concrezioni solide, inclusi i calcoli, erano composti che avevano racchiuse in essi notevoli quantità d’aria, che di solito sono segno di una forza altamente repellente. L’aria all’interno del calcolo poteva essere fatta uscire, e la pietra disciolta, tramite una reazione con un agente che avrebbe cambiato il pH dell’urina. Tali agenti chimici sono numerosi in laboratorio; i due uomini ne stavano cercando uno che si potesse ingerire senza correre rischi. Nei suoi Saggi di statistica, Hales ipotizza che l’aria sia un componente in molte “sostanze animali, vegetali e minerali”. Una particella apparentemente inerte di materia contiene al suo interno forze di attrazione e di repulsione in equilibrio dinamico (da qui la prontezza delle particelle di far sì che i nervi “vibrino”). In tali particelle le concrezioni e le dissoluzioni avvengono in continuazione; i materiali all’interno dei corpi degli esseri viventi formano, dissolvono e formano di nuovo – “in tal modo questa meravigliosa struttura può essere mantenuta”.
Hartley applica questi concetti chimici anche alla psicologia. In analogia alle forze di “attrazione” e di “repulsione”, egli scrive riguardo le “associazioni” e le “contro-associazioni” che generano la struttura del sé di una persona. Il ruolo dell’associazione è ovvio: attraverso l’associazione genera le “idee”, delle quali fanno parte i movimenti complessi che sono alla base delle azioni decomplesse che compiamo ogni giorno. Come vedremo tra breve, le associazioni psicologiche formano (“modellano”) gli orientamenti fondamentali del sé. Ma le “contro-associazioni” sono ugualmente importanti; nei nostri sogni, ad esempio, esse sono “particolarmente d’aiuto nell’interrompere il corso delle nostre associazioni. Perché, se fossimo sempre svegli, alcune associazioni accidentali verrebbero consolidate dalla continuità e niente in seguito potrebbe dividerle, la qual cosa sarebbe una pazzia” (1, par. 91). Una mente sana, quindi, è “mantenuta in un continuo circolo di produzione e dissoluzione” e cioè in un equilibrio dinamico di unione e distacco, memoria e dimenticanza, che conserva la possibilità di cambiamento e trasformazione.
(2) Abbiamo notato nell’analisi dell’azione che, secondo la teoria di Hartley, un bambino acquisisce il controllo volontario sul suo corpo per mezzo di una serie di sostituzioni. Tale serie di sostituzioni, o “trasferimenti” di emozione, formano il carattere di una persona. Ad esempio, Hartley fornisce una descrizione dettagliata e affascinante di come il gesto spontaneo per il quale un bambino spaventato e abusato alza la mano per respingere una percossa diventa, attraverso una serie di tali trasferimenti, la percossa che l’adulto violento dirige. accecato dalla rabbia, verso un bambino indifeso (1, par. 97). In questo caso, i legami per i quali la paura viene trasferita, e trasformata in rabbia, includono elementi situazionali, simbolici e semantici: ad esempio, “i segnali e i simboli” di una percossa imminente – la bottiglia di gin, o le parole violente e affettuose, le maledizioni e i baci, che accompagnano l’ebbrezza.
(3) Hartley fornisce un modello originale di sviluppo psicologico: i vari stati emotivi (“gioie e dolori”) che proviamo si dividono in “sei classi”: l’immaginazione, l’ambizione, l’interesse personale, la comprensione, la teopatia e il senso morale. Queste classi si dividono in due gruppi di tre, ognuno dei quali è costituito da due orientamenti fondamentali e da un mezzo per regolarli.
Il primo gruppo è costituito dall’immaginazione, l’orientamento verso gli oggetti e le fonti di piacere o di dispiacere, e dall’ambizione, per cui il piacere o il dolore derivano dalla propria consapevolezza di trovarsi di fronte agli occhi degli altri. In questo gruppo l’interesse personale è l’io, che tenta di controllare e di soddisfare le richieste dell’immaginazione e dell’ambizione. Il secondo gruppo unisce la comprensione, l’orientamento dell’intersoggettività personale, e la teopatia, la relazione personale con il divino (sembra che “teopatia” sia un neologismo di Hartley). Il senso morale (che all’epoca era un termine molto diffuso) è il “regolatore” della comprensione e della teopatia, è un io più elevato, o un sé, che si trova al di sopra dell’io.
La struttura psicologica dei gruppi è epigenetica e trasformativa. Allo stesso modo delle descrizioni degli psicologi del ventesimo secolo quali Maslow, Erikson e Kohlberg, la teoria di Hartley delinea un processo di sviluppo morale come conseguenza delle trasformazioni del sé.
Il processo è epigenetico nel senso che gli orientamenti che precedono “modellano” quelli che seguono. Un bambino, ad esempio, prova un piacere derivato dall’immaginazione quando gioca con dei giocattoli nuovi, ma quando il piacere si trasferisce allo status che deriva dall’essere percepito dagli altri come un (bravo) bambino che ha una collezione di giochi costosi, allora sta sperimentando un piacere derivato dall’ambizione; quindi l’immaginazione e l’ambizione “modellano” l’interesse personale, nella misura in cui il bambino soppesa i piaceri e i dispiaceri, i pro e i contro, di giocare con i giochi o di tenerli su uno scaffale, in mostra. Il problema resta anche più tardi nella vita, quando il piacere degli oggetti acquistati proviene più dal loro valore simbolico che dal loro uso effettivo. Questo è in particolare il caso degli acquisti fatti per soddisfare i piaceri derivati dall’ambizione – dall’essere considerati come il tipo di persona che può possedere una Mercedes, o che riesce a stare al passo con le mode che cambiano freneticamente.
Un altro fatto che contribuisce alla formazione epigenetica del sé è che l’immaginazione, l’ambizione e l’interesse personale generano inevitabilmente delle contro-associazioni – esperienze di dolore o di indifferenza laddove ci si era aspettati il piacere. L’indulgenza nei piaceri dell’immaginazione, scrive Hartley, spesso “porta gli uomini a un grado tale di sollecitudine, ansia e timore per le cose più piccole da far sì che si affliggano da soli dei tormenti più grandi di quelli che potrebbe inventare il più crudele dei tiranni” (2, par. 54). Lo stesso vale per l’ambizione: stare al passo con le “ultime” mode (che si tratti di auto, vestiti, o filosofi) è assai faticoso e provoca ansia.
“Fin dalla nascita incominciamo, e dobbiamo incominciare, la pratica dell’idolatria delle cose esterne e, col procedere del nostro cammino, continuiamo con l’idolatria di noi stessi” (2, par. 4). Così, alcuni accumulano i loro sacrifici per tutta la vita; in altri, le inevitabili e dolorose contro-associazioni agiscono da solvente e finiscono con il disintegrare gli idoli di pietra. In questi ultimi, la comprensione e la teopatia sostituiscono l’immaginazione e l’ambizione in qualità di “obiettivi primari”, di modi fondamentali di esperienza e interazione. Hartley definisce questa trasformazione “l’annullamento del sé”.
Questo “annullamento” non è simile a quello mistico, ma piuttosto è una scoperta di un sé più elevato formato dalla comprensione, dalla teopatia e dal senso morale; esso implica la liberazione da ciò che William Blake chiama “le catene forgiate dalla mente” di un inferno che ci si è creati da soli, per potersi finalmente risvegliare nella propria vera umanità.
Una volta “modellati” gli orientamenti più elevati, essi “modellano nuovamente” quelli inferiori. Per la persona per cui la comprensione e la teopatia sono gli obiettivi principali, l’immaginazione e l’ambizione restano dei modi di interazione, ma modi che sono stati trasformati. A questo punto, la bellezza può essere scorta in persone e cose che precedentemente erano state considerate con indifferenza o disgusto, e la propria felicità e le proprie speranze possono essere relazionate alla felicità di persone che prima si cercava di evitare.
Ciò non significa che la vita diventi più semplice, anzi, Hartley descrive questo percorso come sempre più difficile. Anche se profondamente ottimista riguardo il futuro ultimo dell’umanità – dopo tutto, descrive come l’associazione tenda “a porre rimedio allo stato di coloro che hanno mangiato dell’albero della conoscenza del bene e del male, per ricondurli a una condizione paradisiaca” – è profondamente consapevole dei molti sentieri secondari dell’autoinganno e dell’autodistruzione. È soprattutto conscio dei pericoli che affrontano coloro il cui obiettivo principale è quello di essere comprensivi, teopatetici e moralmente saggi: tali persone possono sviluppare “un’indole amaramente persecutoria” (1, par. 97). In generale, più è alto il livello del conseguimento morale e spirituale, più grande è il rischio di una distruzione rovinosa. A questo proposito, nel leggere Hartley si riscontra una visione della natura umana come profondamente travagliata, in lotta contro se stessa – una visione simile a quella che si trova in Dostoyevsky o Kierkegaard.
Anche se Hartley ritiene che la “comprensione” e la “teopatia” siano degli orientamenti fondamentali, essi non hanno necessariamente un contenuto positivo. Egli non afferma che tutti sono gentili con gli altri, o che tutti amino Dio. In alcuni questi modi sono meramente patologici e la teopatia spesso è sviluppata solo in maniera rudimentale. Nell’affermare che “si possono osservare le associazioni accumularsi sulla parola Dio”, nota che queste hanno inizio con la “falsa idea” che i bambini si creano quando “suppongono che Dio sia un uomo che non hanno mai visto” e che terminano, per molte persone, quando questa idea “viene cancellata senza che niente dalla natura stabile e precisa prenda il suo posto” (1, par. 98). Molti adulti vivono con sentimenti di paura, avversione, noia e, a volte, ardente desiderio, rivolti verso un vuoto – un quadro mentale dal quale è stata cancellata l’immagine centrale.
Il modello del sé di Hartley in termini di immaginazione, ambizione e interesse personale e, in seguito, di comprensione, teopatia e senso morale, è dinamicamente complesso. Nella sua psicologia morale, le emozioni sono come delle cariche elettriche che saltano facilmente da un oggetto, un simbolo, una parola, o un pensiero all’altro. Tramite tali “trasferimenti” di emozione, sei orientamenti sviluppano i loro contenuti; come delle concrezioni fisiche, si uniscono; allo stesso modo, le energie emotive sono legate assieme e quando la forza in una è sufficientemente potente, l’orientamento diventa “l’obiettivo primario” della persona: richiede l’accrescimento del piacere.
Tuttavia, il modello non è statico, con il sé che si fossilizza in “un unico ammasso inattivo” perché, grazie all’interazione delle associazioni e delle contro-associazioni, i sei orientamenti si “modellano” e “rimodellano” a vicenda. I corpi psicologici sono, come Hales disse dei corpi vegetali e animali, in “un continuo circolo di produzione e dissoluzione” – fino a quando, secondo Hartley, tutti scopriranno la propria identità in quel “corpo mistico” dove “tutti hanno uguale cura della felicità propria e altrui; tutti provano più amore, e si realizzano pienamente, creando l’umanità perfetta, per mezzo della quale ogni gioia viene dispensata” (2, par. 68; cfr. Efesini 4.16).
SAMUEL CLARKE

A cura di Alessandro Sangalli
Samuel Clarke (1675-1729) fu uno dei più importanti filosofi inglesi della generazione tra Locke e Berkeley, nonché una delle figure più note del circolo newtoniano. I suoi interessi filosofici spaziavano dalla teologia alla metafisica, ma si occupò anche di temi etici. Il suo vocabolario filosofico e alcune delle sue idee metafisiche risentirono dell’influenza di Cartesio, dal quale mutuò la teoria del dualismo delle sostanze. Tuttavia, in accordo con Malebranche e Locke, negava che l’introspezione potesse permetterci di raggiungere la sostanza spirituale che costituiva la nostra anima: riteneva invece che gli uomini semplicemente non potessero conoscere la sostanza delle cose. In definitiva, il giudizio generale di Clarke su Cartesio era abbastanza critico: condivideva con Pascal, Bayle e Leibniz l’opinione secondo la quale il sistema cartesiano avesse il suo naturale sviluppo in un pericoloso spinozismo. In particolare, credeva che l’identificazione cartesiana della materia con l’estensione – e quindi con lo spazio – finisse per connotarla come eterna ed infinita, attributi propri di Dio. Infine, in alcuni scambi epistolari con Anthony Collins e con Leibniz difese la religione naturale dal dilagante naturalismo (la credenza secondo la quale la natura costituisce un sistema autosufficiente che non necessita dell’intervento di un principio trascendente o spirituale) e la religione rivelata dalla corrente di pensiero del deismo.
1. Vita e opere
Samuel Clarke nacque a Norwich l’11 ottobre 1675. Si laureò in lettere a Cambridge nel 1695, acquisendo il titolo di Bachelor of Arts con una tesi in cui si schierava a sostegno delle teorie newtoniane, a quel tempo ancora lontane dall’essere universalmente accettate. Anche in seguito, quando nel 1697 curò una nuova traduzione latina del Treatise of Physics di Rohault, tornò – nelle note – a difendere la fisica di Newton criticando quella di Cartesio. Nello stesso anno, strinse amicizia con Whiston, un amico che lo introdusse nel circolo newtoniano, del quale lo stesso Clarke divenne ben presto una delle personalità di spicco. Il suo rapporto con Newton è poco chiaro, anche perché nulla della loro corrispondenza è giunto fino a noi (sempre che una corrispondenza ci sia stata, dal momento che i due furono vicini di casa per parecchi anni); tuttavia, al contrario di molti altri membri del circolo, il nostro non incrinò mai la sua amicizia con Newton.
Nel 1704, tenne le sue prime Boyle Lectures dal titolo Una dimostrazione dell’essere e degli attributi di Dio, in particolare in risposta a Hobbes, Spinoza e i loro seguaci. Il successo che riscosse fu così grande che chiese – ed ottenne – di poterle tenere anche l’anno successivo, con il titolo Discorso sugli immutabili obblighi della religione naturale e sulla verità e la certezza della rivelazione cristiana. Le Boyle Lectures gli conferirono grande notorietà e i suoi legami con Newton divennero ufficiali nel 1706, quando curò l’edizione latina dell’Ottica.
Lo stesso anno, Clarke attaccò Henry Dodwell, sostenitore della tesi secondo la quale l’anima, per natura mortale, guadagna l’immortalità tramite l’azione soprannaturale del battesimo. Le critiche del nostro provocarono la risposta di Anthony Collins, materialista e discepolo favorito di Locke, uno tra i più vivaci sostenitori del deismo: i successivi pubblici scambi d’opinioni tra i due accrebbero sempre più la fama di Clarke. La sua reputazione era così notevole che nel 1710 Berkeley inviò a lui la prima edizione del Trattato sui principi della conoscenza umana e, tre anni dopo, Joseph Butler lo consultò per qualche difficoltà nella comprensione delle Boyle Lectures del 1704. Nel frattempo, fu presentato alla Regina Anna, che lo nominò cappellano nel 1706 e in seguito rettore della parrocchia di St. James, Westminster.
Nel 1712, pur contro i consigli di alcuni ministri del regno, Clarke pubblicò La dottrina biblica della Trinità, testo che fu accusato di arianesimo, eresia secondo la quale, all’interno della trinità divina, soltanto il Padre è Dio, mentre il Figlio è tale solo in quanto partecipa della grazia, essendo egli estraneo alla sostanza divina. A causa della polemica che ne scaturì, il nostro autore fu costretto a dar parola di non scrivere né predicare mai più su tale argomento: questo atto di sottomissione, tuttavia, non zittì le indiscrezioni secondo le quali egli – come d’altra parte lo stesso Newton – fosse ancora un ariano convinto. Quanto poi questi sospetti di eresia abbiano effettivamente danneggiato la sua carriera ecclesiastica è un fatto poco chiaro. Stando a quanto ci racconta Voltaire, il vescovo Gibson si oppose alla nomina di Clarke come Arcivescovo di Canterbury dicendo che questi era sì l’uomo più istruito e leale del regno, ma aveva un difetto: non era cristiano.
Dopo l’ascesa al trono degli Hannover, Clarke diede inizio ad una duratura amicizia con Carolina di Anspach, principessa del Galles e futura regina. Fu grazie alla sua mediazione che il nostro ebbe la possibilità di intrattenere con Leibniz una delle corrispondenze filosofiche più famose del XVIII secolo. Gli scambi d’opinione tra i due vertevano su molti degli argomenti che già avevano interessato Clarke nelle Boyle Lectures: infinità ed eternità di Dio, relazione tra Dio e mondo, relazione tra anima e corpo, libero arbitrio, spazio, tempo, natura dei miracoli. Essi discussero anche di temi più squisitamente scientifici, come la costituzione della materia, l’esistenza degli atomi e del vuoto o le dimensioni dell’universo.
Nel 1717 Clarke diede alle stampe il carteggio con Leibniz insieme ad una critica in cui attaccava un’opera di Collins nella quale veniva negata la libera volontà: questo fu il suo ultimo significativo lavoro filosofico. Tuttavia, egli non trascorse inoperoso gli anni che lo separavano dalla morte. Continuò fino alla fine a difendere le sue idee teologiche e nel 1728 scrisse un breve saggio per Philosophical Transactions nel quale intendeva dimostrare – contro i leibniziani – che la corretta misura della forza era mv e non ½ mv2 (il conatus del filosofo tedesco). Nel 1729, su mandato regio, curò l’edizione della traduzione latina dell’Iliade, adoperandosi con lo stesso zelo con il quale aveva portato a termine l’edizione delle opere di Cesare diciassette anni prima.
Samuel Clarke morì in quell’anno stesso, dopo una brevissima ma fatale malattia: morì a soli 54 anni (sopravvisse tuttavia a sua moglie Katherine ed a cinque dei suoi sette figli). In vita fu un uomo educato e cortese, ma che sapeva essere vivace e spiritoso con gli amici; sembra inoltre che avesse una vera passione per il gioco delle carte. Voltaire scrive che quando lo incontrò rimase molto colpito dalla sua devozione religiosa e fu talmente ammirato dalle sue abilità logiche che lo definì “una vera e propria macchina pensante”. A dire il vero, Voltaire ha per lui anche parole di biasimo e di critica: in un passo particolarmente polemico arriva ad asserire che “in Samuel Clarke il predicatore ha soffocato il filosofo”.
2. La critica al naturalismo e la difesa della religione naturale
La critica di Clarke al naturalismo è articolata in cinque punti tra loro interconnessi. (1) In primo luogo, Dio è un essere dalla suprema benevolenza, necessariamente esistente, onnipotente, onnisciente, eterno ed onnipresente. Da ciò segue che (2) il sistema naturale e le leggi che lo governano sono radicalmente contingenti: Dio, in quanto dotato di libera volontà, ha scelto di creare il mondo e di operare in esso secondo un suo disegno. Il ragionamento prosegue affermando che, (3) sebbene lo spazio e il tempo siano infiniti, la materia è spazio-temporalmente finita e non possiede il principio dell’automovimento, essendo dotata della sola vis inertiae. Quindi, (4) Dio è sostanzialmente presente nella natura (o meglio, la natura è in Dio, dal momento che lo spazio e il tempo sono attributi divini) ed esercita costantemente il suo potere tramite forze attrattive o repulsive applicate ai corpi. Perciò, con l’eccezione della forza d’inerzia, che esprime l’essenziale natura passiva della res extensa cartesiana, nessuna legge fisica descrive veramente il comportamento della materia, ma solo le modalità d’azione del potere divino. Infine, (5) benché l’anima sia estesa e interagisca con il corpo, essa è necessariamente immateriale, poiché la materia non possiede la facoltà di pensiero; inoltre l’anima umana è stata dotata di libero arbitrio da parte di Dio.
I primi quattro punti mostrano la non-autosufficienza del sistema natura: senza il continuo e diretto intervento fisico di Dio, i pianeti volerebbero fuori dalle loro orbite, gli atomi si spezzerebbero e l’intera macchina del mondo andrebbe letteralmente in tilt. Il quinto punto, invece, mostra come l’anima spirituale non sia una parte della natura.
2.1 Dio
La prova della necessaria esistenza di Dio e la deduzione dei suoi attributi occupa gran parte di Una dimostrazione dell’essere e degli attributi di Dio, il primo insieme di scritti delle Boyle Lectures di Clarke. La dimostrazione dell’esistenza di Dio segue l’andamento della prova cosmologica classica, fondata sul tradizionale argomento (risalente ad Aristotele) dell’impossibilità di un rimando all’infinito (regressus in infinitum) nella spiegazione razionale del mutamento. Se tutto ciò che muta o diviene è mosso da altro (la causa, aristotelicamente concepita, è nel movente e non nel mosso), deve esistere un principio assoluto del moto, posto al di fuori della serie naturale del divenire fenomenico, un motore immobile che spiega l’origine del movimento senza rimandare ad altro, un ente primo ed incausato (causa sui). Questo ente, che tutto muove senza essere a sua volta mosso, non può che essere Dio.
Come argomento secondario, il nostro sostiene che, dal momento che lo spazio e il tempo non possono essere pensati come non-esistenti, ma che, d’altra parte, non sono nemmeno auto-sussistenti, la sostanza cui ineriscono – Dio – deve esistere necessariamente. Infine, considerazioni di ordine teleologico indicano che Dio è dotato di intelligenza, di saggezza e di tutte le perfezioni morali. Secondo Clarke, gli attributi umani e quelli divini, in special modo quelli etico-morali, hanno la stessa natura: Dio, tuttavia, li possiede in grado infinito.
La più caratteristica e controversa opinione teologica del filosofo concerne l’eternità e l’immensità divina. Secondo la tradizione cristiana infatti, Dio è eterno e immenso.
L’attributo dell’eternità può essere inteso in due sensi: da un lato, può voler dire che Dio è un essere atemporale, che non conosce la successione, che non ha un prima e un dopo, ma solo un presente senza tempo; da un altro lato, può significare che Dio è sempiterno, perenne, imperituro, un essere che è sempre esistito e sempre esisterà attraverso il tempo, per il quale però esistono un prima e un dopo, un passato e un futuro.
Logicamente, anche l’attributo dell’immensità (onnipresenza) può essere variamente inteso. Dio può essere considerato presente in ogni luogo per azione, non per situazione: detto altrimenti, Dio è presente in un luogo non come lo sarebbe un uomo, ma semplicemente agendo in quel luogo; Dio “riempie” una stanza causando essa e ciò che in essa è contenuto in un modo analogo a quello in cui io riempirei un bicchiere versandoci dell’acqua. Tuttavia, si potrebbe ritenere che la presenza operazionale di Dio richieda anche quella situazionale: da ciò seguirebbe che la sostanza divina è coestesa rispetto a ciò che essa riempie.
Esistono però problemi riguardanti anche l’estensione di Dio: se la intendiamo in termini di estensione locale, Dio sarebbe esteso nello stesso significato in cui è esteso un sasso (sebbene Dio possa, a differenza di una pietra, penetrare le altre cose estese); se invece rifiutiamo l’estensione locale, la sostanza divina sarebbe interamente nella totalità dello spazio ed interamente in ogni spazio e in ogni luogo.
Clarke rifiuta la nozione di un Dio sostanzialmente ed assolutamente fuori dallo spazio e dal tempo. L’eternità divina implica sia la necessaria esistenza di Dio, sia la sua infinita duratio che, tuttavia, non è da confondere con tradizionale teoria dell’eterno presente (nunc stans), dal momento che, come Newton, il nostro considera questa teoria inintelligibile o – alla peggio – contraddittoria. Parlando di Dio in termini di durata, si potrebbe concludere che Dio vive, come noi, nel tempo, ma che, a differenza degli esseri umani, non è soggetto al mutamento: non è però questa l’opinione di Clarke. Nella sua corrispondenza con Butler, scrive infatti che Dio non è nello spazio e nel tempo, ma Dio si identifica con lo spazio e il tempo (in quanto essi sono suoi attributi). Inoltre, Clarke attribuisce a Dio pensieri diversi e distinti, poiché, in caso contrario, egli non potrebbe “variare la sua volontà, né diversificare le sue opere, né agire secondo un suo disegno, né governare il mondo e nemmeno avere la facoltà di volere o fare alcuna cosa”.
In definitiva, secondo il nostro pensatore, l’eternità e l’immensità divina devono essere identificate con lo spazio e il tempo. Questa soluzione è però irta di difficoltà, in parte perché la posizione di Clarke non è del tutto chiara. Egli ha ribadito in più occasioni come spazio e tempo siano solo proprietà divine, ma nel contempo ha sostenuto – in una lettera indirizzata a Leibniz – che essi sono effetti necessari dell’esistenza di Dio, nonché requisiti fondamentali per l’eternità e l’ubiquità divine (naturalmente senza fornire alcuna spiegazione su come queste due tesi potessero essere contemporaneamente valide). Come se non bastasse, in uno scambio epistolare con Daniel Waterland, scrisse che spazio e tempo, rigorosamente parlando, non potevano essere definite proprietà di Dio.
2.2 Il libero arbitrio
Clarke attribuisce grande importanza alla discussione sul libero arbitrio: è un sostenitore dell’indeterminismo, del liberum arbitrium indifferentiae, del potere di determinarsi da sé donato all’uomo da Dio. È a tal punto convinto della correttezza della visione indeterministica da asserire che “gli argomenti contro la libertà sono diventati considerevoli solo per l’onore che si è fatto loro di rispondervi”. Il nostro ha come principale obiettivo critico i sistemi deterministici dei grandi filosofi moderni, Hobbes, Spinoza e Leibniz su tutti.
L’argomento principale su cui Clarke si basa è la necessità di un primo motore, di un agente capace di imprimere ab initio il movimento. Un agente necessario, cioè un agente che si limita a trasmettere il movimento, non è propriamente un agente: è un soggetto passivo; negare che ci sia un primo agente che imprime il movimento equivale ad affermare una progressione infinita di effetti senza causa, di comunicazioni passive senza alcun agente. Deve quindi esserci una causa prima del movimento che è Dio. Quindi, se Dio ha il potere di iniziare il movimento (è cioè dotato di libertà) egli deve aver donato questo potere anche alla sua creatura: Dio ha dotato l’uomo del potere di autodeterminarsi, della libertà d’indifferenza, del libero arbitrio. Questa verità è testimoniata dalla coscienza: che l’esperienza attesti l’esistenza della libertà è per Clarke un punto assolutamente al di sopra di ogni dubbio.
Clarke formula anche altri argomenti per dimostrare come le azioni di Dio non possano essere necessarie. Se Dio operasse necessariamente, le cose non potrebbero essere altrimenti da come effettivamente sono. Tuttavia, come ogni persona dotata di ragione ammetterà senza difficoltà, il numero dei pianeti, le loro orbite, la stessa legge di gravità avrebbero effettivamente potuto essere in altro modo. Inoltre, la presenza in natura di cause finali mostra come l’attività divina segua vie non necessarie ma concepite secondo una libera volontà.
Dopo aver appurato che Dio è dotato di libertà, Clarke cerca di dimostrare che lo siamo anche noi uomini. Il suo ragionamento si basa sia sulla metafisica sia sull’esperienza. In primo luogo, è chiaro che la libertà è un potere comunicabile, a differenza di altre qualità divine come l’eternità o l’esistenza per sé; inoltre, come già accennato, la correttezza della tesi ci è fornita dall’esperienza: interiormente, siamo certi di essere agenti liberi. Negare la libertà è come negare l’esistenza del mondo esterno: sono entrambe ipotesi coerenti ma assurde. Ovviamente, questa non è una vera e propria dimostrazione, ma tanto basta: il fardello delle prove e delle dimostrazioni – asserisce Clarke – non è sulle spalle di chi sostiene la libertà, ma di chi la nega.
Analizzando più da vicino la dinamica della volontà umana, Clarke non si nasconde che il volere può essere influenzato dai motivi: tuttavia questo non toglie la libertà. Innanzitutto bisogna distinguere il giudizio antecedente dell’intelletto dalla decisione della volontà; una cosa è giudicare, un’altra è agire: il giudicare è necessario, l’agire è libero. Oltre a ciò, si tenga presente che l’operazione dell’intelletto per cui esso vede la verità è puramente passiva, ed è impossibile che una passività pura (giudizio) determini un movimento (volontà). Riassumendo questo concetto con le parole di Piero Martinetti, si può dire che “i giudizi dell’intelletto possono bene essere l’occasione, in seguito alla quale il principio attivo e libero dell’uomo mette liberamente in azione il suo potere attivo, ma non sono la causa dell’atto e perciò non tolgono la libertà” (da La Libertà).
Parallelamente Clarke si dedica anche alla confutazione delle tesi contrarie al libero arbitrio, occupandosi in particolare dello spinoso problema della prescienza divina. Contro la pretesa che vuole la prescienza divina in contraddizione con la libertà dell’uomo, il nostro ribatte che, dal momento che la conoscenza non ha effetti sulla cosa conosciuta, nemmeno le nostre volizioni e le nostre scelte sono influenzate dall’onniscienza di Dio: rimangono libere indipendentemente dal fatto che Dio le conosca prima che esse siano; il semplice prevedere non necessita.
2.3 La materia e le leggi di natura
Le teorie fisiche di Clarke sono in stretta connessione con le sue opinioni riguardo ai miracoli. Come Joseph Glanville, Thomas Sprat, Boyle e Locke, il nostro appartiene a quel gruppo di intellettuali vicini alla Royal Society per i quali i miracoli potevano essere considerati come prove della verità e della validità della religione cristiana. Secondo la definizione di Clarke, un miracolo è “un’azione insolita […] realizzata tramite l’interposizione di Dio stesso o di un altro agente spirituale superiore all’uomo, allo scopo di provare l’evidenza di una particolare dottrina o l’autorità di una particolare persona”. Tuttavia, egli nota, i sostenitori del deismo, rilevando che la natura è regolare e costante e che cause simili producono effetti simili secondo leggi fisse, hanno concluso che “esistono nella materia peculiari leggi e poteri il risultato dei quali è ‘il corso della natura’, un corso che essi ritengono sia impossibile alterare e di conseguenza pensano che cose come i miracoli non possano esistere”. Non è difficile vedere in queste parole un’ulteriore critica al naturalismo di stampo spinozistico: Clarke sostiene che le cause dei miracoli non si possano sussumere alle leggi naturali; nel sistema spinoziano e nel pensiero dei deisti, essendo queste leggi assolute ed universali, i miracoli spariscono in quanto impossibili. E con loro spariscono le prove della validità del cristianesimo. Anthony Collins, ad esempio, propose di intendere i miracoli, le profezie e tutti gli episodi della rivelazione non verificabili storicamente come semplici allegorie.
A detta di Clarke, la dottrina deistica è completamente sbagliata poiché “tutti gli eventi del mondo accadono o per l’azione diretta di Dio o per l’azione di altri esseri intelligenti da Dio creati: la materia non è evidentemente capace di alcuna legge o potere” eccezion fatta, naturalmente, per la forza d’inerzia. Perciò i cosiddetti effetti delle leggi fisiche, quali le leggi del moto, della gravità, dell’attrazione e così via, propriamente parlando non sono altro che “gli effetti dell’azione di Dio sulla materia in ogni momento, in modo diretto o indiretto”. Analogamente, il corso della natura non è nient’altro che la volontà di Dio che agisce producendo particolari effetti in una maniera regolare, costante ed uniforme la quale, essendo in ogni momento perfettamente arbitraria, è tanto facile da alterare quanto da preservare. La possibilità dei miracoli riposa in definitiva per Clarke su un volontarismo teologico combinato alla negazione dell’attività della materia.
Quello di Clarke è però un volontarismo teologico moderato, che va distinto dall’arbitrarismo estremo di Cartesio: per il nostro, infatti, le leggi morali restano indipendenti dalla volontà divina e perfino il potere assoluto di Dio è limitato a ciò che è logicamente possibile. Né il volere divino è imperscrutabile: l’inscrutabilità implica che gli attributi e i poteri di Dio siano assolutamente diversi da quelli umani, ma, come abbiamo già accennato prima, essi hanno in realtà la stessa natura degli attributi umani e ne differiscono solo per grado. Inoltre, l’arbitrarietà del volere divino non deve essere intesa come irrazionalità: la volontà divina segue infallibilmente il suo giudizio necessariamente corretto, e di conseguenza Dio agisce sulla base delle leggi di “uniformità e proporzione”. Tuttavia Clarke, fedele alla sua posizione libertaria, afferma che il volere, in Dio come in noi, non è causalmente determinato dal giudizio dell’intelletto: perciò le leggi che governano il potere divino, un sottoinsieme delle quali è quello delle leggi di natura, sono liberamente autoposte, non sono il risultato necessario del corretto giudizio di Dio. Esse sono una manifestazione degli attributi morali, e perciò liberi, di Dio, non di quelli metafisici, e quindi necessari.
Clarke è fermamente convinto che la materia non abbia nessun potere di automovimento, né sostanziale né accidentale. Egli condivide questa posizione con molti filosofi moderni, tra i quali Cartesio, Malebranche, Locke e Boyle, ma la sua posizione è più radicale e controversa: Clarke ritiene i vari movimenti non meccanici della materia (che Boyle, Charleton, Petty e Newton avevano descritto come causati da particelle dotate di potere di attrazione/repulsione) come il risultato diretto dell’attività divina o spirituale. Ammettere una materia attiva è per il nostro il preludio dell’ateismo: negare l’intervento continuo e diretto di Dio nella natura equivale ad eliminarlo, come ha fatto John Toland dotando la materia di un autokynesis sostanziale.
2.4 Spazio e Tempo
A detta di Clarke, spazio e tempo sono “le idee semplici prime e più ovvie, idee che la mente di ogni uomo possiede”. Come molti dei filosofi che si sono dedicati a questo tema, il nostro tende a formulare ragionamenti e dimostrazioni che riguardano lo spazio, lasciando al lettore il compito di trarre conclusioni analoghe riguardo al tempo utilizzando i medesimi argomenti.
Egli sostiene, con Newton, che, mentre la materia può essere pensata come non esistente, lo spazio deve necessariamente esistere: la sua rimozione non sarebbe altro che una rimozione dello spazio dallo spazio stesso, il che sarebbe una contraddizione in termini. Clarke prosegue facendo presente che, sebbene lo spazio non si possa conoscere con i sensi, egli si rifiuta di identificarlo con il nulla, dal momento che esso possiede varie proprietà sensibili, ad esempio la quantità e la dimensione. Tra le altre proprietà che egli ammetteva, si possono elencare anche l’omogeneità, l’immutabilità, la continuità e l’impenetrabilità. Lo spazio, perciò, è un’entità in cui gli oggetti stanno, sono, esistono, e non mera assenza di materia.
Sempre seguendo Newton, il nostro adotta la visione di uno spazio assolutamente infinito, poiché, se fosse limitato, dovrebbe essere limitato da qualcosa che occupa spazio, il che implicherebbe un’evidente contraddizione. Dal momento che lo spazio assoluto ha una struttura essenziale invariabile (totalmente indipendente dai corpi che sono in essa e in nessun modo alterata dalla loro presenza), ogni mondo possibile deve conformarsi a questa struttura, la cui essenza nemmeno Dio può alterare, essendo il potere divino limitato a ciò che è logicamente e metafisicamente possibile. Lo stesso dicasi per il tempo, il quale scorre sempre allo stesso modo, indipendentemente da qualsiasi altra cosa. Le cose create occupano una posizione assoluta nello spazio-tempo, posizione che noi possiamo o meno essere in grado di stabilire con precisione, non avendo accesso diretto allo spazio e al tempo assoluti.
L’introduzione del concetto di spazio assoluto rappresentò per Clarke una specie di arma a doppio taglio: se da un lato offrì al nostro un immediato vantaggio nella lotta filosofica contro Spinoza (questo concetto mostrava infatti l’infondatezza dell’identificazione cartesiana di estensione e materia, identificazione che aveva reso possibile gli eccessi spinoziani), dall’altro comportò nuovi problemi e difficoltà (ad esempio la relazione di questo spazio assoluto con Dio, problema che – come abbiamo già visto – Clarke credeva di poter risolvere sostenendo che spazio e tempo fossero gli attributi di Dio o il risultato della sua divina essenza).
2.5 L’anima
Nel 1706, Henry Dodwell pubblicò un libro nel quale sosteneva una sorta di immortalità condizionata dell’anima umana: le nostre anime sarebbero per natura mortali, e diverrebbero immortali solo tramite un intervento divino sovrannaturale. Clarke indirizzò a Dodwell una lettera aperta, facendogli notare che questa teoria apriva le porte al libertinismo e forniva una ai peccatori un motivo per non temere la punizione ultraterrena. Il nostro sosteneva infatti che l’anima, essendo immateriale, era necessariamente e per natura immortale: l’anima umana, dotata di unità di coscienza, in nessun modo potrebbe essere materiale, dal momento che nemmeno Dio può dotare la materia di coscienza.
Gli argomenti di Clarke, tuttavia, non riuscirono a convincere Anthony Collins che, fedele alla sua linea materialista, intervenne in difesa di Dodwell. Nella sua replica a Collins, il nostro sostiene che, se il pensiero nell’uomo è da considerarsi un modo della materia, allora la naturale conseguenza è quella di fare la stessa cosa anche per tutti gli altri esseri razionali, Dio compreso. In questo modo ogni essere pensante – perfino Dio – sarebbe governato da un’assoluta necessità meccanica, la stessa che regola i movimenti di un orologio. L’impossibilità di ogni autodeterminazione e il crollo dei fondamenti ultimi della religione sarebbero gli effetti più immediati.
La disputa con Collins è utile a chiarire meglio i tre punti attorno ai quali ruota l’argomento dell’immaterialità dell’anima per Clarke:
1. La coscienza è necessariamente una facoltà individuale.
2. Una facoltà individuale non può essere il risultato di (o inerire a) una sostanza divisibile.
3. La materia non è – né potrà mai essere – una sostanza individuale.
La conclusione logica è che la coscienza non può essere un prodotto della materia, né tanto meno inerire ad essa.
Il primo punto, spiega Clarke, va inteso come espressione dell’ovvia unità della coscienza, che è necessariamente una e indivisa, e non una molteplicità di coscienze unite insieme. Collins accetta questa premessa e – in linea di massima – accetterebbe anche il terzo punto, con riferimento non alla materia per sé, ma solo ai sistemi di materia quali, ad esempio, il cervello. Egli, tuttavia, non è in accordo con Clarke nel sostenere che una facoltà individuale come la coscienza possa inerire soltanto ad una sostanza individuale: ergo, non ammette che solo una sostanza individuale come l’anima immateriale possa essere il soggetto della coscienza. I tentativi del nostro di ribattere alle obiezioni di Collins diedero vita ad un interessante dibattito che si protrasse per lungo tempo. È chiaro che per Clarke l’anima è per natura immateriale, ma può causare modificazioni nel corpo: questa capacità è conseguenza del suo essere dotata di libertà. Noi sperimentiamo questo potere causale semplicemente muovendo il nostro corpo. Collins obietta chiedendosi come sia possibile che una sostanza immateriale come l’anima sia indivisibile se si assume – come fa Clarke – che essa sia estesa. Il nostro risponde mostrando come queste proprietà dell’anima possano pacificamente convivere: l’anima immateriale, in stretta analogia con lo spazio, è estesa e indivisibile, poiché la forte interdipendenza delle sue parti fa sì che anche una sola divisione sarebbe sufficiente a distruggerne l’essenza.
Ma dove si trova l’anima? Come scrisse una volta a Leibniz, l’anima si trova in un posto particolare, chiamato sensorium, una parte del cervello. Clarke arriva a questa conclusione partendo da due premesse indipendenti: in primo luogo, una cosa può agire e causare effetti solo dove sostanzialmente si trova; in secondo luogo, l’anima interagisce con il corpo. L’anima è perciò sostanzialmente presente dove lo è (almeno) una parte del corpo.
3. Etica e Religione
Sebbene alcuni dei suoi sermoni contengano interessanti analisi di particolari virtù cristiane, l’esposizione più completa delle idee etiche di Clarke si trova nel Discorso sugli immutabili obblighi della religione naturale e sulla verità e la certezza della rivelazione cristiana, secondo insieme delle Boyle Lectures.
Clarke apre il suo discorso affermando che esistono chiaramente tra le persone diversi tipi di relazioni e che da queste relazioni nascono i concetti di “giusto” ed “ingiusto” che regolano i nostri comportamenti. Ad esempio, data la relazione di infinita incommensurabilità tra Dio e gli uomini, è giusto che noi onoriamo e adoriamo il Signore. In altre parole, da particolari relazioni fattuali eterne ed immutabili sorgono particolari obblighi altrettanto eterni e immutabili, obblighi che – nelle loro linee principali – possono essere appresi da chiunque abbia un minimo di ragione, sebbene in taluni casi ci si possa trovare in difficoltà a stabilire con precisione il confine tra il giusto e l’ingiusto. Essendo fondata – come la geometria – su relazioni universali, necessarie e immutabili, l’etica è per Clarke altrettanto universale e necessaria, indipendente da ogni volontà, umana o divina, e da ogni considerazione di punizioni o ricompense ultraterrene. La posizione di Clarke può perciò essere definita una forma di etica razionalista.
L’etica si suddivide in tre grandi rami che comprendono rispettivamente i doveri verso Dio, quelli verso gli altri uomini e quelli verso sé stessi. I doveri verso gli altri sono regolati dall’equità, che comanda di comportarsi con le altre persone come ragionevolmente ci si aspetta che gli altri si comportino con noi, e dall’amore, che comanda di favorire la felicità e il bene di tutte le persone. I doveri verso sé stessi comandano di preservare in buone condizioni la propria vita (materiale e spirituale) in modo tale da poter ottemperare ai propri compiti. Il suicidio è, perciò, sbagliato.
Dal momento che il volere di Dio non è corrotto dall’egoismo o dalla passione, le volizioni divine e i comandi morali hanno il medesimo valore: ergo, Dio vuole che noi seguiamo le leggi morali, un desiderio manifestato dai comandamenti che Dio ci ha inviato. Tuttavia, siccome le leggi richiedono sanzioni, ma queste sanzioni non sono uniformemente presenti in questa vita, i precetti morali sono accompagnati da punizioni e ricompense nell’altra vita.
Diversi punti fondanti della teoria etica di Clarke possono essere – e sono effettivamente stati – un facile bersaglio di critica. Per cominciare, egli non ha mai sufficientemente illustrato quale sia la natura di quelle relazioni tra le persone che fondano la sua morale, facendo smarrire i suoi seguaci e i suoi critici in una discussione infinita ed inconcludente. D’altra parte non è nemmeno del tutto chiaro come i doveri morali universali possano sorgere da queste relazioni che egli definisce de facto, benché eterne ed immutabili. Già David Hume lanciò a Clarke e alla sua etica l’accusa di “impotenza motivazionale”, in quanto la percezione intellettuale del “giusto” non può, di per sé stessa, muovere la volontà. Infine, la teoria del nostro autore soffre di mali più profondi, di problemi strutturali: la morale è infatti lacerata e divisa tra la necessità razionale di seguire i dettami etici e il naturale egoismo umano, una lacerazione che l’affermazione di Clarke circa il livello ideale come il solo livello al quale si devono riferire i doveri morali sembra difficilmente poter sanare.
JOSEPH BUTLER
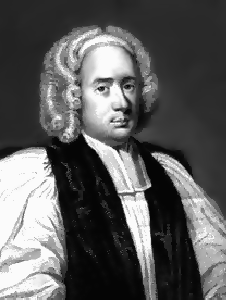
Joseph Butler nasce nella contea inglese del Berkshire, a Wantage, nel 1692. Vescovo di Durham e cappellano nella casa reale, nel 1726 pubblica i Quindici sermoni sulla natura umana, in cui espone le sue idee riguardo all’etica. Nel 1736 dà alle stampe l’Analogia della religione, naturale e rivelata, con la costituzione e il corso della natura, dedicata alle sue concezioni teologiche. I Sei sermoni predicati in pubbliche occasioni risalgono al 1748, e contengono le riflessioni del filosofo inglese in materia politica. Butler muore a Bath nel 1752.
In termini molto generali, egli sostiene l’idea di una complementarità tra “natura” e “rivelazione”, opponendosi fermamente ai deisti più radicali, che invece negano il valore della fede rivelata. Dal momento che intende cercare una via attraverso la quale cogliere qualche conoscenza della realtà trascendente, Butler afferma l’esistenza di un’analogia tra le leggi della natura e quelle dettate dalla rivelazione cristiana, e afferma che i comandi di Dio sono naturali e divini ad un tempo. A questo proposito scrive:
“Paragoniamo la nota costituzione e il noto corso delle cose con quello che è stato detto essere il sistema morale della natura, le dispensazioni riconosciute della provvidenza, o questo governo sotto cui ci troviamo, con la religione che c’insegna a credere e ad aspettare: e vediamo se non siano analoghi e di una stessa sorte. E, in base a questa comparazione, io penso, si troverà che essi sono tali in gran misura: che entrambi possono esser ricalcati secondo le stesse leggi generali, e risolti negli stessi principi di condotta divina”.
È il principio d’analogia, quindi, a fornire un collegamento fra l’intelligenza limitata dell’uomo e quella infinita di Dio.
Tuttavia, ciò non implica la possibilità, da parte degli esseri umani, di conoscere interamente l’ordine rivelato. Al contrario, Butler pone l’accento sui limiti della nostra razionalità, e sul fatto che, come egli stesso afferma, “la religione consiste nella sottomissione e nella rassegnazione alla volontà divina”. Sicché, nell’ammettere un’ampia sfera di coincidenza, o almeno di rapporto analogico, tra ordine naturale e la religione – in quanto provenienti entrambi da Dio –, Butler vede l’elemento comune non tanto nella loro intrinseca razionalità (come invece facevano i deisti), quanto piuttosto nell’inadeguatezza della ragione a spiegare tanto l’uno quanto l’altra. All’impossibilità di afferrare razionalmente i misteri religiosi corrispondono infatti limiti analoghi della ricerca scientifica nel giustificare i propri princìpi. Per questo motivo, affiora in Butler l’esigenza di integrare il dato razionale con quello rivelato: quest’ultimo, benché sia indimostrabile, dà all’uomo la più convincente delle fonti di conoscenza. In particolare, dice Butler, le nostre facoltà non sono in grado di comprendere il mistero della creazione. Questo avviene perché formiamo le nostre conoscenze soltanto valutando gli “effetti”, ossia le cose che cadono sotto la nostra osservazione; ma le loro cause reali, così come le loro intime essenze, ci restano sconosciute. Analogamente, il mondo in cui viviamo è un “effetto” della creazione divina, che però, in quanto “causa”, risulta inafferrabile dall’intelligenza degli uomini. La religione naturale, poi, ha una sua validità, nel senso che “è il fondamento e la parte principale del cristianesimo”; tuttavia, anch’essa ha i suoi limiti, proporzionali ai limiti della razionalità umana.
Butler non nega completamente all’uomo la possibilità di una conoscenza, sia pure molto circoscritta: sostiene che siamo in grado di cogliere qualcosa a proposito dei disegni della provvidenza partendo dalla considerazione delle cause finali, e del merito e del demerito personali che ciascuno di noi può vedere. Questo genere di consapevolezza è sufficiente per sostenere la tradizione religiosa e farci praticare la virtù; eppure, nonostante ciò, il sistema generale dell’universo, nella sua immensità, oltrepassa i limiti della nostra ragione.
Secondo Butler, il mistero che nasconde Dio alla comprensione degli uomini può dipendere da motivi ben precisi, che la divinità stessa non intende svelarci. Scrive infatti il filosofo inglese:
“L’Onnipotente può circondarsi di nubi e di oscurità per ragioni e propositi di cui non abbiamo la minima immagine o idea”.
Butler ritiene che la nostra ignoranza sia “la risposta appropriata a molte questioni che sono denominate obiezioni contro la religione, in particolare a quelle che sorgono alle apparenze di male e di irregolarità nella costituzione della natura e nel governo del mondo”. Consapevoli dei limiti della nostra razionalità, dobbiamo allora applicarci soltanto a quello che non eccede i suoi ristretti confini.
Butler si pone poi il problema dei fondamenti dell’etica, affermando, in tal senso, il valore normativo della coscienza. Questa è una facoltà del tutto naturale nell’uomo, una facoltà grazie alla quale è possibile l’agire morale. La coscienza viene definita come un “principio superiore di riflessione” presente in ognuno di noi, un principio in grado di stabilire che alcune azioni sono giuste ed altre sbagliate. Questo accade perché la coscienza “opera una distinzione tra i principi interiori del suo cuore, così come tra le sue azioni esteriori”, introducendo un giudizio tra sé ed esse. D’altra parte, la coscienza può anche essere intesa come la voce naturale di Dio presente in noi, una voce che, mentre rivela gli innegabili limiti dell’uomo, nello stesso tempo ne scopre l’inesorabile vocazione soprannaturale.
MATTHEW TINDAL

A cura di Gigliana Maestri e Diego Fusaro
“Non aver seguito queste nozioni dettate dalla Ragione, a proposito della natura di Dio, è stata la causa di tutta la superstizione e di questi misfatti che l’umanità, a causa della religione, ha commesso”. (Cristianesimo antico come la creazione)
Nato nel 1656 a Beer Ferrers, nella contea inglese del Devon, Matthew Tindal studia giurisprudenza a Oxford. Nel 1685 si converte al cattolicesimo, per poi tornare alla religione anglicana soltanto tre anni più tardi. Nel Saggio sull’obbedienza ai poteri supremi del 1694, e nella Libertà di stampa del 1698, sostiene le tesi del giusnaturalismo; il suo spirito fortemente polemico e anticlericale emerge nel libro I diritti della chiesa cristiana proclamati contro quella romana, opera che risale al 1706. Tuttavia, il suo scritto più importante è il Cristianesimo antico come la creazione, del 1730, considerato un autentico “classico” del deismo inglese. Il secondo volume di quest’opera, lasciato manoscritto dall’autore, è andato perduto perché bruciato dalle autorità ecclesiastiche; in ogni caso, sebbene incompiuta, ai suoi tempi l’opera suscita notevoli polemiche. Tradotta in tedesco nel 1741, essa diffonde il deismo anche in Germania. Tindal muore a Oxford nel 1733.
La sua riflessione filosofica si segnala per una radicalizzazione delle tesi del deismo. Tindal sostiene infatti che l’unico, valido fondamento della religione naturale è costituito dalla ragione, intesa come facoltà universale e immutabile. Operando un confronto fra religione naturale e religioni positive, Tindal afferma che la prima è l’unica, autentica forma di credenza religiosa, mentre destituisce di valore le seconde, considerandole semplici mistificazioni, imposture, contraffazioni di carattere mitologico elaborate soprattutto dalle caste sacerdotali. Non a caso, il sottotitolo del Cristianesimo antico come la creazione è il seguente: Il Vangelo come ripubblicazione della religione della natura.
Tindal afferma l’inutilità della rivelazione basandosi sul concetto che noi abbiamo di Dio. Essendo Dio buono, immutabile e avendo Egli impresso leggi eterne all’universo e alla natura umana, non ha alcun senso una rivelazione fatta ad un solo popolo e in un preciso momento della storia. La rivelazione è inutile per sua stessa essenza, in quanto è solo “una ripubblicazione della religione della natura”. Così intesa, la rivelazione non è che una semplice riedizione, o copia, della religione naturale, della quale le singole religioni positive non sono che derivazioni o, nella maggior parte dei casi, trasfigurazioni.
Tindal scrive che la religione naturale
“non differisce da quella rivelata altrimenti che nel modo di essere comunicata: la prima è rivelazione interna, la seconda è la rivelazione esterna della stessa volontà immutabile di un Essere che è ugualmente in ogni tempo infinitamente saggio e infinitamente buono”.
La radicalità del pensiero di Tindal (con lui il deismo sembra giungere al culmine) consiste nel fatto che egli non si limita a depurare la Scrittura dalle inconseguenze con la ragione, ma riconosce l’assoluta priorità assiologia e cronologica della religione razionale su ogni forma di rivelazione. Dio, nella sua perfezione immutabile, ha dato da sempre agli uomini una legge altrettanto immutabilmente perfetta. Sicché il cristianesimo non poteva aggiungere o togliere alcunché a questa legge: e, se storicamente potè servire a ravvivare una religione naturale poco attiva, esso è diventato poi pericoloso, consolidando superstizioni e false credenze che non hanno più nulla a che vedere col nucleo originario della legge di Dio.
La critica nei confronti della fede rivelata non implica però il rifiuto del cristianesimo, il quale, a parere di Tindal, è invece l’unica religione che non possa essere definita come una “impostura”. Molte delle verità enunciate da Cristo sono perfettamente in linea con i dettami della nostra ragione; tuttavia, bisogna ammettere che i capi della Chiesa hanno aggiunto alla religione cristiana parecchie dottrine e una serie di pratiche che o sono in contraddizione con gli insegnamenti di Gesù, o non sono essenziali per il suo messaggio.
L’esaltazione della ragione non è in alcun modo diretta contro Dio. Secondo Tindal,
“Dio non ha dato agli uomini nessun altro mezzo ad eccezione dell’uso della ragione; la ragione, la ragione umana, deve allora essere questo mezzo; giacché, siccome Dio ci ha fatto creature ragionevoli, e la ragione ci attesta che questa è la sua volontà, che noi cioè agiamo secondo la dignità della nostra natura, così è la ragione che deve dirci quando agiamo in questo modo”.
Evidentemente, essendo la ragione un dono di Dio agli uomini, usarla non significa offendere l’Essere supremo, ma anzi assecondare la sua volontà e la nostra natura. Allo stesso modo, occorre seguire e rispettare le leggi naturali stabilite da Dio, che sono una fonte di felicità per il genere umano. Infatti, dal momento che Dio è infinitamente felice per se stesso, nel creare gli uomini non può aver desiderato altro che la loro felicità in questa vita e in quella futura. Quindi,
“se l’umanità seguisse queste regole prescritte da Dio in ordine al comportamento reciproco degli uomini, in quale felice, benedetto e fiorente stato essi vivrebbero!”.
DUGALD STEWART

A cura di Gigliana Maestri
Nato ad Edimburgo nel 1753, figlio di un docente di matematica, e allievo di Thomas Reid a Glasgow, Dugald Stewart studia filosofia, matematica ed economia politica. All’Università di Edimburgo insegna matematica fra il 1775 ed il 1785; in seguito, ottiene la cattedra di filosofia morale, subentrando ad Adam Ferguson. Muore nel 1828.
Stewart espone i principi fondamentali del pensiero della “Scuola scozzese” negli Elementi della filosofia della mente umana, apparsi in tre volumi (1792, 1814, 1827); si possono inoltre ricordare i Lineamenti di filosofia morale, che risalgono al 1793, i Saggi filosofici del 1810, la Filosofia delle facoltà attive e morali dell’uomo, pubblicata nel 1828. In generale, le sue opere non rivelano una grande profondità di pensiero, anche se si distinguono per uno stile particolarmente chiaro e piacevole.
Tipico esponente della “Scuola del senso comune”, fondata da Thomas Reid e da James Beattie nell’ambito della Philosophical Society di Aberdeen, Stewart ha il merito di porre in evidenza una difficoltà insita nel pensiero degli scozzesi: l’assenza di un criterio preciso, utile a definire e circoscrivere quei “principi primi” che il senso comune dovrebbe fondare. In genere, egli tende anche ad evitare l’espressione “senso comune”, perché ritiene che possa condurre ad un equivoco, ossia a pensare che i problemi filosofici siano risolvibili sulla base di giudizi “popolari”. Questo è il motivo per cui preferisce parlare di “leggi fondamentali della credenza umana”.
Stewart si preoccupa di stabilire le condizioni principali e le verità fondamentali che rendono possibili tutti i nostri ragionamenti, e senza le quali l’uomo non potrebbe svolgere alcuna inferenza. Esse sono le nostre credenze nell’esistenza dell’io e dell’identità personale, nella veridicità delle testimonianze offerte dalla memoria, nella realtà del mondo esterno e nell’uniformità e costanza delle leggi di natura. A suo parere, sia le vicende umane sia gli eventi naturali sono caratterizzati da un ordine, grazie al quale si possono fondare regole di estrema utilità per mezzo del principio dell’induzione. Infatti, come afferma nei Lineamenti di filosofia morale, riprendendo il problema delle regole alla base dell’argomentare razionale,
“tutte le ricerche filosofiche, e tutte quelle conoscenze pratiche che orientano la nostra condotta nella vita presuppongono un ordine stabilito nella successione degli eventi. Altrimenti l’osservazione del passato sarebbe sterile, e noi non potremmo concludere nulla per il futuro”.
Stewart afferma poi che conosciamo le leggi di natura soltanto grazie all’osservazione e all’esperienza. Il ruolo di quest’ultima è particolarmente importante, perché proprio in base ad essa sappiamo che certi avvenimenti sono sempre associati, per cui, se ne appare uno, inevitabilmente ci aspettiamo anche l’altro. Tuttavia, la nostra conoscenza non può procede oltre. Per Stewart, noi non siamo in grado di scoprire le cause essenziali dei fatti, ma conosciamo soltanto questi e le leggi che li collegano. Pertanto, il vero compito della filosofia consiste nel riunire i fenomeni sparsi, presenti nell’universo, e connetterli alle loro leggi generali. Egli crede inoltre che la filosofia debba configurarsi come una disciplina autenticamente scientifica, del tutto libera dalle speculazioni e dalle categorie della metafisica.
La parte più originale dell’opera di Stewart è considerata quella relativa all’analisi delle nozioni comuni di “immaginazione” e di “fantasia”, di “bello” e di “sublime”. A tale proposito, egli elabora una teoria, fondata sull’ipotesi di un senso comune della bellezza, che ha una certa influenza sul pensiero estetico del XIX secolo. Stewart manifesta poi un sincero interesse per gli argomenti degli “ideologi” francesi; eppure, nonostante questa sua simpatia, s’impegna a difendere l’originalità dell’empirismo tipico di Locke contro la scuola sensistica di Condillac.
THOMAS BROWN

A cura di Gigliana Maestri e Diego Fusaro
Nato a Kirkmabreck il 9 gennaio 1778, allievo di Dugald Stewart, Thomas Brown insegna filosofia morale all’Università di Edimburgo dal 1810 al 1820, anno della sua morte. Studia con dedizione anche legge e medicina. Insieme a Thomas Reid, ad Adam Ferguson e a Stewart, egli fu il massimo esponente di quell’indirizzo di pensiero noto come “Scuola scozzese”. La prima opera di Brown s’intitola Osservazioni sulla Zoonomia del dr Erasmus Darwin e risale al 1798. Scrive poi le Osservazioni sulla natura e la tendenza della dottrina del signor Hume sulla relazione di causa ed effetto, che sono riprese nella Ricerca sulla relazione tra causa ed effetto, apparsa nel 1818; le Lezioni di filosofia dello spirito umano vengono pubblicate nel 1820.
La riflessione di Brown si configura come un’analisi della mente. Quest’ultima è una sostanza suscettibile di modificazioni o di stati che, succedendosi l’uno all’altro, danno luogo ai fenomeni del “pensare” e del “sentire”. La filosofia della mente comprende anche l’esame delle dottrine dell’etica generale, delle teorie politiche e delle dottrine della teologia naturale. Per quanto riguarda l’etica, essa si occupa, ad esempio, dell’obbligo che spetta all’uomo di aumentare ed estendere la felicità degli altri esseri viventi; le dottrine politiche, invece, costituiscono il mezzo attraverso il quale perseguire ed attuare questo ideale di felicità. Infine, le teorie della teologia naturale studiano l’esistenza e gli attributi dell’Essere Supremo, e affermano l’immortalità della nostra anima.
Brown affronta anche il problema della conoscenza. Egli sostiene che essa riguarda esclusivamente i fenomeni e non le essenze, che non siamo in grado di cogliere. A tale proposito, nelle Lezioni di filosofia, scrive che
“la filosofia della materia e la filosofia della mente s’accordano completamente sotto questo rispetto: che in entrambe egualmente la nostra conoscenza è confinata ai fenomeni che essa presenta… se la nostra conoscenza della materia è soltanto una conoscenza relativa, la nostra conoscenza della mente è parimenti relativa”.
In ogni caso, gli uomini hanno bisogno di alcuni princìpi di base per poter attuare i loro ragionamenti, ossia necessitano di certe verità del senso comune che non possano essere poste in dubbio: in primo luogo, la credenza nell’identità personale, che è una certezza immediatamente evidente, e non il risultato di un insieme di proposizioni; in secondo luogo, la credenza nell’esistenza di un mondo esterno, anche questo assolutamente indubitabile. La realtà al di fuori di noi esiste indipendentemente dalle nostre percezioni, anche se è la nostra mente ad osservare e combinare i fenomeni.
Secondo Brown, però, non bisogna moltiplicare i principi della credenza intuitiva, come invece hanno fatto Thomas Reid ed altri filosofi della Scuola scozzese, perché così si rischia di frenare l’impulso alla ricerca filosofica, accontentandosi troppo presto dei risultati. Brown ritiene che, in tutte le indagini razionali, sia necessario attenersi ai fatti ed imparare a dubitare nel modo adeguato. È sbagliato assumere un atteggiamento costantemente scettico, ma è altrettanto errato essere troppo fiduciosi. Occorre invece assumere un atteggiamento che si collochi a metà strada tra questi due pericolosi estremismi: ed è esattamente il senso comune (richiamandosi al quale, Brown segnala la propria fedele appartenenza all’impostazione della Scuola scozzese) ad evitare le secche dello scetticismo e della fede arazionale. Scrive il filosofo:
“la verità è l’ultimo anello di una lunga catena, il cui primo anello la natura lo ha posto nelle nostre mani. Se noi siamo felicemente giunti all’ultimo e avvertiamo completamente che non vi è più alcun anello ulteriore, sarebbe evidentemente assurdo supporre che possiamo procedere oltre”.
In questo modo, Brown sostiene che non bisogna essere precipitosi ed asserire di aver raggiunto “l’ultimo anello della catena” se non ne siamo realmente sicuri, e che soprattutto non dobbiamo mai accontentarci di affermare di aver compiuto il massimo sforzo consentito ad un essere umano.
ADAM FERGUSON

A cura di Roberta Musolesi
“Chi desidera il bene altrui scopre che la felicità degli altri è la fonte più generosa della propria felicità. “.
Adam Ferguson, filosofo, storico e ritenuto comunemente uno dei padri fondatori della sociologia, nacque a Logierait, nel Perthshire, in Scozia, il 20 giugno del 1723. Frequentò la Perth Grammar School e l’Università di St Andrews. Nel 1745, grazie alla sua conoscenza della lingua gaelica, fu nominato cappellano delegato del 43° reggimento, le Guardie Nere, incarico che gli venne impartito in virtù di una particolare dispensa, visto che all’epoca non aveva completato i sei anni di studi teologici richiesti. Nella battaglia di Fontenoy, nel 1745, Ferguson combattè strenuamente nelle fila dell’esercito e, malgrado gli ordini impartitigli dal suo colonnello, rifiutò di lasciare il campo di battaglia. Continuò ad operare nel 43° reggimento fino al 1754, quando, malgrado il suo disappunto, non ottenne la possibilità di rimanere a vita nell’esercito; dal quel momento si dedicò alla cura dei suoi interessi letterari.
Nel gennaio del 1757 sostituì Hume nell’incarico di bibliotecario della Facoltà di Legge, ma presto abbandonò anche questo incarico per divenire precettore presso la famiglia di Lord Bute. In quella veste accompagnò il giovane Earl in viaggio per l’Europa e in tale circostanza ebbe la possibilità di conoscere i filosofi francesi. La sua prolungata assenza da Edimburgo lo portò ad affrontare una causa legale, in cui egli tuttavia difese se stesso con successo e potè quindi riprendere, in seguito, la sua attività universitaria.
Nel 1759 venne nominato professore di filosofia naturale presso l’Università di Edimburgo e nel 1764 venne trasferito alla cattedra di metafisica e filosofia morale. Nel 1767 pubblicò il suo Essay of history of Civil Society, che fu accolto con particolare entusiasmo dai lettori e fu tradotto in numerose lingue. Si tratta di una storia naturale del progresso del genere umano, sviluppata secondo i principi teorici dell’Illuminismo inglese, in particolare quelli di Hume, il quale, pur ritenendo Ferguson uno studioso “dotato di maggior genio degli altri”, ne criticò tuttavia molto duramente il saggio, giudicandolo superficiale. Nel 1776 viene pubblicato, anonimo, un suo pamphlet sulla Rivoluzione Americana, in opposizione allo scritto di Price Osservazioni sulla natura della libertà civile, e in questo breve lavoro Ferguson mostra di prendere posizione a favore del governo britannico; nel 1778 diviene segretario della commissione che tentò, senza successo, di negoziare un accordo con le colonie americane insorte.
Nel 1783 viene pubblicato il suo Progress and Termination of the Roman Republic che venne accolto con molto favore esso e fu pubblicato in numerose edizioni. Questo lavoro nasce dalla convinzione che la storia romana, durante il periodo del suo massimo splendore, rappresentò un esempio pratico di attuazione di quei principi etici e politici che da sempre erano stati oggetto degli studi di Ferguson. Il testo è scritto con uno stile particolarmente gradevole ed accattivante e con spirito di imparzialità, rivelando, nel contempo, un uso consapevole dell’autorità, frutto sicuramente dell’esperienza militare dell’autore.
Ritenendosi inadatto al mestiere di insegnante, si dimise dall’incarico di professore nel 1785 e da quel momento si dedicò alla revisione scrupolosa delle sue lezioni, che pubblicò nel 1792 con il titolo Principles of Moral and Political Science. All’età di 70 anni, Ferguson, con il progetto di pubblicare una nuova opera storica, visitò l’Italia e le principali città europee, dove fu ricevuto con i massimi onori e dove collaborò con i massimi studiosi dell’epoca, fra i quali anche Voltaire.
Dal 1795 risedette nel castello di Neidpath, vicino a Peebles, a Hallyard on Manor e a St. Andrews, dove morì il 22 febbraio del 1816.
Le opere
An Essay on the History of Civil Society, 1767.
Institutes of Moral Philosophy, 1768.
The History of the Progress and Termination of the Roman Republic, 1783.
Principles of Moral and Political Science; being chiefly a retrospect of Lectures delivered in the College of Edinburgh. 1792.
Essays on the Intellectual Powers : Moral sentiment, happiness and national felicity, 1805
Le traduzioni in italiano
Divisione del lavoro e diseguaglianza sociale in Ideologie nella rivoluzione industriale, a cura di Fulvio Papi, Bologna, Zanichelli, 1976
Istituzioni di Filosofia morale del sig. Fergusson tradotte dall’inglese opera classica per l’esattezza nel metodo, per la profondita e sicurezza ne’ principj, e per la chiarezza nella esposizione. Ad uso delle Scuole pubbliche e private d’Italia, realizzato in Venezia, nella stamperia Graziosi a S. Apollinare, 1790
Romani go home, traduzione di Ranieri Carano, Milano, A. Mondadori, 1972
Saggio sulla storia della società civile, a cura di Pasquale Salvucci, con bio-bibliografia ragionata di Mariangelo Massi, Firenze, Vallecchi, 1973.
Il pensiero di Ferguson
Nel suo sistema etico Ferguson analizza l’uomo nell’ambito dei rapporti sociali ed illustra le sue dottrine con esempi politici. Il suo pensiero, criticato da Cousin (si veda il suo Cours d’histoire de la philosophie morale au dix-huitième siècle, 1839-1840), lascia trasparire, nel metodo, la saggezza e la cautela della Scuola Scozzese, con tratti di maggiore fermezza e decisione nei risultati. L’individuazione da parte di Ferguson del principio della perfezione come molla del progresso dell’uomo, principio nuovo e sicuramente più razionale ed esaustivo della benevolenza e della simpatia e sulla base del quale egli cerca di rivedere e integrare tutti i sistemi etici, lo colloca al di sopra dei suoi predecessori. Sul piano più strettamente politico, Ferguson fece riferimento al pensiero di Montesquieu e perseguì la causa di una libertà ben regolata e di un governo libero.
Saggio sulla storia della società civile: divisione del lavoro e subordinazione
Ferguson è uno dei massimi esponenti della cosiddetta “Scuola Scozzese”. Tenendo sempre presenti le riflessioni di Montesquieu, gli autori della “Scuola scozzese” elaborano una “storia naturale della società” articolandola in quattro stadi, nella convinzione che, per poter capire gli usi, i costumi, le leggi vigenti in una società, si debba inevitabilmente fare riferimento al modo in cui gli uomini si procurano di che vivere. Il primo stadio è quello “selvaggio”, nel quale sul piano conoscitivo domina la magia e su quello sociale regna la comunità non strutturata; gli uomini vivevano di pesca e di caccia. Il secondo stadio è quello “barbarico”: esso è contraddistinto dal mito sul piano conoscitivo; sul piano della vita associata, si passa dalla comunità non strutturata alla comunità dotata di proprietà ma priva di leggi. Infine, gli uomini pervengono allo stadio della “società civile”, col quale gli uomini diventano civilizzati: sul piano conoscitivo, trionfa la scienza e, su quello sociale, si instaura la comunità armonica disciplinata dalle leggi. Stando al modello proposto da Ferguson, l’umanità diventa sempre più civile nella misura in cui si addomestica e si ammansisce, espellendo e sublimando i residui ferini che ancora permangono in essa. In ciò, risiede propriamente l’incivilimento, che, a livello di morale, trova la propria compiuta espressione nel trionfo dell’etica kantiana (introiettiva e basata sull’imperativo categorico) sull’arcaica “legge del taglione”. Secondo Ferguson, “la civilizzazione è il risultato dell’azione dell’uomo, non dell’attuarsi di un qualche progetto umano”: frase che ben adombra come, nella prospettiva degli “Scozzesi”, la storia della società debba essere intesa in modo “naturale”, come si può fare una storia della natura, senza considerare presunte finalità o scopi di sorta.
È il sorgere dell’agricoltura a determinare la nascita delle leggi: infatti, alla nascita dell’agricoltura segue quella della proprietà privata, la quale viene protetta dalle leggi. Nella prospettiva dei filosofi della “Scuola scozzese”, la funzione del governo è quella di eliminare gli ostacoli che intralciano uno sviluppo armonico della società civile e tale per cui io produco ciò che manca a te, e tu produci ciò che manca a me. Il presupposto di tutti questi autori è che esista un interesse comune che si sviluppa spontaneamente, come se aiutato – per dirla con Adam Smith – da una misteriosa “mano invisibile” che, dietro l’egoismo dei singoli attori sociali, finisce poi per “dare una mano” a tutti. In una simile prospettiva, nella quale si produce spontaneamente un interesse in favore di tutti, il governo deve limitarsi a garantire i diritti della “società civile” rimuovendo tutto ciò che ne ostacola lo sviluppo. Sicché lo Stato è del tutto subordinato alla “società civile”: contro questa subordinazione protesteranno, pur con intenti e prospettive diversissime, Hegel e Marx.
Nel suo Saggio sulla storia della società civile, Adam Ferguson anticipa alcune considerazioni sul tema della divisione del lavoro che saranno riprese ed ampliate da Adam Smith e da Karl Marx.
Ferguson ritiene che:
“…il sentimento di utilità spinge gli uomini a suddividere senza fine le loro professioni”. [Infatti] …è evidente che un popolo … non potrebbe fare nessun grande progresso nel coltivare le arti della vita, fin tanto che non abbia separato e affidato a persone diverse i vari compiti che richiedono una peculiare abilità e attenzione”.
La divisione dei compiti e la loro distribuzione a soggetti diversi diventa quindi prassi diffusa in ogni società al fine di raggiungere minori costi di produzione e aumento dei profitti. Infatti Ferguson afferma:
“Ogni imprenditore di manifattura trova che quanto più nell’azienda può suddividere i compiti dei suoi operai e quante più mani può impegnare nei distinti articoli, tanto più diminuiscono le sue spese e aumentano i suoi profitti”.
Tuttavia, parallelamente ad un ampliamento della ricchezza, si assiste ad una così evidente degradazione della condizione umana, tale da mettere in dubbio lo stesso progresso e la stessa evoluzione sociale.
A dimostrazione di ciò, Ferguson sottolinea che molti mestieri manuali non richiedono alcuna particolare competenza e riescono perfettamente anche supponendo la totale cancellazione del sentimento e della ragione. Per questi motivi le attività produttive industriali possono prosperare anche quando la mente dell’uomo che in esse opera viene attivata il meno possibile; a ragione quindi la fabbrica e l’officina possono essere considerate alla stregua di enormi macchine, parte dei cui ingranaggi è costituita da uomini. Il proletariato industriale vive quindi condizioni di lavoro che divengono via via sempre più disumane, mentre l’imprenditore concentra su di sé l’intero dominio del processo produttivo. Infatti:
“…se nella pratica di ogni arte e nel dettaglio di ogni dipartimento, vi sono molte parti che non richiedono abilità o tendono attualmente a restringere e a limitare l’orizzonte intellettuale, ve ne sono altre che portano a riflessioni generali e all’ampliamento del pensiero. Nella stessa manifattura il genio dell’imprenditore viene, forse, coltivato, mentre quello dell’operaio dipendente resta incolto…Il primo può avere guadagnato ciò che l’ultimo ha perduto”.
Anche coloro che lavorano nel settore statale sono equiparati da Ferguson a parti di una macchina che concorrono in modo unitario a garantire allo stato le sue ricchezze, la sua forza e la sua condotta. Quindi, ciò che accade nell’industria privata, si verifica allo stesso modo nel settore pubblico:
“…l’uomo di stato può avere una profonda conoscenza degli affari umani, mentre quelli di cui egli si serve come strumenti ignorano il sistema al quale partecipano come parti”.
Tale dualismo fra soggetti che hanno la possibilità di far uso della propria mente ed individui la cui funzione non richiede né ragionamento né passioni si spinge, secondo Ferguson, a tal punto che lo stesso esercizio del pensiero può diventare una professione particolare.
I fattori che spiegano la pesante subordinazione dei lavoratori agli imprenditori, sono così spiegati da Ferguson:
“il primo fondamento di subordinazione è nella differenza dei talenti e delle disposizioni naturali; il secondo nella ineguale divisione della proprietà; il terzo, che non è meno rilevante, risulta dalle abitudini che vengono acquisite a mezzo della pratica delle differenti arti”.
Quest’ultimo fattore appare in effetti fondamentale, in quanto, secondo Ferguson, a determinare concretamente lo stato di subordinazione non è tanto l’assenza di facoltà, quanto il non uso. Quando infatti le facoltà intellettive non vengono impiegate, restano nascoste persino a chi le possiede e il protrarsi del loro mancato utilizzo ne impedisce lo sviluppo e l’affinamento; ciò risulta poi essere aggravato dalla mancanza di istruzione, in quanto:
“[si ritiene che] l’estrema abiezione di certe classi debba sorgere principalmente da una carenza di conoscenze e dalla mancanza di una educazione liberale”.
Applicando questi concetti all’analisi della società nel suo complesso, Ferguson afferma che le qualità intellettuali di un popolo sono coltivate o trascurate nella misura in cui esse vengono utilizzate nelle attività produttive e nell’esercizio degli affari. I costumi sociali, infatti, migliorano se un popolo è incoraggiato ad agire secondo principi di libertà e giustizia o, al contrario, peggiorano se esso è spinto a vivere in una condizione di miseria e di schiavitù.
La società preindustriale, in conclusione, ponendosi come obiettivo principale l’aumento della produzione, spinge verso una sempre più capillare divisione del lavoro, che si traduce in una maggiore produttività. Tuttavia, così facendo, le varie società risultano formate da soggetti che, al di là del loro mestieri particolari, ignorano la maggior parte delle questioni umane.
Di pari passo con l’aumento della produttività, si manifestano quindi, a livello sociale, tutti gli aspetti negativi connessi alla separazione del lavoro manuale da quello intellettuale: il differenziarsi delle professioni, infatti, se da un lato favorisce il perfezionamento delle abilità ed è la spinta che conduce al miglioramento della produttività, dall’altro rompe il legame sociale e allontana e separa gli individui. Con la distinzione delle professioni e la conseguente separazione dei membri della società civile, si diffonde la parcellizzazione delle funzioni e si riduce così la società ad un insieme di parti, nessuna delle quali sente l’esigenza di unirsi alle altre. Il contributo più originale di Ferguson è quindi l’aver individuato il legame fra divisione del lavoro e frammentazione della società, frammentazione che trova i suoi presupposti nella divisione fra lavoro manuale e intellettuale e quindi nell’assenza di uguali possibilità, in seno alla collettività, di sviluppo e cura delle facoltà intellettuali. A suo avviso, inoltre, quando si manifesta una disparità fra le condizioni ed una disuguale possibilità di coltivare le facoltà intellettuali, risulta molto difficile conservare la democrazia e da questo ne consegue che la divisione del lavoro risulta essere un ostacolo anche all’esercizio del potere popolare. In effetti anche Ferguson riconosce che le assemblee popolari, qualora dovessero essere composte da individui dalle inclinazioni abiette e dediti ad occupazioni illiberali, risulterebbero certamente inadatte a scegliere i rappresentanti destinati a guidare la nazione; con tale affermazione l’autore sembra quasi prevedere l’inevitabilità dell’avvento di regimi dittatoriali nel caso di sistemi produttivi che, relegando la maggior parte degli individui all’esecuzione di operazioni meccaniche e ripetitive, ne annullano totalmente le capacità intellettuali. Le professioni che richiedono maggiori conoscenze e che si basano sull’esercizio della fantasia e dell’amore della perfezione, migliorano lo status sociale dei lavoratori che le esercitano e li conducono ad essere sempre più vicini a quella che si ritiene essere la condizione migliore per gli esseri umani. In questa condizione gli uomini, liberi di seguire le loro inclinazioni intellettuali, non sono legati ad un compito particolare e possono così svolgere nella società quel ruolo veramente attivo che la comunità si aspetta da loro.
Ciò che quindi sarebbe veramente auspicabile, per il benessere degli individui e per la salute della società è, secondo Ferguson, offrire a tutti la possibilità di scegliere liberamente come utilizzare le proprie capacità, intellettuali o manuali.
Principles of Moral and Political Science: l’analisi della natura umana
L’opera Principles of Moral and Political Science, pubblicata in due volumi nel 1792, affronta tematiche di carattere sociologico ed antropologico, etico e morale, aventi tutte come tema unificante la qualità dell’esistenza dell’uomo nella disumanizzante dialettica del mondo economico. Il metodo seguito in questa opera è di tipo empirico, quindi basato sulla ricerca di prove concrete a sostegno delle affermazioni; Ferguson, malgrado non giunga mai ad una totale equiparazione delle scienze umane a quelle naturali, nega infatti la possibilità di conoscere l’uomo con un metodo diverso dall’esperienza diretta mediata dal procedimento scientifico.
L’oggetto dell’analisi di Ferguson è la natura umana, nello studio della quale rifugge da soluzioni riconducibili allo stato di natura o al contratto sociale: egli afferma che così come l’origine dei venti è per noi incomprensibile, allo stesso modo, a suo avviso, le forze che producono l’umana società derivano da oscure e lontane origini; esse si sono manifestate prima del sorgere della filosofia e sono il prodotto non della speculazione umana, bensì dall’istinto. Secondo Ferguson, che rifiuta in questo modo anche la prospettiva edonistica di Hume, il comportamento umano è guidato non solo dal conseguimento del piacere, ma anche e soprattutto da volontà di potere, dall’aggressività, dall’animosità, dal desiderio istintivo per il conflitto e dalla predisposizione alla corruzione. Egli afferma infatti che intimorire, intimidire o, quando non è possibile persuadere con la ragione, imporre con la forza sono le occupazioni che mettono maggiormente in azione una mente attiva, consentendole di ottenere i più grandi trionfi; chi non ha mai lottato con i suoi simili è infatti, secondo Ferguson, del tutto estraneo ai comuni sentimenti umani.
Entrando maggiormente in dettaglio nell’analisi sulla natura umana, Ferguson sottolinea in primo luogo la particolare posizione che l’uomo occupa nella scala degli esseri viventi, unica nel suo genere: l’uomo è rispetto alla natura, vista come passiva, autosufficiente ed indipendente e ciò accade in virtù del suo carattere aperto allo sviluppo, al miglioramento e all’evoluzione. Sullo sfondo di queste sue argomentazioni vi è l’idea di un ordine cosmico statico (la “Great Chain of Being” del XVIII secolo) in cui ad ogni vivente viene attribuito un posto fisso e stabile, idea questa molto diffusa ed oggetto di particolare discussione fra uomini di scienza, filosofi e poeti.
Ferguson procede quindi nell’analisi delle facoltà precipuamente umane, come consapevolezza, percezione, memoria, immaginazione, astrazione, ragionamento, per poi spingersi in seguito a considerare tutte le caratteristiche umane connesse all’esercizio della volontà ed approdare infine ad un discorso sulla morale, il tema forse di maggior interesse. Partendo dal presupposto che l’uomo, come la natura, sia esplorabile, Ferguson giunge ad affermare che il futuro dell’essere umano dipende in massima parte dalla conoscenza delle leggi che regolano il suo “funzionamento” animale ed intellettuale, conoscenza che l’uomo è in grado e ha il dovere di realizzare e di impiegare per raggiungere i grandi fini cui tende la sua esistenza. Una di queste leggi è, secondo Ferguson, il sentimento morale, su cui la stessa natura umana si costruisce.
Altro elemento da non trascurare in una corretta indagine sulla natura dell’uomo è, secondo Ferguson, l’analisi dei sentimenti che l’uomo prova nel rapporto con i suoi simili e per questo aspetto, accettando la prospettiva aristotelica dell’uomo come animale politico, si ispira a Montesquieu e al suo modo di concepire l’essere umano, come soggetto che nasce in società e che lì rimane. Secondo Ferguson, molte specie animali mostrano l’istinto di vivere in gruppo, ma soltanto l’uomo mostra la capacità di progredire: ciò che lo differenzia dall’animale non è tanto la capacità di crescere e svilupparsi, quanto piuttosto il fatto che è in grado di migliorare grazie alla sua capacità inventiva e di porsi anche come obiettivo il perfezionamento della società a partire da ciò che egli trova già presente in natura. Questa caratteristica rappresenta, secondo Ferguson, il vantaggio fondamentale che l’uomo ha nei confronti di tutti gli altri esseri viventi.
Altro principio fondamentale e determinante per la vita dell’uomo è, secondo Ferguson, il principio di conservazione: così come Hobbes e Hume, anche lo stesso Ferguson individua nel principio dell’interesse e dell’utilità personale lo strumento principale per la realizzazione del destino umano, il cui scopo effettivo è il raggiungimento della perfezione. Il principio di conservazione, prosegue l’autore, appare in due diverse forme: una, completamente animalesca, che punta alla conservazione fisica del singolo essere e della specie nel suo complesso, l’altra, tipicamente umana, che fa riferimento alla capacità dell’uomo di sentirsi membro di una comunità. Nel primo aspetto l’uomo è in tutto e per tutto simile agli animali, ma a questa sua “animalità” unisce la capacità di provare desideri, di riflettere, di fare previsioni, di apprezzare il possesso e di comprendere ciò che è nel suo interesse: spinto da queste “molle”, l’uomo giunge progressivamente a fare della ricchezza la sua principale preoccupazione e il suo obiettivo più alto, giungendo però a confondere la mole delle ricchezze possedute con il valore della persona. Accade così, secondo Ferguson, che il desiderio di perseguire il proprio interesse conduce l’uomo a negare uno dei principi fondamentali della vita umana, la propensione all’unione e all’associazione. Se l’istinto di conservazione fosse l’unico scopo dell’uomo, allora, secondo Ferguson, una delusione o un piacere in questo campo dovrebbero essere le uniche passioni di cui un essere umano si rende capace. Ciò, tuttavia, non corrisponde in alcun modo a quella che è l’effettiva condizione umana: osservando infatti il comportamento dell’uomo nei confronti degli oggetti naturali inanimati e dei suoi simili, appare evidente, secondo Ferguson, che egli si contraddistingue sempre per la propensione ai rapporti sociali e per il fatto di mostrare attenzione ed interesse per ciò che proviene dai suoi simili. Tali sentimenti, afferma l’autore, uniti alle motivazioni che provengono dalla ragione, sono alla base della natura morale dell’uomo e la felicità di tutti, e non l’istinto di autoconservazione, è generalmente l’obiettivo verso cui sono rivolte tutte le azioni umane.
Altro tratto peculiare della natura umana è la predisposizione verso l’attività e il progresso, in virtù della quale l’uomo tende sempre alla ricerca di nuovi obiettivi; l’esistenza dell’uomo quindi è costantemente segnata dall’azione e dalla lotta. Se il possesso rappresentasse l’unica fonte di felicità per l’uomo, si dovrebbe concludere che, una volta conquistato ciò che desidera, egli raggiungerebbe di fatto la agognata felicità. Tuttavia, afferma Ferguson, appare evidente che l’uomo raggiunge questa condizione solo raramente e per tempi molto brevi e tale conquista è solo in minima parte legata a fattori esteriori, come la sicurezza, la protezione e l’alimentazione. L’attività umana inoltre, prosegue Ferguson, può essere indirizzata verso la contrapposizione con i suoi simili o verso la positiva convivenza con gli altri. Questa seconda forma di espressione dell’attività umana comprende i sentimenti che legano i genitori ai figli e che uniscono in generale gli uomini, ma, innalzata all’ennesima potenza, essa si manifesta come aspirazione a raggiungere la metà ritenuta più alta, il benessere della società, che rappresenta la chiave per la felicità del singolo individuo e per l’umanità nel suo complesso.
Ferguson a questo punto si chiede come sia possibile per una società, date queste premesse, giungere al declino.
Egli rileva che l’uomo, spinto dalla sua natura verso un miglioramento ed un perfezionamento costanti, può interrompere il suo cammino di progresso solo quando sopravvengono l’avidità di profitto e la brama di guadagno. L’avidità disgrega la comunità poiché rende ogni individuo completamente disinteressato nei confronti dell’attività dei propri simili: poiché ognuno inizia a lavorare unicamente per se stesso, tutti cessano di sentirsi parte di una comunità, i rapporti interpersonali non sono più mediati da sentimenti positivi e la vita della comunità viene condotta unicamente in funzione dell’interesse. Emarginando se stesso dalla comunità, l’uomo inizia così a percorrere i primi passi sulla via della decadenza. Questo processo, non necessario, ma certamente favorito, in uno stato, dalle gravi manchevolezze di cui si macchiano i governanti, conduce inevitabilmente verso un regime politico di carattere dispotico, che tuttavia non può perdurare a lungo in quanto contiene già in se stesso il germe dell’autodistruzione.
Ciò che appare interessante, e fondamentalmente ottimistico, nell’analisi di Ferguson è il rilievo attribuito alla non necessità del processo di decadenza e di declino: egli, proprio per le caratteristiche che la sua ricerca assume e per la volontà di mostrare all’umanità come fuggire dall’involuzione, non può ritenere il declino necessario ed ineluttabile e ciò che emerge quindi come messaggio finale dell’opera è la completa fiducia nelle capacità del singolo individuo e nella sua forza che, intrinseca alla sua stessa natura, sarà in grado di riscattarlo dalle drammatiche condizioni che storicamente si trova a vivere.
I FISIOCRATI
Come è noto, nel XVIII secolo il dibattito sul liberalismo e sul suo sviluppo in ambito economico – il liberismo – trovò espressione in due diverse posizioni, per molti versi riconducibili alle specificità delle due nazioni nelle quali fiorì tale dibattito: se nell’Inghilterra della Rivoluzione industriale esso si incarnò nella posizione dell’economia politica classica (il cui principale esponente è Adam Smith), in Francia – ove l’agricoltura aveva ancora un ruolo predominante – esso fu portato avanti dai cosiddetti «fisiocrati», il cui programma è ottimamente compendiato nel nome: «fisiocrazia» è infatti un composto che significa, letteralmente, «forza della natura» (dal greco fùsis e kràtos). Questi autori (tra i quali ricordiamo F. Quesnay, P. Mercier de la Rivière, P. Dupont de Nemours, Turgot e Condorcet) erano fermamente convinti che i processi socio-economici quali la produzione, la circolazione e la distribuzione delle merci fossero ritmati dall’ordine della natura, un ordine che non di rado essi assimilavano al ciclo della produzione e della circolazione del sangue nel corpo umano. Il punto cardinale della teoria fisiocratica è la teoria del «prodotto netto», secondo la quale è soltanto dalle attività economiche naturali, vale a dire legate alla terra, che scaturisce il prodotto netto (determinato dalla differenza tra il prodotto lordo e i costi di produzione): l’inaggirabile conseguenza è che soltanto le attività naturali sono effettivamente produttive e dunque degne di essere praticate. In questa infinita e, per molti versi, ingenua fiducia nella natura, con il conseguente auspicio di un ritorno ad essa, non è certo difficile scorgere la lezione di un philosophe di prim’ordine, Jean-Jacques Rousseau. Il marcato orientamento liberista dei fisiocrati ben affiora nella misura in cui essi si dichiarano contrari a ogni interferenza (dello Stato e, in generale, delle leggi) finalizzata a correggere l’ordine della natura: tale avversione al tentativo di controllare e orientare i processi naturali trova espressione nel famoso motto fisiocratico «laissez faire, laissez passer», col quale i nostri autori intendevano mettere in luce come, anche di fronte alle crisi più gravi, la soluzione migliore consistesse nel lasciare che la natura stessa seguisse il suo corso regolare. Poste queste premesse, non è difficile capire perché la fisiocrazia abbia insistito tanto sulla necessità di lasciare ai privati piena libertà per quel che concerne la proprietà, il lavoro e il commercio. Il progetto fisiocratico trovò una sua concreta applicazione grazie a Turgot, il quale operò alla corte di Luigi XVI: di fronte all’imperversare delle grandi carestie, Turgot optò coerentemente per il non-intervento statale, sperando che fosse l’ordine naturale stesso a provvedere: ma la sua fu una vana speranza che, da un lato, costò il licenziamento a Turgot e, dall’altro, rivelò la problematicità e lo scacco della teoria fisiocratica.
TURGOT

Anne Robert Jacques Turgot, barone di Laulne (1727-1781), fu un noto uomo di stato ed economista di notevole levatura, oltre che filosofo. Legandosi al circolo dei philosophes, prese parte alla stesura dell’Encyclopédie; fu uno dei massimi esponenti della cosiddetta “fisiocrazia” (la dottrina secondo cui i processi socio-economici quali la produzione, la circolazione e la distribuzione delle merci sono ritmati dall’ordine della natura). Nel 1761 venne nominato intendente di Limoges, carica che mantenne fino al 1774 quando, dopo essere stato segretario di stato alla Marina, divenne controllore generale delle finanze del regno. Il suo programma politico, improntato a un graduale riformismo economico, prevedeva una riduzione delle spese belliche, l’abolizione della ferme générale e la libertà di commercio. Nell’ottobre 1774 decretò la libera circolazione dei grani (estesa, poi, anche ad altre derrate). Tuttavia, un cattivo raccolto provocò il rincaro del pane e una serie di rivolte note come la “guerra delle farine”. Inviso ai grandi finanzieri e ai privilegiati, fu costretto a dimettersi (1776). Fra le sue opere vanno ricordate le Riflessioni sulla formazione e la distribuzione delle ricchezze (1766). Molti lo ricordano solo come grande economista e politico e ben pochi come filosofo. Turgot è il vero inventore della dottrina del progresso: e non solo con delle pagine tra le più interessanti di tutta la letteratura filosofica settecentesca (Ludovico Geymonat nella sua monumentale Storia del pensiero scientifico e filosofico, gli dà lo spazio che si merita) ma con le azioni, cioè l’applicazione delle sue teorie, applicate già nel 1761, quando il giovane e geniale funzionario fu nominato intendente a Limoges, dove non solo formulò la sua teoria (oggi nota come “teoria del progresso”) ma la applicò ottenendo dei grandi risultati, suscitando l’attenzione a Parigi, dove fu chiamato da Luigi XVI prima a fare il segretario di Stato della marina, poi a fare il segretario generale delle finanze del regno. A tal proposito, è significativa l’importanza che Turgot attribuisce alla storia: essa è il luogo privilegiato per la conoscenza dell’uomo. La storia è diversa dalla natura, perché al contrario di essa non si riproduce in modo sempre uguale. Essa è opera dell’uomo e per questo nella storia c’è il progresso verso una sempre maggiore perfezione. Questo è il cardine della filosofia della storia di Turgot: il progresso come meta a cui inarrestabilmente tende il genere umano.
“La storia universale abbraccia pertanto la considerazione dei progressi successivi del genere umano, e l’esame particolare delle cause che vi hanno contribuito. Essa comprende cioè i primi inizi dell’umanità, la formazione e l’incontro delle nazioni, l’origine e le trasformazioni dei governi, i progressi delle lingue, della fisica, della morale, dei costumi, delle scienze e delle arti, le rivoluzioni per cui gli imperi sono succeduti agli imperi, le nazioni alle nazioni, le religioni alle religioni: in questi mutamenti il genere umano rimane sempre lo stesso, come l’acqua del mare nelle tempeste, e procede sempre verso la propria perfezione. Scoprire l’influenza delle cause generali e necessarie, delle cause particolari e delle azioni libere dei grandi uomini, ed il rapporto di tutti questi elementi con la costituzione stessa dell’uomo, mostrare le energie e la meccanica delle cause morali attraverso i loro effetti — ecco che cosa rappresenta la storia agli occhi di un filosofo”.
Il giovane re Luigi XVI era ben cosciente del valore di Turgot, ed era anche cosciente che bisognava dare una drastica svolta a tutta la politica economica, e a quella delle finanze dello stato. E per prima cosa bisognava eliminare i parassiti delle finanze dello stato: gli appaltatori che riscuotevano le imposte in regime di monopolio. Ma l’opera di Turgot, appena iniziata, prima fu fortemente contrastata dalla casta di rapaci sovrintendenti delle finanze, poi dai perenni parassiti di corte, ed infine pur messo al vertice, fu cacciato dagli aristocratici nel 1776 (da notare che Luigi XVI, che non era certo un’aquila, fu l’unico ad essere d’accordo con le sue idee). Nominato ministro Controllore Generale delle Finanze, Turgot abolisce le dogane interne del commercio dei grani e cerca di stabilire una libertà nel commercio e nell’industria; applica insomma il “liberismo economico”, sopprimendo nelle grandi città le corporazioni che soffocavano alcuni settori dell’economia, ed eliminando le strozzature doganali che spesso esistevano anche nei piccoli possedimenti di piccoli nobili, che impedivano (con pesanti pedaggi) la circolazione delle merci fra grandi territori a maggior vocazione mercantilistica. E fu Turgot (e non la Rivoluzione, nè Napoleone) ad abolire con un decreto le corvèe feudali e il servaggio. Né dimentichiamo che l’economista Adam Smith fu particolarmente influenzato dalle sue teorie, utilizzandole nella sua celebre opera Ricchezza delle nazioni (1776). Per risanare le finanze statali, Turgot crea l’Imposta Fondiaria Unica. Ma già all’inizio di questa riforma, egli incontra delle serie opposizioni all’interno dei ceti privilegiati, la nobiltà e il clero. Sono del resto loro a detenere la maggior parte dei terreni, e quindi ad essere colpiti dalla riforma. Buona parte di loro hanno il diffuso privilegio di non pagare le tasse o pagarne poche, mentre il clero ne è del tutto esente. Ma soprattutto Turgot cerca di riprendere in mano le attività dei sovraintendenti, degli appaltatori, che ormai da quasi un secolo non sono stati più sostituiti, anche se una norma regia di Luigi XIV del 1681 stabiliva la sostituzione ogni sei anni. Fu quindi subito inviso ai grandi finanzieri e ai privilegiati. Poi quando propose l’abolizione della fermè general (Fermiers generaux), fu poi costretto a dimettersi. La Francia, fin dal 1681, era stata messa in mano agli appaltatori. Da tempo questi erano una vera piaga della Francia, con il lassismo di corte Una piaga perché non solo rimasero sempre gli stessi, ma resero ereditaria anche la loro carica; fino a costituire una potente lobby finanziaria, che riscuoteva le imposte in regime di monopolio, e che si prendeva anche il lusso di versare in ritardo di anni all’erario le somme incassate. Anzi, con gli stessi denari ricevuti in pagamento facevano prestiti alla corona a tassi di interesse che arrivavano al 30/40%, indebitando così esponenzialmente lo stato; interessi sugli interessi. Estirpare queste lobby all’esterno, o i loschi avventurieri e avventuriere all’interno delle corte, non era facile. Dentro c’erano cavalieri e madame serventi meschine, ma c’erano anche quelli che tramavano e istigavano dentro la stessa corte dove mangiavano e si sollazzavano e alla corte dovevano il loro tenore di vita. Dopo la grave crisi causata da un disastroso raccolto, Turgot fu licenziato; i nemici trovarono un pretesto per dare le colpe tutte a Turgot e alle sue teorie del libero commercio. Solo un autoritario sovrano con una buona milizia e buoni comandanti ai suoi ordini poteva applicare i metodi drastici. Ma Luigi XVI non era uno di questi, era un brav’uomo, generoso, pio e modesto, perfino operoso in cento mestieri; ma queste erano qualità apprezzabili in un uomo comune, deprecabili in un sovrano.
FRANÇOIS-JEAN DE CHASTELLUX

A cura di Gemma Lupi
L’autore del testo De la félicité publique,1“non opera di filosofia, né di morale, né di storia, né di economia, ma un po’ di tutte queste discipline messe insieme, in un abile mèlange nel quale i lettori potevano trovare riunite le idee fondamentali sparse in volumi specializzati e più elaborati”,2 è François-Jean de Chastellux, ufficiale dell’esercito francese e “filosofo dilettante”. Noto per gran parte della sua vita con il nome di chevalier de Chastellux, nasce a Parigi nel 1734. Quando ha già iniziato la carriera militare, si appassiona alle lettere e alla filosofia, avendo letto, per caso, un volume dell’Encyclopédie: da questo momento sviluppa la sua cultura da autodidatta. Si inserisce nella società francese del suo tempo, stringendo amicizie con personaggi quali Turgot, Buffon, D’Alembert, Helvétius e d’Holbach; in Inghilterra conosce Hume e in Italia Metastasio. Dopo essere entrato nell’Académie Française, continua, comunque, a dividere il suo tempo tra la passione per le lettere e le arti e l’attività militare: venuto a conoscenza della Rivoluzione americana, infatti, egli parte a sostegno degli Stati Uniti, con il grado di maréchal de camp. Anche in America intrattiene relazioni con personaggi illustri, primo tra tutti il generale Washington. Torna in Francia nel 1783 e qui, nel 1787, si sposa con la dama di compagnia della duchessa di Orléans, ma solo un anno dopo muore.3De la félicité publique viene pubblicata per la prima volta anonima ad Amsterdam nel 1772, la prima ristampa è del 1774 e la seconda, la prima a Parigi, è del 1776, infine, la ristampa del 1822, riporta le note scritte da Voltaire a margine dell’edizione da lui posseduta.
La prima parte di De la félicité publique, oggetto di questa breve trattazione, riguarda i popoli antichi, dagli Egizi all’Impero romano e al Cristianesimo delle origini, passando per la Grecia antica. Nel primo capitolo della prima sezione, l’autore formula il problema: sono più felici gli antichi o i moderni? Lo scopo dell’opera non è quello di aumentare la felicità pubblica, ma solo quello di esaminare la storia dell’umanità per capire se sono stati più felici i popoli antichi o se sono più felici i popoli moderni. Per “felicità” Chastellux usa indistintamente i termini francesi “félicité” e “bonheur”. Per poter procedere nell’indagine storica, l’autore enumera i segni e le cause della felicità pubblica: questi sono, in primo luogo, la pace, l’abbondanza e la libertà, in secondo luogo, l’incremento della popolazione e, infine, il progresso del commercio e dell’industria. Non servono particolari capacità filosofiche o storiche per riconoscerli, ma basta saper esercitare correttamente la ragione: l’importanza attribuita alla ragione inserisce pienamente questo filosofo nel panorama dell’Illuminismo francese. Più avanti nel testo, infatti, egli mostra la consapevolezza e l’orgoglio di vivere nel Secolo dei Lumi:
“Dans un siècle moins éclairé, avec des esprit moins accoutumés aux nourritures les plus substantielles, je devrais m’excuser de cet écart philosophique et sourtout de la forme concise et abstraite que j’ai donné à ces réflexions: mais je n’ignore pas que l’instruction est tellement répandue de nos jours, que les auteurs ne peuvent presque plus réclamer d’autre avantage sur les lecteurs, que d’avoir pensé plus longtemps qu’eux à la chose don’t ils écrivent”.4
Si addice al clima illuminista anche la rilevanza data al tema della libertà, concepita come indefinita e limitata solo dalla libertà altrui: essa è necessaria per la felicità, dal momento che è propria dell’uomo, la cui preoccupazione principale è quella di conservarla o di recuperarla quando la perde.
“Dire que l’homme est né pour la liberté, que son premier soin est de la conserver lorsqu’il en jouit, et de la recouvrer lorsqu’il l’a perdue, c’est lui attribuer un sentiment qu’il partage avec tous les animaux, et qu’on ne peut révoquer en doute”.5
Questa è una verità che non può essere contraddetta, da cui scaturiscono altre verità poco conosciute dagli antichi e non sufficientemente sviluppate dai moderni, ma che hanno una forte influenza sulla felicità dei popoli. La prima verità che Chastellux espone consiste nell’affermare che la libertà è anteriore rispetto alla costituzione dei governi e che, anche se spesso si è cercato di mostrare che i governi permettono agli individui e ai popoli di raggiungere la felicità, nessun governo è nato a questo scopo. La libertà e la proprietà, infatti, si affermano nell’ambito privato, non nello Stato, e ogni forma associativa deve garantirle. I governi, utilizzati come mezzi per assicurarsi tali privilegi, però, non hanno a loro volta il proprio fondamento nella libertà, bensì nella forza e nella violenza: questo vale per le associazioni formate da briganti che seguono colui che tra loro è il più forte, ma anche per i governi militari stabiliti da condottieri e per i governi affermati dal popolo più forte su un popolo sconfitto e conquistato. Negare ciò “c’est renoncer aux lumières de l’histoire et de la raison”:6 ecco un altro riferimento alla facoltà razionale, associata al termine lumières, che contraddistingue il Settecento francese. Affermare che le associazioni nascono dalla forza e dalla violenza implica opporsi alla posizione contraria, per la quale esse si basano su un’unione naturale, fondata sull’agricoltura e sul commercio: questi ultimi, infatti, sono elementi essenziali per la famiglia. L’antichità per prima mostra l’importanza della forza, anche se spesso essa è stata confusa con la virtù, tanto da far coincidere la virtù con la potenza e il coraggio: i primi uomini, infatti, hanno esercitato la forza inizialmente sugli animali, poi tra di loro.
Per poter affrontare il tema del “bonheur des peuples”,7 bisogna far notare che, dopo un periodo in cui il primo interesse degli individui era rivolto alla famiglia, è avvenuto un cambiamento che ha portato gli uomini a privilegiare “la chose publique”8: gli uomini hanno preferito la gloria al piacere, la vita militare alla vita domestica, la patria alla famiglia. Chastellux vede lo Stato in totale opposizione alla famiglia, poiché il primo è nato in modo artificioso per mezzo della violenza, mentre la seconda è caratterizzata dalla naturalità e dalla dolcezza. C’è una visione negativa dello Stato e dell’amor di patria, poiché questo esiste soltanto se esiste anche l’odio per le altre nazioni.
“On n’aimera plus ni sa femme, ni son champ, ni ses propres jouissances; on tournera toutes ses affections vers la cité, vers la republique; et de là naîtra cet amour effréné de la patrie, sentiment qui, si l’on y prend bien garde, a toujours été mêlé de quelque férocité, et qui, chez tous les peuples du monde, est inseparabile de la hainepour leurs voisins”.9
Gli individui che compongono un popolo perennemente occupato ad attaccare altri popoli o a difendersi da essi non vedono più le donne come persone da amare, ma come mezzi per incrementare la popolazione, non vedono più i figli come frutti preziosi di un amore duraturo (“les gages précieux d’une union fidèle et durable”10), ma come futuri guerrieri da educare: gli affari domestici vengono accantonati e le leggi diventano il solo interesse dei cittadini.
“Nous avons vu que tous les legislateurs s’etant occupés plutôt à rendre les homes forts qu’à les rendre heureux, tous les peuples ont été à leur tour esclaves ou usurpateurs. Sans jamais atteindre à une félicité permanente”.11
Pur ammettendo che un popolo sia sempre vincente nelle guerre ed espanda il suo dominio, avrà gloria, ma non felicità: la gloria è una forma di felicità precaria e contro natura, perché l’amore per la libertà individuale è più naturale rispetto all’amore per la patria. Nei popoli che aspirano alla gloria non c’è felicità, poiché sono troppi i sacrifici richiesti agli individui. A proposito di nessuno dei popoli antichi, dunque, si può parlare di felicità assoluta né di vera gioia. Nel terzo capitolo di questa prima sezione, in cui si affronta il problema della felicità degli antichi, il filosofo spiega che i cittadini costretti a molti sacrifici per il loro governo sono infelici, ma sono ugualmente infelici quei popoli in cui regna la rilassatezza dei costumi e in cui i cittadini non si adoperano abbastanza per la collettività.12
Tutte queste osservazioni vengono applicate da Chastellux nel resto della prima parte dell’opera, dedicata all’analisi dei popoli antichi: la tesi da dimostrare è quella per cui “les peuples ne sont pas heureux toutes les fois que les gouvernements prospèrent”.13
A partire dal secondo capitolo inizia l’esame della storia dell’umanità, come anticipato in precedenza: a ogni capitolo che descrive gli eventi caratterizzanti della storia di un popolo,ne segue un altro che chiarisce se quel popolo sia stato felice o meno.
Chastellux inizia facendo notare che tutti i popoli dominanti dell’antichità si sono serviti della guerra: la monarchia egiziana ha imposto il suo dominio attraverso guerre ingiuste, per il desiderio di imporsi dovunque, ma nonostante ciò è plausibile credere a una lunga pace seguita al suo insediamento. Al contrario, gli altri popoli antichi, quali Assiri, Babilonesi, Medi e Lidi, hanno conosciuto solo il dispotismo e la violenza, che dovunque tolgono all’uomo ciò che di buono gli ha dato la natura. Le considerazioni fatte su questo periodo storico permettono di concludere che la felicità non vi ha avuto alcuno spazio, poiché la guerra e la tirannia l’hanno ostacolata: un intero popolo che soddisfa un re dispotico non può essere felice. Non bisogna, dunque, confondere il popolo con il suo governo, la felicità dell’uno con la felicità dell’altro:
“On croit que le peuple est heureux quand l’état s’agrandit: au lieu d’envisager le bien des individus, on ne considère que l’accroissement et la durée des empires, comme si la prospérité publique et la felicité générale étaient deux choses inséparables”.14
Anche a proposito dell’antica Grecia, il filosofo esprime un giudizio negativo, ma, nonostante ciò, non si sente un detrattore dell’antichità, bensì afferma di trovarsi in una posizione di equilibrio.15
“Au seul nom de la Gréce, l’enthousiasme se réveille, et nous rentrace aussitôt les idées de vertu, de courage, de désintéressement et d’austerité, reunies avec celles de la perfection dans les arts, de la délicatesse dans le goût, et du raffinement dans la volupté: tant l’admiration est capable d’allier les choses les plus opposées!”.16
Questa è l’immagine che si presenta alla mente di tutti, ma, guardando con attenzione, Atene appare come un città male organizzata, crudele e ingrata, i cui cittadini sono capaci solo di discutere, ma non di concludere, mentre Sparta si rivela essere un esercito sempre armato, che rinuncia, per questo, a ogni altra attività. Nel discorso sulla Grecia si inserisce anche un giudizio sulla filosofia, nata in questi luoghi. Lo sguardo di Chastellux è di nuovo critico: prima di Socrate la filosofia si riduceva a cosmogonia e teogonia, ma, anche una volta avvenuta la svolta in senso etico, gli effetti sul popolo sono stati scarsi e la Grecia è rimasta impregnata di superstizione e crudeltà. Ma è soprattutto Sparta a essere obiettivo dell’attacco dell’autore: gli Spartani non coltivavano la terra, non conoscevano il commercio, non avevano legami familiari ben regolati. La loro povertà e frugalità non costituisce un punto a loro favore: essi non conoscevano la ricchezza e il lusso, per cui non potevano amarli. La critica si allarga, poi, a quei pensatori che hanno esaltato questo popolo e ne hanno narrato le spaventose imprese, senza denunciarne l’orrore: un simile atteggiamento può risultare pericoloso in particolare per i giovani che si accostano alla storiografia. A questo proposito, Guerci fa notare la polemica con Rousseau, che si trova proprio tra coloro che lodano gli antichi.17
Nessuna tra le civiltà finora presentate si può definire felice e lo stesso vale per Roma. Roma, potenza che merita di essere ricordata perché ha imposto il suo governo e i suoi principi su tutta l’Italia e poi su tutto il mondo, dimostra che la grandezza di un’istituzione politica non coincide con la felicità di un popolo. Infatti, a Roma gli uomini non erano più liberi e più sereni rispetto a quelli degli altri popoli, non c’erano leggi più umane, non mancava la tirannia e il commercio e l’agricoltura non erano più sviluppati che in Grecia. In particolare, la tirannia, di un uomo solo o dell’oligarchia senatoria, si è sempre imposta. Se i Romani non sono un popolo felice, allora il loro governo non è un modello da imitare, come spesso si sostiene: gli storici hanno detto molte falsità riguardo a Roma, cercando di offrire un quadro positivo, che è molto lontano dalla realtà delle cose.
“Transportons-nous en idée dans le sein de cette ville, et voyons une populace triste et misérable frémir autour du sénat”.18
Di sicuro una passione molto forte nei Romani è l’amore per la gloria, una gloria che essi hanno raggiunto, ma, come già chiarito, la gloria è ben diversa dalla felicità.
Il governo dispotico di Roma, con la formazione dell’impero, si è esteso anche ai popoli conquistati che, così, sono stati resi infelici a loro volta: la continua condanna della tirannia mette in risalto, per contrasto, il favore dell’autore nei confronti della repubblica. Condizione imprescindibile per la felicità è la libertà, che può essere realizzata solo dove esiste una costituzione repubblicana. Solo l’epoca di Augusto vede una certa compensazione dei mali con i beni e per questo sembra essere l’epoca più felice della storia di Roma. In effetti, il princeps era pacifico, ma ha comunque dovuto intraprendere guerre per sedare delle rivolte ai confini dell’impero e, in ogni caso, la gran parte del mondo, proprio perché era sottoposta alla dominazione romana era in una condizione di infelicità. “Da un punto di vista generale”, spiega, sintetizzando, Guerci, “i Greci e i Romani erano condannati per aver ignorato i principi e i mezzi atti a promuovere l’agricoltura e il commercio, per non aver avuto né una “véritable morale” né una “saine politique”, soprattutto per essersi macchiati dell’infamia della schiavitù: cosa quest’ultima, che agli occhi di Chastellux bastava a provare la superiorità dei moderni”.19
La seconda sezione della seconda parte è dedicata all’esame dei due più grandi fenomeni che hanno caratterizzato il periodo che va dalla fondazione dell’impero romano alla caduta dell’impero romano d’Occidente, influendo sul grado di felicità: le invasioni barbariche e la diffusione del Cristianesimo.
I Barbari, rozzi e incolti, sono stati in grado di imporsi sui discendenti di Omero e Platone, poiché erano spinti dal bisogno: essi sono stati mossi, infatti, dal desiderio di trovare climi più miti e terre più feconde. Hanno portato guerra in tutta Europa, distruggendo i nemici, poiché questo era il presupposto della loro stessa sopravvivenza, e, con la guerra, hanno portato nelle terre soggette all’invasione anche l’infelicità.
Nell’affrontare il discorso a proposito del Cristianesimo, Chastellux si pone su un piano laico, affermando di voler studiare “l’influence de la religion chrétienne sur le bonheur des hommes, dens cette vie seulement”.20 Tutto il testo, infatti, si presenta sotto la forma di un saggio critico che si serve del dubbio e della discussione e, a maggior ragione, questo metodo dev’essere applicato agli argomenti religiosi. La religione cristiana ha sostituito progressivamente il paganesimo, che ha avuto una durata straordinariamente lunga in rapporto al credito che aveva tra i suoi stessi ministri e tra gli intellettuali. Tra i Romani la religione è sempre stata strettamente legata alla politica, tanto che “le droit de prendre les auspices marquait la différence essentielle qui existait entre la noblesse et le peuple”.21 Il legame tra religione e politica si è perso solo con gli imperatori, che si sono circondati di filosofi trop éclairés per alimentare la superstizione.
Leggendo i testi dei Padri della Chiesa si vede come la separazione tra cristiani ed ebrei non sia stata immediata: per un periodo la legge di Mosè e l’insegnamento di Gesù si trovano a convivere e, ad accomunare cristianesimo ed ebraismo, c’è anche la lotta contro il politeismo e il paganesimo. Quando il Cristianesimo inizia a cercare una propria definizione, nascono al suo interno delle controversie: le discussioni a proposito dei dogmi portano a distinguere i cristiani ortodossi dagli eretici. Per molti teorici e teologi un punto di riferimento nelle dispute diventa il platonismo. Ma non sono certo tali dispute a far guadagnare credito alla religione cristiana, bensì le persecuzioni, a cui i cristiani rispondono con insegnamenti di tolleranza e fratellanza, capaci di diffondersi tra i Romani e tra i Barbari nelle province. A questo si aggiunge il sostegno ottenuto dall’Impero: Costantino, con l’Editto di tolleranza, ha dato inizio all’epoca della Chiesa, nonostante essa fosse divisa al suo interno dai contrasti sui dogmi. Con il concilio di Nicea, però, anche tali contrasti sono stati risolti, sempre alla presenza dell’imperatore. A questa figura Chastellux riserva un intero capitolo, allo scopo di portare alla luce il suo vero volto, ovvero quello di un imperatore crudele, che solo per comodità si è servito del Cristianesimo: uno dei compiti degli studiosi di storia, infatti, è quello di smascherare la falsità e mostrare la verità, occultata spesso dagli storici.
“Il est toujours affligeant de lever le masque sous lequel la faible humanité parvient quelquefois à se cacher; mais cet emploi, odieux dans la società, est noble et utile dans les recherches historiques. En effet, si le cours ordinaire de la justice a besoin qu’un examen lent et impartial vienne, après de longues années, redresser ses propres erreurs, combine l’histoire, placée d’abord entre le flatteur et le zoïle, et livrée ensuite à l’aveugle compilateur, n’est-elle pas en droit de réclamer contre la sentence des siècles passes!”.22
Inoltre, proprio il favore ottenuto dal potere politico ha trasformato i cristiani da perseguitati a persecutori. Il Cristianesimo non tende alla felicità terrena, quindi, né la gloria né la decadenza delle nazioni sono imputabili a esso: se ai primi secoli della Chiesa corrispondono la crisi dell’impero e le invasioni barbariche non è colpa della religione. Si nota che l’autore è prudente nei confronti del Cristianesimo: non si proclama ateo né cristiano né deista, non fa accenni di alcun tipo alla sua fede ed evita di dare giudizi personali su questo tema. La religione cristiana non è riuscita a rendere gli uomini migliori o più felici, poiché è stata ostacolata dal male presente nell’epoca in cui essa ha iniziato a diffondersi. Ma un aspetto sicuramente negativo del cristianesimo è costituito dal fatto che si è accompagnato all’intolleranza.
“De tous les ennemis du genre humain, le plus cruel et le plus moderne, l’intolerance, suivant pas à pas la religion dans ses progress, s’étendit avec elle, et fit briller le glaive partout où le zèle fit entendre la parole”.23
L’affermazione di una religione unica, inoltre, ha fatto sì che alla morale si sia sostituita la teologia e che gli uomini si siano trovati oppressi da essa, oltre che dalle leggi e dalla tirannia.
Dopo aver letto la prima parte di De la félicité publique si vede come Chastellux offra una visione negativa dell’antichità, in cui dominano il dispotismo, la violenza e la guerra: gli antichi rappresentano l’inizio del processo di civilizzazione,24 ma il bonheur può essere realizzato solo con il progresso, inteso come progresso della ragione, delle scienze, delle attività economiche e, di conseguenza, anche del lusso, che non è da criticare, opponendolo alla sobrietà e all’austerità dei popoli antichi.
I primi commenti all’opera di Chastellux risalgono all’anno della prima pubblicazione: nel 1772, infatti, Voltaire scrive una lettera all’autore di De la félicité publique per metterlo a conoscenza della sua opinione. Voltaire, pur avanzando qualche critica, si dimostra entusiasta e non risparmia i complimenti:
“Monsieur, la première fois que j’ai lus la Félicité publique, je fus frappé d’une lumière qui éclairait mes yeux, et qui devait brûler ceux des sots et des fanatiques; mais jq ne savais d’où venait cette lumière”.25
“Je chargeait de notes mon exemplaire, et c’est ce que je ne fais que quand le livre me charme et m’instruit”.26
In un’altra lettera del 1777, invece, Voltaire ringrazia Chastellux per avergli inviato una copia del suo saggio corredato di nuovi approfondimenti. Ma è proprio a Voltaire, che lo elogia per il suo lavoro, che Chastellux si è ispirato. Infatti, con il Saggio sui costumi e sullo spirito della nazioni27e, ancor prima, con Il secolo di Luigi XIV, Voltaire fonda la filosofia della storia: con questi testi egli ricerca il significato generale del processo storico, indicando nell’idea di progresso il suo fondamento. Il philosophe afferma di poter distinguere gli uomini in quattro razze, ma poi ne elenca sette: i Bianchi, i Negri, gli Albini, gli Ottentotti, i Lapponi, i Cinesi e gli Americani. Egli ritiene che tutti siano uguali, ma poi aggiunge che solo i Bianchi sono dotati di un alto grado di intelligenza. Inoltre, i non-europei, fatta eccezione per la civiltà cinese, sono sempre paragonati agli antichi: questo significa che, a parere dell’autore, essi si trovano ad uno stadio iniziale dello sviluppo, in cui regna l’abbruttimento. A questo proposito, Voltaire sottolinea come sia necessario moltissimo tempo perché un popolo si possa formare un linguaggio comune e, poi, riesca a costituirsi una società. E risulta essere ancor più difficile sviluppare “l’arte di rappresentare i propri pensieri”28: ne è una prova il fatto che solo le nazioni civilizzate hanno elaborato una metafisica e una religione monoteista, basata sulla fede in un “eterno architetto”29. Nonostante ciò, dato che tutti i popoli seguono lo stesso percorso evolutivo, sembra che, per Voltaire, prima o poi, in ogni Paese potranno nascere ed affermarsi la filosofia e il monoteismo. Se, per quanto riguarda il futuro, è soltanto probabile che tutte le civiltà raggiungano lo stesso stadio dello sviluppo, per quanto riguarda il passato, bisogna, invece, essere certi che tutti i popoli antichi e, come loro, quelli primitivi, abbiano e abbiano avuto usanze e credenze comuni, dal momento che “la natura è dappertutto la stessa”30.
Si vede, quindi, come Chastellux e Voltaire si trovino d’accordo: le popolazioni antichesono popolazioni non civilizzate, che rappresentano l’infanzia della civiltà. Popoli simili, secondo Voltaire, sono presenti anche nella sua stessa epoca e non coincidono semplicemente con i “selvaggi d’America”,31 ma si trovano in questa condizione anche i Francesi e, in generale, gli Europei non ancora raggiunti dal progresso economico e culturale.
“Che cosa intendete per selvaggi? Degli zotici che abitano in capanne con le loro femmine e qualche animale, sempre esposti alle intemperie, che conoscono solo la terra che li nutre e il mercato dove ogni tanto si recano a vendere le loro derrate per acquistarvi un grossolano indumento, che parlano un dialetto incomprensibile nelle città, dotati di poche idee, e quindi, di poche espressioni, sottoposti senza che sappiano perché, a uno scrivano, al quale tutti gli anni consegnano metà di quanto hanno guadagnato col sudore della fronte, che in certi giorni si riuniscono in una specie di granaio per celebrare cerimonie di cui non capiscono nulla, che ascoltano un uomo vestito diversamente da loro e che essi non intendono affatto; che talvolta abbandonano la loro capanna quando batte il tamburo, per andare a farsi uccidere in terra straniera e a uccidere i loro simili per un quarto di quanto potrebbero guadagnare lavorando a casa loro?”32.
Per entrambi gli autori, quindi, il progresso, in ogni campo, rappresenta un fattore positivo per l’umanità ed è il mezzo per raggiungere il bonheur; un altro punto di contatto tra i due consiste nell’idea che la storia non sia fatta dai re e dai grandi, bensì dai popoli e dai movimenti culturali. Al contrario, le loro opinioni divergono per quanto riguarda la Grecia antica: mentre Chastellux si dimostra critico, Voltaire vede nell’età di Pericle una delle epoche più felici della storia. I Greci hanno il merito di aver fatto nascere le belle arti e di aver fatto progredire la cultura e, soprattutto, hanno accettato la libertà di pensiero.
“La bella architettura, la scultura perfetta, la pittura, la buona musica, la vera poesia, la vera eloquenza, la maniera di scrivere bene la storia, anche la filosofia stessa, sebbene informe e oscura, tutto questo pervenne alle nazioni solo per il tramite dei Greci”.33
“I Greci avevano un’intelligenza talmente acuta che ne abusarono, ma torna a loro onore che nessun governo abbia ostacolato il pensiero degli uomini. Soltanto di Socrate si sa con certezza che le opinioni gli costarono la vita, e fu meno vittima delle proprie opinioni che non di un violento partito formato contro di lui. Gli Ateniesi, è vero, gli fecero bere la cicuta, ma si sa quanto se ne pentirono; si sa che punirono gli accusatori, e che elevarono un tempio a colui che avevano condannato. Atene concesse piena libertà non solo alla filosofia, ma a tutte le religioni; accoglieva tutti gli dei stranieri, e aveva perfino un altare dedicato agli dei sconosciuti”.34
Dopo i primi positivi commenti di Voltaire e dei contemporanei, però, cade il silenzio sull’opera di Chastellux. Probabilmente, ciò è dovuto alla mancanza di originalità della sua opera: “In effetti l’originalità del suo pensiero non è grande; quasi tutte le sue riflessioni, anche quelle della sua opera principale, riprendono temi e posizioni ormai tradizionali nella cultura illuministica”,35 anche se il soffermarsi sul problema della felicità costituisce un elemento nuovo. Questo tema fa parte degli interessi del Settecento, ma il nostro autore stringe il legame tra felicità e progresso, arrivando a identificarli: la felicità non è solamente la conseguenza del progresso, ma un parametro per misurarlo. Gli antichi che si trovano a un livello basso dello sviluppo, sono simultaneamente in una condizione di infelicità. Ma se il progresso è misurato dal grado di felicità, come si misura, a sua volta, la felicità? Chastellux propone un metodo per calcolarla, in rapporto alla quantità di lavoro richiesta a un individuo. Il lavoro, infatti, è necessario a ognuno per provvedere alla propria sussistenza, ma un’eccessiva quantità di tempo dedicata al lavoro rischia di produrre infelicità: questo significa, allora, che la felicità dipende dal tempo disponibile, nella giornata, nel mese o nell’anno, per attività diverse dal lavoro. Bisogna tenere a mente, inoltre, che non si lavora solo per la propria sussistenza, ma anche per pagare imposte al potere sovrano. Al fine di fare un calcolo, seppure approssimativo, del grado di bonheur di un popolo, è necessario presupporre che il lavoro sia diviso equamente tra gli individui e che ognuno sia obbligato a costruirsi una casa, a procurarsi il cibo, a cercarsi gli abiti, a cucinare, a coltivare la terra, a fare tutte le attività normalmente suddivise diversamente in una società. Poi bisogna calcolare il tempo che resta libero e metterlo in rapporto al tempo richiesto dal potere sovrano.36“Or je dis que c’est ce rapport qui décidera du bonheur ou du malheur des peuples”.37
Un altro tratto innovativo di De la félicité publique sta nell’affermare che per raggiungere la felicità bisogna riconoscere e realizzare le leggi dell’ordine naturale, sia sul piano economico sia sul piano sociale. “I principi dell’ordine naturale su cui si fonda la possibilità di progresso della società sono la libertà e la proprietà”.38 Ciò che interessa a Chastellux è “indicare quali siano i segni rivelatori di questo progresso, e che individua in un’agricoltura prospera, una popolazione numerosa ma proporzionata ai mezzi di sussistenza, una diffusa attività commerciale, una crescente integrazione tra le classi sociali”.39 Uno dei segni del progresso è la prosperità dell’agricoltura, dal momento che da essa si trae la sussistenza e, com’è chiaro, condizione basilare per la felicità degli uomini è non soffrire la fame. Un altro segno è la crescita demografica: questa, infatti, è conseguenza della diminuzione delle guerre, delle epidemie e dei disastri naturali e della crescita dell’agricoltura e del commercio. In vista del progresso ha una sua utilità anche la disuguaglianza, in quanto costituisce un fattore di stimolo alla competitività nelle attività economiche: essa va attenuata, ma non può essere eliminata, poiché l’uguaglianza di tutti i cittadini rischierebbe di abbassare le condizioni di vita generali.
Ogni società nasce per difendere la libertà e la proprietà, questo significa escludere la possibilità di un potere assoluto, che avrebbe il diritto di chiedere qualunque sacrificio ai cittadini. Le migliori forme di governo sono la repubblica e la monarchia costituzionale: sotto questi governi, in cui gli individui possono perseguire il loro benessere, sono stati fatti i maggiori progressi in vista della civilizzazione. La libertà può sussistere solo dove esiste la rappresentanza e il potere legislativo è controllato dal popolo: a questo proposito, Chastellux polemizza con Rousseau.40 Rousseau, infatti, sostiene che non ci possa essere libertà in uno Stato troppo grande, dov’è necessario il ricorso alla rappresentanza.
“Non appena il servizio pubblico cessi di essere il principale impegno dei cittadini e questi preferiscano servire con la loro borsa piuttosto che di persona, lo Stato è già prossimo alla rovina. Bisogna andare a combattere? pagano delle truppe e restano a casa; si deve andare al consiglio? eleggono dei deputati e restano a casa. A forza di pigrizia e di danaro finiscono con l’avere dei soldati per asservire la patria e dei rappresentanti per venderla”.41
“La sovranità non può venir rappresentata, per la stessa ragione per cui non può essere alienata; essa consiste essenzialmente nella volontà generale e la volontà non si rappresenta: o è essa stessa o è un’altra; una via di mezzo non esiste. I deputati del popolo non sono dunque e non possono essere i suoi rappresentanti, sono solo i suoi commissari; non possono concludere niente in modo definitivo”.42
Chastellux, al contrario, è convinto che solo un governo di questo tipo possa garantire una pace solida e duratura e, soprattutto, la libertà. Una democrazia diretta, in cui ogni cittadino riveste tutti i ruoli, non può essere ben governata, mentre uno Stato più grande, dotato di corpi intermedi per la gestione del potere, in cui ciascuno svolge al meglio la sua funzione, può essere pacifico e libero. Anche a proposito della rappresentanza, Chastellux trova il sostegno di Voltaire che, però, non condivide il favore per i grandi Stati.
Note
1.F. J. deChastellux, De la félicité publique, Gregg International Publishers Limited Westmead, Farnborough, Hants., England 1971.
2.L. Guerci, Libertà degli antichi e libertà dei moderni, Guida, Napoli 1979, pp. 205-206.
3.Le notizie biografiche su Chastellux sono tratte dalla Notice sur le marquis de Chastellux, scritta da Alfred de Chastellux, figlio dell’autore, e posta all’inizio del testo (cfr., F. J. deChastellux, De la félicité publique cit., pp. I-XX).
4.Ivi, p. 135
5.Ivi, p. 34.
6.Ivi, p. 37
7.Ivi, p. 40
8.Ivi, p. 41.
9. Ivi.
10. Ivi.
11. Ivi, p. 200.
12. “Or, toutes les fois que les projets d’agrandissement de la part du gouvernement obligeront les sujets à sacrifier une partie des jours de l’année, ou des heures dans la journée, don’t l’emploi est nécessaire à leur bonheur, on tombera dans un excès condamnable, dans un veritable abus. D’un autre cotè, si le peuple, abandonné à la mollesse, refuse à l’état la quantité de travail nécessaire au mantien de la sûreté publique, il s’exposera par ce mauvais calcul à devenir la proie du premier qui viendra l’attaquer; et c’est un malheur qu’il ne tardera pas à éprouver” (ivi, p. 65).
13. Ivi, p. 44.
14. Ivi, p. 56.
15. “… nous assurons que nous ne sommes ni enthousiastes, ni détracteurs de l’antiquité” (ivi, p. 97).
16. Ivi, p. 76.
17. Cfr., L. Guerci, Libertà degli antichi e libertà dei moderni cit., pp. 209-210.
18.F. J. deChastellux, De la félicité publique cit., p. 173.
19.L. Guerci, Libertà degli antichi e libertà dei moderni cit., p. 207.
20.F. J. deChastellux, De la félicité publique cit., p. 231.
21. Ivi, p. 242.
22. Ivi, pp. 282-283.
23. Ivi, p. 306.
24. Una visione simile è quella di Voltaire nel Saggio sui costumi.
25. Ivi, p. XXI.
26. Ivi. Le notes che Voltaire ha posto a margine del testo in suo possesso consistono per lo più in espressioni quali Bravo! o Vrai!
27.Voltaire, Saggio sui costumi e lo spirito delle nazioni, Edizioni per il club del libro, Novara 1966.
28. Ivi, p. 30.
29. Ivi, p. 32.
30. Ivi, p. 38.
31. A essi Voltaire dedica due capitoli del Saggio sui costumi, intitolati Dei selvaggi e Dell’America.
32. Ivi, pp. 41-42.
33. Ivi, p. 104.
34. Ivi, pp. 108-109.
35.B. Miglio, Progresso e félicité publique nell’opera di Chastellux, in “Rivista di filosofia”, n. 12, ottobre 1978, Giulio Einaudi editore, Torino, p. 398.
36. Bisogna considerare anche le imposte come un lavoro richiesto dal potere sovrano. Cfr., F. J. deChastellux, De la félicité publique cit., pp. 60-61.
37. Ivi, p. 61.
38. B. Miglio, Progresso e félicité publique nell’opera di Chastellux cit., p. 407.
39. Ivi.
40. Chastellux nomina esplicitamente “M. Rousseau”. Cfr., F. J. deChastellux, De la félicité publique cit., p. 101.
41.J. J. Rousseau, Il contratto sociale, traduzione di M. Garin, introduzione di T. Magri, testo francese a fronte, Editori Laterza, Bari 1997, p. 135.
42. Ivi, p. 137.
MARIO PAGANO

Vita e opere
Francesco Mario Pagano nacque a Brienza, nei pressi di Potenza, l’8 dicembre 1748 da una famiglia di avvocati. Dopo essere rimasto orfano di padre, nel 1762 si trasferisce a Napoli, per intraprendere gli studi umanistici; impara la filosofia sotto la guida dello zio prete Gerardo degli Angioli, grazie da cui viene introdotto alla conoscenza di Vico.
Nella grande città borbonica, poi, studia alla facoltà di giurisprudenza ed ha modo di conoscere Antonio Genovesi, di cui fu allievo, e Gaetano Filangieri, suo amico, con il quale condivide l’interesse per la criminologia. Si laurea appena ventenne e Genovesi, che vede in lui un erede, lo invita a partecipare ad un concorso per la cattedra di etica che Pagano perderà, però un anno dopo la otterrà in sostituzione del suo maestro morto improvvisamente. Nel 1769 è già considerato come un grande esperto di cultura classica ed è chiamato “avvocato filosofo” per le sue arringhe ricche di citazioni intellettuali. Successivamente ottiene la cattedra di economia e poi quella di giurisprudenza. Attratto dalla riflessione sul rinnovamento della legislazione penale divenne “avvocato dei poveri”, una sorta di avvocato d’ufficio per i delinquenti più bisognosi; attività per cui sarà sospettato di attività sovversive.
Nel 1785 pubblica i “Saggi politici”, con la sua concezione dello Stato e della sua organizzazione. Sempre nello stesso periodo la sua attività dedicata al diritto lo porta a scrivere opere come “Considerazioni sul processo criminale” (1787) o “ Logica dei probabili o teoria delle prove” che lo pongono sullo stesso piano dei grandi illuministi italiani Beccaria e Filangieri e rappresentano il rinnovamento del pensiero giuridico illuminista del Settecento. Si impegna per abolire la tortura: “la confessione, estorta tra i tormenti, è l’espressione del dolore, non già l’indizio della verità”.
Pubblica tre tragedie: “Gli esuli tebani” (1782), dedicata a Filangieri; “Agamennone” (1787), ambientata in Grecia; “Corradino” (1789) ambientato nel medioevo.
Nel 1792 nacque la “Società patriottica” a cui Pagano aderì; questa era una società di uomini illuminati, senza alcun fine rivoluzionario ma con la speranza di portare il sovrano all’interesse verso la cultura. Le autorità borboniche decisero in quegli anni una brusca svolta repressiva e nel 1794 tre giovani patrioti vengono processati per cospirazione antimonarchica e condannati a morte. La “Società” è sciolta ed inquisita e Pagano assumerà la sua difesa nel 1794 nella “Gran causa dei rei di Stato”. Si impegna a fondo per dimostrare l’infondatezza dell’accusa e il fine non eversivo dell’organizzazione; non riesce a salvare i tre giovani dal patibolo ma ne salva altri grazie alla sua abilità; tuttavia 48 persone saranno condannate all’ergastolo o all’esilio e dal ’94 al ’98 ci saranno ben tremila carcerazioni per altri nemici dei Borbone.
La sua bravura gli venne riconosciuta e fu nominato giudice del tribunale dell’Ammiragliato ma nel 1796 fa arrestare un avvocato corrotto che accusa Pagano di averlo fatto arrestare per la sua fedeltà al Re. Questo dà ai Borbone il pretesto per liberarsi di lui nonostante il suo prestigio; da tempo il sovrano aveva scatenato le sue spie contro il mondo della cultura napoletana. In febbraio dello stesso anno il filosofo viene arrestato e trattenuto per ben 29 mesi in carcere senza alcun processo; nel 1798, non essendosi trovate alcune prove contro di lui, viene liberato.
Dopo la scarcerazione si rifugiò a Roma, accolto con entusiasmo dalla Repubblica Romana che offrirà all’esule una cattedra di diritto pubblico con uno stipendio che gli consente a malapena di sopravvivere. Quando la Repubblica cade, Pagano va a Milano ma il 23 gennaio 1799 a Napoli viene abbattuta la monarchia e Pagano ritorna subito nella città e diviene membro del governo e presidente del Comitato di legislazione. Il filosofo è l’assoluto protagonista: da febbraio ad aprile fa approvare diverse leggi volte a rivoluzionare l’apparato del Regno di Napoli e dà alle stampe la Costituzione Repubblicana che tuttavia non entrerà mai in vigore a causa della breve durata della repubblica (cinque mesi). Il 5 giugno, infatti, il Governo provvisorio è costretto a richiamare alle armi la popolazione perché le armate reazionarie si stanno avvicinando, aiutate dagli inglesi. Anche Pagano combatte strenuamente per la difesa di San Martino ma purtroppo sarà costretto poco dopo a trattare la resa con gli inglesi del celebre Ammiraglio Nelson, l’artefice del crollo della Repubblica Partenopea. È una resa condizionata e la condizione, per Pagano, prevede la sua detenzione su una nave inglese in attesa di giudizio. I patti non saranno rispettati e Re Ferdinando IV si fa consegnare il filosofo da Nelson per rinchiuderlo a Castel Nuovo nel Maschio Angioino. Per fiaccarne le forze sarà messo dentro alla “fossa del coccodrillo”, la zona più buia e umida riservata ai criminali più pericolosi. In seguito sarà rinchiuso a Poggioreale assieme ad altri 119 rivoltosi. Il processo a cui viene sottoposto è già segnato: il giudice gli disse che non avrebbe preso atto della sua dichiarazione in quanto sia la Corte, sia il popolo volevano la sua morte. Pagano rispose che auspicava un futuro in cui il popolo avrebbe parlato attraverso di sé e non per i suoi rappresentanti così bugiardi e corrotti come il giudice del suo processo.
Il 29 ottobre 1799 un Pagano ormai distrutto anche fisicamente dalla dura prigionia viene impiccato in piazza Mercato assieme a Domenico Cirillo, Giorgio Pigliacelli ed Ignazio Ciaja. Per uno strano ricorso storico, l’illuminista sarà impiccato lo stesso giorno (29 ottobre 1268) e nello stesso punto in cui venne impiccato Corradino di Svevia, a cui Pagano aveva dedicato una tragedia.
· Saggi politici
I Saggi politici (1783-85) sono l’opera principale di Mario Pagano. Vogliono tracciare una filosofia della storia in ripresa della Scienza Nuova di Vico. A dispetto del titolo, non si tratta di un’opera formata da più saggi distaccati uno dall’altro ma di un libro strutturato organicamente in sette saggi.
Il primo di questi ci offre uno scenario in cui si dilata tutta la storia umana; in secondo, influenzato da Rousseau, tratta dello stato selvaggio; nel terzo si esaminano le società barbariche, primitive, costituite da principi elementari; nel quarto e quinto saggio l’autore ci indica il progresso delle società barbariche e di quelle evolute. Il sesto saggio ci mostra le società giunte al culmine del proprio sviluppo, che danno vita alle produzioni artistiche. Nella settima e ultima parte dei Saggi viene analizzata la teoria vichiana dei corsi e ricorsi storici: le società giunte ormai al culmine del proprio sviluppo e divenute, grazie all’arte e alla cultura, delle civiltà splendide potrebbero regredire alla barbarie.
Come prefazione al secondo volume apparve un saggio dedicato alle calamità naturali. Infatti, nello stesso periodo in cui stava lavorando al suo capolavoro, in Calabria era capitato un grave terremoto che sarebbe finito per sconvolgere i costumi e il modo di pensare dei cittadini colpiti. Pagano si basa su questo per spiegare come le catastrofi naturali possano provocare dei disastri morali e come in una società possa nascere la superstizione, sottolineando gli aspetti del fatalismo. Per questo saggio fu accusato di aver dato troppa importanza alla materialità e di istigare all’eliminazione di ogni principio di autorità; seppe ben difendersi, da abile avvocato, con un’apologia. Nel 1795 uscirà la seconda edizione dei Saggi, infarciti da Pagano da una totale condanna della monarchia.
Pagano intende la natura come forza e dinamismo; la natura è in continuo divenire nel mondo umano. Anche l’uomo tende a progredire ed alla sua evoluzione in nuove forme di vita, grazie al suo istinto. Il divenire storico della natura e dell’uomo, tuttavia, non è caotico ma si svolge secondo delle leggi e per questo in Pagano non c’è divisione tra natura e storia essendo entrambe sottoposte a leggi. Con queste tesi si mette in contrasto con il giusnaturalismo, che sostenne una natura statica, contro l’Illuminismo che vedeva una netta frattura tra natura e storia. Con Vico, invece, diverge sul modo di evoluzione della civiltà; secondo il filosofo della Scienza Nuova, le società progredivano grazie alla sapienza dei filosofi e non, come Pagano, per il divenire della natura nel mondo civile.
Il divenire storico non è un progresso continuo ma si passa faticosamente da uno stato ad un altro, si passa attraverso una rottura. Il divenire è soggetto a due forze contrapposte: una che porta alla disgregazione e l’altra che porta all’unione ed all’accentramento; inoltre queste due forze non si verificano secondo dei tempi prestabiliti perché il divenire è discontinuo. Senza una vera logica, si alternano momenti di grave dispersione e catastrofi a momenti in cui tutto sembra convergere verso un centro, momenti di unione.
L’uomo è un animale sociale teso alla perfettibilità. Gli uomini hanno molti più motivi di socialità rispetto a quelli elementari degli animali; a questi se ne aggiungono progressivamente altri, partendo da quelli naturali presenti anche negli animali, volti ad unire gli uomini tra loro. Una sempre maggiore socialità porta ad un superiore perfezionamento della società; l’uomo realizzando la propria essenza sociale si discosta dall’animalità.
Il regresso improvviso che si può verificare dopo la maturazione e lo sviluppo delle società, riporta i popoli non alla barbarie (come sosteneva Vico) ma alla schiavitù, alla sottomissione per mano di altri popoli a causa dell’evoluzione di una civiltà mondiale.
Le società “mature” devono basarsi sulla legge ed abolire il privilegio. Compito della legge è quello di tutelare la libertà civile contro l’insolenza. Bisogna impedire però che la legge, per impedire l’insolenza, non si trasformi in una società militarizzata che imponga la sua autorità con le armi e opprima il cittadino; ciò porterebbe ad un’uguale distruzione della libertà civile e la legge avrebbe fallito la sua funzione. La maniera migliore per tenere libera una società consiste nel far intervenire, tempestivamente e con rigore, la giustizia nel momento in cui la legge viene violata.
La pena per Pagano deve avere un forte carattere dissuasivo, deve essere un monito affinché nessuno ripeta più il gesto del condannato. La legge deve agire con fermezza contro l’insolenza, una volta che questa è insorta, ma deve lavorare in modo quasi invisibile poiché i cittadini non devono sentirsi oppressi da essa.
· La Costituzione Napoletana
Il 1° aprile 1799, Pagano diede alle stampe il progetto di Costituzione dopo aver lavorato nei due mesi precedenti a modificare le leggi borboniche. Ispirato da Filangieri e Campanella, Pagano aveva abolito i fedecommessi con i quali i patrimoni feudali passavano al primogenito senza che la proprietà possa essere divisa e diffusa in favore di tutta la società; abolì le servitù feudali, il testatico (una tassa demenziale imposta per il solo fatto di esistere attaccata da Campanella oltre due secoli prima); abolì la tortura e le carcerazioni segrete; abrogò tutte le tasse sugli alimenti popolari. Inoltre la sua riforma complessiva di tutto l’ordinamento giudiziario, previde che ogni cittadino fosse dotato di difesa legale anche non potendosi permettere un avvocato.
La Costituzione della Repubblica Partenopea doveva essere stesa da una commissione di cinque giuristi di cui fece parte anche il nostro Mario Pagano. Oggi sappiamo con certezza che il filosofo di Brienza la scrisse interamente da solo. Il progetto costituzionale anche se ispirato al modello francese ha una propria impronta; si può dire che fosse più napoletana che francese.
La prima parte è dedicata ai diritti e doveri. A differenza della “Carta dei diritti” francese non include i soli diritti dell’uomo ma anche quelli del popolo, del cittadino e dei magistrati. I diritti sono elencati come norme legislative e non come indicazioni di tipo filosofico e morale, come in Francia. La carta dei doveri è del tutto nuova: si ispira al pensiero napoletano del Settecento (Genovesi e Gravina) e non a Robespierre il quale si rifiutò di inserire anche i doveri nella propria costituzione, per paura che potesse essere restaurata una sorta di autorità; i doveri saranno inseriti in Francia solo nel 1795. Pagano, ispirato dalla concezione del Genovesi e non da quella francese del ’95, sostiene che l’uomo in quanto portatore di istanze morali, se deve essere libero, deve farsi portatore di doveri. I doveri nascono dal principio di uguaglianza; poiché tutti gli uomini sono uguali e simili tra di loro, ciascuno deve comportarsi nei confronti dell’altro come si comporterebbe verso di sé: deve avere lo stesso senso di solidarietà e gli stessi affetti che ha verso se stesso. Sono presenti il dovere del rispetto verso l’altro, di soccorrere gli altri e nutrire i bisognosi. L’articolo 20 ci sembra quasi precursore del pensiero mazziniano: “E’ obbligato ogni uomo d’illuminare e d’istruire gli altri”. L’articolo 26 ci mostra invece il dovere dei Funzionari, dunque chi detiene il governo dello Stato: “Ogni pubblico Funzionario deve consecrare sé, i suoi talenti, la sua fortuna, e la sua vita per la conservazione e per lo vantaggio della Repubblica”. Il cittadino deve, con le proprie opere, collaborare al mantenimento dell’ordine sociale. Per questo ha obbligo di prestare servizio militare.
Sono interessanti due diritti fondamentali: quello dell’uomo a migliorarsi (art 2) e quello del cittadino ad essere premiato in proporzione ai suoi meriti (art 11).
Infine si prevedono due istituzioni: la censura e l’eforato. La censura serve a prevenire gli attacchi alla democrazia e che i costumi sfarzosi non prevalgano sulla miseria e giungano ad offendere il cittadino. Gli efori invece devono vigilare sull’equilibrio ed il regolare funzionamento dei tre poteri fondamentali: legislativo, esecutivo e giudiziario; sono i garanti della Costituzione.
· Altri lavori
Come sappiamo, Pagano scrisse anche alcune tragedie. Queste hanno un fine pedagogico perché, secondo lui, il teatro non deve solo dilettare ma anche insegnare. Per arginare il pericolo dell’oscurantismo è necessario che la filosofia si mostri mascherata sul teatro per attirare l’attenzione del pubblico.
JOHANN MARTIN CHLADENIUS

Johann Martin Chladenius (1710-1759) è noto soprattutto come uno dei principali precorritori della moderna scienza storica. Il suo scritto di ermeneutica del 1742, Einleitung zur richtigen Auslegung vernünftiger Reden und Schriften, siconfigura come una vera e propria “ermeneutica profana” (hermeneutica profana). Gli interessi di Chladenius sono diretti ai “libri storici”, come egli stesso ama esprimersi. La sua formazione è imbevuta del razionalismo di Leibniz e di Wolff. Rivela inoltre una pèarticoare attenzione agli studi psicologici, che allora cominciavano ad affermarsi. In forza di questi interessi, egli elabora una teoria ermeneutica che tiene conto non soltanto della struttura logica delle opere da interpretare, ma pure delle componenti psichiche, soprattutto delle intenzioni e dei sentimenti degli autori di tali opere. Nell’epoca in cui scrive Chladenius, l’attività del “comprendere” (verstehen) è ancora intesa come una sorta di appendice della logica. Chladenius cerca di rivendicare la peculiarità del comprendere, e lo fa mettendo in luce l’esistenza di norme specifiche per il processo della comprensione. Per attuare quest’operazione, egli tenta una fondazione metafisica del comprendere, basata sulla monadologia di Leibniz. Nella sua ultima opera importante, intitolata Allgemeine Gescichtswissenschaft (Scienza della storia generale), egli argomenta nel modo che segue:
“Dal momento che ogni tipo di spirito finito deve possedere un suo specifico modo di rappresentarsi il mondo, è per noi necessario sapere in che modo gli uomini giungano alla conoscenza delle trasformazioni del mondo”.
Già nella citata Einleitung zur richtigen Auslegung vernünftiger Reden und Schriften Chladenius aveva osto l’accento sulla necessità di elaborare princìpi universali, validi per l’interpretazione di qualsiasi libro. Restava esclusa la Sacra Scrittura, poiché “misteriosa”, “superiore alla ragione” e dunque inafferrabile dai princìpi dell’interpretazione. Allo stesso modo, “in claris non fit interpretatio”: ossia, ci sono delle cose che – in quanto già di per sé chiare – non abbisognano di alcuna interpretazione. Il comprendere si applica alle cose non chiare ma chiaribili. Nelle sue linee generali, la teoria di Chladenius si articola in due sezioni: una concerne l’interpretazione di verità universali, l’altra ha a che fare con l’intepretazione di notizie storiche. Chladenius distingue attentamente tra il “comprendere” (verstehen) e l’“interpretare” (auslegen): “si comprende un discorso o un testo se si pensa tutto quello che le parole, secondo la ragione e le regole della nostra anima, possono suscitare in noi”; interpretare, invece, “non è altro che dare a qualcuno le nozioni necessarie per comprendere pienamente o imparare a comprendere un discorso o uno scritto”. Essendosi da sempre la logica occupata dell’universale, Chladenius ritiene opportuno indagare sulla conoscenza storica: ed è a questo proposito che egli formula la sua notissima teoria del “punto di vista” (Sehepunkt), centrata sulla metafisica leibniziana e, in particolare, sull’idea di “monade” che si autorappresenta l’universo. In questa teoria sono anche presenti influenze della psicologia allora nascente: il “punto di vista” viene infatti inteso come “lo stato interiore ed esteriore di uno spettatore in quanto capace di produrre un particolare modo d’intuire e considerare le cose che si presentano”. Alla determinazione del “punto di vista” contribuiscono vari aspetti: il posto dell’osservatore, i suoi sentimenti, il suo stato, ecc. Altrettanto importante è la teorizzazione, operata da Chladenius, del passaggio dalle res gestae alla historia rerum gestarum, ossia dalla “storia” alla sua “narrazione”. In questo modo, egli fissa le coordinate fondamentali lungo le quali si muoverà il successivo dibattito storiografico. Chladenius mette bene in luce il rischio relativistico insito nella teoria del “punto di vista”: per scongiurare il rischio di una caduta nel relativismo, egli distingue tra l’intendimento immediato (la comprensione stricto sensu) e l’intendimento mediato. Nel primo, autore e interprete sono destinati a incontrarsi e la mente dell’autore diventa la norma fondamentale. Nell’applicazione – l’intendimento mediato – il centro dell’attenzione slitta dall’autore al lettore, che a seconda del tipo di testo, delle particolari disposizioni della propria anima, ecc., sarà spinto a pensare “cose completamente diverse”, che tuttavia “secondo l’uso introdotto una volta, vengono comprese nell’intendimento del testo”. Queste soluzioni avranno grande incidenza sull’ermeneutica moderna.
GEORG FRIEDRICH MEIER

Georg Friedrich Meier (1718-1777) è passato alla storia soprattutto per il suo tentativo di costruire, tramite lo strumentario concettuale proprio dell’Illuminismo, una teoria generale dell’interpretazione. È a quest’obiettivo che egli consacra la sua Ricerca di un’arte generale dell’interpretazione (Versuch einer Allgemeinen Auslegungskunst). In questo scritto ambizioso, Meier si propone di presentare la teoria dell’interpretazione come una parte di una più ampia semiotica generale, vale a dire di una dottrina dei segni. In questa teoria, la nozione di “segno” indica per Meier un “mezzo tramite cui può venir conosciuta la realtà di un’altra cosa”. Egli segue la tradizionale suddivisione dei segni in “naturali”, “arbitrari” e “artificiali” e, in virtù di tale distinzione, distingue a sua volta nell’ars interpretandi tre parti: di queste, soltanto la terza parte – la hermeneutica significatu strictiori – è intesa come “la scienza delle regole che devono essere osservate qualora si voglia conoscere il senso sulla base del discorso, ed esporlo agli altri”. Anche il linguaggio è inteso da Meier come un insieme di segni, nella fattispecie di “segni artificiali”: per questo motivo, il linguaggio può essere decifrato sia in rapporto alla cosa che per mezzo di esso viene designata, sia in rapporto all’intenzione che lo ha posto in essere, vale a dire alla volontà dell’autore, il quale viene dunque ad assumere un rilievo decisivo (e Meier rivela in ciò l’influenza della “equità ermeneutica” già tematizzata da Wolff). Che cos’è, in concreto, l’equità ermeneutica? Lo si può capire solo se si tiene a mente che per Meier il significato di un segno diventa rilevante soltanto quando esprime una precisa volontà dell’autore. E Meier fonda questo principio sulla metafisica di Leibniz, sostenendo che: “in questo mondo, poiché esso è il migliore di quelli possibili, si realizza la massima e più universale connessione logica possibile. Perciò ogni porzione di realtà in questo mondo può essere un segno naturale immediato o mediato, lontano o vicino, di ogni altra porzione di realtà”. Quest’idea sarà ripresa dal Romanticismo sotto forma di “simbolica universale”. Meier la pone al servizio della conoscenza di Dio, giacché ogni segno naturale deve essere inteso come “prodotto dall’azione divina e quindi conseguenza della scelta più saggia e della migliore volontà”. L’interpreta sarà dunque chiamato a considerare veri quei significati che più concordano “con la perfezione dell’autore dei segni”. Occorrerà allora seguire attentamente una vera e propria “reverentia erga Deum hermeneutica”, che costituisce la forma più alta del principio di “equità ermeneutica”. Anche di fronte ad altri autori l’interprete deve considerare veri dal punto di vista ermeneutico i significati che più corrispondono alle perfezioni della conoscenza e della volontà dell’autore dei segni”. L’interprete dovrà allora sempre essere in grado di conoscere le “perfezioni” dell’autore dei segni, che Meier individua nel seguente modo: in primis, la fecondità della sua mente, in forza della quale “egli usa soltanto segni fecondi”; in secondo luogo, la grandezza dell’animo, la veridicità, la profondità, l’attitudine a usare segni gravidi di utilità pratica. Assai importante, e degno di essere sottolineato, è il problema del “pregiudizio” (Vorurteil), ampiamente sviluppato da Meier in sede ermeneutica. Con le sue riflessioni si sviluppa un modo differente di considerare il pregiudizio: soprattutto nei suoi Beyträge zu der Lehre von den Vorurtheilen des menschlichen Geschlechts (Contributi alla dottrina dei pregiudizi del genere umano). Egli inaugura, in questo modo, quella rielaborazione dei pregiudizi che Verità e metodo (1960) di Hans-Georg Gadamer porterà a compimento. Benché Meier riconosca il dovere da parte di ogni persona istruita di scoprire la verità mediante il Selbstdenken (letteralmente: “pensare da sé”, cioè “autonomia di pensiero”), tuttavia accetta l’inevitabilità di alcuni dei nostri pregiudizi, dato che non possiamo, in ogni preciso momento, sottoporre tutta la nostra conoscenza al tipo di critica richiesta proprio dal Selbstdenken. La riflessione meieriana sui pregiudizi assume toni antropologici e al proposito è rinvenibile un’intonazione da manifesto nel §2 dei Contributi nella parte in cui recita: “l’utilità della dottrina generale dei pregiudizi del genere umano consiste dunque in ciò: mediante essa si può far luce sulla conoscenza della natura umana in generale meglio di quanto non sia possibile fare in sua assenza”. Nell’articolare la sua sottile argomentazione, l’autore individua un punto di svolta nel §15 relativo al pregiudizio fondamentale della conoscenza empirica in base al quale “si suppone che le nostre sensazioni ci rappresentino la qualità e la quantità degli oggetti delle nostre sensazioni” di modo che “ognuno denomina gli oggetti sulla base della qualità delle sensazioni che ne ha”. Questa individuazione di un tale pregiudizio ha indubbiamente esercitato un’influenza decisiva sull’elaborazione della dottrina kantiana delle antinomie della ragione e dei fondamenti del criticismo in generale. Va senz’altro ascritto a merito di Meier l’aver posto in essere una vera e propria “riabilitazione del pregiudizio” ante litteram, cercando di eliminare ogni dualismo mediante l’impostazione di un concetto generale di pregiudizio che è parimenti riscontrabile nella conoscenza comune come in quella erudita e dichiarando apertamente nel §48: ”spero tuttavia di dimostrare a sufficienza che spesso è assai ragionevole risparmiarsi quella coscienziosità senza cui nessun pregiudizio potrebbe essere evitato, e lasciarsi quindi andare in qualche caso alla precipitazione, cadendo vittima del pregiudizio”.
JOHANN JACOB RAMBACH

Johann Jacob Rambach (1693-1735) è noto soprattutto per i suoi contributi allo sviluppo di una ermeneutica dei testi sacri, nel tentativo di mediare la lezione del pietismo con quella della teologia dogmatica luterana. L’opera più importante di Rambach è, in questo senso, la monumentale Institutiones hermeneuticae sacrae, (Istituzioni di ermeneutica sacra), del 1732, il cui obiettivo è palese fin dal titolo. In questo testo, che segna una vera e propria tappa decisiva nell’evoluzione della moderna ermeneutica, l’autore distingue attentamente tre diversi momenti della tecnica interpretativa: la investigatio, la explicatio e la adplicatio. Ad avviso di Rambach, la investigatio coincide con la ricerca del senso della Scrittura; la explicatio ha a che fare con l’esposizione e con la spiegazione ad altri del senso che si è compreso; la adplicatio riguarda invece la capacità di utilizzare in maniera edificante, al servizio di Dio e in vista della salvezza degli uomini, il risultato della comprensione. I primi due punti – explicatio ed explicatio – non sono, di per sé, novità. Innovativo è invece il terzo momento, quello della adplicatio, in quanto con esso emerge per la prima volta nella riflessione ermeneutica un problema che, pur presentissimo in ogni attività interpretativa, era sempre rimasto sullo sfondo, senza trovare un’adeguata concettualizzazione: il momento dell’applicazione del testo compreso e spiegato. Su questo problema l’ermeneutica del Novecento disputerò accanitamente. Rambach riprende un’idea già espressa da Hermann Francke (1663-1727): l’interpretazione della Scrittura è possibile solamente per chi è capace di rinascere in Cristo e, sulla base di ciò, postula l’esistenza di un significato mistico della Scrittura stessa, un significato che si situa al di là (e al di sopra) di quello grammaticale e letterale. In questo modo, resta sì vero che sono importantissimi, per la comprensione, i sussidi esterni, che provengono dalla considerazione degli elementi storici e geografici, oltre che dal contesto grammaticale, logico e retorico dei discorsi, dall’ordine e dalla cronologia dei diversi libri; come del resto rimane vero che il senso mistico di cui l’interprete è in cerca va pur sempre attinto dai testi e non deve essere il prodotto di elucubrazioni dell’interprete: ciò non di meno, Rambach parla espressamente dell’analogia fidei come di un sussidio primario, ossia non rinuncia alla supposizione di una comune ispirazione divina, presente in tutti gli autori dei sacri testi. Per quel che concerne la cosiddetta “teoria degli affetti”, Rambach condivide con Francke l’enfatizzazione del ruolo dell’amore cristiano, che gli permette di soffermarsi più che sui contenuti peculiari del messaggio, sui sentimenti che tramite quei contenuti trovano espressione e che trovano il modo di influenzare la vita del fedele tramite il momento della adplicatio. Per questa via, diventa evidente il ruolo assegnato da Rambach a questa parte dell’ermeneutica: l’interpretazione della Scrittura ha senso solamente in funzione della pratica, dell’edificazione dell’anima e della ricerca di salvezza. Tutto ciò che viene fatto in vista di altre finalità è votato all’insuccesso.
VOLNEY

Constantin François de Chassebœuf, cónte di Volney (Craon 1757 – Parigi 1820), fu un filosofo e letterato francese. Viaggiò in America nel 1795 e vi rimase quasi per tre anni. Imprigionato nel corso della Rivoluzione francese, verrà liberato il 9 termidoro. Dopo aver viaggiato in Egitto e in Siria, rimanendo particolarmente colpito da quelle terre, nel 1791 pubblicò un’opera, alla quale è ancora oggi legato il suo nome: Les Ruines, ou méditations sur les révolutions des empires (Le rovine, ovvero meditazioni sulle rivoluzioni degli imperi). L’opera si apre con una lunga meditazione nel silenzio delle tombe della città di Palmira: in particolare, Volney si domanda quale sia il senso di quelle rovine e, in definitiva, del declino di quella città. Perché – egli si domanda – città un tempo ricche e felici decadono e si trasformano in un cumulo di macerie? Sull’onda di questi interrogativi – su cui, per inciso, ritornerà Hegel nelle Lezioni sulla storia della filosofia, domandandosi quale sia il senso di quel “mattatoio” che è la storia –, egli si chiede se un giorno anche dove ora sorge Parigi non ci saranno soltanto rovine, testimonianze di una civiltà scomparsa, e un nuovo viaggiatore – come sta facendo lui con Palmira – ne piangerà la scomparsa. Il modello narrativo ricorda, in parte, quello utilizzato da Polibio (Storie 38, 22), che narra di Scipione che piangeva sulle rovine di Cartagine, nella convinzione che un giorno sarebbe toccata una sorte analoga anche a Roma. Come Scipione, anche Volney è in preda a una malinconia profonda nel constatare come le vicende dell’umanità non siano altro che un accumularsi di rovine su rovine, quasi come se nella storia regnasse una sorta di “cieca fatalità” che distrugge quanto di bello e di buono produce l’uomo. Proprio mentre nel suo libro Voney sta svolgendo queste considerazioni, ecco che si rizza inaspettatamente un “Genio”, il “Genio delle rovine”, che si propone di insegnare all’autore il significato profondo delle rovine. Sono gli uomini stessi – afferma il Genio – la fonte delle calamità umane, in quanto essi seguono ciecamente l’amore di sé, che di per sé è naturale ma che diventa funesto quando si accompagna all’ignoranza e alla cupidigia. Per questo motivo, le città – anche le più splendide – decadono immancabilmente, e il loro splendore si trasforma in un desolante cumulo di macerie. Ma se le cose stanno in questi termini e l’uomo è causa dei propri mali, allora – obietta Volney al Genio – la situazione è ancora più disperata del previsto, poiché non sembra esservi alcun rimedio possibile. A questo punto, il Genio ricorre alla nozione di “progresso” per confutare Volney: pur lasciando dietro di sé cumuli di macerie e di rovine, l’umanità avanza senza tregua e ciò risulta particolarmente evidente se si considera – dice il Genio – che ormai da parecchio tempo l’uomo non vive più nelle caverne, ma è entrato nella “civiltà”, ossia in uno stato progredito. Il corso generale della storia, se letto in trasparenza, rivela allora che la storia è sottoposta a un progresso incessante, irreversibile e “rettilineo”, che, pur tra improvvise e momentanee battute d’arresto, non impedisce mai del tutto l’avanzamento. Sotto le rovine, vi è un movimento sotterraneo, impercettibile, che fa “sporgere” ogni cosa in avanti, in un trascendimento incessante dei confini del presente. Anche quando tutto sembra fermo, la storia è in realtà in fase di avanzamento. Soprattutto con la più recente fase della storia, ossia con l’Illuminismo, la storia ha conosciuto – dice il Genio – un progresso accelerato, avanzando molto più rapidamente rispetto a quanto non fosse accaduto in passato. Questo avanzamento, attestato nel passato e oggi più che mai rapido e vorticoso, suffraga l’idea secondo cui la storia si configura come un processo in cui ogni cosa – dalla società alla politica, dall’economia all’arte – va incontro a un perfezionamento incessante. La storia è essa stessa sinonimo di progresso, secondo la grande convinzione illuministica. Certo, la strada da percorrere è ancora lunga e irta di difficoltà: tra queste, la più insidiosa è rappresentata dalle religioni, che pretendono di possedere monopolisticamente la verità. Ma nonostante queste difficoltà, la civiltà è in marcia verso il proprio costante perfezionamento, o – secondo la terminologia dell’epoca – verso il proprio “rischiaramento”. Le tenebre appartengono sempre più a un passato lontano, del tutto diverso da un futuro in cui ogni cosa si mostra alla luce della ragione. È questo il cuore dell’insegnamento del Genio. Se all’inizio della narrazione, Volney aveva abbracciato una concezione del tempo di tipo “circolare”, che si reggeva sulla “futuribilità” del passato e in cui la sorte rovinosa delle città passate era destinata ad abbattersi anche in futuro sulle città oggi splendenti, ora, grazie alla lezione impartitagli dal Genio, si è convinto che la Storia si configuri come una corsa unidirezionale, progressiva e irreversibile verso un perfezionamento complessivo: la verità sta nel futuro, secondo un tipico assunto illuministico. È particolarmente interessante il fatto che, nominato professore all’École normale, Volney tiene un ciclo di lezioni – le Leçons d’histoire – in cui insiste su questi temi.

