LA FILOSOFIA ANTICA
“Se gli uomini hanno filosofato per liberarsi dall’ignoranza, è evidente che ricercarono il conoscere solo al fine di sapere e non per conseguire qualche utilità pratica” (Aristotele, Metafisica)
I SETTE SAPIENTI
Dei cosiddetti “Sette Sapienti” – tra cui viene annoverato lo stesso Talete di Mileto – è possibile dire ben poco di storicamente fondato. Delle sentenze che vengono loro attribuite alcune sono certamente spurie e, come se non bastasse, è arduo stabilire con esattezza quali delle autentiche appartengano all’uno e quali all’altro. Ad ogni modo, i “Sette Sapienti” rappresentano il momento dell’affiorare in primo piano dell’interesse morale prima del sorgere della filosofia morale. Nel suo scritto intitolato Protagora (343 A), Platone fornisce questo elenco:
“Tra gli antichi vi furono Talete di Mileto, Pittaco di Mitilene, Biante di Priene, il nostro Solone, Cleobulo di Lindo, Misone di Chene e settimo tra costoro si annoverava Chilone di Sparta: tutti quanti furono ammiratori, appassionati amanti e discepoli dell’educazione spirituale spartana. E che la loro sapienza fosse di tale natura lo si può capire considerando quelle sentenze concise e memorabili, che furono pronunciate da ciascuno, e che, radunatisi insieme, essi offrirono come primizie di sapienza ad Apollo, nel tempio di Delfi, facendo scolpire quelle sentenze che tutti celebrano: Conosci te stesso (Gnoti sautòn) e Nulla di troppo (Medèn agàn). Ma a che scopo io dico questo? Perché il metodo di filosofare degli antichi consisteva appunto in una concisione spartana. E, in particolare, di Pittaco era famoso questo motto, molto lodato dai sapienti: Difficile è l’essere buoni (Calepòn esthlòn èmmenai)”.
Lo stesso Platone scrive significativamente nella sua opera Carmide (164 D):
“Infatti io dico che la temperanza è proprio questo: ‘conoscere se stessi’, d’accordo in tale definizione con l’autore dell’iscrizione votiva di Delfi; […] Infatti ‘Conosci te stesso’ e ‘Sii temperante’ sono la stessa cosa, come recita la scritta e come anch’io affermo, ma qualcuno potrebbe credere che abbiano un diverso significato, come mi sembra che sia capitato a quelli che, in seguito, consacrarono delle scritte del tipo ‘Niente di troppo’ e ‘Garanzia porta disgrazia’. Costoro, infatti, credettero che ‘Conosci te stesso’ fosse un consiglio pratico, non un saluto del dio a quanti entravano e così, per non essere da meno nel proporre suggerimenti, fecero porre queste iscrizioni”.
Sulle orme di Demetrio Falereo, Stobeo (Anthol., I, 172), anziché Misone, menziona Periandro, e ci dona la più ricca raccolta delle sentenze attribuite a questi sapienti. Dal momento che esse presentano il sunto della saggezza morale dei Greci prima del nascere della filosofia morale, è bene leggerle per intero.
Sentenze attribuite a Cleobulo
Cleobulo figlio di Evagora, di Lindo, disse:
1. La misura è la cosa migliore.
2. Si deve rispettare il proprio padre.
3. Bisogna stare bene nel corpo e nell’anima.
4. Bisogna essere desiderosi di ascoltare, e non chiacchieroni.
5. Avere molte e svariate conoscenze è come (o: è sempre meglio che) essere ignorante.
6. Mantenere la lingua pura da empietà.
7. Bisogna essere familiare della virtù, estraneo alla malvagità.
8. Odiare l’ingiustizia, custodire la pietà.
9. Consigliare le decisioni migliori ai concittadini.
10. Mantenere il controllo sul piacere.
11. Non fare nulla con la violenza.
12. Educare i figli.
13. Pregare la fortuna.
14. Risolvere le inimicizie.
15. Considerare un nemico di guerra il nemico del popolo.
16. Non litigare con la moglie e non manifestare troppo affetto verso di lei in presenza di estranei; infatti, il primo atteggiamento può comportare stoltezza, il secondo follia.
17. Non punire i servi sotto l’effetto del vino: altrimenti, sembrerai comportarti in modo sconveniente a causa dell’ubriachezza.
18. Sposarsi con una donna proveniente da una famiglia di pari condizioni: infatti, se ne sposerai una proveniente da una famiglia di condizioni superiori, acquisirai dei padroni, non dei parenti.
19. Non ridere alle battute di chi prende in giro la gente; risulterai antipatico, infatti, a coloro che vengono presi in giro.
20. Quando va bene, non essere superbo; quando va male, non avvilirsi.
Sentenze attribuite a Solone
Solone, figlio di Essecestide, ateniese, disse:
1. Nulla di troppo.
2. Non sedere come giudice, altrimenti risulterai nemico dell’accusato.
3. Fuggi il piacere che produce dolore.
4. Mantieni la virtù della condotta, più affidabile di un giuramento.
5. Poni il sigillo ai discorsi con il silenzio, e al silenzio con il momento opportuno.
6. Non mentire, bensì di’ la verità.
7. Curati delle cose oneste.
8. Non dire cose più giuste dei genitori.
9. Non acquisire amici in fretta, e quelli che hai eventualmente acquisito, non lasciarli in fretta.
10. Apprendendo a essere comandato, imparerai a comandare.
11. Se consideri giusto che gli altri rendano conto del loro operato, assoggéttati anche tu al rendiconto.
12. Consiglia ai concittadini non le cose più piacevoli, ma le migliori.
13. Non insuperbire.
14. Non metterti in compagnia di viziosi.
15. Mantieni relazioni con gli dèi.
16. Venera gli amici.
17. Non dire quello che non sai.
18. Se sai, sta’ zitto.
19. Sii mite con i tuoi.
20. Fornisci indizî evidenti per le cose invisibili.
Sentenze attribuite a Chilone
Chilone, figlio di Damageta, spartano, disse:
1. Conosci te stesso.
2. Mentre bevi, non fare molte chiacchiere: sbaglieresti.
3. Non minacciare le persone libere: non è giusto.
4. Non parlare male del tuo prossimo: altrimenti, sul tuo conto sentirai dire cose di cui dovrai addolorarti.
5. Récati lentamente ai banchetti degli amici; va’ invece incontro velocemente alle loro sventure.
6. Celebra nozze alla buona.
7. Dichiara beato solo chi è morto.
8. Onora chi è più anziano.
9. Odia chi si immischia in quello che non lo riguarda.
10. Scegli una perdita, piuttosto che un guadagno turpe: la prima, infatti, addolorerà una sola volta; l’altro, sempre.
11. Non ridere di chi è sfortunato.
12. Anche se sei impulsivo, cerca di comportarti in modo tranquillo, perché la gente di te abbia rispetto, piuttosto che paura.
13. Sovrintendi alla tua propria casa.
14. La tua lingua non corra avanti rispetto al pensiero.
15. Cerca di contenere l’ira.
16. Non desiderare cose impossibili.
17. Per strada, non affrettarti ad andare avanti.
18. E non gesticolare: denota follia.
19. Obbedisci alle leggi.
20. Se subisci un’ingiustizia, fa’ pace; se subisci un oltraggio, véndicati.
Sentenze attribuite a Talete:
Talete, figlio di Essamia, di Mileto, disse:
1. Dai garanzia, e appresso c’è sventura.
2. Ricòrdati degli amici, presenti e assenti.
3. Non adornare il tuo aspetto esteriore, ma sii bello negli atti.
4. Non arricchirti malamente.
5. Non ti comprometta il tuo discorso nei confronti di quanti ripongono in te la loro fiducia.
6. Non esitare ad adulare i genitori.
7. Non prendere dal padre quello che è vizioso.
8. Quali servigi tu abbia reso ai genitori, tali aspettati di ricevere a tua volta, in vecchiaia, dai figli.
9. È difficile conoscere se stesso.
10. Piacevole in massimo grado è ottenere quello che desideri.
11. La pigrizia è una sciagura.
12. L’intemperanza è una cosa dannosa.
13. Cosa molesta è l’ignoranza.
14. Cerca di imparare e di apprendere il meglio.
15. Non essere pigro, neppure se sei ricco.
16. I mali, nascondili in casa.
17. Fatti invidiare, piuttosto che commiserare.
18. Avvàliti della misura.
19. Non credere a tutti.
20. Incominciando, adorna te stesso.
Sentenze attribuite a Pittaco
Pittaco, figlio di Irra, di Lesbo, dice:
1. Riconosci il momento opportuno.
2. Non dire quello che hai intenzione di fare: se non avrai fortuna, sarai deriso.
3. Avvàliti di ciò che è conveniente.
4. Tutto quello che disapprovi nel tuo prossimo, non farlo tu stesso.
5. Non biasimare un indolente: su gente simile incombe già la vendetta degli dèi.
6. Rendi i depositi.
7. Sopporta, se sei danneggiato dal prossimo in piccola misura.
8. Non dire male dell’amico, e nemmeno bene del nemico: poiché un simile comportamento è illogico.
9. È tremendo conoscere il futuro, sicuro conoscere il passato.
10. La terra è una cosa affidabile, il mare è una cosa infida.
11. Insaziabile è il guadagno.
12. Impadronirsi delle cose proprie.
13. Coltiva la pietà, l’educazione, la temperanza, la saggezza, la verità, la fiducia, l’esperienza, la destrezza, l’amicizia, la sollecitudine, la gestione della casa, l’arte.
Sentenze attribuite a Biante
Biante, figlio di Teutamo, di Priene, disse:
1. La grande maggioranza degli uomini è cattiva.
2. Guardandoti allo specchio – disse –, se appari bello, devi fare cose belle; se appari brutto, devi correggere con la virtù le mancanze della natura.
3. Accìngiti con lentezza a fare qualcosa; ma, in quello che tu abbia incominciato, persévera con costanza.
4. Odia il parlare senza ponderazione, per non sbagliare; segue, infatti, il pentimento.
5. Non essere né sempliciotto, né di cattivi costumi.
6. Non accogliere la stoltezza.
7. Ama la saggezza.
8. Riguardo agli dèi, afferma che esistono.
9. Rifletti sul tuo operato.
10. Ascolta molto.
11. Cerca di parlare a proposito.
12. Se sei povero, non criticare i ricchi, a meno che tu non ne ricavi un grande giovamento.
13. Non elogiare per la sua ricchezza un uomo indegno.
14. Cerca di ottenere in forza della persuasione e non della violenza.
15. Tutto ciò che tu faccia di bello, attribuiscilo agli dèi, non a te stesso.
16. Nella giovinezza, acquisire prosperità; nella vecchiaia, invece, sapienza.
17. Avrai memoria grazie all’esercizio, circospezione grazie al riconoscimento di quanto è opportuno, nobiltà grazie ai modi, temperanza grazie alla fatica, pietà grazie al timore, amicizia grazie alla ricchezza, persuasione grazie al ragionamento, decoro grazie al silenzio, giustizia grazie all’assennatezza, valore grazie al coraggio, potenza grazie all’azione, supremazia grazie alla fama.
Sentenze attribuite a Periandro
Periandro, figlio di Cipselo, di Corinto, disse:
1. Abbi cura di tutto.
2. La tranquillità è una cosa bella.
3. La temerarietà è una cosa pericolosa.
4. Il guadagno è una cosa turpe.
5. * un’accusa della natura.
6. La democrazia è una cosa migliore della tirannide.
7. I piaceri sono mortali; la virtù, immortale.
8. Quando hai fortuna, sii moderato; quando invece hai sfortuna, sii saggio.
9. È meglio morire rispettato, piuttosto che rimanere vivo trovandosi nel bisogno.
10. Renditi degno dei genitori.
11. Cerca di essere lodato da vivo e considerato beato una volta morto.
12. Compòrtati allo stesso modo con gli amici fortunati e sfortunati.
13. Ciò su cui tu sia risultato d’accordo, osservalo; è cosa malvagia, infatti, il trasgredire.
14. Non rivelare discorsi segreti.
15. Rimprovera in maniera tale da risultare ben presto un amico.
16. Quanto alle leggi, attiéniti a quelle antiche; quanto ai cibi, invece, consuma quelli freschi.
17. Non limitarti a castigare quelli che hanno commesso una colpa, ma cerca anche di impedire quelli che stanno per commetterne una.
18. Se sei sfortunato, cerca di nasconderlo, per non fare rallegrare i nemici.
Come siamo venuti dicendo in precedenza, queste sentenze sono fondamentali per adombrare i caratteri e i limiti della “riflessione morale” nel suo stadio – se così si può dire – prefilosofico. Esse sono il prodotto di una lunga e travagliata esperienza, ma sono slegate le une rispetto alle altre, non sono sorrette da un “principio” unificatore, non sono motivate con argomentazioni, e quindi non sono giustificate; stanno quindi al di qua della filosofia, la cui essenza sta – in ultima istanza – nel “rendere ragione” (logon didonai) di ogni cosa, senza lasciare alcunché di immotivato. Il fatto che Talete di Mileto sia annoverato fra i “Sette Sapienti” è, sotto questo profilo, particolarmente interessante. Egli ha fondato la filosofia come indagine fisica e cosmologica (ravvisando nell’acqua l’arché dell’intera realtà), ma non la “filosofia morale”. Del resto, non solo Talete, ma tutti i filosofi “presocratici” come moralisti non andarono oltre il piano della “sentenza” intuitivamente colta: e ciò è dovuto al fatto che essi indagarono il “principio del cosmo”, ma non la “natura dell’uomo in quanto uomo”. Perché potesse sorgere la “filosofia morale” occorreva che l’uomo come tale diventasse oggetto di riflessione della filosofia. Era cioè necessario che venissero determinati l’essenza e il significato dell’uomo in quanto uomo. Cosa che, evidentemente, non accadde con i “Sette Sapienti”. Era altresì necessario che dall’essenza dell’uomo in quanto tale si ricavasse il concetto di “virtù” (areté). A ciò si addivenne tramite un percorso che, avviato dai Sofisti (i primi a spostare il baricentro dell’indagine filosofico dal cosmo all’uomo, dal cielo alla terra), giunse a compimento con Socrate.
TALETE
 I primi passi della filosofia sono stati compiuti nelle colonie della Ionia, sulle vivaci coste dell’Asia Minore (l’attuale Turchia), come Mileto ed Efeso. Se le città del continente, lontane dal contatto con altre popolazioni, rimasero chiuse e vincolate all’orizzonte cosmico e religioso tradizionale, le città coloniali lambite dal mare sono invece caratterizzate da un maggior dinamismo anche sul piano intellettuale. Il fatto stesso che fossero terre di confine (e quindi a contatto con credenze e costumi diversi) contribui a fare di queste aree zone in cui era molto sentito il problema della propria identità e della posizione del mondo. Un modo per risolvere questo problema può essere rintracciato nella ricerca di ciò che rende il mondo, al di là della varietà delle sue manifestazioni, una totalità unitaria. Aristotele (Metafisica, I) ci presenta proiettato in questa ricerca il presocratico Talete, il primo filosofo che la storia ricordi. Leggiamo dunque la sua preziosa testimonianza:
I primi passi della filosofia sono stati compiuti nelle colonie della Ionia, sulle vivaci coste dell’Asia Minore (l’attuale Turchia), come Mileto ed Efeso. Se le città del continente, lontane dal contatto con altre popolazioni, rimasero chiuse e vincolate all’orizzonte cosmico e religioso tradizionale, le città coloniali lambite dal mare sono invece caratterizzate da un maggior dinamismo anche sul piano intellettuale. Il fatto stesso che fossero terre di confine (e quindi a contatto con credenze e costumi diversi) contribui a fare di queste aree zone in cui era molto sentito il problema della propria identità e della posizione del mondo. Un modo per risolvere questo problema può essere rintracciato nella ricerca di ciò che rende il mondo, al di là della varietà delle sue manifestazioni, una totalità unitaria. Aristotele (Metafisica, I) ci presenta proiettato in questa ricerca il presocratico Talete, il primo filosofo che la storia ricordi. Leggiamo dunque la sua preziosa testimonianza:
“La maggior parte di coloro che primi filosofarono pensarono che principi di tutte le cose fossero solo quelli materiali. Infatti essi affermano che ciò di cui tutti gli esseri sono costituiti e ciò da cui derivano originariamente e in cui si risolvono da ultimo, è elemento ed è principio degli esseri, in quanto è una realtà che permane identica pur nel trasmutarsi delle sue affezioni. E, per questa ragione, essi credono che nulla si generi e che nulla si distrugga, dal momento che una tale realtà si conserva sempre. E come non diciamo che Socrate si genera in senso assoluto quando diviene bello o musico, né diciamo che perisce quando perde questi modi di essere, per il fatto che il sostrato – ossia Socrate stesso – continua ad esistere, cosí dobbiamo dire che non si corrompe, in senso assoluto, nessuna delle altre cose: infatti deve esserci qualche realtà naturale (o una sola o piú di una) dalla quale derivano tutte le altre cose, mentre essa continua ad esistere immutata. Tuttavia, questi filosofi non sono tutti d’accordo circa il numero e la specie di un tale principio. Talete, iniziatore di questo tipo di filosofia, dice che quel principio è l’acqua (per questo afferma anche che la Terra galleggia sull’acqua), desumendo indubbiamente questa sua convinzione dalla constatazione che il nutrimento di tutte le cose è umido, e che perfino il caldo si genera dall’umido e vive nell’umido. Ora, ciò da cui tutte le cose si generano è, appunto, il principio di tutto. Egli desunse dunque questa convinzione da questo fatto e dal fatto che i semi di tutte le cose hanno una natura umida e l’acqua è il principio della natura delle cose umide”. (Aristotele, Metafisica 983 b)
Egli nacque e visse a Mileto tra il settimo ed il sesto secolo a.C. e probabilmente non scrisse alcuna opera. La figura di Talete sfumò ben presto nella leggenda: su di lui vi sono parecchie testimonianze. Platone, per esempio, afferma che Talete era stato abilissimo nell’escogitare espedienti tecnici, mentre lo storico Erodoto ci racconta che Talete progettò e realizzò un canale per deviare un fiume dal suo corso e farlo rientrare più avanti nel suo alveo. Sempre Erodoto gli attribuisce la predizione di un’eclissi solare, più precisamente quella del 585 a.C., ed una grande abilità come consigliere politico. Altri autori (di epoche successive) fanno risalire a Talete la dimostrazione di alcuni teoremi di geometria, ma pare difficile che siano effettivamente suoi: tra questi ricordiamo la proposizione che il cerchio è dimezzato dal diametro, che è dimostrabile tramite la sovrapposizione delle due metà. Anche per quel che riguarda l’eclissi solare, è davvero difficile che Talete l’abbia intuita tramite complessi calcoli matematici, che all’epoca non erano in grado di effettuare neppure gli astronomi babilonesi. Pare che Talete, durante la sua permanenza egiziana, riuscì pure a misurare l’altezza delle piramidi tramite le loro ombre. Nel Teeteto, Platone racconta che Talete, per contemplare le meraviglie del cielo, cadde in un pozzo e una donna lo derise per il fatto che voleva guardare il cielo lui che non vedeva neppure cosa c’era per terra. Aristotele nella Politica narra che Talete, grazie alle sue conoscenze astronomiche e metereologiche, previde un abbondante raccolto di olive, fece incetta dei frantoi e in questa situazione di monopolio ricavò ingenti guadagni. Stando a quel che Aristotele sostiene, in veste di storico della filosofia, nel primo libro della Metafisica, Talete è il capostipite della ricerca delle cause (αιτιαι) e del principio (αρχη) da cui sarebbe scaturita l’intera realtà nelle sue manifestazioni. Per lui tutto, in ultima istanza, è costituito da acqua. Non sappiamo esattamente che cosa Talete intendesse con questa affermazione, ma possiamo immaginarlo. Probabilmente aveva in mente, per esempio, il ghiaccio, il vapore, l’umidità… Insomma, egli non poteva non notare l’assoluta centralità dell’acqua nella vita. Egli osservò poi che il cibo degli esseri viventi è in buona parte costituito da acqua, così come i semi degli esseri viventi sono umidi. E’ anche possibile ipotizzare perchè Talete scelse proprio l’acqua come principio: intanto, come abbiamo appena detto, essa si trova praticamente ovunque, ma poi ha delle caratteristiche che la rendono ideale come principio esplicativo della realtà: è incolore, inodore, insapore… In altre parole l’acqua non ha caratteristiche e quindi può assumerle tutte. Per individuare un principio generalmente si scelgono cose che abbiano il minor numero possibile di caratteristiche: l’acqua per Talete, l’aria per Anassimene. Talete affermò che la Terra galleggiasse sull’acqua: secondo la concezione dell’epoca vi era un immenso Oceano, una Terra tonda e delle acque interne: su quest’ Oceano infinito galleggiava, secondo le credenze dell’epoca, la Terra. In Talete riscontriamo un forte influsso orientale: l’idea che la Terra galleggiasse sull’Oceano era presente in diversi miti dell’Oriente. Per di più, come detto, sappiamo che lui stesso soggiornò in Egitto e probabilmente li ebbe modo di assimilare questi miti. Però Talete non si accontenta di accettare la tradizione mitologica, ma da buon filosofo argomenta le sue tesi. Per lui l’acqua è sia sostanza (ciò che sta sotto, in Greco υποκειμενον) sia essenza (ciò che effettivamente è, in Greco ουσια): sotto il mutamento continuo (ghiaccio, vapore, umidità…) la sostanza rimane sempre la stessa: è sempre acqua. Con Talete cominciano a farsi sentire i primi cenni di astrazione, ma è ancora molto legato al mondo concreto: è infatti interessante notare che la parola υποκειμενον (la sostanza, ciò che sta sotto) avrà sì voluto significare in senso astratto che l’acqua nel corso dei suoi mutamenti rimane sempre acqua, ma era pregna di significati concreti: concretamente, infatti, la terra, secondo Talete, galleggiava sull’acqua e di conseguenza l’acqua sta sotto alla terra (il termine υποκειμενον viene preso alla lettera). A noi risulta strana questa mistura di concreto e astratto, ma all’epoca doveva essere normalissima. Però verrebbe da chiedere a Talete: se la terra galleggia sull’acqua, l’acqua su cosa galleggia? senz’altro Talete avrebbe risposto che essa è il principio e perciò non vi è risposta. Nella Metafisica Aristotele, ad un certo punto, dice – a riguardo dell’identificazione dell’acqua come principio – che forse Talete si è formato questa opinione vedendo che il nutrimento di tutte le cose è umido e che perfino il caldo deriva dall’umido e vive di esso: pare interessante, oltre al termine “forse” che denota un’ipotesi personale di Aristotele, il fatto che si parli di principio di “tutte le cose”. Si può avanzare un’obiezione: l’acqua non è il principio di tutte le cose, ma solo degli esseri viventi. Va subito precisato che concetti che per noi sono distinti, ai tempi di Talete non lo erano: non avevano distinzione tra mondo vivente e mondo non vivente: noi l’abbiamo perchè siamo avvantaggiati da strumenti tecnici. In mancanza di strumenti scientifici, la prima cosa che viene spontaneo fare per capire quali esseri sono viventi è osservare il movimento, la capacità di muoversi (Platone stesso definirà la vita come qualcosa che si muove da sè). Se cogliamo nel movimento la distinzione tra vivo e non vivo (che è la distinzione più ovvia che ci sia), di conseguenza dovremmo attribuire a tutto il mondo, sebbene non nella stessa misura, la vita. Spieghiamo il perchè servendoci di un esempio: anche una penna, se lanciata, si muove. Dunque l’atteggiamento di Talete era di attribuire vita alla materia: si parla a tal proposito di “ilozoismo” (dal greco υλη, materia + ζωα, animali). In realtà si tende ad evitare questa parola perchè suggerisce che partendo dall’idea di materia inerte Talete e gli altri materialisti le abbiano attribuito la capacità di movimento e quindi la vita: per Talete, invece, la materia si è sempre mossa. Una testimonianza ci dice che Talete, che fu il primo ad occuparsi di elettricità, affermò che il magnete fosse vivo perchè in grado di far muovere le cose (infatti attrae il ferro) e che avesse un’anima. Viene da chiedersi perchè Talete parli proprio del magnete e non in generale della materia. La risposta è che questi filosofi presocratici, per dimostrare, partivano da situazioni chiare per tutti (come il fatto che il magnete sposti il ferro) per poi estenderle all’intera realtà. Voleva dimostrare che la vita non c’è solo negli esseri viventi, e per farlo si serve dell’esempio più chiaro e comprensibile per tutti. Egli si serve della generalizzazione dell’esperienza: osserva attentamente la realtà e ciò che ha osservato in determinati casi particolari lo estende. Per Talete, così come l’animale fiuta il cibo e si avvicina, così il magnete sente il ferro e si avvicina. Talete affermò pure che “tutto è pieno di dei”: sembra un’affermazione religiosa, il che per un filosofo sarebbe strano. In realtà risulta evidente che il principio è la trascrizione in termine filosofico della divinità, in quanto principio è ciò da cui tutto deriva: dire che tutto è pieno di dei è lo stesso che dire che tutto è pieno di acqua. Come accennavamo, Talete, oltrechè filosofo, fu anche grande matematico: calcolò l’altezza delle piramidi sfruttando l’ombra da esse proiettata ed elaborò il celebre teorema che porta il suo nome. Il teorema di Talete dice che un fascio di rette parallele determina su due trasversali insiemi di segmenti proporzionali. Talete muove dalla convinzione che l’αρχη, ovvero il principio da cui tutto deriva, sia l’acqua e come poc’anzi notavamo dalla convinzione secondo cui l’acqua sarebbe alla base di ogni realtà, fa addirittura conseguire la tesi – che a noi non può strappare un sorriso – secondo cui la Terra stessa galleggerebbe sull’acqua e si troverebbe pertanto in un equilibrio precario. Aristotele, con la curiosità filosofica che lo contraddistingue, prova anche a domandarsi come possa essere la concezione propria di Talete dell’acqua come causa materiale: pur in assenza di certezze (il che è testimoniato dal “forse” che Aristotele premette alla propria constatazione), non si può escludere che Talete sia addivenuto alle sue note conclusioni partendo dall’osservazione che l’umido sta alla base di ogni cosa – perfino del caldo – e che i semi stessi, da cui nasce la vita, sono anch’essi umidi. Da ciò ben si evince come Talete si basasse, nel proprio procedere filosofico, soprattutto sull’osservazione diretta dei fenomeni. Aristotele sembra anche suggerire, in certa misura, che Talete, nella formulazione delle proprie tesi, tenesse conto di quella tradizione mitica – cantata nei poemi di Omero e di Esiodo – in cui Oceano e Teti non erano che i progenitori del mondo: in questo senso, Talete avrebbe sostenuto la stessa tesi dei poeti, ma da essi si sarebbe differenziato per aver dismesso la veste teologica e mitica e per aver indossato quella ipercritica della filosofia. Fare di Talete un razionalista nell’accezione moderna – affermatasi da Cartesio in poi – sarebbe però sbagliato, anche perché su di lui influiscono concezioni animistiche che lo inducono a ritenere vivo il magnete – perché capace di muoversi in presenza del ferro – o ad affermare enigmaticamente che “tutto è pieno di dei” (frase facilmente convertibile in: “tutto è pieno d’acqua”). Anche se Aristotele trascura questo aspetto, noi possiamo tentare di spiegare l’importanza da Talete concordata all’acqua facendo riferimento alla particolare zona in cui egli è vissuto: Mileto era una città marinara, in cui l’acqua era di fondamentale importanza per i traffici e, dunque, per la sopravvivenza dei suoi cittadini. Una domanda destinata a restare senza risposta è se Talete abbia avuto discepoli e, in tal caso, se Anassimandro di Mileto rientrasse nella sua cerchia. Pare assai improbabile (anche se non escludibile) che ciò sia possibile, anche perché nel VII secolo a.C. non abbiamo testimonianze sull’esistenza del rapporto di discepolato; ciò non toglie, tuttavia, che Anassimandro abbia potuto frequentare Talete e prestare ascolto ai suoi insegnamenti.
ANASSIMANDRO
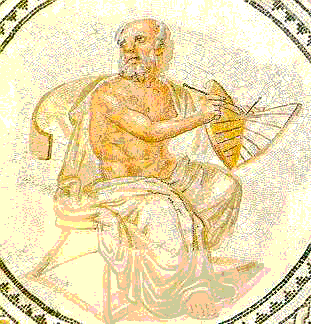 Nel contesto dei presocratici e dei Milesi si colloca insieme a Talete anche Anassimandro, che nacque a Mileto nel 610 circa a.c. e mori intorno alla metà del sesto secolo: la tradizione vuole Anassimandro discepolo di Talete; dato che a quei tempi non c’erano le scuole, si doveva trattare di un vero e proprio rapporto di disdcepolato personale. Senz’altro Anassimandro ha preso qualcosa da Talete: egli infatti si cimenta nella ricerca di un solo principio e per di più che ha a che fare con l’acqua (sebbene non sia proprio acqua pura). Anassimandro scrisse un’opera in prosa (Sulla natura, Περι φύσεως): la poesia cessa di essere l’unico veicolo o, comunque, il veicolo per eccellenza per trasmettere le conoscenze sull’universo e sugli uomini. Ciò non toglie, tuttavia, che lo stile prosastico da lui impiegato non concedesse ampi margini ad un linguaggio immaginifico e poetico, volto ad accattivarsi l’attenzione dei lettori. Di tutta la sua opera, però, possediamo un solo frammento, peraltro difficile da contestualizzare. Se ci basassimo solo su questo frammento, Anassimandro ci sembrerebbe interessato solamente di cosmogonia. Però tramite varie testimonianze ci è possibile comprendere che in realtà Anassimandro si interessava di parecchie cose e la sua opera doveva spaziare nei campi più vasti. A quei tempi il suo libro sarebbe senz’altro stato catalogato come di “storia” (dove la parola storia assume un significato differente da quello che comunemente le attribuiamo: tale parola è infatti riconducibile alla radice ειδ-, a sua volta riconducibile al verbo greco opoo, vedere), ossia di descrizione del mondo: l’opera iniziava con una cosmogonia (da cui è tratto il frammento che ci è pervenuto) in cui Anassimandro cercava di dare una spiegazione all’origine dell’universo e poi proseguiva con una cosmologia, dove egli spiegava la struttura dell’universo. La sua opera non si limitava alla cosmologia e alla cosmogonia (che però senz’altro dovevano essere le parti più filosofiche), ma toccava anche altri argomenti. Ad Anassimandro viene tra l’altro attribuita la prima cartina geografica del mondo allora conosciuto e l’invenzione dell’orologio solare: in tal modo spazio e tempo diventano entità descrivibili e misurabili; l’universo e il tempo in cui si scandisce la sua vicenda possono uscire dalla dispersione e essere ricompresi in una prospettiva unitaria. Oltre alle questioni di ordine stilistico, la grande innovazione apportata da Anassimandro risiede nell’ aver individuato l’αρχη non già in un qualcosa di materiale ed empiricamente constatabile (al pari dell’acqua di Talete), bensi una realtà soprasensibile, forse in base al ragionamento che 1’αρχη non può essere una sola delle entită visibili, ma piuttosto un qualcosa da cui tutte scaturiscano. Per questa via, Anassimandro passa dal visibile all’invisibile. Tale αρχη invisibile è da lui ravvisato nell’ απειρον, ovvero – letteralmente – in “cio che non ha limiti” (α + περας). Questo “illimitato” trova una sua collocazione fisica alla periferia di un universo sferico al cui centro è posizionata la Terra, dotata di forma cilindrica ed equidistante dalla periferia (essa è dunque in perfetto equilibrio nella sua immobilità, senza bisogno di alcun sostegno, nemmeno dell’acqua supposta da Talete). Dall’ απειρον si generano in primis le “qualità contrarie” (caldo freddo, secco/umido, ecc), ossia gli elementi, giacchè alla natura di ciascun elemento corrisponde una data qualità (cosi al fuoco corrisponde il caldo, all’acqua il freddo, ecc). In questo senso, allora, 1’απειρον manca, oltre che di limiti, anche di qualità: proprio da questo sostrato aqualitativo nascono i quattro elementi costituenti la realtà. Non è un caso che, nell’universo, ogni cosa sia dotata di limiti precisi: dalla realtà illimitata (απειρον) nascono tutte le cose e ciascuna di esse diventa col nascere il limite di tutte le altre (tant’è che nel definirla non facciamo che distinguerla dalle altre. In realtà la parola απειρον è intraducibile a causa della sua polisemia e e si preferisce non tradurla: in essa ci sono infatti troppi sottintesi e significati per cui scegliendone uno (che può benissimo essere corretto) se ne tagliano automaticamente fuori altri altrettanto corretti. I due significati principali della parola sono “infinito” ‘e “indefinito”, il primo con valenza quantitativa, il secondo con valenza qualitativa. Per Anassimandro, però, entrambe i significati erano allo stesso modo contenuti nel termine apeiron. Ora dobbiamo meglio spiegare perchè Anassimandro abbia scelto come principio proprio l’apeiron: il principio è quel qualcosa da cui deriva tutta la realtà, quel qualcosa dove tutta la realtà va a finire e quel qualcosa in cui tutta la realtà permane. Se il principio è quindi ciò da cui deriva tutto il resto, Anassimandro deve aver pensato che esso deve essere una fonte inesauribile di tutto, senza fine. Già Talete a suo modo aveva effettuato un ragionamento del genere: l’acqua era per lui il principio di tutto perchè non aveva caratteristiche e poteva di conseguenza assumerle tutte. L’introduzione dell’apeiron rappresenta un grandissimo passo verso l’astrazione: esso ancora più dell’acqua non ha caratteristiche, però per Anassimandro l’apeiron non è solo infinito, ma anche indeterminato (indefinito): egli è convinto che il principio non debba avere alcuna caratteristica e quale è la cosa che ha meno caratteristiche dell’infinito? Anassimandro quindi si distacca da Talete: l’acqua non è più il principio, ma è parte integrante dell’apeiron Riportiamo ora il celebre frammento di Anassimandro: “principio delle cose che sono è l’illimitato… donde le cose che sono hanno la generazione, e là hanno anche il dissolvimento secondo la necessità. Infatti esse pagano l’una all’altra la pena e l’espiazione dell’ingiustizia secondo l’ordine del tempo”. Mentre per Talete era implicito che la materia fosse dotata di movimento, per Anassimandro è esplicito: in realtà a parlarci di Anassimandro e a riportare il suo frammento è un filosofo minore di nome Simplicio: è difficile tradurre e capire che cosa egli intendesse dire. Sembra quasi volerci dire che Anassimandro sia stato il primo ad introdurre il fattore movimento, ma probabilmente Simplicio voleva soltanto dire che Anassimandro è stato il primo ad usare la parola “arke” in senso filosofico, con la valenza di principio. In quell’unico frammento di Anassimandro conservatosi fino a noi il limite è descritto in termini di υβρις, ossia di violenza e di prevaricazione delle cose fra loro, una sorta di ingiustizia di cui le cose pagano il fio con la distruzione (al che provvede il processo del nascere e del perire): sulla scia di Talete, Anassimandro fa leva sul senso comune, spiegando l’ingiustizia cosmica attraverso le ingiustizie che patiamo quotidianamente. Anassimandro ha poi aperto prospettive molto moderne: il concetto di infinito per esempio ricorre spesso anche nella nostra società. Anassimandro arrivò a dire che il nostro universo è un qualcosa di infinito: a noi pare ovvio, ma si è per lungo tempo pensato che fosse finito: questa concezione di finitezza dell’universo si era radicato ai tempi dei Pitagorici, che avevano attribuito al termine “infinito” una connotazione fortemente negativa e confusionaria. Anassimandro diceva che il mondo era nato e che prima o poi sarebbe morto: Aristotele invece diceva che il mondo esistesse da sempre e che sarebbe sempre esistito. Per Anassimandro il nostro mondo non è il solo nell’universo: per lui l’intera realtà universale è cosparsa di mondi come il nostro. Egli concepiva l’universo come un oceano di apeiron con sparsi qua e là infiniti mondi come il nostro. Questi mondi erano per lui realtà definite e tra l’uno e l’altro c’era l’apeiron. Ma che cosa è che da vita ai vari mondi, che fa si che si stacchino dall’apeiron primordiale? Per Anassimandro è il movimento che consente la separazione dei mondi dall’apeiron. Probabilmente mentre effettuava questi ragionamenti aveva in mente i mulinelli dell’acqua: se sulla superficie ci sono corpi galleggianti (pagliuzze, rametti…) a causa della densità si separano gli uni dagli altri. Cosi anche nell’apeiron ci potevano essere vortici in grado di separare i vari contrari. Infatti l’apeiron è tale proprio perché tutto è mescolato e finisce per essere indistinto: infatti caldo-freddo, secco-umido etc. se mescolati sono indefiniti. E’ il movimento che riesce a separarli. Ma non è un movimento qualunque: quello dell’apeiron infatti è un movimento capace di generare e di separare. Infatti di per sè nell’apeiron i contrari non esistono ancora: vengono successivamente generati dai vortici. Questa è la cosmogonia anassimandrea: esaminiamo ora la cosmologia, vale a dire l’assetto del mondo. Anassimandro non ci parla ancora di caldo e di freddo in modo astratto, ma li identifica nell’acqua e nel fuoco, ossia in sostanze concretamente esistenti. Egli ci fa notare che il rapporto tra i contrari è conflittuale: per lui al centro del mondo c’è l’acqua fredda, in periferia il fuoco caldo: essi tendono a scontrarsi costantemente. Il fuoco fa evaporare l’acqua marina con una duplice conseguenza: la formazione di sale e di vapore acqueo. Il sale sta a rappresentare la terra, il vapore acqueo l’aria. Va senz’altro notato che Anassimandro era particolarmente attento e sensibile alle questioni di evaporazione perchè a Mileto vi erano grandi paludi e doveva quindi essere un fenomeno molto diffuso. Quindi per lui al centro c’era l’acqua, in periferia il fuoco ed in una periferia ancora più periferica una corona in cui aria e fuoco si mescolavano. La luna ed il sole non sono nient’altro che “buchi” in cui è possibile scorgere questa corona di periferia. Senz’altro per la sua cosmologia Anassimandro deve aver preso spunto dal funzionamento della pentola a pressione. Il fuoco attacca l’acqua causandone l’evaporazione, ma essa si “vendica” attaccando la corona periferica e smantellandola. Questa sua strana idea del fuoco che agisce a discapito dell’acqua deve essergli derivata dal fatto che egli scorgeva spesso fossili marini a chilometri di distanza dal mare o addirittura sui colli: significava quindi che vi era un’evaporazione costante e che il fuoco “rosicchiava” sempre più terreno all’acqua facendola evaporare. Oltre a notare l’interesse di Anassimandro per gli aspetti comuni , gli va senz’altro riconosciuto il merito di aver capito che cosa fossero i fossili (cosa che non aveva invece capito Aristotele). Quindi per lui il nostro mondo sarebbe finito quando il fuoco sarebbe riuscito a far evaporare tutta l’acqua (che, come aveva notato Talete, è davvero fondamentale per la vita). Per Anassimandro un contrario non può della vita vivere da solo, quindi la scomparsa dell’acqua decreterebbe anche quella del fuoco e del mondo intero. Il mondo, una volta finito, sarebbe ritornato nell’apeiron e li ne sarebbe poi nato uno nuovo. Sempre a riguardo della cosmologia anassimandrea, va ricordato che egli non pensava che la terra fosse rotonda nè che fosse in movimento: la immaginava come il tamburo di una colonna. Per lui la terra sarebbe ferma semplicemente per il fatto che non avrebbe nessun motivo di muoversi: è al centro di tutto e quindi perchè mai dovrebbe spostarsi? Torniamo ora al frammento a noi giunto: l’espressione “secondo l’ordine del tempo” non si è sicuri che sia effettivamente anassimandrea. E’ chiaro che quando dice “da dove hanno origine, hanno fine” allude all’apeiron: il mondo, una volta finito torna, nell’apeiron. Poi egli parla di “ingiustizia”: essa consiste sia nel distacco dall’apeiron del mondo (che può essere visto come una sorta di peccato originale) sia (soprattutto) nel conflitto che oppone un contrario all’altro. A riguardo dell’idea del peccato originale dobbiamo riallacciarci alla religione orfica, che vedeva la nascita dell’uomo come una colpa originaria: la vita sulla terra è sia l’effetto della colpa sia la punizione. Anassimandro estende questa concezione all’intero mondo: il distaccamento dall’apeiron è un peccato: i contrari stessi, opponendosi, commettono una sorta di peccato nei confronti dell’apeiron. E’ interessante l’espressione “secondo necessita”: dà l’idea che le cose avvengano secondo un ordine preciso e non casualmente. Comincia a subentrare un primo e rudimentale concetto di “legge naturale” con il “secondo necessita”. Si può riscontrare nella visione del mondo di Anassimandro un forte pessimismo legato alla tradizione orfica Anassimandro nel suo scritto, oltre a dedicarsi alla cosmologia e alla cosmogonia, si dedica anche alla biologia e alle prime forme di vita: egli cosi ci dice una testimonianza di Aezio sostiene che i primi viventi furono generati dall’umido (va senz’altro notato come Anassimandro sia influenzato da Talete e alle sue dottrine che vedevano l’acqua protagonista della realtà), avvolti in membrane spinose e che col passare del tempo approdarono all’asciutto e, spezzatasi la membrana, mutarono in fretta il genere di vita. Per lui dalla terra e dall’acqua riscaldate nacquero o dei pesci o comunque degli animali molto simili ai pesci; in questi concrebbero gli uomini ed i feti vi rimasero rinchiusi fino alla pubertà. Quando questi si spezzarono, allora finalmente ne uscirono uomini e donne che potevano già nutrirsi. Sembra quasi che in un certo senso anche per Anassimandro il vero principio sia l’acqua.
Nel contesto dei presocratici e dei Milesi si colloca insieme a Talete anche Anassimandro, che nacque a Mileto nel 610 circa a.c. e mori intorno alla metà del sesto secolo: la tradizione vuole Anassimandro discepolo di Talete; dato che a quei tempi non c’erano le scuole, si doveva trattare di un vero e proprio rapporto di disdcepolato personale. Senz’altro Anassimandro ha preso qualcosa da Talete: egli infatti si cimenta nella ricerca di un solo principio e per di più che ha a che fare con l’acqua (sebbene non sia proprio acqua pura). Anassimandro scrisse un’opera in prosa (Sulla natura, Περι φύσεως): la poesia cessa di essere l’unico veicolo o, comunque, il veicolo per eccellenza per trasmettere le conoscenze sull’universo e sugli uomini. Ciò non toglie, tuttavia, che lo stile prosastico da lui impiegato non concedesse ampi margini ad un linguaggio immaginifico e poetico, volto ad accattivarsi l’attenzione dei lettori. Di tutta la sua opera, però, possediamo un solo frammento, peraltro difficile da contestualizzare. Se ci basassimo solo su questo frammento, Anassimandro ci sembrerebbe interessato solamente di cosmogonia. Però tramite varie testimonianze ci è possibile comprendere che in realtà Anassimandro si interessava di parecchie cose e la sua opera doveva spaziare nei campi più vasti. A quei tempi il suo libro sarebbe senz’altro stato catalogato come di “storia” (dove la parola storia assume un significato differente da quello che comunemente le attribuiamo: tale parola è infatti riconducibile alla radice ειδ-, a sua volta riconducibile al verbo greco opoo, vedere), ossia di descrizione del mondo: l’opera iniziava con una cosmogonia (da cui è tratto il frammento che ci è pervenuto) in cui Anassimandro cercava di dare una spiegazione all’origine dell’universo e poi proseguiva con una cosmologia, dove egli spiegava la struttura dell’universo. La sua opera non si limitava alla cosmologia e alla cosmogonia (che però senz’altro dovevano essere le parti più filosofiche), ma toccava anche altri argomenti. Ad Anassimandro viene tra l’altro attribuita la prima cartina geografica del mondo allora conosciuto e l’invenzione dell’orologio solare: in tal modo spazio e tempo diventano entità descrivibili e misurabili; l’universo e il tempo in cui si scandisce la sua vicenda possono uscire dalla dispersione e essere ricompresi in una prospettiva unitaria. Oltre alle questioni di ordine stilistico, la grande innovazione apportata da Anassimandro risiede nell’ aver individuato l’αρχη non già in un qualcosa di materiale ed empiricamente constatabile (al pari dell’acqua di Talete), bensi una realtà soprasensibile, forse in base al ragionamento che 1’αρχη non può essere una sola delle entită visibili, ma piuttosto un qualcosa da cui tutte scaturiscano. Per questa via, Anassimandro passa dal visibile all’invisibile. Tale αρχη invisibile è da lui ravvisato nell’ απειρον, ovvero – letteralmente – in “cio che non ha limiti” (α + περας). Questo “illimitato” trova una sua collocazione fisica alla periferia di un universo sferico al cui centro è posizionata la Terra, dotata di forma cilindrica ed equidistante dalla periferia (essa è dunque in perfetto equilibrio nella sua immobilità, senza bisogno di alcun sostegno, nemmeno dell’acqua supposta da Talete). Dall’ απειρον si generano in primis le “qualità contrarie” (caldo freddo, secco/umido, ecc), ossia gli elementi, giacchè alla natura di ciascun elemento corrisponde una data qualità (cosi al fuoco corrisponde il caldo, all’acqua il freddo, ecc). In questo senso, allora, 1’απειρον manca, oltre che di limiti, anche di qualità: proprio da questo sostrato aqualitativo nascono i quattro elementi costituenti la realtà. Non è un caso che, nell’universo, ogni cosa sia dotata di limiti precisi: dalla realtà illimitata (απειρον) nascono tutte le cose e ciascuna di esse diventa col nascere il limite di tutte le altre (tant’è che nel definirla non facciamo che distinguerla dalle altre. In realtà la parola απειρον è intraducibile a causa della sua polisemia e e si preferisce non tradurla: in essa ci sono infatti troppi sottintesi e significati per cui scegliendone uno (che può benissimo essere corretto) se ne tagliano automaticamente fuori altri altrettanto corretti. I due significati principali della parola sono “infinito” ‘e “indefinito”, il primo con valenza quantitativa, il secondo con valenza qualitativa. Per Anassimandro, però, entrambe i significati erano allo stesso modo contenuti nel termine apeiron. Ora dobbiamo meglio spiegare perchè Anassimandro abbia scelto come principio proprio l’apeiron: il principio è quel qualcosa da cui deriva tutta la realtà, quel qualcosa dove tutta la realtà va a finire e quel qualcosa in cui tutta la realtà permane. Se il principio è quindi ciò da cui deriva tutto il resto, Anassimandro deve aver pensato che esso deve essere una fonte inesauribile di tutto, senza fine. Già Talete a suo modo aveva effettuato un ragionamento del genere: l’acqua era per lui il principio di tutto perchè non aveva caratteristiche e poteva di conseguenza assumerle tutte. L’introduzione dell’apeiron rappresenta un grandissimo passo verso l’astrazione: esso ancora più dell’acqua non ha caratteristiche, però per Anassimandro l’apeiron non è solo infinito, ma anche indeterminato (indefinito): egli è convinto che il principio non debba avere alcuna caratteristica e quale è la cosa che ha meno caratteristiche dell’infinito? Anassimandro quindi si distacca da Talete: l’acqua non è più il principio, ma è parte integrante dell’apeiron Riportiamo ora il celebre frammento di Anassimandro: “principio delle cose che sono è l’illimitato… donde le cose che sono hanno la generazione, e là hanno anche il dissolvimento secondo la necessità. Infatti esse pagano l’una all’altra la pena e l’espiazione dell’ingiustizia secondo l’ordine del tempo”. Mentre per Talete era implicito che la materia fosse dotata di movimento, per Anassimandro è esplicito: in realtà a parlarci di Anassimandro e a riportare il suo frammento è un filosofo minore di nome Simplicio: è difficile tradurre e capire che cosa egli intendesse dire. Sembra quasi volerci dire che Anassimandro sia stato il primo ad introdurre il fattore movimento, ma probabilmente Simplicio voleva soltanto dire che Anassimandro è stato il primo ad usare la parola “arke” in senso filosofico, con la valenza di principio. In quell’unico frammento di Anassimandro conservatosi fino a noi il limite è descritto in termini di υβρις, ossia di violenza e di prevaricazione delle cose fra loro, una sorta di ingiustizia di cui le cose pagano il fio con la distruzione (al che provvede il processo del nascere e del perire): sulla scia di Talete, Anassimandro fa leva sul senso comune, spiegando l’ingiustizia cosmica attraverso le ingiustizie che patiamo quotidianamente. Anassimandro ha poi aperto prospettive molto moderne: il concetto di infinito per esempio ricorre spesso anche nella nostra società. Anassimandro arrivò a dire che il nostro universo è un qualcosa di infinito: a noi pare ovvio, ma si è per lungo tempo pensato che fosse finito: questa concezione di finitezza dell’universo si era radicato ai tempi dei Pitagorici, che avevano attribuito al termine “infinito” una connotazione fortemente negativa e confusionaria. Anassimandro diceva che il mondo era nato e che prima o poi sarebbe morto: Aristotele invece diceva che il mondo esistesse da sempre e che sarebbe sempre esistito. Per Anassimandro il nostro mondo non è il solo nell’universo: per lui l’intera realtà universale è cosparsa di mondi come il nostro. Egli concepiva l’universo come un oceano di apeiron con sparsi qua e là infiniti mondi come il nostro. Questi mondi erano per lui realtà definite e tra l’uno e l’altro c’era l’apeiron. Ma che cosa è che da vita ai vari mondi, che fa si che si stacchino dall’apeiron primordiale? Per Anassimandro è il movimento che consente la separazione dei mondi dall’apeiron. Probabilmente mentre effettuava questi ragionamenti aveva in mente i mulinelli dell’acqua: se sulla superficie ci sono corpi galleggianti (pagliuzze, rametti…) a causa della densità si separano gli uni dagli altri. Cosi anche nell’apeiron ci potevano essere vortici in grado di separare i vari contrari. Infatti l’apeiron è tale proprio perché tutto è mescolato e finisce per essere indistinto: infatti caldo-freddo, secco-umido etc. se mescolati sono indefiniti. E’ il movimento che riesce a separarli. Ma non è un movimento qualunque: quello dell’apeiron infatti è un movimento capace di generare e di separare. Infatti di per sè nell’apeiron i contrari non esistono ancora: vengono successivamente generati dai vortici. Questa è la cosmogonia anassimandrea: esaminiamo ora la cosmologia, vale a dire l’assetto del mondo. Anassimandro non ci parla ancora di caldo e di freddo in modo astratto, ma li identifica nell’acqua e nel fuoco, ossia in sostanze concretamente esistenti. Egli ci fa notare che il rapporto tra i contrari è conflittuale: per lui al centro del mondo c’è l’acqua fredda, in periferia il fuoco caldo: essi tendono a scontrarsi costantemente. Il fuoco fa evaporare l’acqua marina con una duplice conseguenza: la formazione di sale e di vapore acqueo. Il sale sta a rappresentare la terra, il vapore acqueo l’aria. Va senz’altro notato che Anassimandro era particolarmente attento e sensibile alle questioni di evaporazione perchè a Mileto vi erano grandi paludi e doveva quindi essere un fenomeno molto diffuso. Quindi per lui al centro c’era l’acqua, in periferia il fuoco ed in una periferia ancora più periferica una corona in cui aria e fuoco si mescolavano. La luna ed il sole non sono nient’altro che “buchi” in cui è possibile scorgere questa corona di periferia. Senz’altro per la sua cosmologia Anassimandro deve aver preso spunto dal funzionamento della pentola a pressione. Il fuoco attacca l’acqua causandone l’evaporazione, ma essa si “vendica” attaccando la corona periferica e smantellandola. Questa sua strana idea del fuoco che agisce a discapito dell’acqua deve essergli derivata dal fatto che egli scorgeva spesso fossili marini a chilometri di distanza dal mare o addirittura sui colli: significava quindi che vi era un’evaporazione costante e che il fuoco “rosicchiava” sempre più terreno all’acqua facendola evaporare. Oltre a notare l’interesse di Anassimandro per gli aspetti comuni , gli va senz’altro riconosciuto il merito di aver capito che cosa fossero i fossili (cosa che non aveva invece capito Aristotele). Quindi per lui il nostro mondo sarebbe finito quando il fuoco sarebbe riuscito a far evaporare tutta l’acqua (che, come aveva notato Talete, è davvero fondamentale per la vita). Per Anassimandro un contrario non può della vita vivere da solo, quindi la scomparsa dell’acqua decreterebbe anche quella del fuoco e del mondo intero. Il mondo, una volta finito, sarebbe ritornato nell’apeiron e li ne sarebbe poi nato uno nuovo. Sempre a riguardo della cosmologia anassimandrea, va ricordato che egli non pensava che la terra fosse rotonda nè che fosse in movimento: la immaginava come il tamburo di una colonna. Per lui la terra sarebbe ferma semplicemente per il fatto che non avrebbe nessun motivo di muoversi: è al centro di tutto e quindi perchè mai dovrebbe spostarsi? Torniamo ora al frammento a noi giunto: l’espressione “secondo l’ordine del tempo” non si è sicuri che sia effettivamente anassimandrea. E’ chiaro che quando dice “da dove hanno origine, hanno fine” allude all’apeiron: il mondo, una volta finito torna, nell’apeiron. Poi egli parla di “ingiustizia”: essa consiste sia nel distacco dall’apeiron del mondo (che può essere visto come una sorta di peccato originale) sia (soprattutto) nel conflitto che oppone un contrario all’altro. A riguardo dell’idea del peccato originale dobbiamo riallacciarci alla religione orfica, che vedeva la nascita dell’uomo come una colpa originaria: la vita sulla terra è sia l’effetto della colpa sia la punizione. Anassimandro estende questa concezione all’intero mondo: il distaccamento dall’apeiron è un peccato: i contrari stessi, opponendosi, commettono una sorta di peccato nei confronti dell’apeiron. E’ interessante l’espressione “secondo necessita”: dà l’idea che le cose avvengano secondo un ordine preciso e non casualmente. Comincia a subentrare un primo e rudimentale concetto di “legge naturale” con il “secondo necessita”. Si può riscontrare nella visione del mondo di Anassimandro un forte pessimismo legato alla tradizione orfica Anassimandro nel suo scritto, oltre a dedicarsi alla cosmologia e alla cosmogonia, si dedica anche alla biologia e alle prime forme di vita: egli cosi ci dice una testimonianza di Aezio sostiene che i primi viventi furono generati dall’umido (va senz’altro notato come Anassimandro sia influenzato da Talete e alle sue dottrine che vedevano l’acqua protagonista della realtà), avvolti in membrane spinose e che col passare del tempo approdarono all’asciutto e, spezzatasi la membrana, mutarono in fretta il genere di vita. Per lui dalla terra e dall’acqua riscaldate nacquero o dei pesci o comunque degli animali molto simili ai pesci; in questi concrebbero gli uomini ed i feti vi rimasero rinchiusi fino alla pubertà. Quando questi si spezzarono, allora finalmente ne uscirono uomini e donne che potevano già nutrirsi. Sembra quasi che in un certo senso anche per Anassimandro il vero principio sia l’acqua.
ANASSIMENE
 Generalmente Anassimene viene collocato, insieme a Talete e ad Anassimandro, nel contesto dei “milesi”, vale a dire i filosofi della città di Mileto, nella Ionia Minore: egli visse poco dopo il VI secolo a.C. Con Anassimene, la filosofia in terra di Ionia compie un passo indietro: anch’egli autore di un’opera in prosa intitolata Sulla natura (Περι φυσεως), abbandona l’indagine “astratta” intrapresa da Anassimandro e torna alla ricerca di un unico principio materiale, che egli individua non già nell’acqua, bensi nell’aria. Quanto anche la sua sia una filosofia del senso comune lo si può facilmente arguire dall’importanza rivestita dall’aria per la nostra vita, in particolare per la respirazione: secondo Anassimene, l’aria opera a livello cosmico come a livello umano, cosicché essa dá origine e tiene in vita tanto gli uomini quanto l’universo nel suo insieme. Per spiegare il processo di derivazione degli elementi (terra, acqua, fuoco) dall’aria, egli fa riferimento a due processi contrari: la rarefazione e la condensazione. L’acqua riscaldata, infatti, si trasforma in aria, e così via. In questa maniera, le trasformazioni del mondo vengono spiegate come trasformazioni dell’aria, giacchè tutte le cose costituenti l’universo non sono che aria in un diverso grado di densità. Come i suoi due colleghi, anche Anassimene individua un unico principio dal quale sarebbe derivato tutto il resto. Mentre Talete scelse l’acqua e Anassimandro l’apeiron, Anassimene afferma che tutto deriva dall’aria. Si possono avanzare ipotesi sul motivo di questa scelta: in fondo l’aria si identifica un po’ con quel cielo che era la sede degli dei e quindi non pare una scelta insensata. Di per certo sappiamo che Anassimene affermò che l’aria è il principio di tutto in quanto è principio della vita: bisogna tenere in considerazione che il termine greco che indica la vita (l’anima) è ψυχη, che in origine significava proprio “soffio vitale”. Comunque Anassimene viene solitamente trattato a piccoli cenni ed è sempre stato considerato inferiore rispetto agli altri due milesi: Talete fu l’iniziatore della ricerca del principio, Anassimandro fece un grande passo avanti introducendo il concetto di astrazione e Anassimene, se ponderiamo accuratamente la situazione, ha fatto un passo indietro e non ha introdotto nulla di nuovo: è rimasto legato ad un elemento concreto quale è l’aria. Tuttavia ultimamente è stato rivalutato per diverse ragioni: tra le tante, una merita di essere ricordata: in epoche successive a quelle dei Milesi, Diogene di Apollonia penserà di riprendere la filosofia milesia e tra i tre autori scelse proprio di esaminare Anassimene, da cui mutuò l’aria come principio cosmico. Ci deve dunque essere un motivo se un uomo colto come Diogene scelse proprio Anassimene. La risposta è che evidentemente Anassimene dei tre era il più coerente e classico per i successori. Anassimene non si limitò a dire che l’aria era il principio di tutto, ma si sforzò e cercò di spiegare il processo (a differenza di Talete): per lui il processo tramite il quale l’aria si trasforma in tutte le altre cose è quello della rarefazione e della condensazione. Come Talete aveva dimostrato la presenza della vita negli esseri non viventi mediante l’esempio del magnete che attira il ferro e che quindi è vivo, cosi Anassimene parti da un esempio particolare per poi estendere le sue tesi all’intera realtà. Egli si servi dell’esempio della respirazione. Noto che a seconda dell’apertura della bocca l’aria usciva diversamente: a bocca larga usciva calda, mentre a bocca stretta usciva fredda. Cosi estese il processo all’intera realtà sostenendo che freddo e caldo fossero il risultato di un fatto quantitativo. L’aria a seconda che sia più condensata o rarefatta implica il freddo e il caldo. Il caldo e il freddo sono quindi il risultato di processi quantitativi: sono quindi qualità derivanti da una quantità diversa d’aria. Al di là di un certo livello di condensazione si ha l’acqua, e al di là di un certo livello di rarefazione si ha il fuoco. L’aria attraverso passaggi quantitativi può quindi trasformarsi in tutto. Era il più coerente dei Milesi perché Talete non spiegava chiaramente come l’acqua potesse trasformarsi in tutto, mentre Anassimandro nell’ambito delle ricerche naturali dei milesi era uscito un po’ fuori tema introducendo il concetto di apeiron; Anassimene sarà anche stato un po’ monotono (non solo nelle tematiche, ma pure nello stile), ma è comunque stato coerente e ha sempre motivato coerentemente le sue affermazioni. Va poi detto che fu il primo ad ipotizzare che la qualità derivasse dalla quantità, tematica poi ripresa dai Pitagorici.
Generalmente Anassimene viene collocato, insieme a Talete e ad Anassimandro, nel contesto dei “milesi”, vale a dire i filosofi della città di Mileto, nella Ionia Minore: egli visse poco dopo il VI secolo a.C. Con Anassimene, la filosofia in terra di Ionia compie un passo indietro: anch’egli autore di un’opera in prosa intitolata Sulla natura (Περι φυσεως), abbandona l’indagine “astratta” intrapresa da Anassimandro e torna alla ricerca di un unico principio materiale, che egli individua non già nell’acqua, bensi nell’aria. Quanto anche la sua sia una filosofia del senso comune lo si può facilmente arguire dall’importanza rivestita dall’aria per la nostra vita, in particolare per la respirazione: secondo Anassimene, l’aria opera a livello cosmico come a livello umano, cosicché essa dá origine e tiene in vita tanto gli uomini quanto l’universo nel suo insieme. Per spiegare il processo di derivazione degli elementi (terra, acqua, fuoco) dall’aria, egli fa riferimento a due processi contrari: la rarefazione e la condensazione. L’acqua riscaldata, infatti, si trasforma in aria, e così via. In questa maniera, le trasformazioni del mondo vengono spiegate come trasformazioni dell’aria, giacchè tutte le cose costituenti l’universo non sono che aria in un diverso grado di densità. Come i suoi due colleghi, anche Anassimene individua un unico principio dal quale sarebbe derivato tutto il resto. Mentre Talete scelse l’acqua e Anassimandro l’apeiron, Anassimene afferma che tutto deriva dall’aria. Si possono avanzare ipotesi sul motivo di questa scelta: in fondo l’aria si identifica un po’ con quel cielo che era la sede degli dei e quindi non pare una scelta insensata. Di per certo sappiamo che Anassimene affermò che l’aria è il principio di tutto in quanto è principio della vita: bisogna tenere in considerazione che il termine greco che indica la vita (l’anima) è ψυχη, che in origine significava proprio “soffio vitale”. Comunque Anassimene viene solitamente trattato a piccoli cenni ed è sempre stato considerato inferiore rispetto agli altri due milesi: Talete fu l’iniziatore della ricerca del principio, Anassimandro fece un grande passo avanti introducendo il concetto di astrazione e Anassimene, se ponderiamo accuratamente la situazione, ha fatto un passo indietro e non ha introdotto nulla di nuovo: è rimasto legato ad un elemento concreto quale è l’aria. Tuttavia ultimamente è stato rivalutato per diverse ragioni: tra le tante, una merita di essere ricordata: in epoche successive a quelle dei Milesi, Diogene di Apollonia penserà di riprendere la filosofia milesia e tra i tre autori scelse proprio di esaminare Anassimene, da cui mutuò l’aria come principio cosmico. Ci deve dunque essere un motivo se un uomo colto come Diogene scelse proprio Anassimene. La risposta è che evidentemente Anassimene dei tre era il più coerente e classico per i successori. Anassimene non si limitò a dire che l’aria era il principio di tutto, ma si sforzò e cercò di spiegare il processo (a differenza di Talete): per lui il processo tramite il quale l’aria si trasforma in tutte le altre cose è quello della rarefazione e della condensazione. Come Talete aveva dimostrato la presenza della vita negli esseri non viventi mediante l’esempio del magnete che attira il ferro e che quindi è vivo, cosi Anassimene parti da un esempio particolare per poi estendere le sue tesi all’intera realtà. Egli si servi dell’esempio della respirazione. Noto che a seconda dell’apertura della bocca l’aria usciva diversamente: a bocca larga usciva calda, mentre a bocca stretta usciva fredda. Cosi estese il processo all’intera realtà sostenendo che freddo e caldo fossero il risultato di un fatto quantitativo. L’aria a seconda che sia più condensata o rarefatta implica il freddo e il caldo. Il caldo e il freddo sono quindi il risultato di processi quantitativi: sono quindi qualità derivanti da una quantità diversa d’aria. Al di là di un certo livello di condensazione si ha l’acqua, e al di là di un certo livello di rarefazione si ha il fuoco. L’aria attraverso passaggi quantitativi può quindi trasformarsi in tutto. Era il più coerente dei Milesi perché Talete non spiegava chiaramente come l’acqua potesse trasformarsi in tutto, mentre Anassimandro nell’ambito delle ricerche naturali dei milesi era uscito un po’ fuori tema introducendo il concetto di apeiron; Anassimene sarà anche stato un po’ monotono (non solo nelle tematiche, ma pure nello stile), ma è comunque stato coerente e ha sempre motivato coerentemente le sue affermazioni. Va poi detto che fu il primo ad ipotizzare che la qualità derivasse dalla quantità, tematica poi ripresa dai Pitagorici.
ERACLITO
 Eraclito, vissuto ad Efeso tra il VI e il V secolo a.C., è di famiglia aristocratica (addirittura discendente da famiglia regale) e lo stile stesso in cui scrive risente di questa influenza aristocratica (nella sua opera arriverà a dire: “uno è per me diecimila, se è il migliore”). Nel suo libro Περι φυσεως (Sulla natura) traspare palesemente un atteggiamento di disprezzo per la massa popolare (definita come un branco di “cani” che gli abbaiano contro). Va subito precisato, però, che l’aristocraticismo di Eraclito non è molto legato alla vita politica, quanto piuttosto a quella intellettuale e culturale. Secondo la tradizione, Eraclito avrebbe depositato il suo libro (di cui ci sono pervenuti parecchi frammenti) nel tempio di Artemide ad Efeso: egli compie questo gesto senz’altro per il fatto che il tempio era il luogo più sicuro per la custodia (all’epoca le biblioteche non c’erano), ma anche perchè era tipicamente aristocratico riallacciarsi al sapere della casta sacerdotale ed arcaica. Eraclito ritiene dunque che il tempio sia l’unico luogo idoneo a custodire il suo scritto: egli infatti nutre grande sfiducia nella possibilità che il messaggio da lui consegnato allo scritto possa essere compreso dalla maggior parte degli uomini. Ciò dipende dai contenuti di esso, lontani dalle esperienze della vita comune, ma anche dal linguaggio e dalla forma nei quali questi contenuti sono espressi. In effetti ancora oggi non si è riusciti a comprendere la natura dell’opera di Eraclito, sebbene possediamo numerosi frammenti (oltre 100): essa era e singole. Il fatto che fosse un libro “aforistico” non significa che fossero idee campate in aria o che Eraclito saltasse di palo in frasca, cambiando in continuo argomenti: ogni frase, infatti costituita di aforismi, vale a dire paginette autonome ogni pagina può in qualche modo essere collegata ad altre in modo argomentativo. Va senz’altro notato che Eraclito fu probabilmente il primo a fare collegamenti forma-contenuto: dal momento che i contenuti erano complessi, anche lo stile e la forma dovevano essere complessi: è come se Eraclito volesse sottolineare la difficoltà del contenuto tramite la difficoltà della forma (tant’è che veniva spesso denominato “l’oscuro” o “il piangente”): Aristotele stesso, nel tratteggiare le qualità stilistiche proprie dei filosofi, cita Eraclito come esempio in negativo. Socrate stesso dice che per penetrare nel senso dei discorsi di Eraclito occorrerebbe essere dei “palombari di Delo”. Ma Eraclito era pienamente consapevole della difficoltà di interpretazione del suo libro: da buon aristocratico, diceva che non tutti gli uomini erano in grado di capire cosa dicesse: solo i migliori ce l’avrebbero fatta. In Eraclito perfino gli accenti sono ambigui: il termine greco “bios” (βιος), ad esempio, letto “bios” significa “arco”, ma letto “bios” significa “vita” (sono addirittura antitetici i significati: l’arco è un qualcosa che provoca la morte, che è l’opposto della vita). E’ interessante e famoso il frammento in cui Eraclito dice “la natura ama nascondersi” (φυσις φιλει κρυπτειν) : con ciò, egli intende sottolineare che non è facile trovare la realtà, ma occorre aprire bene gli occhi; lo stesso stile eracliteo così oscuro può allora essere inteso come un invito a stare in guardia. In Eraclito vi è una convinzione di fondo: che l’intera realtà sia governata da un solo principio (come dicevano i Milesi), a cui tutto è collegato. Dirà che questi legami che legano la natura sono dettati dal Λογος (Logos): nel mondo c’è una ragione che lo fa andare avanti e un discorso che lo lega. Sia ragione sia discorso vengono proprio tradotti ambedue dormono e li chiama “dormienti”, in contrapposizione con coloro che son desti: con “logos”, termine che riveste una miriade di significati. Logos è anche il discorso che Eraclito consegna al suo scritto, che in questo senso si presenta come espressione adeguata del logos cosmico. Questo è comune a tutti gli uomini, ma essi non sono in grado di comprenderlo perchè restano rinchiusi nel loro orizzonte privato. Eraclito paragona questi uomini a coloro che quale è la differenza tra le due categorie? Quando siamo svegli siamo in grado di mettere in comune le esperienze: non siamo soli, ma c’è un comune terreno d’intesa. Quando invece dormiamo e ciascuno di noi vive nei sogni in un mondo interamente suo. I dormienti quindi, nel caso degli uomini che Eraclito così definisce, sono coloro che rinunciano al logos cosmico, che ci consente di capire insieme la realtà. Certo suona strano che un aristocratico parli di logos comune-cosmico: in realtà la questione è che quel “comune” logos “cosmico” si riferisce non a tutti gli uomini, ma a pochi solo ai migliori, e non ai dormienti. Ma cerchiamo di comprendere che cosa Eraclito intenda con “logos comune, cosmico”: come accennato, la parola logos é polisemantica ed è quindi bene non tradurla. Essa si riconnette al verbo greco “lego”, che in origine significava “legare” ma che poi passò a significare “parlare”. Logos vuol dire, tra le varie cose, discorso: c’è l’idea di più parole che vengono tra loro legate per assumere un significato. Può anche significare “discorso interiore” in quanto prima di parlare, si effettua un ragionamento, un dialogo significati della parola logos sono essenzialmente tre:
Eraclito, vissuto ad Efeso tra il VI e il V secolo a.C., è di famiglia aristocratica (addirittura discendente da famiglia regale) e lo stile stesso in cui scrive risente di questa influenza aristocratica (nella sua opera arriverà a dire: “uno è per me diecimila, se è il migliore”). Nel suo libro Περι φυσεως (Sulla natura) traspare palesemente un atteggiamento di disprezzo per la massa popolare (definita come un branco di “cani” che gli abbaiano contro). Va subito precisato, però, che l’aristocraticismo di Eraclito non è molto legato alla vita politica, quanto piuttosto a quella intellettuale e culturale. Secondo la tradizione, Eraclito avrebbe depositato il suo libro (di cui ci sono pervenuti parecchi frammenti) nel tempio di Artemide ad Efeso: egli compie questo gesto senz’altro per il fatto che il tempio era il luogo più sicuro per la custodia (all’epoca le biblioteche non c’erano), ma anche perchè era tipicamente aristocratico riallacciarsi al sapere della casta sacerdotale ed arcaica. Eraclito ritiene dunque che il tempio sia l’unico luogo idoneo a custodire il suo scritto: egli infatti nutre grande sfiducia nella possibilità che il messaggio da lui consegnato allo scritto possa essere compreso dalla maggior parte degli uomini. Ciò dipende dai contenuti di esso, lontani dalle esperienze della vita comune, ma anche dal linguaggio e dalla forma nei quali questi contenuti sono espressi. In effetti ancora oggi non si è riusciti a comprendere la natura dell’opera di Eraclito, sebbene possediamo numerosi frammenti (oltre 100): essa era e singole. Il fatto che fosse un libro “aforistico” non significa che fossero idee campate in aria o che Eraclito saltasse di palo in frasca, cambiando in continuo argomenti: ogni frase, infatti costituita di aforismi, vale a dire paginette autonome ogni pagina può in qualche modo essere collegata ad altre in modo argomentativo. Va senz’altro notato che Eraclito fu probabilmente il primo a fare collegamenti forma-contenuto: dal momento che i contenuti erano complessi, anche lo stile e la forma dovevano essere complessi: è come se Eraclito volesse sottolineare la difficoltà del contenuto tramite la difficoltà della forma (tant’è che veniva spesso denominato “l’oscuro” o “il piangente”): Aristotele stesso, nel tratteggiare le qualità stilistiche proprie dei filosofi, cita Eraclito come esempio in negativo. Socrate stesso dice che per penetrare nel senso dei discorsi di Eraclito occorrerebbe essere dei “palombari di Delo”. Ma Eraclito era pienamente consapevole della difficoltà di interpretazione del suo libro: da buon aristocratico, diceva che non tutti gli uomini erano in grado di capire cosa dicesse: solo i migliori ce l’avrebbero fatta. In Eraclito perfino gli accenti sono ambigui: il termine greco “bios” (βιος), ad esempio, letto “bios” significa “arco”, ma letto “bios” significa “vita” (sono addirittura antitetici i significati: l’arco è un qualcosa che provoca la morte, che è l’opposto della vita). E’ interessante e famoso il frammento in cui Eraclito dice “la natura ama nascondersi” (φυσις φιλει κρυπτειν) : con ciò, egli intende sottolineare che non è facile trovare la realtà, ma occorre aprire bene gli occhi; lo stesso stile eracliteo così oscuro può allora essere inteso come un invito a stare in guardia. In Eraclito vi è una convinzione di fondo: che l’intera realtà sia governata da un solo principio (come dicevano i Milesi), a cui tutto è collegato. Dirà che questi legami che legano la natura sono dettati dal Λογος (Logos): nel mondo c’è una ragione che lo fa andare avanti e un discorso che lo lega. Sia ragione sia discorso vengono proprio tradotti ambedue dormono e li chiama “dormienti”, in contrapposizione con coloro che son desti: con “logos”, termine che riveste una miriade di significati. Logos è anche il discorso che Eraclito consegna al suo scritto, che in questo senso si presenta come espressione adeguata del logos cosmico. Questo è comune a tutti gli uomini, ma essi non sono in grado di comprenderlo perchè restano rinchiusi nel loro orizzonte privato. Eraclito paragona questi uomini a coloro che quale è la differenza tra le due categorie? Quando siamo svegli siamo in grado di mettere in comune le esperienze: non siamo soli, ma c’è un comune terreno d’intesa. Quando invece dormiamo e ciascuno di noi vive nei sogni in un mondo interamente suo. I dormienti quindi, nel caso degli uomini che Eraclito così definisce, sono coloro che rinunciano al logos cosmico, che ci consente di capire insieme la realtà. Certo suona strano che un aristocratico parli di logos comune-cosmico: in realtà la questione è che quel “comune” logos “cosmico” si riferisce non a tutti gli uomini, ma a pochi solo ai migliori, e non ai dormienti. Ma cerchiamo di comprendere che cosa Eraclito intenda con “logos comune, cosmico”: come accennato, la parola logos é polisemantica ed è quindi bene non tradurla. Essa si riconnette al verbo greco “lego”, che in origine significava “legare” ma che poi passò a significare “parlare”. Logos vuol dire, tra le varie cose, discorso: c’è l’idea di più parole che vengono tra loro legate per assumere un significato. Può anche significare “discorso interiore” in quanto prima di parlare, si effettua un ragionamento, un dialogo significati della parola logos sono essenzialmente tre:
1) La ragione che governa interno a noi stessi. Quindi passò a significare “ragionamento” e da qui “ragione”, ossia la facoltà di effettuare ragionamenti. Per Eraclito però i funzionare l’universo. Eraclito afferma che il logos che abbiamo nella nostra mente non è l’universo
2) Il pensiero che comprende questa ragione universale
3) il discorso che esprime questa conoscenza (dunque il discorso che Eraclito pone per iscritto nel suo testo). Così come abbiamo un logos dentro di noi (la ragione), Eraclito dice che anche nella realtà ci deve essere un logos cosmico, dove logos ha valenza di “ragione”: il logos è quel qualcosa che fa diverso da quello cosmico. Per arrivare a dire questo, probabilmente, Eraclito si deve essere sagacemente chiesto: “come è che quello che noi pensiamo esiste anche nella realtà?”. Questo è anche un modo per rispondere alla domanda: “come si ricollegano le leggi della natura e del mondo? “. Di fatto, Eraclito nega l’esistenza di un dio, ma ammette quella di una ragione universale: c’è un nesso tra la ragione che governa il mondo e quella che governa la nascondersi. Certo è difficile comprendere questo logos universale, ma non è nostra mente: sono la stessa cosa e dunque l’ambiguità espositiva nell’opera “Peri fuseos” è dettata dal logos stesso, che få si che la natura ami tutti disponiamo. Quindi tutti partiamo dallo impossibile: l’uomo ce la può fare usando quel frammento di logos a sua disposizione, insito dentro di lui: la ragione, che non è nient’altro che un pezzettino di logos universale di cui stesso livello, ma solo i migliori riescono ad emergere e ad avvicinarsi al logos cosmico. I dormienti sono coloro che non ci riescono nè ci provano: per raggiungere il logos universale bisogna cooperare, non agire da soli e nel parere che una città per funzionare avesse bisogno delle leggi: come il logos cosmico governa il mondo, cosi le leggi governano la città. Anche le leggi (νομοι), come la mente umana, rappresentano un frammento di logos proprio interesse: Eraclito dice “bisogna seguire ciò che è comune; infatti ciò che è è comune di tutti. Ma pur essendo il logos di tutti, la folla vive come se avesse un proprio ed esclusivo criterio per giudicare”.
Eraclito era del parere che una città per funzionare avesse bisogno delle leggi: come il logos cosmico governa il mondo, cosi le leggi governano la città. Anche le leggi (νομοι), come la mente umana, rappresentano un frammento di logos universale. In Eraclito matura l’idea che la legge umana derivi da quella naturale, della φυσις (natura). Tutte le leggi umane nella misura in cui sono giuste attingono ad un’unica legge cosmica. A quei tempi vi era anche chi ammettere che il principio sia il logos, un’entità assolutamente astratta, tuttavia egli sente il bisogno di diceva che le leggi umane fossero puramente convenzionali e non c’entrassero nulla con la natura. Sebbene Eraclito arrivi ad incarnarlo in qualcosa di materiale, e più precisamente nel fuoco. Eraclito dice che l’universo non è il prodotto di dei o uomini, ma un ordine universale unico ed eterno. Egli lo identifica con “il fuoco sempre vivente”. Con il notte). La vicenda cosmica in tutti i suoi aspetti e nelle sue riferimento al fuoco, Eraclito non intende soltanto introdurre una variazione rispetto alla tesi, tradizionalmente attribuita agli ionici a partire da Aristotele (Metafisica, I), dell’unicità del principio. Intende piuttosto insistere sulla peculiarità di comportamento del fuoco: si accende e si spegne regolarmente secondo una misura, come appare anche dal sole, che ora brilla (di giorno) e ora si spegne (di secondo ritmi precisi. Eraclito sostiene che non si tratti solo della successione di un opposto incessanti trasformazioni è infatti regolata da una misura. La mobilità del tutto non è un divenire casuale o disordinato, ma è regolata all’altro, del giorno alla notte, della vita alla morte e così via. La guerra (πολεμος) assurge a simbolo e insieme regola di tutto ciò che avviene nell’universo: questo è caratterizzato da un’armonia superiore consistente nell’unità e identità degli opposti in tensione tra loro (coincidentia oppositorum). Quindi anche per Eraclito la ricerca dell’unità, al di sotto dell’apparente molteplicità e dispersione di ciò che appare ai più, è l’obiettivo primario. La guerra (“Polemos è signore di tutte le cose”) tra gli opposti non è espressione di ingiustizia, come ritengono i più e come aveva detto Anassimandro: il divenire di tutte le cose è il risultato del perenne conflitto che permea il tutto e si esprime nell’incessante tensione e trasformazione di un contrario nell’altro. Il fuoco suggerisce bene l’idea di questo costante divenire, di dinamicità, di trasformazione e di identità degli opposti: dove c’è il fuoco c’è la vita, ma il fuoco porta anche la morte (come “bios” denota sia la vita sia l’arco mortifero). Eraclito polemizzerà moltissimo con i Pitagorici (ed in particolare con Pitagora che definirà “inventore di coltelli”, vale a dire dell’arte tagliente della retorica, che mira ad affascinare l’ascoltatore con dialoghi raffinati, ma privi di verità), che sostenevano la pace e l’armonia dei contrasti e che vedevano nella musica la struttura numerica della realtà. Per lui la vera armonia è la tensione tra i contrasti (armonia discors): se prendiamo un arco o una lira, notiamo che essi funzionano fin tanto che la struttura data dal contrasto e dalla tensione degli opposti regge. Divenire significa proprio passare da un opposto all’altro. Mentre nella nostra società si tende a dare un valore negativo alla guerra, Eraclito (e in forza di ciò sarà amatissimo ad esempio da Hegel) dice che polemos (la guerra) è il padre di tutte le cose, è ciò che rende liberi o schiavi gli uomini. Da notare che non si può conoscere pienamente una cosa se non si conosce il suo opposto: non si può conoscere davvero la schiavitù se non si sa che cosa sia la libertà. Per Eraclito la guerra è una grande cosa Eraclito afferma che il diametro del sole sia di un piede umano, il che è un’assurdità e lui lo sapeva bene: con quest’affermazione sconcertante egli vuole dire che, cosi come è assurda la sua affermazione, tali sono anche tutte quelle anche perchè determina quali siano gli uomini più valevoli e quelli inferiori: anche nella guerra c’è dunque un frammento di logos universale. Per Eraclito c’è armonia solo quando i contrari sono in tensione. In un suo frammento, che si arrestano all’apparenza, giacchè “la natura ama nascondersi”. In un altro frammento dice di aver indagato se stesso (“ho indagato me stesso”): salta all’occhio questa affermazione perchè sul tempio di Apollo a Delfi c’era scritto γνωθι σαυτον (conosci te stesso): lui dice di aver indagato se stesso ed emerge il legame di Eraclito con il mondo arcaico e sacro, tipicamente aristocratico, quel mondo a cui aveva voluto affidare il proprio scritto. , non è definita: “per quanto tu possa camminare, e Probabilmente quest’affermazione va riferita ad un’importante constatazione di Eraclito: voleva conoscere il logos dell’anima e dice di aver scoperto che l’anima non ha dimensioni ma che non le aveva individuate come identità di opposti. In un frammento neppure percorrendo intera la via, tu potresti mai trovare i confini dell’anima: così profondo è il suo lógos”. Dice che il suo logos è profondo, quasi con l’idea dello scavare in profondità alla ricerca dell’anima. Eraclito biasima anche Esiodo, l’autore di quella specie di Bibbia dei Greci che è la “Teogonia”, che tra le varie coppie di contrari aveva individuato il giorno e la notte, Eraclito dice “la via in su ed in giù è unica ed identica”: un qualsiasi percorso in pendenza è sia salita sia discesa e ciò significa che le stesse cose possono contemporaneamente essere opposte ed identiche ed in particolare traspare l’identificazione degli opposti: la salita e la discesa sono tra loro opposti, ma si identificano. Interessante è il frammento in cui dice: “il fulmine governa tutte le cose”; il fulmine è strettamente connesso al fuoco, che governa tutto ed è l’attributo principale di Zeus, il padre degli dei. Gli Stoici pensavano che vi sarebbe stato un grande anno in cui vi sarebbe stato un incendio che avrebbe portato alla conflagrazione del mondo (εκπυροσις) e che dopo ciò ne sarebbe nato uno nuovo. Essi amavano Eraclito perchè pensavano di leggere nei suoi frammenti idee simili, quali la conflagrazione. In effetti c’è un frammento eracliteo in cui si dice che il fuoco può cambiarsi in tutte le cose e che tutte le cose si possono cambiare in fuoco, ma Eraclito intende semplicemente dire che una parte di cose viene di continuo cambiata in fuoco, e una parte di fuoco viene di continuo cambiata in cose. C’è un equilibrio: Eraclito non intendeva assolutamente parlare di conflagrazioni: si tratta di interpretazioni errate da parte degli stoici. Uno dei frammenti senz’altro più famosi di Eraclito è quello che dice: “negli stessi fumi scendiamo e non scendiamo, siamo e tutto scorre”), come se Eraclito ci stesse suggerendo che non possiamo mai bagnarci due volte nelle stesse acque di un fiume, giacchè esse si rinnovano incessantemente. In realtà l’indirizzo dell’incessante divenire che regola la realtà sarà intrapreso, più che non siamo “: troppo spesso è stato interpretato come il manifesto della “filosofia del divenire”, del παντα ρει (” da Eraclito (nel quale pure non è assente), dal suo discepolo Cratilo (futuro maestro di Platone): egli estremizzerà le posizioni di Eraclito e diventerà il filosofo del “tutto scorre”: a suo avviso è addirittura impossibile dare i nomi alle cose perchè esse cambiano di continuo (noi chiamiamo Po un fiume ma non è corretto, perchè le acque si rinnovano in continuazione e il fiume non è mai lo stesso); si fissa artificialmente una cosa che non è fissabile perchè in continua mutazione . Cratilo con il “panta rei” arriva a dimostrazioni sofistiche: è impossibile conoscere qualcosa che cambia sempre. Quindi in teoria, dal momento che non si possono frammento del fiume, sta argomentando in favore coincidenza degli opposti, mettendo in luce come quando ci immergiamo in un fiume siamo in esso e al contempo non siamo in esso (poiché nel fiume le acque cambiano di della attribuire nomi, bisognerebbe limitarsi ad indicare le cose col dito, senza chiamarle per nome. In realtà Eraclito, con il continuo). Circa l’identità degli opposti, egli dice anche che “il mare è l’acqua più pura e impura, per i pesci potabile e salutare, per gli uomini imbevibile e letale”: in questo frammento si può anche scorgere il famoso relativismo assoluto di Protagora, ad avviso del quale il miele c’è chi lo sente dolce e chi lo sente amaro, ma non si può effettivamente dire se esso sia amaro o dolce: dipende da come ciascuno lo sente.
Durissima è la critica condotta da Eraclito contro i sapienti del suo tempo (Pitagora, Ecateo, Esiodo, Omero, tutta “gente dalla doppia testa”), accusati di πολυμαθια, il “sapere molte cose”: la vera conoscenza dev’essere quella dell’unico logos
CRATILO
 La figura di Cratilo è avvolta da un alone di mistero: tutto quel che sappiamo sul suo conto lo dobbiamo ai riferimenti che a lui Aristotele e Platone fanno nelle loro opere. Con certezza possiamo dire che Cratilo fu un filosofo presocratico vissuto nel V secolo a.C. e che fu vicino ad Eraclito di Efeso, di cui fu discepolo e di cui estremizzò gli ammaestramenti. Per gettar luce sull’ombrosa figura di Cratilo, occorre pertanto fare costante riferimento al suo maestro e alle dottrine da lui elaborate: Eraclito è troppo spesso stato presentato come il “filosofo del divenire”, ovvero come il pensatore convinto che l’universo nella sua interezza sia soggetto ad un incessante processo di cambiamento a cui nulla si sottrae. Ciò sarebbe attestato soprattutto dal celebre frammento in cui egli asserisce che “negli stessi flumi scendiamo e non scendiamo, siamo e non siamo”: con tale constatazione si è notato-egli intenderebbe mettere in mostra l’impossibilità di bagnarsi due volte nelle acque di uno stesso fiume, giacchè esse si rinnovano senza tregua; tale esempio non è che un’immagine lampante di ciò che avviene per ogni singola cosa dell’universo, sottoposta all’indeflettibile legge del divenire. In realtà, Eraclito è, più che il filosofo del divenire (benché la tematica del divenire in lui sia tutt’altro che assente), il filosofo della coincidenza degli opposti: nella sua prospettiva, l’universo non è che un insieme di contrari in guerra reciproca, ma esso risulta non già dal caotico guerreggiare de medesimi, bensi dall’armonica unità dei contrari (coincidentia oppositorum), compresenti in ogni cosa. Sicchè il frammento dei fiumi deve essere innanzitutto inteso in tal senso: quando ci immergiamo nelle acque sempre e di nuovo rinnovatisi di un fiume, ci troviamo nella condizione di essere immersi nel fiume e, insieme, di non essere immersi in esso. Ció esemplifica perfettamente la situazione di “armonia discordante” che ha in mente il filosofo di Efeso: certo, in lui non è assente la tematica del divenire, ma è comunque secondaria rispetto a quella della coincidenza degli opposti. E’ invece Cratilo a portare alle estreme conseguenze ciò che in Eraclito è presente se non embrionalmente, almeno in maniera sfumata: il mondo cosi come lo concepisce Cratilo è il mondo del divenire, in cui tutto scorre via (παντα ρει) con una rapidità tale per cui diventa impossibile cogliere stabilmente l’essenza delle cose. Nulla è stabile, tutto scorre via senza posa in un flusso che non può mai essere arrestato in forme fisse. La conseguenza paradossale cui Cratilo addiveniva è l’impossibilità di nominare le cose, poiché esse nel momento in cui le nomino – già sono divenute altro. Cosi, quando vedo una persona e la chiamo per nome, sto in realtà chiamando un qualcosa che non c’è più. Ne segue – ancor più paradossalmente che, nell’impossibilità di nominare le cose, occorre limitarsi ad indicarle col dito. Significativamente Aristotele (Metafisica, IV 5, 1010A) ci fornisce un’importante testimonianza sul pensiero cratileo: Costui [Cratilo] finì per convincersi che non si dovesse nemmeno parlare, e si limitava a muovere semplicemente il dito, rimproverando perfino Eraclito di aver detto che non è possibile bagnarsi due volte nello stesso flume: Cratilo, infatti, pensava che non fosse possibile neppure una volta. Ben si evince come le posizioni eraclitee siano tenui se raffrontate con quelle radicali di Cratilo: non è possibile bagnarsi nelle stesse acque di un fiume nemmeno una sola volta, tanto è il divenire a cui esso è soggetto. Da ciò segue la tesi cratilea dell’inconoscibilità del reale: in quanto mai fissa, ma sempre fluente in un corso ininterrotto, la realtà non può mai essere afferratae dunque conosciuta – dal pensiero. Stando cosi le cose, Cratilo è non solo il filosofo del divenire, ma anche il filosofo dell’inconoscibilità del reale, tema sul quale egli è addirittura più radicale di quanto non saranno, in età ellenistica, gli Scettici (per i quali non è dato sapere se si conosca o meno la realtà). Sempre Aristotele riporta (Metafisica, I, 6, 987 A) che Platone stesso, prima del suo incontro decisivo con Socrate e col suo modo di far filosofia, sarebbe stato discepolo di Cratilo, da cui avrebbe desunto la convinzione del perenne fluire di ogni cosa: Platone, infatti, essendo stato fin da giovane amico di Cratilo e seguace delle dottrine eraclitee, secondo le quali tutte quante le cose sensibili sono in continuo flusso e di esse non è possibile scienza, mantenne queste convinzioni anche in seguito. In questa sua ricostruzione storica del pensiero platonico, Aristotele ci sta suggerendo che Platone, per sfuggire al παντα ρει prospettato da Cratilo come dominatore del mondo, escogitò la dottrina delle idee come enti perennemente stabili e sottratti al costante divenire imperante nel mondo sensibile: in questa plausibile ricostruzione, Platone avrebbe mutuato da Cratilo la concezione (che mai avrebbe abbandonato) del mondo in incessante divenire e avrebbe proposto la dottrina iperuranica delle idee come antidoto; in questa maniera, l’essere parmenide e il divenire cratileo troverebbero entrambi posto in una realtà dicotomica per cui il mondo fisico diviene senza tregua e quello ideale è fisso nel suo essere immutabile. Potremmo a questo punto dire che le preziose testimonianze riportate da Aristotele ci hanno aiutato a far luce su Cratilo, se non fosse che anche Platone, all’interno dei suoi dialoghi, ci fornisce informazioni imprescindibili su Cratilo e-cosa paradossale-esse non solo non coincidono con quelle aristoteliche, ma addirittura dicono cose opposte. Ci troviamo pertanto nell’imbarazzante situazione di aver dinanzi a noi due Cratili diametralmente opposti: finora abbiamo preso in esame quello di Aristotele, ma ora è giunto il momento di analizzare anche quello di cui ci parla Platone, che a Cratilo dedica un dialogo che porta il suo nome (il Cratilo appunto), costruito intorno al problema del linguaggio. L’aspetto paradossale è che fin dalle prime pagine di quest’opera Cratilo ci è presentato (di contro a quello aristotelico, propugnatore del perenne divenire delle cose, dell’impossibilità di nominarle e di conoscerle) come il fervido sostenitore della dottrina naturalistica del linguaggio, tale per cui esso non sarebbe il frutto di una statuizione degli uomini (come invece sostiene l’altro interlocutore dell’opera, Ermogene), ma, al contrario, avrebbe un’origine naturale (κατα φύσιν); che la sedia si chiami sedia, dunque, non è il frutto di un accordo con cui abbiamo stabilito di attribuire ad essa tale nome, ma è piuttosto come se la natura stessa dell’oggetto ci avesse suggerito il nome da attribuirgli. Significativamente, il dialogo platonico si apre con un’esposizione delle tesi cratilee da parte di Ermogene a un Socrate che entra improvvisamente in scena, senza nulla sapere della tenzone filosofica che vede i due contrapposti: Cratilo, qui presente, sostiene che ciascun essere possiede la correttezza del nome che per natura gli conviene e che il nome non è quello col quale alcuni, come accordatisi a chtamarlo, lo chiamano, mettendo fuori una piccola parte della propria voce, ma che una correttezza riguardo i nomi esista per natura per Greci e barbari ed è la stessa per tutti. Io gli domando dunque se egli ha a nome Cratilo conforme verità ed egli ne conviene. “E che dire”, gli chiedo, “per Socrate?” “Socrate”, mi risponde. Ne segue, allora, che-nominando le cose si coglie in maniera fissa, stabile e incontrovertibile (l’errore non è in alcun caso possibile) la loro essenza: ma ciò è l’esatto opposto di quel che sostiene il Cratilo di cui parla Aristotele, quel Cratilo per il quale la realtà scorre cosi in fretta che non è possibile conoscere le cose né nominarle. Chi dunque – Aristotele o Platone? – dice il vero? E’ storicamente esistito il Cratilo aristotelico, quello del perenne fluire di ogni cosa, o quello platonico, dei nomi come copia infallibile della realtà? Non possiamo fornire una risposta certa, ma possiamo presumibilmente ritenere più attendibile la testimonianza aristotelica, soprattutto in riferimento al fatto che il Cratilo platonico è innanzitutto un piacevole divertissement di Platone (prova ne è l’ampia sezione dedicata alle etimologie, in cui Socrate si sbizzarrisce nelle etimologie più strampalate): del resto, che la cornice del dialogo venga nel Cratilo impiegata in maniera “ironica”, quasi come una prova di bravura dialettica, è provato dal fatto che Cratilo, in ogni situazione renitente ad accettare le tesi mediane di Socrate (a metà strada tra convenzionalismo e naturalismo), finisca poi per accettare con entusiasmo proprio la parte più caduca del discorso socratico, ovvero quella inerente alle etimologie; come se non bastasse, Cratilo è convinto che il Socrate delle etimologie sia invasato e parli per tramite di una divinità! Forse non è casuale, tuttavia, che il naturalismo di cui Cratilo è vessillifero porti in fin dei conti ad una sorta di relativismo in bilico fra eraclitismo e protagonismo, tale per cui è impossibile attribuire nomi falsi; ogni nome è giusto (è messa al bando la possibilità dell’errore, in maniera protagorea) perché dettato dalla natura stessa dell’oggetto di cui è nome, cosicché esso non fa che cogliere in maniera fissa ed infallibile l’essenza della cosa. Sulla serietà dell’ Aristotele storico della filosofia, invece, non v’è dubbio alcuno, cosicché possiamo fidarci della sua testimonianza senz’altro più di quanto non possiamo nei confronti di quella di Platone, inserita in quello spaesante contesto rappresentato dal dialogo platonico. Dei due Cratili tramandatici dalla tradizione tende dunque ad imporsi, grazie alla voce veritativa di Aristotele, quello del παντα ρει, sebbene il fantasma del Cratilo naturalista dei nomi non possa del tutto dirsi allontanato.
La figura di Cratilo è avvolta da un alone di mistero: tutto quel che sappiamo sul suo conto lo dobbiamo ai riferimenti che a lui Aristotele e Platone fanno nelle loro opere. Con certezza possiamo dire che Cratilo fu un filosofo presocratico vissuto nel V secolo a.C. e che fu vicino ad Eraclito di Efeso, di cui fu discepolo e di cui estremizzò gli ammaestramenti. Per gettar luce sull’ombrosa figura di Cratilo, occorre pertanto fare costante riferimento al suo maestro e alle dottrine da lui elaborate: Eraclito è troppo spesso stato presentato come il “filosofo del divenire”, ovvero come il pensatore convinto che l’universo nella sua interezza sia soggetto ad un incessante processo di cambiamento a cui nulla si sottrae. Ciò sarebbe attestato soprattutto dal celebre frammento in cui egli asserisce che “negli stessi flumi scendiamo e non scendiamo, siamo e non siamo”: con tale constatazione si è notato-egli intenderebbe mettere in mostra l’impossibilità di bagnarsi due volte nelle acque di uno stesso fiume, giacchè esse si rinnovano senza tregua; tale esempio non è che un’immagine lampante di ciò che avviene per ogni singola cosa dell’universo, sottoposta all’indeflettibile legge del divenire. In realtà, Eraclito è, più che il filosofo del divenire (benché la tematica del divenire in lui sia tutt’altro che assente), il filosofo della coincidenza degli opposti: nella sua prospettiva, l’universo non è che un insieme di contrari in guerra reciproca, ma esso risulta non già dal caotico guerreggiare de medesimi, bensi dall’armonica unità dei contrari (coincidentia oppositorum), compresenti in ogni cosa. Sicchè il frammento dei fiumi deve essere innanzitutto inteso in tal senso: quando ci immergiamo nelle acque sempre e di nuovo rinnovatisi di un fiume, ci troviamo nella condizione di essere immersi nel fiume e, insieme, di non essere immersi in esso. Ció esemplifica perfettamente la situazione di “armonia discordante” che ha in mente il filosofo di Efeso: certo, in lui non è assente la tematica del divenire, ma è comunque secondaria rispetto a quella della coincidenza degli opposti. E’ invece Cratilo a portare alle estreme conseguenze ciò che in Eraclito è presente se non embrionalmente, almeno in maniera sfumata: il mondo cosi come lo concepisce Cratilo è il mondo del divenire, in cui tutto scorre via (παντα ρει) con una rapidità tale per cui diventa impossibile cogliere stabilmente l’essenza delle cose. Nulla è stabile, tutto scorre via senza posa in un flusso che non può mai essere arrestato in forme fisse. La conseguenza paradossale cui Cratilo addiveniva è l’impossibilità di nominare le cose, poiché esse nel momento in cui le nomino – già sono divenute altro. Cosi, quando vedo una persona e la chiamo per nome, sto in realtà chiamando un qualcosa che non c’è più. Ne segue – ancor più paradossalmente che, nell’impossibilità di nominare le cose, occorre limitarsi ad indicarle col dito. Significativamente Aristotele (Metafisica, IV 5, 1010A) ci fornisce un’importante testimonianza sul pensiero cratileo: Costui [Cratilo] finì per convincersi che non si dovesse nemmeno parlare, e si limitava a muovere semplicemente il dito, rimproverando perfino Eraclito di aver detto che non è possibile bagnarsi due volte nello stesso flume: Cratilo, infatti, pensava che non fosse possibile neppure una volta. Ben si evince come le posizioni eraclitee siano tenui se raffrontate con quelle radicali di Cratilo: non è possibile bagnarsi nelle stesse acque di un fiume nemmeno una sola volta, tanto è il divenire a cui esso è soggetto. Da ciò segue la tesi cratilea dell’inconoscibilità del reale: in quanto mai fissa, ma sempre fluente in un corso ininterrotto, la realtà non può mai essere afferratae dunque conosciuta – dal pensiero. Stando cosi le cose, Cratilo è non solo il filosofo del divenire, ma anche il filosofo dell’inconoscibilità del reale, tema sul quale egli è addirittura più radicale di quanto non saranno, in età ellenistica, gli Scettici (per i quali non è dato sapere se si conosca o meno la realtà). Sempre Aristotele riporta (Metafisica, I, 6, 987 A) che Platone stesso, prima del suo incontro decisivo con Socrate e col suo modo di far filosofia, sarebbe stato discepolo di Cratilo, da cui avrebbe desunto la convinzione del perenne fluire di ogni cosa: Platone, infatti, essendo stato fin da giovane amico di Cratilo e seguace delle dottrine eraclitee, secondo le quali tutte quante le cose sensibili sono in continuo flusso e di esse non è possibile scienza, mantenne queste convinzioni anche in seguito. In questa sua ricostruzione storica del pensiero platonico, Aristotele ci sta suggerendo che Platone, per sfuggire al παντα ρει prospettato da Cratilo come dominatore del mondo, escogitò la dottrina delle idee come enti perennemente stabili e sottratti al costante divenire imperante nel mondo sensibile: in questa plausibile ricostruzione, Platone avrebbe mutuato da Cratilo la concezione (che mai avrebbe abbandonato) del mondo in incessante divenire e avrebbe proposto la dottrina iperuranica delle idee come antidoto; in questa maniera, l’essere parmenide e il divenire cratileo troverebbero entrambi posto in una realtà dicotomica per cui il mondo fisico diviene senza tregua e quello ideale è fisso nel suo essere immutabile. Potremmo a questo punto dire che le preziose testimonianze riportate da Aristotele ci hanno aiutato a far luce su Cratilo, se non fosse che anche Platone, all’interno dei suoi dialoghi, ci fornisce informazioni imprescindibili su Cratilo e-cosa paradossale-esse non solo non coincidono con quelle aristoteliche, ma addirittura dicono cose opposte. Ci troviamo pertanto nell’imbarazzante situazione di aver dinanzi a noi due Cratili diametralmente opposti: finora abbiamo preso in esame quello di Aristotele, ma ora è giunto il momento di analizzare anche quello di cui ci parla Platone, che a Cratilo dedica un dialogo che porta il suo nome (il Cratilo appunto), costruito intorno al problema del linguaggio. L’aspetto paradossale è che fin dalle prime pagine di quest’opera Cratilo ci è presentato (di contro a quello aristotelico, propugnatore del perenne divenire delle cose, dell’impossibilità di nominarle e di conoscerle) come il fervido sostenitore della dottrina naturalistica del linguaggio, tale per cui esso non sarebbe il frutto di una statuizione degli uomini (come invece sostiene l’altro interlocutore dell’opera, Ermogene), ma, al contrario, avrebbe un’origine naturale (κατα φύσιν); che la sedia si chiami sedia, dunque, non è il frutto di un accordo con cui abbiamo stabilito di attribuire ad essa tale nome, ma è piuttosto come se la natura stessa dell’oggetto ci avesse suggerito il nome da attribuirgli. Significativamente, il dialogo platonico si apre con un’esposizione delle tesi cratilee da parte di Ermogene a un Socrate che entra improvvisamente in scena, senza nulla sapere della tenzone filosofica che vede i due contrapposti: Cratilo, qui presente, sostiene che ciascun essere possiede la correttezza del nome che per natura gli conviene e che il nome non è quello col quale alcuni, come accordatisi a chtamarlo, lo chiamano, mettendo fuori una piccola parte della propria voce, ma che una correttezza riguardo i nomi esista per natura per Greci e barbari ed è la stessa per tutti. Io gli domando dunque se egli ha a nome Cratilo conforme verità ed egli ne conviene. “E che dire”, gli chiedo, “per Socrate?” “Socrate”, mi risponde. Ne segue, allora, che-nominando le cose si coglie in maniera fissa, stabile e incontrovertibile (l’errore non è in alcun caso possibile) la loro essenza: ma ciò è l’esatto opposto di quel che sostiene il Cratilo di cui parla Aristotele, quel Cratilo per il quale la realtà scorre cosi in fretta che non è possibile conoscere le cose né nominarle. Chi dunque – Aristotele o Platone? – dice il vero? E’ storicamente esistito il Cratilo aristotelico, quello del perenne fluire di ogni cosa, o quello platonico, dei nomi come copia infallibile della realtà? Non possiamo fornire una risposta certa, ma possiamo presumibilmente ritenere più attendibile la testimonianza aristotelica, soprattutto in riferimento al fatto che il Cratilo platonico è innanzitutto un piacevole divertissement di Platone (prova ne è l’ampia sezione dedicata alle etimologie, in cui Socrate si sbizzarrisce nelle etimologie più strampalate): del resto, che la cornice del dialogo venga nel Cratilo impiegata in maniera “ironica”, quasi come una prova di bravura dialettica, è provato dal fatto che Cratilo, in ogni situazione renitente ad accettare le tesi mediane di Socrate (a metà strada tra convenzionalismo e naturalismo), finisca poi per accettare con entusiasmo proprio la parte più caduca del discorso socratico, ovvero quella inerente alle etimologie; come se non bastasse, Cratilo è convinto che il Socrate delle etimologie sia invasato e parli per tramite di una divinità! Forse non è casuale, tuttavia, che il naturalismo di cui Cratilo è vessillifero porti in fin dei conti ad una sorta di relativismo in bilico fra eraclitismo e protagonismo, tale per cui è impossibile attribuire nomi falsi; ogni nome è giusto (è messa al bando la possibilità dell’errore, in maniera protagorea) perché dettato dalla natura stessa dell’oggetto di cui è nome, cosicché esso non fa che cogliere in maniera fissa ed infallibile l’essenza della cosa. Sulla serietà dell’ Aristotele storico della filosofia, invece, non v’è dubbio alcuno, cosicché possiamo fidarci della sua testimonianza senz’altro più di quanto non possiamo nei confronti di quella di Platone, inserita in quello spaesante contesto rappresentato dal dialogo platonico. Dei due Cratili tramandatici dalla tradizione tende dunque ad imporsi, grazie alla voce veritativa di Aristotele, quello del παντα ρει, sebbene il fantasma del Cratilo naturalista dei nomi non possa del tutto dirsi allontanato.
ORFICI
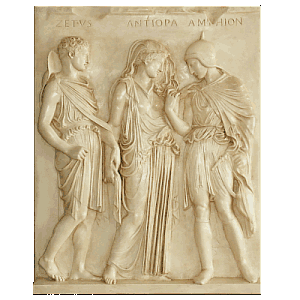 L’orfismo è il più grande fenomeno religioso di carattere mistico che si affacci alla Grecia del sec.VI, in quel secolo così importante per la storia religiosa del mondo, giacché in esso vediamo sorgere Confucio e Lao-tse in Cina, il Buddha nell’India, Ezechiele tra gli Israeliti, Zarathustra nell’Iran, Pitagora tra gli Elleni. Il sec.VI è per la Grecia un’epoca di profonda trasformazione sociale. Esso segna la fine del così detto medio evo greco, che sta tra il crollo delle antiche monarchie rispecchiate dai poemi d’Omero e il sorgere degli Stati democratici di cui Atene è l’esempio più illustre. In questo secolo, che porta in sè la travagliosa gestione di una nuova èra, cadono le forti oligarchie in mezzo a convulsioni politico-sociali di cui quel tanto che sappiamo vale a darci un’idea, e attraverso questo doloroso travaglio il popolo acquista coscienza dei suoi diritti. In quest’epoca agitata l’orfismo rappresenta, nella religione, l’anelito alla liberazione da un regime di oppressione e di violenza, il sacro rifugio degli spiriti migliori, dove è promesso agli adepti conforto nel presente, libertà nel futuro. Perciò presso gli Orfici si trova così vivo l’orrore del sangue, così possente il desiderio della Giustizia (Dike) e della Legge (Nomos): Nomos e Dike, che così sovente ritornano nei frammenti orfici. Perciò a dio centrale della teologia e del culto orfico viene assunto Dioniso, il più giovane degli dei della Grecia, il dio caratteristico sopratutto per i suoi patimenti e per la sua morte ingiusta, il dio straniero e popolare venuto di Tracia, invece degli dei Olimpici che avevano fatto la gloria delle vecchie aristocrazie guerriere cantate da Omero. Perciò specialmente questo movimento mistico trova simpatica accoglienza presso i tiranni che si poggiano sul popolo per abbattere l’oligarchia. E così vediamo Onomacrito teologo orfico, fondatore della comunità orfica di Atene, vivere alla corte dei Pisistratidi e Clistene tiranno di Sicione attribuire a Dioniso gli onori mitici della spedizione dei Sette contro Tebe e proibire ai rapsodi omerici di entrare in Sicione perché esaltano i Dori argivi e l’aristocrazia. Se questi sono i motivi di carattere politico-sociale che hanno suscitato o almeno oltremodo facilitato il rapido diffondersi dell’orfismo, che cosa dobbiamo pensare del fondatore, di Orfeo, il leggendario cantore tracio, capace di attirare non pur gli animali, ma tutta la natura al suono fascinatore della sua lira? La sua figura mitica ha in sè cotanti elementi, riflesso del sistema religioso che da lui prende nome, che non è più possibile delinearne la figura originale1. Egli infatti è originario di Tracia, come tracio è Dioniso, la divinità centrale dell’orfismo; egli muore di morte dionisiaca in quanto viene sbranato dalle baccanti; a lui sono attribuiti inni, oracoli, formole catartiche che costituiscono il bagaglio dell’orfismo posteriore. Sicché l’Orfeo della tradizione ci appare piuttosto figlio che padre della religione che porta il suo nome. Ma checché si debba pensare della sua figura storica, certo alle origini del movimento orfico deve esserci stato un Orfeo, ossia un uomo di profondo ingegno teologico e di profonda ispirazione religiosa, il quale ha sollevato il preesistente mistero dionisiaco alla sua sublimazione orfica, inquadrandolo in una cosmogonia filosofica e sviluppandone le prescrizioni morali in vista del destino superiore riservato all’anima dell’iniziato ai misteri di Orfeo. L’orfismo infatti ci si presenta come una sistemazione teologica dei misteri di Dioniso. Gli Orfici hanno accettato la figura di questo dio il più estraneo al pantheon olimpico, il più vicino all’anima del popolo per la sua vita fatta di emozioni profonde; hanno accettato anche il rituale di uccisione dell’animale sacro con ingestione delle sue carni crude (omwjagia); ma hanno considerato questo sacrificio, come il memoriale, la riproduzione di un sacrificio primordiale, in cui Dioniso, sotto la forma di toro, subì per altrui violenza lo sbranamento (sparagmoz): odioso deicidio, gravido di conseguenze per la storia dolorante dell’umanità, ma dal quale è pur scaturita la scintilla divina che si cela nella cenere della nostra materia, che solo la disciplina orfica può liberare facendola risalire al suo principio. Nella teologia orfica il mito di Dioniso viene inquadrato in una cosmogonia, la quale, presso un popolo, in cui era viva la tradizione di Esiodo, non poteva essere che quella esiodea, almeno come trama fondamentale, salvo quelle modificazioni che i caratteri peculiari della nuova credenza esigevano. Anche fra gli Orfici (e ne dobbiamo a Ferecide di Siro l’elaborazione conservataci dai frammenti del suo Pentemuchos “l’antro dai cinque fondi”, che sarebbero le cinque parti o elementi dell’universo: acqua, aria, terra, fuoco e tartaro) il mondo ordinato, il cosmo si sviluppa da un caos primitivo, per virtù di impulsi successivi, dovuti a figure divine, le quali però più che un valore naturistico, come nella teogonia esiodea, hanno un valore filosofico morale, conforme al pensiero orfico. Tre sono le essenze primordiali Zas (da zhn = vivere) che è il principio della vita; Chronos, il principio del tempo; Chthoniè, il principio della materia. Sono queste che operano l’ordinamento del mondo dopo una lotta che Chronos sostiene contro Ophioneus, il serpente, che è il principio del caos, lotta che ricorda quella della Cosmogonia babilonese tra il luminoso dio ordinatore Marduk contro il dragone Tiàmat. Secondo un’altra versione, raccomandata alle così dette Rapsodie (orfiche) il cui contenuto ci è conservato da Damascio, neoplatonico del sec.VI d. C., i tre elementi primordiali sono Chronos, Aither e Chaos. Chronos fabbrica nel seno di Aither un uovo da cui esce Phanes, il Brillante. Questi si accoppia con la Notte oscura e produce la coppia terra e cielo, da cui – secondo la ferrea legge di Adrastea, la Necessità che impera su tutto l’universo – nasce il vecchio Krono, che genera Zeus il quale a sua volta genera, da Persefone, Dioniso. Con Dioniso il mondo divino si riannoda all’umano. L’accoppiamento di Phanes con Nyx, del luminoso con la tenebrosa, è un motivo nuovo nella teogonia dei Greci. La coppia generatrice primordiale non è più il cielo e la terra, coppia così ovvia nella sua limpidità naturistica che la si trova intuita ed esaltata anche dalla cosmogonia polinesiana: ma è la luce e le tenebre cioè il bene e il male, l’elemento dionisiaco e l’elemento titanico. Il Dioniso, figlio di Zeus e di Persefone, l’ultima figura delle generazioni divine, riceve nell’orfismo il nome particolare di Zagreo, col quale si riannoda in modo tutto speciale al mondo infero2. Egli ha ricevuto da suo padre lo scettro del mondo. Ma i Titani, figli della Terra, elemento oscuro e tenebroso – i quali si trovano qui forse anche in quanto possono rappresentare la trasformazione mitica di un elemento rituale del culto dionisiaco: la spalmatura di argilla (titanoz, che si operava sulla faccia degli iniziati) – aizzati dalla gelosa Hera ne insidiano l’esistenza e mentre Zagreo, ingenuo fanciullo, si diverte nei campi, lo traggono in inganno con vari oggetti (che corrispondono agli strumenti secondari del rituale orfico) tra cui più importante uno specchio. Egli cerca di sfuggire alla presa cambiando di forma, ma i Titani riescono a catturarlo proprio quando ha assunto quella di toro, lo fanno a brani e lo divorano crudo. Ma Athena salva il cuore di Dioniso e lo porta a Zeus, il quale lo trangugia e genera poi da Semele un nuovo Dioniso, gloriosa resurrezione dell’antico.
L’orfismo è il più grande fenomeno religioso di carattere mistico che si affacci alla Grecia del sec.VI, in quel secolo così importante per la storia religiosa del mondo, giacché in esso vediamo sorgere Confucio e Lao-tse in Cina, il Buddha nell’India, Ezechiele tra gli Israeliti, Zarathustra nell’Iran, Pitagora tra gli Elleni. Il sec.VI è per la Grecia un’epoca di profonda trasformazione sociale. Esso segna la fine del così detto medio evo greco, che sta tra il crollo delle antiche monarchie rispecchiate dai poemi d’Omero e il sorgere degli Stati democratici di cui Atene è l’esempio più illustre. In questo secolo, che porta in sè la travagliosa gestione di una nuova èra, cadono le forti oligarchie in mezzo a convulsioni politico-sociali di cui quel tanto che sappiamo vale a darci un’idea, e attraverso questo doloroso travaglio il popolo acquista coscienza dei suoi diritti. In quest’epoca agitata l’orfismo rappresenta, nella religione, l’anelito alla liberazione da un regime di oppressione e di violenza, il sacro rifugio degli spiriti migliori, dove è promesso agli adepti conforto nel presente, libertà nel futuro. Perciò presso gli Orfici si trova così vivo l’orrore del sangue, così possente il desiderio della Giustizia (Dike) e della Legge (Nomos): Nomos e Dike, che così sovente ritornano nei frammenti orfici. Perciò a dio centrale della teologia e del culto orfico viene assunto Dioniso, il più giovane degli dei della Grecia, il dio caratteristico sopratutto per i suoi patimenti e per la sua morte ingiusta, il dio straniero e popolare venuto di Tracia, invece degli dei Olimpici che avevano fatto la gloria delle vecchie aristocrazie guerriere cantate da Omero. Perciò specialmente questo movimento mistico trova simpatica accoglienza presso i tiranni che si poggiano sul popolo per abbattere l’oligarchia. E così vediamo Onomacrito teologo orfico, fondatore della comunità orfica di Atene, vivere alla corte dei Pisistratidi e Clistene tiranno di Sicione attribuire a Dioniso gli onori mitici della spedizione dei Sette contro Tebe e proibire ai rapsodi omerici di entrare in Sicione perché esaltano i Dori argivi e l’aristocrazia. Se questi sono i motivi di carattere politico-sociale che hanno suscitato o almeno oltremodo facilitato il rapido diffondersi dell’orfismo, che cosa dobbiamo pensare del fondatore, di Orfeo, il leggendario cantore tracio, capace di attirare non pur gli animali, ma tutta la natura al suono fascinatore della sua lira? La sua figura mitica ha in sè cotanti elementi, riflesso del sistema religioso che da lui prende nome, che non è più possibile delinearne la figura originale1. Egli infatti è originario di Tracia, come tracio è Dioniso, la divinità centrale dell’orfismo; egli muore di morte dionisiaca in quanto viene sbranato dalle baccanti; a lui sono attribuiti inni, oracoli, formole catartiche che costituiscono il bagaglio dell’orfismo posteriore. Sicché l’Orfeo della tradizione ci appare piuttosto figlio che padre della religione che porta il suo nome. Ma checché si debba pensare della sua figura storica, certo alle origini del movimento orfico deve esserci stato un Orfeo, ossia un uomo di profondo ingegno teologico e di profonda ispirazione religiosa, il quale ha sollevato il preesistente mistero dionisiaco alla sua sublimazione orfica, inquadrandolo in una cosmogonia filosofica e sviluppandone le prescrizioni morali in vista del destino superiore riservato all’anima dell’iniziato ai misteri di Orfeo. L’orfismo infatti ci si presenta come una sistemazione teologica dei misteri di Dioniso. Gli Orfici hanno accettato la figura di questo dio il più estraneo al pantheon olimpico, il più vicino all’anima del popolo per la sua vita fatta di emozioni profonde; hanno accettato anche il rituale di uccisione dell’animale sacro con ingestione delle sue carni crude (omwjagia); ma hanno considerato questo sacrificio, come il memoriale, la riproduzione di un sacrificio primordiale, in cui Dioniso, sotto la forma di toro, subì per altrui violenza lo sbranamento (sparagmoz): odioso deicidio, gravido di conseguenze per la storia dolorante dell’umanità, ma dal quale è pur scaturita la scintilla divina che si cela nella cenere della nostra materia, che solo la disciplina orfica può liberare facendola risalire al suo principio. Nella teologia orfica il mito di Dioniso viene inquadrato in una cosmogonia, la quale, presso un popolo, in cui era viva la tradizione di Esiodo, non poteva essere che quella esiodea, almeno come trama fondamentale, salvo quelle modificazioni che i caratteri peculiari della nuova credenza esigevano. Anche fra gli Orfici (e ne dobbiamo a Ferecide di Siro l’elaborazione conservataci dai frammenti del suo Pentemuchos “l’antro dai cinque fondi”, che sarebbero le cinque parti o elementi dell’universo: acqua, aria, terra, fuoco e tartaro) il mondo ordinato, il cosmo si sviluppa da un caos primitivo, per virtù di impulsi successivi, dovuti a figure divine, le quali però più che un valore naturistico, come nella teogonia esiodea, hanno un valore filosofico morale, conforme al pensiero orfico. Tre sono le essenze primordiali Zas (da zhn = vivere) che è il principio della vita; Chronos, il principio del tempo; Chthoniè, il principio della materia. Sono queste che operano l’ordinamento del mondo dopo una lotta che Chronos sostiene contro Ophioneus, il serpente, che è il principio del caos, lotta che ricorda quella della Cosmogonia babilonese tra il luminoso dio ordinatore Marduk contro il dragone Tiàmat. Secondo un’altra versione, raccomandata alle così dette Rapsodie (orfiche) il cui contenuto ci è conservato da Damascio, neoplatonico del sec.VI d. C., i tre elementi primordiali sono Chronos, Aither e Chaos. Chronos fabbrica nel seno di Aither un uovo da cui esce Phanes, il Brillante. Questi si accoppia con la Notte oscura e produce la coppia terra e cielo, da cui – secondo la ferrea legge di Adrastea, la Necessità che impera su tutto l’universo – nasce il vecchio Krono, che genera Zeus il quale a sua volta genera, da Persefone, Dioniso. Con Dioniso il mondo divino si riannoda all’umano. L’accoppiamento di Phanes con Nyx, del luminoso con la tenebrosa, è un motivo nuovo nella teogonia dei Greci. La coppia generatrice primordiale non è più il cielo e la terra, coppia così ovvia nella sua limpidità naturistica che la si trova intuita ed esaltata anche dalla cosmogonia polinesiana: ma è la luce e le tenebre cioè il bene e il male, l’elemento dionisiaco e l’elemento titanico. Il Dioniso, figlio di Zeus e di Persefone, l’ultima figura delle generazioni divine, riceve nell’orfismo il nome particolare di Zagreo, col quale si riannoda in modo tutto speciale al mondo infero2. Egli ha ricevuto da suo padre lo scettro del mondo. Ma i Titani, figli della Terra, elemento oscuro e tenebroso – i quali si trovano qui forse anche in quanto possono rappresentare la trasformazione mitica di un elemento rituale del culto dionisiaco: la spalmatura di argilla (titanoz, che si operava sulla faccia degli iniziati) – aizzati dalla gelosa Hera ne insidiano l’esistenza e mentre Zagreo, ingenuo fanciullo, si diverte nei campi, lo traggono in inganno con vari oggetti (che corrispondono agli strumenti secondari del rituale orfico) tra cui più importante uno specchio. Egli cerca di sfuggire alla presa cambiando di forma, ma i Titani riescono a catturarlo proprio quando ha assunto quella di toro, lo fanno a brani e lo divorano crudo. Ma Athena salva il cuore di Dioniso e lo porta a Zeus, il quale lo trangugia e genera poi da Semele un nuovo Dioniso, gloriosa resurrezione dell’antico.
I Titani per la loro empietà sono colpiti dalla folgore di Zeus e dalle loro ceneri si forma il genere umano, nel quale perciò si trovano riuniti i due elementi, il bene e il male, il titanico e il dionisiaco, fusi insieme fin da quando i Titani divorarono il corpo divino di Zagreo3. Tutta la disciplina orfica consiste appunto nella liberazione dell’elemento luminoso, celeste, dionisiaco, che è l’anima, dall’elemento oscuro, materiale, titanico che è il corpo. In questa ricostruzione del mito di Zagreo, laboriosamente, ma in maniera definitiva operata dall’eruditissimo Lobeck, si ritrovano tutti gli elementi fondamentali dell’antico sacrificio dionisiaco: Dioniso sotto il nome di Zagreo, il toro sacrificale, lo sbranamento (sparagmos) della vittima, il pasto delle carni crude (omofagia). Questi elementi producono ritualmente ancora tutta la virtù religiosa perché il rito trae sempre dalle sue proprie viscere l’efficacia della sua azione indipendentemente dalle orientazioni del mito. Ma mentre nel concetto dionisiaco il sacrificio aveva l’inebbriante valore di una comunione estatica col dio, volta per volta rinnovata, nella teologia orfica il sacrifizio è il memoriale di una primeva immolazione che è un misfatto, un deicidio, da cui deriva la triste posizione dell’uomo su la terra, la sua oscura prigionia, dalla quale è lunga e difficile la liberazione. Sul destino dell’anima e sui mezzi per raggiungerlo riposano la morale e l’escatologia orfiche: morale ed escatologia di altissimo significato, che hanno offerto alla speculazione posteriore le più ricche fonti di ispirazione e alle anime pie le ebbrezze più dolci e le certezze più consolatrici. L’anima adunque per gli Orfici è di origine divina ed il corpo è una tomba (swma, shma) in cui essa è precipitata in seguito a una colpa primordiale. E la distanza che separa la prigione oscura del corpo dalla sede beata a cui l’anima anela di risalire si può abbreviare e sopprimere soltanto a prezzo di una espiazione, purificatrice, di una catarsiz. Questa espiazione si può compiere battendo due strade. La prima è quella delle rinascite poiché non basta una sola vita a compiere l’espiazione e l’anima è condannata a trasmigrare di corpo in corpo, in una successione di vite che ritorna in se stessa come un circolo : il cerchio della generazione (o cucloz thz genesewz) che gira inesorabilmente, come una ruota, la ruota del Destino (o thz Moiraz trocoz). Quest’idea, derivata certo dalla credenza popolare della trasmigrazione delle anime, che si riscontra nel folklore di tutti i popoli e può assurgere, come in India è assurta, a grande altezza di significato filosofico, ha avuto nell’orfismo uno sviluppo assai grande. La visione di questo ciclo inesorabile pesa su gli occhi e su l’anima dell’orfico e la sua più grande gioia è di poter gridare la rottura della ruota e il ritorno dello spirito liberato al suo principio4.
La seconda strada è quella della purificazione nell’Ade luogo di terrori e di delizie dove l’anima scende dopo la morte, ma dove non trova ad ogni modo la sua gioia, anche nella più gaudiosa delle situazioni, perché il suo unico gaudio è di riunirsi al suo principio ch’è Zagreo. Per raggiungere lo scopo suo finale che è di riunirsi alla divinità, di fondersi in quell’Uno che soffre e si perde effondendosi nella pluralità delle creature, come si esprimevano filosoficamente i neoplatonici cresciuti nel solco del pensiero orfico, l’Orfico si impone una vita di purità, di ascetismo, di purificazioni cerimoniali, i cui meriti erano applicabili anche ai defunti, e le cui prescrizioni erano contenute in appositi rituali e venivano da sacerdoti orfici eseguite a beneficio di privati e di città. Anche segni esteriori contraddistinguono chi mena una vita siffatta: una veste bianca; orrore di tutto che implica un contatto mortuario, come a) la vicinanza delle tombe, b) il mangiare i legumi che sono l’offerta precipua che si fa ai defunti, c) il vestir di lana, anche nella tomba, perché la lana fu il mantello di un animale, d) il gustare uova e carne, perché anch’esse in contatto con le anime peregrinanti nei cicli vari della metempsicosi; fuggire la generazione dei mortali (cenesin broton) nel senso assai diffuso, di evitar la polluzione della partoriente. Queste prescrizioni sono tutte contenute in un prezioso frammento euripideo che si può considerare come il più importante documento della liturgia orfica. Esso appartiene ad una tragedia perduta, intitolata I Cretesi, il che si spiega considerando che in Creta il culto e il mito di Dioniso si era fuso con quello indigeno di Zeus Ideo, un dio anch’esso che nasce e muore, dal nome ignoto, che soltanto per sua grande importanza nell’isola fu dai Greci assimilato alla loro massima divinità olimpica, di origine e di etimologia indoeuropea: “Io meno una vita santa da quando son divenuto iniziato di Zeus Ideo ed essendo pastore del nottivago Zagreo, ho compiuto la celebrazione omofagica ed ho agitato le fiaccole in onore della madre dell’Ida. Santificato ho ricevuto il titolo di Bacco, tra i Cureti. Ora io indosso bianchissime vesti e fuggo il parto dei mortali, né mi accosto alle tombe e mi guardo dal cibarmi di esseri animati”. Per chi ha condotto un’esistenza pura si apre, al di là della tomba, una prospettiva che ha fatto palpitar di speranza generazioni e generazioni di Orfici ed ha dettato a Pindaro un’alata descrizione. Nell’Ade orfico regnano Eubuleo (il ben consulto) che è epiteto di Dioniso infero, Ade detto anche Eukles (il ben nomato) e sopratutto Persefone che predomina nella concezione orfica popolare. Vi sono due vie principali che si diramano dall’ingresso, a destra e a sinistra a foggia di un Y, e menano ai prati fioriti dei buoni, al Tartaro punitore dei malvagi. Vi scorre il Lete o fiume dell’oblio, proprio dell’Ade ove non v’è ricordo della vita, concetto caro agli Orfici che hanno abbandonato la vita oscura del mondo per attingere in Zagreo la scaturigine della vita divina. Appena entrato nell’Ade l’Orfico deve prendere non la sinistra via infausta, degli spiriti mali, segnata da un pioppo bianco, ma la destra che lo guida alla fonte di Mnemosine, da cui appositi guardiani tengono lontano chi non ha avuto il privilegio dell’iniziazione. Dà la parola d’ordine che lo dichiara figlio di Urano e Gaia, del cielo e della terra, ossia partecipe del composto dionisiaco e titanico conforme al mito cosmogonico della setta e domandano alla Regina degli Inferi, Persefone, che lo giudichi (è questo un concetto nuovo prettamente orfico) e lo destini alla dolce primavera dei suoi campi nell’attesa del finale ritorno nell’Unico Zagreo. Tutta questa escatologia ci è esposta dall’una o dall’altra delle laminette auree trovate in tombe orfiche5 nella Magna Grecia, a Roma, in Creta. Queste laminette lunghe pochi centimetri, ripiegate più volte come pezzettini di carta, sono state trovate appese al collo o a portata della mano del defunto come guida e promemoria e amuleto insieme del suo viaggio ultramondano. Contengono formule brevi (e per due di esse incomprensibili) di carmi apocalittici orfici in cui si effondeva la vita devozionale degli adepti e dove era affermata la loro fede ed esaltata la loro speranza. Si trovano ora nel Museo di Napoli (cinque), nel Museo Britannico (due) e in quello di Creta (quattro). Una trattazione, sia pur breve, su l’orfismo non può prescindere dalla lettura di queste vetuste laminette, che hanno anche il pregio di essere documenti originali della fede orfica a noi consegnati quasi dalla mano stessa dei defunti. Vi si sente fremere un desiderio di purificazione, un anelito verso il meglio, una sete di vita divina, che non trova l’uguale nella esperienza religiosa dell’antichità classica e che è la fonte di quanto Eschilo, Pindaro, Platone tra i Greci; Cicerone e Virgilio tra i Latini hanno scritto ad esaltazione della speranza religiosa. Si legge nella laminetta proveniente dall’antica Petelia presso l’attuale Strongoli in Calabria, trovata nel 1834, ora nel Museo Britannico: “E tu troverai a sinistra della casa di Ade una fonte e ritto ivi presso un cipresso bianco; a questa fonte tu neppure ti accosterai da presso; un’altra ne troverai scorrente fresca acqua dal lago di Mnemosine; guardiani vi stanno dinanzi. Dirai: “Figlio di Gea son io o di Uranos stellato, e celeste è la mia stirpe, e ciò pur voi sapete. La sete mi arde e mi consuma; or voi datemi subito della fresca acqua scorrente dal lago dì Mnemosine”. Ed essi ti lasceranno bere alla fonte divina ed allora tu in seguito regnerai con gli altri eroi”. Questa laminetta è la più importante per la topografia dell’Ade orfico e per quella formola breve e recisa in cui è racchiusa la dottrina fondamentale dell’orfismo: emoi genoz ouranion “la mia stirpe è celeste”. Nella certezza di questa dottrina, che anche gli déi sanno, è riposto per l’Orfico il pegno della sua sorte futura. L’Orfico è di cielo ed al cielo deve tornare. Altre quattro laminette trovate in due tombe diverse presso l’antica Thurii (attuale Terranova di Sibari) nel 1879, ora nel Museo di Napoli, sono caratteristiche per nuovi elementi che offrono e che più efficacemente risalteranno dalla lettura. Delle quattro la prima scritta in verso e prosa è stata trovata nel timpone (o tomba a tumulo) grande di Thurii, e dice: “Ma quando l’anima ha abbandonato la luce del sole bisogna che vada da un tale, di sagace intelligenza, che osserva bene ogni cosa. Salve! Col sopportare questo patimento tu non più oltre hai patito, da uomo sei diventato dio: capretto caduto nel latte. Salve. Salve o tu che hai preso la via destra verso i sacri prati e i boschi di Persefone”. Quell’Uno di sagace intelligenza è Pluto il giudice dell’Ade; concetto nuovo nell’escatologia dei Greci per i quali l’Ade racchiude in una uguale vita incolore i buoni e i tristi, i valorosi e gl’inetti, Achille e Tersite. Mentre con gli Orfici si introduce la sanzione del bene e del male, che cambia l’orientamento morale della vita ed è indice di un elevamento della coscienza non solo individuale ma anche sociale. Il patimento che l’anima ha sopportato è il ciclo delle nascite, la legge ferrea della trasmigrazione, da cui la espiatrice vita orfica l’ha liberata. Ed è impressionante quel senso di sollievo, quel salve! ripetuto tre volte come un ebbro compiacimento per la sorte beata dell’anima ormai libera dal duro contatto col male e colle tenebre. Le altre laminette, a, b, c, trovate pure a Thurii ma nel timpone piccolo in una sepoltura unica di famiglia o di sodalizio, sono la copia di un medesimo originale, salvo, nella seconda e nella terza, un’affermazione capitale per la teologia orfica, e un maggiore sviluppo che la prima contiene sul volo dell’anima dopo rotto il cerchio fatale. La laminetta a: “Io, pura fra i puri, vengo a voi o regina degl’inferi o Eukles o Eubuleo, e voi altri dei immortali! Poiché io mi pregio di appartenere alla vostra stirpe beata. Ma la Moira e il balenare del fulmine mi abbattè inaridendomi. Ma io me ne volai via dal cerchio luttuoso e duro e con rapido piede raggiunsi la bramata corona, e discesi nel grembo della signora regina infernale. Felice e beatissimo te che da uomo divenisti dio. Capretto, io caddi nel latte”. Le laminette b e c: “Io pura fra i puri vengo a voi o regina degl’inferi, o Eukles, o Eubuleo, e tutti quanti altri siete déi e spiriti. Poiché io mi pregio di appartenere alla vostra stirpe beata. Ma la Moira e il balenare del fulmine mi abbatté inaridendomi. Questa punizione fu inflitta a causa di opere non giuste. Ora io supplichevole vengo innanzi alla santa Persefone affinché benigna mi mandi nelle sedi dei pii”. Queste tre laminette (a, b, c), di Thurii sono notevoli:
1° – per l’affermazione della purità che contraddistingue l’orfico, il quale da se stesso si chiama il puro che vive in una schiera di puri: “Io pura fra i puri vengo a voi ecc.”;
2° – per l’affermazione in b e c di quella ingiustizia, di quella colpa iniziale (che è il deicidio di Zagreo) di cui tutte le anime hanno pagato il fo subendo la fulgurazione di Zeus nella persona dei Titani e soffrendo nel corpo che le imprigiona una sete che le inaridisce;
3° – per lo slancio con cui l’anima spezza i lacci della sua prigionia e se ne vola a raggiunger la bramata corona, slancio paragonato con efficace similitudine al volo (exeptan) di un uccello liberato dalle reti;
4° – per la frase caratteristica: “Capretto, io son caduto nel latte” che si trova in a e che ricorda quella (formulata in seconda persona) del timpone grande di Thurii: “tu capretto sei caduto nel latte”. Questa frase significa non il ritorno dell’anima (il capretto) nella Via Lattea, cioè nel cielo; non un rito d’immersione dell’iniziato in un bagno di latte e nemmeno una semplice locuzione proverbiale nel senso che l’iniziato sia puro come un capretto lattante. Ma significa, conforme al meccanismo mistico dell’iniziazione, che l’iniziato assimilandosi al divino capretto che è Dioniso (il quale è difatto appellato erijoz nei cosiddetti inni orfici) è diventato un Dioniso anche lui: e che si è immerso nel latte, cibo del capretto nato di fresco, in quanto anche l’Orfico, attraverso l’iniziazione si è tuffato in una vita nuova e divina, fatta di quella purità di cui il candido latte, alimento di neonati e alimento di vegetariani doveva essere presso gli Orfici l’espressione più ovvia e più conveniente. Essa equivale a quest’altra: “Io nuovo Dioniso, ho raggiunto la vita divina”.
Il che è confermato dal fatto che la frase viene, nei due casi in cui è ricordata, subito dopo l’affermazione recisa: “da uomo sei diventato dio”, quasi fosse l’espressione trasparente della trasumanazione dell’Orfico, del suo assorbimento nel dio, del suo indiarsi attraverso l’iniziazione mistica. Altre tre laminette, tutte uguali, ora conservate nel Museo di Atene, sono state ritrovate nel 1893 presso Eleutherna in Creta, dove il culto di Zagreo aveva, come abbiamo accennato, una larga diffusione. Contengono tre soli versi che dovevano appartenere al medesimo carme apocalittico della laminetta di Petelia: “Ardo di sete e mi consumo. Or via, ch’io beva della fonte perenne, a destra, là dov’è il cipresso. Chi sei tu? donde sei? Figlio di Gea son io e di Uranòs stellato”. Questi versi nella loro brevità sono di una eloquenza impressionante. Quella sete che consuma l’anima non è più l’arsura materiale che tutti i primitivi attribuiscono ai defunti e a cui provvedono fornendo al cadavere orciuoli di acqua e pregando per il suo rinfrescamento o refrigerio, ma è la sete della beata immortalità che sì attinge alla fonte di Mnemosine, unico possibile refrigerio per chi sa di esser figlio del cielo stellato. E l’anelito a ricongiungersi al divino principio da cui è uscita e 1’accoramento, quasi, con cui implora l’acqua rinfrescante di immortalità, sono una prova efficacissima dell’elevazione mistica a cui l’orfismo poteva sollevare i suoi fedeli. Resta da menzionare l’ultima laminetta, che può rimontare al II secolo d.C., trovata in Roma sulla via Ostiense e pubblicata nel 1903, ora conservata nel Museo Britannico. Appartiene a una pia matrona romana, Cecilia Secondina, e rappresenta il primo caso in cui si trova il nome dell’iniziato, caso spiegabile però su terra di Roma, dove nemmeno la religione dimenticava tutte quelle norme e precauzioni giuridiche che servivano a individuare le persone e a fissare le cose, nei rapporti tra gli uomini e la divinità. Cecilia Secondina era ascritta a uno di quei sodalizi orfici che avevano continuato a vivere in Italia non ostante la severissima soppressione, ordinata dal Senato, dei Baccanali6 cioè del culto orgiastico di Dioniso, perché l’orfismo, come abbiamo più sopra accennato, si differenzia dalle celebrazioni dionisiache per una sua caratteristica tutta speciale di equilibrio religioso, di speculazione filosofica e di elevazione morale. Dice la laminetta di Cecilia Secondina: “Viene, pura fra i puri, a voi o regina degl’inferi, o Eukles, o Eubuleo, un’anima, nobile figlia di Zeus. Io Cecilia Secondina ho avuto da Mnemosine questo dono, tanto decantato tra gli uomini, perché ho sempre trascorso la vita nell’osservanza della Legge “. Si sente bene che si tratta qui di una Romana, che ha inquadrato il suo misticismo religioso entro una severa cornice etica. Non si leva a voli mistici Cecilia Secondina, non lamenta seti tormentose. Essa dichiara la sua prerogativa di “pura tra i puri”, cioè di orfica, vanta la sua stirpe divina ed afferma di aver avuto il dono di Mnemosine, cioè la beatitudine per aver sempre vissuto secondo la Legge, cioè secondo la disciplina orfica. Nel suo laconismo questa breve laminetta romana non è meno preziosa delle altre. Essa dimostra la persistenza dei sodalizi orfici in piena epoca imperiale, in ambiente completamente estraneo, sia come origine sia come tenore di vita, a quello in cui l’orfismo fiorì. Essa dimostra come questo ideale fosse ancor capace d’imprimere un nuovo orientamento alla vita e di farla trascorrere con l’austera gioia del dovere compiuto, sopra la via tracciata dalla Legge morale. La misteriosofia orfica ha avuto su terra greca prima, nell’ambiente ellenistico poi, delle ripercussioni religiose di prim’ordine. Essa ha innalzato l’anima religiosa dei Greci, ha nobilitato la visione morale della vita, ha irradiato dì luce beata le tenebre fino allora oscure dell’oltretomba, ha dato agli uomini la divina certezza di guardare in alto al cielo come a loro patria, ed ha suggerito loro i mezzi appropriati, la Legge, per camminare in purità di vita, conservando l’anima candida come la veste prescritta dal rituale. La sua influenza su le manifestazioni del pensiero e dell’arte è incalcolabile. Il più inebbriante dialogo platonico, il Fedone, è un dialogo orfico; la tragedia dell’ebbrezza divina in Euripide, le Baccanti, è una tragedia dionisiaca; quel famoso Sogno di Scipione, in cui Cicerone ha consegnato in momenti di sconforto il suo grido di speranza e d’immortalità, è un sogno orfico; il libro sesto di Vergilio, la cui lettura commosse Livia fino al deliquio, è stato scritto sotto l’ispirazione orfica. E se si considera quel fermento spesso incomposto e squilibrato d’idee che all’alba del cristianesimo dilagò in Oriente sotto il nome complesso di gnosticismo, si troverà ancor lì, giuntovi per mezzo della grande corrente neoplatonica, sia pur rafforzato da elementi dualisti iranici e da speculazioni astrali babilonesi che poi culmineranno nella strana religione manichea, quello che è il pensiero centrale dell’orfismo: che l’uomo è un miscuglio di bene e di male, che l’anima è un raggio di luce divina nelle tenebre della materia e che tutto il dovere dell’uomo consiste nel procurarsi la gnosi, la dottrina vera che gli insegna insieme la realtà di questa sua situazione e gli addita la via della liberazione.
Gli elementi di questo pensiero – che come intuizione oscura non è estraneo alla mentalità popolare di ogni tempo, per poco che consideri la tristezza della sua realtà e la paragoni con il fulgore del suo sogno – sono suggeriti già dal culto orgiastico di Dioniso il quale, sollevando le anime durante l’ebbrezza mistica a uno stato sopranormale, dette loro la sensazione viva di una vita divina, più gaudiosa di quella ordinaria, che l’anima può vivere in quei momenti speciali. Il grande movimento orfico, sorto in un’epoca in cui gli spiriti migliori sentivano il bisogno di uscire dalla distretta dolorosa di un mondo in convulsione, assorbì il mistero dionisiaco e ne fece la piattaforma del suo sistema teologico, la fonte dispensatrice dei suoi carismi religiosi. La Grecia non ci ha dato nulla di più alto in materia di esperienza religioso-mistica.
N. Turchi
NOTE:
1 – L’etimologia stessa del nome è assai incerta. Il Kern ha recentemente accettato quella che lo ricollega con orjanoz (lat. orbus) nel senso di solitario, il che quadra con la sua concezione degli Orfici come di gente, in un primo tempo, solitaria, appartata e poi strettasi nelle note conventicole orfiche. Data la parte larghissima che le preoccupazioni ultramondane hanno nell’orfismo, il nome di Orfeo può riconnettersi, secondo un’etimologia suggerita già da G. Curtius, a quello di ereboz (rad. orj = tenebre) in relazione all’oscurità dell’Ade: si hanno di fatti: Orphos dio del mondo infero, Orphne ninfa del lago Averno, Orphnaios cavallo di Plutone. Orfeo infatti secondo il mito scende nell’Ade, donde cerca di trarre fuori Euridice, divinità anch’essa del mondo infero. Assai più strana è l’etimologia proposta recentemente da R. EISLER, Orpheus, the Fisher, London, 1921, il quale poiché i pesci nel santuario di Apollo in Licia erano detti drjoi fa di Orfeo il “pescatore”.
2 – Zagreo infatti è giusta l’Etym. Gud. 227, 37 il gran cacciatore (di anime) che travolge ogni cosa: divinità ctonica e perciò considerata come figlio di Persefone.
3 – Olympiod. ad Phaed. p. 68 [45]; Procli ad Remp. f. 55 v. [44]. Secondo Pausania 8, 37, 5, [38] Onomacrito – il quale era stato il primo ad introdurre in Atene, a tempo di Pisistrato, il culto segreto di Dioniso – fu quegli che introdusse i Titani nel mito di Zagreo.
4 – Anche Pitagora professa la medesima dottrina. Ma conviene rilevare che non è stato Pitagora a parteciparla agli Orfici, ma che l’uno e gli altri l’hanno attinta alla stessa mentalità popolare. Se mai, Pitagora è tributario dell’orfismo posto che Diogene Laerzio [1, 119] lo fa discepolo di Ferecide di Siro. Orfismo e pitagorismo sono due aspetti della medesima tendenza religiosa: più entusiasta, visionario, individualista, democratico, lirico, l’orfismo; più ponderato, dotto, disciplinato, aristocratico, scientifico, il pitagorismo. Distrutto l’organismo politico creato nella Magna Grecia con centro a Crotone, la parte scientifica del pitagorismo rimase in eredità alle scuole filosofiche e quella morale all’orfismo. Cfr. DELATTE, Essai sur la politique pythagoricienne, Paris 1922.
5 – Il modo di sepoltura prescelto dagli Orfici, quale almeno si può studiare nella necropoli di Thurii (Terranova di Sibari) attesta anch’esso il nuovo orientamento di pensiero e di vita portato da questa religione. Gli Orfici seguivano indifferentemente il rito della inumazione (timpone piccolo) o della cremazione (timpone grande), ponevano il cadavere o i resti inceneriti sotterra ricoperti da un bianco lenzuolo tra massicci blocchi di tufo. Presso il capo o vicino alla mano destra collocavano le preziose laminette. Del resto non lusso di marmi, non ricordo di nomi. I loro sepolcri in cui più persone della stessa famiglia o dello stesso sodalizio potevano essere sepolti (ma non estranei alla fede orfica, conforme alla prescrizione contenuta in una iscrizione cimiteriale cumana illustrata dal Comparetti, Laminette p. 47 ss. “ou temiz entouqa ceisqai ei mh ton bebacceumenon : Non è lecito seppellire qui chi non sia iniziato a Dioniso”) sono venuti crescendo in forma di tumuli emergenti sul piano di campagna a causa dei detriti di celebrazioni funerarie compiute sopra di essi. Donde il nome caratteristico, che tuttora essi conservano, di timponi (da tumboz, tumulo funebre). Vedine la particolareggiata descrizione in CAVALLARI, Not. Scavi, 1879 p. 80 ss. riprodotta in COMPARETTI, Laminette p. 5 ss.
6 – Le circostanze che indussero il Senato alla soppressione del culto di Dioniso sono lungamente narrate da Tito Livio, 39, 14-19 [32] da cui si rileva il carattere orgiastico tutto proprio di quei misteri. Il Senatusconsulto, che Livio riassume, ci è conservato da una tavola di bronzo, ora a Vienna, destinata all’”Agro Teurano” e ritrovata nel 1640 presso Catanzaro [31]. Le disposizioni ne erano severissime: potevano sussistere congregazioni dionisiache, là dove un decreto del pretore urbano le avesse permesse, previa autorizzazione del Senato, purché non comprendessero più di cinque membri di cui due uomini e tre donne. Secondo S. REINACH, Une ordalie par le poison à Rome et l’affaire des Bacchanales in “Cultes, Mythes et Religions” III, 244 ss., l’episodio va spiegato come una misura di repressione politica in quanto il Senato vincitore dei Cartaginesi e dei Cisalpini temeva una coalizione del mondo ellenico (Macedonia e Siria) che avrebbe potuto trovare nell’Italia meridionale un aiuto assai efficace.
G. DE SANCTIS, Storia dei Romani vol. IV, I, Torino, 1923, p. 599 approva la giustificata diffidenza del Reinach circa la credibilità del racconto liviano ed attribuisce la esagerata repressione al prevalere delle tendenze conservative, dopo la decadenza del predominio degli Scipioni.
PITAGORICI
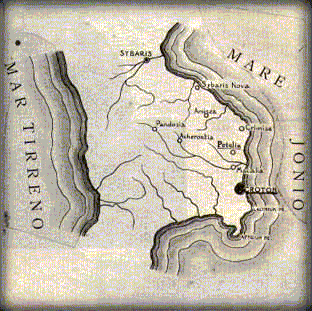 Con i Pitagorici ci troviamo per la prima volta di fronte ad un’autentica scuola filosofica, sebbene molto arcaica e rudimentale. Siamo in pieno VI secolo a.C. e la scuola filosofica assume il carattere di scuola mistica: i contenuti si rispecchiano infatti parzialmente nella setta degli Orfici, mentre le pratiche sono assolutamente uguali: basti pensare che per entrare a far parte della scuola bisognava essere sottoposti ad un rito di iniziazione Sicchè, più che di una scuola, si tratta di una comunità filosofica, religiosa e politica (in certo senso si può anche parlare di “setta” religiosa) i cui membri conducevano vita comune e venivano iniziati. Tutti i pensatori che lavorarono in questa scuola vengono generalmente chiamati Pitagorici, dal nome del loro maestro Pitagora. Oltre a segnare il passaggio di secolo, Pitagora e la sua scuola segnano anche il passaggio della filosofia dalla Grecia e dalle zone della Ionia alla Magna Grecia. Cerchiamo di analizzare le vicende di Pitagora, benché la sua figura sia avvolta da un’aura di mistero: egli nacque a Samo e vi restò finchè non sali al potere un tiranno – Policrate di Samo – sfavorevole all’aristocrazia, nella quale Pitagora si identificava pienamente. Quello di Policrate non è un caso isolato: tutto il V secolo in Grecia (e non solo) è infatti una fase di passaggio da aristocrazia a democrazia (i tiranni infatti erano appoggiati dal popolo). Così Pitagora si vide costretto a fuggire esule a Crotone, nell’attuale Calabria. Ed è qui che egli fondò la scuola, la quale incontrò ben presto un irresistibile successo presso i ceti aristocratici ed i Pitagorici acquisirono un peso determinante nella vita politica di Crotone e delle località limitrofe. Nella scuola l’insegnamento, originariamente, non era affidato allo scritto, ma era impartito oralmente. Inoltre, entrare a far parte della scuola era molto difficile e quando si entrava non vi era la libertà di agire a piacimento: per un po’ di tempo si era, per così dire, Pitagorici “in prova”, acusmatici, ossia ascoltatori di precetti che venivano impartiti senza che venisse mostrato il perchè: gli acusmatici di loro non dicevano nulla, ma si limitavano ad imparare i precetti dei Pitagorici già maturi. Interessante è il modo di definizione pitagorico: se ad esempio veniva loro chiesto che cosa fosse bello, rispondevano dicendo la cosa più bella. Era come se trasformassero la domanda “che cosa è bello?” in “quale è la cosa più bella?”. E’ interessante notare che Aristotele (Metafisica, I), quando ci parla dei vari filosofi che l’hanno preceduto, lo fa singolarmente, ma nel caso dei Pitagorici descrive collettivamente: la scuola stessa era caratterizzata da una vita collettiva (con tanto di comunione dei beni), religiosa e politica, in cui i legami interni erano fortissimi. A Pitagora fu attribuita la valenza di profeta e la sua figura sfumò presto nella leggenda. Le dottrine della scuola erano segrete e anche dopo la morte di Pitagora continuarono ad essere a lui attribuite le variazioni e le evoluzioni, immaginando che parlasse tramite la divinità: da qui nacque la famosa espressione ipse dixit (“l’ha detto lui in persona”), con la quale si indicava che ogni elaborazione non era altro che uno sviluppo delle dottrine del maestro Pitagora. Proprio per questo non sappiamo se il celebre teorema di Pitagora sia effettivamente suo o di qualcun altro a lui vicino. Tutto però ebbe fine quando nel 510 circa vi fu una rivolta democratica a Crotone che portò alla distruzione della scuola, che era di schieramento aristocratico. La tradizione narra che l’ opposizione democratica crotoniate, guidata da un certo Cilone, assalì i Pitagorici nella loro sede e ne fece morire un gran numero nelle fiamme. Sembra poi che il Pitagorismo abbia perfino influenzato le civiltà “barbare” e che il re Numa Pompilio sia stato un pitagorico, ma molto probabilmente si tratta semplicemente di leggende. Si dice spesso che i Pitagorici fossero anti-femministi, aspetto che per altro era caratteristico dell’intera società greca ma probabilmente non è corretto: basti pensare che nella scuola le donne erano accettate. Entriamo ora nell’ambito delle dottrine pitagoriche: tratto saliente dei Pitagorici è il marcato ascetismo a cui essi fanno capo: la pratica di non mangiare carni (la commedia greca ce li rappresenta ironicamente come dei morti di fame) e la credenza (di marca orfica) nella trasmigrazione delle anime e nelle loro espiazioni di colpe sono i pilastri della vita pitagorica; con loro prende via la tradizione del corpo come tomba dell’anima destinata – attraverso Platone prima e attraverso il cristianesimo dopo a segnare in maniera indelebile la cultura occidentale. La cosa curiosa è che Pitagora ci è presentato come politico, come etico, come fisico e come matematico: insomma, come una figura a trecentosessanta gradi. Nel primo libro della Metafisica, Aristotele attribuisce ai Pitagorici la dottrina per cui i numeri costituiscono l’essenza di tutte le cose, tant’è che per lo Stagirita essi rientrano tra i primi indagatori della natura, sebbene non rinvengano Ι’αρχη in un unico principio, ma in una miriade di principi (i numeri); il che fa di loro non già dei monisti, bensì dei pluralisti. Tuttavia non è chiaro a quali Pitagorici faccia riferimento Aristotele (a quelli originari o a quelli a lui contemporanei?): pare difficile che egli alluda ai primi, anche perché la tradizione attesta che il nucleo originario dei loro insegnamenti fosse rigorosamente impartito per via orale e, come se ciò non bastasse, i destinatari erano tenuti al silenzio; solo più tardi, con Filolao di Crotone e Archita (IV secolo a.C. quasi), i Pitagorici mettono per iscritto le loro dottrine ed è dunque presumibile che ad essi alluda Aristotele. Due risultano essere le più importanti dottrine formulate dal Pitagorismo. La prima è quella della trasmigrazione delle anime, di derivazione orfica: l’Orfismo trovò fertile terreno di sviluppo nell’Italia Meridionale e senz’altro sostenne la dottrina della trasmigrazione delle anima prima dei Pitagorici. Sembra quindi che Pitagorismo e Orfismo siano la stessa cosa, ma non è così. L’Orfismo è di carattere maggiormente religioso, il Pitagorismo è più filosofico. Ma vi è poi un’altra grande differenza, che consiste nei mezzi con cui si può raggiungere il fine (la purificazione): per gli Orfici occorreva compiere riti e vivere in modo giusto, per i Pitagorici bisognava si vivere in modo giusto e compiere riti, ma anche (e soprattutto) conoscere i numeri, che stanno alla base della dottrina pitagorica. La seconda grande dottrina pitagorica è appunto quella dei numeri, che è legata, come abbiamo visto, alla precedente. I Pitagorici furono dunque i primi greci ad occuparsi in maniera sistematica della matematica. Essi Ritenevano che i principi della matematica fossero anche i principi dell’intera realtà. Notarono infatti che la matematica aveva tutti i principi adatti per essere presa come principio dell’intera realtà. Essa non è un’opinione e Aristotele stesso dirà che gli oggetti di studio della matematica sono permanenti ed immutabili. Se ad esempio prendiamo la musica, gli accordi non sono nient’altro che rapporti matematici. Proprio partendo da questo esempio, che è il più evidente, estesero le loro dottrine all’intera realtà, così come aveva fatto Talete con il magnete. Così come Talete aveva notato che tutte (o quasi) le cose sono caratterizzate dall’acqua, i Pitagorici notarono che tutte le cose sono caratterizzate dalla misurabilità, vale a dire che si possono misurare. Chiaramente questo segnò un grandissimo passo avanti verso l’astrazione. Bisogna senz’altro riconoscere un merito ai Pitagorici: per loro infatti la fisica è spiegabile tramite la matematica. Il loro rapporto con la matematica non è puramente metodologico, come è per noi, ma anche ontologico: non si tratta per loro di studiare solo i numeri, ma anche la realtà, servendosi dei numeri. Nonostante i Pitagorici abbiano avuto la grande intuizione di applicare la matematica per indagare la realtà, non se ne sono serviti poi molto. Il motivo di questo loro limite è dovuto in gran parte alla mancanza di strumenti concettuali e materiali. Non potendo fare della matematica un uso effettivo, essi finirono per provare a cogliere delle somiglianze tra le caratteristiche dei numeri e quelle della realtà. Per esempio, arrivarono a dire che il numero due corrispondeva al genere femminile, il tre al maschile, il cinque al matrimonio (3+2 = 5). Il quattro ed il nove corrispondevano invece alla giustizia in quanto erano i primi numeri quadrati e suggeriscono l’idea di ordine. Nel tempo stesso va detto che la speculazione numerica pitagorica non può non essere stata influenzata dall’ osservazione dei fenomeni astronomici: dagli astri essi debbono aver tratto le loro prime idee dei numeri aventi posizione, cioè fissati come punti nello spazio, degli aggruppamenti numerici formanti figure geometriche definite e costanti, della ricorrenza di alcuni numeri nei fenomeni celesti. In altre parole, il numero viene elevato a principio universale di interpretazione, via via che é esteso dall’ ordine aritmetico a quello geometrico e, finalmente, all’ ordine fisico. Così, espressione spaziale dell’ uno é il punto; della linea, limitata da due punti, il due; della superficie il tre; del solido il quattro. E’ Aristotele che attribuisce ai Pitagorici la dottrina secondo la quale i numeri costituiscono l’essenza di tutte le cose. Per comprendere meglio il significato di essa, è necessario tenere conto del modo in cui erano abitualmente compiute le operazioni di calcolo. I Greci si servivano dei ψεφοι, ossia di pietruzze mediante le quali i vari numeri erano rappresentati visivamente. Con questi numeri figurati è possibile costruire serie, per esempio quella dei numeri quadrati.
Con i Pitagorici ci troviamo per la prima volta di fronte ad un’autentica scuola filosofica, sebbene molto arcaica e rudimentale. Siamo in pieno VI secolo a.C. e la scuola filosofica assume il carattere di scuola mistica: i contenuti si rispecchiano infatti parzialmente nella setta degli Orfici, mentre le pratiche sono assolutamente uguali: basti pensare che per entrare a far parte della scuola bisognava essere sottoposti ad un rito di iniziazione Sicchè, più che di una scuola, si tratta di una comunità filosofica, religiosa e politica (in certo senso si può anche parlare di “setta” religiosa) i cui membri conducevano vita comune e venivano iniziati. Tutti i pensatori che lavorarono in questa scuola vengono generalmente chiamati Pitagorici, dal nome del loro maestro Pitagora. Oltre a segnare il passaggio di secolo, Pitagora e la sua scuola segnano anche il passaggio della filosofia dalla Grecia e dalle zone della Ionia alla Magna Grecia. Cerchiamo di analizzare le vicende di Pitagora, benché la sua figura sia avvolta da un’aura di mistero: egli nacque a Samo e vi restò finchè non sali al potere un tiranno – Policrate di Samo – sfavorevole all’aristocrazia, nella quale Pitagora si identificava pienamente. Quello di Policrate non è un caso isolato: tutto il V secolo in Grecia (e non solo) è infatti una fase di passaggio da aristocrazia a democrazia (i tiranni infatti erano appoggiati dal popolo). Così Pitagora si vide costretto a fuggire esule a Crotone, nell’attuale Calabria. Ed è qui che egli fondò la scuola, la quale incontrò ben presto un irresistibile successo presso i ceti aristocratici ed i Pitagorici acquisirono un peso determinante nella vita politica di Crotone e delle località limitrofe. Nella scuola l’insegnamento, originariamente, non era affidato allo scritto, ma era impartito oralmente. Inoltre, entrare a far parte della scuola era molto difficile e quando si entrava non vi era la libertà di agire a piacimento: per un po’ di tempo si era, per così dire, Pitagorici “in prova”, acusmatici, ossia ascoltatori di precetti che venivano impartiti senza che venisse mostrato il perchè: gli acusmatici di loro non dicevano nulla, ma si limitavano ad imparare i precetti dei Pitagorici già maturi. Interessante è il modo di definizione pitagorico: se ad esempio veniva loro chiesto che cosa fosse bello, rispondevano dicendo la cosa più bella. Era come se trasformassero la domanda “che cosa è bello?” in “quale è la cosa più bella?”. E’ interessante notare che Aristotele (Metafisica, I), quando ci parla dei vari filosofi che l’hanno preceduto, lo fa singolarmente, ma nel caso dei Pitagorici descrive collettivamente: la scuola stessa era caratterizzata da una vita collettiva (con tanto di comunione dei beni), religiosa e politica, in cui i legami interni erano fortissimi. A Pitagora fu attribuita la valenza di profeta e la sua figura sfumò presto nella leggenda. Le dottrine della scuola erano segrete e anche dopo la morte di Pitagora continuarono ad essere a lui attribuite le variazioni e le evoluzioni, immaginando che parlasse tramite la divinità: da qui nacque la famosa espressione ipse dixit (“l’ha detto lui in persona”), con la quale si indicava che ogni elaborazione non era altro che uno sviluppo delle dottrine del maestro Pitagora. Proprio per questo non sappiamo se il celebre teorema di Pitagora sia effettivamente suo o di qualcun altro a lui vicino. Tutto però ebbe fine quando nel 510 circa vi fu una rivolta democratica a Crotone che portò alla distruzione della scuola, che era di schieramento aristocratico. La tradizione narra che l’ opposizione democratica crotoniate, guidata da un certo Cilone, assalì i Pitagorici nella loro sede e ne fece morire un gran numero nelle fiamme. Sembra poi che il Pitagorismo abbia perfino influenzato le civiltà “barbare” e che il re Numa Pompilio sia stato un pitagorico, ma molto probabilmente si tratta semplicemente di leggende. Si dice spesso che i Pitagorici fossero anti-femministi, aspetto che per altro era caratteristico dell’intera società greca ma probabilmente non è corretto: basti pensare che nella scuola le donne erano accettate. Entriamo ora nell’ambito delle dottrine pitagoriche: tratto saliente dei Pitagorici è il marcato ascetismo a cui essi fanno capo: la pratica di non mangiare carni (la commedia greca ce li rappresenta ironicamente come dei morti di fame) e la credenza (di marca orfica) nella trasmigrazione delle anime e nelle loro espiazioni di colpe sono i pilastri della vita pitagorica; con loro prende via la tradizione del corpo come tomba dell’anima destinata – attraverso Platone prima e attraverso il cristianesimo dopo a segnare in maniera indelebile la cultura occidentale. La cosa curiosa è che Pitagora ci è presentato come politico, come etico, come fisico e come matematico: insomma, come una figura a trecentosessanta gradi. Nel primo libro della Metafisica, Aristotele attribuisce ai Pitagorici la dottrina per cui i numeri costituiscono l’essenza di tutte le cose, tant’è che per lo Stagirita essi rientrano tra i primi indagatori della natura, sebbene non rinvengano Ι’αρχη in un unico principio, ma in una miriade di principi (i numeri); il che fa di loro non già dei monisti, bensì dei pluralisti. Tuttavia non è chiaro a quali Pitagorici faccia riferimento Aristotele (a quelli originari o a quelli a lui contemporanei?): pare difficile che egli alluda ai primi, anche perché la tradizione attesta che il nucleo originario dei loro insegnamenti fosse rigorosamente impartito per via orale e, come se ciò non bastasse, i destinatari erano tenuti al silenzio; solo più tardi, con Filolao di Crotone e Archita (IV secolo a.C. quasi), i Pitagorici mettono per iscritto le loro dottrine ed è dunque presumibile che ad essi alluda Aristotele. Due risultano essere le più importanti dottrine formulate dal Pitagorismo. La prima è quella della trasmigrazione delle anime, di derivazione orfica: l’Orfismo trovò fertile terreno di sviluppo nell’Italia Meridionale e senz’altro sostenne la dottrina della trasmigrazione delle anima prima dei Pitagorici. Sembra quindi che Pitagorismo e Orfismo siano la stessa cosa, ma non è così. L’Orfismo è di carattere maggiormente religioso, il Pitagorismo è più filosofico. Ma vi è poi un’altra grande differenza, che consiste nei mezzi con cui si può raggiungere il fine (la purificazione): per gli Orfici occorreva compiere riti e vivere in modo giusto, per i Pitagorici bisognava si vivere in modo giusto e compiere riti, ma anche (e soprattutto) conoscere i numeri, che stanno alla base della dottrina pitagorica. La seconda grande dottrina pitagorica è appunto quella dei numeri, che è legata, come abbiamo visto, alla precedente. I Pitagorici furono dunque i primi greci ad occuparsi in maniera sistematica della matematica. Essi Ritenevano che i principi della matematica fossero anche i principi dell’intera realtà. Notarono infatti che la matematica aveva tutti i principi adatti per essere presa come principio dell’intera realtà. Essa non è un’opinione e Aristotele stesso dirà che gli oggetti di studio della matematica sono permanenti ed immutabili. Se ad esempio prendiamo la musica, gli accordi non sono nient’altro che rapporti matematici. Proprio partendo da questo esempio, che è il più evidente, estesero le loro dottrine all’intera realtà, così come aveva fatto Talete con il magnete. Così come Talete aveva notato che tutte (o quasi) le cose sono caratterizzate dall’acqua, i Pitagorici notarono che tutte le cose sono caratterizzate dalla misurabilità, vale a dire che si possono misurare. Chiaramente questo segnò un grandissimo passo avanti verso l’astrazione. Bisogna senz’altro riconoscere un merito ai Pitagorici: per loro infatti la fisica è spiegabile tramite la matematica. Il loro rapporto con la matematica non è puramente metodologico, come è per noi, ma anche ontologico: non si tratta per loro di studiare solo i numeri, ma anche la realtà, servendosi dei numeri. Nonostante i Pitagorici abbiano avuto la grande intuizione di applicare la matematica per indagare la realtà, non se ne sono serviti poi molto. Il motivo di questo loro limite è dovuto in gran parte alla mancanza di strumenti concettuali e materiali. Non potendo fare della matematica un uso effettivo, essi finirono per provare a cogliere delle somiglianze tra le caratteristiche dei numeri e quelle della realtà. Per esempio, arrivarono a dire che il numero due corrispondeva al genere femminile, il tre al maschile, il cinque al matrimonio (3+2 = 5). Il quattro ed il nove corrispondevano invece alla giustizia in quanto erano i primi numeri quadrati e suggeriscono l’idea di ordine. Nel tempo stesso va detto che la speculazione numerica pitagorica non può non essere stata influenzata dall’ osservazione dei fenomeni astronomici: dagli astri essi debbono aver tratto le loro prime idee dei numeri aventi posizione, cioè fissati come punti nello spazio, degli aggruppamenti numerici formanti figure geometriche definite e costanti, della ricorrenza di alcuni numeri nei fenomeni celesti. In altre parole, il numero viene elevato a principio universale di interpretazione, via via che é esteso dall’ ordine aritmetico a quello geometrico e, finalmente, all’ ordine fisico. Così, espressione spaziale dell’ uno é il punto; della linea, limitata da due punti, il due; della superficie il tre; del solido il quattro. E’ Aristotele che attribuisce ai Pitagorici la dottrina secondo la quale i numeri costituiscono l’essenza di tutte le cose. Per comprendere meglio il significato di essa, è necessario tenere conto del modo in cui erano abitualmente compiute le operazioni di calcolo. I Greci si servivano dei ψεφοι, ossia di pietruzze mediante le quali i vari numeri erano rappresentati visivamente. Con questi numeri figurati è possibile costruire serie, per esempio quella dei numeri quadrati.
Infatti partendo dal primo numero quadrato, 4 (2×2), essenza della giustizia, raffigurato con quattro punti

applicando lo gnomone, ossia una specie di squadra, si può ottenere il numero quadrato successivo 9 (3×3), anch’esso essenza della giustizia, in questo modo

e poi

ossia 16, il quadrato di quattro e così via con i numeri successivi. Da notare che i Pitagorici non conoscevano lo zero ed è anche facile capire il perchè: con le pietruzze è impossibile rappresentarlo. Questo fatto contribuisce a conferire all’uno uno statuto particolare: è un’entità indivisibile, rispetto alla quale nulla è antecedente. Più che un numero come gli altri, l’uno è la sorgente da cui nascono tutti gli altri numeri. Questi a loro volta si suddividono in pari e dispari, che i Pitagorici identificavano con l’illimitato ed il limite. L’uno veniva chiamato parimpari, in quanto aggiunto ad un dispari genera un pari ed aggiunto ad un pari genera un dispari: ciò significa che l’uno deve contenere in sè sia il pari sia il dispari. Il dispari, a sua volta, diviso in due lascia sempre come resto un’unità che permane come limite, mentre ciò non avviene nel caso del pari, che è pertanto identificato con l’illimitato, l’infinito, che con i Pitagorici diventa un concetto fortemente negativo e così sarà per tantissimo tempo. Mediante il calcolo con i sassolini i Pitagorici dimostrano visivamente alcune proprietà relative a queste classi di numeri: per esempio che pari più pari dia pari, che dispari più dispari dia pari e così via. Di grande simpatia godeva anche il 10, che rappresentava tutti gli altri insieme:. Inoltre esso era una sorta di compendio dell’intero universo ed è rappresentabile sotto la forma chiamata τετρακτύς (letteralmente significa “gruppo di quattro”).

Infatti, la “tetrattide” (tetraktuV) compendiante in sé l’universo (l’1 è il punto, il 2 la linea, il 3 la superficie, il 4 il solido:
1+2+3+4=10). La tetrattide rappresenta quindi la successione delle tre dimensioni che caratterizzano l’universo fisico. Queste considerazioni mostrano come per i Pitagorici ciascun numero è dotato di una propria individualità e pertanto non tutti i numeri si equivalgono come importanza (sembra che l’aristocrazia dei Pitagorici coinvolga addirittura i numeri). I numeri costituiscono una gerarchia di valore e alcuni numeri assurgono a simboli di altre entità, fisiche o concettuali: è il caso della giustizia, rappresentata dal 4 e dal 9. E visivamente il quadrato è rappresentato come la figura avente i lati uguali. Questa trama di corrispondenze simboliche tra numeri e cose è chiamata dai moderni “mistica del numero”. E’ la conoscenza di questo complesso universo di relazioni tra numeri e cose che costituiva per i Pitagorici il vertice dell’apprendimento. Tra i numeri esistono λογοι, ossia rapporti e tra i rapporti è possibile rintracciare una proporzione (in greco αναλογια), ossia uguaglianze di rapporti. Soprattutto Archita sembra essersi dedicato allo studio di esse. I rapporti e le proporzioni si manifestano soprattutto nell’ambito musicale, dove è centrale la nozione di armonia. Poichè anche i corpi celesti compiono con i loro movimenti percorsi regolari, esprimibili numericamente, i Pitagorici giungono a sostenere l’esistenza di un’armonia delle sfere celesti, non afferrabile dall’ occhio umano. Il cosmo (la parola greca κοσμος significa ordine) dei Pitagorici è costituito infatti da un fuoco centrale, paragonato al focolare di una casa, intorno al quale ruotano la terra, la luna, il sole, i cinque pianeti allora conosciuti, ed il cosiddetto cielo delle stelle fisse. Forse per contemplare la serie fino a raggiungere il 10, i Pitagorici aggiungono anche l’antiterra, situata tra il fuoco centrale e la terra. L’aspetto più interessante della cosmologia pitagorica è che per la prima volta nella storia – la terra non viene vista come centro dell’universo. Ma numero e proporzione dominano non solo su questa scala cosmica, ma anche all’interno del mondo umano. Essi sono all’occhio dei Pitagorici lo strumento fondamentale per far cessare la discordia tra gli uomini e instaurare l’armonia tra essi, nei loro rapporti economici e politici, attribuendo a ciascuno secondo la proporzione geometrica ciò che gli è dovuto in rapporto al suo valore e non a tutti lo stesso. Risalta anche qui l’orientamento aristocratico dei Pitagorici, contro i quali tuonerà Eraclito: per lui infatti il rapporto tra gli opposti non deve essere di armonia, ma di lotta, di tensione. Per i Pitagorici invece per avere armonia ci deve essere annullamento tra gli opposti. Tra i Pitagorici va senz’altro ricordato Filolao, che compose uno scritto in dialetto dorico (che secondo la tradizione sarebbe stato comprato da Platone stesso). Della sua opera ci sono rimasti alcuni frammenti dove è annunciata in maniera assertoria la tesi che il cosmo è composto di elementi illimitati e limitanti. Ritornando alle dottrine pitagoriche, come i movimenti celesti sono eterni, perchè in essi, per la loro circolarità, il principio e la fine si ricongiungono, così anche l’anima, a differenza del corpo, ha una serie di ritorni periodici. Del ritorno periodico di tutte le cose, diceva il pitagorico Eudemo che, data l’identità del moto e la costanza delle successioni, tutti gli eventi si riprodurranno in un tempo prefisso: “così anch’ io tornerò a parlare, tenendo questo bastoncino in mano, a voi seduti come ora; e tutto il resto si comporterà ugualmente”. S VERSI AUREI I “versi aurei” costituiscono l’essenza dell’insegnamento Pitagorico; essi non sono direttamente riferibili al filosofo, ma costituiscono una “summa” dei dogmi della “scuola italica”, messa per iscritto dai Pitagorici che seguirono la via del maestro dopo la morte di quest’ultimo, per istruire coloro che sarebbero venuti dopo di loro. Questi principi erano l’unico strumento che consentiva agli adepti di seguire la via divina e di elevare lo spirito, essenza suprema di ciascun individuo, fino al raggiungimento dell’ “estinzione delle sofferenze terrene” per mezzo dell’unione tra lo spirito “individuale” dell’iniziato e Dio, concepito come unica fonte creatrice del tutto.
Venera innanzitutto gli Dei immortali e serba il giuramento; onora poi i radiosi eroi divinificati e ai demoni sotterranei offri secondo il rito; onora anche i genitori e a te chi per sangue sia più vicino; degli altri, fatti amico chi per virtù è il migliore, imitandolo nel parlare con calma e nelle azioni utili. Non adirarti con un amico per una sua colpa lieve, sinchè tu lo possa; approfondisci lo studio di queste cose e queste altre domina: il ventre anzitutto e così pure sonno, sesso e collera; non far cosa che sia turpe in faccia ad altri o a te stesso, ma, soprattutto, rispetta te stesso; poi, esercita la giustizia con le opere e la parola; in ogni cosa, di agir senza riflettere perdi l’abitudine; considera che per tutti è destino morire; delle ricchezze e degli onori accetta ora il venire, ora il dipartirsi;
di quei mali, che per demoniaco destino toccano ai mortali, con animo calmo, senz’ira sopporta la tua parte pur alleviandoli, per quanto ti è dato: e ricordati che non estremi sono quelli riservati dalla Moira al saggio;
il parlare degli uomini può essere buono o cattivo; che esso non ti turbi, non permettere che ti distolga. E se mai venisse detta falsità, ad essa calmo opponiti.
ELENCO DEI PITAGORICI
Quella dei Pitagorici (seconda metà del VI secolo a.C. inizi del III secolo d.C.) costituisce indubbiamente una delle sette più numerose che vanti la filosofia antica, con una storia che si protrae per più di otto secoli. Giamblico conclude la sua celebre Vita Pitagorica con un imponente catalogo di ben 218 uomini e 17 donne, precisando altresì che di molti si sono persi nome e memoria. Ecco le notizie forniteci da Giamblico sugli scolarchi.
1. Pitagora di Samo.
2. Aristeo di Crotone, “di circa sette generazioni più vecchio di Platone” (riferisce sempre Giamblico), il quale assunse, già vecchio, per volere dello stesso Pitagora, la direzione della scuola.
3. Mnesarco, figlio di Pitagora.
4. Bulagora, sotto il cui scolarcato avvenne il sacco di Crotone.
5. Gartida di Crotone, successore di Bulagora.
6. Aresa che, salvatosi, riprese, dopo qualche tempo, la direzione della scuola.
A quest’epoca dovette verificarsi una crisi della scuola, se lo stesso Giamblico rileva che Diodoro d’Aspendo (7) fu accolto nella scuola “per la penuria di Pitagorici regolari”. Tornato in Grecia, poi, Diodoro divulgò le dottrine pitagoriche.
Alla composizione di opere scritte – come sempre Giamblico annota – si dedicarono:
– Clinia di Taranto (8) e Filolao di Taranto (9), nel territorio di Eraclea;
– Teoride (10) ed Eurito (11), a Metaponto;
– Archita di Taranto (12) a Taranto;
– Epicarmo (13), invece, fu membro esterno della scuola.
Ed ecco il celebre catalogo di Giamblico:
Di Crotone: Ippostrato, Dimante, Egone, Emone, Sillo, Cleostene, Agela, Episilo, Ficiada, Ecfanto, Timeo, Buto, Erato, Itaneo, Rodippo, Briante, Evandro, Millia, Antimedonte, Agea, Leofrone, Agilo, Onata, Ippostene, Cleofrone, Alcmeone, Damocle, Milone, Menone.
Di Metaponto: Brontino, Parmisco, Orestada, Leone, Damarmeno, Enea, Chilante, Melesia, Aristea, Lafaone, Evandro, Agesidamo, Senocade, Eurifemo, Aristomene, Agesarco, Alcia, Senofante, Trasea, Eurito, Epifrone, Irisco, Megistia, Leocide, Trasimede, Eufemo, Procle, Antimene, Lacrito, Damotage, Pirrone, Ressibio, Alopeco, Astilo, Lacida, Antioco, Lacrale, Glicino.
Di Agrigento: Empedocle.
Di Elea: Parmenide.
Di Taranto: Filolao, Eurito, Archita, Teodoro, Aristippo, Licone, Estio, Polemarco, Astea, Cenia, Cleone, Eurimedonte, Arcea, Clinagora, Archippo, Zopiro, Eutino, Dicearco, Filonide, Frontida, Liside, Lisibio, Dinocrate, Echecrate, Pactione, Acusilada, Icco, Pisicrate, Clearato, Leonteo, Frinico, Simichia, Aristoclida, Clinia, Abrotele, Pisirrodo, Briante, Elandro, Archemaco, Mimnomaco, Acmonida, Dicante, Carofantida.
Di Sibari: Metopo, Ippaso, Prosseno, Evanore, Leanatte, Menestore, Diocle, Empedo, Timasio, Polemeo, Endio, Tirreno.
Di Cartagine: Miltiade, Ante, Odio, Leocrito.
Di Paro: Eetio, Fenecle, Dessiteo, Alcimaco, Dinarco, Metone, Timeo, Timesianatte, Eumero, Timarida.
Di Locri: Gittio, Senone, Filodamo, Evete, Eudico, Stenonida, Sosistrato, Eutinoo, Zaleuco, Timare.
Di Posidonia: Atamante, Simo, Prosseno, Cranao, Mie, Batilao, Fedone.
Della Lucania: Occelo e Occilo fratelli, Aresandro, Cerambo.
Di Dardano: Malione.
Di Argo: Ippomedonte, Timostene, Eveltone, Trasidamo, Critone, Polittore.
Della Laconia: Autocarida, Cleanore, Euricrate.
Degli Iperborei: Abari.
Di Reggio: Aristide, Demostene, Aristocrate, Fitio, Elicaone, Mnesibulo, Ipparchide, Eutosione, Euticle, Opsimo, Calaide, Selinuntio.
Di Siracusa: Leptine, Fintia, Damone.
Di Samo: Melisso, Lacone, Archippo, Elorippo, Eloride, Ippone.
Di Caulonia: Callimbroto, Dicone, Nasta, Drimone, Senea.
Di Fliunte: Diocle, Echecrate, Polimmesto, Fantone.
Di Sicione: Poliade, Demone, Stratio, Sostene.
Di Cirene: Proro, Melanippo, Aristangelo, Teodoro.
Di Cizico: Pitodoro, Ippostene, Butero, Senofilo.
Di Catania: Caronda, Lisiade.
Di Corinto: Crisippo.
Un tirreno: Nausitoo.
Di Atene: Neocrito.
Del Ponto: Laramno.
In tutto furono duecentodiciotto.
Le pitagoriche più famose furono: Timica, moglie di Millia di Crotone; Filtide, figlia di Teofrio di Crotone e sorella di Bindaco; Occelo ed Eccelo, sorelle dei lucani Occelo e Occilo; Chilonide, figlia di Chilone spartano; Cratesiclea, della Laconia, moglie dello spartano Cleanore; Teano, moglie di Brotino di Metaponto; Miia, moglie di Milone di Crotone; Lastenia, arcade; Abrotelea, figlia di Abrotele di Taranto; Echecratia di Fliunte; Tirsenide di Sibari; Pisirrode di Taranto; Teadusa, della Laconia; Boio di Argo; Babelica di Argo; Cleecma, sorella dello spartano Autocarida.
In tutto furono diciassette.
Dal punto di vista storico, molti di questi nomi sono alquanto problematici. Essi sono assai più numerosi di quanti noi ne conosciamo; nello stesso tempo, però, noi conosciamo altri nomi di Pitagorici che qui non compaiono. Si noti, poi, come nell’elenco siano inclusi anche nomi di famosi filosofi, come Parmenide, Melisso, Empedocle, che non sono riducibili al puro pitagorismo. Sempre da un punto di vista rigorosamente storico, il pitagorismo inizia con Pitagora e si può dire che finisca con Numenio, cioè agli inizi del III secolo d.C. Successivamente il pitagorismo si fonde col platonismo in modo definitivo. In questa storia della filosofia abbiamo proposto la distinzione di tre gruppi di Pitagorici:
I. Pitagorici Antichi, ovvero Pitagorici dell’età arcaica e classica.
II. Mediopitagorici, ovvero Pitagorici dell’età ellenistica, per lo più autori di pseudoepigrafi.
III. Neopitagorici, ovvero Pitagorici che cercano di ripensare a fondo l’antica dottrina, che si presentano alla ribalta già nel I secolo a.C., ma che acquistano la loro precisa fisionomia soprattutto nei secoli I e II d.C.
Ordiniamo, quindi, il complesso materiale (edizioni, traduzioni, studi e bibliografia) sotto queste tre voci.
I. PITAGORICI ANTICHI (secoli VI-IV a.C.)
Ecco il catalogo dei Pitagorici di cui ci sono giunti testimonianze e frammenti. Il primo numero è quello dell’edizione Timpanaro Cardini, che sotto citiamo, e che è oggi il più sicuro punto di riferimento; il secondo fra parentesi è il corrispettivo nella raccolta Diels-Kranz.
1. (= 14 DK) Pitagora di Samo.
2. (= 15 DK) Cercope.
3. (= 16 DK) Petrone di Imera.
4. (= 17 DK) Brotino o Brontino di Metaponto.
5. (= 18 DK) Ippaso di Metaponto o di Crotone.
6. (= 19 DK) Callifonte e Democede di Crotone.
7. (= 20 DK) Parmisco o Parmenisco di Metaponto.
8. (= 24 DK) Alcmeone di Crotone.
9. (= 25 DK) Icco di Taranto.
10. (= 26 DK) Parone.
11. (= 27 DK) Aminia.
12. (= 32 DK) Menestore di Sibari.
13. (= 33 DK) Xuto.
14. (= 36 DK) Ione di Chio.
15. (= 42 DK) Policleto di Argo.
16. (= 42 DK) Ippocrate di Chio.
17. (= 43 DK) Teodoro di Cirene.
18. (= 44 DK) Filolao di Taranto.
19. (= 45 DK) Eurito di Crotone (o di Metaponto o di Taranto).
20. (= 46 DK) Archippo di Taranto, Liside di Taranto, Opsimo di Reggio.
21. (= 47 DK) Archita di Taranto.
22. (= 48 DK) Occello o Ocello di Lucania.
23. (= 49 DK) Timeo di Locri.
24. (= 50 DK) Iceta di Siracusa.
25. (= 51 DK) Ecfanto di Siracusa.
26. (= 52 DK) Senofilo di Calcide.
27. (= 53 DK) Diocle, Echecrate, Polimnesto, Fantone di Fliunte, Arione di Locri.
28. (= 54 DK) Proro di Cirene, Amicla e Clinia di Taranto.
29. (= 55 DK) Damone e Finzia di Siracusa.
30. (= 56 DK) Simo di Posidonia, Mionide, Eufranore.
31. (= 57 DK) Licone o Lico di Taranto.
32. (manca in DK) Timarida.
33. (= 58 DK) Scuola Pitagorica e Pitagorici anonimi.
O Della maggior parte di questi Pitagorici ci sono giunti testimonianze indirette, e, di alcuni dei più recenti, qualche frammento. Cfr. quanto diciamo alla voce Presocratici, in corrispondenza dei numeri DK sopra indicati.
E Oltre all’edizione del Diels-Kranz, è fondamentale, come abbiamo già detto, la seguente edizione, già menzionata, che amplia e migliora quella del Diels-Kranz:
– M. Timpanaro Cardini, Pitagorici, Testimonianze e frammenti, 3 voll., La Nuova Italia, Firenze 1958; 1962; 1964; 19692.
C L’edizione della Timpanaro Cardini si segnala soprattutto per un ampio ed accurato commentario (l’unico completo di cui si disponga a livello internazionale).
T Oltre alla traduzione della Timpanaro Cardini, si segnala anche la seguente per chiarezza:
– A. Maddalena, I Pitagorici, Laterza, Bari 1954 (ora anche nel volume I Presocratici, cfr. voce).
– K.S. Guthrie, T. Taylor, A.Fairbanks, D. R. Fideler, J. Godwin, The Pythagorean sourcebook and Library. An Anthology of Ancient Writings which Relate to Pythagoras and Pythagorean Philosophy, Grand Rapids 1987.
S Tra i numerosi libri su Pitagora e i Pitagorici menzioniamo:
– A. Delatte, Études sur la littérature pythagoricienne, Paris 1915.
– E. Frank, Plato und die sogenannten Pythagoreer, Halle 1923; rist. anast., Darmstadt 1962.
– A. Rostagni, Il verbo di Pitagora, Torino 1924.
– V. Capparelli, La sapienza di Pitagora, 2 voll., Padova 1941-1944.
– J.E. Raven, Pythagoreans and Eleatics, Cambridge 1948; rist. anast., Amsterdam 1966.
– W. Burkert, Weisheit und Wissenschaft, Studien zu Pythagoras, Philolaos und Platon, Nürnberg 1962; trad. inglese, 1972.
– C.J. de Vogel, Pythagoras and Early Pythagoreanism, Assen 1966.
– J.A. Philip, Pythagoras and Early Pythagoreanism, Toronto 1966.
– P. Gorman, Pythagoras: A Life, London 1979.
B Stato della questione, discussione sulle interpretazioni proposte dopo lo Zeller e bibliografia fino al 1938 si troveranno in Zeller-Mondolfo, I, 2, pp. 288-685. Ulteriore bibliografia si troverà in Timpanaro Cardini, fasc. I, pp. XI-XIX; fasc. II, pp. IX-XIX; fasc. III, pp. IX-XVII e in Burkert, op. cit., pp. 457-467. Cfr. anche Totok, Handbuch…, pp. 115-119.
II. MEDIOPITAGORICI, abbiamo proposto questa denominazione per quegli autori, soprattutto dell’età ellenistica (ma alcuni, senza dubbio, anche di età imperiale), i quali si nascosero sotto il falso nome di antichi Pitagorici. La differenza fra questi Pitagorici e i Neopitagorici, è stata da noi precisata.
Un catalogo di questi filosofi e di quanto di essi ci è pervenuto è stato fatto, nel secolo scorso, dal Beckmann (De Pythagoreorum Reliquiis, Berlin 1844) e ad esso si attiene sostanzialmente lo Zeller. Un nuovo catalogo più preciso e più completo, ha redatto di recente O. Thesleff, nelle opere sottoindicate, e qui lo riportiamo, dato che è sconosciuto ai più. Ricordiamo che si tratta, nella maggior parte dei casi, di pseudonimi. In particolare, è da rilevare quanto segue. a) Si tratta, di regola, di nomi di uomini e di donne legate alla persona di Pitagora e alla scuola pitagorica, assunti da falsari. b) Non necessariamente, però, sotto lo stesso nome si nasconde una sola persona: persone diverse possono aver assunto (e in alcuni casi fu certamente cosi) il medesimo nome. c) Lo stesso falsario poté anche assumere nomi diversi. d) Alcuni nomi non sono attestati negli elenchi degli antichi Pitagorici: possono essere quindi nomi di Pitagorici di cui si è perduta notizia, ma non si può escludere che alcuni Pitagorici di età ellenistica si chiamassero davvero con quel nome sotto cui scrivevano e che scrivessero in uno stile analogo a quello dei falsari. e) Alcuni di questi “falsari” erano sicuramente in buona fede, altri no: in particolare, alcuni possono benissimo aver prodotto, come ci è attestato, scritti “pitagorici” a scopi venali.
Ed ecco il catalogo secondo l’ordine alfabetico degli autori (modifichiamo, secondo le esigenze imposte dalla traduzione italiana, l’ordine alfabetico del Thesleff), l’indicazione di quanto ci è pervenuto e la pagina relativa nell’edizione del Thesleff.
1. Acrone di Agrigento. Sotto il suo nome ci sono pervenute solo testimonianze (pp. 1-2).
2. Archippo di Samo o di Taranto. Sotto il suo nome ci sono pervenute solo testimonianze (p. 2).
3. Archita di Taranto. Sotto il suo nome ci sono pervenuti due trattati sulle Categorie e numerosi ed anche consistenti frammenti da varie opere (cfr. il catalogo in Thesleff, An Introduction, pp. 8-11; cfr. anche voce pp. 2-48).
4. Aresa Lucano. Sotto il suo nome ci è pervenuto un ampio frammento conservatoci da Stobeo di un’opera Sulla natura dell’uomo (pp. 48-50).
5. Arignote, sorella di Pitagora. Sotto il suo nome ci sono giunti solo titoli di opere a lei attribuite (pp. 50-51).
6. Arimnesto, figlio di Pitagora. Sotto il suo nome ci è pervenuta una testimonianza di Porfirio, che riporta un epigramma di due versi (p. 51).
7. Aristeo di Crotone. Sotto il suo nome ci sono pervenuti alcuni frammenti, di cui uno abbastanza ampio, tratto dall’opera Sull’armonia (pp. 52-53).
8. Aristombroto. Sotto il suo nome ci è pervenuto un breve frammento da un trattato Sulla visione (pp. 53-54).
9. Astone di Crotone. Diogene Laerzio, VIII, 7, dice che molti discorsi scritti da Astone furono attribuiti a Pitagora. Possediamo solo questa menzione p. 51.
10. Atamanta di Posidonia. Sotto il suo nome ci sono pervenuti pochissime testimonianze ed un frammento in dorico (p. 54).
11. Brisone. Sotto il suo nome ci sono pervenuti un frammento dell’Economico e versioni in lingua araba ed aramaica del medesimo. Cfr.: M. Plessner, Der oikonomikos des Neupyhagoreers Bryson und sein Einfluss auf die islamische Wissenschaft, “Orient und Antike”, 5, Heidelberg 1928. Thesleff pubblica, oltre al frammento greco, un sommario in inglese della traduzione tedesca del Plessner (pp 56-58).
12. Bro(n)tino di Crotone o di Metaponto. Sotto il suo nome ci sono pervenuti alcuni frammenti e titoli di opere (pp. 54-56).
13. Butero di Cizico. Sotto il suo nome ci è pervenuto un frammento conservatoci da Stobeo del trattato Sui numeri (p. 59).
14. Callicratida di Sparta. È noto come filosofo pitagorico solo attraverso Stobeo, che ci ha conservato alcuni frammenti: ma è da ricordare, tuttavia, che cosi si chiamava anche il fratello di Empedocle, legato ai Pitagorici, e che un falsario di età ellenistica potrebbe aver assunto tale nome (pp. 102-107).
15. Caronda di Catania. Sotto il suo nome ci è giunto un Proemio alle Leggi, che potrebbe essere completo (pp. 59-67).
16. Cleemporo. È ritenuto da alcuni (cfr. Plinio, Nat. Hist., 24, 159 autore di un’opera Sull’effetto delle piante, attribuita a Pitagora (pp. 107-175).
17. Clinia di Taranto o di Eraclea. Sotto il suo nome ci sono giunti frammenti da scritti Sulla pietà e Sui numeri (pp. 107-108).
18. Critone di Argo. Sotto il suo nome ci è giunto un frammento dell’opera Sulla saggezza conservato da Stobeo (p. 109).
19. Damippo. Ci sono pervenuti due frammenti conservatici da Stobeo e attribuiti a “Critone e Damippo pitagorico” (pp. 68-69).
20. Dio. Sotto questo nome ci sono pervenuti solamente due frammenti conservatici da Stobeo, che lo chiama appunto “Dios pitagorico” (pp 70-71).
21. Diodoro di Aspendo. Sotto il suo nome ci sono giunte pochissime testimonianze (pp. 69-70).
22. Diotogene. Sotto il suo nome ci sono pervenuti due frammenti piùttosto ampi dai trattati Sulla regalità e Sulla santità, conservatici da Stobeo che lo denomina, appunto, “Diotogene Pitagorico”; cfr. anche voce (pp. 77-78).
23. Eccelo Lucana. Probabilmente coincide con la donna di cui fa menzione il catalogo di Giamblico (DK 58 A I ), e quindi non è necessario identificarla con Occelo (che dal medesimo catalogo risulta essere stato suo fratello). Sotto il suo nome ci è giunto un frammento da uno scritto Sulla giustizia, conservatoci da Stobeo (pp. 77-78).
24. Ecfanto di Crotone o di Siracusa. Sotto il suo nome ci sono giunti quattro ampi frammenti conservatici da Stobeo da uno scritto Sulla regalità; cfr. anche voce (pp. 78-84).
25. Epaminonda di Tebe, discepolo di Liside pitagorico. Cfr. la testimonianza di Claudiano Mamerto, De an., 2,7. Non ci è pervenuto nessun frammento (p. 84).
26. Epicarmo di Siracusa. Sotto il suo nome ci è giunta una sola testimonianza (p. 84).
27. Eurifamo di Metaponto o di Siracusa. Sotto il suo nome ci è pervenuto un ampio frammento da un trattato Sulla vita, conservatoci da Stobeo (pp. 85-87).
28. Eurito di Crotone o di Metaponto o di Taranto. Sotto il suo nome ci è pervenuto un frammento dello scritto Sulla fortuna, conservatoci da Stobeo (pp. 87-88).
29. Filolao di Crotone o di Taranto. Sotto il suo nome ci sono giunte testimonianze e frammenti da scritti Sui ritmi e sulle misure e Sull’anima (pp. 147-151).
30. Fintide, forse coincide con la Filtide di DK 58 A 1. Sotto il suo nome ci sono giunti due frammenti, conservatici da Stobeo, da uno scritto sulla Saggezza della donna (pp. 151-154).
31. Gorgiade. Sotto il suo nome ci è pervenuta solo una testimonianza di Claudiano Mamerto, De an., 2, 7 (p. 88).
32. Ipparco. È detto pitagorico da Stobeo, che riporta un ampio frammento dello scritto Sulla tranquillità; questo frammento in Diels-Kranz è riportato, invece, fra le imitazioni di Democrito: cfr. Diels-Kranz, 68 C 7 (vol. II, pp. 228 sgg.) (pp.88-91).
33. Ippaso di Metaponto o di Crotone o di Sibari. Sotto il suo nome ci sono giunte alcune testimonianze (pp. 91-93).
34. Ippodamo di Mileto o di Turi. Sotto il suo nome ci sono giunti frammenti dagli scritti Sulla felicità e Sulla politeia (pp. 93-102).
35. Licone di Taranto. Sotto il suo nome ci sono giunte solo testimonianze (pp. 109-110).
36. Liside di Taranto o di Tebe. Sotto il suo nome ci sono giunte testimonianze ed una Lettera ad Ipparco (pp. 110-115).
37. Megillo. Sotto il suo nome ci è giunta una testimonianza da uno scritto Sui numeri. Può essere il nome preso dal “falsario” dal personaggio delle Leggi e dell’Epinomide di Platone (p. 115).
38. Melissa. Sotto il suo nome ci è pervenuta una Lettera a Clearta, sul ruolo della donna (pp. 115-116).
39. Metopo di Metaponto. Sotto il suo nome ci sono pervenuti due ampi frammenti conservatici da Stobeo di uno scritto Sulla virtù (pp. 116-121).
40. Metrodoro di Metaponto, figlio di Epicarmo. Sotto il suo nome ci è giunta una testimonianza di Giamblico (pp. 121-122).
41. Miia, sorella di Pitagora. Sotto il suo nome ci è giunta una Lettera a Tillide, sulla cura della prole (pp. 123-124).
42. Milone di Crotone. Di lui ci è pervenuta una breve testimonianza conservataci da Stobeo (pp. 122-123).
43. Ninone Retore. E presentato da Giamblico come uno che pretese di aver indagato i segreti dei Pitagorici. È detto autore di un Discorso sacro contro i Pitagorici. Cfr. Vita di Pitagora, 258-260. Thesleff dubita che sia davvero esistito e si limita a riportarne il nome (p. 124).
44. Numa Pompilio, Re di Roma. Thesleff si limita a menzionare il nome. Vedasi quanto diciamo alla voce (p. 124).
45. Occelo (o Ocello) di Lucania. Sotto il suo nome, oltre ad un frammento dello scritto Sulla Legge, ci è pervenuto un trattato integrale, divenuto abbastanza famoso, Sulla natura dell’universo; cfr. anche voce (pp. 124-138 ).
46. Onata (o Onato) di Crotone. Sotto il suo nome ci sono giunti frammenti di un’opera Su Dio e sul Divino conservatici da Stobeo (pp. 138-140).
47. Opsimo di Reggio. Sotto questo nome ci sono pervenute solo testimonianze (pp. 140-141).
48. Panacheo. Di lui abbiamo due brevissime testimonianze (p. 141).
49. Pempelo di Turi. Sotto il suo nome ci è giunto un frammento conservatoci da Stobeo (pp. 141 sg.).
50. Perittione di Atene. Era il nome della madre di Platone. Ci sono giunti sotto il suo nome frammenti da due scritti, Sull’armonia della donna e Sulla sapienza, conservatici da Stobeo (pp. 142-146).
51. Pitagora di Samo. Sotto il nome di Pitagora ci sono giunti oltre al Carme aureo, frammenti di varie opere, relazioni di quattro discorsi e frammenti di Lettere. Si veda il catalogo Thesleff, Introduction…. pp. 18-21; cfr. anche voce (pp. 155-186).
52. Proro di Cirene. Sotto il suo nome ci sono giunte due testimonianze di uno scritto Sull’ebdomade (pp. 154-155).
53. Simo di Posidonia. Di lui ci sono pervenute pochissime testimonianze (p. 187).
54. Stenida di Locri. Sotto il suo nome ci è pervenuto un frammento di un trattato Sulla regalità, conservatoci da Stobeo (cfr. voce) (pp. 187-188).
55. Teage di Crotone. Sotto il suo nome ci sono pervenuti ampi frammenti di un trattato Sulla virtù, conservatici da Stobeo (pp. 189-193).
56. Teano, moglie o sorella di Pitagora. Sotto il suo nome ci sono pervenuti alcune lettere e i titoli di alcune opere (pp. 193-201).
57. Tearida di Metaponto. Sotto il suo nome ci è giunto un breve frammento da un trattato Sulla natura (p. 201).
58. Telauge, figlio di Pitagora. Sotto il suo nome ci sono giunte alcune testimonianze e frammenti (pp. 188-189).
59. Timaride di Paro o di Taranto. Sotto il suo nome ci sono giunti testimonianze ed alcuni frammenti (pp. 201-202).
60. Timeo di Locri. Sotto il suo nome ci è giunto un trattato Sulla natura del cosmo e dell’anima, che si presenta come il presunto modello del Timeo di Platone; cfr. anche voce (pp. 202-225).
61. Zaleuco di Locri. Sotto il suo nome ci sono giunti frammenti di Proemi alle Leggi (pp. 225-229).
Questo è il catalogo che il Thesleff aveva tracciato nella Introduction… (cfr. sotto). Nell’edizione dei frammenti, ha poi inserito anche i seguenti nomi:
62. Androcide Pitagorico, sotto il cui nome furono fatte circolare falsificazioni (p. 2).
63. Esara, che sarebbe una figlia di Pitagora (p. 1).
64. Eufranore Pitagorico. Di lui ci è riferito che sapeva suonare bene il flauto. Potrebbe essere quindi uno pseudepigrafo che ha fatto circolare sotto il suo nome l’opera Sui flauti, menzionata da Ateneo (p. 85).
65. Cebete. Per il testo della Tavola di Cebete, Thesleff fa rimando alla edizione Praechter; cfr. voce Cebete (p. 107).
66. Platone è elencato fra i Pitagorici dell’età ellenistica per le Lettere spurie (p. 154).
A questi nomi, forse, qualcuno potrà ancora essere aggiunto. Thesleff stesso (Introduction…., p. 7, note 2 e 3) fornisce alcuni esempi di nomi che egli esclude dal catalogo, ma le cui motivazioni potrebbero essere ridiscusse. Qualcuno potrebbe, al contrario, essere tolto. Al momento, però, è questa la tavola più completa che sia stata redatta.
Accanto a questi nomi sono da ricordare le fonti anonime cui attingono le esposizioni pitagoriche di Ovidio (Metam., 15,1-478), di Diodoro, di Alessandro Poliistore (presso Diogene Laerzio, VIII, 2433), di Fozio (Biblioth., cod. 249), che Thesleff menziona o riporta alle pagine 229-245 come appendici, e che si troverà tradotto in AA.VV., The Pythagorean Sourcebook and Library. An Antology of Ancient Writings which Relate to Pythagoras and Pythagorean Philosophy, Compliled and Translated by K.S. Guthrie with Additional Translations by T. Taylor and A. Fairbanks Jr., Introduced and Edited by D.R. Fideler, with a Foreword by J. Godwin, Grand Rapids (Mich.) 1987, pp. 137-140.
Ma su queste fonti il discorso è diverso, e, in ogni caso, esse andrebbero completate, a nostro avviso, con le fonti di Eudoro di Alessandria, di Filone di Alessandria e di Sesto Empirico.
E La moderna edizione critica di tutto questo materiale, come abbiamo già detto, è stata curata da:
– H. Thesleff, The Pythagorean Texts of the Hellenistic Period, Abo Akademi, Abo 1965 (“Acta Academiae Aboensis”, Ser. A, Humaniora, vol. XXX, 1).
Questa edizione ha due soli difetti: non porta la traduzione, che sarebbe stata in molti casi opportuna, data la complessità linguistica dovuta al dialetto dorico in cui gran parte dei frammenti sono scritti, e, soprattutto, ha un indice delle parole del tutto inadeguato all’opera. L’introduzione a questa edizione è di quattro anni anteriore:
– H. Thesleff, An Introduction to the Pythagorean Writings of the Hellenistic Period, Abo Akademi, Abo 1961 (“Acta Academiae Aboensis”, Humaniora. XXIV. 3).
T C – B. Centrone, Pseudopythagorica Ethica. I trattati morali di Archita, Metopo, Teage, Eurifamo, Introduzione, edizione, traduzione, commento, Napoli 1990.
– The Pythagorean Writings. Hellenistic Texts from the 1st. cent. B.C. – 3rd cent. A.D. on Life, Morality, Knowledge and the World, comprising a selection of the Neo-Pythagorean fragments and testimonia of the Hellenistic Period, including those of Philolaus and Archytas, transl. by K.Guthrie, T. Taylor, with an Introduction to the Pithagorean Writings by. R. Navon, with a Foreword by L.G. Westerink, New Gardens 1986.
S – AA.VV., The Pythagorean Sourcebook and Library, Grand Rapids (Mich.) 1987, sopra citato.
Per agevolare la lettura dei difficili testi, si potrà ricorrere alla traduzione latina del Mullach, Fr. Phil. Gr., I, pp. 193 sgg.; 383-575; II, 1-129, che di questi testi pitagorici aveva fornito una raccolta già molto ricca.
Una traduzione italiana di alcuni passi fu fatta dal padre Pagnini e si trova pubblicata in G.D. Romagnosi, Opere, vol. II, 2, Milano 1944, pp. 1561-1579.
Una traduzione inglese di un certo numero di questi documenti è stata fatta da T. Taylor, agli inizi dell’800, e ora riedita:
– Jamblicus of Chalcis, Life of Pythagoras; or, Pythagoric life; accompanied by fragments of the ethical writings of certain Pythagoreans in the Doric dialect; and a coll. of Pythagoric sentences from Stobaeus and others, which are omitted by Gale in his Opuscula mythologica, and have not been noticed by any ed.; tr. from the Greek by Thomas Taylor, John Maurice Watkins, London 1965.
Dei pezzi più significativi della raccolta ci sono invece alcune traduzioni anche recenti, di cui diamo conto alle singole voci (cfr. Cebete, Ecfanto, Diotogene, Ocello, Stenida, Timeo).
Si vedano, sui vari problemi relativi a questi filosofi, i seguenti studi, per diversi aspetti assai utili:
– V. Capparelli, La sapienza di Pitagora, 2 voll., Padova 1941-1944. (Interessa soprattutto il nostro argomento il vol. I che ha il sottotitolo: Problemi e fonti di informazione).
– L. Ferrero, Storia del pitagorismo nel mondo romano (dalle origini alla fine della repubblica), Torino 1955.
– W. Burkert, Hellenistische Pseudopythagorica, in “Philologus”, 105 (1961), pp. 16-43; 226-246.
– W. Burkert, Weisheit und Wissenschaft, Nürnberg 1962.
– H. Thesleff, Introduction…, sopra cit.
– AA.VV., Pseudepigrapha, I, “Entretiens sur l’Antiquité Classique”, XVIII, Vandoeuvres-Geneve 1972.
– B. Centrone, Pseudopythagorica Ethica. Napoli 1990, pp. 13-58. (sopra citato).
– AA.VV., The Pythagorean Sourcebook and Library, Grand Rapids (Mich.) 1987.
B – Lo status quaestionis (soprattutto per ciò che concerne le questioni di carattere storico e cronologico) si troverà in Thesleff, Introduction…, pp. 30-45; ivi, pp. 123-127, si troverà anche una ricca bibliografia. Inadeguato, purtroppo, l’aggiornamento di Del Re della sezione dello Zeller riguardante questo tema: Zeller-Del Re [cfr. indicazione analitica alla voce Neopitagorici], pp. 15 sgg.
– B. Centrone, Pseudopythagorica Ethica, Napoli 1990, pp. 243-247 e 249-323 (sopra citato).
III. NEOPITAGORICI (secoli I a.C. – inizi del III secolo d.C.).
Abbiamo distinto un Mediopitagorismo da un Neopitagorismo per le ragioni spiegate. Mediopitagorici sono certi autori di pseudepigrafi che si nascondono sotto il nome di antichi pitagorici (cfr. voce); mentre Neopitagorici sono, propriamente, quei filosofi che si presentano col loro nome, avendo acquistato piena coscienza della loro identità e del loro ruolo, che manca, invece, agli autori di pseudepigrafi.
Fra i Neopitagorici si possono distinguere i seguenti quattro gruppi: I) un primo gruppo, che operò in ambiente romano, la cui filosofia ebbe una impronta prevalentemente etica; II) un secondo gruppo, che sviluppò l’indirizzo religioso-speculativo; III) un terzo gruppo, che sviluppò l’indirizzo religioso-mistico; IV) un quarto gruppo, costituito da raccoglitori di sentenze, il cui “pitagorismo” è alquanto tenue e generico.
I. Neopitagorici che operarono in ambiente romano
1. Publio Nigidio Figulo, vissuto nella prima metà del I secolo a.C. (cfr. voce).
2. Quinto Sestio (e il suo circolo), fiorito nella seconda metà del I secolo a.C. e nei primi anni del I secolo d.C.
3. Sestio, figlio di Quinto Sestio.
4. Sozione di Alessandria, fu uno dei maestri di Seneca.
5. Lucio Crassicio di Taranto.
6. Fabiano Papirio, che passò dalla retorica alla filosofia. Fu uno dei maestri di Seneca, che di lui ci parla nell’Epistola 100.
II. Neopitagorici che svilupparono l’indirizzo religioso-speculativo
1. Moderato di Gades, vissuto nel I secolo d.C. (cfr. voce).
2. Nicomaco di Gerasa, vissuto nella prima metà del II secolo d.C. (cfr. voce).
3. Numenio di Apamea, vissuto nella seconda metà del II secolo d.C. Fuse il Medioplatonismo col Pitagorismo (cfr. voce).
4. Cronio, presentato da fonti antiche quale seguace di Numenio (cfr. voce).
III. Neopitagorici rappresentanti dell’indirizzo puramente mistico-religioso
1. Apollonio di Tiana, vissuto nel I secolo d.C. (cfr. voce).
2. Filostrato Flavio, famoso soprattutto per aver scritto La vita di Apollonio, da lui composta per ispirazione di Giulia Domna (cfr. voce).
IV. Neopitagorici raccoglitori di sentenze
1. Sesto (da non confondersi con Sestio) (cfr. voce).
2. Secondo (cfr. voce).
O E Di questi pensatori, se si eccettuano Nicomaco, Filostrato, Sesto e Secondo, ci sono pervenuti solo frammenti e testimonianze. Di molti è stata fatta la raccolta e l’edizione dei frammenti, di cui daremo conto alle singole voci. Le fonti per la ricostruzione del pensiero dei Sestii si troveranno indicate negli autori sotto citati.
S Sul Neopitagorismo in genere e su quello romano in particolare si vedano:
– E. Zeller, Die Philosophie der Griechen, III, 1, pp. 699 sgg.; di recente tradotto in italiano: cfr., sotto, Zeller-Del Re.
– A. Gianola, La fortuna di Pitagora presso i Romani, Catania 1921.
– F. Bömer, Der lateinische Neuplatonismus und Neupythagoreismus und Claudianus Mamertus in Sprache und Philosophie, Leipzig 1936.
– V. Capparelli, La sapienza di Pitagora, vol. I, Padova 1941.
– L. Ferrero, Storia del pitagorismo nel mondo romano (dalle origini alla fine della repubblica), Torino 1955.
– A. Squilloni, Il significato etico-politico dell’immagine re-legge animata. Il n?omow ¿emcyxow nei trattati neopitagorici Peròi basile?iaw, “Civiltà Classica e Cristiana”, 11 (1990), 75-94.
– D.J. O’Meara, Pythagoras Revived. Mathemathics and Philosophy in Late Antiquity, Oxford 1998.
– A. Cacciari, Temi mediopltonici e neopitagorici in un frammento pseudo-giustineo, “Paideia” 43 (1988), pp. 3-27.
– J. Whittaker, Neopythagoreanism and the Trascendent Absolute, “Symbolae Osloenses”, 48 (1973), pp. 77-86.
– J. Whittaker, Neopythagoreanism and Negative Theology, “Symbolae Osloenses”, 44 (1969), pp. 109-125.
Di tutti i Neopitagorici di rilievo daremo indicazioni analitiche alle singole voci.
B In Ferrero, op. cit., pp. 422 sgg. e nelle note passim, si troverà ampia bibliografia. Cfr. la bibliografia sugli altri Neopitagorici alle singole voci. Di recente è stata altresi pubblicata la traduzione italiana della parte dell’opera zelleriana contenente la trattazione sui Neopitagorici, con aggiornamenti di R. Del Re, purtroppo non sempre soddisfacenti e soprattutto incompleti:
– E. Zeller – R. Mondolfo, La filosofia dei Greci nel suo sviluppo storico, Parte III, Volume IV: I precursori del Neoplatonismo, traduzione di E. Pocar, a cura di R. Del Re, La Nuova Italia, Firenze 1979, pp. 3-141 [citiamo questo volume con l’abbreviazione Zeller-Del Re].
ARCHITA
 Matematico, stratego e filosofo greco, Archita di Taranto (vissuto approssimativamente tra il 428 e il 347 a. C.), è l’ultimo rappresentante in senso forte del pensiero pitagorico. Austero uomo politico, egli resse per lungo tempo le sorti della sua città incrementandone la prosperità e la potenza e facendone la prima della Magna Grecia. In campo matematico e filosofico, continuò la tradizione pitagorica che anteponeva l’aritmetica alla geometria, pur utilizzando le più differenti tecniche nella risoluzione di complessi problemi matematici. Teorico di musica, derivò dallo studio del rapporto fra suoni armonici il concetto del numero inteso essenzialmente come rapporto, indipendente quindi dai vincoli di commensurabilità e razionalità. Altro problema prettamente aritmetico, espresso geometricamente come duplicazione del cubo (problema di Delo), fu risolto da Archita con un metodo insieme meccanico e di geometria spaziale. Fu infatti il primo e per lungo tempo l’unico filosofo della Grecia classica a intuire i vantaggi di un collegamento fra matematica e meccanica; gli si attribuiscono l’invenzione della raganella (strumento musicale) e la costruzione di una colomba volante di legno e di altri dispositivi meccanici. Ancora dai suoi studi di matematica applicata alla meccanica ricavò le nozioni che il suono è dovuto al movimento e all’urto fra corpi e che esiste un legame fra intensità della vibrazione e altezza di un suono. Amico di Platone, che fu vivamente influenzato dal suo pensiero, si adoperò per la sua liberazione dopo i contrasti che il grande filosofo ateniese ebbe a Siracusa con Dionisio II. Come notavamo, la fama di Archita è legata – oltrechè al ruolo di spicco in veste di Pitagorico – a importanti contributi quali la risoluzione del problema della ‘duplicazione del cubo’ (il cosidetto “problema di Delo”), anticipando di due secoli Eratostene, e il metodo per la costruzione di terne pitagoriche attribuito a Platone. Si dice anche che abbia inventato la carrucola e la vite, anticipando Archimede e che abbia costruito uno dei primi automi, la famosa ‘colomba di Archita’. Si tratta naturlamente di affermazioni trasmesse per tradizione e non controllabili, non essendoci pervenute le sue opere. Orazio lo chiamanò “misuratore del mare, e della terra, e delle innumerevoli arene; ed uomo che sulle celesti sfere ardito avea di sollevarsi ed aggirarsi”, mentre Cicerone lo chiama “virum magnum in primis et praeclarum”. Archita incarnò nella forma più piena l’ideale platonico del filosofo, o meglio del sapiente, coniugando nella sua vita teoria e pratica. Si impegnò anche in politica e fu grande uomo di stato e condottiero, più volte stratega di Taranto e capo della confederazione italiota. Fu un ingegno poliedrico preoccupato dell’unità del sapere. Cercò il vero in tutto e per tutto, fu teorico e tecnico, sostenendo che l’esperienza affascinante della scienza e della scoperta non dà gioia se non la si può comunicare agli amici, in opposizione, sembra, al senso di segretezza e di mistero che avvolgeva la scuola pitagorica. Perì tragicamente in un naufragio al promontorio di Matino presso il Gargano.
Matematico, stratego e filosofo greco, Archita di Taranto (vissuto approssimativamente tra il 428 e il 347 a. C.), è l’ultimo rappresentante in senso forte del pensiero pitagorico. Austero uomo politico, egli resse per lungo tempo le sorti della sua città incrementandone la prosperità e la potenza e facendone la prima della Magna Grecia. In campo matematico e filosofico, continuò la tradizione pitagorica che anteponeva l’aritmetica alla geometria, pur utilizzando le più differenti tecniche nella risoluzione di complessi problemi matematici. Teorico di musica, derivò dallo studio del rapporto fra suoni armonici il concetto del numero inteso essenzialmente come rapporto, indipendente quindi dai vincoli di commensurabilità e razionalità. Altro problema prettamente aritmetico, espresso geometricamente come duplicazione del cubo (problema di Delo), fu risolto da Archita con un metodo insieme meccanico e di geometria spaziale. Fu infatti il primo e per lungo tempo l’unico filosofo della Grecia classica a intuire i vantaggi di un collegamento fra matematica e meccanica; gli si attribuiscono l’invenzione della raganella (strumento musicale) e la costruzione di una colomba volante di legno e di altri dispositivi meccanici. Ancora dai suoi studi di matematica applicata alla meccanica ricavò le nozioni che il suono è dovuto al movimento e all’urto fra corpi e che esiste un legame fra intensità della vibrazione e altezza di un suono. Amico di Platone, che fu vivamente influenzato dal suo pensiero, si adoperò per la sua liberazione dopo i contrasti che il grande filosofo ateniese ebbe a Siracusa con Dionisio II. Come notavamo, la fama di Archita è legata – oltrechè al ruolo di spicco in veste di Pitagorico – a importanti contributi quali la risoluzione del problema della ‘duplicazione del cubo’ (il cosidetto “problema di Delo”), anticipando di due secoli Eratostene, e il metodo per la costruzione di terne pitagoriche attribuito a Platone. Si dice anche che abbia inventato la carrucola e la vite, anticipando Archimede e che abbia costruito uno dei primi automi, la famosa ‘colomba di Archita’. Si tratta naturlamente di affermazioni trasmesse per tradizione e non controllabili, non essendoci pervenute le sue opere. Orazio lo chiamanò “misuratore del mare, e della terra, e delle innumerevoli arene; ed uomo che sulle celesti sfere ardito avea di sollevarsi ed aggirarsi”, mentre Cicerone lo chiama “virum magnum in primis et praeclarum”. Archita incarnò nella forma più piena l’ideale platonico del filosofo, o meglio del sapiente, coniugando nella sua vita teoria e pratica. Si impegnò anche in politica e fu grande uomo di stato e condottiero, più volte stratega di Taranto e capo della confederazione italiota. Fu un ingegno poliedrico preoccupato dell’unità del sapere. Cercò il vero in tutto e per tutto, fu teorico e tecnico, sostenendo che l’esperienza affascinante della scienza e della scoperta non dà gioia se non la si può comunicare agli amici, in opposizione, sembra, al senso di segretezza e di mistero che avvolgeva la scuola pitagorica. Perì tragicamente in un naufragio al promontorio di Matino presso il Gargano.
Curva di Archita
La prima curva gobba (cioè non contenuta in alcun piano) che si incontra nella storia della matematica, introdotta da Archita per risolvere il problema della duplicazione del cubo. Alla sua equazione si arriva nel seguente modo: dati due segmenti a, b siano u e v i loro medi proporzionali, cioè sia a:u= =u:v=v:b.
Se si pone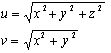
sostituendo questi valori nella proporzione si ricavano le seguenti relazioni: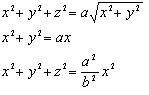
che sono equazioni di superfici. La prima è un toro, le altre due sono un cilindro e un cono quadrici che si incontrano lungo una linea di quart’ordine che costituisce la curva di Archita. Se si proietta questa curva sul piano xy, la sua equazione in coordinate polari r e J è la seguente:![]()
essa costituisce una curva detta campila di Eudosso.
ALCMEONE
 Alcmeone visse a Crotone alla fine del sesto secolo a.C. nel contesto pitagorico; bisogna subito specificare che non fu un vero e proprio pitagorico, in primo luogo perchè elaborò, sì, come i Pitagorici l’idea delle coppie di principi, ma a differenza di essi sceglieva le coppie a caso (e i contrari per lui erano più qualitativi che quantitativi), senza ricorrere a un criterio sistematico. Anche come idee politiche pare che differisse dai Pitagorici, che erano aristocratici: Alcmeone fu fiero sostenitore del regime democratico. Aristotele stesso ce lo presenta come un pitagorico “confusionario” e meno rigoroso. Alcmeone effettuò interessanti considerazioni sull’uomo e fu molto interessato alla medicina (lui stesso era medico). Tra le varie sue dottrine, tre sono le più importanti: 1), strettamente legata alla dottrina pitagorica, era la concezione di salute e malattia: per elaborare questa teoria, egli studiò accuratamente il corpo umano e lo interpretò in analogia con il funzionamento della politica: per lui infatti malattia e salute corrispondevano a due precise situazioni politiche. La salute corrispondeva alla democrazia (più in particolare Alcmeone parla di “isonomia”, uguaglianza di leggi), mentre la malattia alla monarchia. Come nel corpo si ha la salute quando c’è un equilibrio tra gli organi, così nella politica per Alcmeone c’è la democrazia quando tutte le parti sono in equilibrio e tutte possono dire la loro. Invece, così come nel corpo umano c’è una malattia quando un organo prevale sugli altri impedendo loro di agire, così nella politica si ha la monarchia quando prevale un individuo sugli altri e viene a rompere l’equilibrio. Sono idee antitetiche non solo rispetto ai Pitagorici, ma anche a Platone stesso. Dobbiamo poi ricordare che a quei tempi la medicina era una realtà ben differente dalla chirurgia: queste due attività erano addirittura tra loro in contrasto, basti pensare che nel giuramento dei medici di Ippocrate bisognava giurare di non far uso della chirurgia. 2) Molto interessante fu anche la sua teoria su quale fosse l’organo principale del nostro organismo: fu il primo a rispondere che era il cervello, avanzando così un’ipotesi enfalocentrica. Generalmente si era creduto che l’organo fondamentale fosse il fegato o il cuore, mentre il cervello non fu mai preso in considerazione perchè è un organo insensibile. E’ interessante notare come Aristotele credesse che il cervello fosse un organo di raffreddamento e fu sostenitore della teoria cardiocentrica. Alcmeone fece accurati esperimenti su animali e scoprì i nervi che collegavano il cervello ad altri organi vitali (per esempio agli occhi) e ipotizzò che svolgesse la funzione di coordinamento delle mansioni sensitive. Così Alcmeone fu il primo a dire che il cervello fosse l’organo più importante. 3) Alcmeone cercò anche di individuare la posizione degli uomini e scoprì che era intermedia. La sua opera in prosa (di cui si ignora il titolo) inizia proprio con l’affermazione che gli uomini sono inferiori rispetto agli dei: “Alcmeone di Crotone, figlio di Pirito, disse questo a Brotino e a Leonte e a Batillo: delle cose invisibili e delle cose visibili soltanto gli dei hanno conoscenza certa; gli uomini possono soltanto congetturare”. Dopo un’accurata presentazione di sè, egli spiega che per gli dei non ci sono barriere conoscitive e possono conoscere l’intera realtà. Gli uomini invece non riescono a scorgerla e per raggiungerla devono sforzarsi di interpretare e capire gli indizi a loro disposizione e possono comunque solo supporla. La conoscenza degli dei viene definita sapheneia e comporta un legame stretto con la chiarezza: perfino le cose invisibili non sono in realtà tali per gli dei. La conoscenza umana sta tutta nel tekmairestai, ossia nello sfruttare gli indizi per tentare di comprendere ciò che non è immediatamente carpibile con i sensi. Alcmeone dice che gli uomini sono un gradino al di sotto degli dei, ma che essi sono comunque un gradino al di sopra degli animali (da qui il fatto che l’uomo si trovi in una posizione intermedia, tema che sarà centrale nel Rinascimento neoplatonico). Sia gli uomini sia gli animali conoscono ciò che appare loro, ma gli uomini riescono a comprendere, a connettere i dati sensibili in ragionamenti: vi è proprio l’idea dello xuniemi, del comprendere visto come “prendere assieme”: i singoli organi devono raccogliere e connettere gli indizi. Gli uomini organizzando il loro pensiero possono raggiungere le realtà più profonde. Alcmeone era soprattutto mosso dall’esigenza di capire esattamente quale potesse essere la portata della conoscenza umana. Egli distingueva in modo marcato la conoscenza umana da quella divina, mettendo in luce fin dove quella umana potesse estendersi. Il sapere divino veniva da Alcmeone qualificato come σαφηνεια, ovvero assoluta certezza; quello umano, dal canto suo, veniva visto come notevolmente meno chiaro. Quelle cose che per gli uomini risultano invisibili, sono, ad avviso di Alcmeone, perfettamente visibili per gli dèi: il conoscere umano procede attraverso indizi (τεκμηρια) o, nel linguaggio medico, sintomi. Si deve dunque costruire il sapere a partire dai segni, così come il medico parte dai sintomi per diagnosticare la malattia. Per superare il buio, quindi, non ho bisogno di divinità che mi aiutino, ma piuttosto di τεκμηρια sui quali fare inferenze, passando così dalle cose certe a cose che certe non sono. Questi indizi intorno ai quali edificare la conoscenza sono essenzialmente coglibili nell’ambito delle sensazioni, cosicchè si parte da ciò che si presenta ai sensi per arrivare a ciò che ad essi non si presenta; bisogna però spiegare come funziona questo passaggio e quale è lo strumento che consente di attuare l’inferenza. Ed è qui che entrano in gioco gli animali: infatti anch’essi hanno percezioni, ma è solo l’uomo a poterle comprendere, ossia “raccogliere e connettere” ciò che proviene dai singoli organi di senso. Ma ciò non toglie che attraverso quest’operazione di raccoglimento e connessione dei dati sensoriali l’uomo finisca per costruire una conoscenza inferiore rispetto a quella divina: ” delle cose visibili e delle invisibili solo gli dèi hanno conoscenza certa (σαφηνεια); gli uomini possono soltanto congetturare […]. L’uomo differisce dagli altri animali perché esso solo comprende ” (ovvero sa connettere i dati sensoriali).
Alcmeone visse a Crotone alla fine del sesto secolo a.C. nel contesto pitagorico; bisogna subito specificare che non fu un vero e proprio pitagorico, in primo luogo perchè elaborò, sì, come i Pitagorici l’idea delle coppie di principi, ma a differenza di essi sceglieva le coppie a caso (e i contrari per lui erano più qualitativi che quantitativi), senza ricorrere a un criterio sistematico. Anche come idee politiche pare che differisse dai Pitagorici, che erano aristocratici: Alcmeone fu fiero sostenitore del regime democratico. Aristotele stesso ce lo presenta come un pitagorico “confusionario” e meno rigoroso. Alcmeone effettuò interessanti considerazioni sull’uomo e fu molto interessato alla medicina (lui stesso era medico). Tra le varie sue dottrine, tre sono le più importanti: 1), strettamente legata alla dottrina pitagorica, era la concezione di salute e malattia: per elaborare questa teoria, egli studiò accuratamente il corpo umano e lo interpretò in analogia con il funzionamento della politica: per lui infatti malattia e salute corrispondevano a due precise situazioni politiche. La salute corrispondeva alla democrazia (più in particolare Alcmeone parla di “isonomia”, uguaglianza di leggi), mentre la malattia alla monarchia. Come nel corpo si ha la salute quando c’è un equilibrio tra gli organi, così nella politica per Alcmeone c’è la democrazia quando tutte le parti sono in equilibrio e tutte possono dire la loro. Invece, così come nel corpo umano c’è una malattia quando un organo prevale sugli altri impedendo loro di agire, così nella politica si ha la monarchia quando prevale un individuo sugli altri e viene a rompere l’equilibrio. Sono idee antitetiche non solo rispetto ai Pitagorici, ma anche a Platone stesso. Dobbiamo poi ricordare che a quei tempi la medicina era una realtà ben differente dalla chirurgia: queste due attività erano addirittura tra loro in contrasto, basti pensare che nel giuramento dei medici di Ippocrate bisognava giurare di non far uso della chirurgia. 2) Molto interessante fu anche la sua teoria su quale fosse l’organo principale del nostro organismo: fu il primo a rispondere che era il cervello, avanzando così un’ipotesi enfalocentrica. Generalmente si era creduto che l’organo fondamentale fosse il fegato o il cuore, mentre il cervello non fu mai preso in considerazione perchè è un organo insensibile. E’ interessante notare come Aristotele credesse che il cervello fosse un organo di raffreddamento e fu sostenitore della teoria cardiocentrica. Alcmeone fece accurati esperimenti su animali e scoprì i nervi che collegavano il cervello ad altri organi vitali (per esempio agli occhi) e ipotizzò che svolgesse la funzione di coordinamento delle mansioni sensitive. Così Alcmeone fu il primo a dire che il cervello fosse l’organo più importante. 3) Alcmeone cercò anche di individuare la posizione degli uomini e scoprì che era intermedia. La sua opera in prosa (di cui si ignora il titolo) inizia proprio con l’affermazione che gli uomini sono inferiori rispetto agli dei: “Alcmeone di Crotone, figlio di Pirito, disse questo a Brotino e a Leonte e a Batillo: delle cose invisibili e delle cose visibili soltanto gli dei hanno conoscenza certa; gli uomini possono soltanto congetturare”. Dopo un’accurata presentazione di sè, egli spiega che per gli dei non ci sono barriere conoscitive e possono conoscere l’intera realtà. Gli uomini invece non riescono a scorgerla e per raggiungerla devono sforzarsi di interpretare e capire gli indizi a loro disposizione e possono comunque solo supporla. La conoscenza degli dei viene definita sapheneia e comporta un legame stretto con la chiarezza: perfino le cose invisibili non sono in realtà tali per gli dei. La conoscenza umana sta tutta nel tekmairestai, ossia nello sfruttare gli indizi per tentare di comprendere ciò che non è immediatamente carpibile con i sensi. Alcmeone dice che gli uomini sono un gradino al di sotto degli dei, ma che essi sono comunque un gradino al di sopra degli animali (da qui il fatto che l’uomo si trovi in una posizione intermedia, tema che sarà centrale nel Rinascimento neoplatonico). Sia gli uomini sia gli animali conoscono ciò che appare loro, ma gli uomini riescono a comprendere, a connettere i dati sensibili in ragionamenti: vi è proprio l’idea dello xuniemi, del comprendere visto come “prendere assieme”: i singoli organi devono raccogliere e connettere gli indizi. Gli uomini organizzando il loro pensiero possono raggiungere le realtà più profonde. Alcmeone era soprattutto mosso dall’esigenza di capire esattamente quale potesse essere la portata della conoscenza umana. Egli distingueva in modo marcato la conoscenza umana da quella divina, mettendo in luce fin dove quella umana potesse estendersi. Il sapere divino veniva da Alcmeone qualificato come σαφηνεια, ovvero assoluta certezza; quello umano, dal canto suo, veniva visto come notevolmente meno chiaro. Quelle cose che per gli uomini risultano invisibili, sono, ad avviso di Alcmeone, perfettamente visibili per gli dèi: il conoscere umano procede attraverso indizi (τεκμηρια) o, nel linguaggio medico, sintomi. Si deve dunque costruire il sapere a partire dai segni, così come il medico parte dai sintomi per diagnosticare la malattia. Per superare il buio, quindi, non ho bisogno di divinità che mi aiutino, ma piuttosto di τεκμηρια sui quali fare inferenze, passando così dalle cose certe a cose che certe non sono. Questi indizi intorno ai quali edificare la conoscenza sono essenzialmente coglibili nell’ambito delle sensazioni, cosicchè si parte da ciò che si presenta ai sensi per arrivare a ciò che ad essi non si presenta; bisogna però spiegare come funziona questo passaggio e quale è lo strumento che consente di attuare l’inferenza. Ed è qui che entrano in gioco gli animali: infatti anch’essi hanno percezioni, ma è solo l’uomo a poterle comprendere, ossia “raccogliere e connettere” ciò che proviene dai singoli organi di senso. Ma ciò non toglie che attraverso quest’operazione di raccoglimento e connessione dei dati sensoriali l’uomo finisca per costruire una conoscenza inferiore rispetto a quella divina: ” delle cose visibili e delle invisibili solo gli dèi hanno conoscenza certa (σαφηνεια); gli uomini possono soltanto congetturare […]. L’uomo differisce dagli altri animali perché esso solo comprende ” (ovvero sa connettere i dati sensoriali).
SENOFANE
 Senofane sarà ricordato come il grande esule, giramondo, che per un certo tempo visse anche a Zancle (Messina) ed a Catania. Nacque nel 565 a.C. circa a Colofone, in Asia Minore, e mori forse ad Elea (Lucania) nel 470 a.C. Timeo dice che il filosofo ebbe rapporti con Gerone di Siracusa. Per la Theologumena Arithmetica “Infatti si calcolano con la massima approssimazione 514 anni dalla guerra troiana sino a Senofane il fisico e fino ai tempi di Anacreonte e Policrate e fino all’aggressione e devastazione degli Ioni ad opera di Arpago il Medo, fuggendo la quale i Focesi fondarono Massalia” (44,b,13, in I Presocratici, op. cit.). “Son già sessantasette anni che porto in giro per l’Ellade i miei affanni e i miei pensieri. Ed a questi sono da aggiungere i venticinque anni trascorsi dalla nascita, se so dire il vero intorno a queste cose”. (Diogene Laerzio IX, 19; op. cit.). Fu contemporaneo di Empedocle di Agrigento e i due ebbero modo di conoscersi e confrontarsi; l’agrigentino gli fece un giorno osservare che era impossibile riuscire a trovare un uomo sapiente: ‘E’ naturale, perché bisogna che sia sapiente chi vuol riconoscere un sapiente’, rispose il rapsodo. Col siciliano ebbe in comune la visione democratica di governo: i tiranni, disse, o sono molto gradevoli o devono essere rarissimi. Forse fu il fondatore della scuola detta Eleatica, che forgiò Zenone e Parmenide. Agli Eleati, che gli chiesero se era saggio o meno offrire sacrifici oppure canti lamentosi a Leucotea, rispose di non elevare lamenti se essi la ritenevano una dea, e di non dedicarle sacrifici se la consideravano una mortale (Aristotele, Retorica, B, 23; confronta con Plutarco, Sulla superstizione, XIII). Sempre da Plutarco apprendiamo come Senofane si difese dall’accusa d’essere un vile per essersi rifiutato di giocare ai dadi, accusa buttatagli da Laso figlio di Ermione: ammise d’essere molto vile di fronte alle cose inique (De vitioso pudore, 5; in I presocratici, op. cit.). Scrisse Senofane elegie e giambi indirizzati solo a sminuire le qualità di Esiodo ed Omero, le due basi dell’epica classica. Non condivideva quanto da loro narrato descrivendo la vita e le azioni degli dei in tutto simili alle abitudini e attitudini umane. Ma non pare fossero stati solo i due poeti il bersaglio dei suoi dardi critici che appaiono infuocati di livore: osteggiò le dottrine di Talete e di Pitagora, altro fondamento stavolta filosofico – della cultura ellenica. Un suo concetto teorico sostiene che nell’universo possono esistere molteplici cose solo quando subentra l’azione dell’intelligenza per distinguerle. E il Dio, per l’eternità, è per lui solo pensiero e ragione; in questo ha una modernità di pensiero affascinante; ma non possiamo considerarla tale concezione simile alla nostra – Dio fece l’uomo a sua immagine – in quanto il Dio di Senofane è una sfera che “vede ed ascolta ma non respira”. E può essere raggiunto con l’uso dell’intelletto, escludendo le rivelazioni sempre mutevoli dei sensi, di natura opposta a quella dell’Ente supremo ed immobile. A leggere delle varie tesi riportate dalle fonti non si è trovato chi sia stato suo maestro; forse siamo nel giusto se lo consideriamo un ribelle alla cultura ufficiale del tempo, e più per temperamento che per una sua diversa concezione del mondo. La sua produzione poetica venne da lui pure mostrata alla maniera dei rapsodi, cioè come cantore girovago dei canti omerici – e comprende dei canti celebrativi: La fondazione di Colofone e la Colonizzazione di Elea d’Italia (IX, 20). Alla fine dei suoi circa novanta anni di vita Senofane venne sepolto dopo i suoi figli; e si tramanda che egli li seppelli colle sue mani. E per dir lode del suo animo si racconta che egli vedendo un giorno un cane che veniva bastonato, intervenne presso il padrone dicendo: “Cessa, non percuoterlo, poiché d’un uomo, un amico, riconobbi l’anima all’udir le grida” (Diogene Laerzio; VIII, 36).
Senofane sarà ricordato come il grande esule, giramondo, che per un certo tempo visse anche a Zancle (Messina) ed a Catania. Nacque nel 565 a.C. circa a Colofone, in Asia Minore, e mori forse ad Elea (Lucania) nel 470 a.C. Timeo dice che il filosofo ebbe rapporti con Gerone di Siracusa. Per la Theologumena Arithmetica “Infatti si calcolano con la massima approssimazione 514 anni dalla guerra troiana sino a Senofane il fisico e fino ai tempi di Anacreonte e Policrate e fino all’aggressione e devastazione degli Ioni ad opera di Arpago il Medo, fuggendo la quale i Focesi fondarono Massalia” (44,b,13, in I Presocratici, op. cit.). “Son già sessantasette anni che porto in giro per l’Ellade i miei affanni e i miei pensieri. Ed a questi sono da aggiungere i venticinque anni trascorsi dalla nascita, se so dire il vero intorno a queste cose”. (Diogene Laerzio IX, 19; op. cit.). Fu contemporaneo di Empedocle di Agrigento e i due ebbero modo di conoscersi e confrontarsi; l’agrigentino gli fece un giorno osservare che era impossibile riuscire a trovare un uomo sapiente: ‘E’ naturale, perché bisogna che sia sapiente chi vuol riconoscere un sapiente’, rispose il rapsodo. Col siciliano ebbe in comune la visione democratica di governo: i tiranni, disse, o sono molto gradevoli o devono essere rarissimi. Forse fu il fondatore della scuola detta Eleatica, che forgiò Zenone e Parmenide. Agli Eleati, che gli chiesero se era saggio o meno offrire sacrifici oppure canti lamentosi a Leucotea, rispose di non elevare lamenti se essi la ritenevano una dea, e di non dedicarle sacrifici se la consideravano una mortale (Aristotele, Retorica, B, 23; confronta con Plutarco, Sulla superstizione, XIII). Sempre da Plutarco apprendiamo come Senofane si difese dall’accusa d’essere un vile per essersi rifiutato di giocare ai dadi, accusa buttatagli da Laso figlio di Ermione: ammise d’essere molto vile di fronte alle cose inique (De vitioso pudore, 5; in I presocratici, op. cit.). Scrisse Senofane elegie e giambi indirizzati solo a sminuire le qualità di Esiodo ed Omero, le due basi dell’epica classica. Non condivideva quanto da loro narrato descrivendo la vita e le azioni degli dei in tutto simili alle abitudini e attitudini umane. Ma non pare fossero stati solo i due poeti il bersaglio dei suoi dardi critici che appaiono infuocati di livore: osteggiò le dottrine di Talete e di Pitagora, altro fondamento stavolta filosofico – della cultura ellenica. Un suo concetto teorico sostiene che nell’universo possono esistere molteplici cose solo quando subentra l’azione dell’intelligenza per distinguerle. E il Dio, per l’eternità, è per lui solo pensiero e ragione; in questo ha una modernità di pensiero affascinante; ma non possiamo considerarla tale concezione simile alla nostra – Dio fece l’uomo a sua immagine – in quanto il Dio di Senofane è una sfera che “vede ed ascolta ma non respira”. E può essere raggiunto con l’uso dell’intelletto, escludendo le rivelazioni sempre mutevoli dei sensi, di natura opposta a quella dell’Ente supremo ed immobile. A leggere delle varie tesi riportate dalle fonti non si è trovato chi sia stato suo maestro; forse siamo nel giusto se lo consideriamo un ribelle alla cultura ufficiale del tempo, e più per temperamento che per una sua diversa concezione del mondo. La sua produzione poetica venne da lui pure mostrata alla maniera dei rapsodi, cioè come cantore girovago dei canti omerici – e comprende dei canti celebrativi: La fondazione di Colofone e la Colonizzazione di Elea d’Italia (IX, 20). Alla fine dei suoi circa novanta anni di vita Senofane venne sepolto dopo i suoi figli; e si tramanda che egli li seppelli colle sue mani. E per dir lode del suo animo si racconta che egli vedendo un giorno un cane che veniva bastonato, intervenne presso il padrone dicendo: “Cessa, non percuoterlo, poiché d’un uomo, un amico, riconobbi l’anima all’udir le grida” (Diogene Laerzio; VIII, 36).
Senofane, dunque, nacque a Colofone e fu contemporaneo di Pitagora: pure lui dovette fuggire dalla patria e scrisse in ionico, ma non in prosa, allontanandosi così da Anassimandro, che aveva introdotto con il suo scritto la prosa. Senofane visse molto a lungo e passò la sua vita girovagando qua e là. Egli scriveva usando un metro simile a quello omerico e pur usando il metro è un filosofo a tutti gli effetti: il fatto che un filosofo si serva del metro è riconducibile al suo spirito divulgativo: voleva far conoscere i suoi scritti al maggior numero di persone. Egli affronta diversi argomenti tra i quali spicca la dura critica rivolta ai poeti per il loro modo di concepire la divinità. Senofane voleva riformare il concetto di divinità rendendolo più puro e questo suo atteggiamento gli valse l’appellativo di “illuminista”. Pur usando un verso simile a quello omerico, egli critica aspramente i poeti ed in particolare Omero ed Esiodo. Senofane scrive così: “Omero ed Esiodo hanno attribuito agli dei tutto quanto presso gli uomini è oggetto di onta e di biasimo: rubare, fare adulterio e ingannarsi reciprocamente”. Secondo Senofane i due errori dei poeti sono: 1) di natura etica: se il divino deve rappresentare la perfezione ed il modello per gli umani, si deve rifiutare che gli dei abbiano caratteristiche riprovevoli perfino per gli uomini; 2) vi è una condanna dell’antropomorfismo: gli dei erano comunemente rappresentati simili agli uomini e questo era un grande gesto di presunzione del genere umano che Senofane non era disposto ad accettare. Questa sua critica emerge tutta in queste parole: “ma i mortali sono convinti che gli dei siano nati e che abbiano abito a linguaggio e aspetto come loro”. Anche qui troviamo una forte critica nei confronti di Omero (quando dice “che abbiano abito linguaggio e aspetto…”) e di Esiodo (quando dice “siano nati…”: Esiodo è infatti autore della Teogonia, quella sorta di Bibbia dei Greci in cui è narrata la nascita degli dei). Senofane critica con un esperimento mentale l’antropomorfismo: “ma se i buoi (ed i cavalli) e i leoni avessero mani e potessero con le loro mani disegnare e fare ciò che gli uomini sanno fare, i cavalli disegnerebbero figure di dei simili ai cavalli e i buoi simili ai buoi, e farebbero corpi foggiati così come ciascuno di loro è foggiato”; da questo esperimento mentale emerge innanzitutto l’importanza della mano, che è l’elemento che divide il mondo animale da quello umano: essa permette all’uomo di stabilire rapporti complessi con la realtà. Senofane poi sostiene che ci sia una tendenza sbagliata: quella di crearsi gli dei a propria immagine e somiglianza. Questa critica emerge anche in un altro frammento conservatosi: “gli Etiopi dicono che i loro dei sono camusi e neri, i Traci che sono cerulei di occhi e rossi di capelli”. Questa è – per così dire – la pars distruens della filosofia di Senofane: egli smonta qui le tesi già esistenti a riguardo delle divinità per presentarne altre totalmente rinnovate. Vi è poi una parte che risulta particolarmente difficile da comprendere: “Uno, dio, tra gli dei e tra gli uomini il più grande, nè per aspetto simile ai mortali, nè per intelligenza”; pare quasi che Senofane sia monoteista (parla di un dio solo), poi vi è la contrapposizione tra un dio e altri. Nel nostro mondo la contrapposizione tra monoteismo e politeismo è forte, ma all’epoca doveva essere più attenuata: vi era una proliferazione di dei e solo le persone di maggior spicco culturale erano monoteiste (il concetto è un po’ simile a quello nostro della proliferazione dei santi). L’idea predominante nel mondo greco è quella di ritenere il ) anche se le divinità sono tante. Va però fatta per Senofane un’osservazione: l’espressione “tra gli dei e tra gli uomini” poteva benissimo divino come unica realtà (το θειον essere formulare, un modo di dire di allora per sottolineare la potenza del dio: quindi l’espressione “tra gli dei” non è usata in senso proprio come se vi fossero davvero divinità in gioco. Giustamente Senofane è stato considerato il primo teologo, vale a dire argomentatore razionale del divino. Vi è anche un accenno alla “teologia negativa”: partendo dall’impossibilità di rappresentare la divinità con pezzi di realtà, al posto di dire ciò che la divinità è, si dice ciò che non è. Senofane dice poi: “sempre nell’identico luogo permane senza muoversi per nulla, nè gli si addice recarsi or qui, or là”; gli dei omerici dovevano scendere dall’Olimpo per interagire nel mondo e dovevano quindi spostarsi fisicamente. Senofane non accetta questo e afferma che la divinità sia immobile, ma ciononostante può muovere tutto (“ma senza fatica con la forza del pensiero tutto scuote”). Senofane dice poi, in riferimento alla divinità,: “tutto intero vede, tutto intero pensa, tutto intero ode”: dato che non si può rappresentare la divinità attribuendole caratteristiche della realtà, un buon modo di rappresentarla per Senofane è questo: mentre in noi il vedere, il sentire etc. si realizzano un po’ alla volta, in sequenza, nella divinità si realizzano tutte contemporaneamente. Così come per Alcmeone, anche per Senofane c’è distinzione tra il sapere certo degli dei e l’opinare congetturando degli uomini (“il certo nessuno mai lo ha colto nè alcuno ci sarà che lo colga e relativamente agli dei e relativamente a tutte le cose di cui parlo. Infatti, se anche uno si trovasse per caso a dire, come meglio non si può, una cosa reale, tuttavia non la conoscerebbe. Perchè a tutti è dato solo l’opinare”). Comunque il fatto che gli uomini possano solo opinare non ha solo connotazioni negative: significa che l’uomo applicandosi e usando bene la sua mente può conoscere. Senofane è del parere (un po’ come lo siamo noi) che l’uomo parta dal basso per raggiungere col tempo l’alto tramite i suoi sforzi; a proposito egli dice: “non è che da principio gli dei abbiano rivelato tutte le cose ai mortali, ma col tempo essi cercando ritrovano il meglio”). Senofane, oltre a rifondare il concetto di divino, lo depura dalle manifestazioni naturali: l’arcobaleno, per esempio, era visto come fenomeno divino (esso si identificava con la dea Iride); per Senofane è solo un fenomeno naturale che non ha nulla a che fare con il divino: “quella che chiamano Iride è anch’essa una nuvola che presenta alla vista delle colorazioni purpuree scarlatte e verdastre”. Secondo l’autorevole testimonianza di Platone (Sofista), Senofane sarebbe stato il capostipite dell’eleatismo. Il punto di partenza della sua riflessione è costituito dalla critica alle concezioni antropomorfe della divinità: facile comprendere perché Platone scorgesse in lui l’archegeta dell’eleatismo: introducendo una sola divinità, Senofane finiva per proporre quell’unità tanto cara a Parmenide e ai suoi discepoli. Se è sbagliato propugnare l’antropomorfismo degli dèi, altrettanto sbagliato è, nell’ottica di Senofane, ritenere che la conoscenza divina sia paragonabile a quella umana: il sapere proprio della divinità è infatti incommensurabilmente superiore rispetto a quello umano, e gli uomini, nella migliore delle ipotesi, possono acquisire qualche certezza dopo aver percorso un faticoso itinerario conoscitivo; il tema della conoscenza come tortuosa via da percorrere sarà ripreso e approfondito da Parmenide stesso. Senofane dubitava fortemente che la divinità aiutasse gli uomini a conoscere, mettendo in questo modo l’accento sulla responsabilità umana della conoscenza: senza godere di aiuti divini, l’uomo è responsabile e artefice della propria conoscenza. Naturalmente, con la maggiore indipendenza dell’umano dal divino aumenta la fragilità della situazione umana, poiché gli uomini devono agire solo in virtù delle proprie forze, in quanto la divinità non ha fatto loro alcun dono (né le tecniche né il sapere). La prospettiva è piuttosto simile a quella di Alcmeone, ma diversa è la soluzione: se per il filosofo di Crotone agli uomini non restava che congetturare, secondo Senofane, invece, l’unica arma conoscitiva di cui essi dispongano è quella che egli definisce, introducendo un termine destinato al successo, δοκος, l’opinione. La conoscenza umana è, dunque, essenzialmente opinione, nemmeno congettura; il termine “opinione” suggerisce, tra l’altro, l’idea di una instabilità del sapere umano, suscettibile di essere vero o falso. Ma Senofane lascia una via per sperare: agli uomini è infatti concesso di avanzare verso il meglio, verso cioè opinioni migliori. La superiore intelligenza della divinità, ovvero le superiori attività percettive e intellettive che la contraddistinguono, dice Senofane, sono tali perché coinvolgono la divinità nella sua totalità: gli uomini con un senso vedono, con un altro gustano, con un altro ancora odono, e così via, mentre la divinità non presenta, nella sua interezza, distinzioni sensoriali. Ciò non toglie, però, che, pur nella loro notevole inferiorità, gli uomini possano acquisire conoscenze via via migliori: ” non è che in principio gli dèi abbiano rivelato tutte le cose ai mortali; ma col tempo, ricercando, essi trovano il meglio “. La conseguenza necessaria di questa riflessione è che, procedendo per opinioni, il sapere umano non potrà mai raggiungere certezze, ma solo, come abbiamo già detto, opinioni più accreditate di altre. Sotto questo profilo, anche quando crediamo di dare una definizione esatta di qualcosa, in realtà ci muoviamo comunque nell’ambito dell’opinione: ciascuno di noi può esprimere a parole nel migliore dei modi ciò che qualcosa è, ma non per questo può conoscere con certezza, nel suo linguaggio, la cosa stessa.
PARMENIDE
 Parmenide fondò ad Elea, nell’attuale Campania, una vera e propria scuola filosofica e diede inizio alla corrente di pensiero eleatica che vede in Zenone e Melisso due discepoli e sostenitori. Parmenide fu attivo ad Elea verso il 500 a.c., nacque da famiglia aristocratica e avrebbe contribuito alla legislazione della città. Permangono dubbi a proposito del suo possibile soggiorno ad Atene insieme al discepolo Zenone, dove avrebbe incontrato Socrate. Il tema della ricerca è molto sentito da Parmenide, ma è la divinità stessa ad indicare la via che occorre percorrere. Spesso la corrente di pensiero fondata da Parmenide viene denominata “monismo eleatico” per il fatto che essi, se vogliamo riallacciandosi ai Milesi e distaccandosi dai Pitagorici, sostenevano che tutto fosse riconducibile ad un unico principio. In realtà la tradizione antica vuole che il fondatore della scuola di Elea fosse Senofane, partendo da due presupposti; in primo luogo Senofane aveva girato mezzo mondo ed era pure passato ad Elea. In secondo luogo, il tema centrale degli eleatici era l’unitarietà dell’essere, tema già presente in Senofane. Però al giorno d’oggi sappiamo che questo è davvero improbabile: è vero che Senofane predicava l’unitarietà, l’immutabilità, l’eternità e tutte le altre cose che predicavano gli eleatici, ma egli le riferiva interamente alla divinità, mentre gli eleatici le riferivano all’essere. Senofane era un teologo, Parmenide un ontologo: il concetto dell’essere è molto più astratto di quello della divinità. Gli eleatici sostengono l’immobilità della causa e così essa viene a mancare in quanto la sua funzione è quella di spiegare a che cosa è dovuto il cambiamento, che per loro non esiste: l’essere è immutabile. La parola essere (in greco “tò on”, ciò che è) è proprio a partire da Parmenide che entra nell’uso filosofico. Egli fece un ragionamento che comportò un enorme passo avanti verso l’astrazione : notò infatti che tutti gli enti sono tra loro diversi, ma che hanno in comune il fatto di essere, di esistere. Abbiamo detto che egli fu un ontologo: ma cosa significa ? L’ontologo è colui che studia ” l’essere in quanto essere ” (come dice Aristotele), vale a dire le caratteristiche di tutto quel che esiste. Aristotele ci parla di Parmenide e dice che studiava l’essere secondo definizione: si tratta quindi di indagare secondo definizione: la differenza tra Parmenide e gli altri pensatori sta proprio nel fatto che egli non iniziava la sua indagine partendo da constatazioni empiriche per arrivare alle conclusioni; lui partiva dalla definizione di cosa è l’essere e tramite una serie di deduzioni arrivava alle conseguenze, spesso in netta contrapposizione con le testimonianze dei sensi. Parmenide non accenna mai alla realtà empirica. Arriva ad esplicitare due tautologie: a) l’essere è b) l’essere non è. Parmenide scrisse un poema in esametri (proprio come Senofane ed Empedocle), intitolato “Sulla natura” (Περι φυσεως), di cui ci rimangono frammenti. Mentre Senofane si serviva dell’esametro per avere maggior successo sugli ascoltatori e perchè la sua opera si divulgasse il più possibile, Parmenide scriveva in esametri perchè descriveva argomenti divini e quindi il verso epico era il miglior verso per parlare di tali argomenti. L’opera era strutturata in un proemio e due parti successive: proprio alla fine del proemio la divinità spiega che ci sono 3 vie da seguire: 1) L’essere è 2) L’essere non è 3) Si mescolano insieme l’essere ed il non essere. La seconda via verrà dichiarata impraticabile e puramente teoretica: è infatti impossibile dire o pensare ciò che non è. La terza via è quella che imboccano i comuni mortali, che mescolano l’essere con il non essere per esempio i mortali parlano di nascere e morire, il che implica una mescolanza di essere e di non essere : nascere vuol dire essere, ma anche non essere prima di essere e morire vuol dire non essere, ma anche essere prima di non essere .Il criterio per giudicare scorretto il linguaggio degli uomini non è la sua corrispondenza a quanto ci è testimoniato dai sensi: a questi infatti appaiono oggetti che nascono e che muoiono. Ma il verdetto di Parmenide sul linguaggio e sulle opinioni degli uomini, collegate a quel tipo di linguaggio, non assume a criterio di giudizio le apparenze fornite dai sensi, bensì il contenuto logico delle parole usate dagli uomini. Essi infatti usano parole nelle quali si trova mescolato in modo contraddittorio ciò che è disgiunto radicalmente, ossia essere e non essere. Con i termini ” è ” ed” essere ” Parmenide intende probabilmente una molteplicità di cose. Infatti dire che qualcosa è, può significare che esso è presente o che esso esiste o che è qualcosa o che è vero. Tutti questi significati sono presenti nell’essere di Parmenide. Solo ciò che è può essere propriamente pensato e detto: questo comporta un necessario legame tra ESSERE, PENSIERO e LINGUAGGIO. Partendo dalla disgiunzione assoluta tra” é” e “non è “, Parmenide procede quindi ad individuare quali sono le proprietà di ciò di cui si può propriamente pensare o dire che è. Egli introduce in tal modo una procedura che resterà essenziale per il ragionamento non solo filosofico, ma anche matematico. Si tratta della DEDUZIONE, vale a dire il ragionamento che partendo da proposizioni ammesse come premesse ricava delle conclusioni: si parte da definizioni e verità generali per passare in modo logico a nuove verità più particolareggiate. In particolare Parmenide mette in opera una particolare forma di deduzione consistente nella cosiddetta DIMOSTRAZIONE PER ASSURDO, della quale Zenone farà la base per la sua filosofia. Essa assume come premesse il contrario di ciò che si vuole dimostrare e ne deduce una serie di conseguenze contraddittorie o errate. E poichè queste conseguenze sono errate, ne risulta che sono errate le premesse a partire dalle quali sono ricavate. Il risultato è che saranno vere le premesse contrarie a quelle errate. E’ proprio con la dimostrazione per assurdo che Parmenide dimostra l’immutabilità, l’immobilità, l’indivisibilità e l’unicità dell’essere. Ammettiamo che l’essere muti: ne consegue che esso è ciò che non era prima o non è ciò che era prima. Ma in tal modo si attribuisce a una stessa cosa l’essere e il non essere, il che va contro quel carattere di disgiunzione assoluta tra” é “e” non è”, assunto come necessario all’inizio. Per evitare tale contraddizione, diventa allora necessario concludere esattamente l’opposto, ossia che l’essere non muta. Lo stesso vale per dimostrare l’unicità: se l’essere fosse molteplice occorrerebbe riconoscere che ciascuno di questi molteplici è se stesso e non è altri e pertanto nuovamente sarebbe e non sarebbe. L’essere è immobile: ammettiamo che si muova; una cosa è mobile quando si muove da una cosa ad un’altra: l’essere quindi si dovrebbe muovere verso qualcosa di diverso da se stesso. Ma il diverso dall’essere è il non essere, che non esiste: quindi l’essere è immobile. Tra le proprietà dell’essere Parmenide introduce anche il carattere finito di esso: infatti se fosse infinito sarebbe incompiuto e quindi mancherebbe di qualcosa; ma se manca di qualcosa vuol dire che non è ciò di cui manca. Anche la nozione di infinito quindi comporta una mescolanza contradditoria di essere e non essere. Per questo Parmenide paragona “ciò che è” (το ov) ad una sfera compatta, la quale esprime nel miglior modo possibile il carattere di compiutezza e totalità che caratterizza l’essere. La prima parte dell’opera si chiamava “ALETHEIA” (αληθηια “verità”, dal verbo “λανθανω” : la verità è ciò che non si nasconde) e rappresenta la prima via e la verità di primo livello. L’ altra parte dell’opera si chiamava “DOXA” (δοξα “opinione”) e rappresentava la seconda via e la verità di secondo livello. Nell’ Aletheia Parmenide fa considerazioni sull’essere mentre nella Doxa presenta una sorta di mezza verità, dove cerca di rendere compatibile la testimonianza dei sensi con la verità vera e propria: è come se cercasse un’interpretazione del mondo fisico compatibile con i sensi, con il modo in cui lo vediamo, e non in contrasto con l’Aletheia. Del proemio del “Περι φυσεως” possediamo molto, della Doxa invece abbiamo solo pochi frammenti e questo testimonia che era ritenuta contraddittoria perchè dà l’impressione che Parmenide voglia distaccarsi da quanto aveva affermato più volte in precedenza: ciò che capiamo con la ragione va seguito anche se è in contrasto con ciò che ci dicono i sensi. Va riscontrato che Aristotele mentre ci parla di Parmenide nella “Metafisica” prende un’enorme cantonata: dice infatti che secondo Parmenide il caldo si identifica con l’essere ed il freddo con il non essere. Ma passiamo ora ad esaminare il proemio dell’opera di Parmenide: egli racconta di aver compiuto un viaggio verso la verità, voluto dal Cielo. La metafora del viaggio resterà rimarrà una costante nella riflessione antica: dal termine “hodos” (οδος via, strada) si verrà formando già in Platone il termine ” methodos ” (μετα τον οδον, ciò che sta oltre al viaggio: il percorso che conduce alla verità), ma il concetto di hodòs risulta centrale anche per tutta la prima parte del poema. L’iniziativa del viaggio tuttavia e soprattutto la direzione che esso assume non dipende da Parmenide, sebbene egli ne sia protagonista, bensì dalle dee che lo guidano, così come varcata la porta che separa i due domini delle tenebre e della luce, sarà la dea a comunicargli quale via di ricerca egli dovrà, in futuro, percorrere. Il racconto di Parmenide riguarda dunque non una rivelazione già tutta compiuta ; questa infatti fornisce solo i caratteri generali della via lungo la quale occorrerà proseguire la ricerca e soprattutto formula i divieti relativi alle vie che non bisogna percorrere, cioè quelle comunemente battute dagli uomini in preda alle opinioni. Parmenide non dice mai chi siano esattamente le dee che lo guidano, ma sono collegate ad un qualcosa che materialmente non esiste ed è solo frutto della nostra immaginazione in qualche misura esiste: anche un drago per il fatto che viene pensato in qualche misura esiste. Man mano che prosegue il viaggio, salta fuori che in realtà le vie non sono 2, ma 3: la terza è quella che seguono quasi tutti i mortali, dove si mescolano con il culto del Sole e quindi con Apollo. Il percorso che deve affrontare Parmenide conduce dalle tenebre (l’ignoranza) alla luce (la conoscenza); ad un certo punto, mentre il carro su cui è Parmenide sta procedendo velocemente, le dee si tolgono i veli: questo gesto simbolico rappresenta la rivelazione. La metafora tra l’altro spiega che ciò che viene disvelato e ciò che disvela sono lo stesso: si tratta sempre delle dee; è come se l’essere stesso rivelasse la via da percorrere. Parmenide e dee giungono alla porta che separa il giorno dalla notte: descrivendo questo portale Parmenide non fa nient’altro che descrivere l’assetto urbanistico della sua città, Elea, dove esisteva sul serio una porta: essa divideva la parte alta e aristocratica della città (l’acropoli) da quella bassa e popolare. Per aprire la porta è necessario l’intervento della Giustizia (Δικη): le dee stesse la convincono con discorsi suasori ad aprirla. L’oggetto della rivelazione è quindi l’essere, ma attenzione: non è che sia la divinità a darcelo: l’essere, la divinità, il principio sono la stessa cosa: è un’autorivelazione dell’essere e va intesa come spiegazione di quali siano le vie da seguire; la ricerca è l’uomo stesso a farla . Ma non è un percorso che possono fare tutti gli uomini: quello di Parmenide è un percorso solo suo, che nessun altro uomo può fare. La verità stessa impone determinate vie da seguire. Le dee dicono a Parmenide di imparare a conoscere due cose: A) il cuore non scosso ed immobile della Verità, la quale è ben rotonda (come una sfera compatta) B) le opinioni instabili e campate per aria dei mortali: la conoscenza infatti si perfeziona quando oltre a conoscere le cose perfette si conoscono le imperfezioni. Le dee dicono che non si deve fondare il sapere sull’esperienza perchè essa è dettata dai sensi nè sulla lingua, che attribuisce i nomi alle cose, ma si deve ponderare con la ragione. La rivelazione divina non implica che l’uomo non debba cercare di conoscere con il raziocinio. Vengono a Parmenide presentate le vie PENSABILI: il termine greco per pensabili è “νοησαι” che può voler dire sia ” pensabili ” sia ” per pensare”: entrambe le traduzioni sono quindi accettabili. Una via dice che l’essere è e non può non essere, l’altra che l’essere non è e che può non essere. La prima via è quindi effettivamente percorribile ed è caratterizzata dalla verità e dalla persuasione: la Verità è infatti in grado di persuadere. L’altra strada è contraddittoria ed impercorribile. Il testo in questione presenta diverse difficoltà di interpretazione, la più valida delle quali è che solo l’essere è pensabile e dicibile, mentre il non essere è impensabile ed indicibile: la prima via risulta quindi percorribile in quanto pensabile, l’altra no: è qui che emerge maggiormente l’identità parmenidea tra essere e pensare. Ma tutto questo si presta a più interpretazioni: per esempio potrebbe voler dire che se l’unica cosa che è è l’essere, allora il pensiero, dato che è, fa parte dell’essere come tutti gli altri enti. Ma potrebbe anche voler dire che tutto ciò che diciamo e pensiamo è anche se pensiamo ad un qualcosa che materialmente non esiste ed è solo frutto della nostra immaginazione in qualche misura esiste: anche un drago per il fatto che viene pensato in qualche misura esiste. Man mano che prosegue il viaggio, salta fuori che in realtà le vie non sono 2, ma 3: la terza è quella che seguono quasi tutti i mortali, dove si mescolano l’essere ed il non essere: Parmenide li chiama ” uomini dalla doppia testa ” perchè affermano simultaneamente che l’essere è e non è: si tratta di gente stolta ed indecisa, dice Parmenide. Egli muove poi un’aspra critica ad Eraclito ed alla sua concezione del divenire, piena di mescolanza di essere e non essere (ricordiamoci che Parmenide negava che l’essere potesse muoversi e mutare), e a quella di molteplicità. Parmenide dice che questa terza via va assolutamente purificata e resa scevra di errori, affinchè risulti almeno parzialmente compatibile con la Verità della prima via. La seconda invece va assolutamente scartata. Parmenide dà poi una raffinata ed elegante definizione di eternità: l’essere non era nè sarà, perchè è ora tutt’insieme: una cosa è davvero eterna quando è fuori dal tempo. Ma Parmenide non si limita ad affermare, ma dimostra anche: l’essere infatti non può nè nascere nè morire (come dicono i comuni mortali). Ipotizziamo che l’essere nasca: da sè non può nascere e quindi deve nascere da qualcosa che non sia lui stesso: deve essere quindi un qualcosa che non sia essere: ma ciò che non è essere è non essere: ma il non essere non è, di conseguenza l’essere non nasce nè muore. Parmenide dice poi per dissipare definitivamente ogni dubbio sul fatto che l’essere nè nasca nè muoia: che motivo avrebbe mai avuto per nascere ad un certo momento? Tuttavia anche un astratto come Parmenide ha avuto bisogno di ricorrere all’incarnazione dell’astratto (l’essere) in qualcosa di concreto (la sfera tonda e compatta): però va detto che quello della sfera potrebbe essere un semplice paragone e non un’effettiva incarnazione. Dunque Parmenide prova a correggere gli errori dei mortali: il loro primo errore consiste nell’individuazione di due principi della realtà tra loro antitetici: la luce e le tenebre. Il loro è una sorta di pitagorismo esposto in termini fisici. La luce è un principio più attivo, corrispondente al fuoco, le tenebre sono più passive e corrispondono alla terra. Ma accanto a questo errore Parmenide ne individua un altro più grossolano: hanno contrapposto tra loro questi due principi. Ammettiamo di poter interpretare la realtà in termini di luce e tenebre, evitando però di contrapporle e considerarle l’una l’essere e l’altra il non essere. In fondo quello degli esseri mortali comuni non è un errore poi così grave: è vero che hanno mescolato l’essere con il non essere, però se andiamo a vedere nè con la luce nè con le tenebre c’è il nulla, il non essere. I mortali sono stati ” bravi ” a non incappare nella seconda via. Sempre a proposito dell’opera di Parmenide possiamo concludere dicendo che mentre nell’ Aletheia troviamo un Parmenide brillante e convinto di ciò che sta dicendo, nella Doxa egli appare più restio e meno convinto. E’ come se Parmenide, dopo aver sostenuto che bisogna fidarsi solo di ciò che ci dice la ragione, avesse avuto paura di quanto detto perchè portava troppo fuori dalle testimonianze dei sensi e volesse come se scusarsi nella Doxa. Va poi detto che nessuno leggendo il testo di Parmenide si fa convincere a riguardo di quanto egli dice: seguendo il ragionamento logico ci si accorge che Parmenide ha ragione, ma le conclusioni paradossali impediscono al lettore di credere a quanto egli dice. Platone dirà di aver commesso il “parricidio di Parmenide”: si accorgerà infatti che Parmenide aveva commesso un errore a riguardo dei significati dell’essere: Aristotele individua tre modi di intendere l’essere: 1) univoco (l’essere ha un solo significato) 2) biunivoco (l’essere ha equivocità, può essere inteso in più modi) 3)analogico (il verbo essere ha diversi significati ma tutti connessi tra loro). Aristotele lo intendeva in modo analogico, Parmenide in modo univoco: per lui essere significa solo esistere. Dunque Platone farà notare che dire ad esempio ” questo libro non è ” non vuol dire predicare il non essere : infatti si può dire ” questo libro non è una penna”: è l’essere diversamente, dove l’essere assume il valore di copula.
Parmenide fondò ad Elea, nell’attuale Campania, una vera e propria scuola filosofica e diede inizio alla corrente di pensiero eleatica che vede in Zenone e Melisso due discepoli e sostenitori. Parmenide fu attivo ad Elea verso il 500 a.c., nacque da famiglia aristocratica e avrebbe contribuito alla legislazione della città. Permangono dubbi a proposito del suo possibile soggiorno ad Atene insieme al discepolo Zenone, dove avrebbe incontrato Socrate. Il tema della ricerca è molto sentito da Parmenide, ma è la divinità stessa ad indicare la via che occorre percorrere. Spesso la corrente di pensiero fondata da Parmenide viene denominata “monismo eleatico” per il fatto che essi, se vogliamo riallacciandosi ai Milesi e distaccandosi dai Pitagorici, sostenevano che tutto fosse riconducibile ad un unico principio. In realtà la tradizione antica vuole che il fondatore della scuola di Elea fosse Senofane, partendo da due presupposti; in primo luogo Senofane aveva girato mezzo mondo ed era pure passato ad Elea. In secondo luogo, il tema centrale degli eleatici era l’unitarietà dell’essere, tema già presente in Senofane. Però al giorno d’oggi sappiamo che questo è davvero improbabile: è vero che Senofane predicava l’unitarietà, l’immutabilità, l’eternità e tutte le altre cose che predicavano gli eleatici, ma egli le riferiva interamente alla divinità, mentre gli eleatici le riferivano all’essere. Senofane era un teologo, Parmenide un ontologo: il concetto dell’essere è molto più astratto di quello della divinità. Gli eleatici sostengono l’immobilità della causa e così essa viene a mancare in quanto la sua funzione è quella di spiegare a che cosa è dovuto il cambiamento, che per loro non esiste: l’essere è immutabile. La parola essere (in greco “tò on”, ciò che è) è proprio a partire da Parmenide che entra nell’uso filosofico. Egli fece un ragionamento che comportò un enorme passo avanti verso l’astrazione : notò infatti che tutti gli enti sono tra loro diversi, ma che hanno in comune il fatto di essere, di esistere. Abbiamo detto che egli fu un ontologo: ma cosa significa ? L’ontologo è colui che studia ” l’essere in quanto essere ” (come dice Aristotele), vale a dire le caratteristiche di tutto quel che esiste. Aristotele ci parla di Parmenide e dice che studiava l’essere secondo definizione: si tratta quindi di indagare secondo definizione: la differenza tra Parmenide e gli altri pensatori sta proprio nel fatto che egli non iniziava la sua indagine partendo da constatazioni empiriche per arrivare alle conclusioni; lui partiva dalla definizione di cosa è l’essere e tramite una serie di deduzioni arrivava alle conseguenze, spesso in netta contrapposizione con le testimonianze dei sensi. Parmenide non accenna mai alla realtà empirica. Arriva ad esplicitare due tautologie: a) l’essere è b) l’essere non è. Parmenide scrisse un poema in esametri (proprio come Senofane ed Empedocle), intitolato “Sulla natura” (Περι φυσεως), di cui ci rimangono frammenti. Mentre Senofane si serviva dell’esametro per avere maggior successo sugli ascoltatori e perchè la sua opera si divulgasse il più possibile, Parmenide scriveva in esametri perchè descriveva argomenti divini e quindi il verso epico era il miglior verso per parlare di tali argomenti. L’opera era strutturata in un proemio e due parti successive: proprio alla fine del proemio la divinità spiega che ci sono 3 vie da seguire: 1) L’essere è 2) L’essere non è 3) Si mescolano insieme l’essere ed il non essere. La seconda via verrà dichiarata impraticabile e puramente teoretica: è infatti impossibile dire o pensare ciò che non è. La terza via è quella che imboccano i comuni mortali, che mescolano l’essere con il non essere per esempio i mortali parlano di nascere e morire, il che implica una mescolanza di essere e di non essere : nascere vuol dire essere, ma anche non essere prima di essere e morire vuol dire non essere, ma anche essere prima di non essere .Il criterio per giudicare scorretto il linguaggio degli uomini non è la sua corrispondenza a quanto ci è testimoniato dai sensi: a questi infatti appaiono oggetti che nascono e che muoiono. Ma il verdetto di Parmenide sul linguaggio e sulle opinioni degli uomini, collegate a quel tipo di linguaggio, non assume a criterio di giudizio le apparenze fornite dai sensi, bensì il contenuto logico delle parole usate dagli uomini. Essi infatti usano parole nelle quali si trova mescolato in modo contraddittorio ciò che è disgiunto radicalmente, ossia essere e non essere. Con i termini ” è ” ed” essere ” Parmenide intende probabilmente una molteplicità di cose. Infatti dire che qualcosa è, può significare che esso è presente o che esso esiste o che è qualcosa o che è vero. Tutti questi significati sono presenti nell’essere di Parmenide. Solo ciò che è può essere propriamente pensato e detto: questo comporta un necessario legame tra ESSERE, PENSIERO e LINGUAGGIO. Partendo dalla disgiunzione assoluta tra” é” e “non è “, Parmenide procede quindi ad individuare quali sono le proprietà di ciò di cui si può propriamente pensare o dire che è. Egli introduce in tal modo una procedura che resterà essenziale per il ragionamento non solo filosofico, ma anche matematico. Si tratta della DEDUZIONE, vale a dire il ragionamento che partendo da proposizioni ammesse come premesse ricava delle conclusioni: si parte da definizioni e verità generali per passare in modo logico a nuove verità più particolareggiate. In particolare Parmenide mette in opera una particolare forma di deduzione consistente nella cosiddetta DIMOSTRAZIONE PER ASSURDO, della quale Zenone farà la base per la sua filosofia. Essa assume come premesse il contrario di ciò che si vuole dimostrare e ne deduce una serie di conseguenze contraddittorie o errate. E poichè queste conseguenze sono errate, ne risulta che sono errate le premesse a partire dalle quali sono ricavate. Il risultato è che saranno vere le premesse contrarie a quelle errate. E’ proprio con la dimostrazione per assurdo che Parmenide dimostra l’immutabilità, l’immobilità, l’indivisibilità e l’unicità dell’essere. Ammettiamo che l’essere muti: ne consegue che esso è ciò che non era prima o non è ciò che era prima. Ma in tal modo si attribuisce a una stessa cosa l’essere e il non essere, il che va contro quel carattere di disgiunzione assoluta tra” é “e” non è”, assunto come necessario all’inizio. Per evitare tale contraddizione, diventa allora necessario concludere esattamente l’opposto, ossia che l’essere non muta. Lo stesso vale per dimostrare l’unicità: se l’essere fosse molteplice occorrerebbe riconoscere che ciascuno di questi molteplici è se stesso e non è altri e pertanto nuovamente sarebbe e non sarebbe. L’essere è immobile: ammettiamo che si muova; una cosa è mobile quando si muove da una cosa ad un’altra: l’essere quindi si dovrebbe muovere verso qualcosa di diverso da se stesso. Ma il diverso dall’essere è il non essere, che non esiste: quindi l’essere è immobile. Tra le proprietà dell’essere Parmenide introduce anche il carattere finito di esso: infatti se fosse infinito sarebbe incompiuto e quindi mancherebbe di qualcosa; ma se manca di qualcosa vuol dire che non è ciò di cui manca. Anche la nozione di infinito quindi comporta una mescolanza contradditoria di essere e non essere. Per questo Parmenide paragona “ciò che è” (το ov) ad una sfera compatta, la quale esprime nel miglior modo possibile il carattere di compiutezza e totalità che caratterizza l’essere. La prima parte dell’opera si chiamava “ALETHEIA” (αληθηια “verità”, dal verbo “λανθανω” : la verità è ciò che non si nasconde) e rappresenta la prima via e la verità di primo livello. L’ altra parte dell’opera si chiamava “DOXA” (δοξα “opinione”) e rappresentava la seconda via e la verità di secondo livello. Nell’ Aletheia Parmenide fa considerazioni sull’essere mentre nella Doxa presenta una sorta di mezza verità, dove cerca di rendere compatibile la testimonianza dei sensi con la verità vera e propria: è come se cercasse un’interpretazione del mondo fisico compatibile con i sensi, con il modo in cui lo vediamo, e non in contrasto con l’Aletheia. Del proemio del “Περι φυσεως” possediamo molto, della Doxa invece abbiamo solo pochi frammenti e questo testimonia che era ritenuta contraddittoria perchè dà l’impressione che Parmenide voglia distaccarsi da quanto aveva affermato più volte in precedenza: ciò che capiamo con la ragione va seguito anche se è in contrasto con ciò che ci dicono i sensi. Va riscontrato che Aristotele mentre ci parla di Parmenide nella “Metafisica” prende un’enorme cantonata: dice infatti che secondo Parmenide il caldo si identifica con l’essere ed il freddo con il non essere. Ma passiamo ora ad esaminare il proemio dell’opera di Parmenide: egli racconta di aver compiuto un viaggio verso la verità, voluto dal Cielo. La metafora del viaggio resterà rimarrà una costante nella riflessione antica: dal termine “hodos” (οδος via, strada) si verrà formando già in Platone il termine ” methodos ” (μετα τον οδον, ciò che sta oltre al viaggio: il percorso che conduce alla verità), ma il concetto di hodòs risulta centrale anche per tutta la prima parte del poema. L’iniziativa del viaggio tuttavia e soprattutto la direzione che esso assume non dipende da Parmenide, sebbene egli ne sia protagonista, bensì dalle dee che lo guidano, così come varcata la porta che separa i due domini delle tenebre e della luce, sarà la dea a comunicargli quale via di ricerca egli dovrà, in futuro, percorrere. Il racconto di Parmenide riguarda dunque non una rivelazione già tutta compiuta ; questa infatti fornisce solo i caratteri generali della via lungo la quale occorrerà proseguire la ricerca e soprattutto formula i divieti relativi alle vie che non bisogna percorrere, cioè quelle comunemente battute dagli uomini in preda alle opinioni. Parmenide non dice mai chi siano esattamente le dee che lo guidano, ma sono collegate ad un qualcosa che materialmente non esiste ed è solo frutto della nostra immaginazione in qualche misura esiste: anche un drago per il fatto che viene pensato in qualche misura esiste. Man mano che prosegue il viaggio, salta fuori che in realtà le vie non sono 2, ma 3: la terza è quella che seguono quasi tutti i mortali, dove si mescolano con il culto del Sole e quindi con Apollo. Il percorso che deve affrontare Parmenide conduce dalle tenebre (l’ignoranza) alla luce (la conoscenza); ad un certo punto, mentre il carro su cui è Parmenide sta procedendo velocemente, le dee si tolgono i veli: questo gesto simbolico rappresenta la rivelazione. La metafora tra l’altro spiega che ciò che viene disvelato e ciò che disvela sono lo stesso: si tratta sempre delle dee; è come se l’essere stesso rivelasse la via da percorrere. Parmenide e dee giungono alla porta che separa il giorno dalla notte: descrivendo questo portale Parmenide non fa nient’altro che descrivere l’assetto urbanistico della sua città, Elea, dove esisteva sul serio una porta: essa divideva la parte alta e aristocratica della città (l’acropoli) da quella bassa e popolare. Per aprire la porta è necessario l’intervento della Giustizia (Δικη): le dee stesse la convincono con discorsi suasori ad aprirla. L’oggetto della rivelazione è quindi l’essere, ma attenzione: non è che sia la divinità a darcelo: l’essere, la divinità, il principio sono la stessa cosa: è un’autorivelazione dell’essere e va intesa come spiegazione di quali siano le vie da seguire; la ricerca è l’uomo stesso a farla . Ma non è un percorso che possono fare tutti gli uomini: quello di Parmenide è un percorso solo suo, che nessun altro uomo può fare. La verità stessa impone determinate vie da seguire. Le dee dicono a Parmenide di imparare a conoscere due cose: A) il cuore non scosso ed immobile della Verità, la quale è ben rotonda (come una sfera compatta) B) le opinioni instabili e campate per aria dei mortali: la conoscenza infatti si perfeziona quando oltre a conoscere le cose perfette si conoscono le imperfezioni. Le dee dicono che non si deve fondare il sapere sull’esperienza perchè essa è dettata dai sensi nè sulla lingua, che attribuisce i nomi alle cose, ma si deve ponderare con la ragione. La rivelazione divina non implica che l’uomo non debba cercare di conoscere con il raziocinio. Vengono a Parmenide presentate le vie PENSABILI: il termine greco per pensabili è “νοησαι” che può voler dire sia ” pensabili ” sia ” per pensare”: entrambe le traduzioni sono quindi accettabili. Una via dice che l’essere è e non può non essere, l’altra che l’essere non è e che può non essere. La prima via è quindi effettivamente percorribile ed è caratterizzata dalla verità e dalla persuasione: la Verità è infatti in grado di persuadere. L’altra strada è contraddittoria ed impercorribile. Il testo in questione presenta diverse difficoltà di interpretazione, la più valida delle quali è che solo l’essere è pensabile e dicibile, mentre il non essere è impensabile ed indicibile: la prima via risulta quindi percorribile in quanto pensabile, l’altra no: è qui che emerge maggiormente l’identità parmenidea tra essere e pensare. Ma tutto questo si presta a più interpretazioni: per esempio potrebbe voler dire che se l’unica cosa che è è l’essere, allora il pensiero, dato che è, fa parte dell’essere come tutti gli altri enti. Ma potrebbe anche voler dire che tutto ciò che diciamo e pensiamo è anche se pensiamo ad un qualcosa che materialmente non esiste ed è solo frutto della nostra immaginazione in qualche misura esiste: anche un drago per il fatto che viene pensato in qualche misura esiste. Man mano che prosegue il viaggio, salta fuori che in realtà le vie non sono 2, ma 3: la terza è quella che seguono quasi tutti i mortali, dove si mescolano l’essere ed il non essere: Parmenide li chiama ” uomini dalla doppia testa ” perchè affermano simultaneamente che l’essere è e non è: si tratta di gente stolta ed indecisa, dice Parmenide. Egli muove poi un’aspra critica ad Eraclito ed alla sua concezione del divenire, piena di mescolanza di essere e non essere (ricordiamoci che Parmenide negava che l’essere potesse muoversi e mutare), e a quella di molteplicità. Parmenide dice che questa terza via va assolutamente purificata e resa scevra di errori, affinchè risulti almeno parzialmente compatibile con la Verità della prima via. La seconda invece va assolutamente scartata. Parmenide dà poi una raffinata ed elegante definizione di eternità: l’essere non era nè sarà, perchè è ora tutt’insieme: una cosa è davvero eterna quando è fuori dal tempo. Ma Parmenide non si limita ad affermare, ma dimostra anche: l’essere infatti non può nè nascere nè morire (come dicono i comuni mortali). Ipotizziamo che l’essere nasca: da sè non può nascere e quindi deve nascere da qualcosa che non sia lui stesso: deve essere quindi un qualcosa che non sia essere: ma ciò che non è essere è non essere: ma il non essere non è, di conseguenza l’essere non nasce nè muore. Parmenide dice poi per dissipare definitivamente ogni dubbio sul fatto che l’essere nè nasca nè muoia: che motivo avrebbe mai avuto per nascere ad un certo momento? Tuttavia anche un astratto come Parmenide ha avuto bisogno di ricorrere all’incarnazione dell’astratto (l’essere) in qualcosa di concreto (la sfera tonda e compatta): però va detto che quello della sfera potrebbe essere un semplice paragone e non un’effettiva incarnazione. Dunque Parmenide prova a correggere gli errori dei mortali: il loro primo errore consiste nell’individuazione di due principi della realtà tra loro antitetici: la luce e le tenebre. Il loro è una sorta di pitagorismo esposto in termini fisici. La luce è un principio più attivo, corrispondente al fuoco, le tenebre sono più passive e corrispondono alla terra. Ma accanto a questo errore Parmenide ne individua un altro più grossolano: hanno contrapposto tra loro questi due principi. Ammettiamo di poter interpretare la realtà in termini di luce e tenebre, evitando però di contrapporle e considerarle l’una l’essere e l’altra il non essere. In fondo quello degli esseri mortali comuni non è un errore poi così grave: è vero che hanno mescolato l’essere con il non essere, però se andiamo a vedere nè con la luce nè con le tenebre c’è il nulla, il non essere. I mortali sono stati ” bravi ” a non incappare nella seconda via. Sempre a proposito dell’opera di Parmenide possiamo concludere dicendo che mentre nell’ Aletheia troviamo un Parmenide brillante e convinto di ciò che sta dicendo, nella Doxa egli appare più restio e meno convinto. E’ come se Parmenide, dopo aver sostenuto che bisogna fidarsi solo di ciò che ci dice la ragione, avesse avuto paura di quanto detto perchè portava troppo fuori dalle testimonianze dei sensi e volesse come se scusarsi nella Doxa. Va poi detto che nessuno leggendo il testo di Parmenide si fa convincere a riguardo di quanto egli dice: seguendo il ragionamento logico ci si accorge che Parmenide ha ragione, ma le conclusioni paradossali impediscono al lettore di credere a quanto egli dice. Platone dirà di aver commesso il “parricidio di Parmenide”: si accorgerà infatti che Parmenide aveva commesso un errore a riguardo dei significati dell’essere: Aristotele individua tre modi di intendere l’essere: 1) univoco (l’essere ha un solo significato) 2) biunivoco (l’essere ha equivocità, può essere inteso in più modi) 3)analogico (il verbo essere ha diversi significati ma tutti connessi tra loro). Aristotele lo intendeva in modo analogico, Parmenide in modo univoco: per lui essere significa solo esistere. Dunque Platone farà notare che dire ad esempio ” questo libro non è ” non vuol dire predicare il non essere : infatti si può dire ” questo libro non è una penna”: è l’essere diversamente, dove l’essere assume il valore di copula.
ZENONE DI ELEA
 LA VITA
LA VITA
Anche per Zenone l’unica immagine che possediamo è quella contenuta nel racconto platonico del Parmenide (127 a), nel quale un quarantenne Zenone, «ben fatto e gradevole a vedersi» accompagna Parmenide ad Atene. In base a questo racconto la nascita di Zenone andrebbe collocata nel 490 o subito dopo. Secondo Diogene Laerzio (IX, 29; ma il testo è lacunoso) Apollodoro collocava l’acme di Zenone nell’Olimpiade 79 (464-461), facendone risalire la nascita alla fine del secolo precedente. Non conosciamo nessuna vicenda della sua vita, a meno che si voglia dare valore storico alla narrazione del Parmenide platonico e alla notizia in esso contenuta che Zenone era l’amante di Parmenide. Apollodoro ne faceva invece il figlio adottivo di Parmenide e Ateneo protestava contro quella che considerava un’interpretazione maligna e gratuita di Platone. Una tradizione dice che Zenone non abbandonò mai Elea e in particolare non si recò ad Atene: potrebbe trattarsi di una reazione alla versione platonica. Un altro insieme di notizie concerne le vicende politiche di Zenone, che sarebbe stato fiero oppositore e anche vittima di un tiranno.
Non è sicuro di quale tiranno si trattasse, e anche i particolari della storia, fatta di crudeltà e di astuzie, sembrano fittizi. Zenone vi appare chiaramente come un tipico rappresentante della resistenza filosofica alla tirannide e il suo contrasto con il tiranno è anche occasione per trovate astute e risposte sottili.
IL PENSIERO
A Zenone di Elea, che la tradizione raffigurava come il fedele scolaro di Parmenide, sono stati spesso attribuiti gli aspetti più paradossali dell’eleatismo. Isocrate lo collocava vicino a Protagora, Gorgia e Melisso, come rappresentante di una cultura oratoria brillante ma poco utile, e diceva di lui che «tentava di mostrare che le medesime cose sono una volta possibili e poi di nuovo impossibili».
Secondo la testimonianza platonica Zenone dichiarava di esser venuto in aiuto di Parmenide seguendo una via indiretta: contro coloro che mettevano in luce le conseguenze ridicole e contraddittorie delle dottrine parmenidee, mostrava che è invece la molteplicità a produrre risultati contraddittori, facendo apparire «le stesse cose simili e dissimili, una sola e molte, immobili e in movimento». L’interpretazione platonica sembra una correzione dell’immagine paradossale che troviamo in Isocrate. E possibile che l’interpretazione di Platone abbia radici all’interno del gruppo platonico, e all’interpretazione platonica si ricollegava Aristotele quando faceva di Zenone «l’inventore della dialettica». Qui ‘dialettica’ va intesa probabilmente in senso aristotelico, come un ragionamento che parte da assunzioni altrui e le esamina, per metterne in luce eventuali conseguenze poco credibili.
Già le interpretazioni antiche di Zenone dovevano essere discordanti: l’immagine che ne aveva dato Platone dovette restare canonica, anche se Eudemo, Alessandro e Simplicio la dovevano intendere in modi diversi29. Secondo Simplicio, Zenone «nel suo scritto apportava molti argomenti confutatori per mostrare che chi sostiene che esistono molte cose si trova ad asserire cose contrarie, per esempio che le cose sono grandi e piccole, grandi fino ad essere infinite e piccole fino a non avere grandezza». Da una stessa premessa, «i molti sono», Zenone ricavava cioè coppie di conclusioni contraddittorie: i molti sono infinitamente grandi e infinitamente piccoli, hanno molteplicità limitata e molteplicità infinita.
Forse Zenone formulava un primo argomento contro la molteplicità per mostrare che ciascuna delle cose molteplici, se deve essere una e identica a se stessa, non può avere grandezza. Simplicio non ci riferisce questa argomentazione, ma essa doveva introdurre la divisione in parti, che ha tanta importanza nelle argomentazioni zenoniane. Se ha grandezza, una cosa può esser divisa in parti; ma allora non sarà più unitaria né identica a se stessa, perché sarà costituita da una somma di parti e sarà identica a questa somma. Può darsi che a questo punto Zenone prendesse in considerazione una possibile obiezione alla tesi che per esistere un’unità non deve avere grandezza: se non ha grandezza, una cosa non esiste, perché, per esistere, deve far aumentare la cosa cui è aggiunta o diminuire quella da cui è tolta. Ma Zenone faceva di nuovo intervenire la divisione in parti nel suo secondo argomento contro la molteplicità: se si ammette che ciò che è, per essere, deve avere grandezza, allora si avrà una molteplicità, ma i molti saranno piccoli e grandi. Infatti ogni cosa che è avrà grandezza e spessore, e l’avranno anche ciascuna delle sue parti, ognuna delle quali si distinguerà da un’altra, la quale a sua volta avrà grandezza, spessore e si distinguerà da un’altra; e così via. Si avranno allora cose tanto piccole da non avere grandezza e tanto grandi da essere infinite. Infatti, via via che si procede nella divisione di una cosa, le sue parti si fanno sempre più piccole, fino quasi ad annullarsi. Ma se ogni cosa è costituita da infinite parti, aventi ciascuna una grandezza, essa sarà infinitamente grande.
Si è osservato che, dal punto di vista matematico, il ragionamento zenoniano non è corretto perché, se le parti alle quali mette capo la divisione all’infinito tendono a 0, allora la loro somma non può essere infinita, in quanto la somma di una serie che converge a 0 (come 1/2, 1/4, 1/8,…) è 1. In questo caso nessuna delle parti è nulla e la loro somma può coincidere con la cosa di cui sono parti. Zenone però riteneva che le parti prodotte dalla divisione fossero non nulle solo se potevano far cambiare la grandezza di una cosa cui fossero aggiunte o tolte, e probabilmente ricavava di qui l’immagine di una somma di infinite parti uguali, una somma appunto infinita. In questo caso le cose finite diventerebbero somme infinite di parti. Ma è stato anche osservato che nel secondo argomento Zenone poteva formulare non un’antinomia (se si ammette la molteplicità, questa sarà contemporaneamente nulla, perché fatta di parti praticamente uguali a 0, e infinita, perché costituita dalla somma di infinite parti uguali e non nulle), ma un dilemma: o si accetta il primo argomento, e allora le parti alle quali mette capo la divisione, se esistono, non hanno grandezza, sicché la cosa costituita dalla loro somma sarà piccola (dove ‘piccolo’ è inteso in opposizione a ‘grande’); oppure le cose diventano infinitamente grandi, perché sono la somma infinita di infinite parti che hanno grandezza. In questa interpretazione il ragionamento di Zenone sarebbe meno dipendente da una divisione in parti rappresentabile come una serie.
Probabilmente nel formulare i suoi ragionamenti Zenone non dava un’interpretazione geometrica delle cose, ma spingeva oltre ogni limite un processo di divisione che ai suoi primi stadi aveva ovvi riscontri intuitivi. Doveva esser questo il presupposto del terzo argomento contro la molteplicità, che Simplicio dice di riferire alla lettera: «se i molti sono, è necessario che siano tanti quanti sono; e se sono tanti quanti sono, dovrebbero essere limitati. Se i molti sono, le cose che esistono sono infinite: infatti sempre in mezzo alle cose che sono cene sono altre, ed altre ancora in mezzo a queste. E così le cose esistenti sono infinite». Poiché non sempre tra due cose se ne deve ammettere una terza, in quanto possono esistere collezioni di cose discrete e finite, anche in questo caso si è pensato che il ragionamento zenoniano si applichi solo a insiemi densi, come quelli dei punti, tra due dei quali è sempre possibile inserirne un terzo. Ma anche in questo caso è molto più probabile che Zenone, anziché far riferimento a qualcosa come il ‘continuo’ o lo ‘spazio euclideo’, partisse da processi intuitivi, quali l’inserimento di un intervallo tra due corpi, e supponesse l’esecuzione di un’operazione simile all’interno di un corpo per dividerne le parti.
Secondo Diogene Laerzio, Zenone argomentava anche contro il movimento sostenendo che «ciò che si muove non si muove né nel luogo in cui è, né in quello in cui non è». Per Aristotele quattro sono i ragionamenti di Zenone intorno al movimento.
Il primo argomento contro il moto, detto la dicotomia, parte dalla considerazione che un mobile non può mai arrivare al termine della traiettoria, perché prima di percorrere il percorso intero deve percorrerne la metà. Questo testo è stato variamente inteso (fìg. 1). A. Dato il percorso A-B, prima di giungere in B, il mobile deve percorrere ½(A-B), raggiungendo A1, ma prima di raggiungere A1, deve percorrere 3/2(A-A1) e così via.
A. Dato il percorso A-B, prima di giungere in B, il mobile deve percorrere ½(A-B), raggiungendo A1, ma prima di raggiungere A1, deve percorrere 3/2(A-A1) e così via.
B. Supposto che il mobile abbia raggiunto il punto A1, a metà del percorso A-B, esso dovrà percorrere ½ (A2-B) prima di raggiungere B, e poi 1/2(A2-B) e così via.
Aristotele spiegava la difficoltà posta da questo argomento dicendo che in esso una traiettoria infinita doveva essere percorsa in un tempo finito. In entrambe le interpretazioni il mobile dovrà percorrere infiniti intervalli decrescenti di 1/2, 1/4, 1/8,…, dove il denominatore potrà crescere all’infinito. Il secondo argomento contro il moto è quello detto di Achille o di Achille e la tartaruga. Si supponga che Achille insegua una tartaruga, che ha su di lui un vantaggio iniziale; pur muovendosi con una velocità maggiore di quella della tartaruga, Achille non la raggiungerà mai, perché, se si suppone che AB sia il vantaggio della tartaruga su Achille, questi deve giungere in B, per raggiungere la tartaruga. Nel frattempo però la tartaruga sarà passata in A1 e, quando Achille sarà giunto in A1, essa sarà ìn A2 e così via. Secondo Aristotele questo argomento era identico al precedente, con la sola differenza che qui non si ha una serie di dimezzamenti, ma gli spazi che dividono Achille dalla tartaruga diventano sempre più piccoli secondo la serie 1/n, 1/n2 , 1/n3… .
Il secondo argomento contro il moto è quello detto di Achille o di Achille e la tartaruga. Si supponga che Achille insegua una tartaruga, che ha su di lui un vantaggio iniziale; pur muovendosi con una velocità maggiore di quella della tartaruga, Achille non la raggiungerà mai, perché, se si suppone che AB sia il vantaggio della tartaruga su Achille, questi deve giungere in B, per raggiungere la tartaruga. Nel frattempo però la tartaruga sarà passata in A1 e, quando Achille sarà giunto in A1, essa sarà ìn A2 e così via. Secondo Aristotele questo argomento era identico al precedente, con la sola differenza che qui non si ha una serie di dimezzamenti, ma gli spazi che dividono Achille dalla tartaruga diventano sempre più piccoli secondo la serie 1/n, 1/n2 , 1/n3… .
Il terzo argomento contro il moto e quello detto della freccia. In ogni momento dato un corpo occupa uno spazio esattamente uguale alla sua grandezza, e quando un corpo occupa uno spazio uguale a se stesso è in quiete. Pertanto in ogni istante di un movimento il mobile sarà in quiete, e un movimento non può risultare da una somma di stati di quiete. II quarto argomento contro il moto, detto anche delle masse nello stadio, suppone che in uno stadio ci siano tre serie (A1, A2, A3, A4; B1, B2, B3, B3; C1, C2, C3, C4) di corpi. Le tre serie hanno uguale lunghezza e una (A1-A2) è ferma, mentre le altre due si muovono con la stessa velocità lungo percorsi paralleli. Una serie si muove dall’estremità dello stadio e l’altra in senso inverso dalla metà dello stadio verso quell’estremità. Nella posizione iniziale (fìg. 2a) B3 e B4 sono in corrispondenza di A1 e A2, mentre C1 e C2 sono in corrispondenza di A3 e A4. Ci dovrebbe essere un momento in cui ciascuna massa di una serie sarà allineata con la massa corrispondente delle altre due serie, sicché gli estremi A1-B1-C1 e A4-B4-C4 combaceranno (fìg 2b).
II quarto argomento contro il moto, detto anche delle masse nello stadio, suppone che in uno stadio ci siano tre serie (A1, A2, A3, A4; B1, B2, B3, B3; C1, C2, C3, C4) di corpi. Le tre serie hanno uguale lunghezza e una (A1-A2) è ferma, mentre le altre due si muovono con la stessa velocità lungo percorsi paralleli. Una serie si muove dall’estremità dello stadio e l’altra in senso inverso dalla metà dello stadio verso quell’estremità. Nella posizione iniziale (fìg. 2a) B3 e B4 sono in corrispondenza di A1 e A2, mentre C1 e C2 sono in corrispondenza di A3 e A4. Ci dovrebbe essere un momento in cui ciascuna massa di una serie sarà allineata con la massa corrispondente delle altre due serie, sicché gli estremi A1-B1-C1 e A4-B4-C4 combaceranno (fìg 2b).  Per raggiungere questa disposizione le masse B e C superano le une rispetto alle altre 4 intervalli, perché B4 nella posizione iniziale non corrisponde a nessun C, mentre nella posizione finale corrisponde a C4: dunque i B e i C sono sfilati gli uni rispetto agli altri di 4 posizioni. Ma nello stesso tempo, B4 raggiunge A1 e C1 raggiunge A1 muovendosi di 2 soli intervalli. Poiché le serie sono tutte uguali, bisogna ammettere che i corpi in movimento hanno percorso nello stesso tempo spazi uguali e diseguali.
Per raggiungere questa disposizione le masse B e C superano le une rispetto alle altre 4 intervalli, perché B4 nella posizione iniziale non corrisponde a nessun C, mentre nella posizione finale corrisponde a C4: dunque i B e i C sono sfilati gli uni rispetto agli altri di 4 posizioni. Ma nello stesso tempo, B4 raggiunge A1 e C1 raggiunge A1 muovendosi di 2 soli intervalli. Poiché le serie sono tutte uguali, bisogna ammettere che i corpi in movimento hanno percorso nello stesso tempo spazi uguali e diseguali.
Potrebbe essere Aristotele che, esponendo l’argomento della freccia, attribuisce a Zenone la concezione del tempo come somma di istanti in ognuno dei quali la freccia è stazionaria. E Aristotele liquida anche l’argomento delle masse nello stadio con l’osservazione che Zenone trascura le velocità relative dei mobili. La critica aristotelica potrebbe dipendere dal fatto che Aristotele espone gli argomenti zenoniani riferendoli a intervalli finiti e a corpi macroscopici di grandezza finita. Non così faceva con i primi due argomenti contro il moto, la dicotomia e Achille, esponendo i quali sosteneva che Zenone fa percorrere distanze infinite in tempi finiti. In effetti Aristotele faceva riferimento a Zenone nel trattare di infinito e di continuo, e la letteratura filosofica e matematica posteriore ha ripreso quelle argomentazioni.
Quando nell’Ottocento si sistemò la teoria matematica del continuo, parve che anche i paradossi zenoniani potessero esser spiegati e risolti. Nacque così una storiografia che presentava le argomentazioni zenoniane in chiave matematica, tanto più che si poteva pensare che Zenone facesse riferimento a una matematica pitagorica entrata in crisi con la scoperta delle grandezze incommensurabili; e con quella crisi Zenone poteva esser collegato, perché i suoi paradossi nascevano dalla scoperta del continuo, che solo la moderna teoria degli insiemi rendeva possibile padroneggiare.
La storiografia più recente ha cercato di liberarsi dalla prospettiva matematica. La matematica pitagorica è apparsa un’improbabile invenzione, e gli storici sono diventati prudenti nell’introdurre riferimenti all’infinito nei paradossi di Zenone; hanno invece preferito ricostruire il suo linguaggio filosofìco, nel quale i problemi dell’infinito matematico e del continuo non sono presenti.
Non è escluso che Zenone fosse diventato un personaggio al quale si potevano assai liberamente attribuire argomenti paradossali, come quel sorite con il quale avrebbe sostenuto che ogni grano di miglio dovrebbe far rumore cadendo, se fa rumore tutto il mucchio. Oggi è difficile farci un’idea del tipo di scritti nei quali erano esposti i ‘paradossi’ di Zenone, del pubblico al quale si rivolgevano, della funzione che dovevano compiere. Spesso tra i rappresentanti della filosofia presocratica si cita Epicarmo, un personaggio vissuto tra la fine del VI e il V secolo a.C., al quale veniva attribuita l’invenzione della commedia. Alcimo accusò Platone di aver trovato in Epicarmo molte cose e di averle copiate, e la tradizione pitagorica s’impadronì di lui, facendone uno scolaro di Pitagora. Tutte queste notizie sono poco attendibili. E’ certo che Epicarmo era un rappresentante della vita intellettuale delle colonie greche dell’Italia meridionale e della Sicilia, e che scrisse delle composizioni teatrali. In esse compaiono argomentazioni ‘di tipo filosofìco’. Trattandosi di dialoghi non c’è da stupirsi che Epicarmo mettesse in scena dottrine che potevano colpire per la loro stranezza e che potevano essere attribuite ai personaggi rappresentati. Proprio gli eleati diventeranno popolari per la paradossalità delle loro tesi. Ma i testi di Epicarmo potrebbero anche rivelare modi di argomentare inconsueti, e tuttavia diffusi nella cultura letteraria e codificati nella cosiddetta cultura fìlosofica. E possibile trovarvi versi che ricordano Senofane, che possono far venire in mente i paradossi zenoniani e che avranno echi ancora nel Fedone di Platone. Tutto questo non autorizza a dire che Epicarmo sia una fonte di Platone, così come non è possibile dire che ci siano stati rapporti tra Epicarmo e Senofane, Parmenide o Zenone. Ma il riferimento a Epicarmo può mostrare che certi modi di ragionare sono nati proprio nel linguaggio letterario e nella sua ricerca della sottigliezza e del paradosso. Tutto sommato, forse Zenone non ha dato voce a una teoria dell’infinito o del continuo o dello spazio geometrico, ma ha semplicemente costruito paradossi assumendo che una cosa non coincida con la somma delle sue parti, che un movimento sia una somma di stati stazionari, che prima di esser giunti a una posizione bisogna aver occupato la posizione precedente e così via. In questo senso egli riprendeva un elemento parmenideo. Parmenide aveva sostenuto che, una volta introdotta, la negazione genera parole, ciascuna delle quali pretende di avere un riferimento autonomo: e nasce un’immagine fallace dell’universo. Zenone fa qualcosa di analogo: se si mette una parte tra altre due o una tappa prima di un termine, non si può poi più ricostituire il tutto.
La fortuna di Zenone nella letteratura retorica e sofistica fa supporre che la sua connessione con la logica, la dialettica e la matematica possa essere molto sviante. I filologi hanno riportato le arditezze speculative dell’eleatismo al linguaggio letterario arcaico e gli storici della filosofìa hanno cercato di trovare negli usi del linguaggio comune le fonti dei paradossi di Zenone. Queste impostazioni sono in parte figlie della moda filosofica del nostro tempo. Ma certamente non conviene cercare in Zenone un critico della matematica pitagorica o un protagonista della nascita della matematica greca classica o uno scopritore delle difficoltà che la teoria moderna degli insiemi avrebbe risolto.
Zenone è rimasto una figura popolare nella nostra tradizione, e filosofi e matematici moderni hanno spesso fatto riferimento a lui; ma l’immagine che ne è sopravvissuta, passata attraverso i testi aristotelici e legata alla teoria aristotelica dell’infinito e del continuo, si è formata all’interno dei gruppi platonici nel corso della discussione sulla matematica e il movimento. In quel momento la matematica offriva una teoria della molteplicità e del movimento che poteva costituire una difficoltà per le teorie filosofiche condivise dai platonici. Dovette nascere l’idea che le difficoltà filosofiche generate da quelle teorie matematiche dipendessero dall’infinito, e i paradossi di Zenone dovettero sembrare la prova più eloquente in proposito. Infatti, prima di Platone, Zenone è conosciuto soprattutto come costruttore di paradossi e lo stesso Platone partiva da questa immagine per fare di lui un semplice difensore della filosofia parmenidea. Poi, forse già Platone, ma certamente Aristotele si servirono delle argomentazioni di Zenone per mostrare le difficoltà alle quali va incontro il tentativo di introdurre l’infinito.
OPERE
Anche per quel che riguarda l’opera di Zenone la notizia più antica è quella di Platone (Parmenide), che parla di uno scritto di Zenone, che allora arrivava per la prima volta ad Atene. Una tradizione attribuiva a Zenone più opere, forse quattro (Dispute, Esame delle dottrine di Empedocle, Contro i filosofi e Sulla natura), ma gli storici hanno riconosciuto in questi titoli tutt’al più il riferimento tardo a parti di una stessa opera.
Non sappiamo molto della struttura dello scritto di Zenone. Platone parla dei «discorsi» che lo componevano e sembra riconoscere in ogni discorso più «ipotesi».
Probabilmente nel gruppo platonico era invalsa l’abitudine di rappresentare gli eleati, a cominciare dallo stesso Parmenide, nell’atto di discutere. Proclo attribuiva a Zenone ben quaranta argomenti, mentre ai quaranta argomenti contro la molteplicità Elia aggiungeva cinque ragionamenti contro il moto.
Per noi è difficile accedere direttamente allo scritto di Zenone, perduto. Aristotele cita ampiamente argomentazioni zenoniane; ma non sappiamo affatto se egli attinga fedelmente a qualche scritto o se le sue siano interpretazioni di argomentazioni di Zenone o che si facevano risalire a Zenone.
MELISSO
 BREVE PRESENTAZIONE
BREVE PRESENTAZIONE
Melisso (che visse dopo la metà del V secolo a.C.) viene generalmente collocato nell’ambito dei filosofi eleatici (insieme a Parmenide e a Zenone), sebbene fosse originario non già di Elea, bensì di Samo, nella Ionia minore. Il giudizio di Aristotele nei suoi confronti è molto duro: lo Stagirita, infatti, non lo apprezzava a causa della sua rozzezza e grossolanità. Nonostante i giudizi poco lusinghieri di Aristotele, Melisso risulta essere molto importante per la storia della filosofia, in particolare per il suo tentativo di coniugare l’eleatismo con la filosofia della natura. Fu allievo di Parmenide, come Zenone, ma non si limitò a difendere le tesi del maestro (come aveva fatto Zenone stesso), ma apportò alcune modifiche ed innovazioni, in particolar modo l’attribuzione dell’eternità e dell’infinità all’essere. Con Melisso ci troviamo di fronte ad una contaminazione tra gli eleati e gli ionici : il particolare risultato di questa mescolanza è che Melisso dà interpretazioni prettamente fisiche ai concetti astratti di Parmenide, il quale aveva esplicitamente negato che l’ambito del pensiero potesse accordarsi con quello dell’esperienza sensibile, relegata all’ambito della δόξα . In altre parole, Melisso traduce in termini fisici ciò che per Parmenide era solo in termini logici. La sua opera si intitolava Περὶ φύσεως o Sull’essere e, a differenza di quella del maestro Parmenide, era in prosa e non in poesia. In essa egli afferma che essere e non essere sono rispettivamente – in termini naturalistici – pieno e vuoto. Per un certo verso riprende le argomentazioni ioniche dei Milesi: l’essere era e sempre sarà (a differenza di ciò che diceva Parmenide). Tra i vari aspetti in comune con gli Eleatici, troviamo proprio il costante dimostrare per assurdo, portato in auge soprattutto da Zenone, ma non assente in Parmenide stesso. Egli dimostra per assurdo che l’essere è sempre esistito e sempre esisterà: ammettiamo che l’essere sia nato. Una cosa che nasce deve per forza nascere da un’altra realtà, da qualcosa di diverso: se nascesse da sè allora significherebbe che esisteva già, quindi è nato da qualcosa di diverso; in altre parole deve essere generato da qualcosa che non è essere, ma ciò che non è essere è il non essere, ma il non essere non esiste (l’aveva dimostrato Parmenide). Dimostrato per assurdo che l’essere non è generato, ne segue che esso è eterno. Sempre nella sua opera, Melisso conferma tesi parmenidee e zenoniane servendosi di argomentazioni innovative: in particolare egli arriva a sostenere l’inesistenza del movimento, servendosi di una dimostrazione paradossale: abbiamo detto che l’essere è il pieno e il non essere è il vuoto e tutti sappiamo che, perchè avvenga un movimento, ci deve essere un qualcosa che si sposta nel vuoto (pensiamo ad una fetta di pane che viene tagliata con un coltello: il coltello si sposta nel vuoto, condizione del moto del coltello). Ma il vuoto è il non essere e il non essere non esiste, quindi si arriva alla conclusione che il movimento non esiste. Melisso si cimenta anche nel dimostrare contro la molteplicità: se l’essere fosse molteplice, allora non sarebbe unico e, pertanto, ci sarebbero cose che sono non essere, ma il non essere non esiste. Dunque l’essere non è molteplice, ma è uno solo. I successori si servirono delle tesi di Melisso capovolgendole: in particolare, essi partono dall’assunto che il movimento esista (negarlo contrasta con la più banale delle esperienze). Dunque, se voglio giustificare l’esistenza del movimento, devo ammettere il vuoto (siamo tutti d’accordo che il movimento possa essere solo nel vuoto): il vuoto è il non essere e, di conseguenza, il non essere esiste. Stessa cosa può valere per la molteplicità dell’essere, che esperiamo di continuo: quindi essa deve esistere e, di conseguenza, tutti questi enti molteplici devono per forza avere caratteristiche dell’essere, che non è uno. Melisso dimostra poi l’infinità dell’essere: se l’essere è sempre stato e sempre sarà, allora è infinito e, di conseguenza, deve anche essere uno: se infatti l’essere fosse non uno ma due, i due non potrebbero essere infiniti, ma l’uno avrebbe limite nell’altro. E’ la classica dimostrazione per assurdo, con cui Melisso riesce a dimostrare a modo suo l’unicità dell’essere. Dante (Paradiso, XIII,121-126) colloca curiosamente Melisso tra coloro che affrontando la ricerca della verità senza metodo, tornano carichi di errori più di prima che iniziassero il viaggio:
Vie più che indarno da riva si parte,
Perché non torna tal qual ei si muove,
Chi pesca per lo vero, e non ha l’arte:
E di ciò sono al mondo aperte prove
Parmenide, Melisso e Brisso e molti,
I quali andavan, nè sapevan dove.
INTRODUZIONE
Anche se non sappiamo nulla delle loro biografie, Parmenide e Zenone sono diventati, da Platone in poi, una coppia esemplare di maestro e scolaro. Ma è difficile immaginare un legame di scuola che unisca Melisso di Samo, il quale vive nell’area orientale del mondo greco in piena età periclea, a Parmenide e Zenone. Con lui l’eleatismo è già diventato un’entità intellettuale vaga e diffusa. Isocrate lo pone accanto a Parmenide, Zenone e Gorgia come autore di dottrine paradossali. E Polibo, genero di Ippocrate, nel trattato De natura hominis, dopo aver polemizzato contro coloro che, non medici, si affannano a identificare l’uomo e il tutto, chi con l’aria, chi con l’acqua, chi con la terra e chi con il fuoco, disputando più di parole che di fatti, dice che costoro “danno ragione a Melisso”. Il significato di questo accenno non è sicurissimo, ma è possibile che anche qui Melisso apparisse un autore paradossale, al quale si finisce con il dar ragione a forza di dispute puramente verbali. Platone, forse con qualche ironia, dice che Melisso vale un po’ meno di Parmenide43. Ancora una volta Aristotele segue Platone considerando Melisso addirittura “rozzo”. Parmenide e Melisso avevano entrambi svolto una teoria dell’uno, ma Parmenide lo aveva considerato “secondo la definizione”, Melisso “secondo la materia, e per questo uno dice che è finito, l’altro infinito“44. Attraverso questo gergo aristotelico un punto pare effettivamente attribuibile a Melisso: la considerazione dell’uno come infinito. Questo è per Aristotele un errore di categoria, perché l’infinito spetta alla quantità, che è un predicato, e non alle cose che sono soggetti dei predicati. Le cose-soggetto sono sostanze, e le sostanze hanno un limite e sono finite: aveva visto giusto Parmenide che aveva considerato il tutto finito.
Tuttavia in Aristotele e in Simplicio è possibile cogliere una traccia del ragionamento di Melisso, indipendentemente dalle critiche aristoteliche. Per Melisso il tutto è ingenerato, perché prima del tutto non c’è nulla; e dal nulla non sarebbe derivato nulla. Se non è generato, il tutto non ha principio e, se non ha principio, non ha neppure fine, sicché sarà infinito. Per Aristotele Melisso commetteva un errore ricavando dalla proposizione (1) ‘tutto ciò che è generato ha un principio‘ la proposizione (2) ‘tutto ciò che non è generato non ha un principio‘. Per Aristotele il termine ‘principio’ ha un significato generale, non riducibile a quello di ‘inizio’, che risulta nelle testimonianze su Melisso. Pertanto Aristotele ritiene che, se tutto ciò che è generato ha un principio, non tutto ciò che ha un principio è generato45. Probabilmente però Melisso mostrava che l’essere non è generato (perché non può derivare dal nulla) e che perciò non ha inizio né termine, usando così la proposizione (2) senza ricavarla dalla proposizione (1). Si comprende assai bene l’avversione di Aristotele per Melisso. La filosofia di Parmenide poteva apparirgli paradossale, lontana dalla realtà delle cose; ma essa sembrava stabilire che l’essere è limitato e perfetto, un caposaldo della concezione aristotelica del mondo come un tutto ordinato e finito. E anche per Zenone l’infinito era qualcosa di negativo. Melisso invece introduceva l’infinito nell’uno stesso e pretendeva che tutto ciò che ha un principio fosse generato. Il rischio era che un mondo dipendente da un principio, che ne garantisce l’ordine, diventasse generato e perdesse l’eternità: una cosa impossibile nella concezione aristotelica del mondo.
Dai testi trasmessi da Simplicio emergono però alcuni tratti della teoria dell’infinito di Melisso, che l’interpretazione aristotelica lasciava in ombra. Non solo Melisso attribuiva all’essere l’infinità di grandezza e l’eternità temporale, ma soprattutto doveva sviluppare una teoria dell’unicità dell’infinito. Se non fosse uno solo, l’infinito confinerebbe con qualche altra cosa, e perciò non sarebbe infinito: infatti non ci potrebbero essere due infiniti, perché essi si limiterebbero a vicenda. L’uno infinito è anche omogeneo, perché se subisse qualche mutamento non sarebbe più uno. Infatti se cambiasse non sarebbe più simile a se stesso, ma ciò che era prima non ci sarebbe più e ciò che non è nascerebbe: l’uno, cambiando, diventerebbe molti. E basterebbe che mutasse di un capello in diecimila anni, perché perisse completamente: in un tempo infinito una trasformazione, per piccola che sia, potrebbe coinvolgere tutto l’uno. Non esiste neppure il vuoto, che è non essere. L’assenza del vuoto determina la mancanza di movimento, perché l’essere non può spostarsi verso il nulla46. Se esistessero i molti, ciascuno, per esistere davvero, dovrebbe essere come l’uno, e non potrebbe trasformarsi in uno degli altri o comunque mutare. Ma la percezione ci rivela anche trasformazioni e mutamenti, che invece non ci possono essere: perciò non ha vero essere quel che essa ci mostra. L’uno non ha neppure corpo, perché il corpo è divisibile in parti. Se fosse divisibile in parti, queste renderebbero possibile il movimento, e il movimento introdurrebbe il non-essere47.
Si è fatto con Melisso quello che Platone aveva tentato con Zenone: si è supposto che egli conducesse una polemica. I suoi avversari sarebbero ora i pitagorici, ora Empedocle. Ma si tratta di congetture non corroborate da riscontri attendibili. Si è cercato però anche di collegare Melisso con Anassagora, attribuendogli una teoria della completa uniformità dell’essere, oppure con gli atomisti attraverso la sua concezione del vuoto. Ma Anassagora non nega il movimento e gli atomisti ammettono il vuoto. Anche qui siamo del tutto privi di notizie specifiche, e nel caso di Melisso diventa anche più difficile immaginare i rapporti di scuola che secondo Platone avrebbero legato Zenone a Parmenide.
Con un puro confronto di testi è possibile scorgere in Melisso alcuni temi originali all’interno della cultura eleatica. Attribuisce all’uno la durata temporale che Parmenide nega all’essere48 e, mentre Parmenide immagina l’essere come finito e limitato, Melisso lo considera infinito, proprio perché non ha né inizio né fine e si estende senza limiti. Forse perfino l’unità dell’essere e motivo propriamente Melisseo49, e lo è certamente la dimostrazione dell’unicità dell’infinito, che avrà molta fortuna nella tradizione filosofìca. Si potrebbe dire che Melisso ha cercato di limitare l’ordine dell’infinito, evitando che si formassero infiniti di infiniti, oppure che ha cercato di introdurre l’infinito escludendo il continuo; ma sarebbero elucubrazioni. Probabilmente si tratta di schemi argomentativi usati da Melisso: se si ammette una molteplicità, ogni suo elemento si configura come un essere unitario, e dunque infinito; ma più infiniti sono impossibili. Forse Zenone argomentava che se c’è molteplicità c’è infinità e dunque una serie di proprietà contraddittorie. Per Melisso l’infinito in quanto tale non crea difficoltà e può essere attribuito all’uno; però, se c’è molteplicità, c’è sempre più di un infinito, e questo è impossibile.
ANASSAGORA
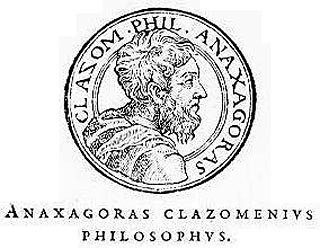 Οψις αδελων τα φαινομενα. (Le cose visibili sono uno sguardo su quelle invisibili)
Οψις αδελων τα φαινομενα. (Le cose visibili sono uno sguardo su quelle invisibili)
Anassagora si colloca nel contesto dei pluralisti, coloro cioè che pur conservando alcuni presupposti degli Eleatici (quale l’immutabilità dell’essere), si allontanano dalla concezione tipicamente eleatica dell’immobilità dell’essere: immutabile non è l’essere nel suo insieme, ma i principi ultimi che lo costituiscono, i quali sono secondo Anassagora, e pure secondo Democrito – un’infinita pluralità (da qui il nome “pluralisti”). La filosofia pluralista parte proprio dalla confutazione, o meglio, dal ribaltamento delle tesi di un Eleatico, Melisso: egli aveva detto che se l’essere fosse molteplice, il molteplice dovrebbe avere alcune caratteristiche dell’essere, quali l’eternità, l’immobilità, ed altre: ma dato che non le ha, l’essere non è molteplice. I pluralisti ribaltano completamente le tesi di Melisso e dicono dato che il molteplice c’è (e lo vediamo tutti), bisogna ammettere per forza che questi esseri molteplici abbiano caratteristiche dell’essere. Per i pluralisti vi è dunque una molteplicità di elementi in movimento, ciascuno dei quali è immutabile: si rendono infatti conto che è contraddittorio parlare di nascita e di morte (da dove si nasce? Dove si finisce una volta morti? Nel non essere! Il che è assurdo) e perciò chiamano morte e nascita i processi di aggregazione e disgregazione. Sono proprio i concetti di aggregazione e disgregazione che implicano la pluralità ed il movimento degli elementi: per aggregarsi e disgregarsi, infatti, devono essere diversi ed in movimento. Anassagora nacque a Clazomene, nella Ionia, e sappiamo che nel 462 a.c. abbandonò la sua città per stabilirsi in Atene. Qui visse per circa 30 anni, stringendo amicizia con il famoso Pericle. Ma nel 438 un indovino di nome Diopite fa approvare un decreto in base al quale sono perseguibili dalla legge tutti coloro che insegnano e divulgano cose empie a riguardo dei fenomeni celesti: Anassagora viene processato per aver sostenuto che il sole è una pietra incandescente e la luna un corpo terroso. Possiamo cogliere in questo processo non tanto un processo contro ciò che effettivamente affermava Anassagora, quanto piuttosto una condanna a carattere politico – sociale rivolta a tutti i conoscenti di Pericle. Tuttavia le dottrine fisiche di Anassagora erano un esplicito attacco a credenze e pratiche religiose. Se infatti si accettavano le sue tesi, i fenomeni celesti non potevano più essere considerati segni inviati dalle divinità agli uomini. Va poi detto che il libro in cui Anassagora esponeva le sue dottrine fisiche (“Peri fuseos”, Περι φυσεως) si era sparso a macchia d’olio per via del suo basso costo nella città di Atene, che si stava progressivamente alfabetizzando. Così Anassagora fu sottoposto ad un processo e dovette abbandonare Atene per rifugiarsi a Lampsaco, nella Ionia, dove morì nel 428 a.c. Anassagora, come molti altri filosofi, affronta il problema di come si sia costituito il mondo nel quale viviamo. Egli ravvisa la matrice originaria del mondo in una totalità indistinta di tutti i materiali da cui risultano costituite le cose. Questi materiali sono da lui chiamati SEMI ed egli afferma, seguendo la scia degli Eleati, che non nascono nè periscono, ma permangono costanti: al di là del mutamento degli enti fenomenici, questi semi restano come sono, eterni. Egli riprende il concetto di mescolanza introdotto da Parmenide e sfruttato contemporaneamente da Empedocle : dice che ogni cosa è una mescolanza di questi semi, che però non sono visibili ad occhio nudo: prendiamo ad esempio un libro blu: noi lo vediamo blu perchè i semi di colore blu sono in netta prevalenza su quelli degli altri colori, che tuttavia sono tutti presenti. Probabilmente Anassagora era arrivato a trarre queste conclusioni a riguardo dei semi partendo dall’osservazione del processo di crescita degli esseri viventi mediante la nutrizione. Egli si deve essere posto questa domanda: “Come è possibile che il pane che noi mangiamo diventi sangue. muscoliossa…?”. La risposta che egli dà a questa domanda è che “tutto sta in tutto” : nel pane ci sono semi di tutte le cose, di sangue, di ossa, di carne, di muscoli… Quindi quando mangiamo il pane i semi di muscoli vanno ad alimentare i muscoli, quelli di ossa vanno ad alimentare le ossa, e così via. Ma come mai noi vediamo solo il pane e non tutti gli altri semi ? Così come nel caso del quaderno noi vediamo il verde perchè c’è una prevalenza di semi verdi, così nel caso del pane noi vediamo il pane perchè i semi di pane sono in maggioranza. Partendo dal visibile (il pane), arriviamo a capire l’esistenza dell’invisibile (i semi): ecco spiegato il celebre motto anassagoreo, “οψις αδελων τα φαινομενα” (le cose che appaiono sono uno sguardo su quelle che non appaiono”), con il quale è messa in luce la possibilità di un inferenza dal visibile all’invisibile. Va specificato che nel mondo in cui viviamo non esistono propriamente parlando semi, ossia particelle allo stato puro dal momento che in ogni cosa continuano a sussistere particelle di tutte le altre cose: noi vedremo il verde non perchè una sostanza sia effettivamente verde, ma perchè il verde prevale su tutti gli altri semi, che tuttavia sono presenti, anche se noi non riusciamo a vederli. In questo senso Anassagora ammette la divisibilità all’infinito, senza che sia mai possibile raggiungere un minimo. Aristotele riprenderà questi concetti e chiamerà i semi di Anassagora col nome di “omeomerie”, vale a dire entità le cui parti sono simili al tutto. Tale è per esempio il caso della carne : se prendiamo una qualsiasi parte di carne sempre carne è, ma se prendiamo una faccia e la dividiamo non avremo tanta facce, ma parti differenti dalla faccia iniziale. Ma propriamente per Anassagora il rapporto di mescolanza tra i semi è diverso secondo i casi e nel mondo che ci circonda non c’è nessuna entità omogenea, ossia tale che tutte le sue parti siano simili al tutto di cui fanno parte. Anassagora è convinto che dalla totalità indistinta di tutti i semi non si è formato soltanto il nostro mondo: per lui si sarebbero formati anche altri mondi, anch’essi abitati da uomini e da esseri viventi. Quindi per Anassagora il nostro mondo non è il centro del tutto così come coloro che lo abitano. Resta però da spiegare come avvenne la transizione dalla totalità originaria alla pluralità dei mondi nelle loro differenziazioni. Chiaramente questa transizione richiede un movimento, ma da che cosa dipende tale movimento? Qui subentra quella che già a Platone e ad Aristotele era sembrata la maggiore innovazione di Anassagora, anche se ai loro occhi non sufficientemente sfruttata. Anassagora infatti introduce un intelletto cosmico, il “NOUS” (Νους), come agente dell’impulso originario di questo movimento. Aristotele ci parla di questo “nous” nella “Fisica”: ciò che più emerge è il fatto che questo intelletto cosmico è un potere assoluto, separato da tutto (αυτοκρατωρ) e per questo non impacciato o condizionato da nulla e quindi capace di sottoporre tutto al suo dominio. E’ proprio questo potere che consente al ” nous ” di dare origine alla formazione e alla progressiva differenziazione delle cose, pur nella persistenza in tutte dei semi di ogni tipo. L’intelletto cosmico ha quindi un’intelligenza totalmente differente rispetto a quella umana: il nous ha un potere incomparabile e questo è per Anassagora dovuto al fatto che esso sia l’unica realtà data non da una mescolanza di semi. Se fosse mescolato con qualcosa sarebbe infatti impedito nella sua azione e non potrebbe pertanto imprimere il movimento iniziale alla massa originaria.Ciò non comporta che per Anassagora il nous sia una sostanza spirituale nè che esso si identifichi con la divinità. Pur chiamando questo motore originario “intelletto”, Anassagora non gli attribuì la funzione di progettare secondo un fine e precisamente in vista del meglio. La principale differenza rispetto ad Empedocle è che non ci sono le due forze che aggregano e disgregano; va poi detto che non è una visione ciclica e pendolare (come era quella di Empedocle), ma è unidirezionale: non si tornerà più alla situazione di partenza. Dunque per Anassagora si parte da questa totale mescolanza dei semi (lui la chiama “MIGMA” – μιγμα -, dal verbo “μιγνυμι”, mescolo = mescolanza totale); poi interviene il nous che smuove il tutto. Da notare che la forza del nous non può essere nè totalmente aggregatrice nè totalmente disgregatrice. Abbiamo detto che Platone e soprattutto Aristotele lo accusavano di usare poco la causa finale che aveva abilmente introdotto (il nous): molto probabilmente però Aristotele (Metafisica) e Platone (Fedone) hanno preso una cantonata perchè hanno tradotto la parola ” nous ” con ” intelletto “; ma il Greco di Anassagora era differente rispetto al loro: ai suoi tempi infatti la parola ” nous ” veniva spesso usata con il significato di ” anima”, “vita”.
Probabilmente Anassagora non voleva parlare di un’intelligenza divina e di una causa finale, ma voleva semplicemente dire che dove c’è movimento c’è vita. Tuttavia se l’intelligenza umana è inferiore rispetto a quella del nous, essa è superiore (come già aveva detto Alcmeone) a quella degli animali. Essa richiede l’impiego della procedura che inferisce ciò che non è visibile a partire da ciò che lo è. Questa procedura sorregge buona parte della stessa costruzione teorica di Anassagora, come si è visto. Il sapere umano per lui è acquisito gradualmente e non è un possesso istantaneo. Anassagora traccia una sequenza cronologica delle acquisizioni:
1)ESPERIENZA
2) SOPHΙΑ (σοφια, sapienza)
3) TECHNE (τεχνη, tecnica).
La sensazione avviene per contrari, in quanto il caldo può essere avvertito mediante il freddo e viceversa: se mettiamo una mano in un secchio pieno di acqua fredda e ne aggiungiamo di calda, la sentiamo benissimo quella calda. Se però ne aggiungiamo di fredda non percepiamo quella fredda aggiunta. Dalla sensazione e dall’osservazione ripetuta si passa alla conservazione di questa nella memoria. Su questa base diventa possibile il costruirsi di un sapere. E’ interessante che come ultimo momento Anassagora indichi la tecnica : è essa che propriamente permette agli uomini di servirsi degli stessi animali e quindi di collocarsi al di sopra di essi. La superiorità dell’uomo sugli altri animali riposa sul fatto che solo l’uomo sa costruire oggetti a lui utili, ossia sa sfruttare al meglio il proprio sapere. Del resto, Anassagora vive in quell’Atene del V secolo, brulicante di cantieri e di lavori splendidi. In questo contesto si comprende forse meglio il significato della celebre tesi secondo la quale l’uomo è più intelligente degli altri animali perchè ha la mano che gli consente di stabilire un diverso rapporto con la realtà. Il possesso della mano si collega strettamente all’esercizio di attività tecniche, che appaiono indice decisivo di umanità. Aristotele invece avanzerà un’ipotesi antitetica rispetto a quella di Anassagora: dal momento che l’uomo è il più intelligente degli animali la natura gli ha dato la mano. Tra l’altro l’affermazione di Anassagora ci consente di capire quanto poco il finalismo rientri nelle sue teorie e di conseguenza se ne evince che la traduzione di Aristotele di nous con intelligenza è erronea. Sempre Aristotele (Metafisica, libro I) ribalta la tesi anassagorea della superiorità della τεχνη sulla σοφια, arrivando a mettere al vertice del sapere il “sapere per il sapere”, ossia il sapere disinteressato, privo di risvolti pratici.
EMPEDOCLE
 Il grande filosofo greco nacque nel 492 circa; si atteggiò a profeta e a taumaturgo; come medico (è ritenuto il fondatore della scuola medica siciliana) pare sua la scoperta del labirinto dell’orecchio interno; e fu forse maestro di Gorgia l’oratore. E Timeo dice che fu allievo di Pitagora (VI – V secolo a.C.) . Non sono da trascurare le sue doti di poeta, nell’utilizzo del metro della tradizione epica, e di fisico.
Il grande filosofo greco nacque nel 492 circa; si atteggiò a profeta e a taumaturgo; come medico (è ritenuto il fondatore della scuola medica siciliana) pare sua la scoperta del labirinto dell’orecchio interno; e fu forse maestro di Gorgia l’oratore. E Timeo dice che fu allievo di Pitagora (VI – V secolo a.C.) . Non sono da trascurare le sue doti di poeta, nell’utilizzo del metro della tradizione epica, e di fisico.
” (…) coloro che presso i Greci vengono chiamati ‘fisici’, dovremmo chiamarli anche poeti, perché il fisico Empedocle scrisse un eccellente poema”. (Cicerone, De Oratore, I, 217)
“Si tramanda che il rapsodo Cleomene abbia recitato in Olimpia proprio il suo poema, le Purificazioni: lo attesta anche Favorino nelle sue Memorie”. (Diogene Laerzio; VIII, 63).
Di nobile famiglia, patteggiò tuttavia per gli esponenti democratici, di cui fece parte nel governo della città grazie alla scomparsa del tiranno Terone nel 472 ed alla cacciata del di lui figlio Tisandro. In gioventù “vinse una corsa di cavalli ad Olimpia” (Ateneo, 3, e). Ma parrebbe che Ateneo confonda tale gesto con quello compiuto dal nonno del poeta, che portava lo stesso nome. Il padre fu invece Metone, leggiamo in Diogene Laerzio (VIII, 51).
“Successivamente Empedocle abolì anche l’assemblea dei Mille, costituita per la durata di tre anni, sì che non solo appartenne ai ricchi, ma anche a quelli che avevano sentimenti democratici. Anche Timeo nell’undicesimo e nel dodicesimo libro – spesso infatti fa menzione di lui – dice che Empedocle sembra aver avuto pensieri contrari al suo atteggiamento politico. E cita quel luogo dove appare vanitoso ed egoista. Dice infatti: ‘Salvete: io tra di voi dio immortale, non più mortale mi aggiro’. Etc. Nel tempo in cui dimorava in Olimpia, era ritenuto degno di maggiore attenzione, sì che di nessun altro nelle conversazioni si faceva una menzione pari a quella di Empedocle. In un tempo posteriore, quando Agrigento era in balìa delle contese civili, si opposero al suo ritorno i discendenti dei suoi nemici; onde si rifugiò nel Peloponneso ed ivi morì (VIII, 66, 67; op. cit.).
Doveva essere il 432 a.C.; durante la sua permanenza in Elea conobbe Parmenide ed il poeta di Ceo Simonide. Ma ad Agrigento circolavano anche le idee di Pitagora e Senofane, Eraclito e i medici Pausania (suo allievo prediletto) e Acrone; ed Empedocle seppe superare gli influssi di tale scuole con la sua personalità con la sua visione della realtà dei quattro classici elementi dell’acqua, dell’aria, del fuoco e della terra.
“Gli uomini non sanno comprendere queste cose né cogli occhi né con le orecchie e neppure con la mente” (Diogene Laerzio; IX, 73).
“Deboli poteri infatti sono diffusi per le membra; molti mali repentini, che ottundono i pensieri. Scorgendo una misera parte della vita nella loro vita di breve destino, come fumo sollevandosi si dileguano, questo solo credendo, in cui ciascuno si imbatte per tutto sospinti, si vantano di scoprire tutto; così queste cose non sono vedute, né udite dagli uomini, né abbracciate con la mente. Tu dunque, essendoti qui straniato, non saprai di più di ciò a cui si solleva la mente umana”. (Sesto Empirico; in I Presocratici, testimonianze e frammenti; Laterza; 1994)
Gli elementi non hanno origine, secondo l’ideale di Parmenide, ma possono modificare le loro caratteristiche sotto la spinta dell’Amore unificatore, o della Discordia disgregatrice: “Due forze che reggono la terra, ieri sono state e domani pur saranno”. All’uomo non resta che adeguarsi, e vivere una esperienza dopo l’altra, per conoscere la realtà fatta dal molteplice, e dall’insieme di innumerevoli singoli elementi. Vivere le esperienze della natura rende l’uomo sempre più simile ad essa, e può comprenderla alfine dall’interno: grazie anche alla metempsicosi. Ciò lo apprendiamo dai frammenti dei suoi lavori giuntici: 111 del poema Della natura
, e pochi delle Purificazioni.
“Le sue opere Della natura e le Purificazioni si estendono per cinquemila versi, il Trattato sulla medicina per seicento righe. Delle tragedie abbiamo già detto” (VIII, 77).
“Concordando quindi con Empedocle: ‘Non vi fu perciò nessuna guerra di dei o frastuono di battaglia, neppure fu Zeus loro re, né Crono, né Poseidone, solo Cipride bensì fu loro regina. Essa viene appagata dalla gente, con offerte devote d’animali dipinti, e balsami riccamente profumati, con sacrifici di pura mirra e fragante incenso, mentre stendono sul terreno libagioni dal giallo miele di favo'”. (Ateneo; 510, c; op. cit.).
Altri lavori dei quali sappiamo solo i titoli sono Politica, Della medicina, Proemio ad Apollo, pur se di incerta attribuzione. Un lavoro sulle guerre persiane pare sia stato distrutto per sua volontà non piacendogli. La sua fede nel valore dell’esperienza – che ci ricorda l’ideale di secoli a noi più vicini – lo condusse a potersi ritenere depositario di conoscenze taumaturgiche:
“Uomini e donne mi lodano seguendomi in massa, domandando a me la parola che sana le numerose malattie che trafiggono ogni ora le carni”.
Con disagio lo potremmo definire anche un santone, per le guarigioni fatte che la voce della leggenda tramanda con altre: una dice che egli si gettò nel cratere dell’Etna , per liberarsi infine del corpo ormai ingombrante o far credere con la sua sparizione di essere stato assunto tra gli dei. Il cratere (riferisce Diogene Laerzio, VIII, 69) rigettò uno dei suoi sandali bronzei. Un’altra leggenda lo vuole sparire in un gran bagliore notturno, dopo aver fatto resuscitare una donna (Idem, VIII, 68). Di certo abbiamo che egli formulò per primo la teoria dei quattro elementi, base di tutte le cose, e sottoposti alle due forze che, a periodi, dominano l’universo o fondendo tutto in un unicum o separando i 4 elementi; consentendo l’esistenza del mondo come lo vediamo e lo viviamo durante i periodi di lotta tra i due: Amore e Odio.
Come egli vedeva sé stesso?
“E’ scritto nel fato che chiunque macchi il suo corpo di sangue, o sia infame seguendo l’esempio di Odio, andrà errando diecimila anni lontano dagli uomini felici, nascendo di volta in volta sotto le sembianze di ogni essere vivente, soffrendo le varie pene d’ogni diversa specie vivente. La forza dell’aria li lancia nel mare, e il mare li scaraventa nella terra e la terra li butta nelle fiamme del sole che, a sua volta, li rimette nell’aria per essere ancora respinti da tutti gli elementi. Uno di costoro sono io, fuggendo gli dei e vagando a colpa della mia fede per l’Odio”.
Ed ancora:“Già un tempo io nacqui fanciullo e fanciulla, arboscello e uccello e pesce ardente balzante fuori dal mare”.
E si narra di qualche miracolo da lui compiuto:
“Scoppiata una pestilenza fra gli abitanti di Selinunte per il fetore derivante dal vicino fiume, sì che essi stessi perivano e le donne soffrivano nel partorire, Empedocle pensò allora di portare in quel luogo a proprie spese (le acque di) altri due fiumi di quelli vicini: con questa mistione le acque divennero dolci. Così cessò la pestilenza e mentre i Selinuntini banchettavano presso il fiume, apparve Empedocle; essi balzarono, gli si prostarono e lo pregarono come un dio. Volle poi confermare quest’opinione di sé e si lanciò nel fuoco”. (VIII, 70).
Cioè si lasciò cadere dentro il cratere dell’Etna.
“E questo tutto abbrustolito chi è? – Empedocle. – Si può sapere perché ti gettasti nel cratere dell’Etna? – Per un eccesso di malinconia. – No: per orgoglio, per sparire dal mondo e farti credere un dio. Ma il fuoco rigettò una scarpa e il trucco fu scoperto”; così satireggia Luciano, allievo di Epicuro (I dialoghi, trad. Mosca; BUR, Rizzoli, 1990).
Altra voce tramanda che egli cadde da un cocchio mentre si recava a Messina, morendo pel conseguente aggravarsi dell’infezione di una ferita alla gamba. Ed il suo sepolcro sarebbe nei pressi di Megara Iblea.
IL PENSIERO
Empedocle di Agrigento svolse la sua attività di filosofo nel V secolo a.C. in Sicilia e fu influenzato dal pitagorismo e dall’orfismo, ma anche dall’eleatismo: tuttavia Empedocle si colloca nell’ambito dei cosiddetti “pluralisti”. Nacque ad Agrigento intorno al 490 a.c. e pur essendo di nobile famiglia , partecipò attivamente alle lotte politiche della sua città schierandosi con i democratici e per questo morì forse in esilio nel 425. Tuttavia la sua figura sfumò presto nella leggenda (che tra l’altro vuole che egli morisse precipitando nel cratere dell’Etna). E presenta ancora i tratti dell’antico sapiente che stende in versi la propria opera e che si occupa di tutto (di medicina, di fisica, di religione, ecc). Discendente da nobile famiglia, Empedocle sceglie di scrivere in versi perché ai suoi tempi la poesia era un’autorità da tutti riconosciuta, che tendeva a meglio diffondersi rispetto alla prosa; a differenza di Parmenide, che dalla poesia aveva ereditato esclusivamente la forma, Empedocle ne assume anche il linguaggio altisonante e roboante, tant’è che Aristotele lo considera l’inventore della retorica. C’è un alone di mistero che circonda le sue opere: il suo scritto principale – intitolato Sulla natura – è affiancato da un altro scritto, tradizionalmente noto come Purificazioni. Il mistero risiede nel fatto che le due opere trattino di cose diversissime tra loro, a tal punto da far dubitare dell’autentica paternità di Empedocle: il Sulla natura è un’opera sensu stricto fisica, mentre dalle Purificazioni traspaiono palesemente influenze pitagoriche ed orfiche, nella misura in cui Empedocle propugna l’immortalità dell’anima (che nel Sulla natura era detta mortale) e la metempsicosi. Le due opere, pertanto, ci restituiscono un Empedocle diverso e, paradossalmente, antitetico. Il mistero si infittisce nel momento in cui ci si chiede se le Purificazioni siano un’opera autonoma o, piuttosto, una parte integrante del Sulla natura. E, in quest’ultimo caso, occorre anche domandarsi in quale parte del Sulla natura debbano essere collocate (all’inizio? alla fine?). Misterioso è anche il fatto che Aristotele sembri conoscere solamente l’Empedocle del Sulla natura e che mai menzioni le Purificazioni (che non conoscesse tale opera pare assai difficile, data la straordinaria erudizione che lo caratterizza). Messo in luce il “giallo” intorno alla figura di Empedocle, proviamo ora a ricostruirne la fisica, alla luce di quanto egli stesso ci ha lasciato nel suo poema Sulla natura: qui, egli spiega la formazione del mondo a partire dall’empiria, ovvero da quel mondo in continuo fieri tanto aborrito da Parmenide. Occorre trovare a fondamento della realtà una pluralità di principi aventi caratteristiche tali da rispettare le norme fissate da Parmenide per il suo essere: unicità (se l’essere fosse molteplice, sarebbe uno e non sarebbe uno, cioè sarebbe e non sarebbe), immobilità (se l’essere fosse in moto, ora sarebbe qui e ora non sarebbe qui, cioè sarebbe e non sarebbe), eternità (se l’essere fosse generato, verrebbe ad essere mentre prima non era). Se si vuole fondare con certezza la realtà spiegandone il divenire e salvando i fenomeni (presupposto a cui tutti i “pluralisti” restano fedeli) senza trasgredire le norme parmenidee, occorre rinvenire più principi aventi tutti le caratteristiche dell’essere parmenideo. Debbono essere molti, poiché altrimenti non si spiegherebbero le molte facce in cui il reale si presenta. Empedocle ritiene di aver individuato i principi in quattro elementi: l’acqua, l’aria, la terra e il fuoco. Tali principi vengono da lui denominati radici (ριζοματα), a sottolineare come essi facciano nascere la realtà e le conferiscano stabilità. Poste a fondamento del reale le quattro “radici”, Empedocle arriva a divinizzarle, cosa che può sembrare strana soprattutto se riferita alla terra, che rappresenta il basso. Esse sono all’origine della corruzione e della generazione, pur essendo esse stesse sottratte a tali processi: le cose che cadono sotto i nostri sensi nascono e muoiono non già nel senso che passino dal non essere all’essere e viceversa, bensì nel senso che siano il frutto dell’aggregazione (nascita) e della disgregazione (morte) delle quattro radici, le quali sono però eterne, immutabili, immobili. L’intera realtà – ivi compresi gli dei e l’anima – rientrano in tale processo di aggregazione e corruzione; solamente le quattro radici (corrispondenti all’essere parmenideo) ne restano fuori. Ciascun aggregato è il prodotto della combinazione delle radici, con la conseguenza che il fondamento della realtà è una struttura invisibile soggiacente a quella visibile e tale da spiegarla. Aristotele nota sagacemente che nella ricerca delle cause Empedocle compie un gran passo avanti, distinguendo per la prima volta tra la causa materiale e quella efficiente (detta “causa del movimento”): infatti, per spiegare come le quattro radici possano combinarsi e separarsi, Empedocle fa riferimento ad altre due cause, da lui chiamate Amore e Odio. Sicchè la generazione delle cose nasce dall’unione delle quattro radici in forza dell’azione dell’Amore, mentre la disgregazione è il frutto dell’agire dell’Odio. In questo senso, la cosmologia empedoclea non è che la proiezione sul mondo delle regole (l’odio e l’amore) stanti alla base dei rapporti umani. Amore e Odio agiscono dunque come causa del movimento delle quattro radici, ma non è in alcun caso possibile – nota Aristotele – attribuire ad essi la funzione di cause formali e finali: infatti, non agiscono in vista di un qualche fine, ma il loro processo è anzi, in certo senso, retto dal caso; in realtà Empedocle, alla parola “caso”, preferisce “armonia”: il processo messo in moto da Amore e Odio è sì casuale, ma tale da creare un’armonia. Il cosmo stesso si configura agli occhi di Empedocle come una totalità ordinata, giacchè soggetto ad una vicenda ciclica che attraversa varie fasi: dapprima prevale l’Amore e le quattro radici si trovano commiste fra loro; poi subentra l’Odio che, introducendo divisioni, permette la nascita dei viventi; in seguito l’Odio prevale e le quattro radici sono del tutto divise. A questo punto, termina il ciclo e riprende da capo. Si tratta di una vicenda ciclica non scandita da divinità, ma autoregolantesi. Anche per Empedocle gli uomini sbagliano quando parlano di perire e di nascere delle cose: Parmenide aveva già detto che l’essere è sempre stato e sempre sarà . Empedocle introduce quindi i due concetti di aggregazione e di disgregazione: in realtà dietro alle vicende di trasformazioni incessanti permangono costanti ed indistruttibili quelli che Empedocle chiama “radici” e che poi saranno chiamati elementi (terra, acqua, aria e fuoco). Questa è una grande innovazione e rappresenta un notevole allontanamento dagli eleati: il dominio di ciò che è, è molteplice. Gli oggetti che cadono sotto i nostri sensi non sono altro che mescolanze delle quattro radici secondo diverse proporzioni. Empedocle si allontana dall’eleatismo anche per il fatto che le radici siano suscettibili di movimento e per il fatto che esistano forze capaci di creare le aggregazioni a partire dalle 4 radici e le disgregazioni degli oggetti così costituiti. Il nascere ed il morire a rigore non esistono : sono solo aggregazioni e disgregazioni : sono prerogative degli oggetti risultanti dalla mescolanza delle 4 radici ; essi sono dovuti all’azione di due forze che Empedocle , attingendo al linguaggio dei racconti mitici, chiama amore e odio. Queste due forze operano non solo sull’universo nella sua totalità , ma anche su ciascuna delle cose che popolano l’universo . Un aspetto fondamentale della loro azione è che essa avviene nel tempo e secondo gradi diversi. Quando l’azione dell’Amore prevale su quella dell’Odio si ha una situazione di pace, che Empedocle , sulla scia di Parmenide, concepisce come una sfera compatta e priva di scissioni al suo interno: è il celebre sfero. Empedocle ci fornisce quindi una sua cosmogonia, una spiegazione sull’origine del mondo . Lo sfero è la situazione primordiale in cui tutte e 4 le radici sono mescolate e vi sono pure l’Amore e l’Odio: è una totale situazione di aggregazione in cui prevale l’Amore sull’Odio. Ma pian piano l’Odio prevarrà e le 4 radici si separeranno; col tempo però tornerà a prevalere l’Amore e torneremo alla situazione primordiale di totale aggregazione. Ma poi si verificherà nuovamente il prevalere dell’Odio e le 4 radici si separeranno pian piano per poi passare alla totale disgregazione e poi nuovamente all’aggregazione. Il nostro mondo si trova proprio nella posizione di separazione dall’Amore, ma non ha ancora raggiunto l’Odio : è a metà strada ; quando raggiungerà l’Odio si distruggerà per poi “rinascer” nuovamente . E’ una visione ciclica del mondo: per Empedocle durerà fin quando dal punto di partenza (l’Amore) non arriverà all’opposto (l’Odio). Ma questo processo di aggregazione e disgregazione non vale solo per il mondo, ma per l’intera realtà: anche gli uomini si vengono a formare in questo modo e quando prevarrà l’Odio si distruggeranno. Ma Empedocle dice che l’aggregazione che porta alla creazione di un uomo (o di qualunque altra realtà) non è immediata e complessiva: non è che l’uomo si formi tutt’insieme in un preciso istante: è come se gli organi nascessero da sè e poi a loro volta si aggregassero per dar vita all’uomo. Empedocle dice poi che possono nascere dall’aggregazione esseri mostruosi come il Minotauro ed il motivo per cui non si vedono in giro è reperibile nel fatto che non riescano a sopravvivere: in natura, infatti, dice Empedocle, riescono a sopravvivere solo i più idonei e i migliori. La tradizione ci presenta Empedocle come medico: pare che egli nutrisse interessi per la comprensione dei fenomeni del vivente, come la generazione o la respirazione: Empedocle affermava che il sangue ed il respiro si muovessero entro gli stessi vasi corporei, che sarebbero riempiti da sangue che fluendo esce da essi e lascia spazio all’aria che entra e, viceversa, l’aria che esce lascerà spazio al sangue. Per Empedocle la respirazione avviene tramite i pori della pelle: per spiegare questo processo lui immagina una situazione in cui si immerge in acqua una clessidra: la clessidra è un vaso con un collo stretto e un’ampia base con piccoli buchi. Se essa viene immersa in acqua con l’orifizio superiore tappato, l’acqua non penetra attraverso i buchi perchè l’aria interna vi si oppone con la sua pressione; ma se si libera l’orifizio superiore , l’aria esce e l’acqua può entrare. Viceversa, se l’orifizio è tappato quando la clessidra è piena d’acqua, l’acqua non può fuoriuscire dai piccoli buchi sul fondo. I due momenti della respirazione, cioè l’inspirazione e la espirazione, corrispondono ai momenti in cui la clessidra, rispettivamente riempita d’acqua e d’aria, viene aperta nell’orifizio superiore consentendo l’ingresso di aria in un caso, di acqua nell’altro. All’acqua della clessidra corrisponde il respiro e all’aria della clessidra il sangue. Non si tratta in realtà di un vero esperimento, quanto piuttosto di un’analogia tra ciò che è osservabile e ciò che non è direttamente osservabile. Va sottolineato il fatto che l’aria sia uno dei 4 elementi; il sangue invece, come ogni realtà, è una mescolanza di essi. Quanto migliore (quindi più proporzionata ) è tale mescolanza, tanto migliore per Empedocle risulta essere la qualità del pensiero, che Empedocle fa proprio risiedere nel sangue intorno al cuore. L’attività del pensiero è quindi legata alla struttura anatomica e alla fisiologia corporea, e poichè il corpo umano è costituito dalle stesse radici di cui sono costituite tutte le cose, sarà possibile istituire una corrispondenza biunivoca tra i costituenti del corpo e quelli delle cose: in ciò consiste per Empedocle la conoscenza, che sarà garantita proprio dalla sussistenza proporzionata di tutte e 4 le radici nel sangue. Il processo della conoscenza risulta quindi fondato nella omogeneità tra l’uomo ed il mondo. Gli interpreti antichi classificheranno questa concezione della conoscenza come conoscenza del simile tramite il simile. Anche le capacità dei singoli individui (per esempio nel parlare o nello svolgere attività) sono riconducibili alle diverse proporzioni in cui avviene la mescolanza di questi costituenti di tutte le cose. Il tempo svolge una funzione centrale nella cosmogonia di Empedocle: egli vuole rintracciare ciò che permane costante al di sotto della vicenda ciclica delle aggregazioni e delle disgregazioni. Ciò si integra perfettamente, ai suoi occhi, con la credenza propria della tradizione orfica a riguardo della trasmigrazione delle anime. L’anima , che in origine è un demone o un dio, spinta dall’Odio commette colpe ed è costretta a compiere un lungo viaggio. Esso dura millenni e porta l’anima a trasmigrare attraverso vari tipi di corpi viventi. Da notare che Empedocle parli di trasmigrazioni non solo in corpi animali, ma anche vegetali. Questa concezione conduce al vegetarianesimo e al rifiuto radicale dei sacrifici. Uccidere animali è infatti per Empedocle una forma di cannibalismo, dal momento che in ogni essere vivente è presente un’anima umana, che sta compiendo il suo ciclo di reincarnazioni . Se nel corso di questo ciclo l’anima si è comportata bene, al termine potrà tornare nella sua condizione divina. Su questo sfondo, Empedocle può proiettare la sua predicazione di salvezza agli uomini, indicando le vie della guarigione e della purificazione. In un mondo che gli appariva in un certo modo sopraffatto dall’Odio, egli additava ai suoi ascoltatori nelle città della Sicilia, con i suoi versi, ma anche con la sua azione di guaritore e mago (si raccontava che avesse ridestato a vita una donna in un caso di morte apparente) capace di influenzare le forze della natura, le linee di una condotta che si opponesse all’azione disgregatrice dell’Odio. Empedocle rappresenta il culmine di una tradizione di sapienti che si presentano dotati di un sapere eccezionale. Ma nel V secolo a.C. queste figure tendono progressivamente a venir meno, lasciando spazio a nuovi tipi di pensatori. Ma le sue teorie furono riprese in seguito da Aristotele (che nella Fisica individuò 4 elementi, parti ultime della realtà) e da Dante che (Inferno, XII) fa un chiaro riferimento alla teoria della disgregazione e dell’aggregazione dicendo : “… da tutte parti l’alta valle feda tremò sì, ch’io pensai che l’universo sentisse amor…“; con questi versi il poeta fiorentino intende chiaramente dire di aver sentito un rumore e un tremolio così forte da pensare che il mondo si stesse disgregando perchè arrivato al fondo del suo processo ciclico.
FRAMMENTI
Frr. 31 B 6, 8, 13, 14, 28, 29, 88 DK (fonti diverse)
Fr. B 6 (Sesto Empirico, Contro i matematici, X, 315)
1 Per prima cosa ascolta che quattro son le radici di tutte le cose:
2 Zeus splendente e Era avvivatrice e Edoneo
3 e Nesti, che di lacrime distilla la sorgente mortale.
Fr. B 8 (Plutarco, Moralia adversus Coloten, 10, 1111f)
1 […] Ma un’altra cosa ti dirò: non vi è nascita di nessuna delle cose
2 mortali, né fine alcuna di morte funesta,
3 ma solo c’è mescolanza e separazione di cose mescolate,
4 ma il nome di nascita, per queste cose, è usato dagli uomini.
Fr. B 13 (Aezio, I, 18, 2)
Nel tutto nulla vi è di vuoto né di sovrabbondante.
Fr B 14 (Pseudo Aristotele, De Melisso Xenophane Gorgia, 2.28, 976 b 26)
Nel tutto nulla vi è di vuoto: donde dunque qualcosa potrebbe sopraggiungere?
Fr. B 28 (Stobeo, Eclogae physicae, I, 15, 2 a-b)
1 Ma dappertutto eguale <a se stesso> e assolutamente infinito
2 è lo Sfero circolare, che gode della solitudine che tutto l’avvolge.
Fr. B 29 (Ippolito, Refutatio contra omnes haereses, VII, 29, 212; Simplicio, Fisica, 1124, 1)
1 Riguardo alla forma del cosmo, quale essa è nell’ordine che le è dato dall’Amicizia, dice in tal modo: “non <…> a se stesso”. Una tale bellissima forma del cosmo l’Amicizia la rende una dal molteplice; la Contesa invece, che è causa della disposizione delle cose parte per parte, da quell’unità introduce la divisione e produce il molteplice.
2 L’Amicizia produce, attraverso l’unificazione, lo Sfero, che chiama anche dio e talvolta usa anche la forma neutra.
3 “Non infatti dal suo dorso si slanciano due braccia,
4 né ha piedi, né veloci ginocchia, né membra per la generazione,
5 ma era Sfero e <d’ogni parte> eguale a se stesso”.
Fr. B 88 (Aristotele, Poetica, 1458a, 4)
<…> da entrambi nasce un’unica vista.
SACRIFICI
Non cesserete dall’uccisione che ha un’eco funesta? Non vedete
che vi divorate reciprocamente per la cecità della mente?
Il padre sollevato l’amato figlio, che ha mutato aspetto, lo
immola pregando, grande stolto! e sono in imbarazzo coloro che
sacrificano l’implorante; ma quello, sordo ai clamori dopo averlo
immolato prepara l’infausto banchetto nella casa.
E allo stesso modo il figlio prendendo il padre e i fanciulli e
la madre, dopo averne strappata la vita, mangiano le loro carni.
(I Presocratici, vol.I, Laterza, 1969, Bari)
L’OCCHIO
Come quando taluno pensando al suo cammino si apparecchia lume,
nella notte tempestosa, splendore di ardente fuoco,
adattando la lucerna che tutte le aure trattiene
e disperde il soffio dei venti impetuosi,
e la luce che fuori ne balza, quanto più è sottile,
rifulge nella casa con infaticabili raggi:
così allora il fuoco primevo costretto in membrane
e in tuniche sottili si appiattò nella rotonda pupilla;
ed esse erano traforate da meravigliosi canali
che il gorgo trattenevano dell’acqua intorno fluente,
ma fuori lasciavano passare il fuoco quanto più era sottile.
Grazie alla Suida, che commenta la voce ‘exanimis’, un altro frammento di Empedocle testimonia della grande considerazione che di sé aveva il poeta e taumaturgo agrigentino:
“Da me apprenderai tutti i filtri magici, con i quali sono allonta nati i malanni e la vecchiaia, poiché io solo te ne riferirò Indi le forze placherai degli sfrenati venti, che irruenti sulla terra coi soffi distruggono i campi. E se vorrai li desterai, invece, dalla terra. Agli uomini una siccità tempestiva, causerai dopo la pioggia. E viceversa il fecondo addurrai dopo la siccità
DIOGENE DI APOLLONIA
Diogene di Apollonia (da non confondersi con il “cinico” Diogene di Sinope), operativo nella seconda metà del V secolo a.C., è autore di un’opera intitolata Sulla natura (Περι φυσεως) – che ebbe una certa circolazione anche in Atene – da cui traspare palesemente l’influenza subita dalle tesi di Anassimene e di Anassagora: ricollegandosi direttamente ad Anassimene, Diogene ritiene che l’aria sia l’αχη in grado di spiegare l’intera realtà nella sua molteplicità. Come già per Anassimene, anche per Diogene l’argomento fondamentale in favore della sua tesi è dato dalla funzione vitale della respirazione: l’imprescindibile funzione da essa esercitata nella vita dell’uomo e degli animali vale anche a livello cosmico per il reale nel suo complesso. Se Diogene si limitasse a sostenere questa tesi, egli non sarebbe che uno Ionico giunto in ritardo – i temi dell’ materiale erano ormai tramontati da tempo e per di più del tutto privo di originalità, giacchè nell’aria era già stato da Anassimene ravvisato il principio della realtà. Ma Diogene fa un passo avanti, ed è qui che emerge l’importanza del pensiero anassagoreo per la sua formazione: in particolare, Diogene ricollega il problema del principio materiale (di marca ionica) a quello dell’Intelligenza (Νους) ammessa da Anassagora come ordinatrice del cosmo; in particolare, Diogene sostiene che l’aria è l’Intelligenza di cui parlava Anassagora. Questi, tuttavia, come nota Aristotele (Metafisica, I) – non si era spinto fino a riconoscere nell’Intelligenza la causa finale: Diogene, dal canto suo, dopo aver identificato l’aria di Anassimene con l’Intelligenza di Anassagora, arriva a dire che tale Intelligenza presiede all’ordinamento del cosmo in senso finalistico: l’aria/Intelligenza dispone le cose nel miglior modo possibile (aspetto assente in Anassagora), secondo una struttura teleologicamente organizzata. Diogene, pur essendo corifeo di posizioni monastiche di remota ascendenza ionica, non è insensibile al problema delle differenziazioni, un problema particolarmente sentito nel V secolo a.С., quando il mondo greco era venuto a contatto con culture e genti diversissime: a tal proposito, egli riconosce l’esistenza di infiniti mondi che nascono, muoiono e si riformano. L’attenzione per la differenza è poi attestata dal fatto che Diogene distingua con una certa precisione, per la prima volta nella storia, diverse zone climatiche, caratterizzate da una diversa qualità dell’aria. L’individuazione di differenti zone climatiche porta Diogene a quello che, con termine moderno, potremmo definire un autentico determinismo ambientale, tale per cui l’ambiente agisce in maniera determinante su tutto ciò che in esso si trova: in questo come negli altri infiniti mondi l’aria si presenta non già nello stesso modo, bensì con caratteristiche diverse. Ed è infatti a seconda del tipo di aria presente che si possono distinguere le zone climatiche; non solo: perfino i viventi si differenziano fra loro nella struttura anatomica a seconda della fascia climatica in cui vivono, cosicché essi sono necessariamente determinati dall’ambiente (o, meglio, dall’aria che in esso è presente). E poiché l’intelligenza di cui gli uomini dispongono non è che aria in una determinata qualità, Diogene può addirittura spiegare la differenza di intelligenza fra gli uomini in base alle fasce climatiche. Chi vive, ad esempio, in zone umide e dall’aria densa sarà meno vivace intellettualmente rispetto a chi vive in zone con aria secca, tale da stimolare il pensiero. Tuttavia Diogene non si spinge fin laddove si era spinto Empedocle, per il quale la percezione e l’intelligenza – in quanto dipendenti dal sangue – appartengono anche alle piante; dal canto suo, Diogene nega che le piante abbiano intelligenza, giacchè esse presentano una struttura piena e non cava, tale da non lasciare spazio all’aria e, dunque, all’intelligenza. Ciò attesta la coerenza metodologica di Diogene, oltre che la sua “economia di pensiero”, che gli permette di spiegare con un unico principio la realtà nel suo articolato sviluppo. Un determinismo ambientale simile a quello professato da Diogene è reperibile anche nello scritto del corpus hippocraticum intitolato Arie acque luoghi. Aristotele ricorda la descrizione dell’apparato venoso dell’uomo fatta da Diogene e ricorda, inoltre, (De anima, I) come questi abbia sostenuto che perfino l’anima umana è costituita da aria. Dell’opera di Diogene non ci sono giunti che pochi frammenti (quasi tutti riportati da Simplicio nel suo commento alla Fisica di Aristotele): è interessante il fatto che lo scritto si aprisse con una riflessione metodologica sul proprio lavoro:
Chi incomincia un qualsivoglia discorso, mi sembra necessario che esibisca un inizio indiscusso e una spiegazione poi semplice e sobria. (Fr.1) Il punto di partenza a cui Diogene fa riferimento deve essere tale da non andare incontro a possibili obiezioni e la trattazione stessa dev’essere semplice e a tutti comprensibile; il che testimonia un’attenzione rivolta alle esigenze del lettore che mai era stata prestata dai filosofi venuti prima. Il punto di partenza che Diogene ritiene inoppugnabile è l’antica tesi monastica dell’unicità del principio di natura materiale (nella fattispecie, l’aria): Per dirla insieme, mi pare che tutte le cose risultino dall’alterazione della stessa cosa e sono la stessa cosa. E ciò è chiaro: infatti, se le cose che sono adesso in questo mondo, terra, acqua, aria e fuoco e tutte le altre, quante si vedono esistere in questo mondo, dunque, se una di queste fosse diversa dall’altra perché diversa per sua propria natura e non fosse lo stesso che si muta in molte forme e si altera, non si potrebbero affatto mescolare tra loro, né all’una [verrebbe dall’altra] utilità o rovina, né mai pianta potrebbe nascere dalla terra né animale né alcun altro essere se non fossero composte in maniera da essere lo stesso. Piuttosto tutte queste cose nascono ora in una forma ora in un’altra in quanto si alterano dallo stesso e in esso ritornano. (Fr.2) Infatti non sarebbe possibile senza intelligenza una divisione tale che di ogni cosa la misura realizzi, e d’inverno e d’estate, e di notte e di giorno, e di piogge e di venti e di sereni: e tutte le altre cose, se uno vuole esaminarle, le troverà disposte nel miglior modo possibile. (Fr.3) Ci sono inoltre anche questi indizi importanti. Gli uomini e le altre creature vivono respirando l’aria. Essa è per loro anima e pensiero, come si dimostrerà chiaramente in quest’opera, e se essa si allontana, l’uomo muore e il pensiero lo abbandona. (Fr.4) Mi sembra sia dotato di intelligenza ciò che gli uomini chiamano aria, che tutti siano da esso governati e che tutto esso domini. Ciò stesso mi sembra che sia dio e giunga dovunque e tutto disponga e in tutto sia. E non c’è niente che non ne partecipi: però niente ne partecipa in maniera uguale, questo come quello, ma molti sono i modi e dell’aria e dell’intelligenza. Essa è poliforme, più calda e più fredda, più asciutta e più umida, più ferma o dotata di più rapido movimento: e vi sono in essa molte altre differenziazioni e un numero infinito di sapori e di odori. E di tutti i viventi l’anima è la stessa cosa, aria più calda di quella esterna in cui viviamo, ma molto più fredda di quella che sta presso il sole. Tuttavia questo calore non è uguale in nessun essere vivente (come neppure in un uomo rispetto all’altro) e differisce non molto, ma in modo che rimangano simili. Però nessuna delle cose che si differenziano può divenire perfettamente uguale all’altra, senza diventare la stessa. Poiché la differenziazione è multiforme, multiformi debbono essere anche gli esseri viventi e molti e, dato il grande numero delle differenziazioni, non simili l’uno all’altro né per forma né per condotta di vita né per intelligenza. Eppure tutti per la stessa cosa vivono e vedono e odono, e dalla stessa cosa tutti hanno intelligenza differente. (Fr.5)
LEUCIPPO

“Nulla avviene a caso, tutto secondo ragione e necessità“.
Si può parlare di un “caso” Leucippo, dal momento che di questo filosofo si sono dati riferimenti, non solo di natura biografica, contrastanti tra loro. Aristotele, quando parla di Leucippo, lo pone sempre in coppia col suo “collega” Democrito, col quale sarebbe stato il fondatore dell’atomismo: da ciò sembra che Leucippo – già presso Aristotele fosse figura dai contorni molto sfumati. Secondo quanto afferma Diogene Laerzio (Vite dei filosofi X 13), Epicuro mise in dubbio l’esistenza stessa di Leucippo, mentre Aristotele in più opere (Metaphysica, De generatione et corruptione, De caelo, De anima) e Teofrasto (370-287 a.C.), la cui dossografia è la fonte per lo stesso Diogene Laerzio in IX 30 sgg., attestano sia la dottrina che la storicità della figura di Leucippo. Hermann Diels in Die Fragmente der Vorsokratiker, II, 80, raccolse le opinioni divergenti degli autori antichi e spiegò tale problematicità verificativa con la formazione nel IV secolo a.C. del corpus democriteum, la raccolta dell’insieme degli scritti di Democrito, in cui furono incluse anche le opere di Leucippo, ingenerando da allora in poi una confusione fatale tra le dottrine rispettive di Leucippo e Democrito, confusione che mise in dubbio l’esistenza stessa di Leucippo. Riunificando i dati tratti da Diogene Laerzio, Aristotele e Simplicio (Physica), pare che Leucippo sia stato più giovane di Parmenide, scolaro di Zenone, maestro di Democrito e contemporaneo di Empedocle e Anassagora. Per ciò che concerne l’opera scritta di Leucippo, abbiamo il Papyrus Herculanensis (un papiro greco scoperto a Ercolano nel 1752 contenente testi filosofici epicurei) che, nell’edizione del 1768 (coll.alt. VIII 58-62) fr. 1, sostiene: “… scrivendo che… le stesse cose erano già state dette in precedenza nella Grande Cosmologia, che dicono essere opera di Leucippo. Ed è deplorato per essersi attribuito talmente le altrui dottrine, non solo ponendo nella Piccola Cosmologia le dottrine che si trovano anche nella Grande…”; e abbiamo Aezio, ed. Diels, I 25, 4 (Doxographi graeci 321), il quale dichiara: “Leucippo dice che tutto avviene secondo necessità e che questa corrisponde al fato. Dice infatti nel libro Dell’intelletto: Nulla si genera senza motivo, ma tutto con una ragione e secondo necessità”. Dalla testimonianza di Aristotele e Teofrasto si evince che Leucippo sia stato il primo a formulare le teorie atomistiche che Democrito in seguito sviluppò, soprattutto tramite l’uso di certi termini, attribuiti dagli studiosi all’opera Grande Cosmologia mai citata da Aristotele, quali “atomi”, ossia parti indivisibili (ατομα σωματα), grande vuoto (μεγα κενον), corpi solidi (nastá), scissione (apotomé), misura (rysmós), contatto reciproco (diathighé), direzione (tropé), rimescolamento (peripalaxis), vortice (dinos). Riassumendo, Leucippo avrebbe considerato la natura legata alla matematica, l’essere come un composto molteplice e materiale di atomi infiniti, ma non infinitamente divisibili, e il non essere come il vuoto in cui vengono a muoversi gli atomi. La visione leucippea sarebbe quindi deterministica e meccanicistica, da qui la spiegazione dell’origine dei mondi attraverso il vortice, che determinerebbe la scissione degli atomi più pesanti dai più leggeri, e la formazione della Terra in seguito alla forza centripeta che raccoglierebbe questi atomi pesanti. Circa l’ordinamento degli astri, Diogene Laerzio (IX, 33) riepiloga così la teoria di Leucippo: “L’orbita del sole è la più esterna, quella della luna è la più vicina alla terra, mentre quelle degli altri astri sono in mezzo a queste due”.
I PRINCIPI DELL’ATOMISMO DEMOCRITEO E LEUCIPPEO Anche gli atomisti, come già Anassagora, assumono come struttura della realtà invisibile ad occhio nudo un’infinità di principi, ancorché questi non siano infinitamente divisibile all’infinito, allora il mondo avrebbe dovuto cessare di essere già da tempo. I principi primi della realtà come li intendono gli atomisti divisibili: se infatti tutto fosse debbono essere pieni e privi di parti: tali sono quelli essi definiscono ατομα σωματα, ovvero – letteralmente – “corpi non ulteriormente tagliabili”, costituenti la struttura profonda del reale. Questi “atomi”, per potersi muovere e per consentire la generazione e la corruzione dei composti, devono avere uno spazio entro cui muoversi ed è per questa ragione che gli atomisti introducono come secondo principio il vuoto (το κενον), condizione imprescindibile del moto atomico. Gli stessi aggregati non sono che unioni di atomi e vuoto: il che è provato dal fatto che, consumandosi, i corpi cedono atomi e, perché ciò possa avvenire, dev’esserci il vuoto. Con terminologia eleatica, Democrito chiama gli atomi e il vuoto rispettivamente “essere” e “non essere”; egli asserisce poi – riprendendo l’antitesi sofistica – che la conoscenza intellettuale (avente come oggetto gli atomi e il vuoto) è κατα φυσιν (secondo natura), mentre quella degli aggregati è κατα νομον (secondo convenzione). Sicchè secondo natura conosciamo gli atomi e il vuoto, secondo convenzione il bianco, il profumato, ecc. Le cose che costantemente esperiamo non sono dunque la verità, ma mera parvenza. Essendo gli atomi infiniti, infiniti saranno anche i mondi che dalla loro aggregazione trarranno origine, cosicché gli atomisti possono relativizzare la vita che conduciamo sul nostro e possono inoltre evitare di far ricorso a cause extra-materiali. Incarnando in sé l’essere parmenideo (ed essendo dunque immutabili, eterni, incorruttibili), gli atomi come si distinguono fra loro? Per Empedocle e Anassagora, i principi si differenziano qualitativamente, il che tra l’altro spiega perché i corpi composti presentino qualità; per Democrito (e forse per Leucippo) invece – stando a quel che riferisce Aristotele – gli atomi si differenziano fra loro per caratteristiche quantitative. Per far luce su questo punto della dottrina atomistica, Aristotele esemplifica servendosi delle lettere dell’alfabeto, che egli chiama στοιχεια: ο στοιχεια sono anche gli “elementi”, con la conseguenza che gli atomi sono un po’ come le lettere dell’alfabeto e il mondo che ne risulta si presenta come una sorta di libro le cui lettere sono gli atomi. Per forma (ρυσμος) gli atomi si distinguono fra loro come la A si distingue dalla N; per ordine (διαθιγη) come AN da NA; per posizione (τροπη) come Z da N. Si tratta evidentemente di differenze puramente geometriche, con caratteristiche misurabili. Tuttavia gli atomisti si spingevano oltre: pare infatti che, poste queste tre differenze di base, essi asserissero che gli atomi sono dotati di un numero incalcolabile di differenze, a tal punto che essi finiscono col riconoscere – il che costerà loro la derisione da parte dei suoi avversari – l’esistenza di atomi di forma uncinata. Il problema cui l’atomismo è chiamato a rispondere è che, se gli atomi sono quantitativamente connotati, come si spiega che poi noi percepiamo qualitativamente i composti? Perché, se la rosa non è che un aggregato di quantità, noi la percepiamo rossa, profumata, ecc? Per render conto di ciò, l’atomismo spiega le qualità come epifenomeni delle quantità, cosicché il bianco deriverebbe da un assetto casuale dato dall’unione di atomi: la rosa non è che un aggregato di atomi quantitativamente connotati che però, colpendo i nostri organi di senso, generano impressioni qualitative (il profumo, il colore rosso, ecc). Un altro problema su cui l’atomismo deve affaticarsi riguarda la natura stessa degli atomi: se essi sono corpi invisibili e indivisibili, allora non avranno parti e saranno come enti geometrici; ma allora come è possibile ch’essi, privi di parti, si aggreghino e formino corpi divisibili costituiti da parti? Come possono muoversi? L’atomismo sostiene che gli atomi sono ab aeterno dotati di moto (il che implica il vuoto in eterno) e, più precisamente, si muovono in qualunque direzione senza tregua, con la conseguenza che possono casualmente incontrarsi e aggregarsi (ciò nel caso in cui le forme siano compatibili, come ad esempio quando si incontrano atomi ad uncino e atomi ad anello). A regolare il moto degli atomi non è una forza esterna o una divinità: l’unica legge (se in questo caso di legge si può parlare) regolante il loro movimento è il caso, non già nel senso ch’essi si muovano senza causa, bensì nel senso che il loro è un moto spontaneo, scevro di finalità e non extra-naturale: è un moto che tiene conto della legge per cui il simile attira il simile. Tutto risponde ad una ragione e ad una ferrea necessità. Oltre a negare la causa finale, l’atomismo nega quella efficiente – nota Aristotele -, giacché essa non è se non una proprietà della materia. Per l’atomismo nulla avviene a caso, tutto avviene secondo una ragione. Questa osservazione può essere provata: a questo scopo non basta accontentarsi dell’osservazione della molteplicità dei fenomeni, ma occorre risalire mediante un procedimento intellettuale alla conoscenza di ciò che non è visibile. Gli oggetti che noi percepiamo ci appaiono caldi o freddi, amari o dolci, ma queste qualità appartengono alla sfera di quello che la cultura del v secolo a.C. raggruppava sotto la categoria del νομος, ossia di ciò che è variabile, convenzionale, instabile, contrapposto al piano stabile e immutevole della natura.
DEMOCRITO
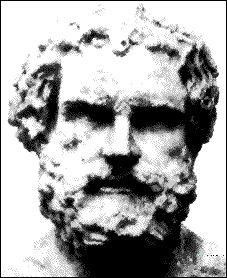 “Al saggio tutta la Terra é aperta, perchè patria di un’anima bella é il mondo intero”
“Al saggio tutta la Terra é aperta, perchè patria di un’anima bella é il mondo intero”
Democrito nacque intorno il 460 a.c. ad Abdera, dove era nato anche Protagora. Egli fu atomista, ovvero segui quelle dottrine che per un verso presuppongono l’indagine naturale dei primi pensatori e la riflessione degli eleati, ma per l’altro anche i dibattiti sui rapporti tra natura (φυσις) e legge convenzionale (νομος). Democrito, a differenza degli altri pensatori e a somiglianza dei suoi contemporanei sofisti, scrisse una miriade di opere: tramite un catalogo stilato da Trasillo nel primo secolo d.C., sappiamo che dovevano aggirarsi intorno alla cinquantina. Purtroppo ci sono pervenuti solo pochi frammenti di esse. Anche Democrito dovette recarsi una volta ad Atene, ma per il resto del tempo pare che abbia vissuto nella sua città natale, dove sarebbe morto tra il 400 e il 380 a.C. Le indagini degli atomisti presuppongono da un lato l’interesse per i problemi posti dall’osservazione dei fenomeni naturali e, dall’altro, la riflessione degli eleati, ma al tempo stesso anche l’attenzione per la pluralità dei mondi e delle culture. Le opere di Democrito trattavano argomenti di vario genere, si passava dalla matematica alla riflessione morale, dallo studio del linguaggio e dei poeti alla medicina e allo studio degli animali, ma alla base di tutta la sua ricerca egli poneva l’obiettivo di trovare una spiegazione causale unitaria di questa molteplicità di manifestazioni e aspetti del mondo fisico e umano. Anche l’atomismo si configura come teoria “pluralistica” che si propone di spiegare il cosmo senza trasgredire le prescrizioni parmenidee: l’iniziatore della corrente atomistica sembra essere stato Leucippo, figura che per noi non è che un nome, visto la scarsissima quantità di materiale sul suo conto che possediamo; ben di più sappiamo sul suo collega Democrito di Abdera, il quale scrisse – come i Sofisti – una miriade di opere sui più svariati argomenti, benché di esse non ci siano giunti che frammenti. Anche Democrito, come già Anassagora, assume come struttura della realtà invisibile ad occhio nudo un’infinità di principi, ancorché questi non siano infinitamente divisibili: se infatti tutto fosse divisibile all’infinito, allora il mondo avrebbe dovuto cessare di essere già da tempo. I principi primi della realtà come li intende Democrito debbono essere pieni e privi di parti: tali sono quelli che egli definisce ατομα σωματα, ovvero – letteralmente – “corpi non ulteriormente tagliabili”, costituenti la struttura profonda del reale. Questi “atomi”, per potersi muovere e per consentire la generazione e la corruzione dei composti, devono avere uno spazio entro cui muoversi ed è per questa ragione che Democrito introduce come secondo principio il vuoto (το κενον), condizione imprescindibile del moto atomico. Gli stessi aggregati non sono che unioni di atomi e vuoto: il che è provato dal fatto che, consumandosi, i corpi cedono atomi e, perché ciò possa avvenire, dev’esserci il vuoto. Con terminologia eleatica, Democrito chiama gli atomi e il vuoto rispettivamente “essere” e “non essere”; egli asserisce poi – riprendendo l’antitesi sofistica – che la conoscenza intellettuale (avente come oggetto gli atomi e il vuoto) è κατα φυσιν (secondo natura), mentre quella degli aggregati è κατα νομον (secondo convenzione). Sicchè secondo natura conosciamo gli atomi e il vuoto, secondo convenzione il bianco, il profumato, ecc. Le cose che costantemente esperiamo non sono dunque la verità, ma mera parvenza. Essendo gli atomi infiniti, infiniti saranno anche i mondi che dalla loro aggregazione trarranno origine, cosicché Democrito può relativizzare la vita che conduciamo sul nostro e può inoltre evitare di far ricorso a cause extra-materiali. Incarnando in sé l’essere parmenideo (ed essendo dunque immutabili, eterni, incorruttibili), gli atomi come si distinguono fra loro? Per Empedocle e Anassagora, i principi si differenziano qualitativamente, il che tra l’altro spiega perché i corpi composti presentino qualità; per Democrito invece – stando a quel che riferisce Aristotele – gli atomi si differenziano fra loro per caratteristiche quantitative. Per far luce su questo punto della dottrina democritea, Aristotele esemplifica servendosi delle lettere dell’alfabeto, che egli chiama στοιχεια: ο στοιχεια sono anche gli “elementi”, con la conseguenza che gli atomi sono un po’ come le lettere dell’alfabeto e il mondo che ne risulta si presenta come una sorta di libro le cui lettere sono gli atomi. Per forma (ρυσμος) gli atomi si distinguono fra loro come la A si distingue dalla N; per ordine (διαθιγη) come AN da NA; per posizione (τροπη) come Z da N. Si tratta evidentemente di differenze puramente geometriche, con caratteristiche misurabili. Tuttavia Democrito si spingeva oltre: pare infatti che, poste queste tre differenze di base, egli asserisse che gli atomi sono dotati di un numero incalcolabile di differenze, a tal punto che egli finisce col riconoscere – il che gli costerà la derisione da parte dei suoi avversari – l’esistenza di atomi di forma uncinata. Il problema cui Democrito è chiamato a rispondere è che, se gli atomi sono quantitativamente connotati, come si spiega che poi noi percepiamo qualitativamente i composti? Perché se la rosa non è che un aggregato di quantità noi la percepiamo rossa, profumata, ecc? Per render conto di ciò, Democrito spiega le qualità come epifenomeni delle quantità, cosicché il bianco deriverebbe da un assetto casuale dato dall’unione di atomi: la rosa non è che un aggregato di atomi quantitativamente connotati che però, colpendo i nostri organi di senso, generano impressioni qualitative (il profumo, il colore rosso, ecc). Un altro problema su cui Democrito deve affaticarsi riguarda la natura stessa degli atomi: se essi sono corpi invisibili e indivisibili, allora non avranno parti e saranno come enti geometrici; ma allora come è possibile ch’essi, privi di parti, si aggreghino e formino corpi divisibili costituiti da parti? Come possono muoversi? Democrito sostiene che gli atomi sono ab aeterno dotati di moto (il che implica il vuoto in eterno) e, più precisamente, si muovono in qualunque direzione senza tregua, con la conseguenza che possono casualmente incontrarsi e aggregarsi (ciò nel caso in cui le forme siano compatibili, come ad esempio quando si incontrano atomi ad uncino e atomi ad anello). A regolare il moto degli atomi non è una forza esterna o una divinità: l’unica legge (se in questo caso di legge si può parlare) regolante il loro movimento è il caso, non già nel senso ch’essi si muovano senza causa, bensì nel senso che il loro è un moto spontaneo, scevro di finalità e non extra-naturale: è un moto che tiene conto della legge per cui il simile attira il simile. Tutto risponde ad una ragione e ad una ferrea necessità. Oltre a negare la causa finale, l’atomismo nega quella efficiente – nota Aristotele -, giacchè per Democrito essa non è se non una proprietà della materia. Per Democrito nulla avviene a caso, tutto avviene secondo una ragione. Questa osservazione può essere provata: a questo scopo non basta accontentarsi dell’osservazione della molteplicità dei fenomeni, ma occorre risalire mediante un procedimento intellettuale alla conoscenza di ciò che non è visibile. Gli oggetti che noi percepiamo ci appaiono caldi o freddi, amari o dolci, ma queste qualità appartengono alla sfera di quello che la cultura del v secolo a.C. raggruppava sotto la categoria del νομος, ossia di ciò che è variabile, convenzionale, instabile, contrapposto al piano stabile e immutevole della natura. La vera conoscenza è quella che consente di accedere al piano nascosto che sfugge ai sensi. Qui essa trova i costituenti di tutte le cose: gli atomi (ατομα σωματα) e il vuoto (το κενον). La parola atomo deriva dal Greco e significa indivisibile (α+τεμνω = che non si può tagliare). Gli atomi sono quindi particelle indivisibili talmente piccole che non possono essere singolarmente percepite da alcun organo di senso. Gli atomisti ritengono – sulle orme di Parmenide – che siano ingenerati ed indistruttibili. Sono dunque i costituenti ultimi della realtà. Sebbene con i pluralisti nasca la causa efficiente (ciò che mette in movimento la materia: per Empedocle Amore e Odio, per Anassagora il Νους), Democrito non la accetta: secondo lui vi è un grande vuoto con atomi sparsi qua e là dotati di movimenti pulviscolari (per capire che cosa intendesse Democrito, si può guardare la polvere contro luce): essi vagano casualmente finchè non si urtano gli uni contro gli altri e, quando si scontrano, avviene un qualcosa di simile al biliardo; gli atomi si scontrano e assumono nuovi movimenti. E’ una concezione materialistica e deterministica (dato un fatto A, se ne verifica necessariamente uno B) e meccanicistica (vi è l’idea che il mondo sia un macchinario dove tutto avviene per contatto: viene così confutata la tesi dei fenomeni che avvengono a distanza, come il magnete di cui parlava Talete). Tutto avviene secondo una necessità inevitabile. Gli atomi si distinguono tra di loro non perchè alcuni sono caldi e altri freddi o perchè alcuni sono amari e altri dolci: in altre parole, non si distinguono per caratteristiche qualitative, ma quantitative. Le loro differenze sono simili a quelle che intercorrono tra le lettere dell’alfabeto. L’insieme delle differenze atomiche (posizione, ordine, forma) è dunque il tipo geometrico, ovvero riguarda la forma e la disposizione nello spazio. Ma bisogna ricordare che la quantità di forme atomiche è innumerevole, non è ristretta al solo tipo delle grandezze geometriche regolari. Com’è possibile che da queste particelle invisibili ed indivisibili si formino gli oggetti che si possono percepire con gli organi di senso? Come abbiamo detto prerogativa degli atomi è il loro continuo movimento “pulviscolare” che non avviene in una direzione privilegiata ed unica. In questi movimenti possono incontrarsi, come le palle sul tavolo del biliardo: se sono incompatibili si respingono, ma se non lo sono si aggregano. Un criterio fondamentale di aggregazione è dato dal principio che il simile si aggrega con il simile. Ma non vi è un agente esterno (una causa efficiente) che fa avvenire le aggregazioni, come era invece per Anassagora e per Empedocle. Fondamentale per il movimento è il vuoto (che fa le veci della tavola da biliardo): gli atomisti possono dire che il vuoto è “non essere” (gli atomi sono invece l’essere in senso parmenideo, ingenerati e incorruttibili), in quanto esso non è dotato di forma individuale, di limitazione e di movimento, come invece è per gli atomi, che possono quindi identificarsi con l’essere. Nel vuoto infinito si formano e si distruggono infiniti mondi, anche diversi da quello in cui viviamo (tale attenzione per la diversità è sintomatica del periodo in cui Democrito vive: il V secolo). Mediante le nozioni di atomo e di vuoto diventa possibile spiegare non solo la costituzione dei mondi e degli oggetti che ciascuno di essi contiene, bensì anche fenomeni biologici come la riproduzione o la respirazione. L’anima è per Democrito una prerogativa degli esseri viventi. La vita è contrassegnata dal calore. A spiegare questo fatto interviene la forma propria degli atomi costitutivi dell’anima: essi sono di forma sferica, la quale è suscettibile della massima mobilità. E la massima mobilità genera il calore. In questa prospettiva, la respirazione è interpretata come una funzione vitale essenziale perchè consente la continua reintegrazione degli atomi di anima che incessantemente si perdono anche per la loro costante mobilità. Quando questa reintegrazione cessa arriva la morte, caratterizzata appunto dall’immobilità e dalla freddezza. Allo stesso modo la riproduzione umana è determinata dal seme costituito da atomi provenienti da tutte le parti del corpo. Ciò permette di spiegare la trasmissione di somiglianze dai genitori ai figli. Gli stessi processi percettivi possono essere chiariti mediante il modello di spiegazione atomistica. Ogni soggetto, anche se a noi sembra immobile, è costituito di atomi intervallati dal vuoto, i quali si muovono incessantemente. Da ciascun oggetto si staccano in continuazione quelli che gli atomisti chiamano ειδωλα (immagini): si tratta di emissioni atomiche che conservano la figurazione degli oggetti dai quali provengono. Se il medio che queste emissioni attraversano, ossia l’aria, non è disturbato ed esse pervengono ai pori, vale a dire i condotti vuoti, presenti sulla superficie del nostro corpo, e attraverso di essi ai nostri organi di senso, si hanno le varie sensazioni della vista, dell’udito e così via. Ogni sensazione è quindi ricondotta a una forma di contatto degli ειδωλα con il nostro corpo. Prendiamo ad esempio l’olfatto: arrivano al nostro naso atomi di un fiore e noi lo sentiamo profumato non per il fatto che gli atomi abbiano già di per sè quell’odore, ma perchè con la loro forma mi stimolano il naso in modo tale da fiutare quell’odore. Gli odori, i sapori, i colori, esistono in me che li provo, ma non nella realtà. Ogni sensazione ci fornisce quindi informazioni sulla configurazione e sui caratteri dell’oggetto corrispondente. Pure i sogni possono avere un contenuto informativo e trasmettere addirittura pensieri e sentimenti propri dell’individuo dal quale proviene il flusso di ειδωλα. Restano comunque inaccessibili ai sensi, sia nello stato di veglia, sia durante il sonno, i principi costitutivi del tutto, ossia gli atomi, nella loro singolarità, ed il vuoto. Alla conoscenza di essi si può pervenire soltanto andando oltre alla sensazione, ossia cercando la verità nel profondo, come dice Democrito, mediante l’intelletto.
Solo questa è la conoscenza genuina. Secondo natura sono solo gli atomi e il vuoto; per convenzione invece sono il bianco, il rosso, il profumato, ecc. Dante (Inferno, IV) definisce Democrito come “colui che il mondo a caso pone” perchè – in sintonia con Aristotele – dà gran peso a quella causa finale che Democrito ignora: è come se per lui le cose andassero a caso, senza uno scopo. Nell’ottica democritea, non c’è differenza di livelli di conoscenza, tutto è percezione (persino gli oggetti del pensiero): dal cielo alla terra non ci sono che corpi costituiti da atomi e contenenti il vuoto e che (proprio perché contenenti il vuoto) emanano gli ειδωλα, le “immagini” delle cose; tali ειδωλα altro non sono se non atomi che si staccano continuamente dai corpi (Epicuro parla di pulsazione dei corpi stessi) e si rendono così a noi percepibili. Anche il corpo del soggetto percipiente, infatti, è un aggregato atomico dotato di vuoto o, meglio, di canali vuoti: gli ειδωλα si incuneano in questi canali vuoti e rispecchiano l’immagine dell’oggetto rendendolo percepibile: si ha dunque una conoscenza per contatto. Ricapitolando, la conoscenza avviene per percezione (sensismo gnoseologico) e quest’ultima avviene per contatto attraverso i cinque sensi e, se non ci fosse il vuoto, la percezione sarebbe dolorosa perché gli ειδωλα colpirebbero i nostri atomi anziché infilarsi nei canali vuoti. Tuttavia, se i corpi continuano a cedere materia (gli ειδωλα che si staccano), allora ne consegue che essi sussistono fin tanto che la materia ceduta è bilanciata da quella ricevuta: e la mancanza di respiro, ovvero la fine del ricambio di atomi, è la prova della fine dell’esistenza del corpo. La legge che vige nel mondo degli atomisti è il caso, nel senso che non vi è alcuna causa extranaturale capace di governare il movimento degli atomi: essi si aggregano in maniera puramente casuale (ed è anche per questo che Dante rinfaccia, nel IV canto dell’Inferno, a Democrito di porre il mondo a caso). Naturalmente sorge spontaneo un quesito: che cosa mi garantisce che gli ειδωλα mi riportino tale e quale la forma dell’oggetto a cui provengono? Non potrebbe essere che, nello spazio che percorrono per giungere a me, subiscono una modificazione? Qui le posizioni degli atomisti divergono: Epicuro pensa che gli ειδωλα ci raggiungano con velocità pari a quella del pensiero, cosicchè non vi è possibilità di errore. Per Democrito, invece, tutto cambia: “nulla conosciamo secondo verità perché la verità è nel profondo”, egli afferma; sembra quasi una professione di scetticismo, ma in realtà non lo è affatto. Infatti, Democrito vuol semplicemente dire che la verità sono gli atomi e il vuoto e che tutto il resto (il dolce, l’amaro, il caldo, il freddo, ecc) è opinione che, in quanto tale, è suscettibile di essere vera o di essere falsa e che varia da individuo a individuo. Democrito si accosta dunque al motto di Anassagora “οψις των αδελων τα φαινομενα”: il mondo che mi appare è opinione, e anche le opinioni si formano in base alla percezione, anche se si fermano alla superficialità, alle qualità esterne del corpo (caldo, freddo, ecc). In quanto frutto di sensazioni, anche le opinioni hanno un fondo di verità, anche se l’unica verità degna di essere definita tale è quella che si conosce quando si conoscono il vuoto e gli atomi. “Non conosciamo nulla che sia invariabile, ma solo aspetti mutevoli”, dice Democrito: e ne deduce l’esistenza di due forme di conoscenza, una genuina (“legittima”, secondo il linguaggio giuridico), l’altra oscura (“illegittima”): la conoscenza sensibile è oscura, mentre gli oggetti di quella genuina sono nascosti. Democrito affronta anche il problema della formazione delle società umane e dei tratti che le caratterizzano. Alla base di questa formazione è quello stesso principio di aggregazione del simile con il simile, che valeva per gli atomi. Un elemento di distinzione tra animali e uomo, un po’ come i sofisti, Democrito lo ravvisa nel processo delle tecniche. Ma Democrito fa leva ancora una volta sul principio della somiglianza per spiegare la genesi delle stesse tecniche: esse si costituiscono infatti a partire dall’imitazione delle attività animali. Per questo aspetto, esiste dunque una certa continuità tra il piano della natura e quello della cultura e delle istituzioni umane. L’imposizione dei nomi alle cose è un’imposizione convenzionale. Così la religione sembra essere un’invenzione umana, ma in questo caso dovuta all’iniziativa di pochi uomini sapienti. Non è difficile scorgere la parentela tra queste affermazioni e quelle sofistiche, anch’esse incentrate sul binomio νομος/φυσις. E’ difficile a causa dei pochi suoi frammenti pervenutici comprendere profondamente la sua indagine etico-politica. Per un verso egli continua la tradizione dell’antica saggezza, compendiata in massime che devono dirigere il proprio comportamento verso se stessi e verso gli altri. Queste massime vertono anche sui mali e sui pericoli che affliggono la società, la discordia e la στασις, il conflitto civile. La legge secondo Democrito dovrebbe salvaguardare da questi mali. Egli mostra una decisa preferenza per la forma di governo democratica, contrapposta alla tirannide, come la libertà lo è alla schiavitù. Ma per un altro verso l’obiettivo della vita è riposto nella tranquillità dell’animo (ευθυμια), immune da passioni eccessive; il che comporta la necessità di non farsi coinvolgere troppo non solo nelle questioni private, ma neppure in quelle pubbliche. L’esercizio della virtù non è più legato in maniera determinante alla dimensione della politica: l’etica di Democrito sembra premiare lo studioso, colui che vive al di fuori della politica (un po’ come sarà per Aristotele). Per Democrito non vi è un luogo privilegiato in cui si debba svolgere l’attività di studioso.
FRAMMENTI
Fr. A 65 (Aristotele, Fisica, 252a, 32)
È del tutto erroneo il supporre di dare un principio sufficiente col dire che è sempre o accade sempre cosí: che è la concezione a cui Democrito riconduce le cause della natura, in base alla considerazione che i fenomeni del passato si sono prodotti nello stesso modo di ora; e la causa dell’eterno, poi, non ritiene di dover ricercare.
Fr A 66 (Cicerone, De fato, 17, 39; Aristotele, Della generazione degli animali, 789b, 2; Aezio, I, 26, 2 e I, 25, 3)
1 Tutte le cose derivano dal fato sí che il fato attribuisce loro una piena necessità: tale fu l’opinione di Democrito, Eraclito, Empedocle, Aristotele.
2 Democrito, lasciate da parte le cause finali, riconduce alla necessità [meccanica] tutte le operazioni della natura.
3 Democrito dice che consiste nella impenetrabilità, nel movimento, e nell’urto della materia.
4 Parmenide e Democrito affermano che tutto avviene per necessità: e che essa è fato e giustizia e provvidenza e produttrice del mondo.
Fr A 67 (Simplicio, Fisica, 327, 24)
Ma anche Democrito, là dove dice “dal tutto si distaccò un vortice di forme d’ogni genere” (ma non dice come né per qual causa), sembra significare che il vortice si produce spontaneamente e casualmente.
Fr. A 68 (Aristotele, Fisica, 195b, 36; Simplicio, Fisica, 330, 14)
1 Alcuni dubitano anche se [il caso] esista o no: dicono infatti che nulla vien prodotto dal caso, ma che esiste una causa determinata di tutte le cose che noi diciamo prodursi spontaneamente o per caso.
2 La frase “come quell’antica dottrina che negava il caso” sembra detta in rapporto a Democrito; questi infatti, benché nella sua cosmogonia paresse valersi del caso, nei problemi particolari invece afferma che il caso non è causa di nulla e ricorre ad altre cause: cosí per esempio, della scoperta di un tesoro è causa lo scavare oppure il piantare un ulivo, e cosí della frattura del cranio del calvo è causa l’aquila che getta la tartaruga affinché il guscio di essa si rompa. Cosí riferisce Eudemo.
Fr. A 69 (Aristotele, Fisica, 196a, 24)
Vi sono poi di quelli che attribuiscono al caso la causa dell’esistenza di questo nostro cielo e di tutti i mondi: dal caso deriva il vortice e il movimento che separò gli elementi e ordinò nella sua forma presente l’universo <…>. E quel che fa veramente meraviglia è che, mentre dicono che gli animali e le piante né esistono né nascono fortuitamente, sibbene hanno una causa, sia poi questa la materia o la mente o qualcosa di simile (giacché da ogni singolo seme non viene fuori ciò che capita, ma da questo qui viene l’olivo, da quell’altro l’uomo ecc.), affermano per contro che il cielo e tutto quanto vi è di piú divino tra i fenomeni derivano dal caso e che non vi è punto per essi una causa analoga a quella che c’è per gli animali e per le piante.
Fr. A 70 (Aristotele, Fisica, 196b, 5; Aezio, I, 29, 7; Lattanzio, Institutiones divinae, I, 2)
1 Vi sono alcuni che considerano come causa il caso, il quale è impenetrabile alla ragione umana, essendo qualcosa quasi di divino e di straordinario.
2 Anassagora e Democrito e gli Stoici introdussero una causa impenetrabile all’umano ragionamento: dissero infatti che vi è ciò che dipende dalla necessità, ciò che dipende dal fato, ciò che dipende da deliberazione, ciò che dipende dal caso.
3 <…> cominciare da quella questione che sembra essere per natura la prima, se vi sia una provvidenza che a tutte le cose provvede o se tutto nel mondo sia stato prodotto e si svolga per opera del caso, opinione questa che ebbe il suo primo assertore in Democrito ed ebbe un propugnatore in Epicuro.
Fr. B 9 (Sesto Empirico, Contro i matematici, VII, 135)
1 Democrito talora rifiuta le apparenze sensibili e dice che nulla in esse ci appare conforme a verità, ma solo conforme a opinione, e che il vero negli oggetti consiste in ciò ch’essi sono atomi e vuoto. Infatti egli dice:
2 “Opinione il dolce, opinione l’amaro, opinione il caldo, opinione il freddo, opinione il colore; verità gli atomi e il vuoto” […].
Fr. B 11 (Sesto Empirico, Contro i matematici, VII, 138, 139)
1 Nei Canoni afferma che vi sono due modi di conoscenza, cioè mediante i sensi e mediante l’intelletto: e chiama genuina la conoscenza mediante l’intelletto, riconoscendo ad essa la credibilità nel giudicare il vero, mentre all’altra dà il nome di oscura, negandole la sicurezza nel conoscere il vero. Dice testualmente:
2 “Vi sono due forme di conoscenza, l’una genuina e l’altra oscura; e a quella oscura appartengono tutti quanti questi oggetti: vista, udito, odorato, gusto e tatto. L’altra forma è la genuina, e gli oggetti di questa sono nascosti [alla conoscenza sensibile od oscura]”.
3 Poscia, mostrando la superiorità della conoscenza genuina su quella oscura, prosegue dicendo:
4 “Quando la conoscenza oscura non può piú spingersi ad oggetto piú piccolo né col vedere né coll’udire né coll’odorato né col gusto né con la sensazione del tatto, ma <si deve indirizzar la ricerca> a ciò che è ancor piú sottile, <allora soccorre la conoscenza genuina, come quella che possiede appunto un organo piú fine, appropriato al pensare>. […]
Fr. B 41 (Massime di Democrito, Natorp 45)
Astienti dalle colpe non per paura ma perché si deve.
Fr. B 171 (Massime di Democrito, Natorp 10-11)
La felicità non consiste negli armenti e neppure nell’oro; l’anima è la dimora della nostra sorte.
Fr. B 234 (Massime di Democrito, Natorp 21)
Gli uomini invocano la salute dagli dèi con le preghiere, e non sanno ch’essa è in loro potere; ma siccome per intemperanza operano contro di essa, sono essi stessi che tradiscono la propria salute a causa delle passioni.
(I Presocratici, Laterza, Bari, 19904, pagg. 694-695, 748, 749, 763, 784, 795)
IPPOCRATE
 “La vita è breve, l’arte lunga, l’esperienza ingannevole, il giudizio difficile”.
“La vita è breve, l’arte lunga, l’esperienza ingannevole, il giudizio difficile”.
Nato sull’isola di Cos in una data imprecisata che può spaziare dal 460 al 450 a.C., Ippocrate è destinato a diventare nei secoli il simbolo stesso dell’arte medica. A quest’aura di leggenda, che sempre circondò la sua figura, si devono le innumerevoli e fantasiose tradizioni fiorite intorno alla sua esistenza e il confluire sotto il suo nome di uno stuolo di opere appartenenti ad altri autori, note nel loro complesso col titolo di Corpus Hippocraticum. Le uniche notizie piuttosto attendibili sulla vita di Ippocrate (che dovette terminare la propria esistenza poco dopo il 380 a.C.) sono quelle che lo vogliono figlio del medico Eraclide e dedito a frequenti viaggi: molto probabilmente, egli soggiornò infatti ad Atene e pure ad Abdera, dove fu in contatto con Democrito, concludendo infine la propria esistenza in Tessaglia. L’esistenza di un sistema ippocratico, che trascende le semplici osservazioni empiriche sulle varie affezioni, pare confermato da un passo del Fedro (270 c) di Platone, in cui il metodo del medico di Cos si dice finalizzato alla conoscenza del corpo in connessione con la natura del tutto, secondo quella corrispondenza fra macrocosmo e microcosmo già intuita da Alcmeone: anche per lui, come per Ippocrate, la salute consiste nell’equilibrio degli opposti, identificati nei quattro umori circolanti nel corpo (sangue, flegma, bile gialla e bile nera). Riportiamo il breve passo del Fedro platonico: “Per ciò che riguarda la natura, esamina che cosa mai dicono Ippocrate e il ragionamento veritiero. Non occorre forse ragionare così riguardo alla natura di qualsiasi cosa? Innanzitutto, bisogna vedere se l’oggetto di cui vorremo essere esperti noi stessi e capaci di rendere tale un altro è semplice o multiforme. In secondo luogo, qualora sia semplice, occorre esaminare quale potenza abbia per natura, a che cosa si rivolga quando è attivo o da che cosa dipenda quando è passivo. Qualora invece abbia molte forme, dopo averle enumerate, bisogna esaminare ciascuna di esse come si è fatto per la forma unica, per vedere con quale forma ciascuna agisca naturalmente e che cosa faccia, o con quale forma subisca, che cosa subisca e per effetto di che cosa”. Null’altro si può affermare con certezza sulla dottrina di Ippocrate, e sterminate sono state le discussioni sulla paternità ippocratica dei singoli scritti (una settantina circa) confluiti nel Corpus Hippocraticum. Un relativo accordo fra gli studiosi sussiste comunque per due di tali scritti: quello sulla Malattia sacra e quello su Arie, acque, luoghi. Sempre al pensiero di Ippocrate paiono potersi ricondurre i due trattati chirurgici sulle Fratture e sulle Articolazioni, nonché il Prognostico e le Epidemie (ovvero i “soggiorni” di medici in città straniere). Lo scritto sulla Malattia sacra tratta in termini antisuperstiziosi e scientifici l’epilessia, tradizionalmente intesa come un morbo inviato dagli dei e perciò detto “sacro”. Nello scritto su Arie, acque, luoghi la salute umana è posta in rapporto con l’influsso esercitato dal clima, e vi trova spazio anche un piacevole excursus etnografico sulle varie regioni d’Europa e d’Asia. Merita poi di essere brevemente menzionata – nel secondo capitolo del Prognostico – la descrizione dei segni che preannunziano la morte, quella che è passata alla storia come facies hippocratica. L’impressione generale che si ricava dalla lettura degli eterogenei scritti confluiti nel Corpus Hippocraticum (e che naturalmente non possono essere tutti attribuiti al solo Ippocrate) è, innanzitutto, quella di una mescolanza tra elementi di arcaicità e di innovazione. Spesso la descrizione dei sintomi e la prescrizione della terapia da adottare ricalca antichissime formule presenti nei testi mesopotamici ed egizi, in cui a una proposizione condizionale contenente le manifestazioni del male (ad esempio, “se un uomo ha dolori allo stomaco”), segue l’indicazione del rimedio (“allora occorrerà che assuma il tale farmaco”). Lo schema logico/sintattico del “se x, allora y” riproduce formalmente quello adoperato nelle pratiche divinatorie, in cui l’osservazione dei segni implicava la possibilità di reinterpretare il volere divino. Ma nel caso degli scritti ippocratici l’analogia è solo esteriore: l’autore del secondo Προρρητικον (Manuale delle predizioni) compreso nella seconda raccolta contesta aspramente l’applicazione del metodo mantico alla diagnostica, contrapponendo al “divinare” (μαντευεσθαι) il “congetturare” (τεκμαιρεσθαι) in base ai sintomi (σημεια) del male. L’assunzione di tale forma di ragionamento deduttivo (λογισμος) applicato alla ricorrenza di certi sintomi ebbe un influsso enorme sul pensiero greco e si estese anche all’ambito filosofico e storiografico: Jaeger sottolinea a tal proposito il debito del metodo socratico nei confronti della scienza medica, e lo stesso può dirsi a proposito di Erodoto e di Tucidide. Il carattere stesso della materia trattata e l’origine non omogenea degli scritti componenti il Corpus Hippocraticum rendono problematico esprimere un giudizio sulle qualità letterarie di questa produzione, in cui a pagine redatte in un arido stile classificatorio se ne alternano altre di piglio vivacemente polemico nei confronti delle credenze tradizionali (nella Malattia sacra e nel Manuale delle predizioni), ossia pervase di una curiosità tipicamente ionica per le terre lontane e favolose (è il caso di Arie, acque, luoghi). Ciò che anima questi scritti è in ogni caso l’ansia del conoscere e la fiducia nella ragione. Quasi certamente più antico di Ippocrate è il celebre Giuramento, che praticamente fino ai giorni nostri è stato alla base dell’etica professionale medica. Questi scritti, non di rado contrastanti tra loro, hanno in parte come destinatari altri medici, cui vengono insegnate terapie adeguate, di tipo dietetico, farmacologico o chirurgico, per la cura delle varie malattie. A volte essi forniscono quadri clinici di singoli pazienti, con indicazioni dei sintomi e dei decorsi delle malattie: è questo il caso dello scritto sulle Epidemie. Sulla base della classificazione di tipi di malattie nella loro sequenza temporale, il medico poteva formulare una previsione del decorso futuro fino alla conclusione (positiva o negativa che fosse). In vista di tale fine era importantissima una valutazione accurata dei dati sintomatici osservabili, cosa a cui provvede il Prognostico. Questo tipo di scritti mette a disposizione di altri medici il sapere acquisito personalmente o ricevuto a propria volta da altri: essi presuppongono, pertanto, che il sapere medico possa essere accumulato e accresciuto gradatamente. Quest’aspetto è evidente anche nel celebre Giuramento ippocratico, che ingiunge esplicitamente di trasmettere gli insegnamenti scritti e orali ai propri figli, ai figli del proprio maestro, agli allievi che hanno prestato il giuramento. In quest’ottica, il sapere medico appare come patrimonio di un gruppo chiuso di specialisti, non di rado legati tra loro da rapporti familiari, il quale è anche tenuto alla trasmissione di tale sapere alle generazioni venture. Un altro gruppo degli scritti costituenti il Corpus Hippocraticum si rivolge invece ad un pubblico colto, non di soli specialisti, interessato a discussioni concernenti la natura dell’uomo, le malattie e i modi per affrontarle e debellarle. Il medico antico appare come un personaggio girovago, che giunge in molte città a offrire i suoi servizi e a mettere a disposizione il proprio sapere: egli si trova dunque in forte competizione coi suoi rivali e deve dimostrare la propria superiorità su di essi non solo nei fatti, ma anche con i propri discorsi. Inoltre, i frequenti insuccessi terapeutici dei medici antichi – per esempio durante la terribile peste che sconvolse Atene nel 429 a.C., mirabilmente descritta da Tucidide – li espongono ad attacchi non solo da parte di altri medici, ma anche da parte di pratiche magiche alternative alla medicina. Il che costringe i medici a riflettere profondamente sui caratteri metodici della loro disciplina, sulle sue possibilità e sui suoi limiti. Un primo obiettivo polemico è per l’appunto dato da forme di medicina magico/religiosa. Contro di esse, si tratta di mostrare il carattere naturale di tutte le malattie, dovute a cause naturali e non divine e curabili con gli strumenti propri della medicina e non con pratiche magiche: è questo il nucleo dello scritto sulla Malattia sacra. Un ulteriore obiettivo polemico è dato da impostazioni mediche fondate su presupposti filosofici neganti alla radice la possibilità di esistenza di una medicina come terapia dei mali del corpo. Tale è l’eleatismo nella formulazione datane da Melisso, giacchè con la sua rigida concezione dell’unità dell’essere esso esclude dal dominio dell’essere la possibilità di provare dolore e, più in generale, di compiere e subire un’azione. Contro le tesi di Melisso e di quei medici che sostengono che uno solo è il costituente fondamentale del corpo umano scende in campo lo scritto intitolato La natura dell’uomo, considerato da Galeno come l’espressione migliore dell’autentico pensiero di Ippocrate (sebbene Aristotele sostenga che lo scritto deve essere attribuito non già a Ippocrate, bensì al suo genero Polibo); il nucleo di questo scritto è la teoria dei quattro umori, ai quali corrispondono i quattro temperamenti fondamentali dell’uomo: i melanconici, in cui predomina la bile nera; i flegmatici, in cui predomina il flegma; i sanguigni, in cui predomina il sangue, e infine i biliosi, in cui predomina la bile gialla. In netta opposizione con Melisso, l’autore de La natura dell’uomo asserisce che la nozione di malattia presuppone l’esistenza di una molteplicità di elementi in relazione tra loro, cosicché l’alternativa è o negare l’esistenza delle malattie (e, con esse, della medicina) o riconoscere che l’uomo è costituito da una molteplicità di elementi. In questa prospettiva, l’autore dell’opera costruisce una teoria generale dell’uomo come insieme costituito dai quattro umori. Dal rapporto equilibrato di essi scaturisce la salute, mentre la malattia non è che la rottura del loro equilibrio. Questa dottrina conoscerà un’ampia diffusione nella tradizione medica antica e sarà trasmessa fino all’epoca moderna. Un posto a parte, nel Corpus Hippocraticum, occupa lo scritto intitolato La medicina antica, anch’esso percorso da una vena fortemente polemica: il bersaglio di tale polemica è dato soprattutto dalle dottrine generali sul cosmo o sulla natura dell’uomo, come quelle elaborate da Empedocle. Esso pone al centro, invece, la variabilità dei casi individuali, portando alle estreme conseguenze quella consapevolezza della molteplicità e diversità delle situazioni naturali e culturali che aveva attraversato l’intera cultura del V secolo a.C., allorché i Greci erano entrati a contatto con civiltà e mondi diversissimi dal loro. Il medico dev’essere attento alla varietà dei casi individuali nel formulare le sue diagnosi e fare le sue terapie, senza cedere all’illusione filosofica che esista un’unica terapia ugualmente valida per tutti gli infiniti casi possibili. Del resto la scoperta stessa della medicina sta a dimostrare, secondo l’autore dello scritto, come solo procedendo per distinzioni sempre più articolate il sapere medico possa pervenire ad una maggiore precisione ed efficacia. La medicina è, in primo luogo, una terapia mediante alimenti, bevande ed esercizi, ossia ha il suo nucleo portante nella dietetica. Ma quest’ultima, che provvede a fornire a ciascun paziente l’alimento adeguato a curarlo, altro non è se non la conseguenza della scoperta che gli uomini, per sopravvivere, non possono nutrirsi degli stessi cibi di cui si nutrono gli animali, così come i malati non possono ricevere la stessa alimentazione dei sani. La medicina è allora un sapere autonomo capace di crescere in direzione di un sempre maggiore perfezionamento dei suoi strumenti metodici e terapeutici: “la medicina da gran tempo ormai dispone di tutti gli elementi, e il principio e la via sono stati scoperti, grazie ai quali in lungo corso di tempo sono state fatte molte ed egregie scoperte, e il resto nel futuro sarà scoperto”. Il pubblico a cui si rivolge questo autore non è costituito esclusivamente da medici: il messaggio centrale che egli vuole trasmettere è che la medicina sta assumendo uno statuto ontologico autonomo e di scienza. La medicina può perfezionarsi solo col tempo e lo scritto si schiera contro ogni medicina “filosofica”, che pretende cioè di insegnare il mestiere ai medici a partire da teorie generali sull’uomo e sul mondo: ciò implica un eccesso di generalità che le rende inutilizzabili, giacchè i filosofi (σοφισται) non spiegano il rapporto dell’universale col particolare. Non a caso l’autore etichetta queste teorie come “ipotesi”, ossia come supposizioni di come stanno le cose, ipotesi a partire dalle quali avanzano la pretesa di aver scoperto chiavi di lettura valide per tutti; e l’autore scaglia i suoi dardi contro Empedocle e contro gli altri pensatori dell’epoca. Il medico, a differenza del filosofo, può rivendicare di dare il bene reale agli uomini: molto marcato è il senso della scoperta della medicina e della sua autonomia indiscutibile, la sua capacità di fare scoperte cosicchè anche “il resto nel futuro sarà scoperto”; non ci si deve, pertanto, fermare alle scoperte fatte, ma bisogna adoperarsi per farne di nuove e questo è possibile solo se le generazioni future faranno tesoro del sapere accumulato dai loro predecessori Coi profani si deve solamente discutere dei mali che affliggono l’uomo e loro stessi in quest’ottica è importantissima l’anamnesi, ovvero la ricostruzione mediante il colloquio col paziente del male passato per costruire il male presente e l’evoluzione che la malattia avrà nel futuro. Questa metodologia non è propria solo dei medici: anche gli storici, in una certa misura, partono dalla convinzione che per prevedere il futuro si debba conoscere bene il passato, perché ciò consente di formulare delle costanti. Ma come è nata la medicina? E’ un sapere naturalissimo, risponde l’anonimo autore del trattato: il momento in cui uomini illuminati si interrogarono se chi soffriva dovesse seguire lo stesso regime alimentare di chi era sano fu la causa scatenante di tale disciplina, nata, in fin dei conti, per la naturalissima esigenza di sopperire alle malattie dell’uomo, necessità ineliminabili. Il passaggio dallo stato ferino alla civiltà sta, ad avviso dell’autore, nella scoperta del fuoco e nella cottura dei cibi. Proprio così si scopersero quali cibi erano utili e quali no: il sapere medico è nato nel momento in cui l’uomo è passato ad uno stato “umano” e al progresso della condizione umana è legato quello della disciplina medica. Non c’è da meravigliarsi se i primi scopritori di quest’arte erano visti come divinità, anche se, in realtà, erano uomini che esercitavano una tecnica tipicamente umana. Ma addirittura per sapere cosa è la natura è necessario partire da studi di medicina: il medico sa cosa è l’uomo e lo deduce da ciò che l’uomo mangia e beve, studiandone la salute e la condotta di vita; medico non è, dunque, chi dice che il formaggio è un cibo cattivo, ma chi dice che il formaggio è cattivo perché genera questi determinati mali. In un brano tratto da un saggio del Corpo ippocratico Sulla tecnica è tratteggiata una sorprendente teoria della scoperta scientifica: “Scopo e compito della scienza (επιστημη) è lo scoprire qualcosa che prima non era scoperto e il cui esser scoperto sia preferibile al restare ignoto”. Assai interessante è anche lo scritto dal titolo Arie, acque, luoghi: il messaggio basilare dell’opera è che il medico deve prestare particolare attenzione ai luoghi, all’aria e all’acqua che caratterizzano l’ambiente, giacchè egli deve scientemente tenerne conto nella prescrizione delle diete e nella diagnosi delle malattie (che trovano nell’aria uno dei principali veicoli di trasmissione). L’ulteriore messaggio che emerge dallo scritto è che le arie, le acque e i luoghi condizionano in maniera imprescindibile la costituzione umana, sia nel bene sia nel male, cosicché il buon medico dovrà conoscere in maniera adeguata l’ambiente circostante per poter così meglio svolgere la sua attività terapeutica. Ci troviamo dunque dinanzi ad un determinismo ambientale assai vicino a quello delineato da Diogene di Apollonia: l’ambiente determina in maniera imprescindibile chi in esso si trova. In questa prospettiva, l’autore dello scritto si lancia in un’autentica fisiognomica ambientale, facendo corrispondere a determinati individui determinati territori (ad esempio, chi è nato in zone boscose presenterà specifiche caratteristiche, e così via); tale corrispondenza si riverbera anche sui popoli: in particolare, l’autore di Arie, acque, luoghi instaura un raffronto tra i Greci e gli Orientali, notando come questi ultimi – poiché viventi in zone calde e secche – siano generalmente indolenti e pigri e, in forza di ciò, facilmente governati da tiranni. Al contrario, il clima solare e felice dei Greci fa sì ch’essi siano particolarmente briosi e agguerriti, pronti al pensiero come all’abbattimento delle tirannidi. Per questa via, l’autore dell’opera anticipa di parecchi secoli le riflessioni fatte da Montesquieu in Lo spirito delle leggi. Stante l’indiscutibile necessità della natura, resta però un interstizio in cui può inserirsi la libertà umana: tale è l’istituzione politica (νομος), grazie alla quale l’uomo può liberamente ritagliarsi uno spazio d’azione i cui confini non possono essere varcati dall’agire necessitante della natura. Così, le popolazioni orientali sono rette da grandi dispotismi e il voμoς coopera a renderle militarmente inette (manca del tutto l’interesse a ribellarsi alla tirannide); sull’altro versante, il clima e l’ambiente greco sottopongono l’uomo a cambiamenti rapidi, come rapido dev’essere il pensiero: e le istituzioni politiche presso di loro in uso non fanno che cooperare col clima controbilanciandone la necessità. L’uomo può dunque mitigare l’agire necessitante della natura attraverso le istituzioni politiche. Lo spazio riservato dall’autore dello scritto al voμoς è parecchio, tant’è che egli arriva addirittura a riconoscere come il νομος possa diventare una seconda natura: per chiarire questo punto, egli adduce l’esempio della popolazione dei Macrocefali, presso la quale era segno di prestigio avere la testa schiacciata; per questo motivo, la testa dei bambini veniva schiacciata, cosicché – nota l’autore dello scritto-, a furia di schiacciarla, le generazioni future sarebbero nate già con la testa schiacciata. In questo senso, il νομος può perfino trionfare sulla φυσις: anzi, νομος ο φυσις sono per l’autore ippocratico due entità combinatisi fra loro. I Sofisti, dal canto loro, tendono a leggerle piuttosto come due realtà opponentisi. Riportiamo qui in forma integrale il celebre Giuramento di Ippocrate: “Affermo con giuramento per Apollo medico e per Esculapio, per Igea e per Panacea – e ne siano testimoni tutti gli Dei e le Dee – che per quanto me lo consentiranno le mie forze e il mio pensiero, adempirò questo mio giuramento che prometto qui per iscritto. Considererò come padre colui che mi iniziò e mi fu maestro in quest’arte, e con gratitudine lo assisterò e gli fornirò quanto possa occorrergli per il nutrimento e per le necessità della vita; considererò come miei fratelli i suoi figli, e se essi vorranno apprendere quest’arte, insegnerò loro senza compenso e senza obbligazioni scritte, e farò partecipi delle mie lezioni e spiegazioni di tutta intera questa disciplina tanto i miei figli quanto quelli del mio maestro, e così i discepoli che abbiano giurato di volersi dedicare a questa professione, e nessun altro all’infuori di essi. Prescriverò agli infermi la dieta opportuna che loro convenga per quanto mi sarà permesso dalle mie cognizioni, e li difenderò da ogni cosa ingiusta e dannosa. Giammai, mosso dalle premurose insistenze di alcuno, propinerò medicamenti letali né commetterò mai cose di questo genere. Per lo stesso motivo mai ad alcuna donna suggerirò prescrizioni che possano farla abortire, ma serberò casta e pura da ogni delitto sia la vita sia la mia arte. Non opererò i malati di calcoli, lasciando tal compito agli esperti di quell’arte. In qualsiasi casa entrato, baderò soltanto alla salute degli infermi, rifuggendo ogni sospetto di ingiustizia e di corruzione, e soprattutto dal desiderio di illecite relazioni con donne o con uomini sia liberi che schiavi. Tutto quello che durante la cura ed anche all’infuori di essa avrò visto e avrò ascoltato sulla vita comune delle persone e che non dovrà essere divulgato, tacerò come cosa sacra. Che io possa, se avrò con ogni scrupolo osservato questo mio giuramento senza mai trasgredirlo, vivere a lungo e felicemente nella piena stima di tutti, e raccogliere copiosi frutti della mia arte. Che se invece lo violerò e sarò quindi spergiuro, possa capitarmi tutto il contrario”.
I MEGARICI
EUCLIDE DI MEGARA, EUBULIDE DI MILETO, DIODORO CRONO
Nelle sue Vite dei filosofi (II, 47), Diogene Laerzio fornisce un prezioso elenco dei più rappresentativi discepoli di Socrate e tra essi indica, accanto a Platone, Senofonte – che in realtà, pur eccellente come generale, non aveva certo la stoffa del filosofo -, Antistene, Eschine, Fedone ed Euclide di Megera. A parte Senofonte ed Eschine (omonimo del più celebre oratore avversario di Demostene), che per noi è poco più che un nome, tutti gli altri fondarono delle scuole filosofiche, ritenendosi ciascuno l’autentico depositario del verbo socratico, nonché il suo legittimo prosecutore: l’unitaria immagine di Socrate viene così a frantumarsi enigmaticamente in una variegata molteplicità di icone tra loro poco conciliabili e, spesso, in aperto contrasto (è questo il caso, ad esempio, del rigido moralismo cinico e dell’edonismo cirenaico), che ci restituiscono tante figure di Socrate tutte diverse l’una dalle altre. Così Antistene pose le basi del Cinismo, Euclide dette il via alla scuola megarica e Aristippo di Cirene – anch’egli fortemente influenzato dal socratismo – fondò la scuola cirenaica. Ciascuno di questi autori (benché di essi non siano sopravvissute opere ma solo scarsi frammenti) fu sì capostipite di una “scuola”, ma dobbiamo comunque tenere presente che si tratta in realtà – più che di scuole in senso istituzionale, con insegnamento regolare e vita in comune – di indirizzi di pensiero a cui ispirarsi. Euclide di Megera – operante nella sua città natale nel IV secolo a.C. – sviluppa soprattutto la tematica dell’unità della virtù, tematica da cui egli trae la conseguenza che il bene è uno, benché esso venga chiamato con una miriade di nomi (saggezza, intelligenza, dio, ecc). Si è spesso discusso – specialmente tra gli interpreti moderni – se l’unicità del bene sia da Euclide mutuata dal socratismo o, piuttosto, da quell’eleatismo (nella sua forma schiettamente parmenidea) che egli aveva certamente frequentato. Si tratta però di una domanda mal formulata: è infatti negabile che le due componenti – socratismo ed eleatismo – siano compresenti nel pensiero euclideo, senza elidersi vicendevolmente, ma anzi trovando sostegno reciproco. Euclide prestò particolare attenzione alle tecniche dell’argomentazione e della discussione delle tesi altrui, sulle quali si incentrava il metodo di cui si avvaleva Socrate stesso. Seguendo le sue orme, l’allievo Eubulide di Mileto mise in chiaro una congerie di difficoltà e fallacie che il linguaggio può generare: si tratta dei celebri paradossi del “mentitore” (se mento e dico che mento, mento o dico la verità?) e del “sorite” o del “mucchio” (un chicco di grano non forma un mucchio, così neppure due chicchi e neppure tre, e così via: quando si può allora dire che si ha un mucchio?). E’ soprattutto muovendo dal pensiero – testé sinteticamente esposto – di Eubulide che possiamo percepire la propensione dei Megarici per le sottigliezze sofistiche, cosa che meritò loro il poco lusinghiero nome di “eristici” e di “dialettici” (qui naturalmente preso in un’accezione negativa). Sappiamo che Euclide di Megera, alla morte del maestro, accolse presso di sé i discepoli di Socrate, fuoriusciti da Atene per timore di rappresaglie, e che fu molto sensibile anche all’atteggiamento parmenideo. Il bene, infatti, secondo Euclide, è uno, anche se acquista vari nomi: ogni discorso, quindi, che non faccia riferimento a quest’unico essere è un discorso vuoto, che si sforza invano di definire ciò che non è:
“Euclide diceva che uno è il bene, chiamato con molti nomi: a volte saggezza, a volte dio, altre volte intelletto e in altri modi ancora. Egli eliminava ciò che è opposto al bene, dicendo che è non essere. Criticava le dimostrazioni attaccandone non le premesse, ma la conclusione. Rifiutava anche il procedimento comparativo, dicendo che esso si avvale di simili o di dissimili; se si tratta di simili, è meglio guardare le cose stesse, che quelle cui sono simili; se si tratta di dissimili, I’accostamento è superfluo”. (Diogene Laerzio II, 106)
La filosofia di Euclide, come quella di Antistene, pose l’accento sulla confutazione e sulla dialettica socratica, ma ponendo come sfondo il problema dell’unità dell’essere parmenideo. Se l’essere è unico, anche la virtù è tale e coincide con il bene. Quindi se essere = bene = virtù, allora divenire, nascere e perire sono contraddittori e quindi impossibili. Per Euclide è dunque un errore considerare le cose come separate, come invece avviene nel linguaggio, che perciò non può che essere solo una convenzione umana, giacché in natura le cose sono enti e quindi uniche. Risulta perciò impossibile sia pensare che discorrere perché ogni discorso può essere ridotto all’assurdo poiché le parole sono contraddittorie rispetto al principio di unità dell’essere. Da questa concezione nasceranno poi i sofismi e i paradossi che caratterizzeranno la critica alla comunicazione. Il grande rigore logico delle dimostrazioni, ma anche la capacità di avvalersi dei trucchi propri del linguaggio e dei giochi di parole, furono una delle caratteristiche salienti della scuola megarica. Come già accennato, Eubulide, sempre nel IV secolo a.C., fu famoso in tutta l’antichità per i suoi “argomenti dialettici”, nei quali faceva grande uso di questo tipo di tecnica confutatoria. Eccone alcuni esempi
“Se tu dici di mentire e dici che questo è vero, menti o dici il vero?”
(Cicerone, Academica priora, II, 20)
“Conosci l’uomo che si avvicina ed è incappucciato? No. Se gli togliamo il cappuccio, lo riconosci? Si. Dunque conosci e non conosci la stessa persona”. (Alessandro di Afrodisia, Commento agli Elenchi sofistici, 62)
“Suppongo che tu affermi o neghi di avere o non avere tutto ciò che non hai perduto; qualunque cosa si risponda, è una rovina. Infatti, se si nega di avere ciò che non si è perso, si conclude che non si hanno gli occhi, che non si sono persi; se, invece, si risponde di avere ciò che non si è perso, si conclude che si hanno le corna, che non si sono perse”. (Aulo Gellio, Notti attiche, XVI, 2)
Ma la dialettica megarica non si esercitava soltanto in questi virtuosismi linguistici e in questi ragionamenti capziosi; essa svolse anche un’accesa polemica contro le dottrine trionfanti di Platone e di Aristotele, e specialmente contro i loro presupposti che il linguaggio fosse sempre in grado di tradurre in enunciati scientifici la realtà. In questa direzione acquista importanza la polemica megarica contro il concetto di possibilità:
“Ci sono alcuni i quali, come i Megarici, dicono che solo quando una cosa è in atto può essere, mentre quando non è in atto non può neppure essere. Per esempio, chi non sta costruendo non può costruire, ma è un costruttore solo quando sta costruendo“. (Aristotele, Metafisica 1046 b 29)
L’argomento contro il concetto di possibilità fu particolarmente sviluppato da Diodoro Crono, un allievo di Eubulide, morto intorno al 307 a.C., che riprese e sviluppò gli antichi paradossi zenoniani contro il movimento. Di Diodoro è anche noto un altro celebre argomento, il “dominatore”, di cui non è pervenuta la formulazione originaria: il nucleo di esso è che si può dire possibile solamente ciò che è o sarà. La conseguenza sembra essere che soltanto ciò che avviene necessariamente si può anche dire possibile. Socratismo ed eleatismo si fondevano dunque in funzione essenzialmente antiplatonica ed antiaristotelica. Contro la teoria del giudizio di Aristotele, e in particolare contro la possibilità di predicare un termine qualsiasi di un altro, si muoveva anche Stilpone di Megara, un altro allievo di Eubulide:
“Se predichiamo il correre di un cavallo, egli dice che il predicato non è identico al soggetto di cui si predica; l’essere del cavallo differisce infatti dall’essere del correre, perché se siamo richiesti della definizione dell’uno e dell’altro, non diamo la stessa risposta. Cosí anche la definizione dell’essenza necessaria di un uomo è diversa da quella di buono. D’onde deriva che sbagliano quelli che predicano i due termini uno dell’altro; se sono identici infatti il buono e l’essere uomo, il correre e l’essere cavallo, come potremo predicare il buono anche del cibo e della medicina e il correre del leone e del cane? Ma se sono diversi non è corretto dire che l’uomo è buono e il cavallo corre”. (Plutarco, Contro Colote, 23, 1120a)
Stilpone fu famosissimo al suo tempo e accolse alla sua scuola anche allievi di altri filosofi: tra i suoi discepoli vi fu anche Zenone di Cizio, il fondatore dello stoicismo. Fatto sta che, nel campo etico, le teorie dei Megarici proclamanti l’apatia (ἀπάϑεια), cioè la vittoria e il dominio sulle passioni e sul dolore, si confondevano sempre di più con quelle dei Cinici, ed entrambe saranno ben presto assorbite dallo stoicismo. Minore importanza (forse anche perché non ne sappiamo quasi nulla) ebbe la scuola di Fedone di Elide (un altro scolaro di Socrate), trasportata poi ad Eretria dal suo discepolo Menedemo.
PROTAGORA
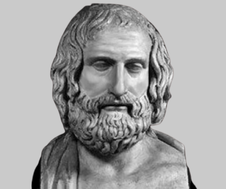 “L’uomo è misura di tutte le cose”.
“L’uomo è misura di tutte le cose”.
A partire dalla metà del V secolo a.c. diverse città della Grecia vengono attraversate da nuovi personaggi: i sofisti. Il termine “sofista” significa letteralmente “colui che fa professione del proprio sapere”. Molti sono i professionisti che mettono in vendita il loro sapere (gli artigiani o i medici, per esempio), ma i sofisti sostenevano che il loro sapere fosse ben più importante rispetto a quello degli artigiani o dei medici, giacchè il loro è il sapere che consente di prendere parte con successo alla vita pubblica della città, quando si accede alle magistrature. Tutto questo trova fondamento nel termine αρητη, la capacità di eccellere nella condotta pubblica e privata. In questo senso i sofisti si presentano come maestri di virtù. E’ chiaro che questo sapere risulta importantissimo in contesti politici in cui le decisioni sono affidate alla totalità dei cittadini, come appunto avviene nella πολις del V secolo a.C. Era dunque un sapere indispensabile soprattutto nelle democrazie. Ma il fatto che i sofisti si facciano pagare molto, fa sì che i loro clienti siano soprattutto giovani di famiglie agiate (Platone non potrà tollerare che essi facciano del sapere una materia vendibile e li definisce sprezzantemente “cacciatori di giovani ricchi”, scrivendo un dialogo – il Sofista – contro di loro: certo per Platone la vita era più facile, visto che era ricco di famiglia e non aveva bisogno di farsi pagare per insegnare). Tra i sofisti spicca la figura di Protagora: egli nacque ad Abdera, in Tracia, verso il 480 a.C., svolse la sua attività di insegnamento girovagando per le città, soggiornando più volte ad Atene. Nel 444 Pericle diede avvio alla fondazione della colonia panellenica di Turii, in Italia meridionale, e Protagora prese parte al progetto di legislazione della città. Nel 411 diede pubblica lettura ad Atene del suo scritto Sugli dei e fu accusato di empietà e dovette così lasciare la città. La tradizione vuole che Protagora sia morto in un naufragio. All’attività orale di insegnante Protagora affiancò l’insegnamento mediante lo scritto; egli non fu autore di un’unica opera, ma di parecchie: Discorsi demolitori, Le antilogie, Sull’essere e scrisse pure a riguardo dei saperi tecnici. Protagora è passato alla storia per la sua celebre affermazione: “l’uomo è misura di tutte le cose, di quelle che sono in quanto sono, e di quelle che non sono in quanto non sono“. E’ difficile comprendere fino in fondo che cosa intendesse Protagora con “uomo” (l’uomo singolo? Il genere umano?), ma è probabile che non si riferisse alla razza umana, bensì al singolo uomo. Con questa frase si sottolinea l’assoluta relatività della verità: si fa notare che ciascuno vede le cose alla sua maniera e in modo diverso rispetto agli altri; se io dico che una bevanda è dolce ed un altro dice che è amara, chi ha ragione dei due? Bisognerebbe avere un parametro che dice la verità, se è dolce o amara, il che è impossibile. Se io la sento dolce e un altro la sente amara, l’unica cosa da fare è chiedere il parere ad un terzo, ma non vi è mai un vero paragone con la cosa in questione. Per Protagora non si può trovare una verità assoluta: non si può stabilire se la bevanda è davvero dolce o se è amara: per me è amara, e per l’altro è dolce: o meglio, per chi la sente dolce è dolce, per chi la sente amara è amara: la verità è soggettiva. Non posso negare che sia amara a chi la sente amara solo perchè io la sento dolce: non c’è una verità generale, ognuno la vede a proprio modo. Non si possono cogliere le cose come realmente sono, ma solo come appaiono all’uomo, ovvero come riesce a percepirle. Le cose per me sono come a me appaiono: sento dolce il miele e, dunque, per me il miele è dolce. Però si fa notare che non tutte le affermazioni sono uguali: esse si distinguono sul piano pratico, poichè se, nel caso della bibita, non posso stabilire se è dolce o amara, tuttavia posso affermare che il dolce è meglio dell’amaro. Ma Protagora non restringe il significato di misura alla sola dimensione dell’esperienza percettiva delle cose. L’esperienza personale di ciascun individuo è più ampia delle singole sensazioni; essa non riguarda soltanto l’istante in cui avviene la singola percezione, bensì l’intera vita dell’individuo. In questo quadro si comprende meglio la portata dell’altra celebre affermazione di Protagora: “riguardo agli dei, non ho la possibilità di accertare nè che sono, nè che non sono, opponendosi a ciò molte cose: l’oscurità dell’argomento e la brevità della vita umana“. Di talune cose, dunque, come per esempio degli dei, non si ha esperienza personale diretta (com’era invece nel caso della bevanda). Di queste cose non si può dire che l’uomo sia misura. L’esperienza personale , d’altronde , differenzia gli individui tra loro , anche per le diverse situazioni ambientali , culturali e politiche nelle quali essi vivono . In questa prospettiva si inquadra in modo centrale la collocazione dell’individuo nella città . La città è interpretata da Protagora come complesso apparato educativo , il quale mira a garantire la conservazione della città stessa mediante la trasmissione dei valori che ne sono alla base. Non potendo più disporre degli dei come termine di differenziazione per caratterizzare l’uomo (infatti ha detto di non conoscere come gli dei siano ), Protagora individua questa differenziazione rispetto agli animali. Egli riconosce un’inferiorità dell’uomo rispetto alla specie animale per quanto riguarda le doti naturali, ma ravvisa nelle tecniche lo strumento che ha consentito all’uomo di capovolgere questa situazione svantaggiosa di partenza. Ma Protagora colloca al di sopra delle varie tecniche agricole e artigianali la tecnica politica, che è prerogativa di tutti i membri di una comunità. E’ appunto la tecnica politica, ossia l’insieme di giustizia e di rispetto degli altri , che la città provvede a trasmettere, prima con l’insegnamento e poi con le leggi, a tutti i suoi membri a partire dall’infanzia. Ma se il veicolo fondamentale per la trasmissione dell’insegnamento etico/politico è la città, resta ancora spazio per l’insegnamento del sofista? Il fatto che individui diversi abbiano esperienze personali diverse non implica che essi debbano per forza sempre divergere nelle loro opinioni su certe cose. Protagora non assume una posizione solipsistica, non rinchiude ogni individuo in se stesso, in una sfera di incomunicabilità con gli altri. Egli ritiene invece che sussistano spazi di accordo possibile tra gli individui. Qui il sofista può innestare la sua opera, contribuendo all’azione educativa della città. Lo strumento principale con cui lavora il sofista è il linguaggio, che può avere efficacia persuasiva facendo appello alle esperienze personali dei singoli e contrapponendo non vero e falso, ma utile e dannoso sia per il singolo sia per la comunità. Protagora afferma che “intorno ad ogni oggetto ci sono due ragionamenti contrapposti“. Questa contrapposizione non sta a significare che uno di essi sia vero e l’altro falso, in quanto ogni discorso non è che la formulazione dell’esperienza personale di ciascuno, la quale (per il relativismo assoluto) è sempre vera. Ma sul piano dei valori, che sono alla base di una città, i due discorsi non si equivalgono: in ultima istanza è la comunità che decide su quanto è giusto e su quanto è dannoso. Il sofista insegna ad usare il linguaggio in modo conforme ed utile alle esigenze della città, per esempio nell’assumere decisioni collettive, dove può anche essere importante “render più forte l’argomento più debole“. In questa prospettiva, Protagora innesta la sua opera di specialista, analoga a quella del medico o dell’artigiano, e procede alla distinzione di vari tipi di discorsi, studiando le loro proprietà, i generi dei nomi, i tempi verbali… Il linguaggio cessa di essere uno strumento usato inconsapevolmente e diventa esso stesso oggetto di indagine e d’insegnamento: il celebre motto dei sofisti diventa “la parola può tutto“. Proprio sulla nozione di relatività era incentrata la più famosa delle tesi di Protagora, trasmessaci da Platone nel “Teeteto” (dialogo dedicato a cosa significhi conoscere) : “l’uomo è misura di tutte le cose, di quelle che sono in quanto sono e di quelle che non sono in quanto non sono” (παντων χρηματων εστιν μετρον ο ανθρωπος). Questa frase, per l’impiego del termine “sono” e “non sono”, sembra inquadrarsi in un contesto vivamente eleatico, anche se viene prospettato chiaramente il criterio per distinguere l’essere da non essere: è l’uomo il metro di misura, sicchè Protagora propone un criterio di conoscenza puramente soggettivo. Sarà vero ciò che a me appare tale; viceversa, per lui sarà vero ciò che a lui appare tale, e così via. La conoscenza, in questo panorama, si riduce al sensismo: cosicchè il miele appare dolce a chi è sano, ma amaro agli ammalati. Tuttavia, in questo groviglio di verità ciascuna diversa dalle altre e ciascuna non meno valida delle altre, Protagora elabora un criterio per stabilire quale opinione (quella del sano che sente dolce il miele, o quella del malato che lo sente amaro?) sia migliore: tale criterio è incentrato sull’utilità e si risolve, per tornare all’esempio del miele, nell’interrogativo se sia migliore l’opinione di chi è malato o di chi è sano. Naturalmente, si risponderà che è migliore l’opinione del sano, anche se, ad onor del vero, sul piano gnoseologico tutte le opinioni sono equivalenti: le sensazioni si traducono in conoscenza, cosicchè la mia opinione, la tua, la sua e così via sono tutte vere, poiché l’uomo è misura di tutte le cose. Contro questa posizione protagorea si schiererà Platone che, nel Teeteto, smonterà l’argomentazione protagorea facendo notare che, se tutto è vero (come asserisce Protagora), allora è anche vero che esistono tesi false; e dato che, appunto, tutto è vero, è anche vero che ciò che dice Protagora è falso.
FRAMMENTI
Fr. 80 B 4 DK (Eusebio, Praeparatio evangelica, XIV 3, 7; Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, IX, 51)
1 Protagora, divenuto seguace di Democrito, si acquistò fama di ateo; si dice infatti che abbia cominciato il libro Degli dèi con questa introduzione:
2 Riguardo agli dèi, non so né che sono, né che non sono, né di che natura sono.
3 Riguardo agli dèi, non ho la possibilità di accertare né che sono, né che non sono, opponendosi a ciò molte cose: l’oscurità dell’argomento e la brevità della vita umana.
Fr. 80 A 5 DK (Platone, Protagora, 317 b, 317 c, 318 a, 318 e, 319 a, 348 e)
[La scena nel 431 a.C. circa; parla Protagora] Io dunque ho preso la via del tutto opposta [a quella di sofisti camuffati da poeti, iniziati, ginnasti, musici, ecc.] e convengo d’esser sofista, e di educare gli uomini […]. E sí che da molt’anni sto nell’arte; perché ne ho parecchi addosso! né v’è alcuno tra voi, al quale non potrei, quanto a età, essere padre […]. Ragazzo mio, se tu frequenterai la mia scuola, già il primo giorno che verrai potrai tornartene a casa migliore; e il giorno dopo lo stesso; e cosí ogni giorno potrai progredire verso il meglio […]. Gli altri rovinano i giovani; sfuggiti questi alle scienze speciali, li riconducono loro malgrado e li ricacciano nelle scienze speciali, insegnando loro e calcolo e astronomia e geometria e musica (e qui dette un’occhiata a Ippia); mentre chi vien da me, non altro studierà se non quello per cui viene. Materia di questo studio è un retto discernimento tanto nelle cose domestiche – quale sia il miglior modo di amministrare la propria casa – quanto nelle politiche – in che modo si divenga abilissimi al governo, sia con l’opera, sia con la parola […]. [Socrate e Protagora] Se ho ben capito, mi sembra che tu alluda alla scienza politica, e che tu t’impegni a rendere gli uomini bravi cittadini. – Questa è appunto, o Socrate, la professione che professo […]. [Socrate] – E sei tanto sicuro di te stesso, che mentre gli altri esercitano questo insegnamento di nascosto, tu ti sei fatto banditore di te stesso apertamente davanti a tutti i Greci chiamandoti sofista, e ti sei esibito maestro di cultura e di virtú, pretendendo, tu per primo, di farti pagare per questo.
Frr. 80 B 6a (Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, IX, 51) e 6b (Aristotele, Retorica, B 24, 1402a 23) DK
1 Intorno ad ogni oggetto ci sono due ragionamenti contrapposti.
2 Render piú forte l’argomento piú debole.
Fr. 80 B 1 DK (Sesto Empirico, Contro i matematici, VII, 60)
1 Alcuni compresero anche Protagora di Abdera nella schiera di quei filosofi che aboliscono una norma di giudizio, per il fatto che afferma che tutte le parvenze e opinioni son vere, e che la verità è tale relativamente a qualcosa, per ciò che tutto quel che appare è opinato da uno, esiste nell’atto stesso come relativo a lui. Appunto egli comincia i suoi Discorsi sovvertitori proclamando:
2 Di tutte le cose misura è l’uomo: di quelle che sono, per ciò che sono, di quelle che non sono, per ciò che non sono.
Frr. 80 A 4 (Eusebio, Chronica; Apuleio, Florida, 18) e 80 A 8 (Platone, Menone, 91 d, e) DK
1 Euripide è ritenuto famoso e anche Protagora sofista, i cui libri furon arsi dagli Ateniesi per pubblico decreto.
2 Di quel Protagora, che fu sofista di straordinaria cultura e oratore insigne tra i primi inventori dell’arte retorica, coetaneo del “fisico” Democrito suo concittadino (da cui egli attinse il suo sapere), si dice che avesse pattuito col suo discepolo Evatlo un compenso esagerato, ma ad una condizione arrischiata etc.
3 [Socrate ad Anito] – Io so d’un uomo, Protagora, che ha guadagnato lui solo piú danari con questa scienza [la sofistica], che non Fidia, le cui belle opere son cosí celebri, e dieci altri scultori insieme […]. Ma intanto, di Protagora, nessuno in tutta quanta la Grecia s’è accorto che guastava i discepoli e li rimandava peggiori di come li aveva ricevuti: e questo, per piú di quarant’anni! Perché credo sia morto quasi a settanta, e abbia esercitato l’arte per quaranta. E in tutto questo tempo fino ad oggi la sua celebrità non è mai venuta meno.
GORGIA
 CENNI BIOGRAFICI
CENNI BIOGRAFICI
Gorgia di Lentini era il figlio di Carmantide e nipote del famoso medico Erodico e lo ricordiamo come il più notevole rappresentante della antica sofistica dopo Protagora, e, insieme al suo maestro Tisia, il creatore dell’arte retorica. Così lo ricorda già Cicerone (I, 103; De Oratore), come colui che volle:
“dichiararsi pronto a rispondere a tutte le domande, che ciascuno volesse fargli”.
Come date di nascita e morte possono essere assunte orientativamente quelle del 483 e del 375 a. C., morendo quindi ultra centenario. Con l’esercizio e con l’insegnamento dell’arte oratoria, una novità anche per il mondo greco, diventò ricco al punto da poter dedicare, a Delfi, una statua d’oro al dio Apollo. Nel 427 andò ad Atene come ambasciatore di Leontini, in cerca di alleanze contro lo scomodo potere siracusano, e lì si fece apprezzare come retore finissimo trovando imitatori: famoso il suo Epitafio, per commemorare dei soldati ateniesi morti in guerra. Dello stesso avviso non pare Platone che, nel suo Gorgia, lo pone in contrasto critico con Socrate (447, c):
“Ma vorrà poi Gorgia discutere con noi? Perché io vorrei sapere da lui quale è la virtù propria di quest’arte che egli professa e insegna e in che cosa precisamente consista”.
E più avanti (449, a):
Socrate – ‘Piuttosto, Gorgia, dicci tu stesso come dobbiamo chiamarti e che arte è la tua’.
Gorgia – ‘La mia arte è la retorica’.
E ancora, dove Platone crea il dialogo tra Socrate e Gorgia in modo che questi si contraddica, quasi a rivelare una latente rivalità per l’ espressione culturale – confronta con la scheda su Tisia – proveniente da una ex terra colonica che diventa sempre più sede di potenti città, usando pure lo stratagemma di “chiedere” a Gorgia risposte concise, mentre il suo Socrate articola domande molto meglio costruite (454/455):
Socrate – Ti sembra che sapere e credere, ossia ‘scienza’ e ‘opinione’, siano la stessa cosa?
Gorgia – No; direi che son cose distinte.
Socrate – E diresti bene. Infatti se uno ti domandasse: ‘Gorgia v’è una opi nione falsa e una vera?’ tu risponderesti di si, credo.
Gorgia – Di si, certo.
Socrate – Ma la scienza può essere falsa e vera?
Gorgia – Assolutamente no.
Socrate – E’ proprio vero, quindi, che scienza e opinione non sono la stessa cosa.
Gorgia – Infatti.
Socrate – Eppure vi ha persuasione sia in quelli che hanno scienza che in quelli che hanno solo opinione.
Gorgia – Lo credo bene.
Socrate – Dobbiamo stabilire, pertanto, due specie di persuasione: quella che produce opinione senza il sapere, l’altra che produce scienza.
Gorgia – Hai ben ragione.
Socrate – E allora dimmi, o Gorgia, quale delle due persuasioni produce nei tribunali e nelle altre adunanze la retorica intorno al giusto e all’ingiusto? Quella, cioè, da cui deriva opinione senza sapere, oppure l’altra da cui deriva il sapere?
Gorgia – Evidentemente quella da cui deriva opinione senza sapere.
Socrate – Dunque la retorica, a quanto pare, è produttrice di quella persua sione che induce all’opinione senza il sapere, e non alla scienza del giusto e dell’ingiusto.
Gorgia – Così è.
Socrate – Di conseguenza il retore non insegna nei tribunali e nelle altre adunanze nulla intorno al giusto e all’ingiusto, ma suscita soltanto una semplice credenza. Ed infatti, come potrebbe in così breve tempo insegnare ad una moltitudine di gente cose di così grande importanza?
Gorgia – Sarebbe effettivamente impossibile.
Tale dialogo di Platone induce a riflettere: l’autore ambienta l’incontro nel 427 a.C, cioè quando Gorgia andò in Atene, ma parrebbe composto intorno al 395, dopo cioè l’avvenuta condanna a morte di Socrate; condanna ottenuta dal potere suggestionante della retorica, a danno del giusto: a danno del giusto Socrate. E il dialogo sopra riprodotto – che andrebbe letto per intero – è colmo di giusto rancore: “Quando dicesti che il retore avrebbe potuto servirsi della retorica anche ingiustamente, io rimasi perplesso (…)”. L’animo di Gorgia si risentì dello scritto dell’allievo di Socrate che lo vedeva protagonista: il siciliano non avrebbe consentito che la nuova scienza venisse applicata malamente. Fanno fede i suoi componimenti ulteriori. Tra gli altri suoi viaggi vi sono quelli a Fere in Beozia e in Tessaglia, e fu altre volte in Atene. La sua dottrina contiene un intendimento dell’arte oratoria come produttrice di persuasione: non occorre cioè che chi ascolta si convinca che ciò che ode è la verità, bensì è più utile che questi si convinca praticamente, piegandosi alla causa sostenuta dall’oratore. Nell’Elogio di Elena alla parola viene dato il potere di dominare la vita, influenzandone le scelte anche affettive, per cui la donna non ha colpa per quel che è accaduto tra i Greci e i Troiani perché fu spinta dagli dei o dalle parole. E saper accostare parola a parola può determinare la modellatura dell’animo del singolo, come del carattere della folla. La parola può modificare l’anima di chi la ode, e tramite la poesia può anche indurre nuove esperienze (concezione di cui è evidente la parentela col relativismo gnoseologico di Protagora). E le due opere prima citate, dedicate a Elena e Palamede, sono saggi tipici di tale abilità retorica, nata con Gorgia. Nell’opera Sul non ente Gorgia sostiene tre tesi: nulla esiste, se esiste non è conoscibile dall’uomo, se è conoscibile non la si può comunicare ad alcuno, specialmente col solo uso della parola.
“La critica più recente ha chiarito, sopratutto mediante l’analisi comparativa delle due esposizioni che ci restano dello scritto gorgiano (quella di Sesto Empirico e quella dello Pseudo-Aristotele), come l’esposizione di Sesto, da cui deriva l’immagine del Gorgia effettivamente scettico e nichilista, sia in realtà deformata dalla sua intenzione di dossografo dello scetticismo, e debba quindi cedere il passo all’esposizione dello Pseudo-Aristotele, nella quale l’intenzione di ironia antieleatica dello scritto di Gorgia appare concretamente connessa al suo relativismo sofistico” (Dizionario Enciclopedico Italiano, ed. Treccani).
Rileggiamo la conclusione dell’Elogio di Elena:
“Così con le parole ho liberato la donna dalla sua cattiva fama secondo la premessa del mio discorso: e sforzandomi di distruggere l’ingiustizia di un’infamia e l’ignoranza di una opinione, questo discorso ho voluto scrivere, non solo per elogiare Elena, ma perché fosse a me di passatempo”.
Sul valore che Gorgia attribuisce al passatempo, allo scherzo, abbiamo una nota di Aristotele, inquadrata con altre e che forse sono traccia di una seconda trattazione sulla Poetica, a noi non pervenuta:
“Su ciò che fa ridere, dal momento che esso sembra avere una sua utilità nei dibattiti, e che Gorgia ha detto, e ha detto bene, che occorre distruggere la serietà degli avversari con il riso e il riso con la serietà, quante siano le forme del comico si è detto negli scritti sulla poetica: di queste l’una si adatta all’uomo libero, l’altra no, e si deve scegliere quel che meglio si adatta”.
La lezione di Gorgia è tra quelle immortali dei classici, ed in generale è tra le più alte lezioni dell’ingegno umano. Per noi immortale vuol dire davvero rileggere Gorgia con attenzione; pare oggi un esercizio nuovo l’ascoltare, a saper meglio valutare la enorme mole di informazioni – che in molti hanno interesse a che venga intesa tutta come cultura – che ci circonda. Ricordiamo un aneddoto grazioso che si narra a proposito del famoso viaggio di Gorgia in Atene. Lì egli arringò a lungo la folla, facendo risaltare la differenza di temperamento che sussisteva tra gli abitanti della Sicilia e della Magna Grecia, e tutti gli altri, definiti barbari. I barbari, diceva Gorgia, vivono nella discordia perché vivono tra loro senza armonia. L’armonia sarebbe stata, secondo l’oratore, il segno distintivo della superiorità greca sui nemici, e ciò avrebbe accresciuto la stima ed il timore dei barbari nei confronti dei greci. A questo punto uno della folla, un anonimo saccente, volle appuntare a Gorgia una annotazione sulla sua situazione familiare.
“Noi siamo in tanti, Gorgia”, disse l’uomo, “e ci suggerisci di andare d’accordo e in armonia; tutti sanno però che a casa tua siete in tre, tu tua moglie ed il servo, e litigate da mane a sera. Non credi che avrebbero più effetto i tuoi discorsi se si sapesse che voi tre non recate molestia ai vicini?”
IL PENSIERO
Anche Gorgia si colloca (come Protagora) nel contesto della Sofistica: anche per lui il problema del linguaggio è centrale. Gorgia nacque a Lentini (nei pressi di Siracusa) verso il 480 a.C., viaggiò parecchio per le città greche – un po’ come il collega Protagora- ottenendo gran successo col suo insegnamento. La sua fama portò la sua città ad inviarlo in più occasioni come ambasciatore presso altre città (ad Atene, per esempio, dove lasciò a bocca aperta gli Ateniesi per la sua eloquenza). Morì in età molto avanzata (verso il 380, in Tessaglia), dove soggiornava presso il tiranno Giasone di Fere. Come Protagora, anche Gorgia scrisse molto e i suoi scritti erano per lo più orientati verso l’orazione, come il discorso Olimpico, proferito ad Olimpia per invitare i Greci a superare le loro discordie e affrontare uniti i barbari e l’Epitafio, finalizzato ad onorare gli Ateniesi caduti in guerra. Tra i suoi scritti va poi ricordato quello Sul non essere o Sulla natura, il cui titolo capovolge intenzionalmente quello dell’opera di Melisso; molto interessanti risultano anche essere L’encomio di Elena e La difesa di Palamede. Nel Non essere o Sulla natura troviamo le tre tesi fondamentali delle filosofia di Gorgia: 1) l’essere non è; 2) se anche fosse, non sarebbe conoscibile; 3) se anche fosse conoscibile, tale conoscenza non sarebbe comunicabile. Quindi per Gorgia, a differenza di Protagora, tutto è falso. Egli arriva a trarre queste conclusioni esaminando profondamente la filosofia ed in particolare quella eleatica: come gli eleatici, anche Gorgia si serve del ragionamento per assurdo: se l’essere ci fosse, sostiene Gorgia, non dovrebbe avere caratteristiche contraddittorie, come invece gli hanno attribuito gli eleatici. Gorgia ha notato che ci sono troppi contrasti tra i filosofi per quel che riguarda la questione dell’essere, cosicché egli addiviene alla conclusione che l’essere è troppo contraddittorio per esistere. Egli conclude che “l’essere non è” partendo dalle dimostrazioni che l’essere non è nè uno nè molti, nè generato nè ingenerato: sono affermazioni davvero contraddittorie. Ma la conseguenza più interessante e radicale che egli trae è probabilmente quella secondo cui non è possibile comunicare tramite il linguaggio ciò che è. Il linguaggio non ha nulla a che fare con la verità, non è possibile dire ad altri come realmente stiano le cose. Supponiamo che l’essere ci sia; prendiamo un quaderno blu: io voglio comunicare ad un altro il colore del quaderno e quindi gli dico “è blu “; ma non è che nella testa dell’altro c’è lo stesso colore, magari è un blu più tendente al verde; fatto sta che non potrà mai avere in mente la stessa cosa che ho io: l’essere, oltre a non esistere, non è pensabile e non è dicibile. Queste tre tesi di Gorgia sono l’anticipazione di quello che sarà il “nichilismo”. Gorgia sosteneva che nulla è, se anche fosse non sarebbe conoscibile, se anche fosse conoscibile non sarebbe comunicabile. La verità, dunque, resta per Gorgia inaccessibile: ne consegue che tutto è falso, e non “tutto è vero”, come invece credeva Protagora. Tutte le proposizioni possono, ad avviso di Gorgia, essere ribaltate attraverso l’arma del λογος (la parola), equiparato dal pensatore di Lentini ad una forza irresistibile alla pari del destino dei tragici o della divinità: la parola può tutto. Anche con Gorgia Platone, a cui stava particolarmente a cuore la possibilità di distinguere il vero dal falso, compie un’operazione simile a quella operata nei confronti di Protagora: se tutto è falso, cosa ci vieta di pensare che anche ciò che dice Gorgia lo sia? Ci si è spesso interrogati se Gorgia fosse un nichilista ante litteram o se, piuttosto, volesse esercitarsi con argomentazioni dialettiche al limite del pensabile. E’ tuttavia certo che l’obiettivo polemico del suo argomentare fosse l’eleatismo: egli si serve, nelle sue argomentazioni, della dimostrazione per assurdo; in altri termini, per dimostrare la verità di A, assume per assurdo che sia vero il contrario (non-A) e, a partire da tale assunzione, si mettono in luce tutte le contraddizioni che ne derivano, a tal punto che si è costretti a riconoscere la falsità di tale assunto (non-A) e ad ammettere la veridicità della tesi di partenza ad essa opposta (A). Le tre proposizioni poc’anzi elencate con cui nega la possibilità della conoscenza non è un caso che ci vengano riportate da uno scettico, Sesto Empirico, nell’opera Contro i dogmatici. Stando a quanto da lui riportato, Gorgia avrebbe sostenuto che se le cose pensate non sono esistenti, allora le cose esistenti non sono pensate: in altri termini, il pensiero non avrebbe un contenuto proprio (poiché ciò che è pensato non esiste) e, per converso, se ne ricaverebbe che ciò che esiste non è pensato. Alla base di quest’argomentazione sta una relazione che Gorgia pone: se A è in relazione con B, allora anche B è in relazione con A; se viceversa A non è in relazione con B, allora anche B non è in relazione con A. Dunque, dato che penso cose che non esistono (dragoni o uomini volanti), allora ciò significa che il pensato non è in relazione con l’essere e, per converso, che l’essere non è in relazione col pensato. Ammettendo, infatti, per assurdo l’esistenza delle cose pensate, ne conseguirebbe che l’uomo che vola o il carro che procede sul mare (tutti oggetti del mio pensiero) dovrebbero esistere, ma l’esperienza confuta ciò. Se poi dico che il pensiero rispecchia l’esistente, non si spiega perché nel pensiero trovino cittadinanza anche l’uomo che vola o il carro che procede sul mare. Il terzo argomento addotto da Gorgia poggia sull’analogia con l’esperienza: giacchè i sensi non interferiscono tra loro né si smentiscono a vicenda, si può essere spinti a credere che ciò valga anche per il pensato, cosicchè le cose che né vedo né sento né tocco, ciononostante il pensiero mi attesta che esistono. Ma in questo modo mi troverei costretto, ancora una volta, ad ammettere l’esistenza dell’uomo che vola e del carro che procede sul mare. Con Gorgia, quindi, viene per la prima volta messa in discussione la possibilità di conoscere alcunché. Sembra essere una filosofia negativa e pessimista, ma in realtà non è così: il ragionamento conduttore è in sostanza che in assenza dell’essere l’uomo è onnipotente, non ha limitazioni. Spieghiamoci meglio: se l’essere esiste, l’uomo trova lì un limite alle sue azioni; ma se l’essere non c’è (non è conoscibile) l’uomo non ha limiti. E’ su questo presupposto che si basa l’onnipotenza della retorica di Gorgia: se l’essere è ed è conoscibile non si può far conoscere alla gente ciò che si vuole (perchè ci si deve attenere all’essere), ma se non c’è l’essere non si hanno limiti e si può convincere la gente di ogni cosa: chi può dire che una cosa sia falsa se non c’è un qualcosa a cui attenersi (l’essere)? La verità per Gorgia non conta niente perchè non esiste: ciò che conta è la capacità di argomentare. Gorgia era fratello di un medico e diceva che pur non sapendo nulla di medicina, riusciva più lui del fratello a convincere i pazienti ad assumere i farmaci. Il linguaggio è totalmente distaccato dalla verità: esso non consiste nell’enunciazione di conoscenze , bensì nella persuasione (nell’encomio di Elena Gorgia prende le difese di Elena, colei per la quale aveva avuto inizio la guerra di Troia: il discorso è in realtà un puro sfoggio di virtuosità oratorie; Gorgia, con l’arte persuasoria, dimostra le cose più assurde). Per Gorgia la persuasione è indipendente dal valore di verità di ciò che viene detto, dal momento che la parola pronunciata esercita la sua influenza sull’apparato emotivo degli ascoltatori, non sulle loro eventuali capacità intellettive. La potenza della parola è equiparata da Gorgia alla potenza dei farmaci e degli incantesimi magici. Come detto, Gorgia diceva di essere più capace a far prendere le medicine ai pazienti di quanto non lo fosse il fratello medico: questo risultato può essere ottenuto sulla base di due presupposti . Il primo consiste nel rendersi conto della particolare condizione psicologica in cui si trovano di volta in volta i propri ascoltatori e di valutare il momento opportuno (in Greco ο καιρος) per parlare e dire determinate cose. Il secondo presupposto consiste nella capacità di usare diversi tipi di discorso appropriati alle circostanze. Il nucleo dell’insegnamento di Gorgia è proprio dato dallo studio delle differenti forme del discorso e della molteplicità delle figure stilistiche da usare. Per ottenere gli effetti persuasivi desiderati. Gorgia elabora anche un’interessante teoria a riguardo dell’arte (fortemente positiva); prima di lui nessuno se ne era occupato: perchè? L’età presofistica era un’età dove la filosofia era prettamente cosmologica: si cercava cioè di spiegare da dove fosse saltato fuori il mondo; con i sofisti la filosofia assume istanze a carattere antropologico: l’oggetto della ricerca diventa l’uomo e tutto ciò che lo riguarda. In seguito, anche Platone elaborerà una teoria sull’arte (fortemente negativa: per lui è meglio attenersi al vero e non lasciarsi trasportare dall’arte che stimola passioni e non è copia di ciò che è veramente) e pure Aristotele (la sua è una visione più positiva); Gorgia parte dal presupposto che noi non possiamo conoscere l’essere: se l’essere esistesse, l’arte sarebbe solo una sua imitazione imperfetta; ma dato che non esiste, da una parte non ho limiti e dall’altra l’arte diventa una mia creazione. Dato che non c’è un vero mondo (l’essere non c’è) , l’artista è un creatore di mondi: per Gorgia il buon artista è quello che riesce ad ingannare gli spettatori, e il buon spettatore è quello che si lascia ingannare dall’artista: tutto questo perchè l’essere non c’è. Una domanda che ci si è sempre posti analizzando Gorgia e tutti i sofisti, è se essi fossero politicamente conservatori o rivoluzionari. Politicamente Gorgia ha idee tipicamente conservatrici: alla domanda “che cos’è la virtù?”, egli rispondeva nel più tradizionale dei modi: “i giovani devono fare questo, i vecchi quello, le donne quell’altro….”. Come mai un tipo innovativo come Gorgia seguiva la tradizione? Egli segue la tradizione perchè se non si ha un criterio per stabilire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato (dato che l’essere non c’è), la cosa migliore da fare è seguire la tradizione, ciò che ci è stato tramandato dagli avi. Nonostante questo, i sofisti (ed in particolare Gorgia) rimangono rivoluzionari perchè seguono la tradizione solo perchè fa loro comodo. Nell’ambito sofistico emersero poi due diverse interpretazioni sul binomio νομος/φυσις (convenzione – natura): esistono due tipi particolari tipi di leggi, quella decretata dalla natura e quella decretata dall’uomo. Facciamo un esempio: per legge della natura, il più forte tende ad avere la meglio sul più debole; ma per la legge artificiale creata dall’uomo, questo non può accadere perchè si è tutti uguali ed è la legge stessa che protegge il più debole dal più forte. Ma quale è quella giusta, quella naturale o quella convenzionale? I sofisti rispondono in maniera differenziata gli uni dagli altri. Dal canto suo, Platone stesso affronta questo problema nel primo libro della Repubblica, in cui un sofista afferma che la legge artificiale è un’ingiustizia perpetrata dai più deboli ai danni dei più forti, giacchè essi cercano di limitare coloro che sono più forti e che per diritto naturale hanno diritto a prevalere introducendo le leggi artificiali.
FRAMMENTI
DEL NON ESSERE O DELLA NATURA
Fr 82 B 3 DK (Sesto Empirico, Contro i matematici, VII, 65-87)
1 Gorgia da Leontini fu anche lui del gruppo di coloro che escludono una norma assoluta di giudizio; non però per le stesse obbiezioni che muoveva Protagora e la sua scuola. Infatti nel suo libro intitolato Del Non essere o Della natura egli pone tre capisaldi, l’uno conseguente all’altro: 1) nulla esiste; 2) se anche alcunché esiste, non è comprensibile all’uomo; 3) se pure è comprensibile, è per certo incomunicabile e inspiegabile agli altri.
2 (66) Che nulla esiste, lo argomenta in questo modo: ammesso che qualcosa esista, esiste soltanto o ciò che è o ciò che non è, ovvero esistono insieme e ciò che è e ciò che non è. Ma né esiste ciò che è, come dimostrerà, né ciò che non è, come ci confermerà; né infine, come anche ci spiegherà, l’essere e il non essere insieme. Dunque, nulla esiste. (67) E invero, il non essere non è; perché, supposto che il non essere sia, esso insieme sarà e non sarà; ché in quanto è concepito come non essere, non sarà, ma in quanto esiste come non esistente, a sua volta esisterà; ora, è assolutamente assurdo che una cosa insieme sia e non sia; e dunque, il non essere non è. E del resto, ammesso che il non essere sia, l’essere non esisterà piú; perché si tratta di cose contrarie tra loro; sicché se del non essere si predica l’essere, dell’essere si predicherà il non essere. E poiché l’essere in nessun modo può non essere, cosí neppure esisterà il non essere.
3 (68) Ma neppure esiste l’essere. Perché se l’essere esiste, è o eterno o generato, oppure è insieme eterno e generato; ma esso non è né eterno, né generato, né l’uno e l’altro insieme come dimostreremo; dunque l’essere non esiste. Perché se l’essere è eterno (cominciamo da questo punto), non ha alcun principio. (69) Poiché ha un principio tutto ciò che nasce; ma l’eterno, essendo per definizione ingenerato, non ha avuto principio. E non avendo principio, è illimitato. E se è illimitato, non è in alcun luogo. Perché se è in qualche luogo, ciò in cui esso è, è cosa distinta da esso; e cosí l’essere non sarà piú illimitato, ove sia contenuto in alcunché; perché il contenente è maggiore del contenuto, mentre nulla può esser maggiore dell’illimitato; dunque l’illimitato non è in alcun luogo. (70) E neppure è contenuto in se stesso. Perché allora sarebbero la stessa cosa il contenente e il contenuto, e l’essere diventerebbe duplice, cioè luogo e corpo; essendo il contenente, luogo, e il contenuto, corpo. Ma questo è assurdo. Dunque l’essere non è neppure in se stesso. Sicché se l’essere è eterno, è illimitato; se è illimitato, non è in alcun luogo; e se non è in alcun luogo, non esiste. Ammessa dunque l’eternità dell’essere, si conclude all’inesistenza assoluta.
4 [Con ragionamenti analoghi Gorgia dimostra che l’Essere non può nemmeno essere generato (par. 71) e nemmeno “eterno e generato insieme” (par. 72). Se comunque l’Essere esistesse dovrebbe essere uno o molteplice, ma non è nessuna delle due cose (parr. 73-74)]. Resta cosí dimostrato che né l’essere, né il non essere esistono.
5 (75) Che poi neppure esistano ambedue [l’Essere e il Non-essere] insieme, è facile a dedursi. Perché ammesso che esista tanto l’essere che il non essere, il non essere s’identificherà con l’essere, per ciò che riguarda l’esistenza; e perciò, nessuno dei due è. Infatti, che il non essere non è, è già convenuto; ora si ammette che l’essere è sostanzialmente lo stesso che il non essere; dunque, anche l’essere non sarà. (76) E per vero, ammesso che l’essere sia lo stesso che il non essere, non è possibile che ambedue esistano; perché se sono due, non sono lo stesso; e se sono lo stesso, non sono due. Donde segue che nulla è. Perché se l’essere non è, né è il non essere, né sono ambedue insieme, né, oltre queste, si può concepire altra possibilità, si deve concludere che nulla è.
6 (77) Passiamo ora a dimostrare che, se anche alcunché sia, esso è, per l’uomo, inconoscibile e inconcepibile. Se infatti, come dice Gorgia, le cose pensate non sono esistenti, ciò che esiste non è pensato. Questo è logico; per esempio, se di cose pensate si può predicar la bianchezza, ne segue che di cose bianche si può predicare la pensabilità; e analogamente, se delle cose pensate si predica l’inesistenza, delle cose esistenti si deve necessariamente predicare l’impensabilità. (78) Per il che, è giusta e conseguente la deduzione, che “se il pensato non esiste, ciò che è non è pensato”. E invero, le cose pensate (rifacciamoci di qui) non esistono, come dimostreremo; dunque, l’essere non è pensato. Che le cose pensate non esistano, è evidente: (79) infatti, se il pensato esiste, allora tutte le cose pensate esistono, comunque le si pensino; ciò che è contrario all’esperienza: perché non è vero che, se uno pensa un uomo che voli, o dei carri che corran sul mare, subito un uomo si mette a volare, o dei carri a correr sul mare. Pertanto il pensato non esiste. (80) Inoltre, se si ammette che il pensato esiste, si deve anche ammettere che l’inesistente non può esser pensato; perché i contrari hanno predicati contrari; e il contrario dell’essere è il non essere. E perciò in via assoluta, se dell’esistente si predica l’esser pensato, dell’inesistente si deve predicare il non esser pensato. Il che è assurdo, perché per esempio e Scilla e Chimera e molte altre cose inesistenti sono pensate. E dunque, ciò che esiste non è pensato. (81) E come, ciò che si vede, in tanto si dice visibile, in quanto si vede; e quel che si ode, in tanto si dice udibile, in quanto si ode; né noi respingiamo le cose visibili pel fatto che non si odano, né ripudiamo le udibili pel fatto che non si vedano (ché ciascuna dev’esser giudicata dal senso che le corrisponde, non da un altro), cosí anche le cose pensate, se pur non si vedano con la vista né si odano con l’udito, esisteranno, in quanto sono concepite dall’organo di giudizio che è proprio di esse. (82) Se dunque uno pensa dei carri che corran sul mare, anche se non li vede, deve credere che ci siano carri che corron sul mare. Ma questa è un’assurdità; dunque l’esistente né si pensa, né si comprende.
7 [Gorgia passa quindi a “dimostrare” che se l’esistente potesse essere pensato e compreso non potrebbe comunque essere comunicato (parr. 83-84). Prosegue poi con una interessante definizione del linguaggio]. (85) […] Perché la parola, dice Gorgia, è l’espressione dell’azione che su noi esercitano i fatti esterni, cioè a dire le cose sensibili; per esempio, dal contatto col sapore, ha origine in noi la parola conforme a questa qualità; e dall’incontro col colore, la parola conforme al colore. Posto questo, ne viene che non già la parola spiega il dato esterno, ma il dato esterno dà significato alla parola. (86) E neppure è possibile dire che, a quel modo che esistono oggettivamente le cose visibili e le udibili, cosí esista anche il linguaggio; sicché, esistendo anch’esso come oggetto, abbia la proprietà di significare la realtà oggettiva. Perché, ammesso pure che la parola sia oggetto, egli dice, tuttavia differisce dagli altri oggetti; e soprattutto differiscono, dalle parole, i corpi visibili; perché altro è l’organo, con cui si percepisce il visibile, ed altro quello, con cui si apprende la parola. Pertanto, la parola non può esprimere la massima parte degli oggetti, cosí come neppure questi possono rivelare l’uno la natura dell’altro. (87) Di fronte a tali quesiti insolubili, sollevati da Gorgia, sparisce, per quanto li concerne, il criterio della verità; perché dell’inesistente, dell’inconoscibile, dell’inesprimibile non c’è possibilità di giudizio.
ENCOMIO DI ELENA
Fr 82 B 11 DK
1 (1) È decoro allo stato una balda gioventú; al corpo, bellezza; all’animo, sapienza; all’azione, virtú; alla parola, verità. Il contrario di questo, disdoro. E uomo e donna, e parola ed opera, e città e azione conviene onorar di lode, chi di lode sia degno; ma sull’indegno, riversar onta; poiché è pari colpevolezza e stoltezza tanto biasimare le cose lodevoli, quanto lodar le riprovevoli. (2) È invece dovere dell’uomo, sia dire rettamente ciò che si addice, sia confutare <il contrario; e dunque è giusto confutare> i detrattori di Elena, donna sulla quale consona e concorde si afferma e la testimonianza di tutti i poeti, e la fama del nome, divenuto simbolo delle fortunose vicende. Pertanto io voglio, svolgendo il discorso secondo un certo metodo logico, lei cosí diffamata liberar dall’accusa, e dimostrati mentitori i suoi detrattori e svelata la verità, far cessare l’ignoranza.
2 (3) Che per nascita e stirpe fosse prima tra i primi – uomini e donne – la donna di cui ora parliamo, non c’è chi lo ignori. Noto è infatti come sua madre fu Leda, e padre autentico un dio, putativo un mortale: Tindaro e Zeus; di cui questi, pel fatto che era, fu ritenuto suo padre; quegli, pel fatto che appariva, fu messo in dubbio; l’uno il piú potente tra gli uomini, l’altro il supremo dominatore di tutti gli esseri. (4) Da tali generata, ebbe bellezza di dea, e, avutala, non nascose d’averla. Ché in moltissimi moltissime brame d’amore suscitò, e con una sola persona molte persone attirò di eroi superbi per superbi vanti: chi avea profusion di ricchezza, chi lustro d’antica nobiltà, chi pregio di innato valore, chi superiorità di sapienza acquisita; e tutti vennero, indotti da amore avido di vittoria e da invitta avidità di onore.
3 (5) Ma chi fu, e per qual motivo, e in che modo appagò l’amore colui che conquistò Elena, non lo dirò: ché il dire, a chi sa, ciò che sa, aggiunge fiducia, ma non porta diletto. E però, varcato ora, col discorso, il tempo d’allora, mi rifarò dal principio del discorso propostomi, ed esporrò le cause per le quali era naturale avvenisse la partenza di Elena verso Troia.
4 (6) Infatti, ella fece quel che fece o per cieca volontà del Caso, e meditata decisione di Dèi, e decreto di Necessità; oppure rapita per forza; o indotta con parole, <o presa da amore>. Se è per il primo motivo, è giusto che s’incolpi chi ha colpa; poiché la provvidenza divina non si può con previdenza umana impedire. Naturale è infatti non che il piú forte sia ostacolato dal piú debole, ma il piú debole sia dal piú forte comandato e condotto; e il piú forte guidi, il piú debole segua. E la Divinità supera l’uomo e in forza e in saggezza e nel resto. Che se dunque al Caso e alla Divinità va attribuita la colpa, Elena va dall’infamia liberata.
5 (7) E se per forza fu rapita, e contro legge violentata, e contro giustizia oltraggiata, è chiaro che del rapitore è la colpa, in quanto oltraggiò, e che la rapita, in quanto oltraggiata, subí una sventura. Merita dunque, colui che intraprese da barbaro una barbara impresa, d’esser colpito e verbalmente, e legalmente, e praticamente; verbalmente, gli spetta l’accusa; legalmente, l’infamia; praticamente, la pena. Ma colei che fu violata, e dalla patria privata, e dei suoi cari orbata, come non dovrebbe esser piuttosto compianta che diffamata? ché quello compí il male, questa lo patí; giusto è dunque che questa si compianga, quello si detesti. compianta che diffamata? ché quello compí il male, questa lo patí; dunque è giusto che questa si compianga, quello si detesti.
6 (8) Se poi fu la parola a persuaderla e a illuderle l’animo, neppur questo è difficile a scusarsi e a giustificarsi cosí: la parola è un gran dominatore, che con piccolissimo corpo e invisibilissimo, divinissime cose sa compiere; riesce infatti e a calmar la paura, e a eliminare il dolore, e a suscitare la gioia, e ad aumentar la pietà. E come ciò ha luogo, lo spiegherò. (9) Perché bisogna anche spiegarlo al giudizio degli uditori: la poesia nelle sue varie forme io la ritengo e la chiamo un discorso con metro, e chi l’ascolta è invaso da un brivido di spavento, da una compassione che strappa le lacrime, da una struggente brama di dolore, e l’anima patisce, per effetto delle parole, un suo proprio patimento, a sentir fortune e sfortune di fatti e di persone straniere. Ma via, torniamo al discorso di prima. (10) Dunque, gli ispirati incantesimi di parole sono apportatori di gioia, liberatori di pena. Aggiungendosi infatti, alla disposizione dell’anima, la potenza dell’incanto, questa la blandisce e persuade e trascina col suo fascino. Di fascinazione e magia si sono create due arti, consistenti in errori dell’animo e in inganni della mente.
(11) E quanti, a quanti, quante cose fecero e fanno credere, foggiando un finto discorso! Che se tutti avessero, circa tutte le cose, delle passate ricordo, delle presenti coscienza, delle future previdenza, non di eguale efficacia sarebbe il medesimo discorso, qual è invece per quelli, che appunto non riescono né a ricordare il passato, né a meditare sul presente, né a divinare il futuro; sicché nel piú dei casi, i piú offrono consigliera all’anima l’impressione del momento. La quale impressione, per esser fallace ed incerta, in fallaci ed incerte fortune implica chi se ne serve. (12) Qual motivo ora impedisce di credere che Elena sia stata trascinata da lusinghe di parole, e cosí poco di sua volontà, come se fosse stata rapita con violenza? Cosí si constaterebbe l’imperio della persuasione, la quale, pur non avendo l’apparenza dell’ineluttabilità, ne ha tuttavia la potenza. Infatti un discorso che abbia persuaso una mente, costringe la mente che ha persuaso, e a credere nei detti, e a consentire nei fatti. Onde chi ha persuaso, in quanto ha esercitato una costrizione, è colpevole; mentre chi fu persuasa, in quanto costretta dalla forza della parola, a torto vien diffamata. (13) E poiché la persuasione, congiunta con la parola, riesce anche a dare all’anima l’impronta che vuole, bisogna apprendere anzitutto i ragionamenti dei meteorologi, i quali sostituendo ipotesi a ipotesi, distruggendone una, costruendone un’altra, fanno apparire agli occhi della mente l’incredibile e l’inconcepibile; in secondo luogo, i dibattiti oratorii di pubblica necessità [politici e giudiziari], nei quali un solo discorso non ispirato a verità, ma scritto con arte, suol dilettare e persuadere la folla; in terzo luogo, le schermaglie filosofiche, nelle quali si rivela anche con che rapidità l’intelligenza facilita il mutar di convinzioni dell’opinione. (14) C’è tra la potenza della parola e la disposizione dell’anima lo stesso rapporto che tra l’ufficio dei farmaci e la natura del corpo. Come infatti certi farmaci eliminano dal corpo certi umori, e altri, altri; e alcuni troncano la malattia, altri la vita; cosí anche dei discorsi, alcuni producon dolore, altri diletto, altri paura, altri ispiran coraggio agli uditori, altri infine, con qualche persuasione perversa, avvelenano l’anima e la stregano.
7 (15) Ecco cosí spiegato che se ella fu persuasa con la parola, non fu colpevole, ma sventurata. Ora la quarta causa spiegherò col quarto ragionamento. Che se fu l’amore a compiere il tutto, non sarà difficile a lei sfuggire all’accusa del fallo attribuitole. Infatti la natura delle cose che vediamo non è quale la vogliamo noi, ma quale è coessenziale a ciascuna; e per mezzo della vista, l’anima anche nei suoi atteggiamenti ne vien modellata. (16) Per esempio, se mai l’occhio scorge nemici armarsi contro nemici in nemica armatura di bronzo e di ferro, l’una a offesa, l’altra a difesa, subito si turba, e turba l’anima, sicché spesso avviene che si fugge atterriti, come fosse il pericolo imminente. Poiché la consuetudine della legge, per quanto sia salda, viene scossa dalla paura prodotta dalla vista, il cui intervento fa dimenticare e il bello che risulta dalla legge, e il buono che nasce dalla vittoria. (17) E non di rado alcuni, alla vista di cose paurose, smarriscono nell’attimo la ragione che ancora possiedono: tanto la paura scaccia e soffoca l’intelligenza. Molti poi cadono in vani affanni, e in gravi malattie, e in insanabili follie; a tal punto la vista ha impresso loro nella mente le immagini delle cose vedute. E di cose terribili molte ne tralascio; ché sono, le tralasciate, simili a quelle anzidette. (18) D’altro lato i pittori, quando da molti colori e corpi compongono in modo perfetto un sol corpo e una sola figura, dilettano la vista. E figure umane scolpite, figure divine cesellate sogliono offrire agli occhi un gradito spettacolo. Sicché certe cose per natura addolorano la vista, certe altre l’attirano. Ché molte cose, in molti, di molti oggetti e persone inspirano l’amore e il desiderio. (19) Che se dunque lo sguardo di Elena, dilettato dalla figura di Alessandro, inspirò all’anima fervore e zelo d’amore, qual meraviglia? il quale amore, se, in quanto dio, ha degli dèi la divina potenza, come un essere inferiore potrebbe respingerlo, o resistergli? e se poi è un’infermità umana e una cecità della mente, non è da condannarsi come colpa, ma da giudicarsi come sventura; venne infatti, come venne, per agguati del caso, non per premeditazioni della mente, e per ineluttabilità d’amore, non per artificiosi raggiri.
8 (20) Come dunque si può ritener giusto il disonore gettato su Elena, la quale, sia che abbia agito come ha agito perché innamorata, sia perché lusingata da parole, sia perché rapita con violenza, sia perché costretta da costrizione divina, in ogni caso è esente da colpa?
9 (21) Ho distrutto con la parola l’infamia d’una donna, ho tenuto fede al principio propostomi all’inizio del discorso, ho tentato di annientare l’ingiustizia di un’onta e l’infondatezza di un’opinione; ho voluto scrivere questo discorso, che fosse a Elena di encomio, a me di gioco dialettico.
da ORAZIONE OLIMPICA
Degni dell’ammirazione universale, o Greci (…). Ed alla nostra gara
sono necessarie due virtù: audacia e sapienza, per svelare l’enigma;
perché la parola come il bando dell’araldo in Olimpia chiama chi si
offre, ma incorona chi riesce.
ANTIFONTE
 “Noi rispettiamo e veneriamo chi è di nobile origine, ma chi è di natali oscuri, né lo rispettiamo, né l’onoriamo. In questo, ci comportiamo gli uni verso gli altri da barbari, poiché di natura tutti siamo assolutamente uguali, sia Greci che barbari. Basta osservare le necessità naturali proprie di tutti gli uomini (…) nessuno di noi può esser definito né come barbaro, né come greco. Tutti infatti respiriamo l’aria con la bocca e con le narici”.
“Noi rispettiamo e veneriamo chi è di nobile origine, ma chi è di natali oscuri, né lo rispettiamo, né l’onoriamo. In questo, ci comportiamo gli uni verso gli altri da barbari, poiché di natura tutti siamo assolutamente uguali, sia Greci che barbari. Basta osservare le necessità naturali proprie di tutti gli uomini (…) nessuno di noi può esser definito né come barbaro, né come greco. Tutti infatti respiriamo l’aria con la bocca e con le narici”.
A cura di Daniele Lo Giudice
Ci furono almeno due Antifonte, l’uno oratore, e l’altro sofista; l’uno originario di Atene e l’altro originario di Ramnunte. Senza escludere l’ipotesi di un terzo uomo, autore, come vedremo, di un trattato sui sogni. Antifonte di Ramnunte fu, forse, più celebre al suo tempo e nei periodi immediatamente successivi ma, non si sa bene, ancor oggi, chi sia davvero l’autore di un’opera in due libri sulla Verità. Ragioni stilistiche portano ad escludere che l’autore possa essere l’oratore e che, quindi, sia il sofista l’uomo che cerchiamo, ovvero quel tizio che tra i primi affermò che le leggi umane sono tutte convenzionali e che l’uomo dovrebbe seguire le leggi di natura, posto che sia possibile stabilire quali sono. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, tuttavia, non fu questo l’aspetto più importante del contributo alla storia del pensiero di Antifonte. Se l’autore è la stessa identica persona, come vedremo, la tesi delle leggi di natura non quadra del tutto con l’affermazione che si deve cercare l’accordo e la convivenza pacifica, perchè, seguendo la natura, è assai probabile che si affermino aspetti egoistici, e non accordi sociali armoniosi. Viene da chiedersi se siamo di fronte ad un filosofo contraddittorio e paradossale, oppure ad una inedita profondità di pensiero, che seppe bene, infine, mostrare la conflittualità intima cui si trova spesso ogni individuo che ragioni. Il secondo lavoro di Antifonte, Della Concordia, potrebbe risultare la continuazione necessaria della Verità, anche se, in proposito, si è osservato che lo stile è diverso, “più artificioso”, in forma di dialogo e non di trattato. L’Untersteiner si confessa contrario all’ipotesi del dialogo e francamente non saprei pronunciarmi. L’opera Politico è di più difficile attribuzione perchè, come testimonia Senofonte nei Memorabili, rivelerebbe un uomo che vuole avere influenza sullo stato, quindi più il retore che il maestro di virtù. Ma l’Untersteiner è piuttosto deciso nell’attribuire anche quest’opera al sofista. Analogamente, egli sostiene che anche Dell’interpretazione dei sogni mostra coerenza con la dottrina del sofista di nome Antifonte. Risultassero vere tutte le ipotesi dell’Untersteiner, saremmo di fronte ad una personalità notevole, da distinguere decisamente rispetto all’Antifonte retore. Altre notizie sulla vita sono impossibili a trovarsi. Siamo di fronte ad un piccolo enigma della storia e la cosa è non poco sconcertante, come vedremo, perchè il pensiero di Antifonte costituì una prima ed importante risposta alla sfida di Gorgia ed alle sue posizioni provocatorie. Sia Platone che Aristotele, ma soprattutto quest’ultimo, ricorsero ad argomenti elaborati da Antifonte e ragionando su molti temi sollevati nei libri di Fisica dello Stagirita, si ha chiaro lo stimolo esercitato da questo pensatore. Antifonte riprese certamente l’ideale protagoreo della pacificazione della vita sociale nel libero confronto di opinioni, ma dovette obbligatoriamente misurarsi, con la dottrina gorgiana della negazione di ogni validità alle esperienze sensibili, ed anche a quelle più squisitamente intellegibili, sentendosi certamente contrariato e negato da questo attacco alle sue più profonde convinzioni. L’Untersteiner offre una citazione nella quale Antifonte riprese il pensiero di Gorgia, esponendolo per poi criticarlo: ” di lui [cioè di Gorgia] apprenderai queste cose: « e che non vi è / per lui nulla che sia uno, fra quante cose può vedere con la vista più lungi e può pensare con l’intelletto chi più lungi può conoscere…» In vista dell’obiettivo di rivalutare non solo sensi, esperienza e ragione, ma anche l’unità sostanziale dell’individuo, si può pensare che Antifonte abbia realizzato una contestazione puntuale ed articolata di tutte le tesi gorgiane, in particolare quella che affermava che né l’eternità, nè la corruzione siano predicabili dell’ente.
Come rispose Antifonte?
Egli pose, in modo davvero efficace, e prekantiano ante-litteram, il tempo come scienza del prima e del poi, misura degli eventi, ordine della loro successione. Gorgia aveva persino provato a negare l’esistenza del tempo, ma aveva sbagliato clamorosamente a confutarlo come esistente in senso ontologico, giacchè il tempo, disse Antifonte, non è sostanza, ma, certamente, sarà “misurabile” e noi lo misuriamo con giorni, ore, lune, cicli di anni. Indirettamente vi è una precisazione rispetto anche a Protagora: l’uomo che conosce il tempo non è solo misura soggettiva di tutte le cose, ma anche misura oggettiva, ovvero comune a tutti quanti abbiano il senso del tempo. Le esperienze si succedono nel tempo, dunque è possibile ordinarle e riflettere su di esse. Il loro verificarsi riporta ad un logos, una ragione per la quale, prima di questo, si è verificato quest’altro. Possiamo avere dubbi, avrà certamente concesso Antifonte, sulla validità di una singola esperienza o sensazione, ma non sulla loro concatenazione. Gorgia nega la legittimità razionale della concatenazione, Antifonte l’afferma. E l’argomento con il quale si volge contro Gorgia, e probabilmente vinse la contesa, fu che l’infinito non esiste in forma attuale, argomento che certamente convinse Aristotele, il quale l’elaborò in parte meglio ed in parte peggio. Tutto sta nel comprendere che, se si vuol dare valore ad un’esperienza, essa deve considerarsi finita. Così come cessiamo di osservare che quando il cielo si annuvola è possibile che piova, ma quando il cielo è sereno, è impossibile che piova. Non vi è alcun motivo per continuare all’infinito l’osservazione del cielo. Su questo piano, e solo su questo, ovviamente, la logica di Antifonte ebbe la meglio. Ma bastava ad andar oltre le difficoltà opposte da Gorgia al processo conoscitivo. Tutte le esperienze si attuano, si attuarono e si attueranno in parte per natura e per caso e in parte per arte Questo disse Antifonte, ed è evidente in questa affermazione lo sforzo per distinguere il carattere e le qualità di ogni singola esperienza. Delle esperienze si può parlare in generale, ma rischiamo di fare d’ogni erba un fascio, se non le analizziamo e le classifichiamo una per una. Il caso va inteso in senso soggettivo. Alcune esperienze ci sono capitate per caso e non perchè le abbiamo volute e cercate, ma non per questo sono meno istruttive delle altre. Quelle per arte, sono dovute al fatto che siamo in grado di fare alcune cose, e l’arte di fare le cose è dovuta all’esperienza. Come potrebbe un inesperto costruire una casa od una trireme? L’Untersteiner aggiunge una sorta di completamento a questa tesi: “tutto quello che viene fatto secondo la legge e indipendentemente dalla legge viene senz’altro compiuto in dato tempo o è stato compiuto o lo sarà.” Scrive a commento: ” Il concetto unitario che ne risulta è chiaro: le esperienze, deve aver detto Antifonte, a qualunque ordine appartengano, sia naturale sia intellettuale, esistono perchè / si manifestano secondo quella successione temporale che, sola, rende possibile un giudizio di esistenza.” Per Antifonte, quindi la percezione sensibile, la memoria che abbiamo di questa, è garanzia sufficiente della validità del conoscere, confutazione oggettiva a qualsiasi contestazione dell’inganno dei sensi. Non ci è dato di sapere a quale livello ci fu anche una polemica con Democrito e la sua teoria della soggettività assoluta in ordine al giudizio di dolce ed amaro, ma è probabile che Antifonte, mente analitica di eccezionale livello, come si sarà compreso, abbia avanzato qualche precisazione in ordine alla differenza tra sensazione elementare ed intensità di piacere o dispiacere che proviamo rispetto ad essa. All’affermazione gorgiana della impossibilità umana di distinguere tra ciò che esiste veramente e ciò che esiste solo nella nostra fantasia, Antifonte rispose per le rime, asserendo che solo ciò che esiste è visibile e conoscibile, mentre la fantasia non ha riscontro materiale e formale con la realtà. L’impossibile non può concretarsi. L’esempio avanzato fu quello di un letto di legno sepolto sottoterra, che per “putredine”, producendo un germoglio, non si sarebbe mai duplicato come letto, ma semplicemente come legno. Anche su questo piano, sembra dire l’Untersteiner, Antifonte distinse natura ed arte, e probabilmente vide nell’arte intesa come tecnica di manipolazione, un’estensione della natura, alla maniera di Prodico di Ceo. Tuttavia, mentre Prodico negò e confutò l’opposizione tra natura e mondo dell’uomo, tra natura e civiltà, Antifonte ammise, anzi, affermò, che tutto ciò che è civiltà e legge, appartiene al mondo della convenzione, senza peraltro considerare che la convenzione stessa ha tratto origine dalla necessità di porre fine alla contesa tra uomo e uomo onde porre le condizioni della coesistenza pacifica.
Opposizione di natura e legge civile
Si è scritto che Antifonte fu particolarmente sensibile al tema della costrizione dell’individuo in abiti civili e formali, e che egli detestava l’eccesso di leggi, di obblighi, di norme che si moltiplicavano all’infinito, ignare ed irrispettose della natura umana, e persino della libertà. Non è chiaro, ovviamente, se questa particolare posizione fosse frutto di una contingenza storica e politica, il dilagare dei diritti del volgo e quella dittatura del conformismo delle masse deprecato da così tanti filosofi in ogni epoca, o se invece rispecchiasse una posizione più profonda e radicale. Comunque sia, il contrasto con Prodico è evidente, dettato da un’insofferenza per l’eccesso legislativo che aveva una qualche dignità filosofica. Antifonte non era un guerrafondaio, e non mirava a liberare belve bionde. Non teorizzò il diritto del più forte a fare i propri comodi nella società. Aveva di mira la concordia politica e sociale. Credeva nell’accordo e nel compromesso, proprio per il suo carattere convenzionale. E’ pertanto da escludere che egli rappresentasse interessi forti compressi dalla legislazione populista. Molto più probabilmente, egli vide che l’eccesso legislativo procurava effetti opposti a quelli desiderati: non più ordine e disciplina, ma caos, ingorghi giudiziari, sentenze contraddittorie, una macchinosità sempre più frenante e debilitante. Fu dunque chiaramente consapevole che la legge interpretata in questo modo cavilloso ed ossessivo portava alla moltiplicazione delle ingiustizie, anzichè a giustizia. E, per di più, esprimeva una visione totalmente pessimistica rispetto all’uomo vero, in carne ed ossa, all’uomo prodotto dalla natura e capace per questo, e non per educazione, di essere virtuoso. Intendiamoci: non buono di natura, nel senso predicato da Rousseau, ma virtuoso nel senso di virile, onesto, quadrato, fermo e responsabile. O per dirla con Aristotele, in grado di deliberare e di cercare l’eccellenza in ogni cosa.
La legge come divisione tra gli uomini e le città
Un altro punto interessante della critica che Antifonte rivolse alla legge intesa come nomos fu quello del particolarismo. Ogni città ha la sua legge, e spesso ciò che è giusto e legale qui, è ingiusto ed illegale là. L’eccesso legislativo è dunque un fattore di divisione, un’esasperazione delle differenze, un contrasto artificioso tra gli uomini. Nessuna legislazione particolare, portata all’estremo cavilloso, può considerarsi universale, e quindi davvero utile a metter fine alle incomprensioni, alle guerre.
Ateo
Pare certo che Antifonte si sia professato ateo. Si ricava questa impressione esaminando l’affermazione, riportata dall’Untersteiner, che “gli dei furono prodotti d’arte e non di natura”. Del divino vi potrebbe essere esperienza, tuttavia, in quanto il nome di ogni singolo dio rinvia all’esperienza che noi abbiamo di determinate funzioni ed operazioni. Isolate ed astratte dal contesto generale delle attività umane e naturali, il forgiare i metalli diviene arte di Efesto, l’usare saggezza, prudenza ed astuzia è arte di Athena, vedere lontano è arte apollinea, e … la musica espressione del dionisiaco.
Distinzione tra arti fantastiche e tecnica di cose serie
C’è qualcosa che non convince nel quadro generale disegnato dall’Untersteiner, ed è la presunta condanna che Antifonte avrebbe formulato nei confronti di musica e poesia. L’apertura mentale di Antifonte, se tutto quanto riportato fin qui corrisponde in qualche modo al vero, non può essersi improvvisamente richiusa di fronte al fenomeno artistico più spontaneo, naturale e genuino: il canto degli uccelli, il canto dell’uomo, la creazione di un testo che racconta esperienze ed emozioni. Forse, Antifonte, ebbe una personale antipatia per la musica e la poesia, ma non al punto da farne una questione di politica educativa. Supponendo, come l’Untersteiner, che Antifonte intendesse escludere dai programmi educativi musica e poesia, si viene di fatto ad ammettere una contraddizione radicale: ovvero l’intenzione di una legislazione per regolare l’educazione e fissarne a priori i contenuti, in maniera censoria. Pare accettabile l’idea della distinzione tra arti rivolte a produrre effetti artistici ed arti rivolte a produrre beni indispensabili, e quindi fondamentali. Poteva essere l’inizio di una riflessione sull’economia politica, ma non abbiamo alcuna notizia che giustifichi una simile ipotesi.
I sogni
Se l’Antifonte di cui abbiamo parlato finora sia lo stesso autore del trattato sui sogni non può essere certo nemmeno al 50%. Tuttavia, potremmo prendere per buone le affermazioni dell’Untersteiner, in mancanza di meglio. Il sogno è, in fondo, un evento naturale cui nessuna legislazione può imporre regole di svolgimento e tantomeno di interpretazione. La posizione di questo Antifonte fu paradossalmente opposta al suo credo fondamentale: sbagliata la divinazione naturale, corretta la divinazione artificiosa. Seguendo la prima, si ha che il sogno è propizio quando riporta eventi felici, e funesto quando propone situazioni drammatiche ed eventi funesti. Al contrario, la divinazione artificiosa prescindeva da questo semplicistico punto di vista, e consentiva di interpretare in senso propizio anche gli incubi notturni. Questo Antifonte cercò di evidenziare l’esistenza di una scienza mantica, e si disse in grado di padroneggiarla, ma francamente le argomentazioni dell’Untersteiner non mi risultano affatto persuasive e chiarificatorie. Ma è difficile dire che questo Antifonte sia lo stesso di cui abbiamo parlato finora.
Sulla legge
“[…] Giustizia consiste nel non trasgredire alcuna delle leggi dello Stato di cui uno sia cittadino; e perciò l’individuo applicherà nel modo a lui piú vantaggioso la giustizia, se farà gran conto delle leggi, di fronte a testimoni; ma in assenza di testimoni, seguirà piuttosto le norme di natura; perché le norme di legge sono accessorie, quelle di natura, essenziali; quelle di legge sono concordate, non native: quelle di natura, sono native, non concordate. Perciò, se uno trasgredisce le norme di legge, finché sfugge agli autori di esse, va esente da biasimo e da pena; se non sfugge, no. Ma se invece violenta oltre il possibile le norme poste in noi da natura, se anche nessuno se ne accorga, non minore è il male, né è maggiore se anche tutti lo sappiano; perché si offende non l’opinione, ma la verità“.
(Fr. 87 B 44 A DK Papiro di Oxyrinco, XI n. 1364)
TRASIMACO
 A cura di Daniele Lo Giudice
A cura di Daniele Lo Giudice
“Il giusto altro non è che l’utile del più forte“.
Introduzione
Trasimaco nacque a Calcedone in Bitinia, una colonia di Megara e fu attivo soprattutto negli ultimi tre decenni del secolo V. La data di nascita potrebbe collocarsi intorno al 450, 460 a.C. Giovenale diffuse la notizia che morì malamente, pentito e rammaricato per le dottrine che aveva insegnato ma, non si è trovata alcuna conferma di quanto affermato successivamente dallo scoliaste, ovvero che si impiccò. Fu soprattutto un retore, un avvocato più che un sofista. Essendo uno dei personaggi protagonisti del dialogo platonico Repubblica, dobbiamo credere che le dottrine morali e politiche quivi patrocinate corrispondano al pensiero di Trasimaco, anche se non sempre Platone fu un testimone obiettivo del pensiero altrui. Trasimaco è presentato come persona irruente, irriverente, antipatica, che nemmeno ama perdersi in chiacchiere. Dopo un primo passaggio, attacca frontalmente Socrate, sfidandolo a dire qualcosa di concreto anzichè perdersi in lunghi giri di parole sulla giustizia. Trasimaco ha la sfrontatezza di chiedere del denaro per dare quella risposta che Socrate dichiara di ignorare, secondo il classico schema dell’unica cosa che so è di non sapere. Trasimaco dichiara, al contrario, di sapere, ed afferma: ” Io dico che la giustizia altro non è che se non ciò che giova al più forte…O perchè non mi lodi? … Ma non lo vorrai.” Socrate obbietta con ironia che se a Polidamante, il pancratiaste, giova la carne di bue, questo potrebbe significare che essa giova anche a noi, meno forti di lui? Trasimaco risponde in modo offensivo:
-“Sei un buffone, Socrate. Tu fingi d’intendere la mia definizione in modo da falsarla addirittura.”
– “Tutt’altro, eccellente uomo; ma di in modo più chiaro che cosa vuoi intendere.”
– “E non sai che alcune città sono rette da tiranni, altre dal popolo, altre da ottimati?”
– “E come no?”
– ” E in ogni città la forza non appartiene al governo costituito?”
– ” Senza dubbio”
– ” Orbene, ciascun governo si fa le leggi che meglio gli giovano: la democrazia se le fa democratiche, la tirannide tiranniche e gli altri al pari, e fattele i governanti dichiarano giusto per i sudditi quel che giova a se stessi e puniscono chi trasgredisce i loro ordini come violatori delle leggi e colpevole di ingiustizia. Questo è dunque, bravuomo, quello che tutte le città io dico essere ugualmente giusto: ciò che giova al governo costituito, che è poi il potere dominante; e però chi ben ragiona deve riconoscere che giusto è dappertutto egualmente questo: ciò che giova al più forte.”
Socrate chiede a Trasimaco se qualche volta i governanti sbaglino, e questi lo ammette. Ma ciò porta ad un’incongruenza: se i governanti sbagliano significa che emanano disposizioni che non giovano a loro stessi. Ciò porta Trasimaco a contraddirsi, ed ad affermare che i governanti non sbagliano mai, e che comunque il popolo deve obbedire. Ciò, secondo Socrate, contraddice ciò che avviene nelle scienze, nessuna delle quali osserva ed ordina quel che giova al più forte, bensì quel che giova al più debole, come la medicina. Trasimaco concede un assenso superficiale all’affermazione socratica, ma subito riprende da capo la sua teoria, asserendo che la giustizia è ciò che giova a chi comanda, mentre l’ingiustizia governa gli ingenui ed i giusti. I giusti, secondo Trasimaco hanno sempre la peggio; dunque chi osserva le leggi è un infelice, mentre il vero ingiusto è sempre felice, soprattutto quando sa comportarsi in modo da non passare per ingiusto. Dalla lettura e dalla riflessione conseguente su questa prima parte del dialogo, mi pare evidente, che tra Trasimaco e Socrate, oltre ad una buona dose di antipatia, si registri anche una mancata comprensione del senso delle rispettive affermazioni. Quella di Trasimaco, infatti, non era una sorta di teorizzazzione dell’ingiustizia, ma una denuncia del carattere strumentale della cosiddetta giustizia. Gli uomini chiamano giustizia l’ipocrisia e la parvenza della legalità, che è dettata dal potere. Ma il potere fa sempre le leggi a sua misura. Trasimaco è dunque in linea con Antifonte ed Ippia, e riprende la loro denuncia del carattere di classe e di parte della legge civile. Socrate, nel tentativo di definire, al contrario, il concetto stesso di giustizia, urta contro la parzialità delle leggi senza, tuttavia, dar loro un gran peso, almeno in questa prima fase. Per lui, infatti, era fondamentale pervenire in primo luogo alla concettualizzazione della giustizia stessa, per chiarire in primo luogo che cosa si andava cercando. Messo a fuoco il tipo e la qualità del contrasto tra Socrate e Trasimaco, viene in evidenza che il vero protagonista di questo primo spezzone del dialogo platonico è l’incomprensione. Socrate e Trasimaco hanno due linguaggi diversi e nessuno dei due sembra particolarmente interessato a capire il motivo dell’altro, anche se, ovviamente, Socrate esce (più apparentemente che realmente) vincitore della contesa. Non è infatti accettabile che l’ingiustizia possa diventare in qualche caso virtù e che un uomo che viola leggi della propria città sia da definirsi virtuoso. Trasimaco, dal canto suo, pur avendo una chiara e realistica visione di come vanno realmente le cose nel mondo civile, non sembra in grado di trarne delle conseguenze politiche. L’unico modo di salvarsi dalla giustizia delle città è l’ingiusto agire individuale di chi è abile a violare le leggi senza farsi scoprire. Non vi è in Trasimaco alcuna speranza di una giustizia giusta, a differenza, ad esempio, di Ippia, per il quale, un giorno, la legge naturale diventerà la legge giusta.
Il problema della giustizia
Nel primo libro della Repubblica Platone riferisce l’opinione di Trasimaco sul rapporto fra la giustizia e il potere. Dalla provocazione di questo sofista prende poi spunto il trattato sullo Stato, sviluppato da Platone nei successivi nove libri.
1 (10) [definizione della giustizia e del giusto]. Piú volte Trasimaco, mentre noi parlavamo, era balzato su per interloquire obbiettando, ma poi n’era stato impedito dagli astanti, che volevano star a sentire il discorso sino alla fine; ma come sostammo un momento dopo ch’io ebbi detto queste cose, non poté piú reggere, e ravvoltosi in se stesso come una fiera, si slanciò su di noi, come per sbranarci. Io e Polemarco dalla paura restammo agghiacciati; ed egli nel mezzo urlando: “Che sciocchezze andate dicendo da un pezzo, o Socrate?” gridò.
2 Io [Trasimaco] affermo dunque essere il giusto non altro che l’utile del piú forte.
3 (8) Trasimaco scrisse in un suo discorso qualcosa di simile, che gli dèi non badano alle cose umane; altrimenti non trascurerebbero il massimo dei beni fra gli uomini, la giustizia; vediamo infatti che gli uomini non l’applicano mai.
Frr. 85 A 10 DK (Platone, Repubblica, I, 336 b, 338 c) e 85 B 8 DK (Hermias Alexandrinus, In Platonis Phaedrum, ed. Couvrer, pag. 239, 21)
CRIZIA
 Nato ad Atene all’incirca verso il 460 da nobilissima famiglia (era cugino della madre di Platone), Crizia fu un elemento di spicco nella rivoluzione oligarchica che, dopo la vittoria spartana nella battaglia navale di Egospotami (405 a.C.) – battaglia che segnò la disfatta decisiva per Atene nella Guerra del Peloponneso – soppresse per qualche tempo la democrazia ad Atene. Egli fu uno dei Trenta Tiranni e, più di altri, fu responsabile del clima di terrore (testimoniato dal meteco Lisia nella sua Contro Eratostene) che si instaurò ad Atene sotto il loro regime autoritario, nonché delle atrocità da quelli perpetrate a danno di chiunque si fosse opposto al loro regime. Mori nel 403 a.C., combattendo a Munichia contro i democratici capeggiati da Trasibulo, restauratore della democrazia in Atene. E’ quasi certamente da ascrivere alla sinistra fama che Crizia si guadagnò col suo operato politico l’oblio in cui cadde la sua ricca produzione letteraria e filosofica, che comprendeva tragedie, elegie e trattati in prosa. Dei suoi drammi conosciamo solamente quattro titoli (Temnes, Radamanto, Piritoo, Sisifo), dei quali i primi tre erroneamente attribuiti ad Euripide, mentre il quarto era un dramma satiresco. Dai frammenti superstiti, è possibile ricavare idee molo sommarie solo sul contenuto del Piritoo e di Sisifo: il primo trattava della discesa all’Ade di Piritoo e di Teseo per riportare alla luce Persefone, colà trattenuta da Ade stesso. Nel secondo, invece, che trattava le vicende del mitico Sisifo, condannato ad un’eterna ed inutile fatica – è celeberrimo il passo in cui Crizia (il quale fu esponente di spicco della Sofistica schierata “a destra”, ovvero in senso decisamente aristocratico e antipopolare) ipotizza che la credenza negli dei sia stata opera di un astuto individuo che, con la paura dell’occulto, volle caricare di sacro timore il diritto e la legge, affinché gli uomini venissero dissuasi dal commettere ingiustizie e crimini. Tale teoria dev’essere considerata come la punta più avanzata dell’insegnamento sofistico: in essa coesistono l’idea del carattere convenzionale che presiedette alla nascita della legge e del diritto, e quella della civiltà come prodotto dell’intervento diretto dell’uomo, che con l’invenzione degli dei “che tutto vedono”, anche il delitto concepito nel silenzio, è riuscito a superare il tempo in cui la vita umana era senza legge e a regolare la vita era la violenza, cosicché i malvagi non ricevevano punizione alcuna, i buoni non erano in alcun modo premiati. Infatti, come si noterà nella Repubblica platonica con il mito dell’anello di Gige, ci tratteniamo dal commettere azioni ingiuste esclusivamente perché temiamo di essere scoperti e, dunque, puniti: se solo avessimo la garanzia dell’impunità (garanzia che ha Gige, in possesso di un anello che lo rende invisibile), non esiteremmo minimamente a commettere ingiustizia. Proprio in ciò risiede la scaltrezza dell’inventore degli dei di cui parla Crizia: in ogni singolo momento della nostra vita siamo osservati dagli dei, cosicché, per evitare di essere punti, dobbiamo comportarci in conformità delle leggi. Se è vero che agiamo giustamente finchè siamo osservati da un’autorità in grado di punirci, allora basterà ipotizzare un’autorità in grado di osservarci ininterrottamente per garantire una condotta irreprensibile: questo è lo scopo per cui sono stati escogitati gli dei, come autorità che ci tengono gli occhi addosso di continuo. Quella di Crizia sull’invenzione degli dèi è una teoria famosa, ripresa di tanto in tanto nei secoli seguenti (ad esempio da alcuni illuministi del Settecento). Secondo la testimonianza di Sesto Empirico che ci ha tramandato il frammento, Crizia avrebbe esposto nel dramma satiresco Sisifo la sua concezione sull’origine della religione: egli sostiene come accennavamo – che la religione è un prodotto assolutamente artificiale dell’uomo; la stessa cosa Prodico sostiene a proposito della legge. Opposta è invece la concezione che i due filosofi hanno della natura umana: per Prodico fondata sull’uguaglianza, per Crizia su uno stato permanente di guerra di tutti contro tutti (l’hobbesiano bellum omnium contra omnes), che troverà espressione nella celebre formula homo homini lupus, usata da Plauto (Asinaria, v. 495) e ripresa nel XVII secolo dal filosofo inglese Thomas Hobbes. La legge – secondo Crizia – si fonda sulla forza, unico strumento per garantire la giustizia. Ma lo stato basato esclusivamente sulla propria capacità repressiva non può esercitare un controllo efficace e continuo su tutti gli uomini (la forza repressiva è di gran lunga meno idonea a garantire l’ordine che non la capacità persuasiva dei discorsi!). Per questo, secondo Crizia, fu necessario “inventare” la religione, come strumento per garantire l’ordine e la legalità. Crizia, quindi, dimostra di essere stato un attento studioso dei risvolti psicologici della natura umana. Riportiamo qui il brano, contenuto nel Contro i matematici (IX, 54) di Sesto Empirico: “Tempo ci fu, quando disordinata era la vita degli uomini, e ferina, e strumento di violenza, quando premio alcuno non c’era pei buoni, né alcun castigo ai malvagi. In seguito, parmi che gli uomini leggi punitive sancissero, si che fosse Giustizia assoluta signora <egualmente di tutti e avesse ad ancella la Forza; ed era punito chiunque peccasse. Ma poi, giacché le leggi distoglievan bensi gli uomini dal compiere aperte violenze, ma di nascosto le compivano, allora, suppongo, <dapprima> un qualche uomo ingegnoso e saggio di mente inventò per gli uomini il timor <degli dèi>, si che uno spauracchio ci fosse ai malvagi anche per ciò che di nascosto facessero o dicessero o pensassero. Laonde introdusse la divinità sotto forma di Genio, fiorente di vita imperitura, che con la mente ode e vede, e con somma perspicacia sorveglia le azioni umane, mostrando divina natura; il quale Genio udirà tutto quanto si dice tra gli uomini e potrà vedere tutto quanto da essi si compie. E se anche tu mediti qualche male in silenzio, ciò non sfuggirà agli dèi; ché troppa è la loro perspicacia. Facendo di questi discorsi, divulgava il piú gradito degli insegnamenti, avvolgendo la verità in un finto racconto. E affermava gli dèi abitare colà, dove ponendoli, sapeva di colpire massimamente gli uomini, là donde sapeva che vengono gli spaventi ai mortali e le consolazioni alla loro misera vita: dalla sfera celeste, dove vedeva esserci lampi, e orrendi rombi di tuoni, e lo stellato corpo del cielo, opera mirabilmente varia del sapiente artefice, il Tempo; là donde s’avanza fulgida la massa rovente del Sole, donde l’umida pioggia sovra la Terra scende. Tali spaventi egli agitò dinanzi agli occhi degli uomini, e servendosi di essi, costrui con la parola, da artista, la divinità, ponendola in un luogo a lei adatto; e spense cosi l’illegalità con le leggi. […] Per tal via dunque io penso che in principio qualcuno inducesse i mortali a credere che vi sia una stirpe di dèi”. Esponente d’eccezione della sofistica schierata “a destra” e di un’oligarchia non più nostalgicamente ancorata ai valori religiosi del passato, bensì spregiudicatamente interessata a una visione totalmente mondana del potere e della forza, Crizia fu fermamente convinto della superiorità naturale dell’aristocrazia, per la quale non possono esistere scrupoli morali d’alcun tipo. La religione e la legge esistono dunque per convenzione (νομος), non per natura (φυσις). Pur disponendo di scarse informazioni in merito, possiamo dire che anche nelle elegie di cui ci restano scarsissimi frammenti è presente una fortissima connotazione ideologica di marca aristocratica, che accomuna i versi di Crizia a quelli dell’antico Teognide di Megara. Impronta altrettanto marcata avevano le Costituzioni, un’opera mista di poesia e prosa che trattava di Atene, della Tessaglia e di Sparta (quest’ultima esaltata più d’ogni altra, in virtù dei suoi ordinamenti oligarchici): la famosa Costituzione degli Ateniesi (risalente ai primi anni della Guerra del Peloponneso), a noi pervenuta nel corpus delle opere di Senofonte, deve essere attribuita a Crizia, come hanno osservato Boeckh e Canfora; nell’opuscolo, viene lucidamente analizzato, da un’angolazione reazionaria, l’assetto istituzionale e sociale della πολις ateniese, di cui si riconosce la profonda coerenza e funzionalità in ordine allo scopo che esso si prefigge: assicurare l’egemonia del popolo ai danni dell’aristocrazia. Che lo scritto debba essere attribuito a Crizia (e non a Senofonte o ad Alcibiade o a Tucidide di Melesia, come vuole la tradizione) è del resto avvalorato dal fatto che esso abbia struttura dialogica: in esso, i giudizi e le considerazioni dell’esponente della destra radicale vengono stimolati man mano dalle larvate obiezioni di un secondo interlocutore (la cui presenza è stata erroneamente cancellata dalla tradizione manoscritta); identificandosi nell’esponente della destra radicale, Crizia avrebbe utilizzato gli schemi dialettici tipici del suo maestro Socrate. L’opera si risolve in un’analisi serrata e lucida del regime democratico ateniese, del quale sono messi in evidenza quelli che Crizia ritiene elementi negativi (la mancanza di scrupoli morali nei governanti, la loro ignoranza, la venalità dei giudici, la libertà di parola concessa anche ai meteci e agli schiavi); in questa spietata e feroce valutazione della democrazia ateniese dell’età periclea, Crizia si attesta su posizioni di netta insofferenza per il popolo, inteso come una massa di inferiori che una città saggiamente governata (ovvero retta da un regime aristocratico) non dovrebbe neppure ammettere alle assemblee, ma anzi dovrebbe tenere in schiavitù. La contrapposizione di natura tra aristocratici e plebei è insanabile: il popolo, in quanto rozzo e ignorante, è inadatto a governare la πολις. Nella seconda parte dell’opera, però, alla marcata insofferenza verso il regime democratico, si sostituiscono positive considerazioni sulla necessità dello sviluppo della talassocrazia ad Atene e sulla validità della gestione economica della città: il che dimostra l’ottima preparazione tecnica e politica di Crizia, che sul finale dell’opera constata in maniera rassegnata l’impossibilità che ad Atene l’attuale situazione possa mutare. Resta sconosciuto, invece, l’argomento degli Aforismi e delle Conversazioni.
Nato ad Atene all’incirca verso il 460 da nobilissima famiglia (era cugino della madre di Platone), Crizia fu un elemento di spicco nella rivoluzione oligarchica che, dopo la vittoria spartana nella battaglia navale di Egospotami (405 a.C.) – battaglia che segnò la disfatta decisiva per Atene nella Guerra del Peloponneso – soppresse per qualche tempo la democrazia ad Atene. Egli fu uno dei Trenta Tiranni e, più di altri, fu responsabile del clima di terrore (testimoniato dal meteco Lisia nella sua Contro Eratostene) che si instaurò ad Atene sotto il loro regime autoritario, nonché delle atrocità da quelli perpetrate a danno di chiunque si fosse opposto al loro regime. Mori nel 403 a.C., combattendo a Munichia contro i democratici capeggiati da Trasibulo, restauratore della democrazia in Atene. E’ quasi certamente da ascrivere alla sinistra fama che Crizia si guadagnò col suo operato politico l’oblio in cui cadde la sua ricca produzione letteraria e filosofica, che comprendeva tragedie, elegie e trattati in prosa. Dei suoi drammi conosciamo solamente quattro titoli (Temnes, Radamanto, Piritoo, Sisifo), dei quali i primi tre erroneamente attribuiti ad Euripide, mentre il quarto era un dramma satiresco. Dai frammenti superstiti, è possibile ricavare idee molo sommarie solo sul contenuto del Piritoo e di Sisifo: il primo trattava della discesa all’Ade di Piritoo e di Teseo per riportare alla luce Persefone, colà trattenuta da Ade stesso. Nel secondo, invece, che trattava le vicende del mitico Sisifo, condannato ad un’eterna ed inutile fatica – è celeberrimo il passo in cui Crizia (il quale fu esponente di spicco della Sofistica schierata “a destra”, ovvero in senso decisamente aristocratico e antipopolare) ipotizza che la credenza negli dei sia stata opera di un astuto individuo che, con la paura dell’occulto, volle caricare di sacro timore il diritto e la legge, affinché gli uomini venissero dissuasi dal commettere ingiustizie e crimini. Tale teoria dev’essere considerata come la punta più avanzata dell’insegnamento sofistico: in essa coesistono l’idea del carattere convenzionale che presiedette alla nascita della legge e del diritto, e quella della civiltà come prodotto dell’intervento diretto dell’uomo, che con l’invenzione degli dei “che tutto vedono”, anche il delitto concepito nel silenzio, è riuscito a superare il tempo in cui la vita umana era senza legge e a regolare la vita era la violenza, cosicché i malvagi non ricevevano punizione alcuna, i buoni non erano in alcun modo premiati. Infatti, come si noterà nella Repubblica platonica con il mito dell’anello di Gige, ci tratteniamo dal commettere azioni ingiuste esclusivamente perché temiamo di essere scoperti e, dunque, puniti: se solo avessimo la garanzia dell’impunità (garanzia che ha Gige, in possesso di un anello che lo rende invisibile), non esiteremmo minimamente a commettere ingiustizia. Proprio in ciò risiede la scaltrezza dell’inventore degli dei di cui parla Crizia: in ogni singolo momento della nostra vita siamo osservati dagli dei, cosicché, per evitare di essere punti, dobbiamo comportarci in conformità delle leggi. Se è vero che agiamo giustamente finchè siamo osservati da un’autorità in grado di punirci, allora basterà ipotizzare un’autorità in grado di osservarci ininterrottamente per garantire una condotta irreprensibile: questo è lo scopo per cui sono stati escogitati gli dei, come autorità che ci tengono gli occhi addosso di continuo. Quella di Crizia sull’invenzione degli dèi è una teoria famosa, ripresa di tanto in tanto nei secoli seguenti (ad esempio da alcuni illuministi del Settecento). Secondo la testimonianza di Sesto Empirico che ci ha tramandato il frammento, Crizia avrebbe esposto nel dramma satiresco Sisifo la sua concezione sull’origine della religione: egli sostiene come accennavamo – che la religione è un prodotto assolutamente artificiale dell’uomo; la stessa cosa Prodico sostiene a proposito della legge. Opposta è invece la concezione che i due filosofi hanno della natura umana: per Prodico fondata sull’uguaglianza, per Crizia su uno stato permanente di guerra di tutti contro tutti (l’hobbesiano bellum omnium contra omnes), che troverà espressione nella celebre formula homo homini lupus, usata da Plauto (Asinaria, v. 495) e ripresa nel XVII secolo dal filosofo inglese Thomas Hobbes. La legge – secondo Crizia – si fonda sulla forza, unico strumento per garantire la giustizia. Ma lo stato basato esclusivamente sulla propria capacità repressiva non può esercitare un controllo efficace e continuo su tutti gli uomini (la forza repressiva è di gran lunga meno idonea a garantire l’ordine che non la capacità persuasiva dei discorsi!). Per questo, secondo Crizia, fu necessario “inventare” la religione, come strumento per garantire l’ordine e la legalità. Crizia, quindi, dimostra di essere stato un attento studioso dei risvolti psicologici della natura umana. Riportiamo qui il brano, contenuto nel Contro i matematici (IX, 54) di Sesto Empirico: “Tempo ci fu, quando disordinata era la vita degli uomini, e ferina, e strumento di violenza, quando premio alcuno non c’era pei buoni, né alcun castigo ai malvagi. In seguito, parmi che gli uomini leggi punitive sancissero, si che fosse Giustizia assoluta signora <egualmente di tutti e avesse ad ancella la Forza; ed era punito chiunque peccasse. Ma poi, giacché le leggi distoglievan bensi gli uomini dal compiere aperte violenze, ma di nascosto le compivano, allora, suppongo, <dapprima> un qualche uomo ingegnoso e saggio di mente inventò per gli uomini il timor <degli dèi>, si che uno spauracchio ci fosse ai malvagi anche per ciò che di nascosto facessero o dicessero o pensassero. Laonde introdusse la divinità sotto forma di Genio, fiorente di vita imperitura, che con la mente ode e vede, e con somma perspicacia sorveglia le azioni umane, mostrando divina natura; il quale Genio udirà tutto quanto si dice tra gli uomini e potrà vedere tutto quanto da essi si compie. E se anche tu mediti qualche male in silenzio, ciò non sfuggirà agli dèi; ché troppa è la loro perspicacia. Facendo di questi discorsi, divulgava il piú gradito degli insegnamenti, avvolgendo la verità in un finto racconto. E affermava gli dèi abitare colà, dove ponendoli, sapeva di colpire massimamente gli uomini, là donde sapeva che vengono gli spaventi ai mortali e le consolazioni alla loro misera vita: dalla sfera celeste, dove vedeva esserci lampi, e orrendi rombi di tuoni, e lo stellato corpo del cielo, opera mirabilmente varia del sapiente artefice, il Tempo; là donde s’avanza fulgida la massa rovente del Sole, donde l’umida pioggia sovra la Terra scende. Tali spaventi egli agitò dinanzi agli occhi degli uomini, e servendosi di essi, costrui con la parola, da artista, la divinità, ponendola in un luogo a lei adatto; e spense cosi l’illegalità con le leggi. […] Per tal via dunque io penso che in principio qualcuno inducesse i mortali a credere che vi sia una stirpe di dèi”. Esponente d’eccezione della sofistica schierata “a destra” e di un’oligarchia non più nostalgicamente ancorata ai valori religiosi del passato, bensì spregiudicatamente interessata a una visione totalmente mondana del potere e della forza, Crizia fu fermamente convinto della superiorità naturale dell’aristocrazia, per la quale non possono esistere scrupoli morali d’alcun tipo. La religione e la legge esistono dunque per convenzione (νομος), non per natura (φυσις). Pur disponendo di scarse informazioni in merito, possiamo dire che anche nelle elegie di cui ci restano scarsissimi frammenti è presente una fortissima connotazione ideologica di marca aristocratica, che accomuna i versi di Crizia a quelli dell’antico Teognide di Megara. Impronta altrettanto marcata avevano le Costituzioni, un’opera mista di poesia e prosa che trattava di Atene, della Tessaglia e di Sparta (quest’ultima esaltata più d’ogni altra, in virtù dei suoi ordinamenti oligarchici): la famosa Costituzione degli Ateniesi (risalente ai primi anni della Guerra del Peloponneso), a noi pervenuta nel corpus delle opere di Senofonte, deve essere attribuita a Crizia, come hanno osservato Boeckh e Canfora; nell’opuscolo, viene lucidamente analizzato, da un’angolazione reazionaria, l’assetto istituzionale e sociale della πολις ateniese, di cui si riconosce la profonda coerenza e funzionalità in ordine allo scopo che esso si prefigge: assicurare l’egemonia del popolo ai danni dell’aristocrazia. Che lo scritto debba essere attribuito a Crizia (e non a Senofonte o ad Alcibiade o a Tucidide di Melesia, come vuole la tradizione) è del resto avvalorato dal fatto che esso abbia struttura dialogica: in esso, i giudizi e le considerazioni dell’esponente della destra radicale vengono stimolati man mano dalle larvate obiezioni di un secondo interlocutore (la cui presenza è stata erroneamente cancellata dalla tradizione manoscritta); identificandosi nell’esponente della destra radicale, Crizia avrebbe utilizzato gli schemi dialettici tipici del suo maestro Socrate. L’opera si risolve in un’analisi serrata e lucida del regime democratico ateniese, del quale sono messi in evidenza quelli che Crizia ritiene elementi negativi (la mancanza di scrupoli morali nei governanti, la loro ignoranza, la venalità dei giudici, la libertà di parola concessa anche ai meteci e agli schiavi); in questa spietata e feroce valutazione della democrazia ateniese dell’età periclea, Crizia si attesta su posizioni di netta insofferenza per il popolo, inteso come una massa di inferiori che una città saggiamente governata (ovvero retta da un regime aristocratico) non dovrebbe neppure ammettere alle assemblee, ma anzi dovrebbe tenere in schiavitù. La contrapposizione di natura tra aristocratici e plebei è insanabile: il popolo, in quanto rozzo e ignorante, è inadatto a governare la πολις. Nella seconda parte dell’opera, però, alla marcata insofferenza verso il regime democratico, si sostituiscono positive considerazioni sulla necessità dello sviluppo della talassocrazia ad Atene e sulla validità della gestione economica della città: il che dimostra l’ottima preparazione tecnica e politica di Crizia, che sul finale dell’opera constata in maniera rassegnata l’impossibilità che ad Atene l’attuale situazione possa mutare. Resta sconosciuto, invece, l’argomento degli Aforismi e delle Conversazioni.
IPPIA di ELIDE
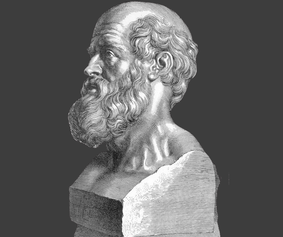 A cura di Daniele Lo Giudice
A cura di Daniele Lo Giudice
Introduzione
Ippia di Elide (443 – prima metà del sec. V) fu filosofo di multiforme ingegno speculativo e di grandi conoscenze enciclopediche, fece frequenti viaggi in qualità di retore e di rappresentante politico a Sparta, Atene, Olimpia e in Sicilia. Fu uno dei principali esponenti rappresentante di quella nobile sofistica di cui parla Platone nel Sofista. La sua filosofia propugnava il principio dell'”autarchia”, cioè del bastare a se stessi, in una prospettiva individualistica, che sta alla base anche della sua filosofia della politica, il cui punto di partenza è l’antitesi tra legge e natura. Le leggi non hanno invariabilità e stabilità assolute, e inoltre determinano arbitrio e giustificano spesso la tirannide, quelle autentiche non sono dettate dall’uomo come concetto astratto bensì dalla stessa natura umana, legislatrice di regole non scritte, radicate nella nostra natura umana, ma che sono tuttavia preferibili perché uguali in ogni luogo e in ogni momento. Con queste tesi brillanti e originali Ippia realizza così una delle prime filosofie a base egualitaria, internazionalista, democratica. Per dare una soluzione al problema geometrico della trisezione dell’angolo, tracciò una curva definita successivamente quadratrice, perchè usata da Dinostrato per risolvere la questione della quadratura del cerchio. Alcuni storici della filosofia lo considerano autore dello scritto attribuito all’Anonimo di Giamblico. Scrisse molto, anche testi di carattere letterario, come odi religiose ed elegie, ma di lui ci sono pervenute solo testimonianze frammentarie e qualche titolo: il Troiano, il Registro dei vincitori ad Olimpia, la Raccolta e i Nomi dei popoli. È molto probabile che sia lo stesso Ippia protagonista dell’Ippia maggiore e dell’Ippia minore di Platone.
Il pensiero
Due dialoghi platonici – Ippia maggiore ed Ippia minore – ci introducono ad un personaggio antipatico e pieno di sé, borioso, spavaldo e superficiale, che fa di una capziosa verbosità la propria arma argomentativa privilegiata. Ma, l’Ippia minore è un dialogo anomalo ed inquietante, nel quale Socrate sembra dare letteralmente i numeri, mentre lo stesso Ippia rimane sconcertato. Socrate avanza una strana teoria, che poi rinnegherà immediatamente, ma intanto l’ha detta, e dicendola la sostiene anche con qualche argomento. La cosa non quadra con una certa idea che abbiamo di Socrate e nemmeno con Platone. Ma c’è Senofonte a testimoniare la veridicità dell’episodio, a meno che non si ammetta che un ignoto burlone abbia scritto il dialogo speculando su quanto raccontato da Senofonte. Di che si tratta? Socrate afferma che chi fa volontariamente il male, sapendo cioè quello che fa, è sicuramente superiore a chi lo compie involontariamente. Ippia risponde che persino le leggi (che lo stesso riteneva sempre insufficienti e mancanti) riconoscono che il dolo volontario è di maggiore gravità, e quindi puniscono l’autore di un crimine volontario con pene più severe. A questo punto Socrate confessa di non sapere a quale argomento appigliarsi. Eppure, preso da stato febbrile, propone ad Ippia di ascoltare qualcosa. Ecco che poco alla volta viene in chiaro cosa intendeva Socrate. Chi sa distinguere tra bene e male e tuttavia sceglie il male, è intellettualmente più dotato, più completo, diremmo noi: più consapevole. Dunque, la conclusione paradossale è che solo un uomo dabbene può fare il male consapevolmente. Uno degli argomenti di Socrate è quello del medico di cui ci serviamo. Chiede ad Ippia: ” E’ meglio servirsi di un medico che fa male involontariamente o di uno che procura malattia volontariamente? ” E quello, ammettendo che è migliore chi sa fare il male, prepara la risposta finale di Socrate. ” E infine, della nostra anima non vorremmo che fosse quanto di migliore è possibile?” “sì” risponde Ippia. ” E non sarà dunque migliore se fa il male volontariamente piuttosto che involontariamente?” Ippia risponde:” Ma sarebbe enorme, Socrate,…” Il dialogo prosegue ancora per un po’, senza che le posizioni mutino sostanzialmente. Ora, per quanto si sia riflettuto su tutta la vicenda, è impossibile trovare probabili che due alternative: o si tratta di un falso, redatto probabilmente da qualche acuto aristotelico, o si tratta di un’opera perfettamente compiuta, ovvero non di un lavoro tralasciato a metà da Platone. Il suo intento non era quello di trasmettere una conclusione, ma di far discutere, superando tutta una serie di luoghi comuni, non ultimi gli stessi luoghi comuni diffusi da Socrate in altri contesti, come quello che in genere fa il male chi non conosce il bene. Il vero obiettivo di Platone era evidenziare, allora, la profondità di Socrate e la pochezza e superficialità di Ippia, che intendeva il termine migliore solo in un senso etico e morale, mentre Socrate lo intendeva nel senso di individuo in grado di discernere, valutare le conseguenze delle proprie azioni, avere una mente lucida. La domanda che dovrebbe venirci spontanea di fronte all’affermazione sarebbe: migliore in che senso? Non venendo da Ippia alcuna reazione di questo tipo, ma solo un rifiuto moralistico, abbiamo un ritratto dell’uomo convinto di avere raggiunto grandi conoscenze e grandi certezze, eppure assai scarso di acutezza intellettuale. Così vengono ad evidenziarsi due metodi assai diversi per introdurre non solo l’insegnamento della filosofia, ma proprio il concetto di educazione in generale. Per Ippia che, secondo l’Untersteiner, fu nientemeno che il fondatore del programmo educativo centrato sul quadrivio, la trasmissione del sapere è retorica, cioè discorso che fissa nella memoria concetti inquestionabili come il bene ed il male. Ed ovviamente si scandalizza di ogni possibile obiezione al dogma. Per Socrate la discussione e la ricerca dialettica sono invece l’unico modo per produrre non solo un sapere superficiale, una cultura di nozioni, ma una consapevolezza, un saggiare le questioni sotto molteplici aspetti. Insomma, è vera filosofia e vera pedagogia la via socratica e non quella di Ippia, niente più di un bravuomo molto preso da quella che poteva essere la sua missione ed il suo tornaconto, ma assolutamente inadatto a fare l’insegnante perchè incapace di suscitare la discussione e la ricerca, incapace di suscitare domande del tipo: in che senso intendi migliore? Non si può prescindere da questo Ippia rappresentato da Platone per parlare di Ippia di Elide, matematico valente, insigne maestro di virtù, tuttologo, sapiente enciclopedico, anch’egli sostenitore della gorgiana teoria che il retore potrebbe imbastire discorsi sensati e persuasivi su tutto lo scibile umano. Socrate, nel vero Ippia, l’Ippia maggiore, sembra dilettarsi nel farlo a pezzettini, nel ridurlo alla statura d’un nano. Ma questa volta non riusciamo a comprendere Platone: non sapeva che riducendo il valore del contendente, veniva a deprezzare il valore di Socrate? Era davvero così scadente, superficiale e vuoto tale Ippia, il prototipo di un certo tipo di sofista, capace solo di discorsi generici e grossolani, ampollosi e vuoti? Qualche dubbio è lecito. Un matematico deve avere mente sobria e disciplinata, essenziale e logica. Ed Ippia fu l’unico tra i sofisti a poter vantare una solida preparazione matematica. Certo, non era di scuola pitagorica. Ma il marchio di fabbrica del pitagorismo qualificava e certificava un matematico in modo particolare? Il primo punto da chiarire è allora questo: a differenza dei pitagorici Ippia ricevette un’educazione alla geometria, o meglio, che privilegiava la geometria rispetto all’aritmetica. Gli storici della matematica grosso modo concordano sul fatto che egli diede un’importante contributo alla quadratura del cerchio, anche se poi, la vera dimostrazione venne riconosciuta come merito di Dinostrato. E, forse, Platone detestava Ippia per la sua superiorità in campo matematico, o, forse, per il suo rifiuto ad insegnare (gratis) nell’Accademia. Ce n’è a sufficienza per capire come mai tra i due non corresse buon sangue. Probabilmente, la verità attorno all’Ippia maggiore è una sola: non un dialogo, ma un pamphlet, uno scritto polemico dovuto a circostanze particolari, persino rabbioso. A meno che, a differenza di tanti altri dialoghi, costruiti in atmosfere ideali e rarefatte, l’Ippia maggiore non fosse che un resoconto nudo e crudo di un vero scontro, un libro-verità su un Socrate più velenoso del solito, cioè il vero Socrate contro uno dei tanti Ippia rinvenibili sul mercato all’ingrosso delle scuole sofistiche. Dopo aver letto i dialoghi platonici si può nutrire nei confronti di Ippia un pregiudizio che non era sano. E’ come quando incontri per la prima volta una persona che tuttavia ti è stata descritta attraverso aneddoti e resoconti sommari. Ha detto questo, ha fatto quest’altro, di solito è nervoso, aggressivo, parla troppo, gli piace la letteratura russa, ha la casa piena di quadri comprati lungo i navigli, non legge i giornali tutti i giorni, spesso mangia in quei bar dove si fa il brunch verso le 11 di mattina, ecc. So tutto di lui senza aver mai visto niente. O, forse, so niente? Merito dell’Untersteiner, indubbiamente, è la ricostruzione del probabile pensiero di Ippia in termini più oggettivi. Scrisse moltissimo, con incursioni in ogni campo, ma non rimangono che frammenti, oppure testi di seconda mano, che è sempre avventuroso riconoscere come legati al vero pensiero di Ippia. Certamente fu enciclopedico; aveva una cultura enorme, allevata da una memoria formidabile. Nacque ad Elide in un molto probabile 443 a.C. Nel 399 era già famoso, ma dei suoi maestri non si sa nulla. Viaggiò molto, anche come ambasciatore e fu spesso a Sparta dove, secondo l’Untesteiner “sperimentò quella rigidità della legge, che doveva combattere nella sua teoria.” Fu ad Atene almeno due volte, e in Sicilia esercitò una grande influenza, specie sul tiranno di Siracusa Dionigi il giovane. Ippia era di orientamento democratico, fece attivamente politica su scala internazionale. Fu ucciso mentre “tramava insidie contro la propria patria.” Aveva sposato una certa Platane, dalla quale ebbe tre figli. Scrisse moltissimo e le sue opere più importanti dovrebbero essere Troiano, Consigli di Chirone, Nomi dei popoli, Registro dei vincitori di Olimpia. Le fonti per conoscere il pensiero di Ippia sono, secondo l’Untersteiner, oltre ai frammenti, il capitolo di Tucidide che interpreta i fatti di Corcira, l’Anonymus Iamblichi, le cui idee rispecchierebbero fedelmente il pensiero di Ippia. Ed il Proemio spurio ai Caratteri di Teofrasto sarebbe opera di Ippia. Su queste basi ecco un quadro del pensiero di Ippia. Un politico deve saper parlare in pubblico in modo elegante e persuasivo. Ma l’arte retorica non basta, occorre avere i materiali da plasmare: i contenuti. Essi si ricavano con la conoscenza di tutto, una conoscenza enciclopedica, e qui è la differenza con Gorgia, non solo perchè Ippia afferma che la conoscenza è possibile, ma perchè è anche comunicabile. La meta della conoscenza, tuttavia non è la sapienza separata di ogni campo, ma la superiore visione della realtà, la quale è natura della realtà stessa. Ha la sapienza politica necessaria chi perviene a conoscere la natura, la physis della realtà. Questa natura della realtà corrisponde alla verità. Sembrerebbe, se non parlassimo di Ippia, che parliamo di Aristotele.
Gradi della conoscenza
La conoscenza della natura delle cose avviene attraverso tre gradini da salire: la conoscenza delle parole e del loro significato, la conoscenza dei numeri, il concetto di giusto ed il concetto in generale. La conoscenza delle parole deve essere analitica prima ancora che semantica. La parola si compone di lettere e fonemi la cui esatta pronuncia, con la giusta considerazione per ritmi ed accenti porta alla perfezione del linguaggio. La scelta delle parole è estremamente importante perchè è attraverso di essa che perveniamo alla precisione del discorso, la quale rispecchia l’acutezza del proposito, del cosa vogliamo comunicare. Il secondo gradino da scalare è quello della matematica, non solo il numero nella sua forma aritmetica, ma l’immagine sensibile delle cose, nella loro forma scheletrica e strutturale, la geometria fondata sulle immagini, le figure. Ippia privilegia l’impatto sensibile, l’esperienza della figura, rispetto ad una concezione idealistica. In questo quadro si spiegherebbero i suoi tentivi, storicamente documentati di fornire una dimostrazione della quadratura della circonferenza, in un quadro dinamico, di geometria animata, di linee mobili, di curve. Il terzo gradino è quello rappresentato dalla conoscenza del concetto di giusto, in diversi significati: appropriato, conforme a norma naturale, regolato da leggi che rispecchiano questa conformità alla natura delle cose. Questo terzo gradino è certamente il più importante perchè Ippia vi fonda la sua convinzione fondamentale: l’aver egli stesso compreso la natura delle cose, e dell’uomo in particolare.
La critica alle leggi
Su questa base egli mosse una critica generale alle leggi, al nomos, asserendo, come Antifonte, che le leggi esercitano violenza sulla natura dell’uomo: siamo così agli antipodi da quanto teorizzato da Prodico di Ceo. Ma il senso dell’affermazione non è chiaro, anche se, muovendo da posizioni democratiche, sostanzialmente protagoriche e periclee, si può pensare che non volesse affermare il diritto del più forte ad esercitare prepotenze, ma qualcosa di radicalmente diverso, ovvero denunciare la gabbia legislativa che limita il libero sviluppo delle persone, proibendo quello che non deve essere proibito, ed imponendo quello che non può essere imposto, come, ad esempio, la religione ufficiale. Avremmo dunque un Ippia radical-democratico, una ragione di più, guarda la combinazione, per un intensa contrapposizione al giovin Platone, simpatizzante per l’aristocrazia e filo-spartano. E questa sarebbe ragion più che sufficiente per realizzare l’antipatia reciproca, se non fosse che, proprio tra i democratici ateniesi della fase post-Pericle, si fosse instaurata una convinzione del tutto anti-democratica, ovvero il diritto della maggioranza di esercitare una sorta di dittatura con la forza della legge. Ippia era un democratico, allora, ma per nulla in sintonia con i democratici reali, la nuova ondata di demagoghi, la canea dei sofisti dei secondo e terzo ordine che concionavano agli angoli delle strade. Queste considerazioni concorrono ad arrichire il quadro già mosso e complesso, per nulla lineare. Raramente, nella storia, progressisti e conservatori hanno formato blocchi monolitici l’un contro l’altro armati, e men che mai questo accadde ad Atene. Raramente gli intellettuali si sono prestati ad essere “organici”, cioè servi di strategie di puro esercizio del potere. Spesso hanno teso a criticare ciò che prediligevano, perchè delusi dai comportamenti dei capi. Come del resto oggi, in Italia, gli interessi puramente economici, il conflitto oggettivo tra le classi passa spesso in secondo ordine rispetto a problemi di potere, istituzionali, giudiziari, a vere e proprie vanità ed ambizioni di singoli, così in Grecia le cose non andavano tanto diversamente. Ecco perchè non convince fino in fondo il ritratto del vanesio disegnato da Platone: quando Ippia affermava di aver compreso la natura dell’uomo e di aver quindi trovato una ricetta, un farmaco alla crisi sociale, morale e politica, doveva, in effetti, aver scoperto qualcosa di importante e di nuovo. Le leggi scritte dagli uomini non riflettevano che in poco le leggi non scritte, ma scolpite nella natura umana. Ad una fase nella quale, come ritiene l’Untersteiner, Ippia credette che le leggi umane fossero il metro di misura della giustizia, seguì una fase nella quale si persuase che le leggi umane negavano la vera giustizia, quella non scritta, ma rinvenibile in ogni uomo e nel logos afferrato da Eraclito. Ma il problema della traduzione di questa giustizia fisica in giustizia legislativa e diritto positivo non pare risolto, e non solo per impossibilità politica, ma per difetto teorico e chiarezza di intenti. Non ne abbiamo le prove, ma nemmeno l’Untersteiner potrebbe esibire prove in senso opposto. Ippia rimane un mistico della giustizia, con una fortissima idea confusa che non riescì ad esporre, se non negando la giustizia realmente esistente, forte delle delusioni e delle amarezze che procura. Solo su un punto egli seppe avanzare una proposta concreta: punire chi calunnia. Constatato che la legislazione delle città greche in generale non prevedeva pene contro chi avanzava accuse ingiuste, oppure spargeva dicerie contro qualcuno al fine di denigrarlo e renderlo odioso, Ippia se ne fece scrupolo e punto d’orgoglio, imbastendo una specie di campagna perchè la falsa testimonionza resa contro qualcuno diventasse un reato, tra i più gravi. Basterebbe questo a smentire la stereotipata superficialità di Ippia? Credo di sì: egli disse, pressapoco, che è ancora più ripugnante chi sparge menzogne rivolte a denigrare altri di chi commette prepotenze: quest’ultimo agisce alla luce del sole; il calunniatore agisce nell’ombra, come Jago, che seppe suscitare i più bestiali sentimenti di gelosia in Otello, fino al punto da indurlo all’assassinio. Grazie a Shakespeare (ed a Giuseppe Verdi), forse anche Ippia può trovare finalmente il giusto riconoscimento. Punendo duramente chi calunnia, anche per legittima difesa, forse la legge umana incontra quella naturale, o divina, che dir si voglia.
La curva di Ippia
Ippia di Elide ideò una curva mediante la quale è facile risolvere sia il problema della quadratura del cerchio che della trisezione dell’angolo generico. Resta ormai chiarito che attraverso il solo uso di riga e compasso non si riesce a rettificare la circonferenza e quindi a quadrare il cerchio. Se, oltre alle linee elementari (segmenti, circoli), consideriamo linee che non sono tali, cioè facciamo ricorso a curve di ordine superiore a due, tracciati eventualmente con strumenti non elementari, allora si riesce nell’intento di rettificare la circonferenza. E’ interessante vedere, fra tante almeno una rettificazione di circonferenza ottenuta senza l’uso esclusivo della riga e del compasso.
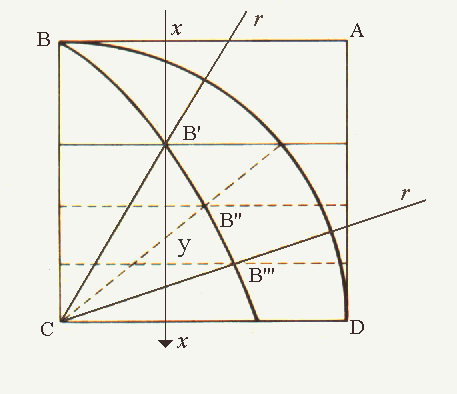
Descrizione della curva
Consideriamo un quadrato abcd e facciamo ruotare uniformemente il lato CB attorno al vertice C, fino a portarsi su CD; contemporaneamente un moto uniforme di traslazione al lato AB fino a portarsi sul lato CD stesso.Regoliamo i due moti in maniera tale che i segmenti detti portano contemporaneamente e giungano sempre contemporaneamente nella posizione finale.Si chiama curva di Ippia il luogo geometrico delle intersezioni dei due segmenti mobili, ottenute istante per istante. La curva è costruibile per punti mediante successive bisezioni del segmento BC e dell’angolo B’CD.
equazione della curva
In termini più moderni, cerchiamo di ricavare dalla definizione l’equazione della curva. Prendiamo intanto il lato del quadrato come unità di misura, come asse x e asse y rispettivamente le rette cui giacciono i lati CD e CB.
ponendo  avremo:
avremo:

![]()
e anche 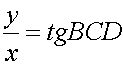
![]()
quindi ![]()
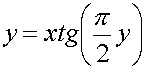 che rappresenta l’equazione della curva descritta.
che rappresenta l’equazione della curva descritta.
PRODICO
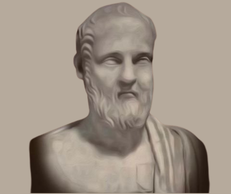 A cura di Daniele Lo Giudice
A cura di Daniele Lo Giudice
Introduzione
Prodico nacque a Ceo, un’isola delle Cicladi, tra il 470 e il 460; venne mandato dalIa sua città in diverse occasioni ad Atene, dove ebbe un grande successo come oratore politico, nonchè per le sue lezioni di filosofia e di retorica. Dovette essere un uomo di grande fascino intellettuale, se riuscì riunire intorno a sè molti giovani. Prodico è rimasto famoso soprattutto per i suoi studi di sinonimica e di etimologia, che inquadrò nel piú vasto problema del rapporto natura-cultura, allora assai sentito e dibattuto. Il linguaggio – le parole – costituisce per Prodico un fatto naturale se considerato in sè (etimologia), ma anche un fatto convenzionale, se considerato nella sua applicazione pratica (sinonimica), all’interno di una società. Intatti l’etimologia, in individuando l’origine di un nome e collegando dei suoni a degli oggetti, a fatti naturali, stabilisce una stretta dipendenza della parola dalla cosa. D’altra parte, oltre a questo significato “naturale” di ogni vocabolo, v’è anche un significato “storico” che esso assume e che deriva dall’uso, cioè dalle condizioni ambientali e storiche in cui viene usato: questo significato storico è studiato appunto dalla sinonimica. Ma Prodico è anche uno studioso della storia dell’uomo; egli ne disegna un profilo che va dallo stato iniziale di ferinità e di soggezione alla natura fino all’istituzione di società fondate sul lavoro e sulle leggi. Il fattore fondamentale di questo sviluppo è techne, cioè l’arte, l’attività lavorativa dell’uomo, che rappresenta lo strumento attraverso il quale – dall’agricoltura all’industria – l’uomo riesce a sfruttare ed a mettere al proprio servizio le forze della natura. A questo proposito anzi Prodico elabora un’importante teoria delle religioni, che per lui sono la celebrazione dei benefici dell’attività umana e degli sforzi degli scopritori delle piú importanti technai, come Efesto del fuoco e della metallurgia.
“Il sole e la luna e i fiumi e le fonti e in genere tutto ciò che giova alla nostra vita, gli antichi li chiamavano dei per la loro utilità, come gli Egiziani fanno per il Nilo, e per questo il pane fu chiamato Demetra, e il vino Dioniso, e l’acqua Poseidone, e il fuoco Efesto e cosí ciascuna cosa che ci è utile“. (DK 84 B 5)
La filosofia morale di Prodico, sostenitore di un’etica che punti sempre sulle virtù, sullo sforzo e sull’impegno dell’ uomo a costruire un mondo di leggi adeguato alla sua natura, ci è testimoniata da un lungo frammento intitolato Le Ore, o Eracles al bivio, in cui si immagina che Eracle, posto di fronte all’alternativa di seguire la via facile del vizio o quella difficile della virtù, imbocchi decisamente questa seconda.
Il pensiero
Prodico nacque a Ceo, forse in un anno da cercarsi tra il 470 el 460 a.C. Fu probabilmente un aristocratico e venne inviato più volte ad Atene come ambasciatore. Secondo l’Untersteiner, ottenne un vivo successo nelle assemblee popolari ed ampio prestigio come retore ed insegnante. Guadagnò, inoltre, molto denaro con l’insegnamento. “Era, dunque, un vero sofista, ma libero da ogni interesse retorico – scrive l’Untersteiner – tant’è vero che definiva il sofista intermedio tra il filosofo ed il politico. ” Questa definizione sembra implicitamente ammettere che già nel V secolo era palese la la distinzione tra vita contemplativa e vita attiva, cioè la partecipazione alla politica, e tra vita intellettuale e dimensione pratica. Amante dei piaceri e cagionevole di salute, Prodico ebbe discepoli importanti come Socrate, Tucidide (al quale trasmise la sua passione per la storia), Euripide, Teramene, Isocrate e Damone. Basterebbe questo a rivalutarne la figura, ma nascono difficoltà spesso insormontabili per ricostruirne fedelmente il pensiero, data la scarsità dei testi disponibili e la carenza di testimonianze, alcune delle quali, come quella di Platone, decisamente riduttive. Prodico scrisse un trattato intitolato
Ωραι
, Le Ore, dee della fecondità venerate a Ceo e significative dell’intero processo naturale. L’Untersteiner sostiene che gli scritti Intorno alla natura e Intorno alla natura dell’uomo erano parte integrante delle Ore e non testi autonomi.
Origine delle cose, umanesimo, forse un “senso della storia”
Prodico guardò alla realtà del mondo con lo sguardo dell’uomo comune, ma per primo, ebbe consapevolezza della necessità di scrivere una storia in chiave antropologica. Fu uno dei primi pensatori a delineare il concetto di progresso, se non di “evoluzione”, ed a tentare di chiarire i processi secondo i quali l’uomo, creatura originariamente fatta con il fango, fosse diventato in un certo senso signore della natura. Scrisse l’Untersteiner: “Nella sua massima opera, le Ore, ove il ciclo delle cose e la legge etica, che tutto regola, trovavano una loro visione unitaria, noi possiamo immaginare che il primo argomento fosse proprio quello dell’origine degli enti, fuggevolmente accennato in Protagora, ma di certo perseguito, in più precisi sviluppi, da Prodico.” Secondo Prodico la condizione originaria dell’umanità era di “estrema fralezza” (Untesteiner), ma esso seppe progredire per opera di “scopritori” che, “con il loro errare, dopo che da essi erano state scoperte da poco le messi, giovarono all’utile degli uomini.” Il talento degli scopritori, secondo Prodico, era consistito nel conoscere la natura, e nel trovare in essa le più segrete risorse. Ne nacque l’arte dell’agricoltura, che fu preludio alla scoperta di tutte le arti. Secondo l’Untersteiner, Prodico si collegava alla religiosità misterica di Eleusi, che appunto predicava Demetra come la dea datrice dell’agricoltura e la poneva a fondamento di tutto ciò che di buono esiste al mondo. Non è chiaro, tuttavia, se Prodico debba essere considerato come un evemerista ante-litteram, ovvero se egli in qualche modo anticipò l’idea di Evemero di Messina, filosofo del III secolo a.C., secondo il quale gli dei erano stati solo uomini di grandi meriti, che gli uomini divinizzarono in seguito alla loro scomparsa. Certo è che alla base delle convinzioni del nostro vi era un curioso impasto di filosofia di Empedocle e di tradizioni misteriche. Egli pose alla radice di una probabile cosmogonia la preesistenza dei quattro elementi e la comparsa del sole e della luna quali determinanti alla vita. Gli dei sono gli elementi stessi, ma nel significato più proprio di “radici” e non di entità sovrannaturali antropomorfe. Secondo l’Untersteiner, la debolezza umana postulata da Prodico come condizione originaria conduce ad un pessimismo cosmico, in singolare contrasto con “l’ottimismo” di altri sofisti come Protagora e Gorgia. L’osservazione non mi sembra molto pertinente, se non altro perchè fatico a comprendere dove stia l’ottimismo di Gorgia. Evidenzierei piuttosto, al contrario, che se, lentamente ed a fatica, si fa strada l’idea di progresso, proprio in Prodico, c’è una nota ottimistica che spezza la circolarità ciclica nella concezione del tempo storico nella mentalità greca, avvicinandolo ad una concezione, in questo caso davvero ante-litteram, ebraico-cristiana. In Prodico la cronologia, visto che è ancora improprio parlare di storia (se historia significava allora primariamente ricerca, e non narrazione e ricostruzione degli eventi), assume già un senso ed una direzione. E questa direzione è caratterizzata dal venire da un tempo di tenebre e di debolezza dell’uomo, ad un tempo di luce e di forza. La civilizzazione non è perdita, ma conquista. La cultura acquisita non è segno di una degenerazione della presunta natura umana, ma il frutto della particolare natura umana, che non è la stessa natura degli altri animali. Sono pensieri moderni, antropologici. Dunque, di fronte all’antitesi, presente in molti sofisti, tra legge (regole umane) e natura (impulsi ed istinti), Prodico mirò alla sintesi. La legge, il nomos, non è altro dalla prosecuzione della natura, come pure l’arte è la sua comprensione più efficace e raffinata. La riflessione consente all’uomo di superare e trascendere la condizione naturale, senza tuttavia abbandonarla del tutto. Ovviamente, non si tratta di interpretare Prodico come fosse Hegel. La sua filosofia della storia è ancora rudimentale, quasi istintiva. In essa la categoria dello spirito umano, della tempra e della mentalità che sono immanenti all’uomo stesso, e non trascendenti, sono semplicemente in nuce. Prodico era ancora convinto della conciliazione reale, e non solo apparente e formale, tra filosofia e religione popolare. Mentre esaltava la divinità naturale come “insieme” e non come particolarità di nomi e di santi patroni (Hermes, Athena, Efesto ed Afrodite), non voleva muovere alcun attacco a tali sacre figure venerate dal popolo e dalla religione ufficiale delle città. Se la filosofia si presentava comunque come superiore alla religione, per Prodico, essa non aveva comunque un oggetto diverso: portava comunque al riconoscimento del divino, alla sua definizione concettuale di benefattore dell’umanità. Il grande merito di Prodico fu certamente quello di inaugurare la riflessione sul linguaggio e la sua origine in maniera feconda, anche se unilaterale. Convinto della continuità tra natura e cultura, egli sostenne con convinzione che le parole ed i nomi non hanno origine nell’arbitrio, ma vengono dalla natura stessa. Molti hanno visto in questa impostazione una indiretta polemica con Gorgia, il quale, asserendo che la conoscenza era incomunicabile, aveva scavato un fossato tra nome e parola, tra significante e significato. Forse, nel tentativo di ricucire lo strappo, Prodico non trovò di meglio che cercare di rifondare la certezza del significante e del nome nella storia e nella genealogia della parola, evidenziando che gli equivoci e le imprecisioni non sono dovute alla debolezza della lingua, ma all’uso impreciso e sommario che se ne fa. Questa ricerca sul significato delle parole e sui sinonimi, se ci si riflette bene, potrebbe aver influito grandemente su Socrate, inducendolo a portare avanti la ricerca sul concetto, la definizione del cosa è questo di cui stiamo parlando. Non diversamente, secondo l’Untersteiner, Prodico, approfondendo la sinonimica, cercò di rispondere anche a Democrito, che aveva postulato l’origine convenzionale dei nomi, e quindi aperto a Gorgia la via della critica al rapporto tra pensiero, linguaggio e realtà. C’è da dire che Platone fu molto critico con Prodico, asserendo che egli, aveva spaccato il capello, “esercitato violenza sulla lingua, senza pervenire all’essenza della cosa, al suo essere, e senza, allo stesso tempo, aver saputo destare autentico interesse filosofico per la vera sapienza e la virtù. E’ arduo pronunciarsi sulla fondatezza di tale rimprovero se non fosse che l’intero approccio di Prodico all’insegnamento della filosofia, o meglio, della sua sophia, era certamente compromesso dal fatto che era a pagamento. Ma proprio da una polemica su tale questione, e sul connesso problema della ricchezza, venne dall’uomo di Ceo un insegnamento, a mio giudizio, di carattere fondamentale. A chi, come lo stesso Socrate, asseriva che la ricchezza era un male in sé, Prodico rispose che: ” per la persona di perfetta onestà e che sa in quale occasione si deve far uso della ricchezza, essa è un bene, mentre per i malvagi che non lo sanno, essa è un male. E’ una tesi che riecheggia la risposta che Gorgia diede allo stesso Socrate sul valore della retorica. Un semplice strumento: c’è chi la usa bene e chi la usa male; non si può dare la colpa a Gorgia se chi impara a fare discorsi, si volge alla calunnia, alla menzogna, alle malefatte. Si tratta, com’è ovvio, di due approcci del tutto diversi e quello di Prodico, in apparenza solo più spregiudicato, era in realtà meno ideologico e più aperto, più aderente alla realtà nella quale è vero che non tutti i ricchi sono disonesti, anche se la ricchezza sembra portare in sé una qualche maledizione che se non colpisce i ricchi, colpisce comunque i loro discendenti, facendone dei “viziati”. Questo inciso ci ha consentito di introdurci agli insegnamenti etici di Prodico che, nella concezione di Aristotele, sarebbe risultato forse più un saggio che un filosofo, un maestro di vita e non un maestro di scienza. L’etica di Prodico, in realtà, è facilmente riassumibile nella storia che egli stessò raccontò, anche se non la inventò, quella di Eracle al bivio. A circa ventanni Eracle si trovò ad un bivio dove incontrò due donne, l’una alta e bella, dai lineamenti armoniosi simboleggiava la virtù; la seconda, bella altrettanto, ma dalle forme prorompenti e lascive, impersonava vizio e corruzione. Entrambe cercarono di attrarre Eracle, incitandolo a seguire una sola strada, vista l’impossibilità di percorrerle entrambe. Ed Eracle scelse la virtù. A prescindere dal fatto che virtù non significava per i greci del tempo, e nemmeno per Prodico, solo il bene, la castità, la perfezione e l’altruismo, ma qualcosa di analogo al valore, al coraggio, all’onestà, cioè a doti più virili che monacali, è evidente che in Prodico era maturata la convinzione che bene e male fossero qualcosa di distinguibile in modo molto più certo e meno relativistico che in Gorgia. L’antitesi, tuttavia, come già s’è detto, non era tra natura e cultura, o tra carne e spirito, ma tra due opposti richiami di carattere assai più primitivo, interni all’uomo stesso, alla sua umanità simboleggiata dalle due donne. Ciò che colpisce è che Arete, la donna virtuosa, il valore, non fece appello alla ragione, all’anima razionale, ma alla natura di Eracle, al suo carattere, alla sua capacità di decidere, in quanto uomo, su quale strada immettersi.
SOCRATE
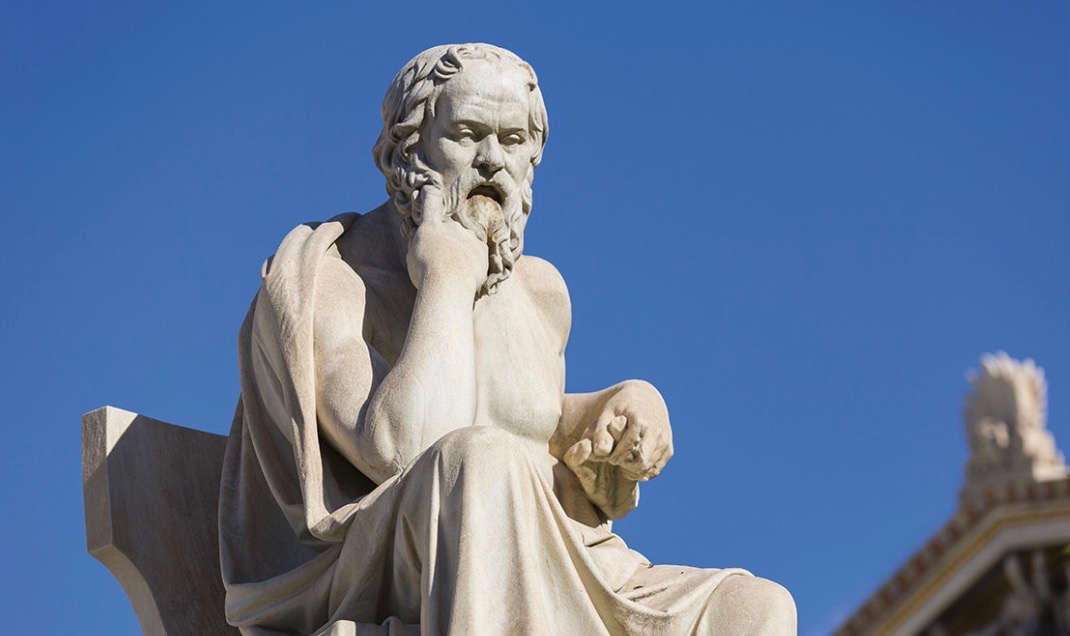 Socrate nacque nel 470 / 469 a.c. da Sofronisco , scultore , e Fenarete , levatrice . Dapprima esercitò forse il mestiere del padre , ma successivamente l’abbandonò per dedicarsi esclusivamente all’indagine filosofica . Non di rado dovette quindi ricorrere all’aiuto economico di amici . Sposò Santippe , che una certa tradizione tende a presentare come donna bisbetica e insopportabile : si è arrivati a pensare che Socrate stesse sempre in piazza non tanto per filosofare quanto piuttosto per stare lontano da Santippe e dalle sue ramanzine continue : pare che Socrate sia riuscito a far ragionare tutti tranne Santippe . Da lei ebbe tre figli . Socrate non lasciò mai Atene se non per brevi spedizioni militari : partecipò infatti nel 432 alla spedizione contro Potidea , traendo in salvo Alcibiade ferito , e nel 424 combattè a Delio a fianco di Lachete durante la ritirata degli Ateniesi di fronte ai Beoti . Successivamente nel 421 combattè ad Anfipoli . Nel 406 in conformità al principio della rotazione delle cariche , fece parte dei pritani , ossia del gruppo del Consiglio al quale spettava decidere quali problemi sottoporre all’Assemblea e si oppose alla proposta illegale di processare tutti insieme i generali vincitori nello scontro navale avvenuto al largo Arginuse , perchè non avevano raccolto i naufraghi . Con questa presa di posizione egli si poneva in contrasto con i democratici , ma nel 404 , passato il potere in mano all’oligarchia capeggiata dai Trenta , rifiutò di obbedire all’ordine di arrestare un loro avversario , Leone di Salamina . Nel 403 la democrazia restaurata , pur concedendo un’amnistia , continuò a ravvisare in Socrate una figura ostile al nuovo ordine , anche per i rapporti da lui intrattenuti in passato con figure come Alcibiade e Crizia . Nel 399 fu presentato da Meleto un atto di accusa contro Socrate , ma tra i suoi accusatori erano anche Licone e soprattutto Anito , uno dei personaggi più influenti della democrazia restaurata . L’atto di accusa è il seguente : ” Socrate è colpevole di essersi rifiutato di riconoscere gli dei riconosciuti dalla città e di avere introdotto altre nuove divinità . Inoltre è colpevole di avere corrotto i giovani . Si richiede la pena di morte ” . Gli accusatori contavano probabilmente in un esilio volontario da parte di Socrate , com’era avvenuto in passato per Protagora o Anassagora , ma egli non abbandonò la città e si sottopose al processo . A maggioranza i giudici votarono per la condanna a morte la quale fu eseguita in carcere mediante la somministrazione di cicuta . Possiamo inserire Socrate nell’era sofistica (sebbene lui si schierò contro i sofisti) perchè come i sofisti si interessò di problemi etici ed antropologici , mettendo da parte la ricerca del principio e della cosmogonia . Socrate non scrisse mai nulla e così per ricostruire il suo pensiero dobbiamo ricorrere ad altri autori . Le fonti principali sulla vita di Socrate sono quattro 1) Platone 2)Senofonte 3)Aristotele 4)Aristofane . 1) Platone è senz’altro la fonte più attendibile : egli fu discepolo diretto di Socrate e con lui condivise sempre l’idea della filosofia come ricerca continua . Senofonte è la fonte più banale e meno interessante : il Socrate degli scritti di Senofonte è un cittadino ligio alla tradizione , il vero interprete dei valori correnti , il saggio che mira al bene dei suoi concittadini ed è ossequioso verso la città e le sue divinità . Va subito precisato che Senofonte era un grande generale , coraggioso e valoroso , ma non era certo un’aquila : i suoi scritti stessi non sono certo esempi eclatanti della letteratura greca : sono ridondanti e ripetitivi . Senofonte fece anche campagne militari con Socrate e nei suoi scritti ne esalta il valore dicendo che non stava mai fermo , era sempre in azione , non soffriva niente (camminava addirittura a piedi nud sul ghiaccio) . A Senofonte della filosofia non gliene importava nulla e con Socrate , di cui era grande amico , non trattava mai argomenti filosofici , ma solo militari : questo ci consente di capire che Socrate modulava il discorso a seconda del personaggio che aveva di fronte : con un filosofo parlava di filosofia , con un generale di guerra . 3) La testimonianza di Aristotele è stata a lungo ritenuta la più attendibile perchè Socrate non viene caricato di significati simbolici : Aristotele ce ne parla in modo oggettivo . Tuttavia la testimonianza aristotelica ha dei limiti : in primis , è la meno ” artistica ” delle 4 ed è l’unica di un non-contemporaneo . Va poi detto che in Aristotele Socrate ci viene presentato quasi come un ” robot ” : la filosofia socratica viene presentata come un susseguirsi di ragionamenti e non viene dato spazio al filosofare in pubblico , al dialogo aperto . 4) Aristofane è il personaggio più vicino a Socrate come età : ci presenta un Socrate relativamente giovane (circa 40 anni) . Va ricordato che Aristofane era un commediografo e ne risulta che l’immagine che lui ci dà di Socrate è fortemente impregnata di tratti sarcastici . Ne ” Le nuvole ” ce lo presenta come un sofista studioso della natura (il contrario di ciò che era in realtà) , con la testa fra le nuvole . Insomma Aristofane è l’unico a darci di Socrate un’immagine fortemente negativa (non a caso Aristofane era stato uno dei primi accusatori di Socrate) . In realtà non dobbiamo pensare che Aristofane volesse gettar discredito su Socrate o lo prendesse in giro per cattiveria : in fondo lui faceva solo il suo lavoro di commediografo , che consisteva nel far ridere . In realtà con la figura di Socrate vuole prendere in giro non Socrate , ma l’intera categoria dei filosofi . La testimonianza di Platone resta la migliore e le altre tre vanno sfruttate come appoggio . Platone lo conosceva davvero bene ed era lui stesso un gran filosofo : il grosso limite è che trattandosi di un filosofo , Platone avrebbe potuto rimaneggiare i discorsi di Socrate , ed è proprio quel che fa man mano che invecchia . ” L’apologia ” , per fortuna , resta un dialogo giovanile nel quale Platone descrive il processo che decretò la condanna a morte di Socrate . E’ proprio in questo dialogo che emerge fortemente la differenza tra Socrate ed i sofisti : i sofisti pronunciavano discorsi raffinati ed eleganti , ma totalmente privi di verità : per loro l’importante era parlar bene , avere un buon effetto sulle orecchie degli ascoltatori . Per Socrate invece quel che più conta è la verità : lui si proclama incapace di controbattere a discorsi così eleganti e ben formulati (ma falsi) . Socrate , pur non tenendo un’orazione raffinata , dice il vero : la critica ai sofisti verrà poi ripresa da Platone stesso . I sofisti puntavano a stupire l’ascoltatore , dal momento che erano convinti che la verità non esistesse (soprattutto Gorgia . Socrate per difendersi in tribunale non pronuncia un discorso (come i sofisti) , ma imposta un dialogo botta e risposta : è proprio dal discorso che viene a galla la verità (Platone dirà che il discorso tra due o più individui è come lo scontro tra due pietre dal quale nasce la fiamma della conoscenza) . Lo stile oratorio di Socrate è scarno , secco e quasi familiare , modulato a seconda dell’interlocutore . Il punto di partenza del discorso socratico è la cosiddetta ” ironia socratica ” , ossia la totale autodiminuzione , ” io non so , tu sai ” . Così inizia anche ” L’apologia” : si pone la domanda “che cosa è x ?” e l’interlocutore cade nel tranello e risponde , sentendosi superiore a Socrate . Socrate , come abbiamo detto parlando di Senofonte , parla di argomenti noti all’interlocutore : se ad esempio parla con un generale gli chiederà ” che cosa è il coraggio ? ” . Quello risponderà , per esempio , dicendo che il coraggio è il non indietreggiare mai . Allora Socrate interverrà dicendo che quello non è coraggio , bensì pazzia . La critica diventa stimolo per l’interlocutore a fornire una seconda risposta meglio articolata : il gioco può andare avanti a lungo e spesso rimane aperto . Questo metodo viene detto ” maieutico ” : Socrate diceva di fare lo stesso lavoro della madre , la quale era ostetrica : lei faceva partorire le donne , lui le anime . Come le ostetriche valutano se il neonato è ” buono ” , così Socrate valuta se le idee , le definizioni sono buone . Non tutti gli interlocutori erano intelligenti e riconoscevano i propri errori : spesso preferivano evitare Socrate . Da un interlocutore Socrate fu anche denominato ” torpedine ” in quanto l’incontro con Socrate risulta scioccante perchè ribalta le concezioni di chi era convinto di sapere e dimostrava che in realtà non sapeva . Socrate stesso si paragonava ad un moscone che stimola il cavallo : lui stimolava gli uomini a ragionare . Socrate con il processo dell’autodiminuzione afferma di non sapere nulla , mentre sostiene che i sofisti sappiano tutto : dice che forse l’educazione che impartisce lui è inutile rispetto a quella sofistica , ma senz’altro è più importante . Le calunnie nei confronti di Socrate hanno avuto inizio quando lui si definiva sapiente in quanto l’oracolo di Delfi gli aveva detto che era il più sapiente tra gli uomini . Lui era rimasto sconvolto da tale affermazione e non riusciva a crederci : allora cominciò a girare per Atene per vedere se trovava persone effettivamente più sapienti di lui . Dunque si recò da coloro che si ritenevano sapienti : politici , poeti , artigiani . Socrate si accorse che tutte e tre le categorie erano convinte di sapere , ma in realtà non sapevano niente : i politici erano i peggiori di tutti non in quanto politici (Socrate stesso , se vogliamo , era un politico perchè svolgeva la sua attività in pubblico) ma in quanto non capaci di insegnare il loro sapere : un vero sapiente deve spiegare ciò che sa : anche i politici migliori (Pericle) non sanno trasmettere il loro sapere . Lo stesso era per i poeti , che a partire da Omero erano considerati sapienti ed educatori : Socrate li biasima sia perchè dicono assurdità , sia perchè il loro non è un sapere , ma una forma di ” follia ispirata ” : era la divinità che parlava per bocca loro . I meno peggio risultarono essere gli artigiani , che almeno sapevano fare diverse cose di utilità pubblica : la loro è una ” tecnè ” , ossia una sapienza pratica . Però anche gli artigiani avevano i loro difetti : erano sì competenti nel loro settore , ma peccavano di presunzione perchè erano convinti che la loro conoscenza fosse universale ed illimitata , anzichè limitata . Inoltre essi agivano senza pensare e ponderare . Socrate arrivò alla conclusione che l’oracolo di Delfi aveva ragione : lui stesso è il più sapiente , pur sapendo di non sapere . Il suo non va interpretato come atteggiamento di rinuncia alla ricerca della verità , ma come segno di modestia intellettuale : è proprio il fatto di essere consapevoli della propria conoscenza che spinge l’uomo a sforzarsi di raggiungere la conoscenza ; se si è convinti di sapere già tutto non ci si sforzerà di migliorare . Tra le varie accuse che vengono mosse a Socrate c’è anche quella di corrompere i giovani nella piazza rendendoli peggiori : lui ribatte a questa accusa dicendo che non avrebbe motivo di fare ciò . Infatti se corrompesse i giovani finirebbe per vivere in una città di giovani corrotti , il che si ritorcerebbe contro lui stesso . Va senz’altro ricordato il cosiddetto ” intellettualismo etico ” di Socrate : secondo lui nessuno può compiere il male sapendo effettivamente di compierlo : nessuno potrebbe mai fare del male volontariamente . Un rapinatore rapina non pensando di fare del male , ma di fare del bene : è un errore intellettuale ritenere bene ciò che è male . E’ un atteggiamento tipicamente cristiano-cattolico che si possa scegliere tra bene e male indistintamente . Dunque Socrate introducendo l’intellettualismo etico dimostra di aver agito per il bene della sua città . E’ Socrate che ha scoperto il concetto moderno di anima ( ψυχη ) : in precedenza significava ” soffio vitale ” , ciò che fa vivere le cose ; il termine ψυχη assunse poi il significato di ” immagine nell’Ade ” , un’esistenza depotenziata . Per gli Orfici significava ” demone ” . A partire da Socrate fino al giorno d’oggi l’anima è diventata il nostro io : ci identifichiamo con l’anima . Secondo Socrate possiamo dividere i beni ed i mali in tre categorie a) dell’anima b) del corpo c) dell’esterno . Il corpo è lo strumento nonchè la prigione dell’anima . Il denaro , per esempio , è un bene esterno . In alcuni frangenti sembra che Socrate (e anche Platone ) rifiuti i beni materiali e del corpo , scegliendo quelli dell’anima ; in altre occasioni pare che possano essere accettati entrambe . Socrate , per esempio , pare che non disprezzasse il vino . Quest’ambiguità tra beni del corpo e beni dell’anima può essere spiegata affermando che i beni son tutti beni finchè non entrano in conflitto con altri : la ricerca del piacere fisico diventa un male quando la si antepone alla ricerca di quello intellettuale . Questo non vale solo per i beni , ma anche per il rapporto tra anima e corpo : il corpo per Socrate e Platone non va disprezzato , anzi va apprezzato perchè serve all’anima . Per il Cristianesimo la ricchezza è un male , per Socrate e Platone è un bene finchè non entra in conflitto con gli altri beni . Interessante è il concetto socratico di ingiustizia : essa non danneggia chi la subisce , ma chi la commette . La giustizia infatti dà un senso di piacere interiore e chi è ingiusto perde questo piacere , mentre chi subisce l’ingiustizia continua a provarlo . Questo vale anche per Platone . Tra le cose che Socrate dice di non sapere vi è la conoscenza dell’aldilà , di cosa c’è dopo la morte ( Platone dirà di essere in grado di dimostrare l’esistenza di un aldilà) . Per lui non è che se si vive una vita giusta si sarà premiati : si è già appagati dal vivere giustamente , la felicità che si prova perchè si è giusti è già una sorta di premio : Socrate dice che magari potrebbe esserci una vita ultraterrena , ma lui non lo sa . Tra le varie accuse rivolte c’era anche quella di ateismo e di empietà : Socrate infatti credeva nei demoni , che lui proclamava ” figli delle divinità ” . Lui dimostra che è un’accusa sbagliata dicendo che se crede nei demoni che sono figli delle divinità , è ovvio che creda anche nelle divinità : perchè ci sia il figlio (demone) , ci devono anche essere il padre e la madre (le altre divinità) . Ma che cosa era questo demone ? Abbiamo due testimonianze divergenti : per Platone era una sorta di angelo custode – coscienza personale che interveniva ogni qual volta Socrate stesse per sbagliare : si tratterebbe di una sorta di ” aiuto privilegiato ” che non tutti hanno : solo le persone per bene . E’ un dono divino per i buoni . E’ come se la divinità partecipasse alla vita umana . Per Senofonte invece il demone è un’entità che lo spinge ad agire in determinati modi : Senofonte intende ancorare fortemente Socrate alla credenza in un ordine divino e in un intervento divino nella vita umana . Per Socrate l’importante non è vivere , ma vivere bene : quando la nostra anima è sana , giusta , allora anche noi stiamo bene . Sempre Senofonte nei ” Detti memorabili ” riassume la prova dell’esistenza di Dio formulata da Socrate in questi termini : ciò che non è opera del caso postula una causa intelligente , con particolare riguardo al corpo umano che ha una struttura organizzata non casuale . Per questa sua origine l’uomo è ritenuto superiore a tutti gli altri animali ed è oggetto dell’interesse di Dio , come si deduce anche dalla possibilità di conoscere i suoi progetti sull’uomo ricorrendo all’arte della divinazione . Va notato che il Dio socratico ( inteso come intelligenza finalizzatrice ) è una sorta di elevazione a entità assoluta della psychè umana . Molti hanno notato che gli accusatori non volevano in realtà condannarlo a morte , ma semplicemente zittirlo . Ma Socrate non può accettare di essere zittito : il suo destino è andare in giro a colloquiare con la gente . Vivere bene per Socrate significa svolgere quest’attività e non rifiutare di essere colpevole significava non far perdere significato alla sua vita . Dal momento che era già vecchio e gli restavano pochi anni di vita , tanto valeva farla finita lì , ma non rinunciare ai suoi ideali . Mentre la ricerca di Platone si spingerà in un’altra dimensione , quella di Socrate rimane saldamente ancorata al mondo terreno : la sua mIssione è far capire ai cittadini ciò che fanno . In Socrate vi è poi un rifiuto della politica (che peraltro troveremo anche in Platone ) : fa infatti notare che lui stesso aveva avuto parecchi problemi con la politica : prima contro di lui si erano scagliati gli oligarchici , ed ora i democratici (nell’accusa ai danni di Socrate si possono scorgere istanze politiche : lui era un aristocratico e i democratici volevano punirlo ) . Pur avendo problemi con la politica , Socrate non dice che vada abolita . Prima dell’esecuzione della pena capitale , a Socrate era stata presentata la possibilità di evadere dal carcere , ma lui si era rifiutato : in lui infatti vi era il massimo rispetto per la legge , che non si deve infrangere in nessun caso . La legge può essee criticata , ma non infranta : di fronte ad una legge ingiusta non bisogna infrangerla , ma bisogna battersi per farla cambiare . Socrate afferma che sarebbe stato suo dovere far cambiare la legge e che non essendoci riuscito è giusto che lui muoia . Gli Ateniesi son convinti di essersi liberati di Socrate avendolo eliminato fisicamente , ma in realtà per liberarsene completamente avrebbero dovuto ” ucciderlo filosoficamente ” , batterlo a parole . In realtà volevano farlo tacere , ma han sortito l’effetto opposto : Platone infatti , che era intenzionato a dedicarsi alla vita politica , resterà sconvolto per condanna del maestro e si dedicherà alla filosofia . In Socrate vi è una vaga idea di provvidenza divina , ma non collettiva , bensì individuale : la divinità aiuta solo i migliori . Celeberrima è la conclusione dell’ Apologia , in cui Socrate si rivolge ai suoi discepoli prima di essere giustiziato : ” Ma ormai è ora di partire : io verso la morte , voi verso la vita . Chi di noi cammini a una meta superiore è oscuro a chiunque : non al mio dio .” Nel ” Simposio ” di PlatonePlatone Alcibiade afferma che Socrate non assomiglia a nessuno degli uomini del passato e del presente : è una figura nuova . Non si interessa di politica , ma non la disprezza , non rifiuta i festini , ma non vi si identifica ( nel ” Simposio ” tutti i convitati si addormentano , Socrate no ) . Soffermiamoci ora maggiormente sulla tecnica discorsiva di Socrate : la confutazione è la tecnica che dimostra l’inconsistenza del sapere dei propri interlocutori . Ma per arrivare a questo risultato bisogna partire dal metodo delle domande e delle risposte . ” Che cosa è la giustizia ? ” può essere il punto di partenza per il dibattito : porre questa o qualsiasi altra domanda del genere significa richiedere la definizione delle cose in questione , che però deve essere valida per tutti i casi particolari . In questo senso la ricerca di Socrate è stata interpretata da Aristotele come ricerca dell’universale , nell’ambito dei concetti e dei problemi morali . Gli interlocutori di Socrate si dimostrano incapaci di rispondere correttamente alla domanda sia perchè sottovalutano Socrate (che dice di essere inferiore) sia perchè rispondono citando casi particolari , anzichè la definizione universale . Abbiamo già citato il caso della domanda ” Che cosa è il coraggio ? ” : rispondere ” non inditreggiare mai ” è sbagliato , così come dire ” assalire il nemico ” : si può essere coraggiosi anche nell’affrontare una malattia o un’interrogazione : una definizione corretta deve coprire tutti i casi possibili . Nella sua funzione negativa il metodo delle domande e risposte si caratterizza come confutazione , ossia dimostrazione della falsità o contradditorietà delle risposte date dall’interlocutore . Gli effetti prodotti dall’esercizio di questo metodo sono paragonati a quelli della torpedine marina , che intorpidisce coloro che tocca . Di fronte alla confutazione si può reagire rifiutandola , come fanno vari interlocutori di Socrate . Ma , se la si accetta , essa può liberare dalle false opinioni che si hanno sui vari argomenti e agire dunque come una forma di purificazione . La situazione , che risulta dalla confutazione , è detta απορια , ossia letteralmente situazione senza vie di uscita . Essa consiste nel rendersi conto che i tentativi sin qui percorsi di rispondere a un determinato problema , hanno condotto a un vicolo cieco . Ma in questa nuova situazione , liberi dal falso sapere e soprattutto dalla presunzione di sapere , ci si può accingere alla ricerca del vero sapere , tentando nuove stade che possano condurre ad esso . In questo nuovo orientamento il metodo delle domande e risposte può assolvere una funzione positiva . Essa è paragonata alla funzione svolta dalla maieutica , capace di far partorire ad ognuno , mediante domande opportunamente indirizzate , la verità , di cui ciascuno è gravido . Socrate si ostina incessantemente a far convergere i propri interlocutori nell’ammissione di un punto fondamentale : per saper agire bene , cioè virtuosamente , in un determinato ambito , occorre possedere il sapere che renda capaci di ciò . A questo risultato egli perviene mediante l’analogia con le tecniche : il buon artigiano che sa svolgere bene la propria attività possiede un sapere capace di guidarlo a questo risultato . La stessa cosa deve valere in ambito etico-politico : questo è il nocciolo della famosa tesi secondo cui la virtù è scienza . Questa tesi conduce ad alcune conseguenze . In primo luogo , chi conosce che cosa è bene e quindi anche che cosa è buono per lui non può non farlo . Il bene è dotato di un potere incontrastabile di attrazione . Ciò non significa che Socrate disconosca l’importanza delle passioni e delle emozioni nella vita umana , ma soltanto che in ogni ambito della vita umana l’unico strumento capace di orientare verso il comportamento corretto è ravvisato nel sapere . La posizione etica di Socrate non va confusa con forme di rigorismo ascetico . Essa è invece definibile come una forma di eudemonismo , perchè pone come obiettivo fondamentale il perseguimento della felicità (in Greco ευδαιμονια ) . E’ il sapere che è in grado di effettuare un corretto calcolo degli stessi piaceri , misurando le conseguenze piacevoli o dolorose che essi possono arrecare . Questo è il sapere , di cui Socrate dichiara di non essere in possesso , ma proprio per questo è il sapere che egli persegue . Non ha senso allora distinguere le varie virtù nettamente le une dalle altre : la virtù è una , come uno solo è il sapere in cui esse si compendiano : sapere che cosa è bene e che cosa è male .
Socrate nacque nel 470 / 469 a.c. da Sofronisco , scultore , e Fenarete , levatrice . Dapprima esercitò forse il mestiere del padre , ma successivamente l’abbandonò per dedicarsi esclusivamente all’indagine filosofica . Non di rado dovette quindi ricorrere all’aiuto economico di amici . Sposò Santippe , che una certa tradizione tende a presentare come donna bisbetica e insopportabile : si è arrivati a pensare che Socrate stesse sempre in piazza non tanto per filosofare quanto piuttosto per stare lontano da Santippe e dalle sue ramanzine continue : pare che Socrate sia riuscito a far ragionare tutti tranne Santippe . Da lei ebbe tre figli . Socrate non lasciò mai Atene se non per brevi spedizioni militari : partecipò infatti nel 432 alla spedizione contro Potidea , traendo in salvo Alcibiade ferito , e nel 424 combattè a Delio a fianco di Lachete durante la ritirata degli Ateniesi di fronte ai Beoti . Successivamente nel 421 combattè ad Anfipoli . Nel 406 in conformità al principio della rotazione delle cariche , fece parte dei pritani , ossia del gruppo del Consiglio al quale spettava decidere quali problemi sottoporre all’Assemblea e si oppose alla proposta illegale di processare tutti insieme i generali vincitori nello scontro navale avvenuto al largo Arginuse , perchè non avevano raccolto i naufraghi . Con questa presa di posizione egli si poneva in contrasto con i democratici , ma nel 404 , passato il potere in mano all’oligarchia capeggiata dai Trenta , rifiutò di obbedire all’ordine di arrestare un loro avversario , Leone di Salamina . Nel 403 la democrazia restaurata , pur concedendo un’amnistia , continuò a ravvisare in Socrate una figura ostile al nuovo ordine , anche per i rapporti da lui intrattenuti in passato con figure come Alcibiade e Crizia . Nel 399 fu presentato da Meleto un atto di accusa contro Socrate , ma tra i suoi accusatori erano anche Licone e soprattutto Anito , uno dei personaggi più influenti della democrazia restaurata . L’atto di accusa è il seguente : ” Socrate è colpevole di essersi rifiutato di riconoscere gli dei riconosciuti dalla città e di avere introdotto altre nuove divinità . Inoltre è colpevole di avere corrotto i giovani . Si richiede la pena di morte ” . Gli accusatori contavano probabilmente in un esilio volontario da parte di Socrate , com’era avvenuto in passato per Protagora o Anassagora , ma egli non abbandonò la città e si sottopose al processo . A maggioranza i giudici votarono per la condanna a morte la quale fu eseguita in carcere mediante la somministrazione di cicuta . Possiamo inserire Socrate nell’era sofistica (sebbene lui si schierò contro i sofisti) perchè come i sofisti si interessò di problemi etici ed antropologici , mettendo da parte la ricerca del principio e della cosmogonia . Socrate non scrisse mai nulla e così per ricostruire il suo pensiero dobbiamo ricorrere ad altri autori . Le fonti principali sulla vita di Socrate sono quattro 1) Platone 2)Senofonte 3)Aristotele 4)Aristofane . 1) Platone è senz’altro la fonte più attendibile : egli fu discepolo diretto di Socrate e con lui condivise sempre l’idea della filosofia come ricerca continua . Senofonte è la fonte più banale e meno interessante : il Socrate degli scritti di Senofonte è un cittadino ligio alla tradizione , il vero interprete dei valori correnti , il saggio che mira al bene dei suoi concittadini ed è ossequioso verso la città e le sue divinità . Va subito precisato che Senofonte era un grande generale , coraggioso e valoroso , ma non era certo un’aquila : i suoi scritti stessi non sono certo esempi eclatanti della letteratura greca : sono ridondanti e ripetitivi . Senofonte fece anche campagne militari con Socrate e nei suoi scritti ne esalta il valore dicendo che non stava mai fermo , era sempre in azione , non soffriva niente (camminava addirittura a piedi nud sul ghiaccio) . A Senofonte della filosofia non gliene importava nulla e con Socrate , di cui era grande amico , non trattava mai argomenti filosofici , ma solo militari : questo ci consente di capire che Socrate modulava il discorso a seconda del personaggio che aveva di fronte : con un filosofo parlava di filosofia , con un generale di guerra . 3) La testimonianza di Aristotele è stata a lungo ritenuta la più attendibile perchè Socrate non viene caricato di significati simbolici : Aristotele ce ne parla in modo oggettivo . Tuttavia la testimonianza aristotelica ha dei limiti : in primis , è la meno ” artistica ” delle 4 ed è l’unica di un non-contemporaneo . Va poi detto che in Aristotele Socrate ci viene presentato quasi come un ” robot ” : la filosofia socratica viene presentata come un susseguirsi di ragionamenti e non viene dato spazio al filosofare in pubblico , al dialogo aperto . 4) Aristofane è il personaggio più vicino a Socrate come età : ci presenta un Socrate relativamente giovane (circa 40 anni) . Va ricordato che Aristofane era un commediografo e ne risulta che l’immagine che lui ci dà di Socrate è fortemente impregnata di tratti sarcastici . Ne ” Le nuvole ” ce lo presenta come un sofista studioso della natura (il contrario di ciò che era in realtà) , con la testa fra le nuvole . Insomma Aristofane è l’unico a darci di Socrate un’immagine fortemente negativa (non a caso Aristofane era stato uno dei primi accusatori di Socrate) . In realtà non dobbiamo pensare che Aristofane volesse gettar discredito su Socrate o lo prendesse in giro per cattiveria : in fondo lui faceva solo il suo lavoro di commediografo , che consisteva nel far ridere . In realtà con la figura di Socrate vuole prendere in giro non Socrate , ma l’intera categoria dei filosofi . La testimonianza di Platone resta la migliore e le altre tre vanno sfruttate come appoggio . Platone lo conosceva davvero bene ed era lui stesso un gran filosofo : il grosso limite è che trattandosi di un filosofo , Platone avrebbe potuto rimaneggiare i discorsi di Socrate , ed è proprio quel che fa man mano che invecchia . ” L’apologia ” , per fortuna , resta un dialogo giovanile nel quale Platone descrive il processo che decretò la condanna a morte di Socrate . E’ proprio in questo dialogo che emerge fortemente la differenza tra Socrate ed i sofisti : i sofisti pronunciavano discorsi raffinati ed eleganti , ma totalmente privi di verità : per loro l’importante era parlar bene , avere un buon effetto sulle orecchie degli ascoltatori . Per Socrate invece quel che più conta è la verità : lui si proclama incapace di controbattere a discorsi così eleganti e ben formulati (ma falsi) . Socrate , pur non tenendo un’orazione raffinata , dice il vero : la critica ai sofisti verrà poi ripresa da Platone stesso . I sofisti puntavano a stupire l’ascoltatore , dal momento che erano convinti che la verità non esistesse (soprattutto Gorgia . Socrate per difendersi in tribunale non pronuncia un discorso (come i sofisti) , ma imposta un dialogo botta e risposta : è proprio dal discorso che viene a galla la verità (Platone dirà che il discorso tra due o più individui è come lo scontro tra due pietre dal quale nasce la fiamma della conoscenza) . Lo stile oratorio di Socrate è scarno , secco e quasi familiare , modulato a seconda dell’interlocutore . Il punto di partenza del discorso socratico è la cosiddetta ” ironia socratica ” , ossia la totale autodiminuzione , ” io non so , tu sai ” . Così inizia anche ” L’apologia” : si pone la domanda “che cosa è x ?” e l’interlocutore cade nel tranello e risponde , sentendosi superiore a Socrate . Socrate , come abbiamo detto parlando di Senofonte , parla di argomenti noti all’interlocutore : se ad esempio parla con un generale gli chiederà ” che cosa è il coraggio ? ” . Quello risponderà , per esempio , dicendo che il coraggio è il non indietreggiare mai . Allora Socrate interverrà dicendo che quello non è coraggio , bensì pazzia . La critica diventa stimolo per l’interlocutore a fornire una seconda risposta meglio articolata : il gioco può andare avanti a lungo e spesso rimane aperto . Questo metodo viene detto ” maieutico ” : Socrate diceva di fare lo stesso lavoro della madre , la quale era ostetrica : lei faceva partorire le donne , lui le anime . Come le ostetriche valutano se il neonato è ” buono ” , così Socrate valuta se le idee , le definizioni sono buone . Non tutti gli interlocutori erano intelligenti e riconoscevano i propri errori : spesso preferivano evitare Socrate . Da un interlocutore Socrate fu anche denominato ” torpedine ” in quanto l’incontro con Socrate risulta scioccante perchè ribalta le concezioni di chi era convinto di sapere e dimostrava che in realtà non sapeva . Socrate stesso si paragonava ad un moscone che stimola il cavallo : lui stimolava gli uomini a ragionare . Socrate con il processo dell’autodiminuzione afferma di non sapere nulla , mentre sostiene che i sofisti sappiano tutto : dice che forse l’educazione che impartisce lui è inutile rispetto a quella sofistica , ma senz’altro è più importante . Le calunnie nei confronti di Socrate hanno avuto inizio quando lui si definiva sapiente in quanto l’oracolo di Delfi gli aveva detto che era il più sapiente tra gli uomini . Lui era rimasto sconvolto da tale affermazione e non riusciva a crederci : allora cominciò a girare per Atene per vedere se trovava persone effettivamente più sapienti di lui . Dunque si recò da coloro che si ritenevano sapienti : politici , poeti , artigiani . Socrate si accorse che tutte e tre le categorie erano convinte di sapere , ma in realtà non sapevano niente : i politici erano i peggiori di tutti non in quanto politici (Socrate stesso , se vogliamo , era un politico perchè svolgeva la sua attività in pubblico) ma in quanto non capaci di insegnare il loro sapere : un vero sapiente deve spiegare ciò che sa : anche i politici migliori (Pericle) non sanno trasmettere il loro sapere . Lo stesso era per i poeti , che a partire da Omero erano considerati sapienti ed educatori : Socrate li biasima sia perchè dicono assurdità , sia perchè il loro non è un sapere , ma una forma di ” follia ispirata ” : era la divinità che parlava per bocca loro . I meno peggio risultarono essere gli artigiani , che almeno sapevano fare diverse cose di utilità pubblica : la loro è una ” tecnè ” , ossia una sapienza pratica . Però anche gli artigiani avevano i loro difetti : erano sì competenti nel loro settore , ma peccavano di presunzione perchè erano convinti che la loro conoscenza fosse universale ed illimitata , anzichè limitata . Inoltre essi agivano senza pensare e ponderare . Socrate arrivò alla conclusione che l’oracolo di Delfi aveva ragione : lui stesso è il più sapiente , pur sapendo di non sapere . Il suo non va interpretato come atteggiamento di rinuncia alla ricerca della verità , ma come segno di modestia intellettuale : è proprio il fatto di essere consapevoli della propria conoscenza che spinge l’uomo a sforzarsi di raggiungere la conoscenza ; se si è convinti di sapere già tutto non ci si sforzerà di migliorare . Tra le varie accuse che vengono mosse a Socrate c’è anche quella di corrompere i giovani nella piazza rendendoli peggiori : lui ribatte a questa accusa dicendo che non avrebbe motivo di fare ciò . Infatti se corrompesse i giovani finirebbe per vivere in una città di giovani corrotti , il che si ritorcerebbe contro lui stesso . Va senz’altro ricordato il cosiddetto ” intellettualismo etico ” di Socrate : secondo lui nessuno può compiere il male sapendo effettivamente di compierlo : nessuno potrebbe mai fare del male volontariamente . Un rapinatore rapina non pensando di fare del male , ma di fare del bene : è un errore intellettuale ritenere bene ciò che è male . E’ un atteggiamento tipicamente cristiano-cattolico che si possa scegliere tra bene e male indistintamente . Dunque Socrate introducendo l’intellettualismo etico dimostra di aver agito per il bene della sua città . E’ Socrate che ha scoperto il concetto moderno di anima ( ψυχη ) : in precedenza significava ” soffio vitale ” , ciò che fa vivere le cose ; il termine ψυχη assunse poi il significato di ” immagine nell’Ade ” , un’esistenza depotenziata . Per gli Orfici significava ” demone ” . A partire da Socrate fino al giorno d’oggi l’anima è diventata il nostro io : ci identifichiamo con l’anima . Secondo Socrate possiamo dividere i beni ed i mali in tre categorie a) dell’anima b) del corpo c) dell’esterno . Il corpo è lo strumento nonchè la prigione dell’anima . Il denaro , per esempio , è un bene esterno . In alcuni frangenti sembra che Socrate (e anche Platone ) rifiuti i beni materiali e del corpo , scegliendo quelli dell’anima ; in altre occasioni pare che possano essere accettati entrambe . Socrate , per esempio , pare che non disprezzasse il vino . Quest’ambiguità tra beni del corpo e beni dell’anima può essere spiegata affermando che i beni son tutti beni finchè non entrano in conflitto con altri : la ricerca del piacere fisico diventa un male quando la si antepone alla ricerca di quello intellettuale . Questo non vale solo per i beni , ma anche per il rapporto tra anima e corpo : il corpo per Socrate e Platone non va disprezzato , anzi va apprezzato perchè serve all’anima . Per il Cristianesimo la ricchezza è un male , per Socrate e Platone è un bene finchè non entra in conflitto con gli altri beni . Interessante è il concetto socratico di ingiustizia : essa non danneggia chi la subisce , ma chi la commette . La giustizia infatti dà un senso di piacere interiore e chi è ingiusto perde questo piacere , mentre chi subisce l’ingiustizia continua a provarlo . Questo vale anche per Platone . Tra le cose che Socrate dice di non sapere vi è la conoscenza dell’aldilà , di cosa c’è dopo la morte ( Platone dirà di essere in grado di dimostrare l’esistenza di un aldilà) . Per lui non è che se si vive una vita giusta si sarà premiati : si è già appagati dal vivere giustamente , la felicità che si prova perchè si è giusti è già una sorta di premio : Socrate dice che magari potrebbe esserci una vita ultraterrena , ma lui non lo sa . Tra le varie accuse rivolte c’era anche quella di ateismo e di empietà : Socrate infatti credeva nei demoni , che lui proclamava ” figli delle divinità ” . Lui dimostra che è un’accusa sbagliata dicendo che se crede nei demoni che sono figli delle divinità , è ovvio che creda anche nelle divinità : perchè ci sia il figlio (demone) , ci devono anche essere il padre e la madre (le altre divinità) . Ma che cosa era questo demone ? Abbiamo due testimonianze divergenti : per Platone era una sorta di angelo custode – coscienza personale che interveniva ogni qual volta Socrate stesse per sbagliare : si tratterebbe di una sorta di ” aiuto privilegiato ” che non tutti hanno : solo le persone per bene . E’ un dono divino per i buoni . E’ come se la divinità partecipasse alla vita umana . Per Senofonte invece il demone è un’entità che lo spinge ad agire in determinati modi : Senofonte intende ancorare fortemente Socrate alla credenza in un ordine divino e in un intervento divino nella vita umana . Per Socrate l’importante non è vivere , ma vivere bene : quando la nostra anima è sana , giusta , allora anche noi stiamo bene . Sempre Senofonte nei ” Detti memorabili ” riassume la prova dell’esistenza di Dio formulata da Socrate in questi termini : ciò che non è opera del caso postula una causa intelligente , con particolare riguardo al corpo umano che ha una struttura organizzata non casuale . Per questa sua origine l’uomo è ritenuto superiore a tutti gli altri animali ed è oggetto dell’interesse di Dio , come si deduce anche dalla possibilità di conoscere i suoi progetti sull’uomo ricorrendo all’arte della divinazione . Va notato che il Dio socratico ( inteso come intelligenza finalizzatrice ) è una sorta di elevazione a entità assoluta della psychè umana . Molti hanno notato che gli accusatori non volevano in realtà condannarlo a morte , ma semplicemente zittirlo . Ma Socrate non può accettare di essere zittito : il suo destino è andare in giro a colloquiare con la gente . Vivere bene per Socrate significa svolgere quest’attività e non rifiutare di essere colpevole significava non far perdere significato alla sua vita . Dal momento che era già vecchio e gli restavano pochi anni di vita , tanto valeva farla finita lì , ma non rinunciare ai suoi ideali . Mentre la ricerca di Platone si spingerà in un’altra dimensione , quella di Socrate rimane saldamente ancorata al mondo terreno : la sua mIssione è far capire ai cittadini ciò che fanno . In Socrate vi è poi un rifiuto della politica (che peraltro troveremo anche in Platone ) : fa infatti notare che lui stesso aveva avuto parecchi problemi con la politica : prima contro di lui si erano scagliati gli oligarchici , ed ora i democratici (nell’accusa ai danni di Socrate si possono scorgere istanze politiche : lui era un aristocratico e i democratici volevano punirlo ) . Pur avendo problemi con la politica , Socrate non dice che vada abolita . Prima dell’esecuzione della pena capitale , a Socrate era stata presentata la possibilità di evadere dal carcere , ma lui si era rifiutato : in lui infatti vi era il massimo rispetto per la legge , che non si deve infrangere in nessun caso . La legge può essee criticata , ma non infranta : di fronte ad una legge ingiusta non bisogna infrangerla , ma bisogna battersi per farla cambiare . Socrate afferma che sarebbe stato suo dovere far cambiare la legge e che non essendoci riuscito è giusto che lui muoia . Gli Ateniesi son convinti di essersi liberati di Socrate avendolo eliminato fisicamente , ma in realtà per liberarsene completamente avrebbero dovuto ” ucciderlo filosoficamente ” , batterlo a parole . In realtà volevano farlo tacere , ma han sortito l’effetto opposto : Platone infatti , che era intenzionato a dedicarsi alla vita politica , resterà sconvolto per condanna del maestro e si dedicherà alla filosofia . In Socrate vi è una vaga idea di provvidenza divina , ma non collettiva , bensì individuale : la divinità aiuta solo i migliori . Celeberrima è la conclusione dell’ Apologia , in cui Socrate si rivolge ai suoi discepoli prima di essere giustiziato : ” Ma ormai è ora di partire : io verso la morte , voi verso la vita . Chi di noi cammini a una meta superiore è oscuro a chiunque : non al mio dio .” Nel ” Simposio ” di PlatonePlatone Alcibiade afferma che Socrate non assomiglia a nessuno degli uomini del passato e del presente : è una figura nuova . Non si interessa di politica , ma non la disprezza , non rifiuta i festini , ma non vi si identifica ( nel ” Simposio ” tutti i convitati si addormentano , Socrate no ) . Soffermiamoci ora maggiormente sulla tecnica discorsiva di Socrate : la confutazione è la tecnica che dimostra l’inconsistenza del sapere dei propri interlocutori . Ma per arrivare a questo risultato bisogna partire dal metodo delle domande e delle risposte . ” Che cosa è la giustizia ? ” può essere il punto di partenza per il dibattito : porre questa o qualsiasi altra domanda del genere significa richiedere la definizione delle cose in questione , che però deve essere valida per tutti i casi particolari . In questo senso la ricerca di Socrate è stata interpretata da Aristotele come ricerca dell’universale , nell’ambito dei concetti e dei problemi morali . Gli interlocutori di Socrate si dimostrano incapaci di rispondere correttamente alla domanda sia perchè sottovalutano Socrate (che dice di essere inferiore) sia perchè rispondono citando casi particolari , anzichè la definizione universale . Abbiamo già citato il caso della domanda ” Che cosa è il coraggio ? ” : rispondere ” non inditreggiare mai ” è sbagliato , così come dire ” assalire il nemico ” : si può essere coraggiosi anche nell’affrontare una malattia o un’interrogazione : una definizione corretta deve coprire tutti i casi possibili . Nella sua funzione negativa il metodo delle domande e risposte si caratterizza come confutazione , ossia dimostrazione della falsità o contradditorietà delle risposte date dall’interlocutore . Gli effetti prodotti dall’esercizio di questo metodo sono paragonati a quelli della torpedine marina , che intorpidisce coloro che tocca . Di fronte alla confutazione si può reagire rifiutandola , come fanno vari interlocutori di Socrate . Ma , se la si accetta , essa può liberare dalle false opinioni che si hanno sui vari argomenti e agire dunque come una forma di purificazione . La situazione , che risulta dalla confutazione , è detta απορια , ossia letteralmente situazione senza vie di uscita . Essa consiste nel rendersi conto che i tentativi sin qui percorsi di rispondere a un determinato problema , hanno condotto a un vicolo cieco . Ma in questa nuova situazione , liberi dal falso sapere e soprattutto dalla presunzione di sapere , ci si può accingere alla ricerca del vero sapere , tentando nuove stade che possano condurre ad esso . In questo nuovo orientamento il metodo delle domande e risposte può assolvere una funzione positiva . Essa è paragonata alla funzione svolta dalla maieutica , capace di far partorire ad ognuno , mediante domande opportunamente indirizzate , la verità , di cui ciascuno è gravido . Socrate si ostina incessantemente a far convergere i propri interlocutori nell’ammissione di un punto fondamentale : per saper agire bene , cioè virtuosamente , in un determinato ambito , occorre possedere il sapere che renda capaci di ciò . A questo risultato egli perviene mediante l’analogia con le tecniche : il buon artigiano che sa svolgere bene la propria attività possiede un sapere capace di guidarlo a questo risultato . La stessa cosa deve valere in ambito etico-politico : questo è il nocciolo della famosa tesi secondo cui la virtù è scienza . Questa tesi conduce ad alcune conseguenze . In primo luogo , chi conosce che cosa è bene e quindi anche che cosa è buono per lui non può non farlo . Il bene è dotato di un potere incontrastabile di attrazione . Ciò non significa che Socrate disconosca l’importanza delle passioni e delle emozioni nella vita umana , ma soltanto che in ogni ambito della vita umana l’unico strumento capace di orientare verso il comportamento corretto è ravvisato nel sapere . La posizione etica di Socrate non va confusa con forme di rigorismo ascetico . Essa è invece definibile come una forma di eudemonismo , perchè pone come obiettivo fondamentale il perseguimento della felicità (in Greco ευδαιμονια ) . E’ il sapere che è in grado di effettuare un corretto calcolo degli stessi piaceri , misurando le conseguenze piacevoli o dolorose che essi possono arrecare . Questo è il sapere , di cui Socrate dichiara di non essere in possesso , ma proprio per questo è il sapere che egli persegue . Non ha senso allora distinguere le varie virtù nettamente le une dalle altre : la virtù è una , come uno solo è il sapere in cui esse si compendiano : sapere che cosa è bene e che cosa è male .
FEDONE
 A cura di Marco Machiorletti
A cura di Marco Machiorletti
Fedone di Elide, degli Eupatridi, fu catturato insieme con la caduta della sua patria e venne costretto a stare in una casa di malaffare. Egli riuscì ad allacciare i contatti con Socrate, e, dietro incitamento di quest’ultimo, Alcibiade, Critone e i loro amici lo riscattarono. Da allora, nuovamente libero, cominciò a dedicarsi alla filosofia. Fedone scrisse dialoghi, fra cui Zopiro e Simone. Diogene Laerzio nelle sue Vite dei filosofi menzionò anche altri titoli, però disse espressamente che alcuni non li ritenevano autentici.
Il nostro filosofo, a cui Platone dedicò l’omonimo dialogo, fondò una scuola nella nativa Elide.
Le testimonianze indicano che egli seguì due direzioni nella sua speculazione.
Il sillografo Timone lo accomuna a Euclide di Megara e sembrerebbe considerarlo, come Euclide stesso, un erista-dialettico.
Da altre fonti, in modo più determinato, risulta invece che Fedone si sia occupato prevalentemente di etica.
Nel suo Zopiro egli sosteneva che il logos (il logos socratico) non trova alcun ostacolo nella natura dell’uomo, nel senso che esso è in grado di dominare anche i caratteri più ribelli e i temperamenti più passionali.
Zopiro era un «fisiognomista»; egli riteneva di saper ricavare dalle fisionomie degli uomini il loro carattere morale. Basandosi sui tratti del volto di Socrate, egli sentenziò che il filosofo doveva essere un vizioso, suscitando la generale ilarità; ma fu proprio Socrate a difendere Zopiro, spiegando che tale egli era stato veramente, prima che il suo logos filosofico lo trasformasse.
Una conferma che tale fosse la tesi di fondo sostenuta da Fedone si trova anche in una lettera dell’imperatore Giuliano:
“Fedone riteneva che non ci fosse nulla di incurabile per la filosofia, e che in virtù di essa tutti potessero distaccarsi da tutti i generi di vita, da tutte le abitudini, da tutte le passioni e da tutte le cose di questo genere. Ora, se la filosofia avesse potere soltanto sugli uomini ben nati e ben educati, non ci sarebbe niente di straordinario in essa: ma che essa sappia portare verso la luce uomini che giacevano in siffatto stato [allusione allo stato di abiezione in cui era caduto Fedone], mi pare veramente essere prodigioso” (Giuliano, Epistola, 82, 445).
È evidente che Fedone approfondì un punto della filosofia socratica di cui aveva direttamente sperimentato l’efficacia. Infatti, come abbiamo visto, il logos di Socrate era stato capace di liberarlo dalla bassezza in cui era caduto restando prigioniero in una casa di malaffare.
La scuola di Elide ebbe breve durata.
A Fedone successe Plisteno, nativo di quella stessa città, il quale non impresse alcuno sviluppo alla Scuola che di fatto si esaurì.
In effetti, già una generazione più tardi, Menedemo e Asclepiade trasferirono la Scuola da Elide a Eretria.
PLATONE: Introduzione

Per guardare gli approfondimenti su Platone, cliccare qui
MAXI RIASSUNTOPlatone nacque ad Atene nel 427-428 a.c.e morì nel 348-347 circa : si è a lungo discusso sul suo soprannome ( Platone , infatti, é solo un soprannome , in quanto il vero nome era Aristocle ): si è concordi sul fatto che derivi dall’aggettivo greco “platùs” (ampio).Vi è chi sostiene che l’aggettivo vada attribuito alla larghezza e alla fluità del suo stile , chi è invece del parere che sia dovuto alla sua fronte particolarmente ampia e chi sostiene che fosse un soprannome datogli dal suo insegnante di ginnastica a causa dell’ampiezza delle sue spalle. Pur essendo un autore di circa 2400 anni fa ,egli affronta problemi che possiamo accomunare a quelli dei giorni nostri:la sua è un’ epoca di passaggio tra oralità e scrittura e lui è il primo ad affrontare questo problema.Di Platone possediamo praticamente tutte le opere(probabilmente molte gli sono attribuite pur non essendo effettivamente sue),ma paradossalmente egli stesso ci dice che la vera filosofia è solo orale.All’inizio del 1800 un teologo luterano di nome Schleirmacher effettuò un gran lavoro sulle opere di Platone ignorando però totalmente quanto abbiamo appena detto:egli esaminò infatti la filosofia platonica con il mezzo del “sola scriptura”(solo mediante la scrittura:era un celebre motto di Lutero):non si curò assolutamente del fatto che per Platone la filosofia fosse solo orale,rifiutando tra l’altro di servirsi di scritti non realmente platonici.Il teologo luterano ebbe però il merito di introdurre un altro metodo per esaminare la filosofia platonica:si trattava del sistema ermeneutico (la parola deriva da Hermes,messaggero ed interpretatore divino;in Italiano la parola ha assunto il significato di “tecnica dell’interpretazione”):era (ed è) infatti difficile definire la filosofia platonica,in quanto non ci troviamo di fronte ad un sistema,ma ad un insieme:il “corpus” platonico,come quello dell’Antico e del Nuovo Testamento,è costituito da una molteplicità di libri;la tecnica dell’ermeneutica consiste nel riuscire a contestualizzare un testo,al fine di comprenderlo,servendosi delle nozioni generali,in questo caso,della filosofia platonica:è come quando leggiamo un articolo di giornale;in realtà non partiamo proprio da zero e tramite la lettura dell’articolo ampliamo le nostre conoscenze.Platone fu discepolo del celebre Socrate e visse in prima persona l’ingiusta condanna del maestro (della quale si fa portavoce nell’ Apologia ):nasce proprio da questa esperienza la filosofia platonica.Egli rimane profondamente deluso dalla politica:prima vi era stato il governo filo-spartano dei Trenta Tiranni,di cui era membro niente meno che il suo stesso zio Crizia:Platone rimase deluso dal loro dominio dispotico e violento.Delusione e sfiducia gli procurò anche la democrazia restaurata,che nel 399 mandò a morte Socrate (in parte si trattava proprio di una condanna politica: Socrate era infatti un aristocratico e pur avendolo accusato di empietà e di corrompere i giovani,il vero motivo della condanna era di origine politica : i suoi “seguaci” ,mentre attendeva in carcere il giorno dell’esecuzione,prepararono un piano per farlo evadere,ma lui si rifiutò di compiere tale azione perchè era del parere che fosse un grande errore violare la legge : egli aveva infatti gran rispetto per la legge , che a suo avviso poteva essere criticata ma non infranta;quindi di fronte ad una legge ingiusta non bisogna reagire infrangendola,bensì battersi per farla modificare in meglio : e Socrate si accusa proprio di non essere riuscito a fare questo). Il tema della condanna di Socrate viene da Platone affrontato anche nel ” Critone ” , dialogo che prende il nome da Critone , un agiato ateniese coetaneo di Socrate e , come ci dice Senofonte , suo discepolo devotissimo . La scena si svolge nel carcere in cui Socrate deve soggiornare in attesa della morte . Critone cerca di persuadere Socrate ad evadere : tenta di convincerlo dicendo che se non fuggirà la gente biasimerà i suoi amici per non averlo aiutato ; Critone dice poi che tutte le difficoltà pratiche che la fuga comporta sono superabili e che rimanendo in carcere Socrate danneggerà se stesso , i figli e gli amici . Poi prende la parola Socrate , che si ostina a preferire la permanenza in carcere : a sua difesa dice che la vita di un uomo deve essere coerente con le sue dottrine : la legge non va violata in nessun caso : Socrate ha sempre rispettato le leggi e non vuole violarle proprio ora : è ormai vecchio e trasgredire le leggi dopo aver condotto una vita corretta , il tutto per vivere solo i pochi anni di vita che gli resterebbero , sarebbe un’assurdità , un’incoerenza . Il problema di fondo è se evadere sia giusto oppure no : per Socrate chiaramente non lo è , e commettere ingiustizia è gravissimo e più dannoso per chi la commette che non per chi la subisce . Socrate pronuncia poi una celeberrima frase : non bisogna tenere in massimo conto il vivere come tale , bensì il vivere bene , ed il vivere bene è lo stesso che il vivere con virtù e con giustizia . Se non avesse vissuto tale esperienza probabilmente si sarebbe dedicato ad attività di tutt’altro genere;egli infatti era aristocratico sia per origini sia per orientamento politico ed è proprio alla vita politica che egli si sarebbe dato se non avesse vissuto la condanna politica del suo maestro.La politica,tuttavia,è una componente che sarà sempre in qualche modo presente nelle sue opere . Perchè Platone amasse tanto l’oralità e il dialogo è facile intuirlo:il dialogo presenta parecchi vantaggi tra i quali la possibilità di interloquire e di modulare il discorso in base a chi ci si rivolge:un libro,invece,non consente un dibattito e può finire nelle mani di persone che potrebbero fraintenderlo;Platone stesso dice che c’è un aspetto che accomuna scrittura e pittura:le immagini dipinte si presentano quasi come se fossero vive,ma se si chiede loro qualcosa,chiaramente,tacciono;lo stesso vale anche per i discorsi scritti:si può quasi avere l’impressione che parlino,ma se si chiede loro di spiegare qualcuno dei concetti che hanno espresso,essi non rispondono.Tuttavia,come abbiamo detto,egli stesso ha scritto molto(sotto il suo nome ci sono giunti 35 dialoghi e 13 lettere,la cui stesura viene generalmente suddivisa in 3 periodi della sua lunga vita:la giovinezza,la maturità e la vecchiaia).Che funzione aveva dunque la srittura per Platone?Egli,pur prediligendo apertamente l’oralità,sente il bisogno di scrivere(probabilmente anche dettato dal periodo di transizione in cui viveva)e la scrittura svolge per Platone principalmente due ruoli:uno propagandistico,vale a dire cercare di invogliare alla filosofia,l’altro rammemorativo,cioè far ricordare la filosofia a chi già l’ha vissuta(ad esempio le persone anziane).Si può quindi dire che anche la scrittura avesse una sua utilità,pur non essendo un “filosofare”pieno:in una sua opera Platone la definisce “un gioco serio”,vale a dire un passatempo piu’ intelligente di molti altri.Egli argomenta in favore dell’oralità in un mito di ambientazione egizia,simbolo per i Greci di una grande civiltà:il protagonista è Teuth,divinità della scrittura e della saggezza.Egli è un inventore dalle grandi abilità e presenta le sue scoperte al faraone che le promuove sempre con entusiasmo;quando però Teuth propone l’invenzione della scrittura,spiegando che serve a ricordare,il faraone non approva,sostenendo che,al contrario,sortirebbe l’effetto opposto:mettendo le cose per iscritto,infatti,non è più necessario ricordarle.Proprio nel ricordare consisteva la sapienza:le posizioni del faraone possono un pò identificarsi con quelle di Platone.E’ un’evidente difesa dell’oralità mediante un mito platonico,inventato di sana pianta,cosa che per altro Platone faceva spessissimo.Può sembrare strano che un filosofo,che per definizione è chi cerca di dare spiegazioni razionali e scientifiche,si serva del mito,che non è nient’altro che una spiegazione fondata sulla tradizione e sulla religione:la verità è che per Platone il mito è una cosa al di fuori del comune,che ha ben poco a che fare con la tradizione.Egli sapeva bene che l’argomentazione razionale era migliore,ma sapeva altrettanto bene che un mito,una favola o una metafora possono sortire ottimi effetti:stimolano la fantasia,divertono e restano meglio impressi.Platone se ne serve dunque come arma impropria dell’intelletto.Inoltre è convinto che si possa dimostrare l’immortalità dell’anima,ma non razionalmente:si serve cosi’ di miti esplicativi,detti escatologici:non a caso si parla di “fede razionale”di Platone.Egli sfrutta inoltre i miti per descrivere particolari livelli della realtà:aveva in mente come una scala che vedeva il suo fulcro intorno all’essere,che corrispondeva al pieno livello di conoscenza(è pienamente conoscibile solo una cosa che è,che esiste pienamente):più ci si allontana dall’essere(sia più in alto,sia più in basso) e più la conoscenza diventa inferiore.Una cosa non pienamente conoscibile non è pienamente razionale ed il modo migliore per parlarne è il mito.Un mito molto interessante è quello raccontato nel “Fedro” ,una dei dialoghi più conosciuti:Platone tratta qui un argomento non pienamente raggiungibile con la ragione,anche se il nucleo è alquanto razionale:racconta dell’esistenza dell’anima e dell’incarnazione.Per Platone l’anima è una biga trainata da cavalli alati:essa è composta da tre elementi:un auriga e due cavalli.Nell’esistenza prenatale le anime degli uomini stavano con quelle degli dei nel cielo,con la possibilità di raggiungere un livello superiore,l’iperuranio,una realtà al di là del mondo fisico che si riconnette alla celeberrima teoria delle idee,che esamineremo in seguito,secondo la quale vi erano due livelli di realtà:il nostro mondo e le idee.L’auriga impersonificava l’elemento razionale,mentre i cavalli quelli irrazionali:ciò significa che la nostra anima è per Platone costituita da elementi razionali ed irrazionali.Dei due cavalli,uno,di colore bianco,è un destriero da corsa ubbidiente e con spirito competitivo,l’altro,nero,è tozzo,recalcitrante ed incapace:compito dell’auriga è riuscire a dominarli grazie alla sua abilità e alla collaborazione del bianco.Il nero si ribella all’auriga (la ragione)e rappresenta le passioni più infime e basse,legate al corpo.Il bianco rappresenta le passioni spirituali,più elevate e sublimi.Significa che non tutti gli aspetti irrazionali sono negativi e che è comunque impossibile eliminarli:si possono solo controllare con la “metriopazia”,la regolazione delle passioni.E’ una metafora efficace perchè è vero che guida l’auriga,ma senza i cavalli la biga non si muove:significa che le passioni sono fondamentali per la vita.Sta anche a significare che soltanto alla parte razionale,in quanto dotata di sapere,spetta il governo dell’anima.Anche le anime degli dei hanno i cavalli,ma solo bianchi.Lo scopo è arrivare all’altopiano dell’iperuranio:gli dei non incontrano particolari difficoltà,mentre le bighe delle anime umane hanno seri problemi perchè si creano ingorghi ed i cavalli neri tendono a volare nella direzione opposta,verso il basso.Accade spesso che le ali dei cavalli si spezzino e la biga precipiti sulla terra:questa è l’incarnazione.Una volta arrivato sulla terra,l’uomo non si ricorda più dell’altra dimensione,e vive con nostalgia:la vita dell’uomo non è nient’altro che un tentativo di tornare a quella situazione primordiale e le vie da percorrere per raggiungerla sono due,vale a dire la filosofia,che ci consente di vedere le ombre di quel mondo splendido,di cui quello terreno è solo un’imitazione,e la bellezza,una via più semplice,che fa nascere l’amore;se ha la meglio il cavallo bianco guidato dall’auriga l’amore assumerà connotazioni sublimi,se vincerà quello nero sarà un amore puramente fisico.La bellezza è una delle tante idee e filtra facilmente nel mondo sensibile perchè è coglibile per tutti grazie ad un senso,la vista.Secondo Platone per gli occhi degli innamorati intercorre un fluido che scorre fino al punto dove le ali dei cavalli s’erano spezzate cosi’ che si ricreano e si può tornare alla dimensione primordiale:il liquido che viene a contatto con l’ala spezzata le dà nuovo vigore facendola rispuntare;proprio quando essa sta ricrescendo,esattamente come i primi denti che spuntano,fa soffrire.Quando si è vicini alla persona amata,contemplandola scorre nuovo flusso che fa passare il dolore dell’anima alimentandola.Quando si è lontani dalla persona amata,invece,non arrivando più il flusso,le ali si inaridiscono e si seccano,accentuando il dolore e la sofferenza.Quindi l’innamorato farà di tutto per vedere il più spesso possibile la persona amata e solo in sua presenza starà bene.Il concetto di amore platonico che abbiamo oggi deriva dal medioevo e non è completamente corretto in quanto i Medioevali credevano che per un innalzamento spirituale non ci dovesse essere amore fisico;per Platone c’è una scala gerarchica dell’amore:nei gradini più bassi si trova l’amore fisico,ma per arrivare in cima ad una scala bisogna percorrere tutti i gradini.Per Platone l’anima ed il corpo hanno caratteristiche opposte:l’una è spirituale e legata all’Iperuranio,alla dimensione delle idee,mentre l’altro è puramente materiale,affine al mondo sensibile e terreno,e soprattutto è mortale.Mentre il corpo spinge l’uomo a cercare piaceri sensibili e di livello basso,l’anima lo induce a cercare piaceri sublimi e spirituali.Va senz’altro notato come Platone riprenda la teoria dei Pitagorici(e degli Orfici )secondo la quale il corpo è la prigione dell’anima(si giocava sulla parola greca “soma” che indica il corpo e “sema”,che indica invece la prigione).Il contrasto anima-corpo lo si affronta anche da un punto di vista gnosologico:il corpo talvolta ci aiuta a conoscere,talvolta ci ostacola:se si disegna un triangolo rettangolo e ci si ragiona,da un lato può essere un aiuto per passare all’astrazione e passare all’idea di triangolo,che è ben diversa dal triangolo disegnato che è solo un’imitazione mal riuscita,dall’altro può essere un ostacolo se ci si limita a ragionare su quel singolo triangolo senza passare al livello di astrazione.La principale differenza tra l’amore di oggi e quello dei tempi di Platone è che al giorno d’oggi abbiamo in mente un amore “bilanciato”,biunivoco,dove i due amanti si amano reciprocamente;ai tempi di Platone era univoco,uno amava e l’altro si faceva amare:nel mondo greco o l’uomo amava la donna o l’uomo amava l’uomo:l’omosessualità era diffusissima.Talvolta ci poteva essere un amore biunivoco,che Platone spiegava ricorrendo sempre alla teoria del flusso che intercorre tra gli occhi:secondo lui poteva venirsi a creare una situazione di “specchio”:in realtà l’amato vede negli occhi di chi lo ama se stesso perchè vede riflessa la propria bellezza;è una concezione mitica che rievoca i celeberrimi versi di Dante:”amor,ch’a nullo amato amar perdona…”:è come se chi è amato si innamorasse del sentimento stesso.Platone ci parla dell’amore(in Greco “eros”,che designa l’amore passionale ed irrazionale,diverso da “agapè”,l’amore puro)nel ” FEDRO “:in realtà gli argomenti trattati sono due:1)l’eros 2)la retorica.Quella di Platone,oltre ad essere un’epoca di passaggio tra oralità e scrittura,è anche un’epoca in cui emerge un importante quesito:come si fanno ad educare i cittadini?Vi era chi rispondeva che l’unica via era la filosofia(tra questi Platone stesso),e chi,come Isocrate,sosteneva che per tale funzione ci fosse la retorica.Platone,dunque,vuole argomentare in difesa della filosofia:le vicende si svolgono nella campagna circostante Atene,in una calda giornata estiva.Protagonista è Socrate ,che si potrebbe dire sempre presente nei dialoghi di Platone sebbene man mano che l’autore matura tenda a sfumare;Socrate in campagna si imbatte in Fedro,un suo discepolo che ama i bei discorsi a tal punto da trascriverli tutti.I due si siedono al riparo dal sole sotto un platano e Fedro mostra a Socrate un’orazione di Lisia,uno dei più grandi oratori greci,che si è appena trascritto:è un’orazione riguardante l’amore a carattere “sofistico”,si cercano cioè di dimostrare cose paradossali ed assurde:Lisia (va senz’altro notato come Platone ben riproduca lo stile lisiano)cerca di dimostrare come sia meglio concedersi a chi non ama:Lisia parte dal presupposto che l’amore sia una “follia” e che concedersi a chi ama è una stoltezza:si avrebbe un amore troppo “appiccicaticcio” che se mai si rompesse farebbe soffrire terribilmente l’innamorato-amante;poi dopo che è passato l’ardore iniziale si torna in sè e ci si rimprovera di esseresi comportati così da “rimbambiti” e si finisce per soffrire di continuo.Con una persona non amata è chiaro che ci si comporterebbe in tutt’altro modo:più che altro si penserebbe ad essere felici noi rispetto all’amato non amato . Socrate a sua volta imposta due discorsi:nel primo conferma la tesi lisiana,mentre nel secondo sostiene che il suo “demone”(una specie di coscienza personale-angelo custode che si fa sentire solo quando Socrate sta commettendo un errore) lo sta ammonendo,facendogli capire che sta clamorosamente sbagliando.Anche per Socrate l’amore è una follia,però,a differenza di Lisia,per lui è positiva:vi sono infatti follie dannose e negative,ma anche positive e benigne.Poi Socrate formula un nuovo discorso per farsi perdonare per quel che ha detto dal dio dell’amore (“Eros”).E’ difficile comprendere quale sia il tema centrale(l’amore?La retorica?);fatto sta che sono due argomenti strettamente connessi tra loro in quanto l’amore(l’eros)è una metafora per indicare la filosofia:questa stretta parentela Platone la esamina meglio nel “SIMPOSIO”(dal Greco sun+pino=bere insieme),il suo capolavoro : Socrate si sta dirigendo verso la casa del tragediografo Agatone quando incontra un amico;allora invita anche l’amico e quando sono ormai arrivati , Socrate comincia a riflettere intensamente.Durante i simposi (all’epoca non c’era la TV e le serate si trascorrevano cosi’)veniva nominato un simposiarca il cui compito era quello di dare un ordine alla discussione facendo passare la parola da un invitato all’altro e selezionare l’argomento da trattare.Si sceglie di parlare dell’amore:c’è chi dice che Eros è la divinità più giovane e più bella,chi dice che è la più vecchia in quanto forza generatrice di tutto,chi sostiene che sia una forza cosmica che domina la natura,chi suggerisce che sia un tentativo da parte di tutti gli enti finiti di eternarsi procreando,c’è chi è del parere che sia la divinità più valorosa in quanto riesce a dominare perfino la guerra,facendo riferimento all’episodio mitico secondo il quale Ares,il dio della guerra,sarebbe innamorato di Afrodite.Aristofane,celeberrimo commediografo,narra una storia semiseria:si tratta di un mito secondo il quale gli uomini un tempo erano tondi, sferici e doppi:questi esseri si sentivano forti e perfetti e peccarono di tracotanza;gli dei per punirli li tagliarono a metà e per ricucirli fecero loro un nodo(l’ombelico)sulla schiena;poi lo posizionarono sulla pancia perchè si ricordassero di quanto era successo ogni volta che guardavano in basso:questi esseri sentivano il bisogno di ritrovare l’altra metà e la cercavano disperatamente.Quando la trovavano si attaccavano e non si staccavano più neanche per mangiare e cosi’ morivano di fame;cosi’ gli dei crearono l’atto sessuale che consentiva di trovare un appagamento da questa unione.Questo mito originale ci spiega due cose:1)in ogni epoca i rapporti sessuali sono sempre stati etero e omo.2)il tentativo di ritornare ad una situazione primordiale.Notare che nel mondo greco la forma sferica è sempre vista come unità originaria perfetta( cosi’ era già in altri grandi filosofi quali Empedocle,Parmenide…).Se si leggono accuratamente tutti i discorsi ci si accorge che ognuno di essi contiene una parte di verità:il discorso finale di Socrate non sarà nient’altro che una sintesi in cui li unisce praticamente tutti.Egli racconta di essersi una volta incontrato con una sacerdotessa(Diotima)che gli ha rivelato tutti i misteri dell’eros:viene a proposito citato un mito riguardante i festeggiamenti divini per la nascita di Afrodite:tra le varie divinità ci sono anche Poros(astuzia,furbizia)e Penia(povertà).Essi,ormai ubriachi per l’eccessivo bere,si uniscono e viene cosi’concepito Eros,che ha quindi le caratteristiche dei suoi genitori:è ignorante,povero e brutto a causa di Penia,ma sa cavarsela sempre grazie a Poros.Non è bello,ma sa andare a caccia della bellezza;egli sente l’amore ed è soggetto della ricerca della bellezza e dell’amore,svolge le mansioni dell’amante e non dell’amato.Chiaramente se ricerca la bellezza significa che non la possiede:così il filosofo è privo e bisognoso del sapere (penia=povertà),ma ha anche le capacità di cercarsi e di procurarsi ciò di cui è privo (poros=astuzia,espediente);dato che Eros è privo di bellezza e le cose buone sono belle,manca anche di bontà;ciò che non è bello o buono,non è necessariamente brutto e cattivo;per Platone vi è un livello intermedio;tra il sapere e l’essere ignoranti la via di mezzo consiste nell’avere buone opinioni,senza però darne ragione;la posizione intermedia comunque non è un male perchè è uno stimolo per arrivare al top:chi si trova nella posizione più bassa sa di non potersi elevare e neanche ci prova,chi si trova in quella più alta non si deve impegnare perchè è già nella posizione ottimale:chi si impegna e lavora è chi si trova in una zona intermedia (i filosofi,che non sanno ma si sforzano di avvicinarsi al sapere).Tutti gli dei,gli aveva detto Diotima,sono belli e buoni e di conseguenza Eros non rientra nella categoria.Anche da questo punto di vista Eros riveste una posizione intermedia:non è un dio,ma neanche un mortale:è un qualcosa che nasce e muore di continuo;è una metafora con cui si vuole dimostrare che non si può mai possedere totalmente l’amore;è anche metafora della filosofia perchè l’uomo non possiede il sapere,ma si sforza per ottenerlo;può riuscire ad avvicinarvisi,ma non si tratta comunque di una conquista definitiva:il pieno sapere è irraggiungibile.Dunque Eros è una semi-divinità intermedia.Nella struttura sociale dell’epoca l’omosessualità era tipica dei filospartani e di coloro che avevano un’impostazione culturale arcaica:è questo il caso di Socrate e Platone.Il rapporto veniva vissuto “pedagogicamente”,vale a dire che era un rapporto di tipo maestro-allievo.A differenza dell’amore eterosessuale,di livello più basso in quanto volto al piacere fisico e alla procreazione materiale,quello omosessuale era di più alto livello in quanto volto alla procreazione spirituale:vengono fecondate le anime per procreare nuove idee.Propriamente in Socrate non si parlava di amore,ma vanno tenute in considerazione le affermazioni a riguardo della maieutica(Socrate diceva di fare lo stesso lavoro della madre che era un’ostetrica:lei faceva partorire le donne,lui le idee): Socrate aveva quindi già in mente anime gravide da far partorire;Platone invece sostiene che ci sia una vera e propria fecondazione delle anime,che chiaramente non devono essere sterili.Ben si intuisce che la ricerca dell’amore combacia con quella della filosofia.Alla fine del Simposio irrompe improvvisamente il famoso Alcibiade,totalmente ubriaco,che racconta pubblicamente di aver fatto delle “avances” a Socrate ,che però non ha accettato:lui,bello,giovane,aitante con un vecchio decrepito che non ci sta:il che sta a significare che la bellezza esteriore conta meno di quella interiore,ed è anche un modo per ribadire il concetto della scala gerarchica dell’amore. Socrate non ci viene presentato come un asceta:egli è totalmente immerso nella sua realtà,ma non si lascia catturare:ai festini lui partecipa tranquillamente,pur non identificandovisi;dagli altri si distingue perchè mantiene sempre la sua capacità di giudizio(nel Simposio è l’unico a non addormentarsi).Nella LETTERA 7°(non si è certi se sia realmente opera di Platone:la maggior parte delle lettere,infatti,sono false in quanto compaiono dottrine posteriori a quelle platoniche.Si è quasi sicuri sull’autenticità della Lettera 7° in quanto sono effettivamente presenti le ideologie platoniche e lo stile;a supportare ulteriormente questa tesi sta il fatto che non è mai successo che un falsario abbia inventato un genere tutto nuovo come questo:la lettera 7° infatti è una lettera “aperta” finalizzata a fare “pubblicità” alle ideologie platoniche ) vi è una sua autobiografia dove ci racconta anche di un incontro con il tiranno di Siracusa Dionigi.Nella mente di Platone è fortemente radicata l’idea che ci sarà un buon governo solo quando o i filosofi diventeranno re o i re diventeranno filosofi;proprio la conoscenza dell’idea del bene rende legittima l’attribuzione del governo ai filosofi(conoscere il bene significa conoscere ciò che rende buone le cose);a sua volta,il governo della città dipende dal buon uso del sapere.Per chiarire in che cosa consista questo uso del sapere Platone introduce nella “Repubblica” ,una sua celebre opera,il mito “della caverna”;egli paragona il processo conoscitivo,che attraversa i vari gradi sino a culminare nella conoscenza dell’idea del bene,ad un processo di liberazione da catene che ci tengono imprigionati nel fondo di una caverna sino all’uscita alla luce del sole:Dopo che ci si è liberati dai legami sensibili che tengono imprigionati nella caverna rischiarata artificialmente soltanto da un fuoco,si arriva soltanto lentamente ad abituarsi alla luce del sole.Il sole è appunto l’analogo del bene.Platone si capaciterà definitivamente che quello dei filosofi re o dei re filosofi è un progetto irrealizzabile (lo stato ideale per Platone non è quindi realizzabile su questa terra:è solo un’idea,e come tale appartiene al mondo intellegibile delle idee) proprio da questo incontro;Platone cercò di insegnare la filosofia a Dionigi ed il risultato che ottenne fu che il tiranno scrisse un libro dove spacciava per sue le idee di Platone,il quale si indignò parecchio e ribadi’ che la vera filosofia è solo orale,è un dibattito aperto tra due o più individui dal cui “scontro”,come da quello di due pietre,prende vita una fiamma,che rappresenta la conoscenza che coglie l’uomo:secondo Platone,talvolta, è la conoscenza che si impossessa dell’uomo;a volte,invece,si serve della metafora della caccia per indicare che l’uomo deve andare alla caccia del sapere.Platone per definire la filosofia,oltre a quella dell’eros,si serve di un’altra efficace metafora:paragona la filosofia alla medicina che con Ippocrate aveva raggiunto livelli elevati.Per Platone la filosofia è come una sorta di medicina per l’anima.Ma non si accontenta di dire questo e attacca ancora una volta la retorica affermando che la filosofia sta alla retorica come la medicina alla gastronomia.La medicina si occupa del corpo e la filosofia dell’anima:pure la gastronomia si occupa del corpo,come la retorica dell’anima.La medicina però si occupa del bene del corpo,mentre la gastronomia del piacere;cosi’ vale anche per la filosofia e per la retorica:una si occupa del bene dell’anima,l’altra del piacere.La filosofia fornisce all’anima un nutrimento piacevole e sostanzioso.La retorica le fornisce solo un piacere:sentire una persona pronunciare discorsi raffinati ed eleganti è senz’altro piacevole,ma se sono privi di verità(come nel caso della retorica,che è proprio l’arte del parlare)sono totalmente inutili.vi è quindi una distinzione tra bene e piacere,che non si identificano affatto tra di loro:contro l’identità bene-piacere vi sono diverse argomentazioni da parte di Platone,nessuna delle quali risulta però totalmente convincente;fatto sta che ad avere a che fare con il piacere sono principalmente le persone peggiori.Platone dice che il piacere può essere considerato bene nella misura in cui è razionalmente controllabile (pare,per esempio,che Socrate non disdegnasse il vino,ma che comunque sapesse regolarsi);il bene può infatti riuscire a controllare il piacere.Dunque il vero piacere è quello che viaggia di pari passo con il bene,senza separarsene:tuttavia bene e piacere non si identificano:il piacere in alcune sue forme può essere un bene,in altre un male.Quindi l’argomentazione in realtà si limita a dire che piacere e bene sono due cose distinte e che tuttavia dove c’è piacere non c’è necessariamente male.Il piacere non esiste mai “puro”:è sempre accompagnato dal dolore:nel “Gorgia”,un’altra grande opera platoniana,si fa addirittura notare che il piacere ed il dolore sono la stessa cosa:un caso con cui possiamo esemplificare ciò che intendeva Platone è quello della fame e della sete,entrambe forme di dolore;il dolore consiste nel provare la sete(o la fame) e il piacere nel soddisfare l’esigenza bevendo(o mangiando,nel caso della fame);se sparisce il dolore,sparisce anche il piacere.Per cui se sparisse la sete,è vero che non soffriremmo più,ma non proveremmo neppure più piacere.Un quesito che ha sempre crucciato l’uomo è quello di come si fa a sapere,a conoscere.I sofisti sostenevano ch e non si può imparare perchè o già una cosa la si conosce o non la si conosce:nel secondo caso è impossibile trovare una cosa che non si sa cosa sia,come sia fatta. Socrate stesso aveva detto che non si poteva insegnare,ma solo imparare tramite la maieutica,la tecnica con la quale faceva partorire le anime.Questo tema Platone lo affronta soprattutto nel “Menone”.Ancora una volta Platone assume una posizione intermedia,servendosi in parte delle affermazioni dei sofisti:se è vero quel che dicono i sofisti e uno dei loro più grandi esponenti,Gorgia,(cioè che non si può imparare e quindi neanche insegnare),si può ricordare:una cosa che ci siamo dimenticati e ci torna in mente,non possiamo dire di conoscerla ma neanche di non conoscerla.Dunque per Platone il processo attraverso il quale si impara e si conosce è puramente di rammemorazione(in Greco anamnesis).L’unico modo di considerare il sapere come “ricordare”è quello di fare una ipotesi piuttosto strana(ragionare per ipotesi significa vedere quale è la condizione che bisogna ammettere perchè si verifichi un determinato fatto):l’unica ipotesi per Platone valida è quella della preesistenza dell’anima.Nel Menone il corpo viene visto proprio come prigione dell’anima.Anche nel “Fedone”,dialogo ambientato nel periodo dopo la condanna e prima della sua morte,Socrate parla con due Pitagorici a riguardo della preesistenza dell’anima:egli li porta a capire la questione servendosi di esempi:tira in ballo la scienza dell’uomo e quella della lira,che sono evidentemente diverse tra loro; Socrate afferma che agli innamorati,nel momento in cui vedono una lira o un vestito che il loro amato è solito usare,succede quanto segue:riconoscono la lira e nel pensiero colgono l’idea del ragazzo a cui appartiene la lira:la reminescenza consiste proprio in questo,riuscire a ricordarsi cose tramite vari “agganci”,aspetti che stimolano il ricordo.Nel “Menone” Socrate parla con uno schiavo privo di cultura e gli pone una serie di domande mirate e legate al teorema di Pitagora ;chiaramente lo schiavo non lo conosce,ma Socrate ponendogli solo domande specifiche lo porta alla soluzione:è un tipico caso di maieutica.L’unica spiegazione possibile è che lo schiavo si ricordi di un qualcosa che già conosceva,ma aveva dimenticato:dato che non l’ha conosciuto nell’attuale vita significa che l’ha conosciuto in un’altra dimensione(l’altopiano dell’iperuranio).Tale dimenticanza è legata al momento dell’incarnazione:nella sua vita terrena l’uomo può avere momenti in cui ricorda.L’apprendimento è quindi interpretato come il recupero di conoscenze acquisite dall’anima prima di incarnarsi in un corpo,ma dimenticate al momento della nascita e rimaste latenti in essa.Si definisce giustamente Platone “INNATISTA”,perchè sostiene che quando nasciamo sono già presenti in noi alcuni elementi di conoscenza.Lo schiavo il teorema ce l’aveva già nella sua mente,si trattava solo di ricordarglielo.Quali sono dunque le vie per ricordare?Un modo,come nel Menone ,è avere qualcuno che ci aiuti(Socrate),un altro(più impegnativo)è usare bene la propria esperienza(come nel caso di Pitagora ,che per primo si ricordò con la sua esperienza del teorema che gli viene attribuito:in realtà lui non l’ha inventato,se l’è solo ricordato per primo).Oltre a sostenere la preesistenza dell’anima,Platone era anche convinto della sua immortalità e della sua eternità:l’anima è viva per definizione e un corpo è vivo o morto a seconda che abbia o meno un’anima;l’anima,quindi,dà e toglie la vita.E’ un qualcosa che partecipa all’idea di vita e che di conseguenza non può partecipare a quella di morte,come il numero 3 partecipa all’idea di dispari e non può partecipare a quella di pari.Per Platone ciò che può corrompere l’anima è l’ingiustizia;essa però non può distruggerla:se l’ingiustizia,che è il suo male peggiore,non è in grado di annientarla,è chiaro che neanche i mali minori ce la faranno.L’anima,essendo increata,è anche eterna ed immutabile.Per Platone vivere significa prepararsi alla morte perchè il distacco dell’anima dal corpo va preparato moralmente:bisogna liberarsi dalle passioni legate al corpo superandole (un pò come era per i Pitagorici e per gli Orfici :occorreva purificarsi).Dal punto di visto gnosologico,l’anima disincarnata coglie facilmente le idee nell’Iperuranio;in Platone compare la frase “omoios teo”,che significa ottenere un tale perfezionamento da diventare tutt’uno con la divinità : dice questo nel Teeteto dove dice testualmente che ” non è possibile che i mali scompaiano del tutto perchè è una necessità che ci sia sempre qualcosa di contrapposto al bene , nè possono avere sede tra gli dei , ma si aggirano nella natura mortale e in questo nostro mondo qui . E’ per questo che bisogna anche sforzarsi di fuggire di qui a lassù al più presto . E fuga è rendersi simili a Dio secondo le proprie possibilità : e rendersi simili a Dio significa diventare giusti e santi , e insieme sapienti ” . Va poi ricordato che Platone aveva identificato diversi livelli di conoscenza,i cui 2 più importanti sono quello della conoscenza sensibile (doxa),basato su un sapere sensibile,instabile e dettato dalle opinioni,e della conoscenza intellegibile (episteme),sicura,certa e basata su cause vere e proprie.A noi viene da pensare che la differenza tra la doxa e l’episteme ad esempio quando osserviamo un libro consista nel conoscerlo meglio o peggio;pensiamo che guardandolo si abbia una conoscenza sensibile e superficiale,mentre esaminandolo da un punto di vista geometrico se ne abbia una intellettuale.Platone invece è convinto che ad ogni livello di conoscenza corrisponda un oggetto preciso:non è che cogliamo il libro prima con i sensi e poi con l’intelletto.Per Platone dopo che esaminiamo attentamente il libro in modo sensibile,esso ci rievoca con le sue forme geometriche l’idea di parallelepipedo,che è totalmente differente dal libro stesso.Infatti il libro partecipa all’idea di parallelepipedo,cioè la imita,ma non lo è:quando in matematica si dimostra su un parallelepipedo disegnato,in realtà si dimostra sull’idea stessa di parallelepipedo:le regole di dimostrazione valgono per tutti i parallelepipedi perchè in realtà vanno riferite solo all’idea del parallelepipedo;d’altronde le misure che risultano dalla dimostrazione non potranno mai essere esattamente compatibili con quelle del nostro disegno:lo sono esclusivamente con quelle dell’idea (quando noi diciamo di disegnare un triangolo rettangolo,diciamo un’assurdità perchè è impossibile che un angolo risulti esattamente di 90°:in realtà esiste solo l’idea di triangolo rettangolo).Di conseguenza ci sono anche 2 soggetti conoscitivi:a conoscere il libro è la sfera del sensibile(il corpo),mentre a conoscere il parallelepipedo è la sfera dell’ intellegibile(l’anima).Tutto questo dimostra che vi è una stretta parentela tra l’anima e le idee,che non a caso Platone dice essere costituite dello stesso materiale metafisico ed entrambe eterne:vale a dire che sono immutabili.Che cos’è la dottrina delle idee?La parola “idea”,innanzitutto,deriva dalla radice greca “id-“che è a sua volta riconducibile al verbo “orao”,vedere:è quindi qualcosa che si può vedere ma non con gli occhi,bensi’ con l’intelletto;la percezione degli oggetti sensibili risveglia il ricordo delle idee dell’iperuranio,le quali permettono di misurare l’inferiorità e la deficienza degli oggetti sensibili rispetto ad esse.Cosi’ qualunque oggetto sensibile possa essere detto bello, non coincide mai con l’idea della bellezza nella sua perfezione ed immutabilità.L’idea di bellezza,per esempio, è il modello ed il criterio in base al quale possiamo denominare belli determinati oggetti:infatti è perchè già possediamo l’idea di bellezza che possiamo designare belli questi altri oggetti.Nei primi dialoghi Platone aveva presentato l’indagine di Socrate proiettata alla ricerca di definizioni ( un dialogo in cui troviamo un Socrate proiettato alla ricerca di definizioni é , per esempio , l’ ” Ippia Maggiore “ , che ruota tutto intorno alla ricerca del bello ),ossia di risposte corrette alla domanda:”Che cos’è x ?”(dove x sta per bello,giusto…).Per Platone la risposta a questa domanda consiste nel rintracciare l’idea in questione(per esempio l’idea di bellezza,di giustizia…).L’idea è dunque un “universale”:ciò significa che i molteplici oggetti sensibili,dei quali l’idea si predica,dicendoli per esempio belli o giusti,sono casi o esempi particolari rispetto all’idea:una bella persona o una bella pentola sono casi particolari di bellezza,non sono la bellezza.Mentre gli oggetti sensibili sono caratterizzati dal divenire e dal mutamento,soltanto delle idee si può propriamente dire che sono stabilmente se stesse;proprio questa differenza di livelli ontologici,ossia di consistenza di essere,qualifica le idee come modelli rispetto agli oggetti sensibili corrispondenti.L’attività di un artigiano,per esempio di un costruttore di letti,è descrivibile da parte di Platone come un insieme di operazioni che mirano a foggiare un determinato materiale (in questo caso il legno) secondo il modello dell’ idea del letto,alla quale egli si riferisce costantemente con il suo pensiero.L’idea è quindi dotata di esistenza autonoma,nè dipende per la sua esistenza dal fatto di poter essere pensata;essa è ciò di cui gli oggetti sensibili partecipano.La partecipazione all’idea,per esempio,di bellezza rende un determinato oggetto sensibile bello.Si usa solitamente dire che le idee abbiano una triplice valenza:1)Ontologica (dal participio del verbo essere greco):due cavalli,per esempio,si assomigliano perchè compartecipano all’idea.L’idea rende conto di ciò che una cosa è.Le cose sono infatti quel che sono perchè imitano le idee.2)Gnosologica (dal verbo greco “gignosco”,conoscere):noi conosciamo le cose perchè facciamo riferimento all’idea di uguaglianza:nella realtà empirica l’uguaglianza non esiste;essa esiste in un’altra dimensione.Due uomini si assomigliano perchè partecipano entrambe all’idea di uomo.3)Assiologica (da “axiologia”,la scienza che studia i valori):l’idea è il modello (in Greco “paradigma”) imitando il quale ogni cosa tende al bene,che è lo scopo di ogni cosa:per un cavallo il bene sarà correre veloce.Ovviamente le imitazioni non potranno mai essere uguali al modello;questo avviene per diversi motivi:uno che merita di essere ricordato è che le idee nell’iperuranio non avevano nè forma,nè colore,nè dimensioni…quindi se disegnamo un triangolo bianco è già diverso dal modello che non aveva alcun colore e che paradossalmente li aveva tutti.Platone sostiene quindi la causa finale:secondo lui la causa il motivo per cui avviene una cosa è il suo fine stesso;la causa finale di una casa è farvi abitare della gente:ci sono però anche delle “concause”(che noi definiremmo “la condizione senza la quale…”),in questo caso i mattoni,il cemento…la vera causa finale però è l’idea stessa,sul modello della quale la casa viene costruita:il fine della casa infatti è essere fatta sul modello dell’idea di casa,cioè nel migliore dei modi:il meglio di ogni categoria corrisponde infatti alla sua idea.I sofisti avevano individuato solo una causa riferita alla materia;Platone non accetta questo e dice,servendosi di una metafora legata alla tecnica della navigazione,che la loro “prima navigazione” era fallita,e che quindi lui si serve della “seconda navigazione”,quella che si usa quando non c’è vento e ci si serve dei remi:è una navigazione più faticosa,ma più sicura.Della “seconda navigazione” Platone ce ne parla nel “Fedone”:Socrate racconta che in gioventù era stato attratto dalla scienza naturale,che era tipica dei sofisti (non a caso Aristofane nelle sue commedie ce lo presenta come un sofista con la testa fra le nuvole)ma poi se ne era allontanato per dedicarsi alla vera filisofia e aveva così effettuato la seconda navigazione . Anassagora , fra i filosofi naturalisti, sembrava, con la sua dottrina del “Nous”, aver trovato la vera causa delle cose. Ma a questa affermazione, di per sé eccellente, Anassagora non seppe dare adeguato fondamento. Infatti, il “Nous” avrebbe dovuto spiegare come tutti i fenomeni siano strutturati in funzione del meglio, presupponendo quindi una precisa conoscenza, da parte del “Nous”, del Bene e del Male. Ma Anassagora non ha saputo fare questo e ha continuato ad assegnare agli elementi fisici – le “omeomerìe” – un ruolo di causa determinante. Gli elementi fisici sono solo una causa ausiliare, non la vera causa. Ma se vogliamo spiegare la «vera causa» noi non possiamo riferirci a cause fisiche; la vera causa, ossia la causa reale, è l’Intelligenza che opera in funzione del meglio. Occorre guadagnare quel «meglio», ossia quel «Bene», in funzione di cui opera l’intelligenza, il quale sta al di là del fisico e del sensibile; occorre quindi guadagnare il piano dell’essere intelligibile, metasensibile, ovvero l’essere «metafisico». La verità delle cose sta appunto nelle realtà intelligibili, che Platone ha chiamato “Idee”, pure forme, eterni modelli delle cose, rispetto alle quali le cose sensibili sono un mezzo o strumento di realizzazione, non quindi l’essenza delle cose, ma ciò mediante cui l’essenza si realizza nella sfera del sensibile . Questa scoperta delle Idee come vero essere, intelligibile, incorporeo, immutabile, in sé e per sé esistente, è stato in passato considerato il vertice speculativo del pensiero platonico (oggi noi sappiamo che Platone, nelle «Dottrine non scritte», si è spinto ancora oltre con la teoria dei Principi primi e supremi.). Hegel scriveva addirittura che proprio nella formulazione della dottrina delle Idee sta «la vera grandezza speculativa» di Platone, «grazie alla quale egli segna una pietra miliare nella storia della filosofia e quindi nella storia universale»(Hegel, “Lezioni sulla storia della filosofia” . Socrate (e anche Platone) non solo si era allontanato dai sofisti,ma addirittura cercava di far comprendere ai suoi concittadini che il loro metodo era sbagliato:essi non danno motivazioni razionali e partono dal presupposto (in particolare Protagora) che non esista una verità:l’uomo è misura di tutte le cose);per di più i sofisti si fanno pagare per i loro discorsi raffinati e privi di verità;per dimostrare la loro bravura effettuano dimostrazioni assolutamente paradossali (vedi quella di Lisia);Platone non può tollerare che “vendano”il sapere:è una cosa sbagliatissima e a riguardo si esprime nel “Protagora”;va però detto che per lui la vita era facile:era nato ricco e non aveva problemi economici:ma non tutti si trovavano nella sua stessa condizione.L’errore consiste soprattutto nel considerare il sapere alla pari delle altre cose,vendibile come esse:il rischio nell’acquisto degli insegnamenti è molto più grande rispetto a quello ,per esempio, del cibo,con il quale abbiamo un rapporto di “incorporazione”:i cibi,però,si possono portare a casa in recipienti e analizzarli con calma,mentre le cognizioni le si devono mettere alla prova su se stessi,sulla propria anima;il che può essere tanto un bene quanto un male ed in entrambe i casi non si può più tornare indietro:è un processo irreversibile.Acquisire nuove conoscenze,infatti,significa cambiare in un senso lineare ed inevocabile,e non semplicemente soddisfare un bisogno che si ripresenta ciclicamente e che deve essere soddisfatto per la sopravvivenza.Il rapporto che si instaura tra il commerciante ed il cliente è di manipolazione:chi vende si interessa solo di sfruttare a proprio vantaggio un bisogno altrui o addirittura di suscitare negli altri un bisogno che non hanno.Socrate dice poi che ad Atene,città democratica per eccellenza,tutti hanno voce in capitolo quando è il momento di prendere le decisioni,mentre nelle altre arti (per esempio la medicina) c’è una divisione del lavoro che porta ad affidare le scelte tecniche a persone competenti e non a chiunque.Di conseguenza per gli Ateniesi la politica non è insegnabile;infatti se tutti hanno voce in capitolo e dicono la loro,significa che tutti la conoscono già e non occorre insegnargliela,meno che mai a pagamento. Protagora replica affermando che lui insegna l’arte politica,che consiste nell’amministrare con senno tanto la propria casa quanto le questioni pubbliche. Platone passa dal concretismo sofistico all’astrattismo.Nella teoria delle idee traspare una sorta di ambiguità,che nasce dalla diversità delle valenze ontologiche ed assiologiche:infatti l’idea dovrebbe rendere conto di ciò che una cosa è,e di ciò che dovrebbe essere:il che è contradditorio,ma perchè non siano contrastanti bisogna supporre che l’essere ed il dover essere siano lo stesso.Ciò nella realtà è chiaramente impossibile, e Platone lo sapeva bene.La condizione pare essere che l’essenza di ciascuna cosa stia nel tendere a realizzare una determinata idea.L’essere è quindi concepito come stato dinamico e di tensione.Platone ha una concezione trascendente della realtà:ogni essere che appartiene al mondo fisico,secondo Platone, ha la propria essenza fuori di sè:si trova nell’idea.L’idea sta quindi oltre l’esistenza fisica;noi uomini non siamo al 100%100 dentro di noi;una delle parti più importanti si trova fuori.Chiaramente le parole che Platone mette in bocca a Socrate non sappiamo se siano effettivamente di Platone o di Socrate : man mano che matura Platone tende sempre più a elaborare e a reinterpretare i discorsi di Socrate ,mettendogli in bocca proprie idee.Va senz’altro ricordato che Platone fu il fondatore di una scuola(l’Accademia)dove veniva fornita un’impostazione culturale che spaziava nei campi più vasti e che si prefiggeva di selezionare coloro che avrebbero dovuto continuare gli studi per poi governare rettamente,oltre ad insegnare il bene(che non si identifica con il piacere:la filosofia fornisce bene all’anima,la retorica piacere;è questo il tema trattato nel “Gorgia”.I beni sono molteplici,ma il bene vero e proprio è per l’uomo è quello che riguarda la sua anima.Da questo punto di vista la filosofia si costituisce come medicina,come terapia dell’anima.Dove si può apprendere il bene?Non di certo nella città,che ha condannato ingiustamente Socrate,il suo uomo migliore;la vera sede per cercarlo diventa la scuola filosofica):si basava quindi sulla selezione.Per arrivare al potere non bastava essere figli di governanti,bensi’bisognava dimostrarsi idonei di svolgere tale ruolo.Tutti gli studenti venivano quindi messi alla pari e a creare le distinzioni tra loro era solo il merito del singolo.Questo ben rispecchia gli orientamenti politici aristocratici (la parola stessa “aristos”migliore+”crazia”forza,indica che il potere dev’essere in mano a chi se lo merita ed è superiore agli altri) di Platone.Le due materie che venivano maggiormente trattate erano la matematica e la filosofia:la prima,che era volta alla conoscenza degli enti matematici,eleva l’anima umana dal mondo sensibile a quello intellegibile,portando all’astrazione;la seconda perchè fornisce le conoscenze della realtà vera,di quei modelli perfetti della realtà cui tende l’anima umana .
La “REPUBBLICA” è l’opera in cui affiorano maggiormente tutti i temi di Platone:è un libro composto a sua volta da 10 dialoghi dove in particolare emerge il pensiero politico platoniano;come abbiamo già detto Platone era rimasto molto deluso dalla politica della sua città che aveva condannato il suo uomo più giusto e per lui lo stato ideale è quello in cui l’uomo giusto può trovare il suo collocamento senza essere tormentato;molto deluso era anche rimasto dall’incontro con il tiranno di Siracusa e si accorge quindi che il suo concetto di stato è inattuabile,puramente ideale:come ogni altra idea,anche quella di stato va imitata,sebbene sia impossibile riuscirvi totalmente.Si dice spesso che lo stato platoniano sia una utopia,vale a dire un qualcosa che non sta da nessuna parte . Netta pare la distinzione tra il primo “libro” della repubblica,probabilmente scritto in gioventù, e gli altri:è il dialogo tra Socrate ed un sofista,che dà una definizione di giustizia:essa per lui è il diritto del più forte;egli sostiene,come molti altri sofisti,che gli uomini per natura nascono diversi,chi più forte e chi più debole,ed è solo la legge che li fa uguali:per lui la legge non è nient’altro che un’ingiustizia dei più deboli nei confronti dei più forti,che dovrebbero dominare per natura.Per il sofista il modello d’uomo ideale è il tiranno,colui che ha fatto valere la sua superiorità sui più deboli:il tiranno è l’uomo più felice e potente.Il primo libro termina con la confutazione di Socrate delle tesi del sofista:per lui ci deve essre per forza una giustizia,in quanto l’ingiustizia che predicava il sofista non può esserci,perchè tende ad eliminarsi da sè:Socrate porta l’esempio dei briganti,ingiusti per eccellenza;anche dopo che hanno commesso ingiustizie rubando,per dividersi il bottino dovranno pur applicare qualche norma.A partire dal 2° libro Socrate imposta il suo discorso cambiando prospettiva,sostenendo che il modo migliore per esaminare l’uomo giusto sia vedere le cose più in grande:dov’è che esiste più in grande il concetto di giustizia?Certamente nello stato;Socrate mirerà a dimostrare l’opposto del sofista:per lui l’uomo ingiusto non è il più felice.Socrate aveva già più volte affermato che la giustizia rende automaticamente felici:nel libro 10° della Repubblica Platone ci spiega attraverso un mito escatologico ( che possiamo in qualche modo paragonare a quello presente nel Gorgia , il mito dei morti ) che la giustizia conduce alla felicità anche nel mondo ultraterreno . Tuttavia Socrate dovrà anche confutare la critica mossagli dall’ aristocratico Glaucone , che sostiene che si é giusti solo per timore di essere scoperti ; non solo , ma chi é ingiusto conduce una vita molto più felice rispetto al giusto . Glaucone argomenta servendosi del celebre mito di Gige , il pastore che imbattutosi in un anello capace di rendere invisibile chiunque se lo fosse infilato , da giusto che era divenne ladro e omicida , diventando ingiusto proprio perchè non poteva essere scoperto ; Socrate potrà ribattere servendosi della super-idea del bene . Socrate imposta poi il suo discorso tratteggiando lo stato ideale,partendo da zero:uno stato nasce secondo lui da esigenze materiali e per soddisfare dei bisogni;dal momento che ci sono diverse tecniche per soddisfarli,occorre selezionarle.A suo parere uno stato per funzionare deve avere tre classi sociali:1)i governanti.2)i difensori.3)i produttori.Ogni classe deve svolgere le sue funzioni,che non sono però di ugual livello,sebbene siano tutte fondamentali;è una chiara prospettiva aristocratica.In realtà la classe dei governanti si costituisce tramite la selezione di difensori che maturando diventano governanti:la forza fisica cede il passo a quella intellettuale e morale.Questa tripartizione ebbe enorme successo nella storia:nel Medioevo,per esempio,la società era suddivisa in oratores,bellatores e laboratores.E le donne che funzione avevano?Platone è stato il primo ad affermare che non ci siano propriamente lavori maschili e lavori femminili;tuttavia era convinto che in ogni campo gli uomini fossero superiori e riuscissero meglio. La città ideale di Platone è aristocratica,cioè governata da coloro che risultano essere i migliori ed i più idonei a svolgere tale compito;i migliori vengono selezionati in base al loro talento e non al fatto che i loro genitori potessero essere governanti;tuttavia egli ammette che ci sia una sorta di ereditarietà:ciò non significa che i giovani venissero selezionati per la loro discendenza,ma è un dato di fatto che coloro che mostrano maggiori attitudini per il governo sono proprio i figli dei governanti.Per selezionare occorre effettuare 2 lavori:1)la selezione vera e propria,2)sviluppare le propensioni dei selezionati.In realtà lo stato delineato da Platone è lo stato spartano idealizzato:a quei tempi presso gli aristocratici era visto come il top dell’organizzazione.Ma Platone tratteggia anche le possibili degenerazioni statali e proprio tra queste ci sarà lo stato spartano che era in realtà dominato non da aristocratici,ma da militari e proprietari terrieri.Secondo Platone ad ogni classe sociale spetta una virtù;poi ce n’è una comune a tutti e tre i gruppi:in tutto sono 4 le virtù (anche nel Cristianesimo ci sono le virtù,4 cardinali e 3 teologali:le 4 cardinali l’uomo le possiede per natura,le 3 teologali deriverebbero dalla divinità e sono fede,carità e speranza) e si suddividono così:1)sapere2)coraggio3)temperanza4)giustizia.I governanti,come abbiamo già detto,devono essere filosofi e quindi la loro virtù è il sapere;quella dei difensori è il coraggio che serve loro per difendere strenuamente lo stato;i produttori devono invece essere dotati della temperanza,devono cioè sapere che vi è chi governa e chi lavora;è una virtù che in realtà appartiene un pò a tutti,ma soprattutto a loro che devono obbedire.In termini moderni la temperanza è il consenso:se non c’è una diffusa convinzione del fatto che ci sia chi governa e chi lavora lo stato non può reggere.Bisogna tenere a mente che Platone sta sì parlando per bocca di Socrate per delineare la giustizia statale ideale ma solo per tratteggiare l’uomo giusto:si serve dello stato per poter operare su un modello più grande.La “Repubblica” viene spesso letta solo in chiave politica sebbene la politica sia in secondo piano:il tema centrale è proprio l’uomo giusto e la sua formazione.Per esempio descrive le degenerazioni statali per delineare parallelamente quelle umane;a sostenere la tesi che sia un libro il cui fulcro è l’uomo è il 10° libro che con un mito escatologico spiega che ne sarà dell’uomo giusto nell’aldilà.Nella “Repubblica” Platone ripropone la tripartizione dell’anima che corrisponde esattamente a quella statale,dettata dal fatto che non in tutti gli uomini prevale la stessa parte dell’anima:quella razionale (l’auriga) dominerà nei governanti,i quali ricercano il sapere razionale;quella irascibile (il cavallo bianco)prevale nei difensori,che agiscono mossi da orgoglio;quella concubiscibile (il cavallo nero) avrà la meglio sui produttori.Possiamo così comprendere perchè Platone la chiami temperanza:le varie parti dell’anima capiscono che bisogna tenere a bada,temperare, quella concubiscibile.Platone definisce un uomo più forte di se stesso quando la parte razionale tiene a freno le altre,vale a dire quando l’auriga ha la meglio.La giustizia è la 4° virtù : si ha giustizia quando ciascuno svolge le proprie mansioni e non pretende di svolgere ruoli che non gli spettano.Sparta era una oligarchia militare e quindi era ingiusta in quanto svolgevano le mansioni di governanti persone non idonee e a detenere il potere non sono necessariamente i migliori.Atene,città democratica, era anche messa peggio:era retta dalla 3° classe,i produttori;Platone definisce la democrazia il governo degli incompetenti,dove bisogna ascoltare il parere di qualsiasi stolto e dove ciascuno pensa solo a se stesso.Lo stesso vale per l’uomo:l’uomo giusto non si lascia trascinare dai piaceri (tanto meno da quelli fisici) ed è felice perchè la giustizia stessa fornisce un piacevole senso di benessere;la parte irascibile (cavallo bianco),vincolata dall’orgoglio, si vergogna dei piaceri e aiuta l’auriga a tenerne l’anima distante.Per Platone il tiranno è schiavo della parte peggiore di se stesso,del cavallo nero:è quindi ingiusto perchè nel contesto dell’anima non spetta al cavallo nero di comandare ed infelice perchè privo di giustizia.Un dubbio che può sorgere è come si ottiene il consenso o temperanza che dir si voglia:Platone dà una spiegazione tramite un mito,che può quindi anche rivestire una funzione politica:per convincere afferma che gli uomini siano stati forgiati con 3 diversi metalli (oro,argento,ferro):ci sono quindi differenze naturali tra gli uomini e quindi la tripartizione è necessaria e giustificata.Si ha consenso quando si ha una ideologia diffusa:la parola ideologia ha una lieve sfumatura negativa,come se si affermasse qualcosa non proprio corretto ma fatto passare per buono:è proprio il caso del mito platonico con valenza politica;Platone parla anche in questo caso di menzogne buone e necessarie per il consenso.Per lui,comunque,quando lo stato è felice,allora anche tutti i gruppi lo sono.Secondo le concezioni liberali e moderne è l’opposto:quando i singoli stanno bene,anche lo stato procede felicemente.Platone,per motivare quanto detto,si serve di una concezione “organicista”:se il nostro organismo sta bene,allora ogni singolo membro sta bene.dire concezione organicista,non significa che le singole parti debbano per forza essere subordinate alla totalità:Platone dice che da un lato conta il tutto,ma che dall’altro se il tutto è felice anche le parti lo sono.Come possono essere esse felici?Platone non si limita alla precedente argomentazione organicista;egli pone dei limiti allo stato:non deve essere troppo ampio perchè uno stato è tale solo quando i suoi abitanti hanno la consapevolezza di formarlo;uno stato troppo esteso è anche difficilmente controllabile.Platone vedeva lo stato come una grande famiglia basata sull’armonia e sulla solidarietà:per creare questa situazione bisogna a suo avviso eliminare la famiglia naturale in modo che gli abitanti dello stato considerino propri familiari gli altri abitanti;bisogna poi eliminare la proprietà che frammenta la società.E’ un comunismo radicale ed estremista dove bisogna addirittura vivere insieme;lo scopo è far sì che i cittadini concepiscano un forte senso di solidarietà:ciascuno lavorerà e difenderà lo stato come farebbe con la propria famiglia.Probabilmente Platone prese spunto dalla società spartana arcaica e militare improntata sul governo oligarchico-militare.Questo comunismo per Platone deve riguardare solo alle due classi superiori,che devono governare.Bisogna eliminare gli interessi personali in modo tale da evitare che i governanti tutelino i propri interessi accecati dalla smania di denaro,tralasciando quelli altrui.L’obiezione di fondo che solitamente si muove,al di là dell’estremismo,è che i governanti,condannati ad una scelta così rigida,condurrebbero una vita tristissima.La società è fortemente gerarchizzata e sul piano materiale sono avvantaggiati i produttori,che vivono normalmente e possono arricchirsi.Quindi può sembrare che i ceti superiori siano infelici;in realtà i governanti ed i guardiani che poi lo diverranno hanno un talento naturale e sono già stati selezionati ed educati dallo stato;da questa educazione trarranno enormi vantaggi e saranno poi chiamati a governare,sebbene contro la loro volontà:infatti vengono educati alla sapienza e alla conoscenza,che comprenderanno essere le cose più importanti ed utili di tutte;dello stato non gliene importa nulla,così come non gli importa delle ricchezze materiali:la sapienza rappresenta una ricchezza morale molto più importante e duratura.Verranno però poi chiamati a governare proprio perchè non vogliono!Secondo Platone infatti lo stato va amministrato da chi non vuole farlo,da chi ha raggiunto un alto livello di educazione e ha compreso che ciò che più conta è il sapere,e non da chi vuole amministrarlo,in quanto lo farebbe solo per interessi personali.Vivranno quindi la maggior parte della loro vita dedicandosi alla cultura,ma saranno poi costretti a governare per un pò:lo devono allo stato che li ha allevati e mantenuti negli studi.E’ un dovere morale.Guardiamo ora alle singole classi sociali.i governanti (ed i difensori) nel complesso fanno ciò che desiderano,svolgono cioè la loro vita dedicandosi al sapere (il periodo in cui governano,come abbiamo detto,è breve);ai produttori non interessa il sapere e sono felici di arricchirsi materialmente e perseguire questi strumenti inferiori di felicità.Quindi è una società (ideale) felice anche nelle sue singole parti.Platone viene anche criticato per aver creato uno stato totalitario,che vuole organizzare totalmente la vita dei singoli,la cui vita non conta nulla di per sè,se non in funzione dello stato:si può portare come esempio il caso che Platone cita in uno dei 10 libri:l’ eugenetica (dal Greco eu,bene,+gignomai,nasco,=nascere bene);lo stato sceglie gli individui da far accoppiare in modo tale da avere una discendenza perfetta.Un filosofo di posizioni liberali,Popper,criticava la società di Platone,perfetta e totalitaria,ed era in favore di una società aperta,che avesse la possibilità di correggersi e di migliorare: Popper era del parere che creare una società perfetta fosse impossibile perchè l’uomo stesso è imperfetto per natura.La società aperta è inferiore a quella totalitaria platonica,ma ha conoscenza della propria inferiorità e sa correggersi cambiando in continuazione:una società perfetta non ha motivo di fare questo.Platone insiste invece sull’immutabilità:la società per lui è perfetta così com’è e non deve assolutamente cambiare.Popper ha però commesso un errore dimenticandosi nella foga che Platone parla di un’idea statale:un’idea,per definizione,non è mai realizzabile:è solo un punto verso cui muovere.Nelle “Leggi”,opera incompiuta,Platone delineerà lo “stato secondo”:dal momento che quello delineato nella “Repubblica” è puramente ideale,Platone ne tratteggia uno attuabile,dove prende gli aspetti migliori di ogni governo in modo tale da creare il miglior stato tra quelli attuabili (questa soluzione piacque molto in seguito ed è considerata il punto di partenza dello stato “misto”.Il ragionamento di Popper è dunque in parte fuori luogo:se ipotizzassimo la società perfetta,perchè mai dovremmo cambiarla?Perchè cambiare qualcosa di perfetto?Potrebbe cambiare solo in peggio.Abbiamo detto che lo stato delineato nella “Repubblica” è un’utopia ed è interessante notare la distinzione tra i due aggettivi che ne derivano;”utopistico” è un qualcosa di negativo che si pretende realizzabile,ma che per fortuna non lo è:utopistico è il Comunismo ideale.”Utopico” è un concetto tipicamente progressista che induce a vedere il mondo,che molti credono buono così com’è,imperfetto e migliorabile:il progressista ha un atteggiamento sempre volto al cambiare.Si può dire che il concetto di “utopistico” si avvicini molto a Platone che nelle Leggi fa notare che lo stato così com’è non va bene e ne propone uno “misto”,dal momento che quello ideale-aristocratico è inattuabile. Popper ha invece preso l’idea di Platone utopica di stato per utopistica.La “Repubblica” può anche essere vista in chiave di trattato pedagogico-educativo volto all’istruzione dei futuri governanti:Platone ci indica qui i diversi livelli di conoscenza e contrappone la filosofia ad altri metodi di educazione,primo tra tutti quello della retorica capeggiato da Isocrate ;per Platone la vera retorica è quella che si fonda sulla piena conoscenza della verità e delle persone cui ci si rivolge,non come la intendevano tutti i suoi contemporanei:per Isocrate e tutti gli altri essa consisteva invece nel formulare discorsi eleganti ma privi di verità.Platone critica anche la poesia:Socrate stesso diceva che essa non è un vero sapere,ma una forma di conoscenza infusa dalla divinità:il poeta infatti quando componeva era divinamente ispirato,la divinità si serviva di lui per comunicare (basti pensare ad Omero ,che parlava ammaestrato dalla Musa).Platone era appassionato di etimologia e si divertiva a dare interpretazioni sull’origine e la derivazione delle parole,che per lo più erano errate;una di queste,però,era corretta:Platone fece derivare la parola “mantica” dal termine greco “mania”,follia.Infatti quando si davano responsi si era come se fuori di sè: a parlare era la divinità.Non significa comunque che la poesia non valga nulla (Platone stesso può essere considerato poeta). Va senz’altro a proposito citato lo ” Ione “ , un dialogo platonico considerato ” minore ” , dove ben emerge come fondamento della poesia non sia la scienza , bensì l’ispirazione . Protagonisti sono Socrate e Ione , un rapsodo . Ione si dichiara espertissimo di Omero e di tutte le sue opere , e ne dà prova recitando a memoria i pezzi più svariati . Ione ne sa davvero molto su Omero , ma Socrate gli dimostra che il suo sapere non si basa su conoscenza e scienza : è un’ispirazione divina . Platone nella “Repubblica” fa considerazioni più articolate e complesse rispetto a quelle di Socrate ,attaccando l’arte su due piani differenti:1)morale e più banale rispetto all’altro:Platone,come già Senofane,sostiene che l’arte ci presenta gli dei o gli eroi con caratteristiche fortemente negative e che assumono atteggiamenti meschini e di basso valore morale (basti pensare all’ira di Achille);lo stesso vale anche per la musica,di cui Platone era esperto (si racconta che ormai in fin di vita,sentendo una fanciulla che suonava il flauto,le ultime parole che pronunciò prima di morire furono di rimprovero perchè ella aveva stonato):a quell’epoca vi erano diversi stili ben canonizzati e definiti,ognuno dei quali stimolava determinati sentimenti,positivi e negativi.Secondo Platone la musica che stimola sentimenti negativi va assolutamente censurata;al giorno d’oggi abbiamo criteri di giudizio differenti:un brano musicale o ci piace o non ci piace,indistintamente dal suo valore morale:per noi bello e brutto sono su un livello totalmente differente da buono e cattivo.Prendiamo per esempio i Carmina Burana di Orf,di orientamento filo-nazista:si possono apprezzare pur non essendo filo-nazisti.Presso di noi vige l’autonomia dell’arte,che Platone non ha riconosciuto:bello-brutto è diverso da buono-cattivo e da vero-falso:in un libro di storia ricerco la verità,in un romanzo la bellezza…Platone era senz’altro molto attratto dalla questione del bello,che per lui aveva a che fare con la natura e non con l’arte:parla infatti di begli uomini,belle piante,belle azioni…Il suo giudizio è puramente morale:se un’opera è cattiva sul piano morale,anche se bella va censurata,il che rientra bene nella concezione di stato totalitario platonico.Bisogna comunque dire che era un concetto molto diffuso presso i Greci,che lo riassumevano nella “calogazia”:non c’era differenza tra bello e buono.Abbiamo anche tirato in ballo la coppia vero-falso,di valenza gnosologica;abbiamo già detto a riguardo delle idee che il piano ontologico e quello gnosologico corrispondono:vero e falso si identifica con essere e non essere;di conseguenza il falso va censurato.2)metafisico e di più alto livello:in un primo momento Platone afferma dunque che le opere d’arte pericolose vanno allontanate;successivamente,non soddisfatto di quanto detto,sostiene che vadano censurate tutte dalla prima all’ultima.Quando un artista raffigura un corpo,secondo Platone,imita un corpo esistente in natura;ma abbiamo detto che per Platone le cose sono imitazioni delle idee.Le opere d’arte sono quindi a suo avviso imitazioni di imitazioni:se già le cose sensibili sono inferiori alle idee,figuriamoci le opere d’arte:sono un gradino più distanti e contengono un tasso di verità addirittura inferiore a quello delle cose:le opere d’arte impediscono all’uomo ancora di più rispetto alle cose sensibili di conoscere le idee e vanno dunque bandite.L’arte diventa quindi negativa a prescindere dal fatto che stimoli buoni o cattivi sentimenti:il piano morale non conta più.Sono affermazioni piuttosto strane,soprattutto se consideriamo che Platone stesso era un artista e dedicò dialoghi al bello naturale,come il “Fedro” o il “Simposio” .Chiaramente aveva ben presente le capacità persuasive dell’arte.Tuttavia in epoche successive si sono usate queste stesse affermazioni platoniche per giustificare l’arte:essa non imita la realtà empirica,ma le idee stesse ed è strano che Platone non se ne sia accorto in quanto aveva tutti gli strumenti:i ritratti stessi (presso i Greci ancora di più i busti) sono idealizzati;l’artista sfrutta il volto di chi deve ritrarre per poi passare all’idea vera e propria (è lo stesso del triangolo disegnato che serve per ragionare sull’idea di triangolo).Probabilmente per noi è più facile capirlo perchè possediamo la macchina fotografica;è facile per tutti capire la differenza tra un ritratto e una foto.Da notare,poi,che dalla scoperta della macchina fotografica in poi i pittori hanno cominciato a fare ritratti sempre più astratti e meno realistici.Gorgiaaveva dato grande importanza all’arte sganciandola dal piano ontologico:secondo lui dal momento che la verità non esiste,ci si può creare un mondo proprio,dato che non c’è un vero mondo:non si hanno vincoli imitativi;per Gorgia l’artista è tanto più bravo tanto più riesce ad ingannare.Gli artisti secondo Platone,invece, con le loro “copie” precludono agli uomini la possibilità di conoscere.Altro motivo della condanna da parte di Platone è che l’arte corrompe i giovani perchè rappresenta l’uomo in preda alle passioni;vengono indotti a considerare normale una vita in balia delle passioni,dell’odio,dell’invidia…l’arte stessa sviluppa le passioni.Lo stesso Omero (che veniva anche definito “la bibbia dei Greci” dal momento che nelle sue opere si trovava un pò di tutto:verità religiose,tecniche militari…)ha rappresentato i più grandi eroi in preda a passioni.Platone nella sua condanna risparmia solo la musica e le poesie patriottiche che elevano l’uomo al grande dovere di sacrificio per la patria,ispirandosi al modello spartano,dove la musica patriottica aveva avuto importanza sul piano educativo.Tuttavia in altri dialoghi dà un giudizio positivo rivalutandola completamente (egli stesso era un grande poeta).Platone,come detto,si occupa dell’educazione dei futuri governanti,recuperando alcuni aspetti della “paideia” tradizionale;il percorso da seguire è lungo e difficile e si può suddividere in varie tappe:nel periodo della giovane età l’educazione viene improntata sulla musica e sulla ginnastica;Platone è convinto che nella prima fase dell’educazione non si possa forzare sul piano teoretico.La musica aveva a che fare con il ritmo e più che musica come la intendiamo noi,era educazione ad ogni tipo di ritmo:era quindi educazione dell’anima.La ginnastica aveva la funzione di creare uno stato di armonia sia nel corpo sia nell’anima, e di conseguenza era una forma di educazione tanto relativa al corpo quanto all’anima.Si può dire che l’intero percorso educativo miri all’armonia dell’anima:in poche parole l’uomo giusto è l’uomo armonico.Prima di entrare nella fase vera e propria dello studio teoretico secondo Platone bisogna dunque impartire un’armonia psico-fisica tramite queste due attività.lo studio vero e proprio si articola nello studio della matematica e della filosofia:il culmine consiste nel raggiungimento dell’idea di bene;è un itinerario lungo e selettivo:quando lo si completerà si avranno ormai circa 50 anni per poi essere pronti a governare lo stato,anche se controvoglia.E’ interessante il fatto che nelle “Leggi” Platone parli di un’educazione prenatale:a suo avviso grazie a tecniche particolari (modi di cullare,per esempio) si può dare una prima educazione all’armonia;ai giorni nostri si è scoperto che ciò ha davvero una sua influenza;è quindi un’interessante intuizione platonica,che sapeva bene che l’educazione non è solo razionale.La dimensione conoscitiva è legata ancora una volta alla gerarchia ontologica;Platone per esprimere meglio questa idea si serve di un’efficace immagine e di un mito (il celebre mito della caverna):la prima è la celebre immagine della “linea”:
come abbiamo già detto la conoscenza stabile è quella basata sull’episteme,quella mutevole ed opinabile sulla doxa.Ancora una volta riscontriamo una chiara influenza pitagorica : i Pitagorici infatti individuarono il
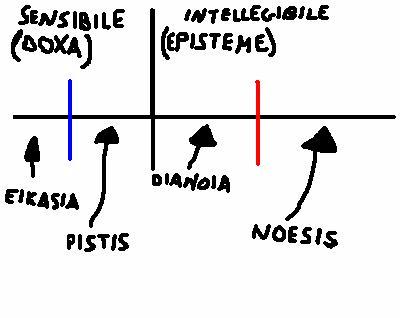
numero come principio della realtà e crearono una “piramide” di principi che partiva dalla coppia finiti-infinito e da lì si generavano tutte le altre coppie.Per il momento diciamo che i livelli platonici sono 4 (anche se quelli fondamentali restano 2).L’eikasia ha a che fare con la radice eik- di somiglianza,apparenza:è opportuno tradurla con “immaginazione”,ma va depurata da tutti i significati che le attribuiamo noi;è la capacità di cogliere le immagini;si tratta di verità addirittura inferiori a quelle del mondo sensibile e possiamo in parte identificarle con le opere d’arte,ma anche con i riflessi delle cose,come gli specchi o le superfici di laghi o fiumi:Platone aveva in mente tutte le riproduzioni del mondo sensibile;ma molti studiosi hanno anche sostenuto che nella capacità di immaginazione si possa vedere anche un primitivo atteggiamento conoscitivo:si tratta della pura e semplice sensazione;quando prendiamo in mano un quaderno abbiamo dapprima una pura e semplice percezione sensuale:notiamo la forma,il colore…Conoscere realmente un quaderno significa mettere insieme le sensazioni e sfruttarle;forse per capire meglio basterebbe chiudere gli occhi e stringere un libro:lo si percepirebbe con il tasto e si potrebbe immaginare cosa si vedrebbe ad occhi aperti;verso la fine del ‘600 si cominciarono ad effettuare i primi interventi di cataratta e si fecero vedere per la prima volta persone che non avevano mai visto:quando costoro riferirono le loro impressioni si scoprirono cose interessanti;per esempio non riuscirono ad identificare con la vista ciò che per anni avevano toccato;chiaramente è molto differente da ciò che intendeva Platone,ma ci permette comunque di capire che l’oggetto della conoscenza (sebbene la conoscenza empirica sia inferiore a quella intellegibile)è il risultato di operazioni complesse:si associano esperienze visive con esperienze tattili;tuttavia non siamo per niente sicuri che Platone ci sia davvero arrivato.La pistis,che possiamo tradurre con “credenza”è il soggetto conoscitivo degli oggetti sensibili.Della episteme abbiamo già parlato:i suoi oggetti sono intellegibili,ma non necessariamente idee;o meglio,ci sono sì le idee,ma anche gli enti matematici che possiamo suddividere in a)geometria,b)musica,vista come rapporti matematici,c)stereometria,che è la geometria dei corpi solidi,d)astronomia,vista come scienza del movimento dei solidi:erano le arti del “quadrivio”,diremmo oggi le materie scientifiche che già all’epoca si contrapponevano a quelle umanistiche.Dunque la dianoia corrisponde alla matematica in generale,la noesis alle idee;Platone era molto interessato di matematica (anche qui possiamo riscontrare un’influenza pitagorica ) e proprio sull’entrata dell’Accademia (i cui resti si possono vedere qui di fianco )
accademia; c’era scritto

“Non entri chi non conosce la matematica”:essa per Platone aveva una valenza propedeutica e di ginnastica mentale.Per un verso assomiglia alla filosofia perchè ha oggetti stabili,permanenti e non sensibili (uso sì disegni,ma per dimostrare su idee)per un altro presenta grandi limiti:si pensa sì ad idee,ma si lavora pur sempre su cose sensibili:occorre sempre l’appoggio del piano sensibile;la filosofia invece è un percorso mentale tutto interno alle idee.La matematica ha poi bisogno di ipotesi:si parte da postulati e da definizioni:cose che vengono accettate senza venir dimostrate;la filosofia ha invece un carattere critico:non si accetta mai nessuna cosa per data e si tende a mettere sempre in discussione fino ad arrivare alla conoscenza.Bisogna infatti risalire tutte le ipotesi fino ad arrivare ad una ipotesi indiscutibile da cui derivano tutte le altre.Va poi ricordato che gli oggetti matematici sono su un piano intermedio:hanno caratteristiche di idee (l’immutabilità) ma anche di enti empirici (la molteplicità):molteplicità e immutabilità sono proprio 2 dei principali aspetti che differenziano il mondo sensibile da quello intellegibile;il numero 3,ad esempio,è immutabile ma in un’espressione matematica lo si può scrivere più volte.Dianoia e noesis hanno entrambe la radice di “nous”,intelletto:la noesis è la versione pura e senza aggiunte e si può tradurre con “intellezione”;dianoia è più complessa perchè compare la radice “dià”,attraverso-mediante,che implica il passaggio da qualcosa a qualcos’altro e si può tradurre con “ragionamento discorsivo”:in un’espressione ci sono diversi passaggi e si passa di continuo da mondo empirico a mondo intellegibile.La noesis è l’intellezione,la contemplazione delle idee.La diversa lunghezza dei segmenti nel disegno di prima suggerisce una chiara gerarchizzazione:un segmento più è lungo e più è conoscibile,vale a dire che contiene un maggior tasso di essere.Il punto di arrivo della conoscenza è il bene in sè,l’idea di bene,cui Platone allude qua e là nei suoi dialoghi,sempre velatamente,chiamandola “misura”,”uno”,”bellezza”…Si tratta del più alto livello di argomentazione platonica:ce ne parla però in maniera molto indiretta e sfumata e doveva rientrare nelle dottrine non scritte;Platone stesso ci dice che lui non ne parlerà usando una strana metafora,che si può definire “bancaria”:dice che parlerà “del figlio e non del padre”,termini che in greco significano anche “interesse” e “capitale”:quindi si può intendere “vi parlerò dell’interesse e non del capitale”.Si serve poi di un’efficace metafora “solare”:il bene sta al mondo delle idee come il sole sta a quello sensibile.Con bene in sè,idea di bene si intende un bene assoluto e non relativo ad altre cose come le idee (l’idea di forza,ad esempio,è un bene relativo perchè può essere un bene come un male:dipende dall’uso e dalle circostanze).Il bene in sè è la conoscenza suprema e sublime a cui sono chiamati i filosofi-re,che devono seguire il lungo percorso di studi:esso è il top del percorso educativo:quando si ottiene la conoscenza del bene in sè si è chiamati a governare la città;ciò che porta ad orientare ogni cosa verso il bene,a renderla buona è proprio la conoscenza del bene in sè.Per molti aspetti esso coincide con l’idea del bello:la bellezza è il modo in cui si esterna il bene interno:è una concezione ampiamente diffusa in tutto il mondo greco.Secondo Platone il sole è la “ratio essendi” (la ragione di essere)e la “ratio cognoscendi” (la ragione di conoscere)nel mondo sensibile:è infatti grazie al sole che riusciamo a vedere il mondo sensibile;in sua assenza vediamo molto male ed è grazie a lui che conosciamo la realtà sensibile.Il sole consente poi la vita:dove non c’è il sole non c’è vita.Il bene riveste le stesse funzioni del sole,però nel mondo intellegibile delle idee,che in un certo senso sono anch’esse “ratio cognoscendi” e “ratio essendi”:l’idea fa sì che un cavallo sia tale e che lo si riconosca.Come detto,l’idea ha anche valenza assiologica (i cavalli mirano ad imitare l’idea di cavallo) ed è bene aggiungere di “unità della molteplicità”:i cavalli sono tantissimi,ma l’idea di cavallo è unica e la si può definire “stampo” dei cavalli.Il bene in sè,oltre a quelle del sole,svolge le funzioni anche delle idee:risulta quindi inesatto definirlo idea:è una idea delle idee,una super-idea che si trova ad un livello superiore delle idee e che riveste funzioni analoghe a quelle delle idee sul mondo sensibile,ma sulle idee a stesse.Le idee sono unità della molteplicità,ma tuttavia sono tante:quindi si può fare lo stesso discorso che facevamo per le funzioni delle idee sul mondo sensibile;esse dovranno avere qualcosa in comune tra di loro.Esse rappresentano il bene per ciascuna categoria,il punto cui devono mirare i componenti di ogni “classe”:le idee tendono ad essere il bene per la loro categoria:l’idea di uomo è il punto cui tutti miriamo:le idee fanno quindi riferimento al bene in sè,che è quindi un principio supremo,una super-idea.Esso svolge le stesse funzioni che le idee svolgono nel mondo sensibile,ma sulle idee stesse:ce le renderà conoscibili (conosco un’idea perchè è il bene della sua categoria),le farà esistere ( esistono nella misura in cui sono il bene della loro categoria,partecipano al bene).L’idea del bene sarà anche l’unità della molteplicità delle idee,che sono innumerevoli,pur essendo il solo modello per ogni categoria.Abbiamo detto che a volte,al posto di bene in sè,troviamo “uno”,”misura”…Abbiamo anche già parlato di quella volta che Platone tenne la conferenza sul bene parlando di matematica:dunque l’”uno” ben si riallaccia.Ma che cos’era il bene in sè?Per Platone esso è unità,armonia,ordine,misura,unità…In altri dialoghi parla del bene in sè,del vertice della realtà,come coppia di principi,o meglio come principio bipolare:al vertice della realtà ci sarebbero dunque l’”uno” e la “diade indefinita”.L’”uno” è l’unità,la diade fa riferimento al 2,quasi all’idea di 2:Platone col 2 vuole chiaramente indicare la negazione dell’unità,suggerendo il principio della molteplicità o almeno un primo passo verso di essa.Con il bene in sè (in greco “katà auton”)sta pian piano rivelandoci l’esistenza di un 5° livello,principio supremo della realtà.La dottrina delle idee serve a spiegare perchè,in fin dei conti,le cose sono buone,o meglio le idee sono buone:il mondo sensibile cerca di imitare la bontà delle idee,ma con scarsi risultati.Abbiamo fin’ora detto che le imitazioni risultano imperfette:è un’ipotesi molto vaga.E’ il momento di spoiegare perchè le cose non sono perfettamente buone:bisogna o ammettere un altro principio o ammettere la bipolarità del principio:accanto all’”uno” (il bene vero e proprio)c’è la diade,la molteplicità concettuale che crea disordine.Cerchiamo di ritracciare lo schema già trattato in precedenza,però più corretto :
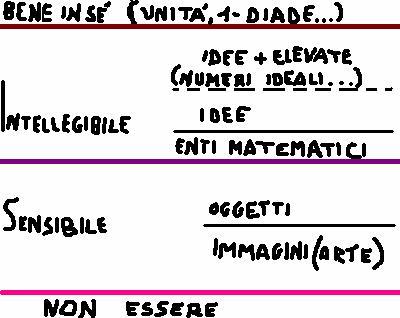
é una gerarchia ontologica:più si sale e più cresce il tasso di essere perchè si ha esistenza sempre più forte:l’idea di cavallo non muore,il cavallo sì.Il punto di partenza,puramente teorico,addirittura sotto il livello delle immagini-imitazioni,è il non essere,poi troviamo l’essere pieno delle idee;il bene in sè,però,per Platone è per “dignità e per potenza” superiore all’essere:se le idee sono l’essere ciò che le motiva (il bene in sè) non può essere essere.Di fronte a questa affermazione di Socrate (ricordiamoci che a parlare è lui,con parole platoniche)l’interlocutore del dialogo esclama con stupore “Oddio!”.In realtà esclama “per Apollo”.Un interprete ha avanzato un’ipotesi:dato che è un pezzo di dialogo particolarmente allusivo egli ha ritenuto che sotto l’espressione “Apollo” (la divinità del sole,già qui ci può essere un collegamento alla proporzione precedente)si possa leggere “a” (alfa privativa) e “pollos”,che significherebbe non molteplice.Effettuando questa affermazione non ci dice tanto ciò che il principio supremo è,quanto piuttosto ciò che non è (molteplice).Il bene risulta quindi coglibile con qualcosa che sta oltre alla conoscenza:se i livelli della conoscenza corrispondono all’essere e il non essere non è conoscibile,man mano che cresce il tasso di essere cresce il tasso di conoscibilità:ma il bene in sè è sopra,al di là dell’essere e quindi ha una conoscibilità totalmente fuori dal normale.Platone stesso ci dice che è una conoscenza extra-razionale.Schematizziamola in un grafico:
la conoscenza non è nient’altro che un tentativo del soggetto di arrivare all’oggetto o dell’oggetto di arrivare al soggetto:l
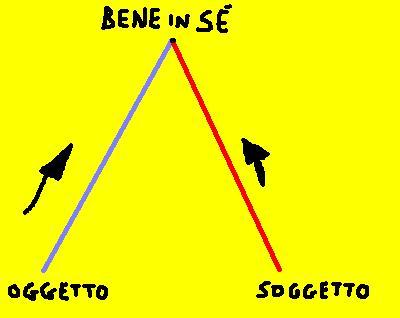
imitiamoci a dire che è un tentativo di unione tra soggetto ed oggetto.Se si sale dalla parte del soggetto,di pari passo si sale da quella dell’oggetto:crescono di pari passo.Paradossalmente,però,l’identificazione tra soggetto e oggetto implica l’inconoscibilità:per conoscere ci deve essere un soggetto che compie l’azione ed un oggetto che viene conosciuto:se vengono a mancare,manca di conseguenza anche la conoscibilità.Il bene in sè si trova esattamente nel punto di incontro tra soggetto ed oggetto:Platone afferma che la conoscenza del bene in sè sia un’esperienza mistica dove però è indispensabile la ragione;la si potrebbe tranquillamente definire una mistica di superamento della ragione.Platone dice poi di voler descrivere la nostra situazione di uomini,di come siamo e di come il nostro destino può cambiare.Si serve qui del celeberrimo mito della caverna,forse il più famoso mito platonico,dove emerge tutta la sua filosofia :
mito descrive una caverna profonda stretta ed in pendenza,simile ad un vicolo cieco.Sul fondo ci sono gli uomini,che sono nati e hanno sempre vissuto lì;essi sono seduti ed incatenati,rivolti verso la parete della caverna:non possono liberarsi nè uscire nè vedere quel che succede all’esterno.Fuori dalla caverna vi è un mondo normalissimo:piante,alberi,laghi,il sole,le stelle…Però prima di tutto questo,proprio all’entrata

della caverna,c’è un muro dietro il quale ci sono persone che portano oggetti sulla testa:da dietro il muro spuntano solo gli oggetti che trasportano e non le persone:è un pò come il teatro dei burattini,come afferma Platone stesso.Poi c’è un gran fuoco,che fornisce un’illuminazione differente rispetto a quella del sole.Questa è l’immagine di cui si serve Platone per descrivere la nostra situazione e per comprendere occorre osservare una proporzione di tipo A : B = B : C La caverna sta al mondo esterno (i fiori,gli alberi…) così come nella realtà il mondo esterno sta al mondo delle idee:nell’immagine il mondo esterno rappresenta però quello ideale tant’è che le cose riflesse nel lago rappresentano i numeri e non le immagini empiriche riflesse.Si vuole illustrare la differenza di vita nel mondo sensibile rispetto a quella nel mondo intellegibile.Noi siamo come questi uomini nella caverna,costretti a fissare lo sguardo sul fondo,che svolge la funzioni di schermo:su di esso si proiettano le immagini degli oggetti portati dietro il muro.La luce del fuoco,meno potente di quella solare,illumina e proietta questo mondo semi-vero.Gli uomini della caverna scambieranno le ombre proiettate sul fondo per verità,così come le voci degli uomini dietro il muro:in realtà è solo l’eco delle voci reali.Gli uomini della caverna avranno un sapere basato su immagini e passeranno il tempo a misurarsi a chi è più bravo nel cogliere le ombre riflesse,nell’indovinare quale sarà la sequenza:è l’unica forma di sapere a loro disposizione ed il più bravo sarà colui il quale riuscirà a riconoscere tutte le ombre.Supponiamo che uno degli uomini incatenati riesca a liberarsi:subito si volterebbe e comincerebbe a vedere fuori gli oggetti portati da dietro il muro non più riflessi sul fondo della caverna.Poi comincerà ad uscire ma sarà piuttosto riluttante perchè infastidito dalla luce alla quale era desueto:quando finalmente uscirà si sentirà completamente smarrito e disorientato.Comincerà a guardare indirettamente la luce solare:ad esempio la osserverà riflessa su uno specchio d’acqua.Man mano che la vista si abitua guarda gli oggetti veri:gli alberi,i fiori…In un secondo tempo le stelle e poi riuscirà perfino a vedere il sole.Chiaramente vi sono chiare allusioni a varie dottrine platoniche:evidente risulta l’allusione ai 5 livelli di conoscenza;le immagini proiettate sul fondo della caverna sono l’eikasia la capacità di cogliere le realtà empiriche riflesse,grazie al fuoco che rende visibili questi oggetti “artificiali”.Gli oggetti artificiali che portano dietro il muro sono la pistis,il mondo sensibile vero e proprio.Curioso è che l’atto di voltarsi da parte degli uomini nella caverna venga espresso con la parola “convertirsi”:è l’atto fondamentale per il cambiamento della propria prospettiva esistenziale.Le cose dietro il muro riflesse nello specchio d’acqua rappresentano la dianoia,gli enti matematici;gli alberi ed i fiori sono invece le idee vere e proprie,la noesis.Il sole,invece,è il bene in sè.Le stelle sono le idee più elevate (i numeri ideali…).L’uomo che è fuggito dalla caverna e ha visto tutto si trova in una situazione piuttosto ambigua:da un lato vorrebbe rimanere all’aperto,dall’altro sente il bisogno di far uscire anche i suoi amici incatenati;alla fine decide di calarsi nella caverna e quando arriva in fondo non vede più niente,è come se accecato.Sostiene di essere tornato per condurli in un’altra realtà,ma essi lo deridono perchè non riesce più neppure a vedere le ombre riflesse sul fondo.Lui però continua a parlar loro del mondo esterno ma i suoi “amici” lo deridono e si arrabbiano e lo picchiano perfino.In realtà Platone vuole qui descrivere la storia di Socrate ,un uomo che ha visto realtà superiori e ha cercato di farle conoscere agli altri che non hanno però accettato.Per quel che riguarda il fatto che l’uomo tornato nella caverna non riesca più a cogliere le realtà sensibili,possiamo portare ad esempio la vicenda del filosofo Talete,che guardando le stelle cadeva nei pozzi e veniva deriso per il fatto che voleva vedere le stelle lui che non vedeva neppure cosa c’era per terra.La liberazione dalle catene avviene (come la reminescenza) o per caso o grazie all’intervento di qualcuno.Comunque il mito rievoca pure il compito dei governanti,che una volta raggiunto il sapere devono per forza tornare nel mondo sensibile per governare.La fuoriuscita dalla caverna può anche essere metafora del lungo percorso educativo dei filosofi-re.Si può quindi definire correttamente il mito della caverna come una sorta di riassunto della filosofia platonica.Platone passa poi alla descrizione delle “decadenze” statali:a suo avviso la miglior forma di governo è quella dello stato ideale da lui tratteggiato,che è però inattuabile:essa potremmo identificarla con l’aristocrazia,dove a detenere il potere sono coloro che risultano essere i più idonei.Tra gli stati attuabili Platone attribuisce il secondo posto (se non contiamo lo “stato secondo” delle “Leggi” )alla Timocrazia,vale a dire il governo basato sul senso dell’onore corrispondente allo stato spartano nel suo periodo migliore.A lungo si è pensato che Platone avesse effettuato questa graduatoria di forme di governo a seconda del numero di governanti:più ce n’è peggio è.In realtà la differenza tra un governo e l’altro è solo la capacità dei governanti.La repubblica ideale di Platone è un’aristocrazia idealizzata che non si distingue solo per il numero esiguo di persone preposte al governo,ma anche per le loro abilità:la sequenza delle decadenze statali va vista in parallelo con quella delle decadenze umane:infatti si ha aristocrazia quando nell’anima prevale la parte razionale (l’auriga).Nella Timocrazia,invece,prevale la parte irascibile (il cavallo bianco),desideroso di farsi onore.Subito sotto alla Timocrazia troviamo l’oligarchia,il governo dei pochi che però non sono i migliori:si servono del loro potere per arricchirsi,accecati dalla cupidigia.Ad un livello al di sotto troviamo la democrazia,che si viene ad instaurare quando la massa degli ignoranti diventa gelosa delle ricchezze degli oligarchici:il “demos” volge a suo favore i beni che prima erano dell’oligarchia.ai tempi di Platone la democrazia corrispondeva grosso modo con l’anarchia dove ciascuno faceva ciò che voleva e vigeva la maleducazione totale.Subito sotto troviamo la tirannide:dalla democrazia si passa alla tirannide quando la massa ignorante si fa abbindolare dai demagoghi che promettono sempre maggiore libertà.Essi dicono che tutti ce l’hanno con loro e che per dare al popolo la libertà promessa han bisogno di guardie del corpo e così nasce la tirannide.Platone arriva adimostrare che il destino dell’uomo giusto sono la felicità e la giustizia.Egli è felice nella vita terrena perchè la giustizia lo appaga e gli rende l’anima sana.Nel libro 10° della “Repubblica” PLatone afferma che dopo la morte per i giusti ci sarà ulteriore felicità,per gli ingiusti altra infelicità.Pur avendo già dimostrato che l’anima è eterna in modo razionale,Platone si serve poi di un mito,il celebre mito di Er ,un guerriero della Panfilia morto in battaglia.Il suo corpo viene raccolto e portato sul rogo (era un’usanza greca):proprio prima che gli diano fuoco si risveglia e racconta ciò che ha visto nell’aldilà,affermando che gli dei gli han concesso di ritornare sulla terra per raccontare agli altri uomini ciò che ha visto.Dice di aver visto 4 passaggi attraverso i quali le anime salgono nella dimensione ultraterrena,da un passaggio le buone,dall’altro le malvagie,e tramite i quali ritornano sulla terra.Infatti,dice,le anime buone finivano in una sorta di Paradiso dove godevano,le cattive in una sorta di Purgatorio (l’Inferno era un fatto raro,destinato solo ai più malvagi).I giusti ricevono premi per 1000 anni,i malvagi soffrono.Dopo questi 1000 anni le anime buone e quelle cattive si devono reincarnare.Esse si recano al cospetto delle 3 Moire che devono stabilire il loro destino.Le anime vengono radunate da una specie di araldo che distribuisce a caso dei numeri,seguendo una prassi che può ricordarci quella dei supermercati;infatti prende i numeri e li getta per aria ed ogni anima prende quello che le è caduto più vicino (questo sottolinea come nella nostra vita ci sia comunque una componente di casualità).Il numero serve per dare un ordine alle anime che devono scegliere in chi reincarnarsi;chiaramente chi ha il numero 1 è avvantaggiato perchè ha una scelta maggiore,ma deve comunque saper scegliere bene.Dunque c’è sì una componente di casualità,ma in fin dei conti la nostra vita ce la scegliamo noi:è vero che per chi nasce,per esempio,in una famiglia agiata è più facile essere onesti rispetto a chi nasce in una famiglia povera,oppure chi nasce in una famiglia onesta è avvantaggiato rispetto a chi nasce in una famiglia disonesta,ma tuttavia la nostra vita ce la scegliamo noi.Ma quelli che hanno numeri sfavorevoli non sono necessariamente svantaggiati perchè scelgono dopo:in primo luogo le possibilità di scelta che gli restano sono sempre tantissime,in secondo luogo chi è primo non sempre effettua buone scelte; Er racconta che nel suo caso chi scelse per primo scelse la tirannide che gli aveva fatto una buona impressione (infatti lassù si vedono le cose sotto forma di oggetti:forse la tirannide aveva dei bei colori,chi lo sa?).Costui,non appena si era accorto di ciò che comportava l’essere tiranno,non voleva più esserlo,ma era troppo tardi:le Moire gli danno l’incarico di tiranno e lo lanciano sulla terra,dopo averlo immerso nel fiume Lete perchè dimentichi (Er chiaramente non è stato immerso).Er dice che per ultima era arrivata l’anima di Ulisse e che,stanca della passata vita “movimentata”,scelse la vita di un comune cittadino.Platone fa notare che di solito chi veniva dal Paradiso tendeva ad effettuare scelte sbagliate,mentre chi veniva dal Purgatorio e aveva sofferto sceglieva bene.Infatti chi aveva vissuto per 1000 anni di beatitudine si era scordato di che cosa fosse la sofferenza.Quindi chi ha sofferto sceglie bene e sceglie una buona vita che lo porterà al Paradiso,mentre chi ha goduto sceglie male e dopo che ri-morirà finirà in Purgatorio.Pare quindi un circolo vizioso,ma in realtà Platone dice che il motivo per cui si sceglie una vita buona o una cattiva può derivare da doti naturali:ci sono infatti persone portate a comportarsi bene per inclinazione naturale:vi è anche chi ha conoscenze basate sulla doxa (l’opinione) e che può cogliere alte realtà,ma solo casualmente,senza riuscire a fornire motivazioni:costoro,che conducono una vita buona per caso,non radicata nella coscienza,si smontano facilmente nel Paradiso quando godono e finiranno per scegliere male.Chi ha invece raggiunto il bene in sè,la super-idea del bene,non cadrà mai nel male.Secondo alcuni studiosi nella fase della vecchiaia è come se Platone effettuasse un’autocritica della dottrina delle idee:essa,infatti,risolve alcuni problemi per crearne altri;non si è totalmente certi che sia realmente un’autocritica e c’è chi sostiene semplicemente che Platone si faccia portatore di discussioni che si tenevano nell’Accademia ,un luogo aperto dal punto di vista intellettuale:forse vi fu chi non approvò la teoria delle idee e la contestò.Vi sono anche indizi che ci inducono a pensare che sia così:il “Parmenide” rientra in questi dialoghi e vede al centro la figura di Parmenide perchè si affronta il problema del rapporto tra l’uno ed i molti,molto caro a Parmenide appunto,e quello del rapporto idee-superidea del bene;i temi centrali sono quelli dei tempi di Parmenide (il dialogo è ambientato in quel periodo):è come se Platone riprendesse ciò che era stato lasciato in sospeso anni addietro.Protagonisti del dialogo sono Socrate , Parmenide e Zenone, discepolo di Parmenide ;questo dialogo può per diversi aspetti essere accostato al “Sofista”,dove il protagonista è “lo straniero di Elea”,la città di Parmenide e di Zenone.Il vero tema centrale del “Parmenide” è quello riguardante le idee e le cose,a cui Platone aveva finora solo accennato senza mai sbilanciarsi troppo : che cosa intendesse per “compartecipazione”,per esempio,non l’aveva ancora detto : arriva a dire che le idee sono ciò in virtù di cui le cose empiriche possiedono certe caratteristiche . Nel Parmenide sono attestate l’una accanto all’altra e con pari legittimità una versione concreta e materiale e una versione astratta e metaforica della compartecipazione : nella sua versione concreta , la partecipazione delle cose empiriche ad un’idea implica che l’idea sia effettivamente presente nelle cose partecipanti : ad esempio , tutte le cose empiriche molteplici si rivelano molteplici in quanto l’idea della molteplicità è presente in esse . Nella sua versione astratta e metaforica , invece , la partecipazione consiste nella somiglianza delle cose empiriche ad un’idea . Affronta questo problema partendo proprio dall’uno ed i molti.Tuttavia , se Platone si distacca dal maestro Socrate , egli è e gli resta fedele ; è e resta fedele cioè all’ideale , che questi incarna , della filosofia come continua ricerca.Pure nel “Sofista” c’è il problema uno-molti,ma non è riferito al rapporto tra idee e cose,bensì tra idee e basta:è una questione tutta interna alle idee.Va subito rilevato che nel “Parmenide” ed in generale in tutti questi dialoghi della vecchiaia vi è un’attenuazione dell’aspetto dinamico,forse dovuto all’età:la fantasia giovanile tende a venir meno,così come la figura di Socrate tende a sfumare; mentre il “Simposio” è un esempio della letteratura greca,il “Parmenide” non lo è : testimonia la volontà di addentrarsi in discussioni tecniche e di conseguenza lo stile si fa più arido.Anche la figura di Socrate tende a diventare marginale ed a sparire:ciò significa che i temi di Platone sono davvero estranei e distanti da Socrate e non se la sente di metterglieli in bocca;è evidente che quando si parla di virtù e di giustizia ci si può riallacciare a Socrate ,ma i problemi metafisici e ontologici non erano materie che rientravano negli interessi del maestro di Platone.Nel “Parmenide” la figura di Socrate è addirittura quella di un ragazzino:volendo introdurre Parmenide per questioni cronologiche è costretto a mettere in gioco un Socrate giovane ed un Parmenide vecchio (Zenone è un uomo maturo);fatto sta che Platone deve comunque aver forzato leggermente la cronologia per immaginare l’incontro.Parmenide nel dialogo è sempre accompagnato dagli aggettivi “venerando” (sia perchè è anziano sia perchè Platone lo ritiene il fondatore della filosofia astratta) e “terribile” (ragionava in modo così logico e razionale da mettere in crisi).In tutti i dialoghi che abbiamo esaminato Socrate è sempre stato il protagonista indiscusso in cui Platone si identificava;ma nel “Parmenide” in chi dei tre si identifica ? Da un certo punto di vista si identifica in Parmenide ,da un altro in Socrate ;compare come Socrate nella forma giovanile,come Parmenide in quella senile.Il nucleo del dialogo ruota intorno a Socrate che fa delle affermazioni e a Parmenide che le corregge,dicendogli che da grande capirà.Vi è una interpretazione ingenua e giovanile delle idee ed una più senile e completa: Parmenide non è che dica cose opposte,si limita a correggere ed a rendere più complesse e complete le affermazioni di Socrate .E’ Platone anziano che si confronta con Platone giovane,ma può anche essere Platone che si confronta con chi nell’ Accademia contestava la dottrina delle idee.Come detto il “Parmenide” affronta due tematiche:l’uno-molti,che viene discusso a livello astratto,e idee-cose.Cosa significa in concreto che molte cose partecipano a un’idea sola ? Platone avanza diverse ipotesi e le respinge un pò tutte:per esempio ipotizza che il rapporto di partecipazione sia di presenza:un’unica idea sarebbe quindi presente in più cose,ma sarebbe molteplice e non più unità del molteplice:infatti ce ne sarebbero tantissime.Vi è poi la famosa argomentazione del “terzo uomo”,nella quale si evidenzia la difficoltà nel rapporto idee-cose:Parmenide ,dopo che Socrate ha esposto la dottrina delle idee, afferma che l’idea è quindi ciò che unifica molte cose,che il ragionamento è che tante cose insieme presentano una cosa in comune:gli uomini hanno una cosa in comune:l’idea di uomo.Ma l’idea di uomo,che rappresenta l’unità,dovrà per forza avere qualcosa in comune con gli uomini:gli uomini sensibili si assomigliano perchè imitano l’idea di uomo;ma un rapporto di somiglianza non c’è solo tra gli uomini sensibili,ma anche con l’idea di uomo:se ci sono gli uomini e l’idea di uomo e sono tra loro simili,ci deve essere per forza essere qualcosa di comune all’idea di uomo e agli uomini che li rende simili,che li accomuna:ci deve essere un terzo uomo;questa argomentazione può andare avanti all’infinito perchè ci dovrà sempre essere qualcosa in comune.Vi è chiaramente una contraddizione nella dottrina delle idee,che era servita per semplificare la realtà ma che la complica ammettendo la molteplicità:gli enti invece di ridursi si moltiplicano all’infinito.Vi è poi una terza argomentazione: Parmenide chiede a Socrate di che cosa ammette che ci siano le idee e lui risponde citando le cose astratte quali la giustizia,la bellezza,gli enti matematici…Dice di non essere certo che esistano idee degli oggetti sensibili veri e propri:l’idea di albero,di cavallo,di cane…Platone era ricorso a queste idee:per spiegare l’attività di un artigiano aveva perfino ammesso che le idee potessero essere create dall’uomo:Platone si era occupato del problema delle tecniche e aveva ammesso che ci fossero delle tecniche di produzione e delle tecniche di uso;chi costruisce le briglie per i cavalli mette in atto la tecnica di produzione ,il cavaliere che cavalca quella di uso.Il cavaliere deve sapere come le briglie devono essere usate,come funzionano,come devono essere:dà le indicazioni all’artigiano che le fa come vuole il cavaliere.Chi applica la tecnica di uso crea un’idea che l’artigiano deve imitare:egli guarda ad un’idea creata da chi mette in pratica la tecnica d’uso.Platone sembra ipotizzare la produzione delle idee:l’idea di tavolo,per esempio,è una sorta di idea che gli uomini si fanno.Chiaramente in una ipotetica scala gerarchica chi usa è più in alto di chi produce.Socrate dice che certamente non esistono le idee delle cose spregevoli ed insignificanti:ad esempio,il fango ed il capello che corrispettivo possono avere nel mondo delle idee,dice Socrate.Ma Parmenide gli dice di pensarci bene e forse un giorno capirà.Socrate stava evidentemente pensando alla valenza assiologica:l’idea è il punto cui le cose sensibili devono mirare,è il meglio verso cui tendere.Come si può tendere all’idea di fango ? Però Parmenide ,ontologo per eccellenza,dice che se l’idea deve essere l’essenza di ogni cosa ,anche il fango dovrà avere una sua idea. Parmenide fa qui notare che nel concetto di idea la valenza ontologica contrasta con quella assiologica,cosa che peraltro Platone sapeva benissimo : proprio per questo possiamo leggere il dibattito Parmenide–Socrate come uno scontro tra il Platone ontologico e quello assiologico . In effetti se pensiamo al piano assiologico pare impossibile che esistano idee di cose spregevoli : se però consideriamo quello ontologico , così come un cavallo esiste nella misura in cui compartecipa all’idea di cavallo , anche il fango o la sporcizia esistono nella misura in cui imitano l’idea di fango e di sporcizia . Parmenide poi mette definitivamente a tacere Socrate con un’ultima obiezione : comunque venga concepita , l’ipotesi della compartecipazione pare in contrasto con l’assunto della separazione delle idee; in effetti se le idee rimangono davvero separate dal mondo sensibile , esse saranno in relazione tra loro soltanto ma non con il mondo sensibile degli uomini , come d’altronde anche le cose empiriche si porranno le une in rapporto alle altre senza alcun genere di contatto con le idee . Pertanto se vi è questa separazione nettissima che Platone (qui Socrate) aveva sempre predicato tra mondo sensibile e mondo intellegibile , nessuna partecipazione tra idee e mondo sensibile sarà ammessa e così neppure nessuna conoscenza delle idee per noi uomini sarà possibile . Questa difficoltà è indicata da Parmenide come “la più grande di tutte” (“megiston dè tòde”) : le idee devono per forza rimanere in sè e per sè , radicalmente separate dal mondo sensibile , perchè la separazione ne preserva l’assoluta superiorità ontologica , stabilendo un’incolmabile discontinuità rispetto alle cose empiriche .Va notato che Platone,in ogni suo dialogo,prende spunto un pò da tutti gli altri filosofi e Parmenide non fa eccezione : l’idea platonica è unità e stabilità proprio come l’essere parmenideo.L’istanza etica di Socrate vuole idee solo positive e guarda alla assiologia , mentre Parmenide è interessato all’essere,al piano ontologico:d’altronde è risaputo che Socrate fosse un antropologo,una persona che si interessava ai valori.Platone si rende conto che è Parmenide ad avere ragione e non Socrate .Nel dialogo Parmenide discute sul rapporto tra l’uno ed i molti:è una discussione a tal punto tecnica e complessa che si è arrivati a pensare che si tratti di una parodia,una presa in giro da parte di Platone di alcune scuole. Comunque Platone mette in discussione la dottrina delle idee anche nell’ ” Eutidemo “ , dove viene tirato in ballo un quesito piuttosto strano : se una cosa stando vicino all’idea di bellezza diventa bella , Socrate stando vicino a Platone diventa Platone ? Tornando al “Parmenide” , in esso comincia a trasparire una nuova accezione della parola “dialettica”,tipica di Socrate e di Platone : originariamente designava il dialogo socratico , poi è passata a designare la tecnica argomentativa di Platone ed è anche divenuta sinonimo di “filosofia”;nel Parmenide” il significato si sposta da un certo modo di affrontare la conoscenza al rapporto tra le idee:non esiste solo un dialogo-scontro tra gli uomini (quello che dava vita alla fiamma) che aumenta la conoscenza , ma anche tra le idee : lo “scontro” si sposta dal soggetto della conoscenza all’oggetto.Il concetto dell’uno ed i molti si richiamano a vicenda:non si può conoscere pienamente il concetto di uno se non si conosce il concetto di molti e viceversa.Un modo per sintetizzare la filosofia di Parmenide può essere l’affermazione “l’uno è” ,la negazione della molteplicità ;Platone dice che quando si predica il concetta di uno lo si moltiplica:se non si predicasse affatto sarebbe davvero uno ,ma se ne parlo non è già più uno,è già due:gli si aggiunge il concetto di essere.”L’uno è l’essere” :affermo il molteplice perchè lo predico : nego e affermo nello stesso tempo.Le idee non sono una accanto all’altra,ma se le accosto dialogano e si scontrano.Questo è il nuovo significato di dialettica,che non designa più solo un metodo di indagine:diventa anche la struttura della realtà.Di conseguenza la dialettica è lo strumento migliore di ricerca della realtà perchè essa stessa è la realtà:c’è uno stretto rapporto tra la realtà soggettiva e quella oggettiva.Questo concetto viene trattato nel “Sofista” ancora di più che nel “Parmenide”.Un altro problema,molto astratto e legato alla possibilità di ragionare,che Platone affronta in età avanzata (e anche in gioventù) ed in diversi dialoghi è quello riguardante il vero e il falso,in parallelo con l’essere ed il non essere : si torna a problematiche parmenidee e viene messa da parte la figura di Socrate.La possibilità di poter distinguere il vero dal falso è legata al poter commettere errori ed il tema viene affrontato nel “Sofista” ;già dal titolo dell’opera si può intuire la solita critica platonica dei sofisti,già avanzata in gioventù:qui però è trattata con sfumature più ontologiche.Che cosa c’entrano i sofisti con il vero-falso e l’errore ? Si può sbagliare solo quando si può porre una differenza tra vero e falso : Gorgia e Protagora ,i due maggiori esponenti sofisti,erano rispettivamente del parere che tutto fosse falso ( Gorgia ) e che tutto fosse vero ( Protagora ):per entrambe non vi è la distinzione tra vero e falso 😮 ce n’è uno o l’altro,si basano sul fatto di non poter distinguere il vero dal falso.Per Parmenide dire il falso vuol dire ammettere il non essere,le cose come non sono (il che è impossibile);per Parmenide si dice e si pensa solo ciò che è,ciò che esiste.Questo spiega come un dialogo tutto incentrato sulla filosofia eleatica si leghi al sofismo:le tesi eleatiche e quelle sofiste mirano ad affermare che l’errore sia impossibile,che non ci sia la distinzione tra vero e falso.Sono posizioni differenti che portano alle stesse conclusioni,sebbene in modi diversi.Il “Cratilo” ed il “Teeteto” sono dialoghi dove si cerca di contestare la possibilità di non errare : se non esiste la possibilità di sbagliare tutti i discorsi saranno o veri o falsi;se tutto è vero o falso e non c’è la via di mezzo viene a perdere di significato perchè una cosa è sensata quando contiene un pò di verità,ma anche un pò di falsità,quando si trova in una via di mezzo (ancora una volta Platone assume posizioni intermedie);se non si ammette l’errore non si può ammettere la verità,che è ciò che non è sbagliato.Il “Cratilo” prende il nome da un seguace di Eraclito,che però aveva radicalizzato le posizioni del maestro e si era molto soffermato sul “panta rei” (tutto scorre):a suo avviso è impossibile dare i nomi alle cose perchè cambiano di continuo:noi chiamiamo Pò un fiume ma non è corretto:non esiste qualcosa che si chiami Pò perchè cambia in continuo (è un esempio evidente perchè le acque si rinnovano in continuazione);si fissa artificialmente una cosa che non è fissabile perchè in continua mutazione.Cratilo con il “panta rei” arriva a dimostrazioni sofistiche:è impossibile conoscere qualcosa che cambia sempre.Quindi in teoria ,dal momento che non si possono attribuire nomi,bisognerebbe solo indicare le cose.Secondo alcuni studiosi Platone stesso sarebbe stato allievo di Cratilo,il che può sembrare strano se consideriamo la dottrina delle idee,in cui viene ammesso un essere fisso,stabile e permanente.Pensandoci bene,però,non è poi così strano:Platone deve aver constatato che nel mondo sensibile non c’è nulla di stabile ed è ricorso alle idee.Platone nel “Cratilo” effettua un’ampia discussione sulla problematica della lingua.Al tempo dei sofisti vi erano state interessanti considerazioni a riguardo , legate al binomio “nomos”-“fusis” (convenzione-natura);questo della lingua è un problema tipicamente antropologico e di materia sofistica.Alcuni sofisti erano del parere che si attribuiscano i nomi in maniera spontanea,secondo natura (“katà fusin”),come se la natura stessa ci suggerisse la nomenclatura di cui servirsi nei suoi confronti.Altri la pensavano in modo opposto:gli uomini attribuiscono i nomi in maniera assolutamente artificiale,secondo convenzione (“katà vomon”).Questa diatriba è in corso ancora al giorno nostro;Platone,dal canto suo,sostenne che attribuiamo i nomi un pò “katà fusin” e un pò “katà nomon”.Nella tradizione ebraico-cristiana vi è il mito della torre di Babele;la lingua di Adamo (l’ebraico) sarebbe stata naturale ed i nomi corrispondevano esattamente all’essenza delle cose e proprio con i nomi si poteva cogliere l’essenza delle cose.Nella torre di Babele i linguaggi successivi sarebbero stati convenzionali e non vi era più piena corrispondenza tra i nomi e le cose.Platone è dunque del parere che la soluzione sia intermedia e noi moderni concordiamo con lui:vi è una mescolanza dei fenomeni.Esiste sì una derivazione naturale dei nomi:sono le cose stesse che suggeriscono i nomi da usare,ma le lingue parlate sono molteplici:una componente di arbitrareità ci deve per forza essere.Quindi le cose tendono a suggerire il nome con cui chiamarle ma dopo di che l’uomo ci lavora sopra correggendo il tutto con la ragione:ancora oggi,comunque,ci sono parole onomatopeiche,che suggeriscono l’essenza del soggetto cui sono riferite (“zanzara”,”cornacchia”…).Si tratta di una teoria intermedia che mette insieme il lavoro razionale a quello naturale.Ma cosa c’entra tutto questo nell’ambito del “Cratilo” e della discussione del vero-falso ? Più di quello che potrebbe sembrare : per Platone entrambe le possibilità per denominare le cose negano la possibilità dell’errore : le parole corrispondono esattamente alle cose;o sono totalmente artificiali o totalmente naturali:si arriva alla stessa conclusione.Se mi attengo alla teoria “katà fusin” un libro mi suggerisce la parola con cui chiamarlo ed è solo quella:non c’è possibilità di errore.Se mi attengo al “katà nomon” i nomi sono totalmente artificiali e quindi vanno bene tutti :lo posso chiamare libro,ma anche tavolo,scarpa…sarà in ogni caso corretto e anche qui non c’è possibilità di sbagliare:infatti in assenza di un arbitrio generale tutti i nomi risultano corretti.Il far corrispondere al meglio (con un misto di lavoro naturale e artificiale) il nome all’essenza delle cose consente di affermare che l’errore esiste e che la retorica (quella vera è ) è la filosofia.Platone sposta poi il problema dalle cose alle idee:così come si possono dare nomi alle cose che si conoscono,si possono dare nomi alle idee che si conoscono:c’è una dimensione conoscitiva e vi è uno sforzo di attribuire nomi che esprimano l’essenza di ciò a cui si riferiscono.Il “Teeteto” è un dialogo dedicato alla matematica:il protagonista , Teeteto , è un giovane matematico che in futuro diventerà famoso.E’ anche dedicato alla conoscenza sensibile e a quella intellegibile,che è quella vera e propria.Quando si parla della conoscenza sensibile viene citato Protagora,che sosteneva che le cose sono come mi sembrano e che l’uomo è misura di ogni cosa:si tratta del relativismo assoluto.Platone è interessato a ciò perchè siamo di fronte al rapporto tra vero e falso.Per poter ragionare,come detto,occorre ammattere l’esistenza del vero e del falso.A supportare le tesi di Platone è un suo allievo, Aristotele ; egli dice che con i sofisti non si può neppure discutere perchè ,dal momento che sostengono che tutto sia vero o che tutto sia falso , nel momento in cui un sofista discute smonta le sue stesse tesi perchè in un certo senso ammette la distinzione tra vero e falso,la possibilità dell’errore:se infatti ci fosse solo il vero o il falso che motivo ci sarebbe di discutere ? C’è anche chi vuole che il “Parmenide” sia in realtà una confutazione da parte di Aristotele delle teorie del maestro Platone : dunque Socrate rappresenterebbe Platone,mentre Parmenide Aristotele.In effetti ci sono numerosi indizi a sostegno di questa tesi : la stessa argomentazione del terzo uomo la ritroviamo in testi di Aristotele ed è quindi probabile che sia sua a tutti gli effetti.D’altronde Aristotele non condivise mai pienamente le teorie del maestro e se rimase nell’Accademia fino a oltre trent’anni fu solo per il rispetto che aveva nei confronti di Platone.Nel “Sofista” Socrate compare come interlocutore secondario in quanto il vero protagonista è lo “straniero di Elea” ,una figura misteriosa, che non possiamo far coincidere nè con Parmenide nè con Zenone ,e che alla fine dovrà effettuare il “parricidio” di Parmenide : arriverà cioè a rivedere le tesi dell’ontologo Parmenide e ad ammettere il non essere.Perchè se il protagonista è un eleatico il dialogo si chiama il “Sofista” ? Evidentemente perchè sia gli eleatici sia i sofisti miravano a negare l’esistenza del non essere:per i sofisti ammettere il non essere è ammettere il falso,per gli eleatici (ed in particolare per Parmenide ) ammettere il non essere significa ammettere un’ altra entità:per loro solo l’essere è e solo l’essere può essere detto.In linea di principio il tema principale del dialogo dovrebbe essere la ricerca di che cos’è il sofista tramite la ricerca di una definizione (è un processo che molto ricorda quello effettuato da Socrate).In realtà per arrivare alla conclusione si fa un giro molto lungo dove si trattano numerosi temi,il più importante dei quali è l’essere (ricordiamoci che “lo straniero” è un eleatico).Che cos’è l’essere ? Lo straniero (quindi Platone) pone due possibili alternative di interpretazione effettuate da due diversi gruppi di persone : lo scontro tra i due gruppi viene paragonato al conflitto tra i Titani e gli Dei . Gli uni vivevano sulla terra e rappresentavano la forza terrena e materiale , gli altri in cielo.I due gruppi che si scontrano nel “Sofista” sono i materialisti (paragonati ai Titani )che sostengono che l’essere è solo quello materiale e gli idealisti (paragonati agli Dei)che affermano che il vero essere sia quello ideale (Platone li chiama “amici delle idee”).Chiaramente Platone fa riferimento alle teorie di Democrito,materialista per eccellenza : egli fu il primo a depurare la materia da concezioni vitalistiche e “ilozoistiche”.Platone in qualità di filosofo idealista vede in Democrito un acerrimo nemico e la sua netta contrapposizione tra mondo sensibile e mondo intellegibile è un modo per dare contro all’avversario : è chiaro che se Platone fosse vissuto prima di Democrito non avrebbe formulato tutte le teorie che ci sono pervenute.I filosofi sono grandi o quando rompono decisamente con la filosofia a loro precedente o quando operano grandi sintesi dei loro “antenati” per creare un qualcosa di nuovo : è proprio questo il caso di Platone nella cui filosofia troviamo tutti i filosofi precedenti : Socrate ,i sofisti , i pitagorici , Parmenide , Eraclito (questi ultimi due hanno addirittura concezioni antitetiche : il primo è il filosofo dell’essere , l’altro del divenire : per Platone le idee sono l’essere pieno mentre le realtà empiriche sono il divenire).Un grande filosofo si serve anche di chi dice cose opposte alle sue : è il caso dei sofisti che si inseriscono in modo “dialettico” nella filosofia platonica ; basti pensare alla questione della seconda navigazione (che Platone effettua perchè non può accetare la ricerca delle cause materiali) o alla reminescenza (che Platone tira in ballo partendo dalle affermazioni sofiste secondo le quali è impossibile imparare).Già solo leggendo i titoli delle opere platoniche ci si accorge di come ci sia tutta la filosofia dell’epoca.Tra i personaggi che Platone cita , quello che viene sempre meno ricordato è Democrito , il cui nome di fatto non compare mai;Platone probabilmente lo conosceva benissimo e lo considerava il suo nemico naturale e l’espressione che compare nel dialogo platonico “l’essere non è nient’altro che il corpo” è senz’altro di Democrito,il materialista più convinto.Come detto,Platone contrappone gli idealisti ai materialisti:entrambe hanno torto,come dirà lo straniero,ma i materialisti sono un caso disperato ed irrecuperabile : sono teste dure con cui è impossibile il dialogo e quindi Platone dice che supporrà un dialogo fittizio con loro (immaginandosi materialisti più aperti e meglio disposti) perchè di fatto sarebbe impossibile parlare con gente così cocciuta e rigida,rigida proprio come ciò che sostengono,quasi come se la loro testa fosse piena di quella materia che vedevano ovunque : cercano di portare tutto sulla terra,come i Titani cercavano di far scendere dal cielo gli Dei. Democrito è quindi l’avversario più temibile e che più di chiunque altro va sconfitto e Platone costruisce la propria filosofia proprio per dargli contro ; chiaramente non si sarebbe potuti arrivare ad una posizione idealista se prima non ci fosse stato chi sosteneva il materialismo:sono posizioni antitetiche ma l’esistenza dell’una determina quella dell’altra.Sullo sfondo di questo scontro tra i due gruppi e tra le loro definizioni di essere,anche lo straniero dà la sua definendo l’essere come “dunamis” (possibilità , potenza):possibilità a fare che cosa ? Esiste tutto ciò che può agire o può subire una cosa : anche l’azione più piccola connota l’esistenza.A questo punto i materialisti affermano che solo ciò che è un corpo può subire o compiere azioni : essi non si limitano a dire che i corpi esistono,ma sostengono che siano le uniche cose ad esistere.Platone dice (muovendo una critica tipicamente idealista) che non è vero : se ammettiamo l’esistenza solo dei corpi cadiamo in una contraddizione.Se esiste solo ciò che è materiale,la giustizia esiste ? Platone si serve della dimostrazione per assurdo,tipica di Zenone : ammettiamo che la giustizia non esista :con che criterio diciamo che una cosa è giusta o sbagliata ? E’ inammissibile che non esista in quanto le cose sono giuste nella misura in cui compartecipano all’idea di giustizia.Ammettendo che esista è alquanto facile dire che essa non sia una realtà materiale.L’ipotesi che l’essere sia solo materiale cade miseramente.Anche “gli amici delle idee” hanno torto,ma chi sono ? Sono coloro che sostengono le tesi di Platone e che pur sbagliando sono aperti al dialogo : potrebbero tranquillamente rappresentare il Platone di tempi addietro , quando aveva appena scoperto la dottrina delle idee e non aveva ancora pensato ai problemi che potevano derivarne e gli pareva che tutto filasse liscio.Però gli “amici delle idee” possono anche rappresentare posizioni interne all’Accademia ma troppo rigide : essi stanno quindi dalla parte di Platone,che però li critica.Dove sbagliano ? Essi (ma anche Platone stesso nella sua giovinezza) sostengono la dottrina delle idee recuperando concetti tipici della filosofia parmenidea : le idee hanno infatti carattere di unicità , permanenza , eternità ,immobilità … Platone evidenzia particolarmente un aspetto : la presunta immobilità e separazione reciproca delle idee . Come detto, “gli amici delle idee” sostengono anche l’esistenza delle cose non materiali e di conseguenza delle idee in quanto subiscono un’azione :vengono pensate e conosciute.Così,però,entra in crisi la concezione delle idee come un qualcosa di immobile : esse esistono nella misura in cui subiscono un’azione e di conseguenza è ovvio che ciò comporti il movimento.Le idee si muovono perchè subiscono l’azione dell’essere conosciute. Dopo di che , Platone passa ad esaminare 5 idee di fondamentale importanza : l’essere , la quiete , il movimento , l’identico , il diverso .Platone fa subito notare come queste 5 idee siano in rapporto complesso tra di loro ed è come se fossero vive perchè hanno rapporti complessi le une con le altre.Si arriva a dire che il mondo delle idee sia un mondo vivo , dotato di intelligenza (sennò come farebbero le idee ad avere rapporti complessi ? );queste 5 idee sono tra l’altro molto importanti per esemplificare che il mondo delle idee non è affatto statico.Dapprima si considerano l’essere , la quiete ed il movimento:derivano tutte e tre dalla discussione precedente (l’essere e le 2 ipotesi , quella dei materialisti,secondo i quali l’essere è in continua evoluzione e non è mai lo stesso , e quella degli idealisti ,secondo cui è un essere immobile )e si comincia una complessa e articolata indagine per analizzare i vari rapporti che intercorrono tra queste idee : ogni idea , infatti , partecipa di altre idee,senza però identificarvisi : è chiaro che solo l’idea di essere è l’idea di essere , ma tutte le altre idee ne partecipano : infatti tutte le idee esistono , sono.Solo l’idea della quiete è l’idea della quieta,ma molte altre ne partecipano(lo stesso vale per quella di movimento).Si passa poi all’idea di identico e di diverso:ogni idea è identica a se stessa e diversa dalle altre , pur non identificandosi nell’idea di identico e di diverso.L’idea stessa dell’essere partecipa all’idea di non essere perchè l’essere è se stesso ma non è nessun’ altra idea.da qui nasce il famoso parricidio di Parmenide : anche il non essere è ,esiste ; si evidenzia quindi la distinzione di essere con valore copulativo (quel libro è bello) da essere con valore esistenziale (l’uomo è):dire “una cosa non è” non vuol dire negare la sua esistenza , ma dire che è diversamente : la penna non è il libro.Nasce quindi la possibilità dell’errore , che prima pareva negata : sbagliare significa dire le cose diversamente da come sono.Vi è quindi il nuovo valore della parola “dialettica”:le idee si richiamano le une alle altre e tra loro intercorrono comlessi rapporto:sono vive e “pensanti” , in quanto si rapportano tra di loro secondo una logica.Secondo Platone le idee sono come le lettere dell’alfabeto che si possono legare e formare un numero quasi infinito di parole ,attenendosi però alle precise regole del discorso;così le idee si possono legare con altre idee (ma non con tutte) secondo determinate leggi e non a caso (come le parole unite a caso non hanno senso , così anche le idee).Le due mansioni che la dialettica deve svolgere sono la “sunopsis” (sun + orao = vedere insieme -> unire ) e la “diairesis” (dià + aireo = dividere attraverso -> divisione ):per Platone bisogna agire come un macellaio che taglia le carni seguendo le articolazioni : occorre ritagliare il mondo delle idee ,che si ricollegano, secondo confini reali:bisogna mettere insieme ciò che va messo insieme e tagliare ciò che va separato.Si arriva a definire il sofista come “cacciatore di giovani” che va a caccia di giovani ricchi da cui spillare soldi:alla definizione si arriva mediante la “diairesis”:in primis bisogna definire la categoria generalissima a cui appartiene la cosa che stiamo definendo:nel caso del sofista bisogna subito “ritagliare” la tecnica.Ma si tratta di una tecnica di produzione o di acquisizione ? Chiaramente nel caso del sofista è acquisizione .Ma si possono acquisire diverse cose : animali , commercianti …La “diairesis” consiste nell’individuare la categoria generalissima e da lì dividere sempre a metà : ogni volta si arriva ad un bivio e si deve scegliere da che parte svoltare , per poi trovarsi ad un altro bivio finchè non si arriva ad una specie ultima , quando cioè la divisione mi porterebbe a trovare solo personaggi (nel caso del sofista Gorgia , Protagora ).Nell’ambito dei dialoghi composti in età avanzata troviamo il “Timeo” , che ha in comune con tutti gli altri dialoghi della vecchiaia il fatto che si facciano vedere le idee in una dimensione più dinamica e si evidenzino i rapporti che intercorrono tra le idee stesse (il “Sofista” ) e tra idee e cose (il “Parmenide” ).Nel “Timeo” si parla in modo particolare del rapporto idee-cose e Platone si occupa del mondo fisico a tal punto che non è sbagliato definire il “Timeo” libro fisico (da “fusis”,libro della natura).Infatti finora non si era praticamente occupato del mondo sensibile se non per affermare che è una pallida copia del mondo delle idee e per evidenziare la sua inferiorità rispetto al mondo intellegibile.Dato che era un argomento meno importante e che il “filosofo” si muove tra le idee , Platone dedicò solo un’ opera al mondo sensibile, che ci viene presentato come “il mondo in cui si muove l’uomo”.Il “Timeo” ci viene da Platone presentato come continuazione della “Repubblica” :è come se dopo aver parlato dello stato ideale , Platone si cimentasse a descrivesse il mondo fisico in cui lo stato deve operare.Va poi ricordato che il “Timeo” e il “Crizia” sono i dialoghi del mito di Atlantide , città nemica della Atene preistorica che era vista come realizzazione dello stato ideale:chiaramente Atene è collocata in un tempo senza tempo,è vista come città mitica.Questo mito tutto platonico serve a far conoscere qualcosa che non è pienamente coglibile con il raziocinio (le idde sono l’essere pieno e quindi effettivamente conoscibili con la ragione : il mondo sensibile è in continua mutazione e di conseguenza non è un essere pieno e non può essere conosciuto con la ragione;così era anche per il mito della caverna in cui si parlava del bene in sè,che era al di sopra delle idee e quindi non era pienamente conoscibile con la ragione).Questo mito verosimile viene presentato in un contesto pitagorico (il protagonista,Timeo ,è di Locri ,nell’attuale Calabria;non si sa però se codesto Timeo sia realmente esistito o sia un’ invenzione platonica come molti sofisti;fatto sta che Timeo rappresenta il “pitagorico” )e presenta una cosmogonia (come è nato il mondo) e una cosmologia (come è fatto il mondo).Descrivendo la nascita del mondo Platone si serve di una metafora (ricordiamoci che stiamo parlando di una “opinione vera”) biologica : il mondo in cui viviamo ha un padre e una madre:il padre è il mondo delle idee mentre la madre è la materia (notare che la parola materia deriva dal latino “mater” = madre).Secondo Platone il padre fornisce la forma mentre la madre la materia ( a quei tempi si dava per scontato che l’aspetto più nobile della riproduzione fosse paterno,mentre l’aspetto materno era ritenuto inferiore sebbene essenziale).Dunque ci sono questi due elementi , il padre (ricordiamoci che la forma del mondo sensibile deriva,nella misura in cui ne compartecipa, da quella del mondo intellegibile) e la madre (Platone per definirla non usa la parola materia,in greco “ule”,che verrà poi introdotta da Aristotele ,ma “concausa”,per il fatto che la madre ha un ruolo secondario rispetto al padre,o “causa necessaria”,per il fatto che la materia è la condizione per la realizzazione di qualcosa:c’è sì il cavallo ideale , ma senza materia con cui plasmare non si può fare nulla).Tuttavia chiama la madre anche “ricettacolo delle forme” per il fatto che la materia è il luogo in cui vengono ricevute le forme , e “spazio” (in greco “kora” = regione ,ma con valore astratto = spazio):la parola “kora” dà proprio l’idea dell’estensione pura,senza alcuna forma (il che comporta il fatto che può assumerle tutte).Sappiamo che le idee sono fuori dal tempo e dallo spazio : quando un’idea è compartecipata dal mondo sensibile si cala nello spazio.Tutto il “Timeo” è incentrato sulla necessità di spiegare il mondo fisico e la sua compartecipazione alle idee:le idee sono perfette , le cose no:da un lato si predica il bene (le cose tendono alla perfezione ideale)dall’altro il male (non riescono ad imitare perfettamente): si crea così una sorta di ambiguità;si può accettare la frase non platonica ( é infatti stoica ) “viviamo nel migliore dei mondi possibili” in quanto il nostro mondo si avvicina più che può a quello intellegibile.Finora per quel che riguarda l’imperfezione del mondo sensibile ce l’eravamo cavata dicendo che un’imitazione , per definizione , non è mai perfetta:ma perchè il mondo non sarà mai perfetto ? Qual è l’ostacolo ? Platone era del parere che il nostro fosse un mondo buono,ma tuttavia era consapevole della sua imperfezione.Alla domanda che ci siamo appena posti Platone rispose così : per lui ciò che impedisce al mondo sensibile di essere perfetto è la materia;perchè il mondo empirico si realizzi e si plasmi occorre che si realizzi in qualcosa privo di forma : è come un metallo che deve essere lavorato : se avesse già una sua forma immutabile non lo si potrebbe lavorare.Quindi la caratteristica della materia è non avere caratteristiche.Platone dice che il ragionamento che ci porta a conoscere la materia è “bastardo”,impuro , scorretto perchè se ad esempio guardiamo un cavallo , in realtà conosciamo l’idea : la materia la conosco come ciò che non è idea:si arriva alla conclusione in modo negativo perchè il ragionamento coglie solo una caratteristica : la materia non ha forma.Non potrebbe essere “ricettacolo delle forme” se avesse una forma definita (è come la cera sulla quale si deve attaccare un sigillo:deve essere molle e senza forma per poter così prendere quella del sigillo).Se affermiamo che la materia per ricevere le forme non deve avere forme cogliamo simultaneamente un aspetto positivo e uno negativo : è di fondamentale importanza ma soffrirà sempre di una deficienza.Consente alla materia di avere forme,ma le riceverà sempre imperfettamente perchè è priva di forme , disordinata : le si darà una forma , ma manterrà sempre una componente priva di forma:è proprio questa componente a rendere il mondo sensibile imperfetto.Quindi la materia è contemporaneamente un aiuto perchè fa calare le idee nel mondo sensibile ed un ostacolo perchè , per inclinazione naturale , mantiene una componente di disordine.Tra gli “agrafa dogma” (le dottrine non scritte) di Platone troviamo la diade indefinita , alla quale abbiamo già accennato.Platone è all’ultima fase della sua riflessione e risulta particolarmente influenzato dai pitagorici ;al vertice della realtà si trova il principio bipolare,in cui vi sono due poli come in un magnete:e come un magnete esiste solo quando ci sono un polo negativo e uno positivo che risultano essere indivisibili.L’uno è il vertice unitario , il due quello molteplice , diade indeterminata del piccolo e del grande.Platone ha spiegato che in fondo il mondo è uno , di parvenza molteplice:non è una dispersione di cose.Ma perchè , pur essendo uno , pare essere molteplice ? Come mai l’uno si moltiplica ? Vi sono due risposte : a) c’è di mezzo la materia , che genera scompiglio ed indeterminatezza , b) c’è la diade , che genera indeterminazione : se si ha della materia alla quale dare una forma , la forma stessa determina che essa sia nei suoi limiti , nè più grande nè più piccola di ciò che è : piccolo e grande sono una coppia di concetti simmetrici e polari , entrambe indeterminati (c’è sempre qualcosa di più grande e qualcosa di più piccolo) : ricorda molto il gioco del limite e dell’illimitato dei pitagorici .La parziale differenza è che più che essere due principi , sono un principio solo bipolare , altrimenti se il mondo si moltiplicasse significherebbe che i due principi (uno-diade) devono essere impliciti nella realtà.Nel principio che genera il mondo (l’uno) ci deve anche essere la diade : l’uno non rimane uno (come invece era per Parmenide) , ma presentando aspetti molteplici scende di livello : parte dal bene in sè,passa alle idee e poi si cala al mondo sensibile.se vogliamo,la materia rappresenta il male in quanto è elemento di disordine della realtà.Pare quindi che il male stesso sia parte del principio ; in verità c’è il principio da cui si origina il male , ma il male di per sè all’inizio non c’è : la diade indeterminata sta a significare che l’uno (il bene in sè) non rimane unitario , ma si cala nelle idee (che sono tante) prima e nel mondo sensibile poi.E’ come se la potenziale negatività della materia si manifestasse gradualmente : quando è nell’uno non la si vede neppure , è ben inserita e quasi identificabile con lo stesso uno.Nel mondo delle idee , invece , non si è ancora manifestata come male, ma solo come molteplicità (le idee sono tante , ma ordinate ).Nel mondo sensibile le cose sono molteplici (e si sono moltiplicate in modo indefinito : mentre l’idea di cavallo è una , i cavalli sono tantissimi , un numero quasi infinito)e disordinate:la componente di imperfezione è presente in tutti i livelli , ma man mano che si scende è come se si “inspessisse” sempre di più.Comunque tutto questo discorso rimane avvolto da un’ alone di mistero un pò perchè non sta scritto da nessuna parte , un pò perchè non è pienamente coglibile con la ragione.Dunque il mondo fisico deriva da un padre (il mondo delle idee) e da una madre (la materia , che è la condizione per l’esistenza del mondo fisico stesso ma che mantiene comunque una componente di indeterminazione) : ma cos’è che fa da madiatore tra il mondo delle idee e la materia ? Cos’è che fa sì che le idee si calino nel mondo sensibile ? Platone mette a questo punto in gioco la figura del Demiurgo (dal Greco “demos” ,popolo, + “ergon” , opera, = artigiano).Il Demiurgo è un divino artigiano : è colui che contemplando le idee plasma la materia sul modello delle idee stesse.Platone introduce quindi una divinità a tutti gli effetti (fino ad adesso non ne avevamo mai realmente incontrata una).Il concetto che l’artigiano guardi ad un modello è tipicamente platonico (e aristotelico ): mentre gli artigiani umani guardano ad un modello che hanno nella loro testa , il Demiurgo guarda ad un qualcosa che è fuori da lui:dato che le idee sono il bene per la loro categoria , anche il mondo sensibile dev’essere per forza buono , sebbene indeterminato.Che rapporto intercorre tra le idee , la materia ed il Demiurgo ? Tutti e tre sono coeterni , sono sempre esistiti.A differenza della divinità cristiana , che crea il mondo, quella platonica si limita a plasmarlo e non è onnipotente : ha infatti due limiti : la materia , che gli impedisce di costruire un mondo perfetto , e le idee , che sono il modello a cui deve per forza attenersi.Il Demiurgo guarda sì al meglio , ma il suo comportamento è dato da qualcosa da lui esterno ed indipendente.Nel Medioevo vi fu un grande dibattito teologico : le cose sono sante perchè piacciono alla divinità o piacciono alla divinità perchè sono sante ? In altre parole : la divinità è colei che riconosce le cose buone e le sceglie , o è colei che fa le cose buone ? Platone affronta questo argomento , legato al santo , nell’ ” Eutifrone “ : a suo avviso le cose sono buone ( sante ) intrinsecamente e non perchè c’è chi decide che lo siano : il bene in sè è il criterio per giudicare tutte le cose che possono essere buone;è buono ciò che partecipa alla super-idea di bene , come è bello ciò che partecipa all’idea di bellezza.Le idee sono il modello per gli uomini e per la divinità.Chiaramente la divinità vale di più rispetto all’uomo : essa riconosce facilmente il bene , mentre gli uomini hanno delle difficoltà e non sempre ci riescono.Vi fu chi arrivò a dire che ciò che è giusto è giusto perchè l’ha deciso la divinità.Chiaramente se Platone avesse avuto modo di prendere parte al dibattito teologico medioevale , avrebbe affermato che le cose buone piacciono alla divinità perchè sono buone e non avrebbe potuto accettare l’idea che le cose sono buone perchè piacciono alla divinità. E’ corretto affermare che la divinità per Platone è il Demiurgo solo entro certi limiti : se la divinità per definizione è il principio supremo , allora la divinità platonica dovrebbe essere il bene in sè.Se la divinità è principio della realtà , è evidente che non deve dipendere da nulla : ma il Demiurgo dipende dalla super-idea del bene e dalle altre idee che è costretto ad imitare : ne consegue che non è indipendente ma è al contrario limitato.Il bene in sè ,invece,abbiamo visto che è illimitato ed è lui stesso il principio (bipolare) della realtà.Il concetto di divinità nella tradizione ebraico-cristiana attinge un pò dal Demiurgo e un pò dalla super-idea del bene.Non a caso nel Medioevo il “Timeo” (che è appunto il dialogo dove compare il Demiurgo) ,a differenza degli altri dialoghi platonici, continuò ad essere letto e non cadde in disuso.Questo perchè il “Timeo” è l’opera platonica più vicina al Cristianesimo : c’è l’idea della plasmazione , piuttosto vicina a quella della creazione : inoltre la divinità in un certo momento crea il mondo (la divinità di Aristotele invece fa ben poco).Va poi ricordato che il Demiurgo è un dio-persona come quello dei Cristiani.Dietro a questo amore cristiano per il “Timeo” , probabilmente c’è un fraintendimento : le interpretazioni del “Timeo” sono due e i Cristiani scelsero probabilmente quella sbagliata.Se si legge il “Timeo” alla lettere si incontra questo “plasmatore” divino : sembra che il mondo prima non ci sia e che ci sia solo la materia : si ha l’impressione che ci sia un tempo prima e un tempo dopo . Ma Platone credeva in ciò che diceva ? Se si legge accuratamente il “Timeo” ci si accorge che Platone ad un certo punto si pone un quesito : che cos’è il tempo ? Il Demiurgo tra le varie cose plasma anche gli astri , il cui movimento regolare si identifica con il tempo.Il tempo viene definito “immagine mobile dell’eternità”: come il mondo sensibile è imitazione di quello intellegibile (il primo mutevole , il secondo eterno) , così il tempo è imitazione dell’eternità.Non a caso il tempo viene identificato con il movimento circolare : se si vuole rappresentare l’eternità con qualcosa di movimentato , senz’altro ciò che meglio la rappresenta è il cerchio , il movimento circolare in cui si compie un giro per poi tornare al punto di partenza:infatti il tempo è caratterizzato dal non essere eternità ma tornare sempre su se stesso.La cosa più simile a ciò che non si muove mai è quella che torna sempre su stessa , così come la cosa più simile che l’uomo possa fare per eternarsi è il riprodursi ciclicamente.Dunque il tempo è la plasmazione dell’eternità ideale da parte del Demiurgo.La conseguenza è che non c’è un tempo prima del mondo perchè è solo con la nascita del mondo sensibile che il Demiurgo ha calato nella realtà sensibile l’imitazione di eternità.Questa è una visione ben diversa da quella cristiana nella quale la divinità in un certo momento decise di creare il mondo.Va poi ricordato che Platone stesso all’inizio del “Timeo” dice che si tratta di un mito : di conseguenza i Cristiani hanno preso per vero qualcosa che Platone stesso dice non essere vero , ma solo un’immagine che rappresenta la relazione tra mondo intellegibile e materia.Quindi Platone non credeva assolutamente nella figura del Demiurgo ed il suo vero dio resta il bene in sè.Oltre ad esprimere la relazione tra idee e materia , il mito del Demiurgo esprime anche il finalismo : Kant direbbe “è come se” il mondo fosse stato elaborato da un artigiano.Il mondo sensibile è da sempre e per sempre un’ immagine temporale del mondo delle idee.Il Demiurgo dunque comincia a plasmare nella materia (che Platone chiama anche “spazio”)e arriva a generare tutta la realtà . Platone dice che la prima cosa che si crea nello spazio sono 4 solidi geometrici fondamentali : si tratta dei 4 solidi regolari (costituiti da facce uguali tra di loro).Platone è convinto che si possano ottenere tutti e 4 partendo da un triangolo rettangolo isoscele:ricombinandolo si possono ottenere vari tipi di figure ( se ne creerebbero 5 , ma Platone una la scarta).Essi sono il cubo , l’ottaedro , il tetraedro , l’icosaedro (quello che scarta è il dodecaedro). Questi 4 solidi stanno a rappresentare i 4 elementi fondamentali di Empedocle (terra , acqua , aria , fuoco , che verranno poi anche ripresi da Aristotele ) : ognuno dei 4 elementi di Platone è costituito da parti minime (non ulteriormente divisibili)e ciascuno è caratterizzato da una forma : per Platone la terra è il cubo , che suggerisce l’idea di regolarità , materialità , stabilità e compattezza.Il fuoco , per esempio, è invece rappresentato dal tetraedro perchè , dal momento che brucia , deve essere particolarmente spigoloso (il tetraedro è il più spigoloso) e la forma stessa della fiamma è simile a quella del tetraedro.Platone ancora una volta prende spunto dalla filosofia dei suoi precedenti mescolando in questo caso Empedocle a Democrito (che tra le varie cose riteneva che a stimolare i nostri sensi fossero le determinate forme degli atomi)e ai Pitagorici (Timeo è pitagorico e le forme degli elementi sono geometriche).Tra l’altro ci possiamo anche riallacciare alla gerarchia dei livelli della realtà : abbiamo detto (con l’aiuto del grafico) che i numeri erano a metà strada tra mondo sensibile e mondo intellegibile ; qui vengono utilizzati come collegamento tra mondo ideale e materiale.Il Demiurgo plasma quindi l’ Universo ed il Sistema (non è molto chiara la struttura astronomica che attribuisce al Sistema : pare che Platone abbia superato la teoria geocentrica ; non ammette il movimento di rivoluzione , ma sembra ammettere quello di rotazione:è la Terra che gira). Platone introduce poi il concetto di “anima del mondo” : il mondo delle idee abbiamo detto che è movimentato , intelligente, vitale: il mondo sensibile , nella misura in cui il Demiurgo lo plasma , non può che essere simile a quello intellegibile : ha un’ anima sua .L’Universo è un grande essere vivente permeato interamente da un’ anima.Tutto quindi è vitale , sebbene in diverse misure.L’osso è vivo perchè fa parte di un essere vivente , ma anche la pietra è viva perchè fa parte di questo grande essere vivente (l’Universo).Platone insiste poi particolarmente sul finalismo ( il cavallo è nato per essere veloce , il cane per fare la guardia…) e sulla stretta parentela tra uomo e animali (gli animali sono il frutto di incarnazioni infelici delle anime nell’aldilà : ricordiamoci del mito di Er ;di tutte le incarnazioni , Platone sostiene che la peggiore , dopo quella di donna e di animale , sia quella dei pesci).Le ultime riflessioni di Platone sulla vita etica (quella del singolo individuo) e sulla vita politica (quella dell’intera comunità) le troviamo nel “Filebo” e nel “Politico” : ci troviamo di fronte ad un Platone più scettico e che mette in discussione le sue stesse teorie.Si pensa che questi due dialoghi risalgano all’esperienza siracusana con il tiranno,ma c’è anche chi è del parere che questa “sfiducia” nelle sue dottrine sia dovuta solo all’età ormai avanzata:Platone , ormai vecchio , non è più entusiasta come quand’era giovane delle sue dottrine che erano nate per risolvere problemi , ma che in realtà ne avevano solo creati di nuovi.Probabilmente sono entrambe questi due fattori (l’esperienza con il tiranno e l’età avanzata) che fanno sì che Platone sia così scettico.Il “Filebo” non è un dialogo propriamente politico : viene posto l’interessante quesito : che cos’è la vita buona ? Dunque Platone riprende un tema tipicamente socratico ; si discute ancora una volta (come già nel “Gorgia” o nel “Fedone” ) se bene e piacere siano identificabili : a differenza degli altri dialoghi in cui aveva affrontato questo problema , nel “Filebo” Platone assume posizioni più moderate : anche qui nega l’identificazione , ma arriva tuttavia ad individuare diversi tipi di piacere , non necessariamente negativi : non tutti i piaceri sono per forza accompagnati dal dolore . Ci sono anche piaceri intellettuali (ad esempio la musica o quelle conoscenze che danno un senso di piacere)che non sono così strettamente legati al dolore: sono piaceri a dimensione positiva.In poche parole quando ci sono sono un piacere , quando non ci sono sono un dolore.Secondo Platone bisogna privilegiare e coltivare solo certi piaceri.Una vita buona non può essere priva di piaceri (così avevamo anche detto a riguardo dell’anima : le passioni sono fondamentali).Platone delinea così la “vita mista” , basandosi sull’idea che la bontà consista in un equilibrio dato dalla mescolanza di elementi diversi che si mescolano secondo misura : da notare che misura , 1 , numero etc. sono sinonimi per definire il bene in sè.La vita buona , per Platone , è mescolanza di intelligenza e piacere : questa mescolanza non è casuale , ma ponderata : bisogna vedere attentamente in che misura mescolare intelligenza e piacere.Per Platone l’intelligenza è superiore al piacere e tenderà sempre a prevalere per il semplice fatto che se si deve stabilire in che misura mescolare piacere ed intelligenza , è l’intelligenza stessa che ci indica la misura in cui mescolare.Quindi ,di per sè,l’intelligenza è maggiormente presente nella vita buona.Se si presta attenzione alla filosofia platonica , ci si accorge che ritorna spesso l’idea che la spiegazione ultima di tutto è riconducibile ad un sistema binomio,ad un duplice principio.Prendiamo , ad esempio, la “Repubblica” e più precisamente la tripartizione della società : le classi in realtà sono due perchè i difensori sono i futuri governanti . E’ la classe dei governanti che dà l’equilibrio alla sua classe e a quella dei produttori.Spostiamoci ora al “Fedro” e al mito della biga alata , metafora dell’anima : c’è un principio razionale (l’auriga : il fatto che sia uno solo sta a significare che la piena razionalità è nell’unicità) e due irrazionali (il cavallo bianco , che simboleggia la parte arazionale , e quello nero , che è emblema dell’irrazionalità : l’irrazionalità è data da due elementi , che simboleggiano la molteplicità):la ragione è ordinata e unica , l’irrazionalità è molteplice : il fatto che sia data da due cavalli implica la possibilità di andare in due direzioni diverse.Passiamo poi agli “agrafa dogma” (le dottrine non scritte) e al principio bipolare uno-diade : un polo (quello dominante) è l’unitarietà , l’altro è la molteplicità.Nel caso della biga alata , emerge il fatto che con la misura si controlla ciò che è illimitato : pensiamo ad un termometro ; le temperature sono pressochè infinite (in realtà non lo sono , ma facciamo conto che lo siano) e il termometro rende quindi definito ciò che è indefinito.Platone voleva scrivere una trilogia : 1) il sofista 2) il politico 3)il filosofo : il primo l’ha effettivamente ralizzato , il secondo l’ha iniziato ma non l’ha finito ed il terzo non l’ha mai neppure cominciato.Analizziamo ora il “Politico” : l’opera si intitola il “Politico” e non “la politica” (come si chiamerà invece l’opera di Aristotele ) perchè Platone era convinto che per avere uno stato perfetto occorresse che fosse governato da uomini politici perfetti.Ma chi è il vero uomo politico ? Platone parte dallo scartare la definizione omerica “il re è pastore di uomini” perchè implica una superiorità di razza da parte del politico e ciò lo si poteva accettare solo se si torna all’epoca mitica in cui gli dei governavano gli uomini.Così come nel “Sofista” (in cui il tema centrale era la possibilità di dire il falso , il non essere) , anche nel “Politico” la definizione del personaggio passa in secondo piano e risulta scherzosa.Così come nel “Sofista” , per definire si serve della “diairesis” : quella del politico è una tecnica analoga a quella del tessitore che intreccia fibre di carattere diverso:intreccia trama e ordito.Ancora oggi si suole usare l’espressione “tessuto sociale” per indicare che le funzioni si intrecciano . Nell’intrecciare i tessuti , ci sono caratteri più solidi ( coraggiosi, nella politica) ed altri più raffinati (intelligenti , nella politica) : il politico deve sapere la misura per mescolare bene i diversi “strati” sociali.Ben emerge come Platone sia più rigido e meno sciolto (soprattutto nello stile) rispetto a quanto lo era in gioventù.Egli arriva ad affermare che nello stato perfetto non ci sarebbe bisogno delle leggi perchè esse sono quasi un “male necessario” che si introducono in assenza dell’uomo politico perfetto.Infatti la legge per quanto cerchi di cogliere le sfumature non ci riesce mai totalmente e non è mai assolutamente giusta : la legge dice di non rubare e di punire chi ruba con determinate pene : ma non dice , per esempio , di punire chi ruba due libri ed un quaderno con due mesi di carcere.Se ci fossero politici perfetti deciderebbero quale pena applicare in ogni determinato caso.Come il medico riesce a vedere in ogni frangente la cura da amministrare al paziente , così il politico , per Platone , deve prendere le decisioni senza essere vincolato dalle leggi.Ma nella realtà , dove è impossibile per definizione essere perfetti ,Platone dice che le leggi sono necessarie : esse sono necessarie perchè è vero che danno norme universali e non sempre giuste in tutti i casi , ma comunque in questo vincolare danno delle regole alle quali attenersi.Seguendole non si otterrà un risultato perfetto (che si otterrebbe invece seguendo il politico perfetto) , ma comunque buono. Platone crea poi nel “Politico” una nuova gerarchia dei governi : al vertice mette sempre il suo stato ideale ma subito dopo si trovano i governanti che regnano secondo le leggi.Negli ultimi posti ci sono i governi in cui si comanda senza leggi.L’ultima fatica di Platone è costituita dalle “Leggi” , un dialogo rimasto incompiuto : si è curato della sua pubblicazione e di inserire l’ultimo libro un allievo di Platone : questo ci aiuta a capire il carattere pesante e ridondante dell’opera.E’ di gran lunga l’opera più lunga : si tratta di una raccolta di leggi e pure questo aspetto contribuisce alla pesantezza dell’opera.Il problema del consenso che abbiamo affrontato nella “Repubblica” si trasforma nell’essere tutti d’accordo che le leggi sono buone:ogni legge viene preceduta da un preambolo , da un’argomentazione dove si spiega perchè quella legge viene elaborata, perchè è giusta : oggigiorno questo non c’è nelle nostre leggi , ma tuttavia nelle proposte di legge viene data una motivazione alle nuove leggi.Vi è anche chi dice che le “Leggi” fossero un manuale in uso nell’Accademia che assunse gran prestigio : pare infatti che le nuove città , o quelle rifondate o ancora quelle ricostituite si rivolsero all’Accademia per farsi varare le leggi.Abbiamo già parlato dello Stato Secondo : Platone cerca un compromesso tra lo stato ideale (che sa bene che sia inattuabile) e la realtà : egli elimina gli aspetti più scioccanti ed inattuabili (l’abolizione della proprietà terriera e della famiglia , sebbene sostenga che i governanti debbano vivere di tanto in tanto insieme).Per lo stato delineato qui da Platone si parla anche di “involuzione politica” : lo stato di Platone , a sorpresa , diventa teocratico . Per Platone si devono venerare gli astri a causa del loro ordine e bisogna imporre la religione ai cittadini (anche con la forza : Platone può quindi apparire l’antenato degli inquisitori spagnoli). Ci troviamo di fronte ad un Platone molto conservatore (dice addirittura che chi non crede nella religione vada ucciso) e distante dalle posizioni di Socrate (che aveva idee religiose molto personali).La teoria delle “Leggi” che di gran lunga ha avuto più successo nella storia è quella della costituzione mista , che abbiamo già esaminato.Prendendo infatti i migliori aspetti di ogni forma di governo i difetti di ciascuna si attutiscono : vi è una sorta di equilibrio dei poteri.Dopo la morte di Platone , la sua scuola si continua per quasi 8 secoli, se vogliamo includervi anche la neoplatonica;ma non conserva in tutto il suo svolgimento lo stesso spirito nè si mantiene fedele alla dottrina del maestro.I successori immediati di Platone furono Speusippo e dopo di lui Senocrate , nei quali già comincia a manifestarsi l’influsso di Aristotele ,almeno per quel che riguarda la necessità di dare un ordine più sistematico ed architettonico alla dottrina.
A parte una trentina di epigrammi e il frammento di un carme in esametri , quasi certamente spuri , il corpus platonico consta di 36 scritti a carattere filosofico , che ci sono giunti distribuiti in nove tetralogie ( gruppi di quattro ) , secondo una schema tradizionalmente attribuito all’erudito Trasillo di Alessandria ( epoca dell’imperatore Tiberio ) , ma forse risalente a un periodo ancora più antico .
Delle 36 opere , 34 sono dialoghi ; una , l’ “ Apologia di Socrate ”, riporta in forma immaginaria l’autodifesa pronunciata da Socrate davanti ai giudici , mentre l’ultima consiste in una raccolta di tredici lettere .
Ecco l’elenco completo delle 9 tetralogie :
1 Eutifrone 2 Apologia 3 Critone 4 Fedone
1 Cratilo 2 Teeteto 3 Sofista 4 Politico
1 Parmenide 2 Filebo 3 Simposio 4 Fedro
1 Alcibiade maggiore 2 Alcibiade minore 3 Ipparco 4 Amanti
1 Teagete 2 Carmide 3 Lachete 4 Liside
1 Eutidemo 2 Protagora 3 Gorgia 4 Menone
1 Ippia maggiore 2 Ippia minore 3 Ione 4 Menesseno
1 Clitofonte 2 Repubblica 3 Timeo 4 Crizia
1 Minosse 2 Leggi 3 Epinomide 4 Lettere
Nel corpus si trova anche un’appendice comprendente altri sette dialoghi ( Sul giusto , Sulla virtù , Demodoco , Sisifo , Erissia , Assioco e Alcione ) che già gli antichi ritenevano spuri , e le Definizioni , costituite da oltre 200 termini relativi a svariati ambiti culturali e certamente non attribuibili a Platone . Anche sull’autenticità di alcune opere comprese nelle tetralogie gli antichi avanzavano forti sospetti , che i moderni hanno generalmente confermato e anzi esteso ad altri scritti . In compenso si può affermare che che sono ritenuti concordemente spuri Alcibiade primo e Alcibiade secondo , Ipparco , Amanti , Teagete , Minosse , Epinomide . Delle lettere l’unica certamente autentica é la Lettera 7 , da cui sono attinte notizie biografiche riferite . Assai arduo si é prospettato il problema di ricostruire la successione cronologica di una serie così numerosa di scritti , soprattutto allo scopo di seguire la linea evolutiva del pensiero di Platone . Le vie percorse sono state essenzialmente due : 1) di carattere contenutistico 2) di carattere formale . Nel primo caso l’attenzione si é focalizzata sulla figura di Socrate , la cui importanza viene progressivamente ridimensionata man mano che il sistema platonico va assumendo una sua autonomia nei confronti dell’insegnamento del maestro , fino a scomparire quasi del tutto nelle opere del periodo più tardo ; i sostenitori del secondo metodo si sono invece rivolti più che altro a indagini sul lessico , sullo stile e sulla struttura dei dialoghi , nella convinzione che tali elementi vadano trasformandosi nel tempo e agevolino dunque la collocazione delle singole opere lungo un asse cronologico . L’unico dato certo é quello tramandatoci da Aristotele e da Diogene Laerzio , secondo cui le Leggi furono l’ultima opera scritta da Platone e pubblicata postuma da un suo discepolo.
Nonostante la diversità dei criteri adoperati , le ricerche svolte in questo ambito hanno finito col dare risultati abbastanza convergenti , i quali consentono di tracciare con una certa attendibilità il seguente schema cronologico dei dialoghi sicuramente autentici , che vengono a essere raggruppati in 3 periodi :
PRIMO PERIODO : Eutifrone Apologia Critone Ione Ippia maggiore Ippia minore Lachete Liside Carmide Alcibiade maggiore Alcibiade minore Protagora Gorgia
SECONDO PERIODO : Menone Eutidemo Menesseno Cratilo Simposio Fedro RepubblicaFedone
TERZO PERIODO : Parmenide Teeteto Sofista Politico Filebo Timeo Crizia Leggi
A sottolineare il carattere relativo della partizione proposta , aggiungeremo che qualcuno propende per una suddivisione in 4 periodi e che anche in questa da noi adottata la collocazione di alcuni scritti é tutt’altro che sicura : in ogni caso , nell’esporre succintamente il contenuto dei singoli dialoghi , ci atterremo per praticità a tale schema , operando piccoli spostamenti nella successione di opere che presentino affinità di contenuto . Non é arbitrario definire ” socratici ” i dialoghi del primo periodo , vista la rilevanza che vi hanno sia la figura sia il pensiero del maestro di Platone . Alcuni di essi sono inoltre caratterizzati da toni polemici e apologetici , che fanno supporre ancora vicini nel tempo il processo e la condanna di Socrate : anche se non é mancato chi ha sostenuto per qualche dialogo una datazione anteriore , l’ipotesi più probabile é che Platone abbia cominciato a scrivere dopo il 399 a.C. L’Apologia di Socrate ( unico scritto in forma non dialogica ) ricostruisce il discorso pronunciato da Socrate dinanzi ai giudici , mentre il Critone descrive il suo rifiuto a un progetto di evasione predisposto dagli amici . Momento culminante del Critone é quello in cui le leggi della città esortano Socrate ad accettare la condanna a morte . Il tema tipicamente socratico del ” tì estin ” , cioè della ricerca volta a dare una precisa definizione dei vari concetti , accomuna una serie di dialoghi del primo gruppo : nell’ Eutifrone s’indaga sulla natura della pietà religiosa , nel Lachete su quella del coraggio virile , mentre il Liside e il Carmide prendono rispettivamente in esame l’amicizia e la saggia moderazione . Di tutte queste virtù viene sottoposta a critica la nozione tradizionale , troppo formalistica , anche se non si giunge mai ( come é nello spirito del metodo socratico ) a conclusioni definitive . Problematiche di carattere estetico-letterario affrontano invece lo Ione e l’ Ippia maggiore . Nel primo dialogo si afferma che la poesia non é prodotto di abilità tecnica , ma di ispirazione divina . Intitolato al celebre sofista , l’ Ippia maggiore é invece dedicato alla ricerca di una definizione esaustiva dal bello , ma costituisce soprattutto un pretesto per tracciare un ritratto caricaturale del magniloquente e borioso personaggio . Questo motivo é ripreso anche nell’ Ippia minore , il cui tema centrale é quello secondo il quale si compie il male pensando di compiere il bene . La polemica contro i sofisti trova un suo compiuto e coerente sviluppo nei due dialoghi intitolati ai maggiori esponenti del movimento , Protagora e Gorgia . Il Protagora vede un animato dibattito tra Socrate e alcuni dei più celebri sofisti ( Protagora , Ippia , Prodico ) . I temi affrontati sono parecchi , ma su tutti predomina quello riguardante la possibilità di insegnare la virtù come una qualsiasi scienza . Assai più aspra la polemica antisofistica del Gorgia , che vede come interlocutori , oltre a Socrate e al sofista di Lentini , anche un allievo di questi , Polo , e Callicle . Argomento del dialogo é l’uso della retorica come mezzo per la conquista e l’esercizio del potere .
Col Menone si apre una fase nuova nei dialoghi platonici , giacchè nel riprendere la stessa questione affrontata nel Il Protagora ( l’insegnabilità della virtù ) , viene introdotta per la prima volta la teoria dell’ anamnesi ( o reminescenza ) e comincia a prender corpo la dottrina delle idee , pur se esse non hanno ancora valore ontologico , ma puramente conoscitivo . Nel Critone e nell’ Eutidemo ritornano gli attacchi contro la vacua verbosità dei cultori della retorica . Al problema del linguaggio é dedicato il Cratilo : si affronta il problema dei nomi delle cose e si arriva a dire ce essi sono l’effetto di una rielaborazione umana . Di impianto assai elaborato e complesso , il Simposio é qualcosa di più che un semplice dialogo . Costruito secondo una tecnica a ” incastro ” , esso consta anche di una cornice , rappresentata dal convito che il poeta tragico Agatone offre nella propria casa a un gruppo di amici per festeggiare la sua vittoria in un concorso drammatico . Dopo la cena i convitati decidono di parlare dell’amore e ciascuno espone le proprie idee , che poi verranno riprese e meglio organizzate dal discorso finale di Socrate . Al tema dell’amore é dedicato anche il Fedro , pur se una parte di esso ha come oggetto la retorica e le sue varie forme , argomento questo che ci riporta alla temperie del Gorgia , più che a quella del Simposio . All’immortalità dell’anima e al mondo delle idee é dedicato il Fedone . Esso rievoca le ultime ore di Socrate ed é perciò collocato nella prima tetralogia ma é palesemente opera composta in una fase matura del pensiero platonico . Con la serenità di chi sa che la morte é solo la liberazione dell’anima dal carcere del corpo , Socrate sviluppa la tesi dell’immortalità di essa attraverso tre argomenti , il primo basato sulla reminescenza , il secondo sulle affinità tra anima e idde , ed il terzo sulla presenza nell’anima dell’idea di vita , che esclude quella di morte . Va poi ricordato che il Fedone é il dialogo in cui Platone rivela di aver abbandonato la ricerca della vera causa nel mondo terreno , per spostare la sua indagine nel mondo ultraterreno , compiendo quella che con una felice espressione chiama ” seconda navigazione ” . Opera vasta e complessa , la Repubblica ci é giunta suddivisa in 10 libri , secondo una partizione quasi certamente posteriore all’autore , del cui pensiero costituisce una vera ” summa ” . In essa Platone si propone di delineare uno stato ideale , governato da persone che effettivamente meritino l’incarico : fondamento del sistema politico teorizzato nella Repubblica é la suddivisione dei cittadini in tre classi : governanti , guardiani e artigiani . Perchè lo stato funzioni , dice Platone , é indispensabile che ognuno si occupi di ciò che gli compete senza avanzar pretese di competere anche in altri campi . E’ uno stato visto come una grande famiglia , dove tutto é di tutti : si tratta di un’utopia che Platone sapeva bene essere irrealizzabile . Le opere del terzo ed ultimo periodo sono in genere caratterizzate dal tentativo di sanare certe aporie derivanti dal rigido dualismo fra mondo sensibile e mondo intellegibile , due universi paralleli che Platone cerca in qualche modo di ricongiungere , nonchè da una spiccata attenzione verso la dialettica , la matematica e la scienza in generale . Rispetto a quelli dei periodi precedenti , gli scritti di questa terza fase , pur conservando formalmente la struttura diologica , tendono ai toni del trattato e sono caratterizzati da un uso pressochè generalizzato del metodo dialettico già delineato nel Fedro .
Tra di loro strettamente legati risultano in questo senso dialoghi come Il Parmenide , Il Sofista , Il Teeteto , Il Politico e Il Filebo . Nel primo Platone descrive un colloquio tra Socrate giovanissimo e i due maggiori esponenti della scuola eleatica , Parmenide e Zenone , facendone argomento la propria dottrina delle idee : si tratta di un dialogo in cui Platone fa un’autocritica della sua dottrina stessa e delle incongruenze che essa presenta . Al problema della scienza é legato Il Teeteto , non a caso intitolato a questa figura di studioso , considerato ideatore della stereometria e della teoria dei 5 solidi . Lo stesso personaggio ritroviamo nel Sofista , i cui interlocutori ritornano in massima parte anche nel Politico . Argomento del Sofista é un attento esame della dottrina delle idee : in gioventù Platone aveva affermato che il mondo delle idee fosse un mondo stabile ( le idee erano infatti l’essere stabile ) , nel Sofista invece arriva ad ammettere che quello delle idee é un mondo mobile , dinamico . Sempre nel Sofista vi é il famoso parricidio di Parmenide , ossia Platone arriva ad ammettere il significato biunivoco dell’essere , che Parmenide non aveva afferrato : dire una penna non é un libro non vuol dire ammettere l’esistenza del non essere . Il Politico , insieme al Sofista , doveva far parte di una trilogia ( Il Sofista , il Politico , il Filosofo ) rimasta incompiuta : vi é una disquisizione sulle leggi , che non possono essere effettivamente giuste perchè non sono decretate in base ai casi particolari . Carattere etico ha la problematica dibattuta nel Filebo , in cui si discute se il bene sia da ricercarsi nel piacere o nella saggezza : Platone arriva poi a tratteggiare la famosa vita mista , costituita per metà dall’intelligenza e per metà dal piacere . Il Crizia é il dialogo del mito della città di Atlantide , città rivale di Atene dove la vita si svolgeva in modo perfetto , ma i suoi abitanti peccarono di tracotanza e furono puniti dagli dei , che fecero affondare la città . Il Timeo é il dialogo cosmologico per eccellenza : la cosmologia in esso descritta ha squarci di possente grandiosità , ma risulta nel complesso rigidamente modellata sulla dottrina delle idee : viene addirittura introdotta la figura di un Dio , il Demiurgo che cala le idee nella materia . del tutto assente é la figura di Socrate nell’ultima opera di Platone , Le leggi , dove Platone , consapevole dell’irrealizzabilità dello stato descritto nella Repubblica , delinea uno stato secondo , certo non come quello ideale , ma tuttavia realizzabile : caratteristica della costituzione di questo stato é l’assunzione dei migliori aspetti di ogni forma di governo .
ANTISTENE
 ” Io vedo i cavalli, non la cavallinità!”
” Io vedo i cavalli, non la cavallinità!”
Dopo la morte di Socrate (399 a.C.), la “filosofia socratica” fu insegnata ad Atene da Antistene, che – unico tra i suoi discepoli – non si era allontanato dalla città dell’Attica. Nato e vissuto ad Atene tra il 444 e il 365 a.C., egli tenne le sue lezioni filosofiche nel ginnasio ateniese di Cinosarge, rivelando grande attenzione per le tematiche dialettiche connesse al metodo d’indagine sviluppato da Socrate. Particolarmente rilevante è il nome del ginnasio in cui Antistene tenne le sue lezioni: “Cinosarge”, infatti, significa letteralmente “cane agile” (κυων + αργος) ε secondo un’antica tradizione – di qui sarebbe derivato il nome di “cinici” a coloro che si richiamarono all’insegnamento di Antistene, tanto più che i suoi seguaci predicavano e conducevano una vita sciolta da qualsiasi vincolo familiare o politico, al di fuori di tutte le convenzioni sociali: una vita, insomma, simile a quella dei cani, che sono appunto liberi da qualsiasi legame, e pienamente autosufficienti. I principali esponenti del “cinismo” antisteneo furono Diogene di Sinope, Cratete, Metrocle e nel III secolo – Menedemo e Menippo. Antistene era giunto a Socrate dopo una lunga frequentazione dei Sofisti (soprattutto Gorgia di Lentini) e ciò contribui a metterlo in una posizione di particolare attrito con l’altro condiscepolo Platone, cui contese il titolo di vero interprete delle dottrine del maestro: in realtà, dalle interpretazioni che danno Antistene e Platone emergono due figure di Socrate diverse e inconciliabili; attento alle problematiche gnoseologiche, alle quali sa fornire – nei dialoghi della maturità – risposte incontrovertibilmente salde, perché poggianti sull’iperuranico mondo delle Idee, il Socrate di Platone è un Socrate “metafisico”; interamente assorbito dalle problematiche di ordine etico, incurante dei problemi concernenti la conoscenza, il Socrate di Antistene è un Socrate “antimetafisico” e completamente votato all’etica. Va subito precisato che i Cinici furono i rappresentanti di una filosofia “popolare” (c’è chi ha qualificato il loro pensiero come “filosofia del proletariato greco”) che continuò a sussistere per molto tempo nell’ambito della cultura greca ed ispirò anche generi letterari, tra i quali famosa fu la satira; anche quando i loro insegnamenti confluirono nelle dottrine digli Stoici (a partire dalla fine del IV secolo a.C.), l’atteggiamento “cinico” rappresentò sempre l’anima popolare dello stoicismo, parallela e contrapposta all’ispirazione aristocratica e colta di quella scuola. Alla base del pensiero di Antistene è il cosiddetto “intellettualismo socratico”, secondo il quale la virtù si può insegnare e può essere raggiunta attraverso un laborioso esercizio interiore (ασκησις), che addestra lo spirito come la ginnastica fa col corpo. Da qui nasce l’inflessibile rigorismo morale – che perviene a conclusioni diametralmente opposte a quelle cui era addivenuto Aristippo, propugnatore dell’edonismo, con la condanna di ogni “vanità” umana in nome di una vita basata sull’autosufficienza (αυταρκεια) del saggio: atteggiamento ben compendiato dalla figura di Diogene di Sinope, il quale faceva addirittura a meno di una dimora fissa e conduceva la propria esistenza in una botte. La riflessione etica elaborata da Socrate è dunque da Antistene portata alle estreme conseguenze, con un’estremizzazione che certo non era socratica: “preferirei impazzire piuttosto che provare piacere”, asserisce significativamente Antistene, in netta rottura con Aristippo. La virtù poggia interamente sullo sforzo e sulla fatica: perciò l’eroe modello al quale fare costante riferimento è Ercole, che ha vittoriosamente affrontato le sue fatiche. Essendo la felicità riposta nell’autosufficienza, diventa necessario non soltanto non cedere ai piaceri, ma anche liberarsi dai desideri e dalle passioni che ingombrano il nostro animo. Il criterio a cui fare riferimento è, in tale ottica, la natura e non il mondo delle istituzioni umane, convenzionali, le quali incrementano i bisogni umani e quindi accrescono le forme di dipendenza:
“La virtù è sufficiente, da sola, per il raggiungimento della felicità, e non ha bisogno di niente altro. La virtù è propria delle opere, e non ha bisogno né di molti discorsi né di nozioni. Il sapiente è autosufficiente: tutte le cose degli altri sono sue. Il sapiente non si regola secondo le leggi stabilite dalle comunità politiche, ma secondo la legge della virtù”. (Diogene Laerzio VI, 10)
La polemica sofistica (derivata da Gorgia) contro la convenzionalità delle leggi si trasforma così in Antistene e, ancor più, nei Cinici posteriori in un rifiuto totale delle regole della convivenza sociale e politica:
“Diceva queste cose, ma dava anche l’esempio facendole: di fatto falsificava monete, non concedendo nulla né alle regole morali, né a quelle naturali. Egli diceva di vivere secondo il modello di vita che era stato proprio di Ercole, senza dare la preferenza a nulla rispetto alla libertà”. (Diogene Laerzio VI,71)
La crisi dei valori politici e morali della πολις (quella crisi che si era tragicamente manifestata nella condanna a morte di Socrate da parte della democrazia restaurata) trova così nella filosofia “socratica” dei Cinici una prima tipica espressione: il cinico che non crede piú nel regime democratico, ma nemmeno in quello aristocratico, trova troppo angusto per realizzare la sua “virtù” lo spazio offertogli dalla πολις, sicchè per lui “la sola vera città è quella che coincide con il mondo” (Diogene Laerzio VI, 72).
Il tema del cosmopolitismo sarà destinato a godere di grande fortuna anche presso gli Stoici. Interessato alla logica, Antistene ne contesta gli sviluppi metafisici arbitrariamente operati da Platone, soprattutto sul piano della dottrina delle idee. Celebre è, a proposito, l’affermazione di Antistene circa le Idee platoniche:
“io vedo i cavalli, non la cavallinità!“. Il punto di partenza e il vero contenuto dell’apprendimento è costituito dai nomi; le definizioni, invece, in quanto connessioni tra termini, non colgono la vera natura delle cose, ma possono solamente indicare analogie tra cose. Di qui scaturisce per Antistene l’impossibilità della predicazione: le uniche proposizioni legittime sono le proposizioni identiche, per esempio “uomo è uomo“, “cane è cane“, e così via. Attribuire ad un soggetto un predicato diverso da esso equivale ad attribuire ad una cosa più nomi, ovvero a considerare ciò che è uno uguale a molti, il che è palesemente assurdo. Ogni cosa, dunque, ha un solo λογος οικειος (“discorso appropriato“), ovvero ogni cosa può essere espressa attraverso un solo nome: ne segue, allora, l’impossibilità che i nomi mentano; il falso è in questa maniera messo al bando. Antistene afferma che mentre è possibile vedere un cavallo non è altrettanto possibile vedere e quindi descrivere e comunicare la platonica idea della cavallinità (“io vedo i cavalli, non la cavallinità!”); perciò, si può solo affermare che il cavallo è il cavallo, e non è possibile connettere in un giudizio o in una definizione due nomi, visto che dire “un cavallo è un animale” implica affermare l’identità fra i due termini, e non la relazione di appartenenza ad un insieme più vasto. Su questo problema scende in campo Platone in due dei suoi dialoghi: il Cratilo e il Sofista. Nel primo, egli dimostra come l’errore sia possibile, mentre nel secondo smaschera la possibilità (ammessa da Antistene) del “giudizio identico” (per cui ogni cosa ha un solo nome appropriato):
“[…] e con questo, credo, abbiamo apparecchiato un lauto banchetto ai giovani e a quei vecchi che imparano tardi. Infatti, è alla portata di chiunque ribattere immediatamente che è impossibile che i molti siano uno e l’uno sia molti e certamente essi godono a non lasciar dire uomo buono, ma soltanto il buono buono e l’uomo uomo”. (Sofista, 251 b)
Ben emerge come sia impossibile costruire un discorso conoscitivo sulla realtà, che è fatta di tante entità individuali irriducibili l’una all’altra; ogni entità ha un proprio nome, che è l’unico segno che di essa noi abbiamo a disposizione. Sulla scia di Platone, anche Aristotele formula un giudizio assai severo su Antistene: “Antistene rozzamente credeva che nulla si potesse dire se non il nome proprio delle cose, un nome per ciascuna cosa“. (Metafisica, 1024 b 32)
Perciò non è possibile costruire un discorso scientifico sulle cose, perché di ciascuna di esse possiamo dire soltanto che è se stessa: l’albero è albero, il bue è bue, e cosí via. Le scienze sono quindi finzioni, e per di piú inutili: “la musica, la geometria, l’astronomia e le altre discipline di questo genere devono essere trascurate, perché inutili e non necessarie“. (Diogene Laerzio VI, 73) Messa da parte la sfera gnoseologica – poiché riconosciuta del tutto improduttiva -, l’unica via degna di essere seguita è allora la via etica, sulla quale si incammineranno le filosofie fiorite in età ellenistica. I discepoli di Antistene assumeranno via via posizioni sempre più radicali e, in certo senso, esasperate rispetto a quelle del maestro: ciò avviene, in particolare, in Diogene di Sinope (400-325 a.C.) e nel suo allievo Cratete di Tebe, autore di poesie parodistiche e satiriche nonché maestro di quello Zenone di Cizio che fonderà lo Stoicismo, nel quale il Cinismo finirà per confluire.
ARISTOTELE

La filosofia non serve a nulla,dirai;ma sappi che proprio perchè priva del legame di servitù é il sapere più nobile.
LA VITA
Aristotele nacque a Stagira , una cittadina della penisola Calcidica nel nord della Grecia nel 384 a.c.Il padre Nicomaco era medico presso la corte del re dei macedoni Aminta , ma morì quando Aristotele era ancora giovane.Egli fu quindi allevato da un parente più anziano , di nome Prosseno.Nel 367 , all’età di 17 anni , andò ad Atene al fine di entrare a far parte dell’Accademia di Platone , che si trovava all’epoca a Siracusa.Vi rimase per ben 20 anni svolgendo un’attività di insegnamento , sino alla morte di Platone che fu nel 347-348 : in realtà se ne sarebbe già andato prima in quanto aveva idee divergenti da quelle del maestro , ma si trattenne fino alla sua morte per il rispetto che aveva nei confronti di Platone . Si allontanò dall’Accademia proprio quando era subentrato Speusippo e tra i motivi del suo allontanamento possiamo annoverare la crescente ostilità che si era venuta a creare ad Atene verso il re macedone Filippo , il quale nel 348 si era impadronito di Olinto nel nord della Grecia.Nel 347 si recò da Ermia , tiranno di Atarneo , che nutriva simpatie per la filosofia platonica e aveva messo a disposizione degli accademici una sede ad Asso ,nella Troade , una zona dell’Asia minore. Qui si stabilì Aristotele e poi nel 345 a Militene , sull’isola di Lesbo.In questo periodo egli sposò Pizia , nipote di Ermia , dalla quale ebbe 2 figli , Pizia e Nicomano , entrò in rapporto con Teofrasto , che divenne suo discepolo , e intraprese ricerche biologiche sugli animali.Nel 343 Filippo lo invitò a corte in veste di precettore di Alessandro . Qui rimase a lungo finchè Filippo non fu assassinato da Pausania nel 336 e Alessandro gli succedette al trono.Nel 335 Aristotele fece il suo rientro ad Atene con Teofrasto e svolse attività di ricerca e di insegnamento nel Liceo , un ginnasio vicino al tempio di Apollo Liceo (originariamente fu chiamato “peripato” , passeggiata e luogo di discussione) , raccogliendo intorno a sè amici e scolari.Nel 323 però , morto Alessandro in Oriente , prese il sopravvento in Atene la corrente anti-macedone capeggiata da Iperide . La tradizione vuole che Aristotele , accusato di empietà a causa dei suoi difficili rapporti con la monarchia macedone,abbia allora pronunciato la celebre frase : ” Non voglio che gli Ateniesi commettano un secondo crimine contro la filosofia ” , alludendo alle vicende di Socrate .Di fatto egli si allontanò da Atene e si ritirò a Calcide , sull’isola di Eubea , dove la famiglia di sua madre aveva possedimenti : qui morì intorno a 62 anni nel 322 a.c.Nominò suo esecutore testamentario Antipatro , che proprio nel 322 ristabiliva il dominio macedone sulla Grecia e su Atene , e lasciò Teofrasto a capo della scuola. Dunque Aristotele vive una generazione dopo rispetto al maestro Platone.Proprio rispetto a Platone ha origini sociali e geografiche differenti : abbiamo detto che non era di Atene e questo aspetto contribuì al fatto che Aristotele desse meno peso alla politica rispetto a Platone , che si sentiva pienamente cittadino della polis.Senz’altro a far sì che desse poco peso alla politica fu anche il fatto che all’epoca la polis stava attraversando un periodo di profonda crisi : infatti nella seconda metà del quarto secolo subentrò il regno macedone (ricordiamoci che il padre di Aristotele fu medico di Filippo e Aristotele stesso fu precettore di Alessandro Magno).Tuttavia quando si dedica alla politica , Aristotele risulta essere ancora molto legato al concetto di polis.Senz’altro Aristotele è influenzato dall’Accademia dove era stato per molto tempo , sebbene non condividesse pienamente le ideologie (dirà ” amicus Plato , sed magis veritas ” : egli era molto legato alla figura del suo maestro , ma tuttavia era più attratto dalla verità).Atene si trova in un momento difficile dove si alternano al potere il partito macedone (al quale Aristotele era vicino) e quello anti-macedone , il cui più grande e accanito sostenitore era l’oratore Demostene.Risulta particolarmente importante l’esperienza a Militene : qui , come detto , si dedicò insieme a Teofrasto a ricerche in ambito biologico e tutte strettamente legate al mondo terreno : si dice spesso che Aristotele sia partito come platonico (seguendo la dottrina delle idee) ma che poi habbia dato una svolta alle sue indagini orientandole sempre di più verso il mondo terreno.
MAXi RIASSUNTO
Aristotele nacque a Stagira , una cittadina della penisola Calcidica nel nord della Grecia nel 384 a.c.Il padre Nicomaco era medico presso la corte del re dei macedoni Aminta , ma morì quando Aristotele era ancora giovane.Egli fu quindi allevato da un parente più anziano , di nome Prosseno.Nel 367 , all’età di 17 anni , andò ad Atene al fine di entrare a far parte dell’Accademia di Platone , che si trovava all’epoca a Siracusa.Vi rimase per ben 20 anni svolgendo un’attività di insegnamento , sino alla morte di Platone che fu nel 347-348 : in realtà se ne sarebbe già andato prima in quanto aveva idee divergenti da quelle del maestro , ma si trattenne fino alla sua morte per il rispetto che aveva nei confronti di Platone . Si allontanò dall’Accademia proprio quando era subentrato Speusippo e tra i motivi del suo allontanamento possiamo annoverare la crescente ostilità che si era venuta a creare ad Atene verso il re macedone Filippo , il quale nel 348 si era impadronito di Olinto nel nord della Grecia.Nel 347 si recò da Ermia , tiranno di Atarneo , che nutriva simpatie per la filosofia platonica e aveva messo a disposizione degli accademici una sede ad Asso ,nella Troade , una zona dell’Asia minore. Qui si stabilì Aristotele e poi nel 345 a Militene , sull’isola di Lesbo.In questo periodo egli sposò Pizia , nipote di Ermia , dalla quale ebbe 2 figli , Pizia e Nicomano , entrò in rapporto con Teofrasto , che divenne suo discepolo , e intraprese ricerche biologiche sugli animali.Nel 343 Filippo lo invitò a corte in veste di precettore di Alessandro . Qui rimase a lungo finchè Filippo non fu assassinato da Pausania nel 336 e Alessandro gli succedette al trono.Nel 335 Aristotele fece il suo rientro ad Atene con Teofrasto e svolse attività di ricerca e di insegnamento nel Liceo , un ginnasio vicino al tempio di Apollo Liceo (originariamente fu chiamato “peripato” , passeggiata e luogo di discussione) , raccogliendo intorno a sè amici e scolari.Nel 323 però , morto Alessandro in Oriente , prese il sopravvento in Atene la corrente anti-macedone capeggiata da Iperide . La tradizione vuole che Aristotele , accusato di empietà a causa dei suoi difficili rapporti con la monarchia macedone,abbia allora pronunciato la celebre frase : ” Non voglio che gli Ateniesi commettano un secondo crimine contro la filosofia ” , alludendo alle vicende di Socrate.Di fatto egli si allontanò da Atene e si ritirò a Calcide , sull’isola di Eubea , dove la famiglia di sua madre aveva possedimenti : qui morì intorno a 62 anni nel 322 a.c.Nominò suo esecutore testamentario Antipatro , che proprio nel 322 ristabiliva il dominio macedone sulla Grecia e su Atene , e lasciò Teofrasto a capo della scuola. Dunque Aristotele vive una generazione dopo rispetto al maestro Platone.Proprio rispetto a Platone ha origini sociali e geografiche differenti : abbiamo detto che non era di Atene e questo aspetto contribuì al fatto che Aristotele desse meno peso alla politica rispetto a Platone , che si sentiva pienamente cittadino della polis.Senz’altro a far sì che desse poco peso alla politica fu anche il fatto che all’epoca la polis stava attraversando un periodo di profonda crisi : infatti nella seconda metà del quarto secolo subentrò il regno macedone (ricordiamoci che il padre di Aristotele fu medico di Filippo e Aristotele stesso fu precettore di Alessandro Magno).Tuttavia quando si dedica alla politica , Aristotele risulta essere ancora molto legato al concetto di polis.Senz’altro Aristotele è influenzato dall’Accademia dove era stato per molto tempo , sebbene non condividesse pienamente le ideologie (dirà ” amicus Plato , sed magis amica veritas ” : egli era molto legato alla figura del suo maestro , ma tuttavia era più attratto dalla verità).Atene si trova in un momento difficile dove si alternano al potere il partito macedone (al quale Aristotele era vicino) e quello anti-macedone , il cui più grande e accanito sostenitore era l’oratore Demostene.Risulta particolarmente importante l’esperienza a Militene : qui , come detto , si dedicò insieme a Teofrasto a ricerche in ambito biologico e tutte strettamente legate al mondo terreno : si dice spesso che Aristotele sia partito come platonico (seguendo la dottrina delle idee) ma che poi habbia dato una svolta alle sue indagini orientandole sempre di più verso il mondo terreno.Non a caso in una celebre rappresentazione di Raffaello (che possiamo ammirare qui a lato) Platone (ormai vecchio) è raffigurato con il dito teso verso l’alto e verso il mondo delle idee , mentre Aristotele è raffigurato con la mano aperta e tesa verso la terra , verso il mondo terreno. E’ a lungo prevalsa l’idea che Aristotele segua uno schema : si è infatti sempre pensato che le opere legate alla ricerca empirica dovessero essere state scritte nella fase della vecchiaia , quando Aristotele si era ormai definitivamente allontanato dal maestro Platone e dalle sue dottrine incentrate sul mondo intellegibile. E’ invece assai probabile che le opere di ricerca empirica siano state elaborate durante il soggiorno sull’isola di Militene , tra il primo ed il secondo soggiorno ad Atene . Se non risalgono esattamente a quel periodo , appare comunque evidente che risentano di tale esperienza : sono opere piene di osservazioni della vita marina tipica dell’isola . Gli uomini del 500 – 600 che polemizzarono avevano di Aristotele l’idea di un pensiero astratto e , potremmo dire , “libresco” : galileo stesso contrapporrà la lettura del libro della natura a quella dei libri cartacei che gli aristotelici leggevano . In realtà è una polemica non corretta : è sì vero che gli aristotelici erano come Galileo li definiva , ma è altrettanto vero che Aristotele non era così ! Quello di Aristotele non era poi un pensiero così sistematico ( spesso lo si è contrapposto a Platone stesso , che sondava le stesse cose da più punti di vista) e rigido : non è affatto vero che non guardasse al mondo ma solo ai libri . Senz’altro i libri gli piacevano e lo affascinavano , ma comunque le opere biologiche rivelano che faceva osservazioni dirette , specialmente a Militene : si recava spesso sulla spiaggia e nelle reti dei pescatori trovava interessante materiale di osservazione ; amava anche andare ad osservare dai pastori . i dati di fatto li esaminava , ma chiedeva anche il parere agli esperti in materia (pescatori , pastori) : era un uomo molto attento alla realtà . Per esempio scoprì che i cetacei non sono pesci , riuscì a scovare gli organi genitali dei polpi (che si trovano sul collo) e osservò lo sviluppo dell’embrione del pollo prendendo e aprendo uova fecondate . Mentre Platone ha composto un solo dialogo dedicato al mondo empirico (il ” Timeo “) , Aristotele ha dedicato più della metà delle sue opere a questo mondo . A differenza del maestro (che riteneva che il nostro non fosse il vero mondo) , Aristotele era convinto che l’unico mondo esistente fosse il nostro . Va poi detto che gran parte dei concetti aristotelici sono di derivazione biologica ed è interessante come dalla biologia derivino concetti filosofici . Platone svolgeva la duplice attività di maestro e di conferenziere , di Aristotele possediamo tutto ciò che ha scritto , ma il problema è che le cose più importanti non le ha messe per iscritto : come il suo maestro ha scritto per la pubblicazione : scriveva molto bene , ma probabilmente non come Platone .Dai dialoghi composti per la pubblicazione emerge che le sue posizioni non si distinguevano molto da quelle di Platone (può benissimo darsi che siano composizioni che risalgono ad un periodo in cui non si era ancora allontanato da quelle idee) : in una di queste opere troviamo di un tale che si reca da un oracolo per chiedere se tornerà mai in patria . Nonostante l’oracolo gli avesse detto che sarebbe tornato in patria , egli morì : probabilmente la patria alla quale si fa qui riferimente non è nient’altro che l’iperuranio platonico . Prendiamo ora in considerazione un’altra opera , il “Protrettico” , che potremmo definire “invito alla filosofia” ( funzione che lo scritto già rivestiva in Platone) : si tratta di un invito rivolto al re di Cipro a dedicarsi alla filosofia tramite un ragionamento “sofistico” e dialettico : la domanda che Aristotele pone è se si deve filosofare o no . Se non si deve filosofare si dirà che la filosofia è dannosa , spregevole … insomma si motiverà il perchè non bisogna filosofare : ma così facendo si filosofa , si fa un ragionamento filosofico . Sembra un’argomentazione sofistica ma non lo è in verità : una filosofia che fa prevalere gli aspetti irrazionali nella realtà lo fa tramite la razionalità (è il caso di Schopenaur o di Niezsche).Comunque questi dialoghi per la pubblicazione li possediamo solo per frammenti . Probabilmente andò così : Aristotele , come Platone , insegnava a scuola e scriveva , però a differenza del maestro il lavoro scolastico lo metteva per iscritto : quindi accanto agli scritti finalizzati alla pubblicazione vi erano gli appunti per le lezioni . Gli appunti erano più che altro uno schema da seguire e ci doveva comunque essere una componente di oralità . Questo ci aiuta a comprendere perchè fossero così schematici e disordinati . Oltre agli appunti che si tracciava Aristotele , vi erano anche quelli che prendevano i suoi alunni mentre lui spiegava : chiaramente anche questi hanno uno stile ben differente da quello usato nei testi da pubblicare . E’ proprio negli appunti che troviamo il vero Aristotele . Alla sua morte , i due gruppi di opere ebbero destini differenti : 1) quelle rivolte verso la scuola e sotto forma di appunti (dette ESOTERICHE o ACROMATICHE) finirono per cadere in disuso per via della loro “pesantezza” stilistica : l’aggettivo “esoterico” ha a che fare con il mistero 2)quelle finalizzate alla pubblicazione (ESSOTERICHE) , fluide e scorrevoli proprio perchè dovevano essere pubblicate , ebbero enorme successo : quelle esoteriche , come detto , erano troppo pesanti e ridondanti (nelle due “Etiche” 3 dei libri sono identici !!! E nella “Metafisica” riprende cose già dette) e finirono per andare perdute.Nella metà del primo secolo Andronico di Rodi ritrovò gli scritti esoterici andati perduti : li ripulì e cercò di tirare fuori un’edizione , riordinando il tutto.I criteri per riordinare delle opere sono parecchi ed uno dei più usati è senz’altro quello cronologico , che è neutro e nello stesso tempo coglie l’autore nel suo svilupparsi e perfezionarsi . Ma Andronico preferì riordinare per argomenti , raggruppando tutti i libri che trattavano un determinato argomento insieme : logica , fisica , etica.Tutto questo ebbe due conseguenze : a) A sparire furono le opere essoteriche (quelle volte alla pubblicazione) , in quanto si capì subito che il vero Aristotele era quello degli appunti scolastici. b) Ancora oggi abbiamo l’ordine che fu assegnato da Andronico e non quello effettivamente assegnato da Aristotele : non bisogna farsi ingannare , in quanto Aristotele ha scritto opere singole : non possiamo sapere se quello di Andronico fu realmente l’ordine che diede Aristotele (è molto imbrobabile) . Di conseguenza la sistematicità di cui lo si accusava gli derivava da Andronico : infatti Aristotele era aperto e desideroso di confrontarsi con predecessori e contemporanei.L’intero “corpus” aristotelico è strutturato secondo l’andamento dato : 1) Logica (che Aristotele non chiamava però così : lui inventò la logica ma non la parola ; la chiamava “analitica” : si tratta degli aspetti formali dei ragionamenti) : i tanti scritti di logica vengono definiti “organon” (strumento della conoscenza): nella sua classificazione delle scienze , Aristotele non inserisce la logica perchè non ha contenuti : il contenuto della logica è la sua forma stessa.Le due categorie di conoscenza erano la FISICA (in quanto ci sono corpi che cadono : comprendeva anche la biologia) e l’ETICA (intesa in senso lato : politica).Questa è dunque la tripartizione classica , ma nella logica ci sono anche la retorica e la politica , ma è sotto il nome di “Metafisica” (ciò che sta al di là della dimensione fisica) che si trovano gli scritti più importanti : Aristotele la chiamava Filosofia prima.Perchè si chiamava metafisica ? Inizialmente la filosofia prima venne chiamata metafisica perchè Andronico collocò i trattati di filosofia prima dopo i trattati di fisica : “metà” in greco , seguito dall’accusativo , significa “dopo” e quindi “metà tà fusicà” significava ciò che stava dopo le cose fisiche.Da allora nasce quest’idea della metafisica , prima con valenza editoriale , dopo con il significato vero e proprio : le cose al di là del mondo fisico.Qui emergono diversi concetti che però Aristotele elaborava “fisicamente” : a confermare questa tesi è il fatto che raccogliesse pareri qua e là , oppure che varò la costituzione per gli Ateniesi (egli raccolse 158 costituzioni per avere materiale su cui ragionare per la sua politica : tra l’altro un secolo fa in Egitto questa costituzione ateniese di Aristotele fu ritrovata in un papiro ) : non si deve poi scordare la “historia animalium” (che non è una storia , bensì una descrizione particolareggiata degli animali) , che potremmo catalogare come opera zoologica : Aristotele per creare quest’opera aveva raccolto diverse esperienze (l’amico Teofrasto , invece , si occupò di botanica).Nella “Metafisica” Aristotele argomenta che l’uomo per sua inclinazione naturale aspira alla conoscenza e traccia dunque una scala gerarchica della conoscenza ( un pò come aveva fatto Platone ) : man mano che si sale ogni gradino è caratterizzato da un approfondimento rispetto al precedente . Al gradino più basso troviamo 1)la SENSAZIONE : ricordiamoci che Aristotele ha della conoscenza una concezione empiristica : la mente umana prima delle sensazioni è una “tabula rasa” (una tavola incerata schiacciata e rinnovata) : prima dell’esperienza sensuale non c’è nulla (a differenza di quanto diceva Platone , che era un innatista) ; in Aristotele c’è un rifiuto radicale della concezione innatistica : la conoscenza ci deriva interamente dall’esperienza sensuale.Per Platone l’esperienza sensuale c’era , ma era una concausa : era infatti semplicemente un modo per realizzare la reminescenza . L’opposizione Platone – Aristotele è davvero forte : ancora oggi c’è chi è innatista (e sostiene che nasciamo già con alcune cose nella testa) e chi è empirista (ed è del parere che la nostra mente è una tabula rasa).In realtà la filosofia successiva non sarà nient’altro che una variante di posizioni aristoteliche o platoniche . E’ come se questi due grandi filosofi avessero tracciato i due modelli per filosofare .Le sensazioni sono quelle che l’uomo ha in comune con gli animali : per Aristotele ci sono due tipi diversi di anime : un tipo , più complesso , ed un altro , più semplice. L’anima dei vegetali , per esempio , non prova sensazioni , mentre quella dell’uomo e dell’animale prova sensazioni : è proprio il poter provare sensazioni che funge da punto di partenza per la conoscenza.Aristotele attribuisce grande importanza all’udito (organo con cui si possono ascoltare i discorsi : malgrado Aristotele sia più “libresco” di Platone , in lui non troveremo mai una polemica contro gli scritti : anzi , l’idea che per studiare ci si debba servire di libri è tipicamente aristotelica ) e questo significa che ai suoi tempi l’oralità era ancora importantissima . Però per Aristotele l’organo di gran lunga più importante era la vista perchè più di ogni altro consente di distinguere gli oggetti : non a caso conoscere significa proprio distinguere , definire : ad un livello empirico la prima separazione è la distinzione degli oggetti sensibili . Però il grosso limite della sensazione è che fa cogliere solo il fatto , il che (in greco l'”oti”) e non il perchè (il “dioti”) : per arrivare al perchè bisogna seguire un lungo percorso .2) Al secondo gradino Aristotele mette la MEMORIA : l’intelligenza si può sviluppare se accanto alla sensazione c’è la memoria : gli animali non riescono a conservare la singola esperienza e così non hanno intelligenza . La memoria consiste proprio nel conservare le singole esperienze , nel ricordare le sensazioni . 3) Al terzo gradino Aristotele pone l’ESPERIENZA : essa non è la singola sensazione , bensì l’accumularsi di sensazioni grazie alla memoria : questa è l’esperienza : mettendo insieme una serie di casi singoli si riesce ad arrivare ad una prima forma di generalizzazione . Se si ha avuto a che fare con malattie e cure , si avrà una generalizzazione e si saprà come agire nel caso si ripresentino : mi sono accorto che una medicina giova ad una determinata persona , poi ad un’altra e poi ad un’altra ancora tutti accomunati dalla stessa malattia , anche somministrandola ad un’altra persona otterrò gli stessi risultati . Chi ha esperienza medica e ha visto che certe medicine hanno giovato a più persone con una stessa malattia è arrivato a dire che a chi ha tale malattia va somministrata tale medicina : questa però non è ancora la “scienza” vera e propria . Si ha una vera conoscenza quando si può dire che la determinata malattia va curata con una determinata medicina perchè va ad operare su determinate cose , organi…Con la scienza si arriva al “dioti” puro ; mentre con l’esperienza intuisco che una determinata medicina giova in certi casi , con la scienza riesco a fornire delle motivazioni : ad esempio , tramite la scienza so che l’aspirina ha un effetto anticoagulante e che di conseguenza posso prevenire e curare l’infarto : non dico più che in certi casi ha funzionato e che quindi anche qui deve funzionare , bensì che avendo un effetto anticoagulante curerà e gioverà a tutti coloro che han l’infarto . Si passa così dall’oti al dioti : quelle persone sono guarite perchè hanno quella determinata malattia e questa medicina la cura. Si passa quindi dal particolare all’universale : il vero passaggio è quando da un pò di casi riesco a cogliere il significato universale : non parlo più di individui che hanno certi sintomi etc. , ma , per esempio , di diabetici.Da una collezione di casi particolari raggiungo una concezione universale.La scienza grazie all’esperienza mi dice che le malattie circolatorie si curano con l’aspirina e di conseguenza quell’individuo che soffre di cuore deve essere curato con l’aspirina : con una serie di esperienze raggiungiamo la scienza . Aristotele , poi ,

afferma che coloro che sono esperti , che hanno acquisito tante esperienze , sono migliori rispetto a quelli che hanno studiato e sanno solo il dioti : affinchè la scienza entri in funzione le esperienze sono fondamentali : esse ci consentono di riportare i casi singoli a verità universali . L’esperto ha solo la casistica , lo scienziato solo la scienza , la verità universale : nella pratica l’esperto va meglio fin tanto che lo scienziato non fa esperienze . Un medico che non abbia mai studiato medicina , ma che sia esperto (avendo già curato o operato) è di sicuro meglio di un medico che abbia studiato tutto ma che non abbia mai avuto esperienze di intervento . Il medico con scienza ed esperienza risulta a sua volta essere il migliore di tutti : l’esperienza è un insieme di casi da cui si possono trarre conclusioni generali operative : il buon medico deve sapere da casi particolari ricondursi a casi generali e viceversa . La “tekne” sembra essere molto vicina all’esperienza , ma in realtà comporta un coglimento della realtà universale , l’acquisizione del dioti e dell’oti . Da questi singoli casi si trae una verità di carattere generale : perchè in tutti quei casi va così ? Nel caso della medicina parliamo di eziologia , perchè si usa una determinata cura : se si sa calare l’universale nel particolare è già una buona cosa : perchè se io ho un ‘ottima conoscenza dell’universale (che ho ottenuto studiando sui libri) , ma poi non so calarla nel particolare , la mia conoscenza è inutile . In realtà si dovrebbe parlare di scienza applicata , di “tekne” . Aristotele sulle scienze fa una classificazione generale : 1) le scienze applicabili (quelle che mi consentono di produrre qualcosa) 2) le scienze NON applicabili (quelle che non mi fanno produrre niente) . A proposito delle “teknai” Aristotele effettua una tripartizione : ci sono le tecniche a)necessarie b)utili c)piacevoli . Esaminiamo le distinzioni : la tecnica di procacciarsi il cibo è senz’altro necessaria : occorrono conoscenze applicative per sapersi procacciare il cibo (Ippocrate diceva che occorreva pure la conoscenza di come cucinarlo , e questa è una scienza utile , non fondamentale) ; come esempio di “tekne” piacevole possiamo portare l’arte culinaria , che mira solo a soddisfare e a dare piacere al palato . La tekne per Aristotele non rappresenta comunque il livello più alto del sapere perchè è subordinata in ogni caso a fini diversi della conoscenza : è dall’esperienza che si genera la tekne , ma l’esperienza non è ancora tekne pura : la tekne è infatti caratterizzata dall’avere come oggetto della propria conoscenza l’universale : la medicina raggiunge il livello di tecne (e non più di semplice esperienza) quando è in grado di conoscere che un determinato rimedio non guarisce solamente Socrate e Platone , bensì ogni persona affetta da una determinata malattia . Il che significa che quel rimedio è efficace nella totalità o universalità dei casi in cui c’è quella malattia . Anche chi ha fatto esperienza sa che quel determinato rimedio è stato efficace in una pluralità di casi , ma non sa perchè (ha l’oti , ma non il dioti) . Secondo Aristotele al di sopra delle tecniche si colloca una forma di conoscenza che ha di mira soltanto se stessa : il sapere per il sapere , ossia la conoscenza disinteressata , libera da vincoli , non subordinata a fini esterni ad essa . Questa è la “sophia” , il sapere più sublime a cui mira la filosofia . Così Aristotele ha definitivamente staccato l’idea del sapere da come era in passato , dove il sapere veniva visto come legato e funzionale all’agire e al produrre . Per poter ricercare questo sapere disinteressato occorre quella che in greco era detta “scholè” , ossia l “otium” latino , il tempo libero da ogni attività lavorativa o pubblica . Dunque se è vero che tutti gli uomini per inclinazione naturale aspirano al sapere , è altrettanto vero che solo i filosofi realizzano in senso pieno questo fine iscritto nella natura dell’uomo . Ma perchè questo sapere che in fondo non serve a nulla è la cosa più importante ? E’ proprio il fatto di non servire a niente che lo innalza : una cosa che non serve è più nobile perchè non è legata al rapporto di servitù . Le sensazioni servono all’uomo e ne prova piacere : se per esempio avessimo la possibilità di conoscere la realtà senza vederla , non per questo vorremmo essere ciechi : nella vista consiste un piacere irrinunciabile . Questo “esperimento mentale” conferma le tesi di Aristotele . Comunque Aristotele crea anche una scala di acquisizione cronologica di queste teknai : le scienze necessarie sono le prime che l’uomo deve acquisire , in quanto gli consentono la sopravvivenza , poi deve acquisire quelle utili , che gli offrono comodità non fondamentali , ma importanti , ed infine quelle piacevoli (ed inutili) : possiamo riassumere così la scala di acquisizione cronologica :”primum vivere , deinde philosophare “: prima di tutto bisogna pensare alla vita (Aristotele si mostra ancoira una volta legato al mondo terreno) . Il fatto che vengano acquisite per ultime , non significa che le scienze piacevoli valgano meno , anzi sono le più preziose in assoluto . Le prime scienze che acquisiamo sono le esperienze , ma le più importanti sono le scienze universali , che consentono una visione di insieme . Come abbiamo detto , le conoscenze piacevoli si sviluppavano nella “scholè” : per noi il non fare niente è un concetto negativo prima che sul piano morale-assiologico , su quello ontologico : nel non far niente vi è la mancanza di qualcosa . Per i Greci e per i Latini era diverso : la “scholè” era quella parte dell’esistenza in cui ci si dedicava all’attività studiosa . E’ interessante come Aristotele insista su questa forma di studio disinteressato e affermi ripetutamente che questa sia la più nobile delle vite . Questo è dovuto a due fattori : 1) la mentalità greca generale (come quella Latina) era propensa ad esaltare l’ozio 2) tra Platone e Aristotele c’è una grande differenza : secondo Platone si deve arrivare alle conoscenze supreme , al mondo intellegibile ; per Aristotele le conoscenze sono sensibili e presenti su questo mondo . Quando delineano il modello di vita da seguire , Platone traccia il percorso volto al raggiungimento del bene in sè (si vede comunque nel mito della caverna che i filosofi devono ritornare sulla terra a governare : il punto di arrivo è il re-filosofo) ; per Aristotele non è così : riconosce il modello dell’uomo cittadino , ma l’uomo più elevato sarà lo studioso , colui che si dedica all’otium e non al negotium : come mai ? Ricordiamoci che Aristotele vive dopo Platone , in un’epoca in cui la polis è in crisi (per Platone e Socrate era scontato che l’uomo ed il cittadino fossero un tutt’uno ) : vi è un progressivo scollamento da Socrate in poi tra uomo e cittadino , che un tempo erano indivisibili : Socrate aveva voluto morire , mentre Platone si era reso conto che la politica fosse ingiusta e aveva spostato la figura del politico nel mondo ideale : Sofocle in persona aveva notato questo progressivo scollamento uomo-cittadino . Per Aristotele non solo l’uomo può essere uomo senza essere necessariamente cittadino , ma anzi nella dimensione in cui non è cittadino è migliore : questa teoria avrà gran successo e prenderà piede (pensiamo agli epicurei ed al loro motto “lathe biosas” , ” vivi di nascosto ” : l’uomo per essere felice deve vivere lontano dalla politica , in privato ).Quindi possiamo provare a tracciare una graduatoria del graduale staccamento uomo – cittadino : a) in Socrate c’è piena identificazione b) in Platone c’è sì identificazione , ma non in questo mondo (in quello delle idee) c) Aristotele apprezza la vita politica , ma non c’è più l’identificazione tra uomo e cittadino d) in Epicuro c’è un totale rifiuto della figura uomo-politico associata . Va poi ricordato che Aristotele era uno straniero e non poteva svolgere vita politica : è quindi evidente che non si sentisse uomo-cittadino , ma tuttavia questo è l’aspetto meno imprtante che determinò lo scolllamento aristotelico tra uomo e cittadino .Dalla fine del quinto secolo fino al terzo si arriva ad un rifiuto della politica : la filosofia nasce quando le civiltà si sviluppano e un gruppo sociale ( i filosofi ) può vivere senza lavorare . Aristotele distingue due grandi classi di scienze : quelle che hanno come oggetto il necessario e quelle che hanno come oggetto il possibile . Osserviamo qui sotto lo schema generale : Le prime sono dette scienze TEORETICHE e riguardano appunto ciò che è o ciò che avviene necessariamente sempre o per lo più (in greco “epì polù”) nello stesso modo . Per necessario intendiamo ciò che non può essere o avvenire diversamente da come è o avviene . Si tratta dunque di domini di oggetti o eventi caratterizzati da una regolarità totale o con scarse eccezioni : la matematica rientra nelle teor
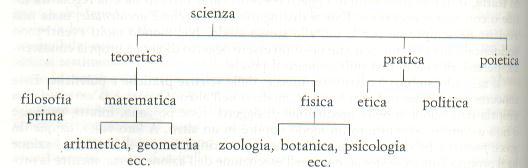
etiche perchè 2 + 2 mi darà sempre 4 e non si può fare nulla se non indagare a fondo . Il mondo biologico rientra anch’esso nelle teoretiche ma nella “sezione” epì polù (per lo più ) . L’epì polù lo possiamo definire come un surrogato delle scienze matematiche , che vanno sempre allo stesso modo : Aristotele studiò anche le generazioni e si accorse che non sempre riuscivano bene : gli individui di solito (per lo più) vengono in un modo , ma può succedere che vada diversamente e che abbia storpiature , deformità . Come nel caso delle generazioni , così anche nel mondo molti avvenimenti sono accidentali ma non sono studiabili perchè di essi non si può indicare il dioti (il perchè) . Il secondo ambito è invece costituito dalle scienze PRATICHE e POIETICHE : esse concernono ciò che può essere in un modo o nell’altro ; questa è la caratteristica propria dell’ azione e della produzione di oggetti : esse infatti possono avvenire o non avvenire , avvenire in un modo o in un altro . A loro volta azione (praxis , da qui pratiche) e produzione (da poieo , da qui poietiche) si distinguono per il fatto che l’azione ha il proprio fine in se stessa , ossia nell’esecuzione dell’azione stessa , mentre la produzione ha il suo fine fuori di sè , ossia nell’oggetto che essa produce . L’etica è una scienza pratica : il suo fine è in se stessa ed è il comportamento ; la poesia è una scienza poietica perchè mi fa produrre poesie : il suo fine sta al di fuori di sè . Tuttavia Aristotele non ci parla molto delle poietiche perchè non lo interessavano molto : ricordiamoci che per lui la vita migliore è quella del filosofo , mentre quella dell’artigiano che produce non è valutata positivamente (come d’altronde non lo era in tutto il mondo greco) . L’unica scienza poietica valida ed utile era per Aristotele la poesia , della quale ci parla ampiamente nella “Poietica” , opera che però non ci è pervenuta interamente : pare che ce ne fosse un altro libro che non fu mai ritrovato e sulla cui ricerca ruota “Il nome della rosa” di Umberto Eco . Per Aristotele il concetto di poietica era molto legato a quello di tragedia : la poietica infatti la si può estendere a qualsiasi forma di creazione artistica : è la conoscenza che genera qualcosa . A riguardo dell’opera d’arte e della tragedia erano già state formulate due importanti tesi : a) Gorgia , il cui giudizio era stato fortemente positivo : in assenza di un modello da imitare (per lui l’essere non esisteva e tutto era falso) , l’artista è colui che crea nuovi mondi ed è tanto più bravo tanto più riesce ad ingannare gli spettatori . b) Platone , il cui giudizio non era certo stato positivo : per lui l’arte e la tragedia erano copie di copie , vale a dire copie del mondo sensibile che a sua volta è copia del mondo intellegibile . Si aggiungeva poi la crisi sul piano morale : l’arte fomenta e stimola la passioni inducendo i giovani (e non solo) ad avvicinarsi ad esse . Aristotele assume una nuova ed importantissima posizione : egli rivaluta l’arte (ed in particolare la tragedia) sia sotto il profilo ontologico sia sotto quello etico : sul iano ontologico Platone diceva che era imitazione di imitazione , Aristotele fa notare che la tragedia ha per lo più come argomento il mito , che racconta cose non vere : i prsonaggi sono dei “tipi umani” . La tragedia , dice Aristotele , descrive il verosimile : non ci dice cosa ha fatto quella determinata persona in quel frangente , ma cosa farebbe qualsiasi persona in quel caso . Ci presenta non il vero ma il verosimile : questo per Aristotele è un elemento che conferisce un valore particolare : ricordiamoci che la vera scienza per Aristotele è scienza dell’universale e non el particolare : la tragedia ha quindi una valenza conoscitiva ed è molto migliore della storia : la storia infatti non mette mai di fronte all’universale , bensì racconta le gesta dei singoli : mi racconta casi particolari e non universali . La tragedia ha quindi una valenza filosofica perchè mi mette di fronte a casi universali.La tragedia è imitazione in forma drammatica e non narrativa di un’azione seria e compiuta in sè attraverso una serie di avvenimenti che suscitano pietà e terrore : il suo contenuto è un mito . Da qui in poi si rivaluterà completamente l’arte che Platone aveva disprezzato . Per dirla alla Platone , l’arte per Aristotele non imita il mondo sensibile , ma le idee stesse : imita infatti l’universale . Esaminiamo ora l’aspetto etico-morale dell’arte : come Platone , così anche Aristotele sostiene la metriopazia ( il controllo , la misura delle passioni) e non l’apazia (la privazione delle passioni ) : la valutazione della tragedia da parte di Aristotele è antitetica rispetto a Platone anche sul piano etico : Platone diceva che stimolava alle passioni e che quindi andava abolita , Aristotele introduce la KATARSI artistica : (parola che deriva dalla medicina , suo padre era medico , e risente del suo interesse biologico : katarsi significa “purga” e più in generale “purificazione” : è il meccanismo con cui ci si purifica dalle sostanze dannose ) : chiaramente è una metafora . Ma che cosa intende Aristotele per purificazione ? Il passo in cui ci parla della katarsi è molto breve (ricordiamoci che erano appunti) complesso e quindi è difficile capire se intenda purificazione dAlle passioni o dElle passioni : Se fosse dAlle passioni , sembrerebbe che con la tragedia ci si libera dalle passioni , il che è una contraddizione ; quindi Aristotele intendeva purificazione dElle passioni : nella tragedia infatti vengono messe in gioco passioni negative , spaventose : Platone le rifiutava totalmente perchè pensava che vedendole si stimolassero e nascessero in chi le vedeva ; Aristotele , invece , scopre che vedere in scena certe passioni ha l’effetto di oggettivarle e di far sì che l’individuo possa riuscire a controllarle : ancora oggi gli psicologi mirano quando i pazienti sono afflitti da ansie a farle uscire , a tirarle fuori , a far prendere coscienza al paziente delle proprie ansie : il fatto di guardarle in faccia , a tu per tu , consente di controllarle e di razionalizzarle . Vedere sulla scena , in un situazione in cui si oggettiva e si vede con un certo distacco , permette di razionalizzare le passioni . Il processo della katarsi consente all’uomo di vivere meglio le passioni negative , il terrore inducendolo a guardarsene . Ritorniamo ale scienze teoretiche , il cui fine è la verità e la cui base è il sapere per il sapere : Aristotele effettua una tripartizione : le scienze teoretiche sono 1) FISICA 2) MATEMATICA 3)FILOSOFIA PRIMA .Parliamo di esse a seconda degli oggetti che studiano . Della fisica Aristotele ne parla come filosofia seconda : essa studia oggetti che esistono di per sè , ma sono mutevoli . La matematica studia oggetti immutabili , ma che di per sè non esistono . La filosofia invece studia oggetti che non si muovono ed esistono di per sè .Per Platone erano sostanze in senso pieno le idee , mentre il mondo sensibile era un essere depotenziato : Aristotele costruisce una filosofia più vicina al senso comune : egli si chiede : ” quali tipi di sostanze esistono ? ” Arriverà a dimostrare l’esistenza di cose immmateriali , come Dio , ma egli parte dicendo che senz’altro tutte le cose materiali che vediamo intorno a noi esistono ; per Aristotele non esistono da soli e separatamente quelle cose che per Platone esistevano (in particolare quelle caratteristiche quantitative che Platone diceva esistere di per sè) , come gli enti matematici , i numeri : per Platone c’era il triangolo in sè e poi gli altri triangoli sensibili . Per Aristotele è l’opposto : esistono i triangoli materiali e poi quello immateriale , che però non può mai esistere come realtà autonoma . Platone aveva minuziosamente dimostrato che noi quando dimostriamo ci riportiamo all’idea di triangolo . Per Aristotele esistono prima i triangoli materiali e poi quello immateriale : quello “ideale” per Aristotele non è nient’altro che una nostra creazione , siamo noi che facciamo un’astrazione : esso esiste solo come risultato di un processo di astrazione da noi operata . Due libri hanno la forma di parallelepipedo : Platone direbbe che imitano l’idea di parallelepipedo . Per Aristotele no , è l’opposto : si fa un processo di astrazione dove poco per volta si tirano fuori le caratteristiche : i due libri non hanno colori uguali , quindi tolgo i colori ; hanno scritte diverse , quindi tolgo le scritte ; sono imprecisi , tolgo le imprecisioni ; privato di tutte le caratteristiche mi rimane solo più la forma di parallelepipedo : il processo consiste essenzialmente nell’asportare via le differenze tra i due libri . Diciamo che la matematica indaga cose che di per sè non esistono perchè le si creano con l’astrazione e cher indaga cose immutevoli perchè il parallelepipedo è sempre esistito . Per Platone il parallelepipedo esiste nell’iperuranio , per Aristotele nel mondo terreno , nei due libri , per esempio . La fisica studia quel mondo fisico che Platone non amava : le sostanze materiali che di per sè esistono ma sono mutevoli . In particolare la fisica studia gli enti naturali . La filosofia prima è anche chiamata metafisica (abbiamo già spiegato il perchè) Che cosa studia ? Ci sono due modi per definire l’oggetto dello studio della filosofia prima : a) Gli oggetti che esistono da soli come le cose sensibili e sono però immutabili come i numeri della matematica : la filosofia prima assumerà poi le istanze di teologia perchè è solo la divinità che è immutabile ed esiste di per sè . b) E’ comunque anche un’ontologia perchè studia pure l’essere in quanto essere (quest’espressione , essere in quanto essere , fu proprio creata da Aristotele) . Non si occupa di un tipo particolare di essere . Lo studio degli animali in quanto animali è la biologia , quello dei numeri in quanto numeri è la matematica , e così via .La filosofia prima invece studia simultaneamente un solo oggetto (la divinità) e tutti gli oggetti per la loro caratteristica di essere . Aristotele discute poi dell’infinito nel contesto matematico : egli nega l’esistenza dell’infinito , che negherà anche parlando di cosmologia : il cosmo è una cosa finita . L’infinito per Aristotele esiste solo potenzialmente , ma non è mai effettivamente attuabile . Non esiste come realtà fisica e neanche come realtà matematica : esiste solo potenzialmente . Concentriamoci sul contesto matematico : Aristotele sa bene che ogni numero è aumentabile di una unità : l’infinito numerico è però solo potenziale : si usano sempre e solo numeri finiti che si possono aumentare di una unità : non c’è mai in atto un numero infinito , solo potenzialmente c’è . L’infinito esiste anche nell’infinitamente piccolo (sempre potenzialmente) : si può dividere all’infinito , ma comunque in realtà non si trova mai un numero infinito . Bisogna precisare che Aristotele aveva una concezione CONTINUA della realtà e non discreta (come invece aveva Democrito ) : per Aristotele i numeri non sono infinitamente divisibili (va detto che all’epoca non si conoscevano le frazioni ). L’infinito potenziale esiste , sia nel piccolo sia nel grande ; questo però vale solo per la matematica , perchè invece nel mondo fisico non c’è neppure in forma potenziale . Le considerazioni di Aristotele sulla matematica sono state importantissime per la storia tant’è che ancora oggi abbiamo una concezione della matematica che ci deriva da Aristotele : per noi , come per Aristotele , i numeri sono astrazioni e non realtà di per sè esistenti (come era invece per Platone : il due esisteva perchè imitava l’idea di due) : per Platone il due di per sè non esiste : lo si ricava tramite quel processo di astrazione che abbiamo prima spiegato : ci sono due libri , due penne … Comunque ancora oggi la questione non è stata risolta e c’è ancora chi sostiene che i numeri esistano davvero come realtà a sè stanti , schierandosi così dalla parte di Platone : il ragionamento che li porta a dire che esistano indipendentemente dalla realtà è riassumibile in questi termini : se nessuno contasse più , i numeri continuerebbero ad esistere ? I semiplatonici dicono di sì . Però ad Aristotele la matematica non interessa molto , a differenza di Platone che era legato ai Pitagorici : la fisica aristotelica torna ad essere una fisica puramente qualitativa . Se ci chiedessimo se nella concezione della realtà è più moderno Platone o Aristotele la risposta non sarebbe facilissima : Aristotele riconosce un’autonomia del mondo fisico (indipendente dal mondo delle idee) ; però Platone ha un carattere quantitativo nello studio della realtà : lo si può definire un precursore della fisica moderna ; per Platone infatti non si può studiare il mondo sensibile senza applicare la matematica . Il motore che avvia la ricerca del sapere è ravvisato da Aristotele nell meraviglia , nel meravigliarsi e nel chiedere “perchè ?” . La meraviglia dà quindi avvio ad una ricerca volta a dare risposta a questa domanda e segna la transizione dal che (l’oti) al perchè (il dioti) . Per Aristotele la scienza trova la sua espressione nel linguaggio e precisamente nei discorsi . Nei dialoghi la logica svolge un ruolo fondamentale : essa era stata inventata in epoche precedenti ad Aristotele ; pensiamo a Parmenide (identità , contraddizione) o a Platone (soprattutto nel ” Sofista “) : però non era ancora chiaro fino in fondo il carattere formale della logica : veniva solo applicata ad aspetti concreti . Aristotele invece è stato l’inventore di un metodo : la sostituzione delle proposizioni con le lettere (cosa che si usa adesso soprattutto in matematica) : a è un numero qualsiasi , non si sa quale , ma sarà sempre quello . Ciò implica la possibilità di studiare le strutture a prescindere dai contenuti . In realtà la parola “logica” è stata coniata dagli Stoici ed ha avuto gran successo : la logica è quella che studia il “logos” , il pensiero . In realtà Aristotele la chiamava ANALITICA (dal greco analuo , ana+luo = scomporre una realtà complessa nei suoi elementi : proprio come le proposizioni sostituite dalle lettere ) . Come detto , la logica non rientra nelle scienze perchè non è scienza , però è lo strumento delle scienze : mi consente di verificare la coerenza dei passaggi logici : essa di per sè non ha nessun oggetto . Logica deriva da logos , termine che significa tanto discorso quanto pensiero : è come se prima di parlare ad alta voce si parlasse dentro di noi ; lo studio di Aristotele in teoria studia , indaga il pensiero ma in realtà studia il linguaggio perchè non si può avere accesso alle menti altrui per indagare il pensiero . Successivamente la logica diventerà studio dei diversi tipi di discorso . Accanto ai libri di logica , Aristotele ha scritto la “Retorica” : fa notare che noi siamo abituati a pensare che la forma classica del discorso è quella in cui si predicano il soggetto ed il predicato : esempio “Socrate corre ” ; “Socrate è ad Atene” …Le proposizioni costituite da predicato e soggetto sono chiamate APOFANTICHE (o dichiarative : dicono qualcosa di qualcosa) : queste proposizioni sono le uniche che possono essere o vere o false : se dico “il libro è sul tavolo ” può essere vero (se effettivamente il libro è sul tavolo) , ma anche falso (se non è sul tavolo) . Le preghiere , le esclamazioni , le domande , i comandi non dichiarativi : non sono nè veri nè falsi ; se dico “oimè ” non è nè vero nè falso . La retorica può rivolgersi sia al passato (valuto , per esempio , le imprese di un uomo) sia al presente (lodo le caratteristiche di una persona , per esempio) sia al futuro (impartisco comandi) : sono i discorsi suasori , dove l’importante è la tecnica del persuadere ; Aristotele però non si rivela molto interessato ai discorsi suasori , che non sono nè veri nè falsi . Dire “Socrate è un uomo” non è un ragionamento , ma una proposizione (apofantica) che può essere o vera o falsa . Un ragionamento invece è una catena di proposizioni e Aristotele lo chiama ” SILLOGISMO ” (sun + lego = ragionamento concatenato) ; un sillogismo è costruito da due premesse e una conclusione . Le proposizioni sono anche scomponibili ; le parti che costituiscono una proposizione sono il soggetto ed il predicato , e dato che sono gli estremi della proposizione vengono chiamati “termini della proposizione” . Le proposizioni possono essere divise sotto tre aspetti : 1) QUANTITATIVO 2)QUALITATIVO 3) MODALE . 1) Sul piano quantitativo , le proposizioni possono essere universali o particolari .Se dico “tutti gli uomini sono mortali” è universale ; se invece dico “alcuni esseri viventi sono animali” è particolare. Nel primo caso dico che tutti , senza eccezioni , gli uomini sono mortali . Nel secondo caso dico alcuni . Aristotele nell’ambito delle quntitative riconosce anche le “individuali” , per esempio “Socrate è uomo ” il soggetto non ha valenza nè universale nè particolare , bensì individuale o particolarissimo . Un termine individuale in una proposizione non può mai fungere da predicato , ma solo da soggetto . Invece , i termini che rientrano a costituire le proposizioni della scienza possono fungere sia da predicato sia da soggetto : sono quindi termini universali (ad esempio “uomo”) . 2)Sul piano qualitativo , possono essere affermative o negative : sia le universali sia le particolari possono essere sia negative sia affermative ;universale affermativa “tutti gli uomini sono mortali” ; particolare affermativa “alcuni esseri viventi sono mortali” ; universale negativa : “Nessun uomo è bianco” ; particolare negativa “qualche uomo non è bianco ” . 3) Sul piano modale , le proposizioni possono essere a) possibili b) contingenti c) impossibili d) necessarie : a)non è in un modo , ma potrebbe esserlo (non piove ma potrebbe cominciare) b) è l’opposto del possibile : è in un modo , ma potrebbe non esserlo (piove , ma potrebbe non piovere) c) ciò che non è che non può essere d) ciò che è e che non potrebbe non essere . Le modali stanno tra loro a 2 a 2 : l’impossibilità è una forma di necessità : dire che una cosa è impossibile significa dire che è necessario che non sia .Nel “Parmenide” di Platone questo concetto emergeva molto bene : la necessità è ciò che è e che non può non essere . La logica ci consente di studiare la struttura del pensiero e di cogliere gli aspetti formali , evitando così di incappare in errori formali : essa ci permette di fare ragionamenti coerenti .L’unico modo per non fare errori di ragionamento è separare la forma dal contenuto . Aristotele dice che le proposizioni possono essere CONTRADDITORIE o CONTRARIE : le contrarie hanno la prerogativa di non poter essere entrambe vere , ma di poter essere entrambe false : per esempio le proposizioni “tutti gli uomini sono bianchi” e “nessun uomo è bianco” sono tutte e due false , in quanto qualche uomo è bianco e qualche altro non lo è . Le contrarie però accettano una via di mezzo : in questo caso la via di mezzo è “alcuni uomini sono bianchi” : un buon modo per cogliere due proposizioni contrarie è vedere se hanno una via di mezzo. Le contradditorie invece hanno la prerogativa di essere necessariamente una vera e l’altra falsa : “tutti gli uomini sono bianchi” , “qualche uomo non è bianco” : se la seconda è vera , la prima non lo è .Questa divisione aristotelica tra proposizioni contrarie e contradditorie è di fondamentale importanza perchè noi nei ragionamenti talvolta traiamo conclusioni sbagliate perchè non abbiamo ben chiaro il funzionamento delle proposizioni : a volte diciamo che una cosa è falsa e argomentiamo che l’opposto è vero : questo vale solo per le contradditorie : è il principio della dimostrazione per assurdo . Se non mi accorgo che le proposizioni sono contrarie e ragiono così sbaglio clamorosamente : ad esempio , ” Stalin è un imbecille” : questo non mi consente di dire ” Hitler è intelligente” : sono due contrarie e quindi ci deve essee una possibilità intermedia . Finchè le forme del pensiero sono intrecciate col contenuto , i ragionamenti sono incoerenti : per ragionare bene bisogna separare la forma dal contenuto , un pò come nella matematica con le lettere , dove si vede il ragionamento allo stato puro . La logica si muove su tre livelli 1) TERMINI : come abbiamo detto sono il soggetto ed il predicato : i termini non sono mai nè veri nè falsi , solo le proposizioni possono essere vere o false : se dico “uomo” non è nè vero nè falso , ma se dico “l’uomo corre” può essere falso ; anche se dico una cosa che non esiste come l’ippogriffo , un animale mitologico , non è sbagliato : infatti costruendo la proposizione potrò dire “l’ippogriffo non esiste ” ed è giusto , oppure “l’ippogriffo esiste” ed è sbagliato . 2) le proposizioni , che sono le uniche che possono essere o vere o false . 3) I sillogismi , dati da due premesse e una conclusione : essi non sono nè veri nè falsi , ma coerenti o incoerenti : tutto dipende dalle premesse che avevo in partenza . Ad esempio, prendiamo due premesse sbagliate : “tutte le cose verdi sono vegetali” e “tutte le rane sono verdi” : con il sillogismo arrivo alla conclusione che tutte le rane sono vegetali , ma il sillogismo non è affatto sbagliato : sono sbagliate le premesse ! La conclusione è stata tratta correttamente sfruttando le premesse . si chiama premessa maggiore di un sillogismo quella che fornisce informazioni più generali , mentre premessa minore quella che fornisce informazioni più particolareggiate : ad esempio : premessa maggiore “tutti gli animali sono mortali” ; premessa minore “tutti gli uomini sono animali” ; conclusione “dunque tutti gli uomini sono mortali” . Questo sillogismo viene detto di “prima figura” : le premesse sono universali affermative ed il termine medio è “animali” , che nella prima frase è soggetto , nella seconda è predicato . Il termine “animali” è termine MEDIO perchè mi consente di collegare tra loro nella conclusione gli altri due termini che compaiono invece ciascuno in una sola delle premesse . Accanto a questa prima figura per Aristotele esistono altri due tipi di figure , che si distinguono in base alla posizione del termine medio come soggetto o predicato nelle premesse . Ciascuna figura a sua volta si può articolare in diversi “modi” , a seconda delle qualità delle premesse (affermative o negative) o della quantità (universali o particolari) . Ma solo la prima figura agli occhi di Aristotele è quella propriamente scientifica : essa infatti consente di rispondere alla domanda centrale della scienza “perchè ?” ; nel nostro caso se ci si chiede perchè tutti gli uomini sono mortali , la risposta è insita nel termine medio “animali” . E’ il fatto che gli uomini sono animali a spiegare il fatto che essi sono mortali . Il sillogismo partendo dalle premesse arriva a dimostrare che gli uomini sono mortali . Se le premesse sono vere anche la conclusione è necessariamente vera . Proprietà del sillogismo è infatti la trasmissione della verità dalle premesse alla conclusione.Il carattere universale delle premesse consente di raggiungere una conclusione universale e necessario e proprio della scienza è ciò che è vero universalmente in tutti i casi . Il termine medio gioca un ruolo fondamentale perchè mi consente di collegare le premesse per trarre la conclusione . Si possono anche analizzare le mansioni dei termini : il medio svolge le funzioni sia di predicato (tutti gli uomini sono animali) sia di soggetto (tutti gli animali sono mortali) : è proprio il fatto che in una proposizione il medio sia soggetto e nell’altra predicato che mi consente di trarre la conclusione corretta . Se il “medio” fosse solo predicato o solo soggetto in tutte e due le premesse non potremmo trarre conclusioni così semplici : se per esempio avessimo queste due premesse “tutti i vegetali sono verdi ” e “tutte le rane sono verdi” finiremmo per dire “tutte le rane sono vegetali” : il medio (rane) è soggetto in tutte e due le proposizioni . In questo caso teoricamente non lo si può neanche chiamare termine medio . La logica , come detto , ci consente di evitare errori perchè separa le forme dai contenuti ; nel passato ci fu chi disse “quel tale ha quel carattere ed è delinquente” “tu hai quel carattere” “di conseguenza sei delinquente” : è sbagliatissimi perchè il termine medio (carattere) è solo predicato . Secondo Aristotele il termine medio serve a spiegare il dioti , il perchè di un qualcosa . Si è però più volte notato che in realtà le conclusioni spesso non derivano dalle premesse : nel nostro caso per dire che gli uomini sono mortali non è necessario dire che sono animali e gli animali ono mortali : tutti sappiamo che gli uomini sono mortali anche senza effettuare questo ragionamento . Sappiamo per altre vie che l’uomo è mortale (per esempio per il fatto che tutti gli uomini esistiti sono morti) , però il sillogismo ci fa capire il legame logico tra le varie proposizioni : ci consente di acquisire il dioti e non solo l’oti ; sappiamo tutti che l’uomo è mortale , ma per capire il perchè occorre il sillogismo . Ciò che ci fa capire il perchè (ed in parte vi si identifica) è il termine medio : il puro e semplice oti (gli uomini sono mortali) non dimostra l’inutilità del sillogismo : è un pò come un sistema . In altre parole il sillogismo non ci fa capire la verità , ma i nessi tra le verità . Perchè gli uomini sono mortali ? La risposta è nel termine medio : perchè sono animali . La struttura del sillogismo è DEDUTTIVA : si parte da verità universali per dimostrare realtà particolari . Il termine deduzione deriva dal latino “deduco” (de+duco = tiro giù da una verità che sta più in alto una verità che sta più in basso) . Ma che origine hanno le premesse ? Possono avere due origini differenti : a) possono essere conclusioni : ogni premessa infatti può essere conclusione di altre premesse : è comunque un processo che non può andare avanti all’infinito . b) In molti casi le premesse generali derivano da processi induttivi (arrivo cioè da casi particolari a casi più generali) ; la conoscenza è un pò come un circolo , ma non vizioso : da casi generali si passa a casi più specifici e viceversa ; sarebbe un circolo vizioso se per arrivare a verità generali si dovessero analizzare tutti i casi : ad esempio se per dimostrare che “tutti gli animali sono mortali” dovessi esaminare uno ad uno tutti gli animali esistenti (ed esistiti) sono mortali : ma non è così ! Aristotele ritiene che mediante processi astrattivi , con un certo numeri di esempi si possa cogliere un’essenza generale comune a tutti gli elementi di una specie : come per Platone , anche per Aristotele esistono realtà universali che vengono compartecipate da tanti individui : per lui però sono forme e non idee: la forma uomo è in tutti gli uomini : se l’essenza uomo è caratterizzata dalla mortalità posso arrivare a tirar fuori da un pò di casi che tutti gli uomini sono mortali . Per capire questo non ho bisogno di andare a vedere che tutti gli uomini esistiti sono morti : da singoli casi con l’astrazione e cogliendo le caratteristiche (sfruttando solo quelle comuni) posso arrivare a dire che tutti gli uomini sono mortali : questo anche se analizzo solo tre uomini : tutti e tre han la forma uomo : se son morti quei tre tutti quanti gli uomini sono mortali : passo dal particolare all’universale . Anche Socrate , per dire , anche se adesso è ancora vivo , è un mortale perchè tutti gli uomini lo sono : dimostro con l’induzione . Quindi abbiamo detto che non è un circolo vizioso perchè non vado ad esaminare tutti gli uomini del mondo , ma solo alcuni : arrivo a dire che è mortale Socrate che non era nel gruppo di coloro che ho analizzato : però arrivo a dire che anche lui è mortale . Per Aristotele esistono gli UNIVERSALI , che a differenza di quanto era per Platone sono calati nella materia : se in un tale colgo l’essenza universale dell’uomo , questo processo vale per qualsiasi uomo . L’intelletto per Aristotele ha funzione DIMOSTRATIVA : consente , partendo da determinati principi , di arrrivare a conseguenze . Ma abbiamo detto che il sillogismo può essere di vari tipi : quello scientifico è quello che parte da premesse vere per arrivare a conclusioni vere . Aristotele fa notare che mentre se una premessa le conclusioni sono vere , se invece le premesse sono false non sempre le conclusioni sono false . Ad esempio , posso arrivae a dire che le rane sono verdi dicendo che sono vegetali . Tutte le rane sono vegetali , tutti i vegetali sono verdi , di conseguenza tutte le rane sono verdi . Si può in qualche misura argomentare in modo contrario : quando le conclusioni son false , allora anche le premesse sono false (argomentazione per assurdo) , ma se mi trovo di fronte a conclusioni vere non sempre le premesse sono vere . Il sillogismo scientifico presuppone che oltre al dimostrare correttamente , ci sia l’intelletto , il saper cogliere principi : c’è la dimostrazione come argomentazione , l’intelletto per cogliere principi : la scienza raccoglie ambedue . Il numero di casi per l’induzione non è sempre lo stesso : per i casi empirici ne occorrono un pò : Aristotele crede di poter stabilire una realazione tra il fatto che un animale sia longevo e il fatto che sia dotato di cistifellea : cita così diverse specie animali e la durata della loro vita . Ma in alcuni frangenti basta un caso solo : è il caso della geometria . Con l’induzione si arriva a tante cose : per Aristotele attraverso l’intelletto si arriva a principi comuni validi per tutte le scienze , e ad altri validi solo per alcune scienze : i principi della geometria per esempio riguardano solo le qualità spaziali . Facciamo un piccolo riassunto : il sillogismo è lo strumento principale della scienza : la scienza è quindi dimostrazione . Ma si può dimostrare tutto ? Nasce qui il problema dell’assunzione delle premesse ; certamente molte premesse di determinati sillogismi (come abbiamo già detto) sono a loro volta conclusioni di altri sillogismi , ma se si vuole evitare di andare all’infinito alla ricerca di premesse , che debbono costituire il saldo punto di partenza della scienza ,occorre rintracciare un tipo di premesse la cui verità non richieda necessariamente una dimostrazione . Occorre quindi uno strumento , diverso dalla dimostrazione , in grado di coglierle nella loro verità . A questa funzione presiede l’intelletto . Esso è dunque una disposizione non innata , ma acquisibile con l’esercizio , a cogliere l’universale per via non dimostrativa . Esso coglie i primi principi indimostrabili che stanno alla base di ogni scienza per via induttiva . Ecco quindi la distinzione di cui parlavamo tra principi propri di ogni singola scienza (quali per la geometria la definizione degli enti e delle figure geometriche , per l’aritmetica la definizione dei numeri in pari , dispari …) e i principi comuni a tutte le scienze (per esempio “il tutto è maggiore della parte” o “Se da uguali sono sottratti uguali , i resti sono uguali):essi hanno una caratteristica non devono essere dimostrati . Ciascuna scienza li usa in relazione agli oggetti specifici di sua competenza : per esempio la geometria in relazione alle grandezze geometriche , l’aritmetica in relazion ai numeri , e così via . Aristotele trova tre principi fondamentali da cui nessuna scienza può prescindere : 1) IDENTITA’ 2) CONTRADDIZIONE 3) TERZO ESCLUSO . 1) A è A e non può essere non-A 2)Aristotele dà 2 formulazioni a questo principio a)è impossibile che la stessa cosa sia e non sia al tempo stesso (sembra uguale a quello di identità , ma non lo è) b) è impossibile che una stessa cosa appartenga e non appartenga nello stesso tempo alla stessa cosa . c)A o è B o non è B : non c’è una terza possibilità : delle due proposizioni contradditorie una deve essere per forza vera . Questi sono i principi generaliossimi della logica : aristotele fa notare che non sono dimostrabili (come abbiamo detto anche noi) ; a rigore non si possono neppure cogliere bene per via induttiva . Aristotele argomenta in loro favore con la CONFUTAZIONE : non dimostra la verità , ma fa notare che sarebbe impossibile ragionare senza di loro ; non solo , è anche impossibile argomentare contro questi tre principi . E’ un caso di dimostrazione indiretta (quasi per assurdo) . Aristotele è il primo autore che ammetta una autonomia reciproca delle scienze : per Platone esisteva una sola scienza : chi sapeva i principi , sapeva tutto . Con Aristotele incomincia quel processo per cui le varie scienze hanno acquisito autonomia dal sapere centrale e dalla filosofia . In Aristotele la filosofia è la filosofia , ma poi c’è l’albero della scienza , dove c’è un tronco centrale ma anche tante ramificazioni . Aristotele riconosce sì una certa autonomia alle varie scienze , ma come i rami di un albero sono in stretto contatto con il tronco centrale , così le varie scienze sono imparentate con un tronco centrale : la filosofia e la logica : da notare che i principi della logica sono in buona parte gli stessi della filosofia . Prendiamo per esempio le tesi di Parmenide ed in particolare il principio della contraddizione : in termini logici si dice che non c’è contraddizione , ma sul piano filosofico-ontologico si dice che è impossibile che lo stesso soggetto abbia caratteristiche contradditorie : per noi come per Aristotele le leggi del pensiero e della realtà sono le stesse . Aristotele fa vedere cose della realtà anche nell’ambito della logica , in forma logica . A quei tempi tutto era diverso : pensiamo ai Pitagorici che si stupivano che ciò che scopriva la matematica corrispondeva alla realtà : il teorema di Pitagora vale su un triangolo astratto (sull’idea di triangolo, secondo Platone ) e poi su quelli reali . In Aristotele la parola DIALETTICA ha significato diverso rispetto a Platone : per Platone era un sinonimo di filosofia , per Aristotele significa “ragionamento che implica una dimostrazione con gli altri” . Posso sì dedurre ed indurre da solo , ma la dialettica implica un rapporto con gli altri : è quel ragionamento che parte non da ciò che è vero perchè colto col sillogismo ed il ragionamento scientifico , ma da punti di partenza (premesse) prese per buone nel contesto in cui si parla : Aristotele dice “le premesse usate dai più o dagli esperti o dalla maggioranza degli esperti ” : non è una verità assoluta , ma un modo per cominciare la discussione di una tematica . E’ interessante notare che Aristotele abbia inventato il sillogismo ma che l’abbia usato davvero poco : usa di più gli argomenti dialettici : prende dei punti condivisi da molti e li discute : quando si cimenta nella ricerca delle quattro cause , parte dai punti di vista dei presocratici (coloro che vissero prima di Socrate ) .Agli occhi di Aristotele la conoscenza è una sorta di processo collettivo nel quale si trovano coinvolti gli uomini del passato e del presente . Quindi partiva dalle premesse dei suoi predecessori e ci ragionava sopra discutendo se potevano essere accettate o no . Aristotele crede di partire dai PHAINOMENA (“fenomeni” , ciò che appare all’esperienza) : questo conferma il fatto che Aristotele sia un empirista : per lui la mente è una “tabula rasa” da riempire con le esperienze . Comunque fanno parte dei “phainomena” non solo le esperienze , ma anche le opinioni altrui : Aristotele anche quando studia gli organismi riproduttivi , non si serve solo delle esperienze personali , ma anche dei pareri degli antichi . Lo studia comincia ad essere mescolanza di esperienze personali e ragionamenti con il libro : è proprio con Aristotele che il libro diventa strumento di sapere : ci fornisce quel materiale di elaborazione degli altri , ciò che è stato scritto . Ma se per conoscere si usano queste tecniche , il sillogismo che valore ha ? Il meccanismo per scoprire la verità è la dialettica , quello per stabilire i nessi delle realtà è il sillogismo , che ci fornisce il dioti . A livello teorico abbiamo distinto fisica da metafisica : sia il sillogismo sia la dialettica rientrano nella metafisica , la pretesa di cogliere ciò che sta al di là delle cose fisiche . L’essenza c’è anche nella fisica . La fisica studia gli oggetti che esistono di per sè ma sono mutevoli (è l’opposto della matematica) ; la metafisica studia tutto l’essere in quanto essere ma anche l’essere che esiste ed è immutabile (la divinità) ; in pratica studiamo la metafisica come ontologia : se è studio dell’essere in quanto essere si occupa anche di oggetti fisici . Ma che cos’è l’essere ? L’essere può essere ricondotto alla sostanza . Dire “che cosa è l’essere?” si può ricondurre a “che cosa è la sostanza?” . Per rispondere Aristotele si pone un problema : ” essere” ha significato univoco o biunivoco ? (in realtà “biunivoco” e “univoco” sono termini medioevali) Aristotele risponde che non è nè univoco nè biunivoco , ha significati analogici ; a questo punto Aristotele fa un esempio servendosi dell’aggettivo greco “salutare” : è salutare tutto ciò che ha a che fare con la salute , il clima , una persona , un cibo … Il ragionamento che ne consegue è che se ci chiediamo se è univoco o biunivoco il significato dell’essere , dobbiamo rispondere che non è nè l’uno nè l’altro : non può avere sempre lo stesso significato , ma comunque i vari significati sono tra loro imparentati perchè si riferiscono tutti ad un unico concetto , la salute . L’essere è analogico : tutti i significati di essre si appoggiano alla “sostanza” , il significato più importante . Aristotele fa poi un discorso a cavallo tra realtà e logica : le cose possono avere una miriade di caratteristiche ; è vero che posso predicare in maniera sterminata , ma le tipologie si possono ridurre a poche possibilità , le CATEGORIE (in totale 8 o 10 : in realtà erano 8 , ma il 10 suonava meglio …):in Greco categoria significa “predicato” : le categorie sono quindi 8 tipi di predicazioni che si possono fare : prendiamo ad esempio Socrate : 1) SOSTANZA ? Socrate 2)QUANTITA’? Un metro e mezzo 3) QUALITA’ ? Bianco o filosofo 4) RELAZIONE ? Figlio di Sofronisco 5)LUOGO ? In carcere 6) TEMPO ? L’anno della morte 7) SITUAZIONE ? Star seduto 8) AVERE ? Un mantello (Aristotele ne aggiunge poi due giusto per far cifra tonda e arrivare a 10 : 9)AGIRE? Bagnare 10)SUBIRE? L’essere bagnato). Tra le categorie la più importante è appunto la sostanza : tutte la altre infatti devono per forza essere predicate di qualcosa , ossia appunto di una sostanza . Per esempio “bianco” o “un metro e mezzo” possono essere predicati alla sostanza “Socrate” .Il loro essere è sempre in riferimento ad una sostanza , e dipende da essa . Ma la stessa cosa non vale necessariamente per tutte le sostanze . A questo proposito Aristotele distingue nello scritto “Sulle categorie ” tra sostanze prime e sostanze seconde . La sostanza prima , per esempio “questo uomo qui” (l’individuo Socrate) non può mai essere predicata di un’altra sostanza nè esistere in un’altra sostanza . Le sostanze seconde invece , ossia le specie (per esempio , uomo) e i generi ( per esempio , animale), possono essere predicate delle sostanze prime . Per esempio è possibile dire “Socrate è uomo” . Secondo Aristotele , Platone aveva commesso l’errore di attribuire esistenza autonoma ai predicati , ossia alle sostanze seconde che in realtà esistono soltanto in riferimento a sostanze individuali .Ma viene spontaneo chiedersi quale sia la differenza tra universale e sostanza : Aristotele stesso si pone questa domanda e cerca di dare una risposta ne “La metafisica” ; egli dice che la sostanza di una cosa è quella che è caratteristica di quella cosa , che non inerisce ad un’altra cosa . L’universale invece è comune , perchè infatti si dice universale ciò che per natura inerisce a più cose . Quindi di che cosa sarà sostanza l’universale ? Infatti l’universale o sarà la sostanza di tutte le cose alle quali inerisce , o non sarà la sostanza di nessuna . Ma non può essere la sostanza di tutte ; se sarà la sostanza di una sola cosa , allora anche tutte le altre cose saranno quest’unica cosa , poichè le cose che hanno un’unica sostanza ed un’unica essenza sostanziale sono esse stesse un’unica cosa : è un ragionamento per assurdo , si assume cioè come premessa che l’universale sia sostanza . Inoltre si dice sostanza ciò che non può essere predicato di un soggetto (nel caso delle sostanze prime) , mentre l’universale si predica sempre di un soggetto . Aristotele arriva alla conclusione che gli universali (che Platone chiamava idee) non possano esistere separatamente dalle sostanze : “uomo” non esiste come entità separata dalle sostanze singole , “Socrate” , “Platone” , “Gorgia” … Ci sono 8 modi per dire l’essere ma non equivoci : tutti si riconnettono all’essere come sostanza : perchè? Non esistono le qualità al di fuori delle quantità : pensiamo al quadrato : di per sè non esiste , esiste solo come processo di astrazione di un libro per esempio . Il libro è blu : il blu esiste sempre nella misura in cui inerisce alla quantità (il libro) : il libro esiste di per sè sempre . Le categorie risultano dunque 7 + 1 (la sostanza) . Ci sono poi le cose che esistono come qualità delle sostanze (il blu , il quadrato …)Il significato principale dell’essere è la sostanza : ma più precisamente la sostanza individuale ; emerge qui un’altra grande differenza tra Platone e Aristotele : per Platone esistevano più gli universali (le idee) che gli individuali : l’idea di cavallo esisteva più del cavallo stesso : le idee si calavano nel mondo sensibile . Per Aristotele invece esistevano di più gli enti empirici rispetto a quelli astratti : ciò che una cosa è sta nella cosa stessa e non al di fuori di essa ; è una visione IMMANENTE , mentre quella platonica è trascendente . Ciò che propriamente esiste sono gli enti singoli : il significato principale dell’essere è la sostanza , ciò che è effettivamente . La sostanza è ciò a cui le qualità ineriscono . Il quaderno però (esempio di sostanza ) può essere due cose diverse : 1) può essere il quaderno che ho in mano “hic et nunc” (qui e adesso , in Greco “tòde ti”) 2)può anche essere la categoria generale dei quaderni : di fronte ad una persona posso dire “Caio” (per esempio), che è il nome proprio della persona o “uomo” che è la categoria alla quale appartiene : in entrambe i casi indico la sostanza con entrambe i nomi : quand’è che si indica la sostanza prima di cui abbiamo già parlato ? Quando si cita ciò che è “hic et nunc” : quando dico che la sostanza è il significato dell’essere , devo dire che il significato primo dell’essere è la sostanza prima . Come si può distinguere sostanza prima da sostanza seconda ? La sostanza prima è sempre e solo soggetto : se dico “il libro è blu” è sostanza prima perchè soggetto ; se però dico “quest’oggetto è un libro” è sostanza seconda perchè “libro” è predicato . Se dico “Socrate è uomo” non può fungere che da soggetto e da sostanza prima : anche se dico “questo qui è Socrate” in fondo è soggetto . Le sostanze seconde possono essere SPECIE e GENERI : Socrate è sostanza prima , “uomo” è la specie , “animale” è il genere : ci sono più livelli di generità . Un buon modo per distinguere specie da genere è che se ho una specie non la si può suddividere ulteriormente se non in casi singoli : da uomo posso solo passare a Socrate , Platone … Il genere (animale) invece è ulteriormente divisibile . Questo ci aiuta a capire che cosa significa per Aristotele definire : non posso definire Socrate , ma l’uomo : definire è indicare la specie , la divisione ultima . Platone si serviva invece della diairesis . Aristotele punta su genere-specie : si individua il genere prossimo , cioè il genere immediatamente successivo , più generale dopo la specie : nel genere animale devo indicare la caratteristica che separa quel genere dagli altri : nel caso del genere animale bisogna dire per indicare l’uomo “animale razionale” . Si troova la differenza che contraddistingue l’elemento dal resto della specie . Le sostanze dunque sono in senso primario e non in funzione di qualcos’altro . Se dico “Socrate è magro” , l’esser magro di Socrate è un caso individuale della qualità generale dell’essere magro . Ma questa qualità generale , la magrezza , non è una sostanza . Infatti mentre la sostanza (ad esempio Socrate) può esistere senza la qualità di magrezza , la magrezza non può esistere senza la sostanza a cui è riferita . In questo caso la nozione di sostanza si distingue da quella di ACCIDENTE : una sostanza ha molte proprietà accidentali , vale a dire proprietà che essa può avere o non avere , senza che l’averle o il non averle comprometta il suo essere quella sostanza determinata . Queste considerazioni portano Aristotele lontano dalla dottrina delle idee platonica . Per Platone ci sono cose bianche perchè c’è l’idea di bianchezza che viene compartecipata ; per Aristotele la bianchezza è perchè ci sono cose bianche , ossia sostanze dotate della qualità di bianchezza . Così il numero 3 esiste perchè esistono gruppi di tre cose . L’universale (il tre , la bianchezza , l’uomo…) , che è oggetto della scienza , non ha esistenza separata dalle cose sensibili , come aveva preteso Platone , ma esiste nelle sostanze individuali . Ritorniamo allo studio dell’accidente : ogni specie ha determinate caratteristiche che appartengono agli individui della specie sempre o “epì tò polù” (per lo più) ; i cani hanno sempre o per lo più quattro gambe . La sostanza di ogni specie indica ciò che hanno sempre o quasi sempre (epì tò polù) : ma Aristotele non si interessa delle singole differenze . L’uomo ha sempre o per lo più due occhi perchè fa parte della sua natura : ma non fa parte della sua natura che siano blu , verdi … Ecco allora che ci troviamo di fronte agli accidenti , quelle cose che non sono nè sempre nè epì tò polù : possono esserci . I concetti fondamentali della fisica sono legati al mutamento e al movimento : infatti gli enti fisici sono quelli che esistono di per sè , ma che sono mutevoli . Il termine greco che designa il movimento è “kìnesis” : in realtà sarebbe più appropriato tradurlo con ” mutamento-movimento” : certi mutamenti vanno infatti ricondotti al movimento : prendiamo ad esempio il crescere di un animale , forma di mutamento : le sue particelle si muovono e fanno sì che lui cambi . Il mutamento però può avvenire solo sotto 4 categorie : 1) luogo : è il più banale ; la penna era qui , ora è lì : si è spostata . 2) quantità : un essere che cresce muta di quantità 3)qualità : abbronzandosi , per esempio , si muta di colore e quindi di qualità . 4)sostanza : è il mutamento più radicale : quando un animale nasce passa dal non essere all’essere e viceversa quando muore passa dall’essere al non essere . Il movimento inerisce alle cose fisiche : ma non necessariamente dove c’è movimento c’è corruzione : il mutamento avviene non per forza sotto tutte e 4 le categorie : è solo con il mutamento di sostanza che c’è corruzione . Gli astri , per esempio , mutano solo di luogo e non di sostanza : per questo per Aristotele sono eterni . Per lui ci sono propriamente tre enti : a) SUBLUNARE : è il nostro mondo , che sta al di sotto della luna ;esso muta sotto tutte e 4 le cause e per questo è corruttibile . b)CELESTI : gli enti celesti per Aristotele sono eterni : mutano solo di luogo . Gli enti celesti sono quegli enti che vanno dalla luna in sù . c) DIO : non muta affatto , in nessuna delle 4 categorie . Aristotele rifiuta la seconda navigazione platonica e orienta le sue indagini interamente sul mondo sensibile . Ma come funziona il mutamento ? Una prima spiegazione la troviamo nel binomio forma-materia : mentre Platone parlava di idee , Aristotele parla invece di forma : è come se Aristotele immanentizzasse le idee nella realtà . E’ interessante notare che Platone le idee le chiamava o “eidos” o “idea” (tutti e due i termini derivano da “orao” , vedere : le idee erano quelle cose che si vedevano non con gli occhi , ma con l’intelletto ) ; Aristotele dal canto suo traduce “forma” con due parole : “morfè” o “eidos” : si è sempre cercato di evitare di mettere in gioco la stessa parola nei due autori e così per Platone parliamo di idee e con Aristotele di forma : ma in realtà tutti e due usano la stessa parola (eidos) : infatti l’idea di idea c’era anche in Aristotele , ma lui la calava totalmente nella realtà . Aristotele è arrivato a dire che la sostanza è il significato principale dell’essere : ma la sostanza come è fatta ? I predecessori avevano individuato due cose tra loro distinte : a)i Presocratici avevano individuato la materia : ciò di cui una cosa è fatta . b) Platone aveva individuato la forma che una cosa ha : Platone diceva che ciò che faceva un cavallo non era la materia ma la forma . Aristotele non accetta nè la A nè la B : l’idea di cavallo da sola non esiste , ma neppure la pura e semplice materia da sola . Per essere una sostanza deve essere una sostanza specifica ed in più deve essere caratterizzata da una struttura specifica che mi consenta di dire “questo è un cavallo” . Un quaderno è un quaderno perchè c’è della materia ed in più c’è la forma , la struttura che me lo fa individuare come quaderno . Si tratta di un vero BINOMIO materia-forma (Aristotele lo chiama “sinolo” da sun + olos = un tutt’uno di materia e forma) ; ogni sostanza fisica è un binomio di materia e forma : non è un semplice aggregato : per Platone un uomo era fatto di anima e corpo : l’anima era una realtà a parte , tant’è che il corpo per lei era una prigione . Per Platone erano due materie separate . Per Aristotele è totalmente differente la questione : l’uomo è un sinolo , un binomio di anima e corpo . Non si può dividere la materia dalla forma : è una realtà inscindibile; senza il binomio non può esistere la sostanza ; questo implica la mortalità dell’uomo : l’uomo è un sinolo di materia e forma : quando si scioglie una componente (il corpo) si rompe tutto . La forma è quel carattere comune a tutti gli enti di una determinata specie : la forma uomo è presente in tutti gli uomini . Prendiamo un gatto : cosa è che rende quel gatto diverso dagli altri gatti ? E’ la materia , che fa sì che lui sia , esista ; la forma fa sì che lui sia un gatto e non un cane . La materia individua la forma : la forma gatto non esiste da nessuna parte : essa è solo in tutti i gatti esistenti , ma di per sè non esiste . Quando il gatto muore la forma e la materia si disperdono : in realtà la forma non sparisce perchè è in tutti gli altri gatti (anche in quelli che l’han procreato) . Aristotele è un FISSISTA : le specie , secondo lui , sono sempre esistite e sempre esisteranno . In ogni trasformazione c’è sempre qualcosa che cambia , che si trasforma : è la materia (o SOSTRATO , dal latino “substratum” = ciò che giace sotto ; dal greco “upokeimenon”).Facciamo un esempio : una persona va al sole e diventa scura : c’è un sostrato che muta , pur restando in fondo lo stesso : in questo caso il sostrato è la persona stessa : è ciò che permane nella trasformazione . Si passa dalla privazione di una forma all’acquisizione di una forma . Facciamo un esempio : nella procreazione Aristotele (come Platone ) era convinto che la madre fornisse la materia ed il padre la forma : la materia passa dal non possedere la forma del padre ad avere la forma del padre . Dunque abbiamo in gioco : a)il sostrato (o materia) b) la privazione di forma c) l’acquisizione di forma . Il concetto di materia è puramente relativo : ogni processo non riguarda mai la materia pura : uno che si abbronza , passa dalla privazione di colorito all’acquisizione di colorito : la persona funge da sostrato , ciò che perdura nel mutamento . La materia della persona che si abbronza passa dalla mancanza di una forma all’acquisizione di una forma (l’abbronzatura) : la persona è già strutturata , è un sinolo di forma e materia . Aristotele parla allora di materia prima (“prote ule”) , della materia priva di forma , senza il sinolo : è un concetto solo teoretico : in realtà in ogni ente c’è sempre il binomio . Ogni processo parte da qualcosa che funge da materia pura priva di forma per arrivare ad acquisire la forma : però in realtà la materia che deve acquisire la forma , è già un sinolo di materia e forma . Nel nostro caso la persona che si abbronza funge da sostrato : deve acquisire la forma abbronzatura : funge quindi da materia pura , ma in realtà è già un sinolo di forma e materia . Ha già cioè subito un processo di formazione dal padre e dalla madre . E’ quindi passato da privazione abbronzatura ad acquisizione abbronzatura : ma qualcuno potrebbe dire (giustamente) “è passato da acquisizione pallore a privazione pallore” . Noi infatti abbiamo una concezione meccanicistica : le cose che avvengono in natura non sono nè buone nè cattive : Aristotele è un finalista e per lui la natura non fa nulla invano : tutto ciò che fa ha uno scopo (positivo) . Aristotele ha dunque una concezione finalistica (o teleologica) della natura : ogni ente la forma la porta dentro di sè e tende a realizzarla il più possibile . Per Aristotele le cose negative non hanno forma (come per Platone non c’era l’idea di cose negative , come il fango o il capello) . Per noi il processo con cui si nasce è analogo a quello con cui si muore : in entrambe i casi da una forma si passa ad un’altra . Per Platone la morte è un processo degenerativo . Aristotele analizza il movimento vedendolo come il passaggio di un sostrato da privazione di una forma ad acquisizione di quella forma . Comunque questi tre aspetti si possono ricondurre a due : infatti sia privazione sia acquisizione sono riferiti alla forma : sono privazione e acquisizione di forma . Il cambiamento lo si può anche vedere sotto la celebre dottrina delle 4 cause : 1)materiale : indica ciò di cui una cosa è fatta (nel caso di una statua , per esempio , il bronzo) 2)efficiente (o motrice) : indica ciò che mette in moto la cosa , ciò che fa avvenire il processo (nel caso di una statua , lo scultore) . 3) Formale : indica la forma che acquisirà (forma di statua) . 4)Finale : indica lo scopo per cui è fatta (nel caso della statua , per venerare la divinità ). Aristotele utilizza le 4 cause per gli enti naturali , ma si serve di esempi del mondo artificiale-umano perchè così può rendere più visibili cose che nel mondo naturale sono meno visibili . In effetti che in natura ci sia il finalismo è difficile dimostrarlo : invece , un architetto che fa una casa la fa per mettere al riparo delle persone . Nella natura il finalismo è immanente . In Platone il fine stava al di fuori delle cose stesse (consisteva nell’imitare le idee nel miglior modo possibile) . In Aristotele l’essenza delle cose è nelle cose stesse e l’essenza è un qualcosa di dinamico : non è solo ciò che un cavallo è , ma anche ciò che mira ad essere (un cavallo mira ad essere un buon cavallo). Per Aristotele il mondo fisico non va svalutato come era per Platone : è proprio nel mondo fisico che si trova l’essenza delle cose . Aristotele sa bene che anche il mondo naturale è finalistico , che un fiore ha il suo scopo , ma sa anche che è meno evidente rispetto al caso della casa . Anche Aristotele , un pò come Talete con il magnete , prende esempi significativi per poi estenderli all’intera realtà . Nel mondo artificiale , poi , le cause sono caratterizzate dal fatto di essere totalmente separate e distinte le une dalle altre;prendiamo il caso della casa : c’è il materiale (i mattoni , il cemento… emerge come la materia sia un concetto relativo : il mattone è già un sinolo di materia e forma , ma funge da materia prima ), l’architetto (che è la causa efficiente : mette in moto la materia) , la forma (che l’architetto ha in mente) e lo scopo (far vivere delle persone all’interno) . Le opere biologiche di Aristotele sono molto importanti perchè da lì ha derivato le sue ideologie : per esempio , i fenomeni riproduttivi animali : la madre fornisce la materia , il padre la forma (la madre fornisce la materia priva di forma,quindi è causa materiale : tutte le altre cause sono nel padre : egli possiede già la forma da dare ed è quindi causa formale , è causa efficiente perchè mette in moto il processo fecondando , ed è pure causa finale : lo scopo dell’uomo è essere uomo ) . L’essenza è quindi , come abbiamo detto , ciò che una cosa è , ma anche ciò che mira ad essere ; in fin dei conti le cause sono riconducibili a due principi : la forma e la materia . Per Aristotele gli enti naturali hanno dentro di sè il principio del movimento : nel caso delle produzioni tecniche è esterno . Un altro modo con cui Aristotele spiega il movimento è quello della POTENZA e dell’ATTO : questa coppia è un altro modo per ammazzare Parmenide : già Platone aveva commesso il parricidio di Parmenide introducendo l’essere diversamente . Aristotele lavora però nel campo del cambiamento : dall’essere una cosa al non essere più quella cosa e viceversa . Introduce quindi la coppia potenza-atto . Aristotele fa notare che quando qualcosa cambia non passa solo da privazione ad acquisizione , ma subisce anche un altro processo : in partenza era potenzialmente quello che poi è diventato effettivamente . La pianta è trasformazione del seme : il sostrato da privazione di forma albero passa ad acquisizione di forma albero : ma si può anche dire che il seme è un albero in potenza : può diventare albero , come può non diventarlo . Il seme può quindi diventare albero : da albero potenziale diventa albero attuale . Aristotele afferma che questa coppia spiega anche una cosa che nella forma di cambiamento sostrato,privazione,acquisizione non era spiegata : non sempre il seme diventa albero . Certo un seme di quercia ha più possibilità di diventare albero rispetto ad un chicco di grano : il primo è un albero in potenza , il secondo no . Ci sono quindi varie canalizzazioni : prima si deve appurare che sia un albero in potenza (il chicco di grano non può esserlo) , poi occorre che ci siano le condizioni favorevoli perchè diventi albero attuale . Un uovo di struzzo sarà per forza struzzo in potenza e non potrà mai diventare gallina . Aristotele insiste particolarmente sul fatto che ogni cosa per passare da potenza ad atto ha bisogno di qualcosa che sia già in atto : l’uovo di struzzo , per esempio , per diventare struzzo attuale ha bisogno di essere fecondato da uno struzzo già struzzo , uno struzzo attuale . Se non intervengono i fattori necessari alla realizzazione del processo , esso non avviene . Il processo di canalizzazione è molto meno forte nel mondo artificiale rispetto al mondo naturale (a differenza del finalismo) : se ad esempio prendiamo un pezzo di legno , a differenza di uno struzzo , può diventare non tutto , ma più cose : un tavolo , una sedia , un mobile … E’ interessante ricordare che Aristotele ha dato una sua risposta al quesito “è nato prima l’uovo o la gallina ? ” : lui rispose che nacque prima il gallo ; questa domanda era problematica pure per lui (ricordiamo che era un fissista) ; questa domanda può anche essere interpretata come “è nato prima l’atto (la gallina) o la potenza (l’uovo) ?” . Aristotele a questo punto fa notare che l’atto sta prima della potenza ontologicamente e concettualmente : non possiamo definire fino in fondo un uovo se non specifichiamo di che cosa è (di gallina , di struzzo…) : se invece diciamo gallina tutti capiamo senza problemi . L’uovo non è quindi definibile perfettamente se non faccio riferimento all’atto , se non dico che è una gallina in potenza (per definirlo ho quindi bisogno di conoscere l’atto) . La potenza ha come fine l’atto , ma l’atto non ha come fine la potenza . Un bambino è un uomo in potenza : questa teoria però ha creato problemi ed esagerazioni sul piano pedagogico (soprattutto nella pedagogia gesuita) : si è negata l’autonomia delle varie età basandosi sul fatto che il fine è essere uomo . Anche nella storia si fa spesso così : si valuta ciò che viene prima in funzione di ciò che viene dopo : così è anche per i Presocratici , che sono stati appellati in questo modo in funzione della venuta di Socrate , negando loro autonomia . Sul piano ontologico abbiamo visto che , ad esempio , l’uovo per diventare gallina deve essere fecondato da un gallo già in atto . Addentriamoci ora nella cosmologia aristotelica : di che cosa è fatto il mondo ? In ultima istanza sarà fatto di forma e materia , come tutto il resto : ma sono concetti puramente teoretici e relativi : non esiste mai (o quasi) materia senza forma o forma senza materia . Aristotele riprende Empedocle ed individua 4 sinoli elementari : acqua , terra , cielo , fuoco . Ciascuno di questi sinoli è caratterizzato dal possedere due delle quattro qualità base : secco e umido , caldo e freddo . La terra per esempio è fredda e secca , il fuoco è caldo e secco e così via . Ma dove sarebbero questi sinoli elementari ? Prendiamo un qualsiasi elemento di questo mondo : ad esempio un uomo : la materia sono i suoi organi , la forma è il modo in cui sono stati strutturati ; prendiamo ora il suo cuore : anch’esso è un sinolo di materia e forma : la materia è il tessuto , la forma è quella del cuore . Ora prendiamo il tessuto : anche lui è sinolo di materia e forma : la materia sono i quattro elementi , la forma è la proporzione in cui sono stati mescolati . Prendiamo ora l’acqua (uno dei 4 elementi) : quale è la materia e quale è la forma ? Qui la separazione può essere solo concettuale : si può dire che essa è fatta di materia prima (prote ule) : abbiamo già detto che però in realtà il sinolo materia forma è inscindibile . Oltre alla materia prima troviamo anche due coppie di realtà : il caldo e il freddo ; il secco e l’umido : combinando queste 4 coppie si potrebbero teoricamente ottenere 6 cose , ma in realtà se combino il caldo con il freddo e il secco con l’umido non mi ricavo niente : così sono solo 4 le coppie combinabili . Ogni accoppiamento caratterizza ciascuno dei 4 elementi : abbiamo già detto che la terra è caratterizzata dall’essere fredda e secca . I 4 elementi sono la base dalla cui aggregazione e disgregazione deriva tutto il resto : sembra uguale ad Empedocle , ma in realtà non è così : per Aristotele , infatti , non sono le parti ultime della realtà (che invece sono le coppie caldo-freddo e secco-umido) : di conseguenza gli elementi possono trasformarsi gli uni negli altri , ad esempio tramite processi di evaporazione o di congelamento : mediante questi processi si possono spiegare , tra l’altro , i fenomeni metereologici . Ogni elemento può trasformarsi immediatamente in quello con cui ha una caratteristica in comune acquisendo l’altra . Per esempio la terra ha in comune con il fuoco il fatto di essere secca , però lei è fredda mentre il fuoco è calda : acquisendo il calore diventa fuoco . Gli elementi hanno poi un’altra caratteristica : il peso . Due elementi sono leggeri (fuoco,aria) , due pesanti (acqua,terra) . Il PESO per Aristotele è la tendenza ad andare verso il centro della terra (che per lui è pure centro dell’universo) : il basso in generale è il centro della terra . Noi pensiamo che il centro della luna sia sulla luna , Aristotele invece pensa che sia sulla terra . Per lui alto e basso hanno valore assoluto : il basso è il centro della terra . Tutti i corpi tendono o a scendere o a salire : sono i movimenti naturali . Ogni elemento si muove per propria natura in una direzione determinata dal suo peso : ciascuno di essi ha dunque un proprio LUOGO NATURALE , al quale tende . Quindi il luogo naturale di ogni elemento corrisponde al suo peso : in ordine di peso stanno così : 1)terra 2)acqua 3)aria 4)fuoco . Da notare che il finalismo vale perfino per le realtà più elementari : se il fine del cavallo è essere cavallo , quale è il fine della terra (uno a caso dei 4 elementi) ? Il suo fine è comportarsi come le compete , stare cioè verso Terra . Il finalismo dei 4 elementi è tendere ciascuno al proprio luogo naturale . Facciamo un esempio : prendiamo un libro ; esso è fatto di terra (di materia , insomma) : se lo mettiamo per terra non si muove perchè è nel suo luogo naturale . Se lo alziamo e lo portiamo in aria e poi lo lasciamo , esso cade perchè l’aria non è il suo luogo naturale e tende quindi a ritornare alla sua collocazione . Lo stesso discorso vale per una bottiglia d’aria messa in acqua : essa tende a salire (dal momento che l’acqua non è il luogo naturale dell’aria) per raggiungere l’aria . Aristotele dice che ci sono due tipi di movimenti a) Quelli che riportano gli elementi ai loro luoghi naturali b) Quelli violenti o contro natura : posso lanciare una pietra in aria o mettere una bottiglia piena d’aria sott’acqua : la pietra ricade e la bottiglia risale . Se tiriamo una penna per aria , noi sappiamo che per un pò sale in quanto le diamo un impulso che la fa salire per un pò : per Aristotele non è così . Lui è convinto che ogni cosa che si muove è mossa da altre (da una causa efficiente) : non ammette che una cosa tenda a mantenere lo stato in cui viene posta (principio di inerzia) ; Questo vale sia per i moti naturali sia per quelli violenti . Aristotele dice che se lancio in aria una penna essa trascina movimenti circostanti e composti : viene qui messo in gioco l’ambiente : è l’ambiente che secondo Aristotele porta su per un pò la penna . Facciamo qualche osservazione : se Aristotele ammette quest’idea , vuol dire che nega l’esistenza del vuoto : non esiste neanche come vuoto relativo (come era per Democrito) : se ci fosse il vuoto salirebbe all’infinito . Il principio di inerzia mi dice che se conferisco movimento ad un corpo , esso tende a tenere quel moto all’infinito : questo significa che sia quiete sia moto sono stati : se un oggetto si muove quindi ciò che va spiegato è perchè si fermi : dovrebbe per il principio di inerzia proseguire in quel moto all’infinito . Bisogna quindi spiegare il mutamento di stato (da moto passa ad inerzia) . Per Aristotele invece non va spiegata la quiete ma il movimento , che è una forma di cambiamento : è un passaggio da potenza ad atto : la penna è qui ma potrebbe essere lì ; la sposto ed ecco che è lì . Il mutamento-movimento per Aristotele richiede una causa . Per noi va invece spiegata l’accelerazione , il cambiamento di velocità . Il lancio della penna mi spiega che acquista un movimento teoricamente infinito ; per Aristotele è normalissimo che la penna dopo un pò cada : essa tende al suo luogo naturale : quello che per lui va spiegato è perchè per un pò essa tenda a salire . Per Aristotele la quiete è uno stato , il movimento un mutamento (ed i mutamenti vanno spiegati) . Per noi sono entrambe stati . Abbiamo detto che si accusò Aristotele di essere poco attento alla realtà : qui abbiamo una prova per smentire quest’affermazione : infatti la realtà a riguardo della penna sembra proprio dare ragione a lui e non a noi . Guardiamo ora alla concezione cosmologica aristotelica : Aristotele sostiene il geocentrismo : la terra , in quanto corpo più pesante , occupa il centro dell’universo . Da notare che il mondo di Aristotele è un mondo finito : a partire dai Pitagorici era prevalsa l’idea che l’infinito fosse qualcosa di negativo (diversamente da come la pensava Anassimandro) . Il finito è quindi sinonimo di perfezione . Aristotele dice poi che c’è un centro : ci sono i luoghi naturali e alcuni corpi tendono al centro , altri alla periferia . Se ci sono un basso e un alto ci deve per forza essere anche un centro : se esistono gli elementi ed i luoghi naturali , allora il mondo è finito . Nell’infinito infatti non ci sono nè l’alto nè il basso . Ma attenzione , si può capovolgere il ragionamento : l’infinito esiste , quindi l’alto ed il basso non ci sono . Aristotele parte però dal presupposto che il basso e l’alto esistano . E’ un pò come per Melisso : le sue tesi vennero riprese dagli Atomisti per capovolgere le tesi eleatiche . In sostanza Aristotele nega l’esistenza di più universi : Democrito e Anassimandro invece la sostenevano . Se la tendenza è di andare al centro della terra non ci devono essere altri universi altrimenti collasserebbero tutti al centro della terra : Aristotele si serve della dimostrazione per assurdo : se esistesse un altro mondo esso sarebbe costituito dagli stessi elementi del nostro : ma in base alla dottrina dei luoghi naturali ciascun elemento tenderebbe ad esso e quindi la terra di questo secondo universo tenderebbe a congiungersi con la terra del nostro universo e così tutti gli altri elementi ; il carattere finito dell’universo è contrassegnato dalla sua perfezione . I 4 elementi spiegano il funzionamento del mondo sublunare , che per Aristotele è assai differente da quello celeste : il sublunare è caratterizzato dai 4 elementi , il cui destino è di nascita e di morte . Essendo una realtà fisica , per essere eterno dovrebbe avere un movimento eterno , che però non ha : il movimento del mondo è infatti rettilineo : l’eternità non può identificarsi con qualcosa di rettilineo . Così il destino degli enti fisici è di nascita e di morte . Una forma di eternità sul nostro mondo può essere reperita nelle specie , che sono eterne (Platone diceva che l’eros era un tentativo degli enti mortali di eternarsi) , o nei 4 elementi che si mutano tra loro . Queste cose godono di una eternità indiretta . Il mondo celeste (quello che va dalla luna in sù) è differente : a quei tempi si pensava che fosse immutabile perchè per intere generazioni si vedevano costellazioni immutate , sempre disposte nello stesso modo . Solo le comete si muovevano , ma Aristotele pensava che esse fossero un fenomeno metereologico del mondo sublunare . Quindi il mondo celeste per Aristotele è immutabile : abbiamo detto che il mutamento può essere secondo 4 qualità e Aristotele credeva che fossero gli altri pianeti a ruotare intorno alla terra e non viceversa (come invece aveva ipotizzato Platone ) : ma se si muovono devono per forza mutare e quindi non sono eterni , direbbe qualcuno . Aristotele però dice che il loro è un movimento circolare , che ritorna su se stesso . E’ un movimento che non comporta alcuna forma di corruzione : Platone aveva parlato del movimento circolare come immagine mobile dell’eternità : Aristotele riprende questa concezione . Aristotele dice che il mondo sublunare è costituito da un quinto elemento , l’ETERE , privo di peso e dotato di movimento circolare : di esso sono dotati i corpi celesti . Dicevamo che per Aristotele il vuoto non c’è : come non esiste nel mondo sublunare , così non esiste fuori dall’universo : per lui tutto è pieno . Ma fuori dell’universo cosa c’è ? La risposta di Aristotele è “niente” , che è diverso dal vuoto : finisce proprio l’universo . Se ci fosse il vuoto ci dovrebbe essere un luogo che lo contiene , un contenitore di vuoto : per Aristotele proprio non c’è niente ! L’universo non è in nesun luogo perchè : Aristotele definisce un luogo come la superficie contenuta da qualcosa : ma dato che nulla può contenere l’universo , esso non è in nessun luogo . Se non è in nessun luogo non è nel vuoto . Non è un nulla fisico , ma un nulla metafisico . La finitezza stessa della materia impedisce che ci sia uno spazio infinito . La fisica moderna ha fatto marcia indietro perchè tende a dire che l’universo non è nè finito nè infinito . Aristotele invece è convinto al cento per cento che sia finito e che non ci sia vuoto nè nel mondo sublunare nè nell’intero universo . L’infinito abbiamo visto che esiste solo potenzialmente nei numeri : essi non sono nè finiti nè infiniti . Ma come funziona il cosmo aristotelico ? Il mondo sublunare è costituito da 4 sfere ; poi ci sono la luna e gli astri . L’universo nel suo insieme è una grande sfera . Dalla luna fino al confine estremo tutto è fatto di etere . L’equilibrio dell’universo è dato dall’orbita : ci sono 2 forze , una che spinge per far andare il tutto sulla retta (come va il mondo sublunare) , l’altra che spinge per far cadere : le due forze contendono e ne consegue che l’universo giri su se stesso . La luna non è nient’altro che un oggetto incastrato nell’etere che ruota intorno alla terra : la luna è conficcata nella sfera dell’etere . In sostanza è tutta la sfera che ruota e non solo la luna : essa ruota proprio perchè ruota la sfera . Aristotele distingue i PIANETI dalle STELLE FISSE , che hanno la caratteristica di girare tutte insieme . I pianeti , invece , vagano per conto loro (il termine pianeta in greco significa letteralmente “vagante”) .Per ogni sfera ci sono pianeti ed ogni gruppo di sfere fa muovere un pianeta . Ma quali sono i pianeti ? Il sole , la luna ed altri ancora , come Mercurio . Come abbiamo detto Aristotele dà per scontato che le realtà celesti siano immutabili : egli arriva ad ammettere la circolarità e la regolarità partendo dal presupposto che fossero immutabili ; da questo derivava che avessero movimenti circolari : il movimento circolare è infatti quello che suggerisce maggiormente l’idea di eternità . Chiaramente non erano dati osservativi , perchè Aristotele vedeva che i pianeti son fermi e a volte in movimento , a volte accelerano , a volte rallentano : per motivare questi moti irregolari Aristotele doveva ricorrere a più sfere concentriche che insieme muovevano un pianeta (ogni gruppo di sfere muove il suo pianeta). Il movimento di ogni pianeta era ottenuto con la combinazione di più sfere ed ogni sfera era legata a sua volta a più sfere : ne consegue che Aristotele arrivi ad ammettere che non siano le 4 che abbiamo detto più quelle necessarie a muovere un pianeta (che , per dire , erano 3) : in tutto erano circa 47 o 55. Aristotele acquisì queste idee da Eucnosso di Cnide , un platonico . Le sfere rappresentano l’eternità , o meglio , un’eternità speciale . Sia la realtà sublunare sia quella celeste ha una sua forma di eternità : il mondo sublunare ha un’eternità specifica , che cogliamo soprattutto nell’eternità delle specie , il mondo celeste ha una eternità numerica : tra queste due forme di eternità intercorre una forma di rapporto : la ciclicità degli enti celesti detta l’alternarsi delle stagioni : possiamo quindi affermare che la ciclicità specifica è in gran parte dettata da quella numerica . Abbiamo già detto che per Aristotele dove c’è movimento ci deve essere per forza essere qualcosa che muove (causa efficiente) perchè ” omne movens ab alio movetur ” : anche il movimento celeste va quindi spiegato . Quale è la prima cosa che muove tutta la realtà celeste (Aristotele dice :”quale è il primo mobile ?”) ? La risposta sta nel CIELO DELLE STELLE FISSE , una specie di pelle dell’universo : le stelle sono infatti fissate nel cielo . Ma se il cielo delle stelle fisse muove tutto il resto , vuol dire che anche lui si muove : dove c’è movimento c’è qualcosa che muove : quindi qualcosa deve mettere in moto il cielo delle stelle fisse . Sembra che si possa andare avanti all’infinito nella ricerca del “primo motore” (ciò che per primo ha messo in movimento tutto) . Qualcuno potrebbe dire : ma non c’è un movimento ciclico che possa spiegare tutto ? Aristotele dice di no . Bisogna trovare un punto fisso che muove senza essere mosso . Se A è causato da B , B non ha bisogno di motivazioni oppure si fa riferimento a C e poi a D . Ma andare all’infinito alla ricerca delle spiegazioni è un processo privo di senso . Come nella logica occorreva trovare qualcosa che fosse così e non avesse bisogno di spiegazioni : chi pretende che tutto debba essere dimostrato , secondo , Aristotele è una persona con cui non si può ragionare . Si deve quindi trovare qualcosa che causi il movimento ma che non venga mosso . Ebbene una cosa che muove paradossalmente può non essere mossa . Esiste quindi un primo motore che pur senza essere mosso e senza muoversi mette in moto l’intero universo : è il “motore immobile” , come lo chiama Aristotele : esso si identifica con la DIVINITA’ . Abbiamo già detto che Aristotele aveva risposto alla domanda “che cosa esiste” dicendo “intanto esistono indubbiamente le cose fisiche che vediamo intorno a noi” : ora arriva a dimostrare l’esistenza di una realtà immateriale . Il movimento dei cieli abbiamo detto che è eterno (proprio perchè il cielo è eterno) : se il movimento è eterno , allora il motore è dotato di pura attualità ed è privo di potenza : essa infatti implica che una cosa possa accadere , ma anche che possa non accadere . Un qualcosa fatto di potenza e atto è destinato a fermarsi prima o poi . Il motore immobile (la divinità) è quindi atto allo stato puro . Ma sappiamo che l’atto si identifica con la forma e la potenza si identifica con la materia : di conseguenza la divinità è forma allo stato puro : non è un sinolo di materia e forma . Abbiamo detto che nella concatenazione dei motori bisogna per forza arrivare ad un qualcosa che muova senza essere mosso sennò si andrebbe avanti nella ricerca all’infinito . A questo punto quindi Aristotele introduce la divinità . Questo motore deve poi essere eterno perchè deve giustificare il movimento eterno delle sfere celesti . La divinità è l’unica realtà immateriale che Aristotele individui . Abbiamo già detto che la divinità è l’oggetto principale della filosofia prima , che ha le istanze di ontologia e di teologia . Ma se la divinità è una realtà immateriale , come fa a muovere , visto che il movimento avviene per contatto ? Aristotele risponde che la divinità muove il cielo delle stelle fisse non come causa efficiente , bensì come causa finale : se fosse causa efficiente , la divinità dovrebbe effettivamente agire sul mondo spostandolo . Ma questo è impossibile perchè è una realtà immateriale . Ma c’è anche un’altra motivazione , altrettanto importante : la divinità proprio perchè è una realtà suprema non può “interessarsi” e quindi agire effettivamente sul mondo : la divinità non fa nulla direttamente sul mondo , non ha una volontà d’azione sul mondo . Ha un’attività tutta sua e particolare che si svolge interamente dentro di lui . Agire sul mondo significherebbe autodiminuirsi : una realtà superiore quale la divinità che si occupa di una realtà inferiore quale è il nostro mondo sarebbe un controsenso , una forma di autodiminuzione della divinità stessa . Sarebbe un’ imperfezione della divinità . La divinità agisce sul mondo come “oggetto di amore e desiderio” : come la cosa amata attrae chi la ama , così la divinità attrae il mondo . Quando una cosa attrae qualcuno non si può propriamente dire che la cosa agisca su questo qualcuno , anche se in un certo senso è causa (finale) del movimento : è per quella cosa che quel qualcuno muove . Così la divinità è causa del movimento dei cieli e quindi indirettamente dell’intero universo (ricordiamoci che la ciclicità del movimento dei cieli è poi causa della ciclicità delle stagioni che a sua volta influisce sulla ciclicità particolare del mondo sublunare : la riproduzione che rende le specie eterne) . La divinità diventa quindi la causa (finale) del movimento dell’intero universo , quindi la si può chiamare motore immobile o causa incausata . La divinità non produce l’universo dal nulla , come fa invece nella tradizione ebraico-cristiana , nè lo plasma , come faceva invece il demiurgo platonico : lo mette semplicemente in moto . Non ha quindi nessun rapporto causale con l’esistenza del mondo , ma ha solo rapporto causale (finale) con il movimento del mondo . Cosa vuol dire che la divinità attrae il mondo ? Non bisogna pensare che sia come un cane che sente il cibo e gli si avvicina , perchè così non quadrerebbero alcune cose : l’universo si sposterebbe , e per andare dove ? La divinità è priva di materia e quindi non sta in nessun luogo , dato che è puramente formale . Bisogna quindi rettificare che il primo mobile cerca di avvicinarsi alla divinità nel senso che cerca di imitarla . L’avvicinarsi del mondo alla divinità va visto come un tentativo del mondo di assimilarsi alla divinità . Ma cosa vuol dire assimilarsi alla divinità ? Abbiamo visto che la caratteristica fondamentale della divinità è la sua eternità , data dalla mancanza di materia e di potenza . Come fa la realtà fisica ad imitare , ad assimilarsi ad una realtà immateriale ed eterna ? La risposta sta nel moto circolare , la miglior imitazione di eternità da parte degli enti fisici in movimento . Perchè il cielo delle stelle fisse gira ? Perchè è imitazione dell’eternità divina . Questo è il moto del primo mobile , ma come si muovono le sfere successive ? Qui i passi di Aristotele non sono chiarissimi (ricordiamoci che si tratta di appunti) . Ci sono due ipotesi : 1) che si muova per attrito : una volta che si muove il cielo delle stelle fisse , tutti gli altri cieli inferiori si muovono per attrito . Ma è poco probabile quest’ipotesi perchè è vero che tutte le sfere si muovono in modo circolare , ma il movimento è dato dalla combinazione di più movimenti , tutti circolari , ma gli uni differenti dagli altri . Se andasse davvero per attrito , le sfere avrebbero tutte la stessa direzione . 2) Già Platone ipotizzava che i cieli fossero realtà viventi ed intelligenti : per lui movimento era sinonimo di vita ed in più movimenti così ordinati presupponevano un’intelligenza . Aristotele riprende in sostanza questa teoria (in maniera meno animistica) : è probabile che pensasse che non solo il primo mobile imita la divinità col moto circolare , ma anche le sfere inferiori , a modo loro , operano alla stassa maniera , ciascuna secondo la propria natura . Dato che ciascuna lo fa secondo la propria natura , è evidente che lo fanno in modo diverso : ci sono quindi movimenti differenti e questo implica che ogni sfera abbia un qualcosa di molto simile ad un’anima : le sfere celesti sono dotate di una specie di anima . Quest’idea dell’intelligenza celeste aristotelica viene in qualche modo tradotta nell’intelligenza angelica dantesca : gli angeli del Paradiso che muovono le sfere celesti , sono proprio dei governatori di queste sfere . E’ la traduzione in chiave cristiana della teoria aristotelica . Ma la divinità cosa fa in buona fine ? Certo non agisce sul mondo in modo provvidenziale . E’ stato detto che l’ateismo ha due varianti : a) c’è l’ateismo nel senso più classico , che è la nagazione dell’esistenza di dio ( come esempio si può citare Leopardi ) . b) Ma si può parlare di ateismo anche quando si dice che dio non si occupa del mondo . Gli epicurei per esempio non negavano l’esistenza degli dei , ma dicevano che proprio perchè erano perfetti non si occupavano del mondo dell’uomo : sarebbe un abbassamento delle divinità . E’ un ateismo più sfumato . Aristotele assume una posizione che è una via di mezzo : anche per lui la divinità non si occupa del mondo , ma tuttavia lo governa : si configura come causa finale ultima : tutto il finalismo che governa l’intera realtà ha il suo punto di riferimento nella divinità , che è quindi garante dell’ordine e della regolarità , ma non in senso attivo : non c’è nessuna provvidenza . Governa il mondo perchè il mondo cerca di imitarlo . Dante conclude la Divina Commedia dicendo “… l’amor che muove il cielo e le altre stelle” : da notare che c’è un richiamo ad Aristotele , ma attenzione : Dante sta parlando dell’ l’amore di Dio (genitivo soggettivo ) , l’amore che dio prova per gli uomini : Aristotele invece dice l’amore di dio , ma con il genitivo oggettivo : l’amore nei confronti di dio : è l’amore che il mondo prova per dio che lo fa muovere . La divinità aristotelica non è provvidenziale e non la si può pregare : la preghiera di Aristotele è l’intera sua opera , in particolare le parti biologiche : c’è chi l’ha definita una preghiera apofantica : non è una preghiera con cui si prega e si chiede , ma con cui si illustra la perfezione dell’universo . Nel mondo classico non c’era nè politeismo nè monoteismo : anche in Aristotele è così : c’è la divinità come realtà suprema , ma in un certo senso le intelligenze celesti sono divinità minori : c’è quindi una sorta di mescolanza tra monoteismo e politeismo . La divinità non si occupa del mondo , ma non può non fare niente . La perfezione e la felicità sono per Aristotele legate all’attività e quindi anche la divinità deve fare qualcosa : ha un’attività tutta interna a se stessa . L’attività suprema per Aristotele è il pensare , quindi la divinità è essenzialmente una mente . Ma a che cosa pensa ? Di sicuro non pensa ad una realtà inferiore come l’universo e quindi pensa solo a se stesso . Emerge qui la definizione della divinità come “pensiero di pensiero” . Ritorniamo ora sulla nostra terra . Vediamo ora il pensiero di Aristotele a riguardo del vivente e dell’anima : Aristotele ha scritto parecchi libri a riguardo : “Historia animalium” , “De partibus animalium” , “De generatione animalium” , “Parva naturalia” , “De motu animalium” … Le opere biologiche sono importanti perchè i concetti fondamentali della metafisica derivano da qui in Aristotele . Il concetto di movimento , per esempio , è particolarmente evidente nel mondo naturale . La riproduzione degli animali deve avergli dato lo spunto per formulare la teoria della privazione forma , acquisizione forma , sostrato … Le realtà viventi sono realtà fisiche e quindi dotate di materia e forma : nella fattispecie la materia e la forma di cui è composto un sinolo vivente sono quelle che comunemente chiamiamo anima e corpo . L’anima non è una realtà fisica ultima : è fatta di materia e forma . Sono dotati di anima gli uomini , gli animali e le piante . L’anima è la forma particolare che hanno gli esseri viventi . Questo significa che non c’è una differenza qualitativa radicale tra le cose inorganiche e gli esseri viventi , c’è solo una differenza quantitativa : l’anima non è altro che un tipo di forma particolarmente complesso . Facciamo un esempio : anche gli elementi hanno forma : la forma della terra è l’essere fredda e secca . Se metto insieme alcuni o tutti e 4 gli elementi ottengo una realtà complessa . Significa aggiungere sempre aspetti formali nuovi : la terra ha solo quei 2 aspetti formali , se mescolo con alcuni dei 4 elementi ottengo una realtà complessa e composta : ottengo un tessuto ; se aggrego tessuti diversi posso ottenere un organo . Allora significa aggiungere sempre aspetti formali nuovi . Se prendo un pò di muscolo , un pò di tessuto tendineo ed un pò di tessuto osseo ottengo per esempio una mano : non è la stessa cosa che i tessuti di cui è fatta : c’è un elemento formale in più . C’è una differenza : a livello di elemento l’aspetto formale di quelli che abbiamo detto ; a livello di tessuti etc. l’elemento formale che si aggiunge è il modo in cui sono combinati : i tessuti da Aristotele vengono chiamati parti OMEOMERE , cioè sono parti che quando vengono divise sono costituite della stessa materia : se divido un muscolo in 2 parti , ottengo 2 parti di muscolo . Significa “parti simili” . Se invece ho una mano , che è la combinazione di tessuti ed è un ORGANO , essa si chiama parte non omeomere , non simili tra loro : se divido una mano , non ottengo 2 mani , bensì più tessuti differenti . Se metto insieme diversi organi ottengo un SISTEMA (ad esempio il sistema nervoso , o quello respiratorio) e se invece unisco tutti i sistemi ottengo un ORGANISMO complesso . Aristotele dice che l’anima è ” l’atto puro di un corpo che ha la vita in potenza ” : in un corpo costituito da tessuti , organi e sistemi , l’anima è la forma di quel corpo lì , non di un corpo qualsiasi , ad esempio un libro che non ha la struttura adatta per avere un’anima . Tutte le cose hanno una forma , ma solo le cose strutturate in maniera complessa (complessa = capace di svolgere tante funzioni diverse ; una penna non può fare che cadere ; un corpo vivente , una pianta , svolge diverse funzioni) hanno un’anima ; questo consente ad Aristotele di negare la reincarnazione dell’anima , che invece sosteneva Platone : la trasmigrazione presupponeva che ogni anima potesse starsene da sola ; e poi non può andare da qualsiasi parte l’anima : per Platone l’anima poteva finire in un corpo femminile , nel corpo di un animale … Questo per Aristotele è impossibile perchè un’anima è strettamente connessa ad un corpo : la forma vale solo per un corpo . Per Platone anima e corpo sono due cose distinte , una abita nell’altra : per Aristotele l’anima non è una sostanza , è una forma : la sostanza è solo il sinolo materia-forma . Di conseguenza viene negata la trasmigrazione delle anime , dove ogni forma andava in ogni corpo ; ma viene anche negata l’immortalità dell’anima : se l’anima è la forma di un corpo vivente , quando il sinolo si rompe , la forma non può vivere da sola (solo quella divina può) : essa vive solo calata nella materia . Certo abbiamo detto che la forma uomo non muore quando muore il singolo uomo : continua ad esistere in tutti gli altri uomini . Non si può però parlare di sopravvivenza individuale . Abbiamo già visto che il mondo aristotelico è dominato dal finalismo , che emerge soprattutto nel mondo biologico : i cavalli hanno gli zoccoli per poter camminare su determinati terreni . Il finalismo non è però perfetto : è un pò come per Platone : c’è di mezzo la materia che interferisce : è quella cosa priva di forma necessaria a far realizzare le forme ; per Aristotele vale ancora di più che per Platone che le forme per esistere abbiano bisogno della materia : per Platone infatti c’erano le idee che esistevano di per sè . La materia fa sì che le cose materiali siano destinate a morire . E’ con Aristotele che la parola ULE (materia) assume il significato di materia : essa infatti prima significava legname ed aveva la stessa derivazione del latino “silva” , senza la v e la s : il legname suggerisce proprio l’idea di materiale da costruzione . Tutto quel che nasce è destinato a perire ; certo è vero che “la natura non fa nulla invano” , come ripete sempre Aristotele , tutto è finalizzato ; tutto è dotato di forma e quindi tutto è bello per Aristotele anche l’insetto più ripugnante ha una sua forma e quindi va apprezzato . Va però detto che la natura può fare tutto , ma con quello che ha a disposizione : Aristotele è convinto che nel metabolismo degli esseri viventi si producano materiali di scarto : tra di essi Aristotele annovera pure le produzioni di carattere corneo : le unghie , i capelli : non vengono prodotte per un fine ; ci sono anche produzioni casuali : ma la natura per quanto può usa tutto ciò che ha a disposizione : ha a disposizione questi scarti e lei li usa per i capelli e le unghie . Non tutto quindi è finalizzato : utilizzando ciò che ha a disposizione la natura fa del suo meglio , ma non sempre ci riesce . Ad esempio : la riproduzione è un processo finalistico (dare la forma paterna) : se tutto funzionasse bene i figli sarebbero tutti maschi : ma dato che la materia è elemento di imperfezione , può succedere che nascano femmine o bambini difettosi . Può succedere che non assomigli al padre , nè a nessun parente : quando la forma non riesce a dominare la materia allora si verificano questi casi . Non c’è un salto netto tra mondo vivente e mondo non vivente , così come non c’è un salto netto tra mondo vivente superiore (uomini) e mondo vivente inferiore (piante , animali): entrambe sono costituiti dal sinolo materia-forma . E’ interessante il fatto che Aristotele credesse nella generazione spontanea : credeva che gli animali superiori si riproducessero in maniera sessuata , mentre che gli esseri inferiori (come i piccoli insetti) si generassero spontaneamente : Aristotele non era in grado di vedere che in realtà si riproducono con le uova , le larve … Lui ipotizzava che l’energia del sole fosse in grado di far passare in certe occasioni dal mondo inorganico al mondo organico . Diceva che nelle acque stagnanti riscaldate dal sole potevano generarsi organismi viventi . Ovviamente questa idea si basava sul fatto che non ci fosse un salto netto tra mondo organico e mondo inorganico : era solo una differenza di complessità . Naturalmente Aristotele aveva torto , come spesso accadeva (Aristotele va ricordato che non era riuscito a capire che cosa fossero effettivamente i fossili) : si scoprì nel ‘600 che in realtà c’erano le uova , la larve e quant’altro mediante un esperimento : misero della carne in un barattolo privo di contatti con l’esterno : la carne andò in putrefazione , ma non nacquero gli organismi perchè gli insetti non poterono depositare le larve . Nel ‘600 però si arrivò ad una conclusione giusta in merito alle circostanze , però in generale meno giusta di quanto si possa pensare : veniva negata ogni forma di passaggio dal mondo inorganico a quello organico , come se il mondo organico fosse differente qualitativamente . In realtà non è così : la scienza moderna ci suggerisce che in qualche situazione questo passaggio si è verificato . Aristotele non aveva concettualmente torto : l’idea di fondo era giusta . Questo consente di dire che certe cose che per un verso sono progresso , per un altro non lo sono e viceversa . Dunque abbiamo detto che gli organismi viventi hanno un’anima : Platone aveva parlato di 3 parti dell’anima (la biga alata) : Aristotele fa un discorso che presenta analogie con quello platonico , ma che in realtà è diverso : non parla di 3 parti dell’anima , ma di tipi diversi di anima , alcuni più semplici , altri più complessi . I più semplici presentano determinate funzioni , quelli più complessi presentano accanto alle funzioni più semplici possedute dagli altri , alcune funzioni più complesse . Aristotele parla di tre tipi di anima : 1) VEGETATIVA 2) SENSITIVA 3) INTELLETTIVA . Apparentemente sembra che parli di 3 anime diverse : in realtà sono 3 tipologie di anime dotate alcune di poche funzioni , altre di più funzioni . In sostanza lui divide i vegetali dagli animali , dall’uomo . I vegetali hanno l’anima vegetativa ; non possiede nè le funzioni intellettive nè quelle sensitive (alle quali sono connesse le funzioni del movimento) : la pianta ha solo la funzione vegetativa , si nutre , cresce e si riproduce . Sono anime vegetative perchè hanno solo l’anima vegetativa . Gli animali possiedono altre funzioni , per cui la loro anima è sensitiva : ma attenzione , l’anima sensitiva oltre a possedere le funzioni vegetative possiede ulteriori funzioni . L’anima sensitiva fa sì che gli animali mangino , crescano , si riproducano (come le piante) ma in più provino sensazioni ed abbiano (di conseguenza) il movimento perchè solo l’animale sentendo che là c’è il cibo si muove per prenderlo . L’uomo ha l’anima intellettiva : non è un’anima che si aggiunge , è solo un’anima più complessa : possiede le funzioni vegetative (come piante e animali) , quelle sensitive (come gli animali) ed in più possiede la funzione intellettiva , la capacità di ragionare ed universalizzare : scire per causas e generalizzare . Le anime si distinguono quantitativamente e non qualitativamente . E’ interessante notare che queste anime vengano chiamate con la funzione che le contraddistingue dalle altre : l’anima sensitiva possiede anche le funzioni vegetative , ma ciò che caratterizza l’animale è il fatto di provare sensazioni . Così l’anima intellettiva caratterizza l’uomo per la facoltà di ragionare : vuol dire che l’uomo non è caratterizzato dal fatto di vivere , ma di pensare . Il pensare è l’essenza dell’uomo . Infatti è quello che lo contraddistingue dagli altri animali : è un animale razionale . A riguardo dell’intelletto umano è nata una delle questioni più complesse della storia della riflessione , questo perchè Aristotele ci fornisce poche informazioni e non chiarissime : abbiamo visto la questione della potenza e dell’atto : ogni cosa che passa dalla potenza all’atto , ha bisogno per far questo dell’intervento di qualcosa già in atto . Questo vale anche per i processi conoscitivi : l’uomo è senziente in potenza finchè non ha una percezione specifica ; così il blu di un libro è un sensibile in potenza finchè non viene percepito : finchè la mia capacità di vedere non si incontra con il colore , io rimango un senziente in potenza ed il blu sensibile in potenza . Quando si incontrano io divento senziente in atto ed il blu sensibile in atto : vale anche per l’intelletto ; nella mia anima si forma la forma sensibile dell’oggetto che vedo , vale a dire la forma senza materia : la forma sensibile in potenza è diventata forma sensibile in atto . Una volta che ho una forma sensibile (o più di una) , devo fare un ulteriore passaggio che non è percepire il libro , ma pensarlo . Pensare e conoscere vuol dire secondo l’universale . Vuol dire deprivare una forma sensibile dalle sue caratteristiche specifiche che ne fanno la forma di quel particolare oggetto per cogliere quell’aspetto generale che ne fa una forma intellegibile : incontro una persona (sensibile in potenza) e diventa sensibile in atto , io senziente in atto : nella mia mente entra la sua forma con le sue caratteristiche specifiche e sensibili ; la capacità intellettiva è quella che fa un altro passaggio : fa passare la forma sensibile in atto al livello atto : conoscere nella persona che incontro la forma uomo (tramite l’induzione) : tolgo le caratteristiche specifiche per arrivare al generale . La forma sensibile in atto è quindi forma intellegibile in potenza : le forme sensibili di tizio e di caio , possono diventare il punto di partenza per il processo di astrazione che mi porta alla forma uomo . Potenzialmente la forma di tizio è forma uomo . L’intelletto in potenza diventa intelletto in atto : l’intelletto in potenza inizialmente è una tabula rasa : prima di arricchirsi con esperienze è vuoto . Ma l’intelletto per passare da potenza ad atto deve avere l’aiuto di qualcosa già in atto ed ecco che Aristotele fa riferimento ad un intelletto definito POIETIKOS (intelletto attivo o produttivo) : io ho intelletto in potenza ; con le esperienze sensibili diventa intelletto in atto : ma ci deve essere qualcosa in atto che consenta il passaggio : ecco il “nous poietikos” (che compare una volta sola in tutte le opere di Aristotele) , quel qualcosa che essendo già in atto (ha cioè già in atto tutte le forme)mi consente il passaggio ; che cosa sia il nous poietikos Aristotele lo dice solo di sfuggita : dice che è qualcosa che sopravviene dall’esterno ed è incorruttibile . Da questa frase buttata lì da migliaia di anni si discute : le possibilità sono diverse : 1) é una parte dell’anima umana : ma se è parte dell’anima umana , sembra che ci sia un pezzetto di anima umana immortale , che già quando nasciamo ha tutte le forme . 2) Questo nous poietikos è uno solo , esterno all’anima : a questo punto è una divinità , ma è la stessa che abbiamo incontrata nella cosmolgia ? Cadremmo di nuovo in contraddizione , perchè quella là pensava solo a se stessa . Qui aiuta gli uomini a pensare , è provvidenziale . Alessandro di Afrodisia diede la prima interpretazione : il nous poietikos è parte dell’individuo e quando si muore muore anch’esso . Averroè dirà che il nous poietikos si identifica con la divinità : è unico e separato . Accettata quest’ipotesi viene comunque negata l’immortalità dell’anima : il nous poietikos è qualcosa al di fuori dell’uomo . Averroè diceva “chi pensa è immortale , chi non pensa crepa” : se pensando si partecipa dell’attività del nous poietikos si partecipa all’immortalità del nous poietikos : si ha una forma di immortalità . Per capire il finalismo aristotelico è interessante il confronto con Anassagora : Anassagora diceva che l’uomo è intelligente perchè ha la mano che gli consente di avere un particolare rapporto con la natura ; Aristotele diceva che l’uomo è l’animale più intelligente e che di conseguenza la natura (che non fa nulla invano) gli ha dato la mano . Passiamo ora ad esaminare la politica e l’etica aristotelica , che stanno nelle scienze pratiche . La politica riguarda il comportamento della società , mentre l’etica quello del singolo . In Platone il cittadino e l’uomo erano ancora grosso modo un tutt’uno , ma con Aristotele la distinzione si accentua . Aristotele dedica un libro alla politica (“La politica”) . Il punto di partenza è la frase famosa “l’uomo è per natura un animale politico” ; Aristotele dice che non sono politici nè gli animali nè gli dei : solo l’uomo lo è . Cosa significa quest’espressione ? Vuol dire sia che per natura è legato ad una vita comunitaria con gli altri sia che la forma tipica della vita sociale è la polis (termine dal quale deriva la parola politica) . Aristotele come sappiamo ha vissuto rapporti stretti con la Macedonia : tuttavia la politica di Alessandro Magno ha poco a che fare con il pensiero di Aristotele : è legato all’idea che l’uomo è legato alla polis e Alessandro Magno è la nagazione della polis . Aristotele innanzitutto fa notare una cosa : aqltri animali vivono in società , ma è un fatto istintivo : in loro manca l’aspetto organizzativo . Dire che l’uomo per natura è un animale politico significa anche implicitamente negare il cosiddetto “CONTRATTUALISMO” , la tesi secondo la quale lo stato è un contratto , una convenzione fatta a tavolino dagli uomini , che si rendono conto che stare insieme è vantaggioso . Aristotele la pensa diversamente : è un’attitudine naturale ; è vero che gli uomini si raggruppano anche per interesse , per trarre vantaggi : nessuno può fare tutto bene e da sè ed è meglio che ciascuno si specializzi in un’attività . Ma non è un processo convenzionale , bensì è spontaneo . Aristotele dice poi che il fatto di vivere insieme non è solo dettato da esigenze materiali : anche se l’uomo avesse tutto ciò di cui ha bisogno e fosse autonomo tenderebbe lo stesso a vivere insieme ad altri . Vi è una spontanea voglia di stare insieme . L’uomo tende quindi ad aggregarsi in modo naturale : i contrattualisti dicevano che ogni uomo era un atomo nella società . Il carattere naturale per Aristotele comporta il carattere gradualistico : vede nella polis l’ultima gradino dei processi aggregativi : prima c’è il villaggio , e prima ancora la famiglia , il nucleo naturale dei processi di aggregazione sociale , il cui culmine è nella polis . Che la famiglia sia un’associazione naturale e precedente alla polis è un’affermazione importante perchè ha influenzato molto la dottrina cattolica sulla famiglia . La famiglia è la società naturale e primordiale : è nata prima e autonomamente e quindi ha dei suoi diritti . Quando Aristotele parla della famiglia la chiama OIKOS (casa) : è interessante perchè la famiglia è il nucleo primario non solo sul piano degli affetti , ma anche sul piano economico : economia infatti significa regolamentazione dell’oikos . Quando Aristotele parla della famiglia cita 4 figure : padre , madre , figli e schiavi , che svolgevano attività agricole e di servizio per la casa . Anche nella famiglia si formano diversi rapporti di autorità : il padre (il pater familias latino) ha diversi rapporti di autorità sulla moglie , sui figli e sugli schiavi . Il rapporto nei confronti dei figli è temporaneo e dura finchè essi non crescono ; il rapporto nei confronti degli schiavi è permanente . A noi pare sconcertante il concetto di schiavitù , ma Aristotele cerca di fornire argomentazioni valide : tuttavia , lui stesso si accorge di alcune contraddizioni . Lui dice che la schiavitù è un qualcosa di naturale e necessario (da notare che Aristotele tende molto di più di Platone ad accettare le cose come sono : non ci dice come Platone come dovrebbe essere il mondo , ma come è effettivamente) ; anche nello studio della politica Aristotele parte dai phainomena , dalle documentazioni storiche per poi fare confronti tra le varie forme di governo : raccolse tantissime costituzioni e fece le sue considerazioni . Come giustifica la schiavitù ? Dice che esistono individui per natura liberi ed altri per natura schiavi ; l’argomentazione è fondata sulla capacità di deliberare , di ragionare ; Aristotele dice che c’è una parte dell’umanità capace a mettere in pratica le sue capacità mentali (in potenza le abbiamo tutti , si tratta di farle passare in atto ) e una parte che non è capace : non sa fare scelte razionali . Se è così , dice Aristotele , è meglio non solo per i padroni , ma anche per gli schiavi stessi essere schiavi (va ricordato che la schiavitù greca era molto meno pesante di quella romana) : una persona incapace di governarsi autonomamente trae solo benefici dall’essere governata da qualcun altro . Aristotele arriva a definire lo schiavo STRUMENTO INANIMATO . Il vero problema è che in concreto non si diventa schiavi per il fatto che non si è in grado di pensare : si diventa schiavi con le guerre : chi perde diventa schiavo , chi vince diventa padrone . Ricordiamoci che Platone stesso aveva rischiato di diventare schiavo perchè era stato catturato dai pirati : certo Platone in quanto a pensare ne sapeva qualcosa … Aristotele se ne rende conto ma non trova altre via di uscita . Aristotele è stato il fondatore della scienza economica : uno dei concetti fondamentali da lui elaborati è la concezione del denaro e delle sue funzioni . Per lui esistono due modi per usare il denaro , una legittima , l’altra no . L’economia è il governo della casa , il processo con cui si procurano i beni per far funzionare bene la casa . Naturalmente bisogna fare acquisti e scambi : c’è il baratto ma anche l’uso della moneta . Le idee di Aristotele sul denaro verranno addirittura riprese da Marx : l’uso del denaro è legittimo se viene usato per fare acquisti , ma diventa illegittimo se lo si usa non come mezzo ma come fine , quando cioè non lo uso più per fare acquisti ma per accumularlo : Aristotele quindi condanna l’accumulazione (in Greco “crematistikà”) . E’ un uso contro natura del denaro ; questo concetto di secondo natura e contro natura è sempre presente in Aristotele . La natura del denaro , la sua essenza è quella di essere mezzo di scambio . E’ una condanna ante litteram del capitalismo . Passiamo all’analisi politica vera e propria : opera anche lui una catalogazione delle forme di governo . E’ una catalogazione abbastanza simile a quella operata da Platone nel “Politico” : la distinzione tra forme di governo negative e positive è data dal fatto che chi governa governi per l’interesse pubblico o personale . La monarchia è la forma di governo dove il singolo governa per il bene di tutti ; la tirannide quella dove il singolo governa per il proprio bene . L’aristocrazia e l’oligarchia sono lo stesso e così anche la democrazia e la politeia . La democrazia è il governo dei molti : la collettività può governare negli interessi di tutti (politeia) o in quelli della maggioranza che governa (la democrazia) . La politeia è la costituzione per eccellenza (secondo Aristotele) ; in realtà bisogna fare attenzione al fatto che Aristotele divida secondo due criteri politici : a)numerico : governano tanti , pochi… b)sociologico : la democrazia non è solo il governo dei più , ma anche il governo del demos (popolo) : anche in Italiano l’espressione popolo ha duplice valenza : può essere governo della popolazione , ma anche governo del popolo inteso come parte inferiore della società . Condanna la democrazia perchè è il governo della maggioranza popolare , socialmente inferiore , che tende a governare per il proprio interesse , varando leggi a proprio interesse . Per Aristotele la miglior forma di governo è la politeia , la democrazia positiva , quando i più governano bene . La politeia viene vista secondo un criterio quantitativo , ma anche secondo un criterio sociale : Aristotele dice che tutti accetteremmo che fosse uno solo a governare se egli avesse più virtù di tutti gli altri messi insieme : sarebbe il miglior governo , ma è puramente astratto . Nella politeia , per quanto la maggior parte delle persone abbia virtù mediocri , tutto sommato mettendole insieme qualcosa si ottiene : messi insieme non saranno gran chè , ma insieme riusciranno a far funzionare il governo . Sul piano della sociologia come si caratterizza la politeia ? Per il prevalere del ceto medio : la politeia è una democrazia moderata , del ceto medio . Il motivo principale è che è una società non polarizzata , dove non c’è netta distinzione tra ricchi e poveri : una società troppo polarizzata è instabile perchè in perenne conflitto . Quindi sarà una società più stabile ; ma c’è poi un effetto paradossale : noi siamo abituati all’idea che una democrazia funziona tanto meglio quanto più è compartecipata : Aristotele fa un ragionamento opposto . In sostanza dice in maniera più realistica quanto Platone aveva detto nella ” Repubblica ” : il ceto medio non ha alcun interesse a governare (come i filosofi per Platone ) ; se diamo il potere al ceto medio , è presumibile che esso sarà poco attirato dal governo perchè ha una sua attività economica . Parteciperà moderatamente : Aristotele ha in mente una democrazia tranquilla . Passiamo ora all’etica : primo concetto fondamentale è quello di felicità ; l’etica di Aristotele è un’etica eudaimonistica (che mira alla felicità) . Va però fatta una distinzione tra etica EUDAIMONISTICA ed EDONISTICA (che mira al piacere) : Aristotele tende a descrivere come l’uomo si comporta e non come dovrebbe comportarsi . Dice che l’uomo mira alla felicità ; l’etica edonistica è una variante dell’etica eudaimonistica . L’etica epicurea sarà edonistica : l’uomo cerca il piacere . Aristotele non nega che il piacere abbia la sua importanza ; ma la felicità non è il piacere , è qualcosa di più ampio che contiene anche il piacere . L’etica di Aristotele è eudaimonistica ma non edonistica . Il ragionamento di Aristotele è questo : deve arrivare a capire quale è il fine ultimo dell’uomo . Quindi dice che bisogna distinguere i fini in sè ed i fini che mirano a realizzarne altri : è vero che ciascuno ha fini personali , ma in realtà il fine ultimo di tutti è la felicità : cosa vuoi fare ? voglio acquisire un titolo di studio . Ma non è un fine in se stesso : lo fai in funzione di qualcos’altro . Per svolgere una professione . Non è un fine ultimo : lo fai per fare qualcos’altro : per avere soldi . Ma coi soldi voglio andare in vacanza . Ma perchè vuoi andare in vacanza ? Per fare cose che mi piacciono . Perchè vuoi fare quelle cose ? Perchè così sono felice . La felicità è il fine ultimo dell’uomo . Il piacere non è il fine ultimo , ma accompagna e perfeziona ogni attività e sarà tanto migliore quanto migliore è l’attività che esso accompagna . La felicità non viene mai concepita come far niente : è sempre legata all’attività , sia fisica sia intellettiva : la felicità è l’atto di un’azione ben riuscita . Il piacere si accompagna a queste situazioni . Che cos’è la felicità per l’uomo ? La felicità deriva dall’esercizio di un’attività e visto che la specificità dell’uomo è la razionalità , si può dire che la felicità derivi dall’esercizio della ragione . Per gli animali in teoria non si può parlare di felicità , ma comunque la felicità di un cavallo , per esempio , è fare il cavallo . Lo stesso in un certo senso vale per l’uomo . E’ meglio essere sani che malati , belli che brutti e così via , ma non è l’elemento centrale : l’elemento centrale è fare l’uomo , esecitare la ragione . Esercitare la ragione vorrà dire due cose distinte . Aristotele ha distinto ragione teoretica (quella che ci fa conoscere) da ragione pratica (quella in grado di goverrnare razionalmente il nostro comportamento ) . Questa distinziona delle funzioni della ragione governa la distinzione delle due tipologie di VIRTU’: la parola virtù va intesa in senso più generico da come siamo abituati : in Greco è “aretè” ed è l’eccellenza , ciò che fa sì che l’uomo sia veramente uomo , esercitando al meglio le facoltà che gli sono proprie . Ci sono le virtù etiche e le virtù dianoetiche , che riguardano la ragione , la virtù teoretica di per se stessa : le etiche riguardano l’uso della ragione volto a finalità pratiche , mentre le dianoetiche riguardano l’uso della ragione di per se stessa . Le etiche invece hanno a che fare con il costume , l’ethos (il mos latino) . Sono legate a funzioni pratiche . Aristotele considera le virtù etiche come “habitus” , la tendenza di fondo a comportarsi in un determinato modo . Nella fattispecie la virtù è habitus a comportarsi secondo la medietà : la mediocritas latina , la via di mezzo , l’evitare gli estremi . Aristotele in greco la chiama “MESOTES” , la capacità a tenere il giusto mezzo . La virtù è quindi in generale la disposizione costante a cogliere la via di mezzo sempre . Cosa vuol dire ? Ricordiamoci che quella aristotelica (come quella platonica) è l’etica della metriopazia , del controllo delle passioni . Rispetto ad ogni passioni bisogna evitare sia l’eccesso sia l’eliminazione . Per passione intendiamo quegli istinti naturali che la ragione deve saper controllare . Prendiamo come esempio la virtù del coraggio : consisterà in una habitus a mantenere il giusto mezzo di fronte ad una paura . Quale è il giusto mezzo ? Non la codardia , ma nemmeno la temerarietà . Consisterà in una medietà . La medietà di cui parla Aristotele è più qualitativa che quantitativa : l’esempio classico di Aristotele è quello della generosità : non si deve nè essere avari nè prodighi (lo dice anche Dante nel settimo canto dell’Inferno) : la generosità consiste nel dare il giusto . Se essere prodighi vuol dire dare 10 denari ed essere avari vuol dire darne 2 , non è che la generosità consista nel darne 6 (che è la media matematica) : il giusto mezzo è qualcosa di molto più sfumato . Essere generosi vuol dire cogliere il giusto comportamento in ogni singola circostanza . Non è sempre la metà : a volte può essere di più , a volte meno . Chiaro che la generosoità per chi ha tanti soldi è diversa rispetto a chi ne ha pochi . Il problema è questo : l’habitus è innato o acquisito ? Don Abbondio avrebbe optato per la prima ipotesi : il coraggio se non lo si ha non può nascere da sè . Aristotele non sarebbe d’accordo : per lui infatti c’è il problema di un’apparenza di circolo vizioso che lui vuole risolvere . Quale è ? E’ questa : compirà azioni coraggiose chi è coraggioso ; però è anche vero che è compiendo azioni coraggiose che si acquisisce l’habitus . Quindi c’è un circolo vizioso apparente : chi è coraggioso compie azioni coraggiose , chi compie azioni coraggiose diventa coraggioso . In realtà è molto meno vizioso di quel che sembri : è evidente che solo chi sa suonare il pianoforte suona bene il pianoforte . E’ anche vero che non c’è altra maniera per imparare a suonare il pianoforte che suonare il pianoforte . In realtà cosa è che realmente succede ? In una sorta di circolarità aperta mi si dice a livello teorico come fare un accordo con il piano : si acquisiscono pian piano le basi fino ad arrivare a suonare autonomamente . Non è un circolo vizioso . E’ presumibile che Aristotele intendesse dire che ci fossero proprio momenti in cui mettersi a tavolino e studiare il da farsi . La ragione pratica mi fa scegliere il comportamento giusto . Aristotele individua poi il concetto di giustizia distributiva e commutativa . E’ un concetto già intuito da Platone : la giustizia distributiva è quella che distribuisce secondo certi parametri ; quella commutativa è quella che distribuisce in parti uguali . La giustizia distributiva distribuisce determinate cose a gruppi di persone : denaro , onore , potere … Ma secondo quale criterio ? Aristotele sottolinea che i criteri variano a seconda del regime . I regimi democratici distribuivano il potere in base alla cittadinanza , quelli oligarchici in base alla ricchezza e così via . La commutativa è quella che regola gli scambi : non è una questione di proporzione , ma di uguaglianza . In poche parole , mentre con la distributiva ci sarà chi riceverà di più e chi di meno a seconda dei criteri in vigore , con la commutativa non è così : negli atti di compravendita non conta che una persona sia nobile , bella ricca e altro … Se io vendo una cosa voglio che mi si dia in cambio lo stesso valore : è irrilevante se sono più ricco , più bello … Aristotele dice che questo vale sia per i contratti volontari (come quello di compravendita) sia per quelli involontari . Lui definisce il furto “contratto involontario” : uno prende ad un altro una cosa che l’altro non è disposto a dargli ; però vale anche qui la giustizia commutativa : bisogna punire il ladro in modo equivalente al danno che la vittima ha subito e questo vale per tutti . Da notare una cosa : è uno dei tanti modi di concepire la punizione , ma non è il solo . Poi Aristotele fa una classificazione delle virtù dianoetiche , che corrisponde all’elenco dei diversi tipi di scienze : l’arte (tekne) , la saggezza (phronesis) , la scienza , l’intelletto e la sapienza . Apparentemente non corrisponde : le scienze erano 3 e qui troviamo 5 nomi . In realtà in pratica corrisponde : sono 5 virtù del sapere . L’arte corrisponde alle scienze poietiche (è un sapere che mira a produrre) , la saggezza corrisponde alle scienze pratiche (saggezza è ben diverso da sapienza : è il sapere che mi permette di governare il mio comportamento) , tutte le altre 3 corrispondono alle teoretiche : la sapienza è la somma di scienza ed intelletto : l’intelletto è la capacità di cogliere i principi di una dimostrazione , la scienza è la capacità di dimostrare . Mettendo insieme queste due facoltà ottengo la sapienza . C’è una sovrapposizione tra le scienze etiche e tra le dianoetiche : la saggezza : è una forma del sapere , ma essendo forma di sapoere che riguarda il saper fare , il comportarsi è chiaro che è la ragione che mi consente di sviluppare le virtù etiche : le scelte umane si fanno con la saggezza . Il tema conclusivo dell’etica è l’AMICIZIA : ci son diversi tipi di amicizia : a) per utilità : sono amico di uno perchè ne traggo vantaggi ; b) per piacere : sono amico di uno perchè mi fa piacere (magari è una persona divertente); c) amicizia disinteressata , fondata sulla virtù : lega i buoni ed i buoni naturalmente . L’amicizia non è necessariamente legata all’utilità o al piacere ; come nella politica dicevamo che l’uomo per natura è animale politico , qui l’uomo per natura cerca amicizie , è animale socievole . Nessun uomo fa a meno di avere amicizie . La vera amicizia è quella fondata sulla virtù : è l’unica che lega buoni con buoni . Aristotele fa notare che se anche l’uomo potesse fare a meno da un punto di vista pratico delle amicizie , tenderebbe ugualmente ad averne . La conclusione è incentrata sulla ricerca del modello ultimo di vita da imitare . Fa una distinzione che in Platone non c’era : Platone era molto socratico ed il sapiente platonico era quello che sapeva e che era giusto di conseguenza . In Aristotele c’è collegamento tra scienza e virtù , ma non una sovrapposizione (come invece c’era per Platone); sul piano umano il modello di vita è quello fondato sulle virtù etiche : il modello del buon cittadino . In realtà però le virtù dianoetiche sono superiori , però il seguire perfettamente le virtù dianoetiche è un qualcosa di sovraumano . Chi è il modello del sapiente che segue la virtù dianoetica ? La divinità . Essa pensa sempre e all’oggetto supremo : una vita contemplativa , di studio , intellettuale . E’ ancora superiore rispetto al cittadino , ma è sovraumano : anche il filosofo che cerca di seguire le virtù dianoetiche si avvicina alla divinità . Ma la divinità svolge quell’attività di continuo , il filosofo lo può fare solo in qualche momento : ha esigenze biologiche , politiche , economiche … Solo in pochi momenti gode della virtù divina . E’ una posizione intermedia quella di Aristotele . Il sapiente è ancorato al divino in primo luogo perchè gli oggetti del suo sapere sono divini : egli infatti cerca di scoprire i principi e le cause che sono all’origine del mondo . Va poi detto che la divinità stessa è l’esatta proiezione della vita del sapiente : il pensare , la “theoria” , è l’attività propria della divinità , che però a differenza del sapiente , la esercita ininterrottamente : ” sedendo et quiescendo efficitur sapiens ” ( sedendo e riposando si diventa saggi ) .
GRIGLIA RIASSUNTIVA
Esposizione
Impostazione di fondo
Esiste sì, come per il suo maestro Platone, un mondo intelligibile, spirituale e invisibile (i “Motori immobili”), ma è pienamente reale anche il mondo sensibile, questo mondo, che è fatto di sostanze materiali.
Se infatti per Platone centrale è l’idea, realtà perfetta e immutabile, per Aristotele centrale è la sostanza, che è anzitutto sostanza materiale, corporea.
Mentre Platone era quindi tutto proteso verso il mondo delle idee, che abbiamo già visto prima e vedremo dopo dell’unione al corpo della nostra anima, per Aristotele questa, presente, è la vera vita. Niente egli ci dice di una vita ultraterrena (che però nemmeno esclude).
suddivisione del sapere
tutto il sapere si suddivide ordinatamente:
- scienze teoretiche (mirano al sapere [per il sapere, cioè disinteressatamente]: la loro origine è la meraviglia, non una utilità operativa)
- metafisica
- matematica
- fisica
- scienze pratiche
- etica
- politica
-
scienze poietiche
Metafisica
Il suo fine è la contemplazione, cioè la conoscenza (disinteressata) della verità. Infatti, secondo Aristotele “tutti egli uomini, per natura, tendono al conoscere (παντες ανθροποι του ειδέναι ορεγονται φυσει)”.
“Gli uomini hanno cominciato a filosofare, ora come in origine, a causa della meraviglia (…). Ora chi prova un senso di dubbio e di meraviglia riconosce di non sapere (…). Cosicché se gli uomini hanno filosofato per liberarsi dall’ignoranza, è evidente che ricercarono il conoscere solo al fine di sapere e non per conseguire qualche utilità pratica.” (Met, A, 2, 982b)
” Il fine della scienza teoretica è la verità” (Met, α ελαττον, 1, 993b).
Il che significa che c’è nell’uomo il desiderio di conoscere la verità, e questo desiderio è più forte di qualsiasi interesse pratico. L’uomo desidera sapere il senso della sua esistenza, come è davvero, non piegandone la ricerca a un progetto predeterminato.
La metafisica ha quattro significati fondamentali
Aitiologia
In quanto tale la metafisica è scienza delle cause prime, ossia dei supremi perché. Si possono in effetti conoscere dei perché prossimi, che si costituiscono in realtà come dei “come” in rapporto ai perché supremi, alle cause prime, che la metafisca considera.
Tali cause prime sono quattro: materiale, formale, efficiente (o agente) e finale.
La causa materiale o materia è il sostrato indeterminato, privo quindi di caratteri specifici. Di questa causa si sono occupati essenzialmente i primi filosofi (dalla scuola ionica a Eraclito).
La causa formale o forma è il fattore determinante, ciò che fa sì che la materia indeterminata assuma certi caratteri distintivi. Di questa causa si è occupato in particolare Platone, con la sua teoria delle idee.
La causa efficiente (o efficace, o agente) è ciò da cui è prodotto l’effetto: è la causa nel senso corrente del termine. È Empedocle ad aver per primo individuato questa causa, da lui collocata nelle forze di Amore e Odio.
La causa finale o fine è ciò verso cui tende la cosa causata. Di questa causa ha parlato soprattutto Anassagora, con la sua teoria del Nous, che organizza tutta la realtà dei semi in modo ordinato e finalizzato.
Materia e forma sono principi intrinseci alla cosa, al punto che non si possono scindere. Causa efficiente e finale sono invece estrinseci alla cosa causata, la prima precedendola, la seconda seguendola.
Ontologia
“Vi è una scienza che studia l’essere in quanto essere e le proprietà che gli competono in quanto tale”, afferma Aristotele all’inizio del libro Gamma. La metafisica è infatti, nel suo secondo senso, scienza dell’essere in quanto essere.
[analogia=uni-molteplicità dell’essere] L’essere, ciò che è in ogni cosa, è al contempo uno (identico nelle diverse cose) e molteplice (poiché le cose sono comunque molte), ossia è analogo. Aristotele afferma quindi la analogia dell’essere.
[unità dell’essere] In quanto uno, l’essere ha delle leggi, dei principi a cui obbedisce: il principio di identità, di non-contraddizione e del “terzo escluso”, per cui è impossibile che la stessa cosa sia e non sia (το γαρ αυτό αμα υπαρχειν τε και μη υπαρχειν αδύνατον τω αυτω και κατα το αυτο, G, 3, 1005b 19/20).
Come si dimostrano tali principi supremi? Non possono essere dimostrati positivamente. È da pazzi dice infatti Aristotele, chiedere la dimostrazione di tutto: alcune cose sono autodimostrantesi: sono evidenti. Se si pretendesse di dimostrare tutto si cadrebbe in un circolo vizioso: si dimostrerebbe A con B, B con C e così via, fino a Z, che sarebbe dimostrata con A. Ilche sospenderebbe il tutto a una ultima non dimostrazione. Da un lato quindi i principi supremi sono immediatamente evidenti.
Tuttavia una qualche forma di dimostrazione esiste: per assurdo. Mostrando che chi volesse negarli non potrebbe essere coerente.
Chi volesse negare i principi supremi dovrebbe essere come un tronco (ομοιοσ φυτω): infatti qualsiasi parola o discorso uno pronunzi intende dare con ciò stesso un senso preciso al suo discorso o alla sua parola. Nessuno parla per dire una cosa e il suo contrario e infinite altre cose. Ma così dovrebbe essere se il principio di non contraddizione non fosse vero. Il che dimostra che è impossibile, di fatto, negarlo (Г, сар. 4/6).
[molteplicità dell’essere] Si danno quattro significati fondamentali dell’essere:
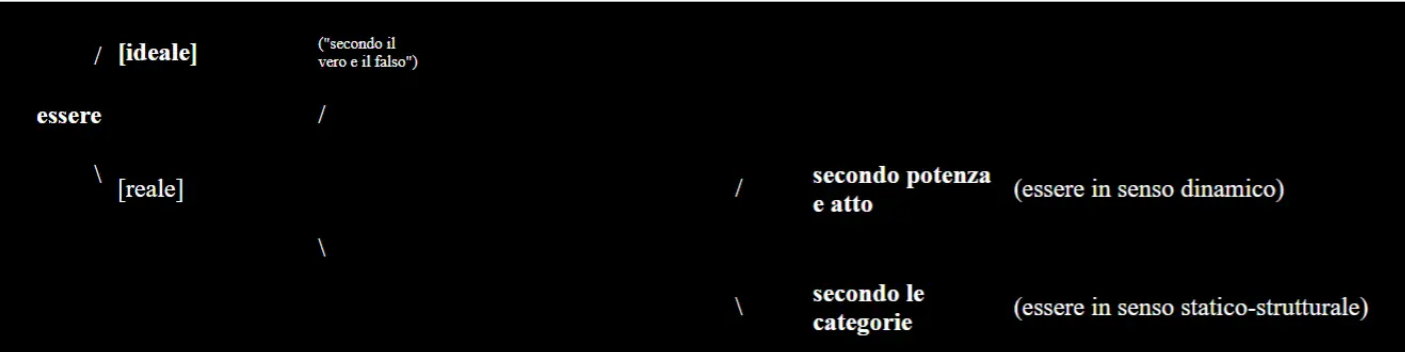
Specificazioni
1. Essere secondo il vero e il falso (to on os alethès): è l’essere in quanto pensato: solo questo essere può essere falso; infatti la falsità è solo nel giudizio del soggetto che non si “adegua” all’oggettività del reale. Non esistono “cose false”, ma pensieri falsi. Il che significa che l’esssere in senso vero e proprio coincide col vero. Il che è molto prossimo al dire che la realtà non inganna, ma è il soggetto umano a porre diaframmi alla verità, a cercare di alterare ciò che di per sè sarebbe retto e limpido.
2. Essere accidentale: è l’essere che di fatto si trova ad accadere, ma potrebbe anche non accadere; è senza essere radicato nelle profondità necessarie delle strutture intelligibili che costituiscono l’intelaiatura del reale. Di fatto è accidentale ogni realtà particolare e ogni evento concreto. Necessarie sono solo le struttura inteligibili, le nature specifiche e le leggi universali. Questo significa che per Aristotele io che scrivo e tu che leggi esistiamo per un caso, e per caso ci è accaduto nella vita quello che ci è accaduto: il particolare in quanto tale non ha senso, è assurdo. Sensato è unicamente l’universale. Ma in questo modo, per Aristotele, la vita concreta non è salvata.
3. Essere secondo potenza e atto. Con questi concetti Aristotele imposta la sua soluzione al problema della contraddittorietà del divenire, quale la aveva prospettata Parmenide. Per il quale il divenire è l’essere del non essere e il non essere dell’essere. Invece il passaggio è non dal non-essere (assoluto) ma da quel non-essere relativo che è l’essere potenziale all’essere attuale. Il che non implica contraddizione. Essere potenziale è ad esempio il seme rispetto alla piante che se ne svilupperà: il seme è in atto seme, e in potenza pianta.
4. Essere secondo le categorie. Ossia sostanza, qualità, quantità, luogo, tempo, relazione, agire, patire. Una distinzione essenziale va fatta tra la categoria di sostanza, che è la principale, e quelle degli “accidenti”. Solo la sostanza “sussiste”, mentre gli accidenti “ineriscono” alla sostanza, come sue determinazioni. Non esiste il verde in sè, ma il verde di una data sostanza (ad esempio di una pianta), mentre la pianta esiste in sè stessa, non “appoggiandosi” ad altro, non inerendo.
Usiologia
Nell’essere, tra i vari tipi di essere un posto centrale lo occupa la sostanza.
Sostanza è un essere che non inerisce ad altro, ma è sostrato di inerenza di altro (cioè degli accidenti). Le caratteristiche della sostanza sono le seguenti:
- unità (la sostanza deve essere un che di uno: un sasso è una sostanza, un mucchio di sassi no)
- determinatezza (deve essere un tode tì, deve potersi indicare concretamente)
- indipendenza (appunto in quanto la sostanza sussiste, e non inerisce: un maglione è sostanza, il blu no, perché è sempre blu di qualcosa, di qualche sostanza, ad esempio blu del maglione)
- attualità (deve essere qualcosa di attuale, di reale: il seme che è seme ora, è sostanza, la pianta che il seme può diventare, sviluppandosi, non è sostanza, finché il seme resta seme).
In base a tali presupposti può essere detto sostanza:
non la materia: che non è attuale, nè determinata, nè indipendente, nè davvero una
nemmeno, sotto ogni aspetto, la pura forma, che nelle sostanze corporee non è indipendente, pur essendo determinata, una e attuale
ma il sinolo di forma e materia: questa è la vera sostanza che costituisce il mondo fisico, da noi immediatamente conosciuto.
teologia tra le varie sostanze centrale è la sostanza prima, il Motore Immobile, che, pur invisibile e spirituale, può essere affermato a partire dal divenire che constatiamo nel mondo fisico.
Il Motore Immobile, suprema perfezione della realtà, è eternamente felice nella contemplazione di sè stesso, ma non conosce altro fuori che sè (=non è creatore del mondo, nè provvidenza: è il mondo che “va” verso di lui, come verso il suo Fine)
fisica.
Il mondo sensibile è fatto da sostanze, composte di materia e di forma, e divenienti;
il loro divenire può essere di diversi tipi (locale, qualitativo, quantitativo, sostanziale), ed ha necessariamente delle cause.
le sostanze corporee sono collocate in uno spazio, che è finito, mentre divengono nel tempo che è infinito (=il mondo è eterno).
etica.
L’uomo organizza tutto il suo agire in vista di un fine, e i fini particolari sono subordinati a un fine ultimo;
di fatto i diversi uomini hanni diversi fini ultimi (il denaro, il piacere, il successo, etc.), ma ciò non toglie che il vero fine ultimo, quello commisurato alla natura umana sia uno solo.
Esso non può essere il piacere (comune agli animali), nè la ricchezza (che è puro strumento-per), nè il successo e la gloria, che sono esteriori all’uomo; esso è la realizzazione ciò che di più proprio abbiamo come uomini, e al contempo la più perfetta partecipazione possibile alla vita del Motore Immobile: la contemplazione della verità intelligibile; di fatto solo pochi uomini possono raggiungere tale fine ultimo
tutti invece possono coltivare le virtù, ognuna delle quali è giusto mezzo tra due estremi (esempio il coraggio lo è tra viltà e temerarietà)
politica.
L’uomo è per natura socievole la forma migliore di società è quella basata sul “giusto mezzo”: una “polis” non troppo grande nè troppo piccola, non governata nè da una troppo ristretta oligarchia nè dalla massa del popolo, incline a farsi condizionare dalle emozioni;
esistono differenze qualitative tra gli esseri umani: i liberi sono superiori agli schiavi, i greci ai barbari, gli uomini alle donne e ai figli.
LE OPERE
In diversi passi dei suoi scritti Aristotele parla di opere ” essoteriche ” ( exoterikoi logoi ) e in un brano della Poetica ( I 454b 15 ) usa nello stesso significato l’ espressione ” opere pubblicate ” ( ekdedomenoi logoi ) . Il riferimento é ad un complesso di libri destinati ad un pubblico più vasto della ristretta cerchia degli allievi , e perciò caratterizzati da una particolare cura per la forma , quella stessa che indusse Cicerone a parlare del ” flumen orationis aureum ” ( acad. II , 119 ) a proposito dello stile del filosofo . Di questi scritti nulla ci é rimasto , tranne una Costituzione di Atene , conservataci da un papiro egiziano , alcuni titoli e un certo numero di frammenti . Il corpus aristotelico a noi pervenuto é invece costituito dalle cosiddette opere ” acroamatiche ” ( cioè destinate all’ ascolto ) o ” pragmateiai ” , che si possono chiamare anche ” esoteriche ” , in quanto di uso esclusivamente interno alla scuola , il Liceo . Al primo gruppo , quello delle opere perdute , appartenevano alcuni scritti giovanili in forma dialogica , che anche nei titoli riecheggiavano opere di Platone ( Politico , Sofista , Menesseno , Simposio ) o comunque riprendevano argomenti tipici della speculazione di quello , come ” grillo ” o ” Sulla retorica ” , ” Eudemo ” o ” Sull’ anima ” , ” Sulla filosofia ” , ” Sull’ educazione ” , ” erotico ” , ” Sulla giustizia ” , ” Protrettico ” ( cioè esortazione alla filosofia ) ecc . Al suo regale allievo macedone erano indirizzati gli scritti ” Sulla monarchia ” e ” Alessandro ” o ” Sulla colonizzazione ” , mentre carattere essenzialmente erudito avevano alcune compilazioni come gli ” Elenchi dei vincitori dei giochi Pitici e Olimpici ” , ” Le vittorie alle Dionisie cittadine e alle Lenee ” e ” Le didascalie ” , che riportavano gli argomenti dei drammi partecipanti ai concorsi drammatici , con la data e il piazzamento ottenuto , mentre un’ opera di proporzioni gigantesche , realizzata con l’ apporto degli allievi , era la raccolta delle Costituzioni di 158 città greche , della quale faceva parte quella di Atene . Le opere esoteriche ci sono giunte ordinate secondo uno schema , che si apre con il cosiddetto Organon , comprendente gli scritti dedicati alla logica , concepita appunto come ” strumento ” ( organon ) indispensabile e preliminare alla speculazione filosofica : essi sono le Categorie ( di dubbia autenticità ) , sulle dieci definizioni dell’ essere ; ” Sull’ interpretazione ” , sulle parti e le forme della proposizione ; ” Analitici primi ” , in due libri , sul sillogismo ; ” Analitici secondi ” , anch’ essi in due libri , sulla teoria della conoscenza ; ” Topici ” in otto libri , sul metodo dialettico di argomentazione ; ” Confutazioni sofistiche ” . Seguono gli scritti dedicati alla fisica , intesa come scienza della natura , che comprendono la ” Fisica ” , in otto libri , sulla costituzione dell’ universo ; ” Sul cielo ” , in quattro libri ; ” Sulla generazione e sulla corruzione ” , in due libri ; ” Fenomeni metereologici ” , in quattro libri . Una sezione di questo gruppo di opere é dedicata allo studio del mondo vivente : a un’ introduzione di carattere generale , ” Sull’ anima ” in tre libri , segue una raccolta di nove opuscoli , di vario argomento , nota col titolo latino di ” parva naturalia ” ( ” brevi trattati di scienze naturali ” ) e una serie di scritti sul mondo animale ( ” Sulle parti degli animali ” , ” Sulla generazione degli animali ” , ecc. ) . Alla parte dedicata alla fisica segue , in 14 libri , quella che Aristotele chiamava ” filosofia prima ” , ma che é comunemente detta ” Metafisica ” , dalla posizione occupata all’ interno del corpus ( metà tà fusikà , dopo gli scritti di fisica ) . L’ opera , che dopo una storia della filosofia precedente passa a trattare la dottrina dell’ Essere , risulta costituita da parti composte in tempi diversi e non tutte autentiche , ma al di là delle oscillazioni di pensiero costituisce uno dei momenti chiave della speculazione aristotelica . La ricerca del bene individuale e di quello collettivo sono rispettivamente oggetto dell’ etica e della politica . La prima comprende tre scritti : ” Etica Nicomachea ” , in dieci libri , detta così da Nicomaco , figlio di Aristotele , che ne fu l’ editore ; ” Etica Eudemea ” , in sette libri , che per motivo analogo al precedente prende il nome da Eudemo , discepolo di Aristotele , ma non da tutti é ritenuta autentica ; ” Grande Etica ” , in due libri , meglio nota col titolo latino di ” Magna moralia ” e quasi certamente di redazione scolastica . In otto libri é la ” Politica ” , di cui taluni considrano le Costituzioni una sorta di lavoro preparatorio . Completano lo schema la ” Retorica ” , in tre libri , e la Poetica , in due libri di cui ci é giunto solo il primo . A queste opere vanno aggiunte quelle che , pur presenti nel corpus , sono quasi concordemente ritenute spurie e tra le quali possiamo ricordare ” Sull’ universo ” , ” Sullo spirito ” , ” Sui colori ” , ” Sulle piante ” , ” Problemi ” , ” Retorica ad Alessandro ” , ecc. Il modo in cui questo secondo gruppo di scritti ci é pervenuto é quanto mai avventuroso : lasciati da Aristotele in eredità al suo successore Teofrasto e da questo a un altro allievo , Neleo di Scepsi , rimasero nelle mani dei discendenti di costui , che per un certo periodo li nascosero addirittura in un sotterraneo per sottrarli ai sovrani di Pergamo , i quali avrebbero voluto collocarli nella loro biblioteca . Acquistati poi dal bibliofilo Apellicone di Teo , furono infine ritrovati ad Atene da Silla durante la guerra militare ( 86 a.C. ) e portati a Roma , dove vennero pubblicati da Andronico di Rodi .
LA CONOSCENZA
Nella “Metafisica” Aristotele argomenta che l’uomo per sua inclinazione naturale aspira alla conoscenza e traccia dunque una scala gerarchica della conoscenza (un pò come aveva fatto Platone ) : man mano che si sale ogni gradino è caratterizzato da un approfondimento rispetto al precedente . Al gradino più basso troviamo 1)la SENSAZIONE : ricordiamoci che Aristotele ha della conoscenza una concezione empiristica : la mente umana prima delle sensazioni è una “tabula rasa” (una tavola incerata schiacciata e rinnovata) : prima dell’esperienza sensuale non c’è nulla (a differenza di quanto diceva Platone , che era un innatista) ; in Aristotele c’è un rifiuto radicale della concezione innatistica : la conoscenza ci deriva interamente dall’esperienza sensuale.Per Platone l’esperienza sensuale c’era , ma era una concausa : era infatti semplicemente un modo per realizzare la reminescenza . L’opposizione Platone – Aristotele è davvero forte : ancora oggi c’è chi è innatista (e sostiene che nasciamo già con alcune cose nella testa) e chi è empirista (ed è del parere che la nostra mente è una tabula rasa).In realtà la filosofia successiva non sarà nient’altro che una variante di posizioni aristoteliche o platoniche . E’ come se questi due grandi filosofi avessero tracciato i due modelli per filosofare .Le sensazioni sono quelle che l’uomo ha in comune con gli animali : per Aristotele ci sono due tipi diversi di anime : un tipo , più complesso , ed un altro , più semplice. L’anima dei vegetali , per esempio , non prova sensazioni , mentre quella dell’uomo e dell’animale prova sensazioni : è proprio il poter provare sensazioni che funge da punto di partenza per la conoscenza.Aristotele attribuisce grande importanza all’udito (organo con cui si possono ascoltare i discorsi : malgrado Aristotele sia più “libresco” di Platone , in lui non troveremo mai una polemica contro gli scritti : anzi , l’idea che per studiare ci si debba servire di libri è tipicamente aristotelica ) e questo significa che ai suoi tempi l’oralità era ancora importantissima . Però per Aristotele l’organo di gran lunga più importante era la vista perchè più di ogni altro consente di distinguere gli oggetti : non a caso conoscere significa proprio distinguere , definire : ad un livello empirico la prima separazione è la distinzione degli oggetti sensibili . Però il grosso limite della sensazione è che fa cogliere solo il fatto , il che (in greco l'”oti”) e non il perchè (il “dioti”) : per arrivare al perchè bisogna seguire un lungo percorso .2) Al secondo gradino Aristotele mette la MEMORIA : l’intelligenza si può sviluppare se accanto alla sensazione c’è la memoria : gli animali non riescono a conservare la singola esperienza e così non hanno intelligenza . La memoria consiste proprio nel conservare le singole esperienze , nel ricordare le sensazioni . 3) Al terzo gradino Aristotele pone l’ESPERIENZA : essa non è la singola sensazione , bensì l’accumularsi di sensazioni grazie alla memoria : questa è l’esperienza : mettendo insieme una serie di casi singoli si riesce ad arrivare ad una prima forma di generalizzazione . Se si ha avuto a che fare con malattie e cure , si avrà una generalizzazione e si saprà come agire nel caso si ripresentino : mi sono accorto che una medicina giova ad una determinata persona , poi ad un’altra e poi ad un’altra ancora tutti accomunati dalla stessa malattia , anche somministrandola ad un’altra persona otterrò gli stessi risultati . Chi ha esperienza medica e ha visto che certe medicine hanno giovato a più persone con una stessa malattia è arrivato a dire che a chi ha tale malattia va somministrata tale medicina : questa però non è ancora la “scienza” vera e propria . Si ha una vera conoscenza quando si può dire che la determinata malattia va curata con una determinata medicina perchè va ad operare su determinate cose , organi…Con la scienza si arriva al “dioti” puro ; mentre con l’esperienza intuisco che una determinata medicina giova in certi casi , con la scienza riesco a fornire delle motivazioni : ad esempio , tramite la scienza so che l’aspirina ha un effetto anticoagulante e che di conseguenza posso prevenire e curare l’infarto : non dico più che in certi casi ha funzionato e che quindi anche qui deve funzionare , bensì che avendo un effetto anticoagulante curerà e gioverà a tutti coloro che han l’infarto . Si passa così dall’oti al dioti : quelle persone sono guarite perchè hanno quella determinata malattia e questa medicina la cura. Si passa quindi dal particolare all’universale : il vero passaggio è quando da un pò di casi riesco a cogliere il significato universale : non parlo più di individui che hanno certi sintomi etc. , ma , per esempio , di diabetici.Da una collezione di casi particolari raggiungo una concezione universale.La scienza grazie all’esperienza mi dice che le malattie circolatorie si curano con l’aspirina e di conseguenza quell’individuo che soffre di cuore deve essere curato con l’aspirina : con una serie di esperienze raggiungiamo la scienza . Aristotele , poi , afferma che coloro che sono esperti , che hanno acquisito tante esperienze , sono migliori rispetto a quelli che hanno studiato e sanno solo il dioti : affinchè la scienza entri in funzione le esperienze sono fondamentali : esse ci consentono di riportare i casi singoli a verità universali . L’esperto ha solo la casistica , lo scienziato solo la scienza , la verità universale : nella pratica l’esperto va meglio fin tanto che lo scienziato non fa esperienze . Un medico che non abbia mai studiato medicina , ma che sia esperto (avendo già curato o operato) è di sicuro meglio di un medico che abbia studiato tutto ma che non abbia mai avuto esperienze di intervento . Il medico con scienza ed esperienza risulta a sua volta essere il migliore di tutti : l’esperienza è un insieme di casi da cui si possono trarre conclusioni generali operative : il buon medico deve sapere da casi particolari ricondursi a casi generali e viceversa . La “tekne” sembra essere molto vicina all’esperienza , ma in realtà comporta un coglimento della realtà universale , l’acquisizione del dioti e dell’oti . Da questi singoli casi si trae una verità di carattere generale : perchè in tutti quei casi va così ? Nel caso della medicina parliamo di eziologia , perchè si usa una determinata cura : se si sa calare l’universale nel particolare è già una buona cosa : perchè se io ho un ‘ottima conoscenza dell’universale (che ho ottenuto studiando sui libri) , ma poi non so calarla nel particolare , la mia conoscenza è inutile . In realtà si dovrebbe parlare di scienza applicata , di “tekne” . Aristotele sulle scienze fa una classificazione generale : 1) le scienze applicabili (quelle che mi consentono di produrre qualcosa) 2) le scienze NON applicabili (quelle che non mi fanno produrre niente) . A proposito delle “teknai” Aristotele effettua una tripartizione : ci sono le tecniche a)necessarie b)utili c)piacevoli . Esaminiamo le distinzioni : la tecnica di procacciarsi il cibo è senz’altro necessaria : occorrono conoscenze applicative per sapersi procacciare il cibo (Ippocrate diceva che occorreva pure la conoscenza di come cucinarlo , e questa è una scienza utile , non fondamentale) ; come esempio di “tekne” piacevole possiamo portare l’arte culinaria , che mira solo a soddisfare e a dare piacere al palato . La tekne per Aristotele non rappresenta comunque il livello più alto del sapere perchè è subordinata in ogni caso a fini diversi della conoscenza : è dall’esperienza che si genera la tekne , ma l’esperienza non è ancora tekne pura : la tekne è infatti caratterizzata dall’avere come oggetto della propria conoscenza l’universale : la medicina raggiunge il livello di tecne (e non più di semplice esperienza) quando è in grado di conoscere che un determinato rimedio non guarisce solamente Socrate e Platone , bensì ogni persona affetta da una determinata malattia . Il che significa che quel rimedio è efficace nella totalità o universalità dei casi in cui c’è quella malattia . Anche chi ha fatto esperienza sa che quel determinato rimedio è stato efficace in una pluralità di casi , ma non sa perchè (ha l’oti , ma non il dioti) . Secondo Aristotele al di sopra delle tecniche si colloca una forma di conoscenza che ha di mira soltanto se stessa : il sapere per il sapere , ossia la conoscenza disinteressata , libera da vincoli , non subordinata a fini esterni ad essa . Questa è la “sophia” , il sapere più sublime a cui mira la filosofia . Così Aristotele ha definitivamente staccato l’idea del sapere da come era in passato , dove il sapere veniva visto come legato e funzionale all’agire e al produrre . Per poter ricercare questo sapere disinteressato occorre quella che in greco era detta “scholè” , ossia l “otium” latino , il tempo libero da ogni attività lavorativa o pubblica . Dunque se è vero che tutti gli uomini per inclinazione naturale aspirano al sapere , è altrettanto vero che solo i filosofi realizzano in senso pieno questo fine iscritto nella natura dell’uomo . Ma perchè questo sapere che in fondo non serve a nulla è la cosa più importante ? E’ proprio il fatto di non servire a niente che lo innalza : una cosa che non serve è più nobile perchè non è legata al rapporto di servitù . Le sensazioni servono all’uomo e ne prova piacere : se per esempio avessimo la possibilità di conoscere la realtà senza vederla , non per questo vorremmo essere ciechi : nella vista consiste un piacere irrinunciabile . Questo “esperimento mentale” conferma le tesi di Aristotele . Comunque Aristotele crea anche una scala di acquisizione cronologica di queste teknai : le scienze necessarie sono le prime che l’uomo deve acquisire , in quanto gli consentono la sopravvivenza , poi deve acquisire quelle utili , che gli offrono comodità non fondamentali , ma importanti , ed infine quelle piacevoli (ed inutili) : possiamo riassumere così la scala di acquisizione cronologica :”primum vivere , deinde philosophare “: prima di tutto bisogna pensare alla vita (Aristotele si mostra ancoira una volta legato al mondo terreno) . Il fatto che vengano acquisite per ultime , non significa che le scienze piacevoli valgano meno , anzi sono le più preziose in assoluto . Le prime scienze che acquisiamo sono le esperienze , ma le più importanti sono le scienze universali , che consentono una visione di insieme . Come abbiamo detto , le conoscenze piacevoli si sviluppavano nella “scholè” : per noi il non fare niente è un concetto negativo prima che sul piano morale-assiologico , su quello ontologico : nel non far niente vi è la mancanza di qualcosa . Per i Greci e per i Latini era diverso : la “scholè” era quella parte dell’esistenza in cui ci si dedicava all’attività studiosa.
LA CONCEZIONE DEL CITTADINO
Per noi moderni il non fare niente è un concetto negativo prima che sul piano morale-assiologico , su quello ontologico : nel non far niente vi è la mancanza di qualcosa . Per i Greci e per i Latini era diverso : la “scholè” era quella parte dell’esistenza in cui ci si dedicava all’attività studiosa . E’ interessante come Aristotele insista su questa forma di studio disinteressato e affermi ripetutamente che questa sia la più nobile delle vite . Questo è dovuto a due fattori : 1) la mentalità greca generale (come quella Latina) era propensa ad esaltare l’ozio 2) tra Platone e Aristotele c’è una grande differenza : secondo Platone si deve arrivare alle conoscenze supreme , al mondo intellegibile ; per Aristotele le conoscenze sono sensibili e presenti su questo mondo . Quando delineano il modello di vita da seguire , Platone traccia il percorso volto al raggiungimento del bene in sè (si vede comunque nel mito della caverna che i filosofi devono ritornare sulla terra a governare : il punto di arrivo è il re-filosofo) ; per Aristotele non è così : riconosce il modello dell’uomo cittadino , ma l’uomo più elevato sarà lo studioso , colui che si dedica all’otium e non al negotium : come mai ? Ricordiamoci che Aristotele vive dopo Platone , in un’epoca in cui la polis è in crisi (per Platone e Socrate era scontato che l’uomo ed il cittadino fossero un tutt’uno ) : vi è un progressivo scollamento da Socrate in poi tra uomo e cittadino , che un tempo erano indivisibili : Socrate aveva voluto morire , mentre Platone si era reso conto che la politica fosse ingiusta e aveva spostato la figura del politico nel mondo ideale : Sofocle in persona aveva notato questo progressivo scollamento uomo-cittadino . Per Aristotele non solo l’uomo può essere uomo senza essere necessariamente cittadino , ma anzi nella dimensione in cui non è cittadino è migliore : questa teoria avrà gran successo e prenderà piede (pensiamo agli epicurei ed al loro motto “lathe biosas” , ” vivi di nascosto ” : l’uomo per essere felice deve vivere lontano dalla politica , in privato ).Quindi possiamo provare a tracciare una graduatoria del graduale staccamento uomo – cittadino : a) in Socrate c’è piena identificazione b) in Platone c’è sì identificazione , ma non in questo mondo (in quello delle idee) c) Aristotele apprezza la vita politica , ma non c’è più l’identificazione tra uomo e cittadino d) in Epicuro c’è un totale rifiuto della figura uomo-politico associata . Va poi ricordato che Aristotele era uno straniero e non poteva svolgere vita politica : è quindi evidente che non si sentisse uomo-cittadino , ma tuttavia questo è l’aspetto meno imprtante che determinò lo scolllamento aristotelico tra uomo e cittadino .Dalla fine del quinto secolo fino al terzo si arriva ad un rifiuto della politica : la filosofia nasce quando le civiltà si sviluppano e un gruppo sociale (i filosofi) può vivere senza lavorare .
LE SCIENZE
Aristotele distingue due grandi classi di scienze : quelle che hanno come oggetto il necessario e quelle che hanno come oggetto il possibile . Osserviamo qui sotto lo schema generale
Le prime sono dette scienze TEORETICHE e riguardano appunto ciò che è o ciò che avviene necessariamente sempre o per lo più (in greco “epì polù”) nello stesso modo . Per necessario intendiamo ciò che non può essere o avvenire diversamente da come è o avviene . Si tratta dunque di domini di oggetti o eventi caratterizzati da una regolarità totale o con scarse eccezioni : la matematica rientra nelle teoretiche perchè 2 + 2 mi darà sempre 4 e non si può fare nulla se non indagare a fondo . Il mondo biologico rientra anch’esso nelle teoretiche ma nella “sezione” epì polù (per lo più ) . L’epì polù lo possiamo definire come un surrogato delle scienze
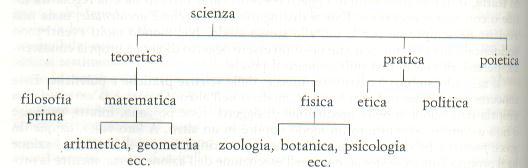
matematiche , che vanno sempre allo stesso modo : Aristotele studiò anche le generazioni e si accorse che non sempre riuscivano bene : gli individui di solito (per lo più) vengono in un modo , ma può succedere che vada diversamente e che abbia storpiature , deformità . Come nel caso delle generazioni , così anche nel mondo molti avvenimenti sono accidentali ma non sono studiabili perchè di essi non si può indicare il dioti (il perchè) . Il secondo ambito è invece costituito dalle scienze PRATICHE e POIETICHE : esse concernono ciò che può essere in un modo o nell’altro ; questa è la caratteristica propria dell’ azione e della produzione di oggetti : esse infatti possono avvenire o non avvenire , avvenire in un modo o in un altro . A loro volta azione (praxis , da qui pratiche) e produzione (da poieo , da qui poietiche) si distinguono per il fatto che l’azione ha il proprio fine in se stessa , ossia nell’esecuzione dell’azione stessa , mentre la produzione ha il suo fine fuori di sè , ossia nell’oggetto che essa produce . L’etica è una scienza pratica : il suo fine è in se stessa ed è il comportamento ; la poesia è una scienza poietica perchè mi fa produrre poesie : il suo fine sta al di fuori di sè . Tuttavia Aristotele non ci parla molto delle poietiche perchè non lo interessavano molto : ricordiamoci che per lui la vita migliore è quella del filosofo , mentre quella dell’artigiano che produce non è valutata positivamente (come d’altronde non lo era in tutto il mondo greco) . L’unica scienza poietica valida ed utile era per Aristotele la poesia , della quale ci parla ampiamente nella “Poietica” , opera che però non ci è pervenuta interamente : pare che ce ne fosse un altro libro che non fu mai ritrovato e sulla cui ricerca ruota “Il nome della rosa” di Umberto Eco . Per Aristotele il concetto di poietica era molto legato a quello di tragedia : la poietica infatti la si può estendere a qualsiasi forma di creazione artistica : è la conoscenza che genera qualcosa . Ritorniamo ale scienze teoretiche , il cui fine è la verità e la cui base è il sapere per il sapere : Aristotele effettua una tripartizione : le scienze teoretiche sono 1) FISICA 2) MATEMATICA 3)FILOSOFIA PRIMA .Parliamo di esse a seconda degli oggetti che studiano . Della fisica Aristotele ne parla come filosofia seconda : essa studia oggetti che esistono di per sè , ma sono mutevoli . La matematica studia oggetti immutabili , ma che di per sè non esistono . La filosofia invece studia oggetti che non si muovono ed esistono di per sè .Per Platone erano sostanze in senso pieno le idee , mentre il mondo sensibile era un essere depotenziato : Aristotele costruisce una filosofia più vicina al senso comune : egli si chiede : ” quali tipi di sostanze esistono ? ” Arriverà a dimostrare l’esistenza di cose immmateriali , come Dio , ma egli parte dicendo che senz’altro tutte le cose materiali che vediamo intorno a noi esistono ; per Aristotele non esistono da soli e separatamente quelle cose che per Platoneesistevano (in particolare quelle caratteristiche quantitative che Platone diceva esistere di per sè) , come gli enti matematici , i numeri : per Platone c’era il triangolo in sè e poi gli altri triangoli sensibili . Per Aristotele è l’opposto : esistono i triangoli materiali e poi quello immmateriale , che però non può mai esistere come realtà autonoma . Platone aveva minuziosamente dimostrato che noi quando dimostriamo ci riportiamo all’idea di triangolo . Per Aristotele esistono prima i triangoli materiali e poi quello immateriale : quello “ideale” per Aristotele non è nient’altro che una nostra creazione , siamo noi che facciamo un’astrazione : esso esiste solo come risultato di un processo di astrazione da noi operata . Due libri hanno la forma di parallelepipedo : Platone direbbe che imitano l’idea di triangolo . Per Aristotele no , è l’opposto : si fa un processo di astrazione dove poco per volta si tirano fuori le caratteristiche : i due libri non hanno colori uguali , quindi tolgo i colori ; hanno scritte diverse , quindi tolgo le scritte ; sono imprecisi , tolgo le imprecisioni ; privato di tutte le caratteristiche mi rimane solo più la forma di parallelepipedo : il processo consiste essenzialmente nell’asportare via le differenze tra i due libri . Diciamo che la matematica indaga cose che di per sè non esistono perchè le si creano con l’astrazione e cher indaga cose immutevoli perchè il parallelepipedo è sempre esistito . Per Platone il parallelepipedo esiste nell’iperuranio , per Aristotele nel mondo terreno , nei due libri , per esempio . La fisica studia quel mondo fisico che Platone non amava : le sostanze materiali che di per sè esistono ma sono mutevoli . In particolare la fisica studia gli enti naturali . La filosofia prima è anche chiamata metafisica (abbiamo già spiegato il perchè) Che cosa studia ? Ci sono due modi per definire l’oggetto dello studio della filosofia prima : a) Gli oggetti che esistono da soli come le cose sensibili e sono però immutabili come i numeri della matematica : la filosofia prima assumerà poi le istanze di teologia perchè è solo la divinità che è immutabile ed esiste di per sè . b) E’ comunque anche un’ontologia perchè studia pure l’essere in quanto essere (quest’espressione , essere in quanto essere , fu proprio creata da Aristotele) . Non si occupa di un tipo particolare di essere . Lo studio degli animali in quanto animali è la biologia , quello dei numeri in quanto numeri è la matematica , e così via .La filosofia prima invece studia simultaneamente un solo oggetto (la divinità) e tutti gli oggetti per la loro caratteristica di essere . Aristotele discute poi dell’infinito nel contesto matematico : egli nega l’esistenza dell’infinito , che negherà anche parlando di cosmologia : il cosmo è una cosa finita . L’infinito per Aristotele esiste solo potenzialmente , ma non è mai effettivamente attuabile . Non esiste come realtà fisica e neanche come realtà matematica : esiste solo potenzialmente . Concentriamoci sul contesto matematico : Aristotele sa bene che ogni numero è aumentabile di una unità : l’infinito numerico è però solo potenziale : si usano sempre e solo numeri finiti che si possono aumentare di una unità : non c’è mai in atto un numero infinito , solo potenzialmente c’è . L’infinito esiste anche nell’infinitamente piccolo (sempre potenzialmente) : si può dividere all’infinito , ma comunque in realtà non si trova mai un numero infinito . Bisogna precisare che Aristotele aveva una concezione CONTINUA della realtà e non discreta (come invece aveva Democrito ) : per Aristotele i numeri non sono infinitamente divisibili (va detto che all’epoca non si conoscevano le frazioni ). L’infinito potenziale esiste , sia nel piccolo sia nel grande ; questo però vale solo per la matematica , perchè invece nel mondo fisico non c’è neppure in forma potenziale . Le considerazioni di Aristotele sulla matematica sono state importantissime per la storia tant’è che ancora oggi abbiamo una concezione della matematica che ci deriva da Aristotele : per noi , come per Aristotele , i numeri sono astrazioni e non realtà di per sè esistenti (come era invece per Platone : il due esisteva perchè imitava l’idea di due) : per Platone il due di per sè non esiste : lo si ricava tramite quel processo di astrazione che abbiamo prima spiegato : ci sono due libri , due penne … Comunque ancora oggi la questione non è stata risolta e c’è ancora chi sostiene che i numeri esistano davvero come realtà a sè stanti , schierandosi così dalla parte di Platone : il ragionamento che li porta a dire che esistano indipendentemente dalla realtà è riassumibile in questi termini : se nessuno contasse più , i numeri continuerebbero ad esistere ? I semiplatonici dicono di sì . Però ad Aristotele la matematica non interessa molto , a differenza di Platone che era legato ai Pitagorici : la fisica aristotelica torna ad essere una fisica puramente qualitativa . Se ci chiedessimo se nella concezione della realtà è più moderno Platone o Aristotele la risposta non sarebbe facilissima : Aristotele riconosce un’autonomia del mondo fisico (indipendente dal mondo delle idee) ; però Platone ha un carattere quantitativo nello studio della realtà : lo si può definire un precursore della fisica moderna ; per Platone infatti non si può studiare il mondo sensibile senza applicare la matematica . Il motore che avvia la ricerca del sapere è ravvisato da Aristotele nell meraviglia , nel meravigliarsi e nel chiedere “perchè ?” . La meraviglia dà quindi avvio ad una ricerca volta a dare risposta a questa domanda e segna la transizione dal che (l’oti) al perchè (il dioti) . Per Aristotele la scienza trova la sua espressione nel linguaggio e precisamente nei discorsi . Nei dialoghi la logica svolge un ruolo fondamentale : essa era stata inventata in epoche precedenti ad Aristotele ; pensiamo a Parmenide (identità , contraddizione) o a Platone (soprattutto nel “Sofista” ) : però non era ancora chiaro fino in fondo il carattere formale della logica : veniva solo applicata ad aspetti concreti . Aristotele invece è stato l’inventore di un metodo : la sostituzione delle proposizioni con le lettere (cosa che si usa adesso soprattutto in matematica) : a è un numero qualsiasi , non si sa quale , ma sarà sempre quello . Ciò implica la possibilità di studiare le strutture a prescindere dai contenuti . In realtà la parola “logica” è stata coniata dagli Stoici ed ha avuto gran successo : la logica è quella che studia il “logos” , il pensiero . In realtà Aristotele la chiamava ANALITICA (dal greco analuo , ana+luo = scomporre una realtà complessa nei suoi elementi : proprio come le proposizioni sostituite dalle lettere ) . Come detto , la logica non rientra nelle scienze perchè non è scienza , però è lo strumento delle scienze : mi consente di verificare la coerenza dei passaggi logici : essa di per sè non ha nessun oggetto . Logica deriva da logos , termine che significa tanto discorso quanto pensiero : è come se prima di parlare ad alta voce si parlasse dentro di noi ; lo studio di Aristotele in teoria studia , indaga il pensiero ma in realtà studia il linguaggio perchè non si può avere accesso alle menti altrui per indagare il pensiero . Successivamente la logica diventerà studio dei diversi tipi di discorso . Accanto ai libri di logica , Aristotele ha scritto la “Retorica” : fa notare che noi siamo abituati a pensare che la forma classica del discorso è quella in cui si predicano il soggetto ed il predicato : esempio ” Socrate corre ” ; ” Socrate è ad Atene” .
L’ARTE E LA KATARSI
Per Aristotele il concetto di poietica era molto legato a quello di tragedia : la poietica infatti la si può estendere a qualsiasi forma di creazione artistica : è la conoscenza che genera qualcosa . A riguardo dell’opera d’arte e della tragedia erano già state formulate due importanti tesi : a) Gorgia , il cui giudizio era stato fortemente positivo : in assenza di un modello da imitare (per lui l’essere non esisteva e tutto era falso) , l’artista è colui che crea nuovi mondi ed è tanto più bravo tanto più riesce ad ingannare gli spettatori . b) Platone , il cui giudizio non era certo stato positivo : per lui l’arte e la tragedia erano copie di copie , vale a dire copie del mondo sensibile che a sua volta è copia del mondo intellegibile . Si aggiungeva poi la crisi sul piano morale : l’arte fomenta e stimola la passioni inducendo i giovani (e non solo) ad avvicinarsi ad esse . Aristotele assume una nuova ed importantissima posizione : egli rivaluta l’arte (ed in particolare la tragedia) sia sotto il profilo ontologico sia sotto quello etico : sul iano ontologico Platone diceva che era imitazione di imitazione , Aristotele fa notare che la tragedia ha per lo più come argomento il mito , che racconta cose non vere : i prsonaggi sono dei “tipi umani” . La tragedia , dice Aristotele , descrive il verosimile : non ci dice cosa ha fatto quella determinata persona in quel frangente , ma cosa farebbe qualsiasi persona in quel caso . Ci presenta non il vero ma il verosimile : questo per Aristotele è un elemento che conferisce un valore particolare : ricordiamoci che la vera scienza per Aristotele è scienza dell’universale e non el particolare : la tragedia ha quindi una valenza conoscitiva ed è molto migliore della storia : la storia infatti non mette mai di fronte all’universale , bensì racconta le gesta dei singoli : mi racconta casi particolari e non universali . La tragedia ha quindi una valenza filosofica perchè mi mette di fronte a casi universali.La tragedia è imitazione in forma drammatica e non narrativa di un’azione seria e compiuta in sè attraverso una serie di avvenimenti che suscitano pietà e terrore : il suo contenuto è un mito . Da qui in poi si rivaluterà completamente l’arte che Platone aveva disprezzato . Per dirla alla Platone , l’arte per Aristotele non imita il mondo sensibile , ma le idee stesse : imita infatti l’universale . Esaminiamo ora l’aspetto etico-morale dell’arte : come Platone , così anche Aristotele sostiene la metriopazia ( il controllo , la misura delle passioni) e non l’apazia (la privazione delle passioni ) : la valutazione della tragedia da parte di Aristotele è antitetica rispetto a Platone anche sul piano etico : Platone diceva che stimolava alle passioni e che quindi andava abolita , Aristotele introduce la KATARSI artistica : (parola che deriva dalla medicina , suo padre era medico , e risente del suo interesse biologico : katarsi significa “purga” e più in generale “purificazione” : è il meccanismo con cui ci si purifica dalle sostanze dannose ) : chiaramente è una metafora . Ma che cosa intende Aristotele per purificazione ? Il passo in cui ci parla della katarsi è molto breve (ricordiamoci che erano appunti) complesso e quindi è difficile capire se intenda purificazione dAlle passioni o dElle passioni : Se fosse dAlle passioni , sembrerebbe che con la tragedia ci si libera dalle passioni , il che è una contraddizione ; quindi Aristotele intendeva purificazione dElle passioni : nella tragedia infatti vengono messe in gioco passioni negative , spaventose : Platone le rifiutava totalmente perchè pensava che vedendole si stimolassero e nascessero in chi le vedeva ; Aristotele , invece , scopre che vedere in scena certe passioni ha l’effetto di oggettivarle e di far sì che l’individuo possa riuscire a controllarle : ancora oggi gli psicologi mirano quando i pazienti sono afflitti da ansie a farle uscire , a tirarle fuori , a far prendere coscienza al paziente delle proprie ansie : il fatto di guardarle in faccia , a tu per tu , consente di controllarle e di razionalizzarle . Vedere sulla scena , in un situazione in cui si oggettiva e si vede con un certo distacco , permette di razionalizzare le passioni . Il processo della katarsi consente all’uomo di vivere meglio le passioni negative , il terrore inducendolo a guardarsene .
I SILLOGISMI
Accanto ai libri di logica , Aristotele ha scritto la “Retorica” : fa notare che noi siamo abituati a pensare che la forma classica del discorso è quella in cui si predicano il soggetto ed il predicato : esempio ” Socrate corre ” ; ” Socrate è ad Atene” …Le proposizioni costituite da predicato e soggetto sono chiamate APOFANTICHE (o dichiarative : dicono qualcosa di qualcosa) : queste proposizioni sono le uniche che possono essere o vere o false : se dico “il libro è sul tavolo ” può essere vero (se effettivamente il libro è sul tavolo) , ma anche falso (se non è sul tavolo) . Le preghiere , le esclamazioni , le domande , i comandi non dichiarativi : non sono nè veri nè falsi ; se dico “oimè ” non è nè vero nè falso . La retorica può rivolgersi sia al passato (valuto , per esempio , le imprese di un uomo) sia al presente (lodo le caratteristiche di una persona , per esempio) sia al futuro (impartisco comandi) : sono i discorsi suasori , dove l’importante è la tecnica del persuadere ; Aristotele però non si rivela molto interessato ai discorsi suasori , che non sono nè veri nè falsi . Dire ” Socrate è un uomo” non è un ragionamento , ma una proposizione (apofantica) che può essere o vera o falsa . Un ragionamento invece è una catena di proposizioni e Aristotele lo chiama ” SILLOGISMO ” (sun + lego = ragionamento concatenato) ; un sillogismo è costruito da due premesse e una conclusione . Le proposizioni sono anche scomponibili ; le parti che costituiscono una proposizione sono il soggetto ed il predicato , e dato che sono gli estremi della proposizione vengono chiamati “termini della proposizione” . Le proposizioni possono essere divise sotto tre aspetti : 1) QUANTITATIVO 2)QUALITATIVO 3) MODALE . 1) Sul piano quantitativo , le proposizioni possono essere universali o particolari .Se dico “tutti gli uomini sono mortali” è universale ; se invece dico “alcuni esseri viventi sono animali” è particolare. Nel primo caso dico che tutti , senza eccezioni , gli uomini sono mortali . Nel secondo caso dico alcuni . Aristotele nell’ambito delle quntitative riconosce anche le “individuali” , per esempio “Socrate è uomo ” il soggetto non ha valenza nè universale nè particolare , bensì individuale o particolarissimo . Un termine individuale in una proposizione non può mai fungere da predicato , ma solo da soggetto . Invece , i termini che rientrano a costituire le proposizioni della scienza possono fungere sia da predicato sia da soggetto : sono quindi termini universali (ad esempio “uomo”) . 2)Sul piano qualitativo , possono essere affermative o negative : sia le universali sia le particolari possono essere sia negative sia affermative ;universale affermativa “tutti gli uomini sono mortali” ; particolare affermativa “alcuni esseri viventi sono mortali” ; universale negativa : “Nessun uomo è bianco” ; particolare negativa “qualche uomo non è bianco ” . 3) Sul piano modale , le proposizioni possono essere a) possibili b) contingenti c) impossibili d) necessarie : a)non è in un modo , ma potrebbe esserlo (non piove ma potrebbe cominciare) b) è l’opposto del possibile : è in un modo , ma potrebbe non esserlo (piove , ma potrebbe non piovere) c) ciò che non è che non può essere d) ciò che è e che non potrebbe non essere . Le modali stanno tra loro a 2 a 2 : l’impossibilità è una forma di necessità : dire che una cosa è impossibile significa dire che è necessario che non sia .Nel “Parmenide” di Platone questo concetto emergeva molto bene : la necessità è ciò che è e che non può non essere . La logica ci consente di studiare la struttura del pensiero e di cogliere gli aspetti formali , evitando così di incappare in errori formali : essa ci permette di fare ragionamenti coerenti .L’unico modo per non fare errori di ragionamento è separare la forma dal contenuto . Aristotele dice che le proposizioni possono essere CONTRADDITORIE o CONTRARIE : le contrarie hanno la prerogativa di non poter essere entrambe vere , ma di poter essere entrambe false : per esempio le proposizioni “tutti gli uomini sono bianchi” e “nessun uomo è bianco” sono tutte e due false , in quanto qualche uomo è bianco e qualche altro non lo è . Le contrarie però accettano una via di mezzo : in questo caso la via di mezzo è “alcuni uomini sono bianchi” : un buon modo per cogliere due proposizioni contrarie è vedere se hanno una via di mezzo. Le contradditorie invece hanno la prerogativa di essere necessariamente una vera e l’altra falsa : “tutti gli uomini sono bianchi” , “qualche uomo non è bianco” : se la seconda è vera , la prima non lo è .Questa divisione aristotelica tra proposizioni contrarie e contradditorie è di fondamentale importanza perchè noi nei ragionamenti talvolta traiamo conclusioni sbagliate perchè non abbiamo ben chiaro il funzionamento delle proposizioni : a volte diciamo che una cosa è falsa e argomentiamo che l’opposto è vero : questo vale solo per le contradditorie : è il principio della dimostrazione per assurdo . Se non mi accorgo che le proposizioni sono contrarie e ragiono così sbaglio clamorosamente : ad esempio , ” Stalin è un imbecille” : questo non mi consente di dire ” Hitler è intelligente” : sono due contrarie e quindi ci deve essee una possibilità intermedia . Finchè le forme del pensiero sono intrecciate col contenuto , i ragionamenti sono incoerenti : per ragionare bene bisogna separare la forma dal contenuto , un pò come nella matematica con le lettere , dove si vede il ragionamento allo stato puro . La logica si muove su tre livelli 1) TERMINI : come abbiamo detto sono il soggetto ed il predicato : i termini non sono mai nè veri nè falsi , solo le proposizioni possono essere vere o false : se dico “uomo” non è nè vero nè falso , ma se dico “l’uomo corre” può essere falso ; anche se dico una cosa che non esiste come l’ippogriffo , un animale mitologico , non è sbagliato : infatti costruendo la proposizione potrò dire “l’ippogriffo non esiste ” ed è giusto , oppure “l’ippogriffo esiste” ed è sbagliato . 2) le proposizioni , che sono le uniche che possono essere o vere o false . 3) I sillogismi , dati da due premesse e una conclusione : essi non sono nè veri nè falsi , ma coerenti o incoerenti : tutto dipende dalle premesse che avevo in partenza . Ad esempio, prendiamo due premesse sbagliate : “tutte le cose verdi sono vegetali” e “tutte le rane sono verdi” : con il sillogismo arrivo alla conclusione che tutte le rane sono vegetali , ma il sillogismo non è affatto sbagliato : sono sbagliate le premesse ! La conclusione è stata tratta correttamente sfruttando le premesse . si chiama premessa maggiore di un sillogismo quella che fornisce informazioni più generali , mentre premessa minore quella che fornisce informazioni più particolareggiate : ad esempio : premessa maggiore “tutti gli animali sono mortali” ; premessa minore “tutti gli uomini sono animali” ; conclusione “dunque tutti gli uomini sono mortali” . Questo sillogismo viene detto di “prima figura” : le premesse sono universali affermative ed il termine medio è “animali” , che nella prima frase è soggetto , nella seconda è predicato . Il termine “animali” è termine MEDIO perchè mi consente di collegare tra loro nella conclusione gli altri due termini che compaiono invece ciascuno in una sola delle premesse . Accanto a questa prima figura per Aristotele esistono altri due tipi di figure , che si distinguono in base alla posizione del termine medio come soggetto o predicato nelle premesse . Ciascuna figura a sua volta si può articolare in diversi “modi” , a seconda delle qualità delle premesse (affermative o negative) o della quantità (universali o particolari) . Ma solo la prima figura agli occhi di Aristotele è quella propriamente scientifica : essa infatti consente di rispondere alla domanda centrale della scienza “perchè ?” ; nel nostro caso se ci si chiede perchè tutti gli uomini sono mortali , la risposta è insita nel termine medio “animali” . E’ il fatto che gli uomini sono animali a spiegare il fatto che essi sono mortali . Il sillogismo partendo dalle premesse arriva a dimostrare che gli uomini sono mortali . Se le premesse sono vere anche la conclusione è necessariamente vera . Proprietà del sillogismo è infatti la trasmissione della verità dalle premesse alla conclusione.Il carattere universale delle premesse consente di raggiungere una conclusione universale e necessario e proprio della scienza è ciò che è vero universalmente in tutti i casi . Il termine medio gioca un ruolo fondamentale perchè mi consente di collegare le premesse per trarre la conclusione . Si possono anche analizzare le mansioni dei termini : il medio svolge le funzioni sia di predicato (tutti gli uomini sono animali) sia di soggetto (tutti gli animali sono mortali) : è proprio il fatto che in una proposizione il medio sia soggetto e nell’altra predicato che mi consente di trarre la conclusione corretta . Se il “medio” fosse solo predicato o solo soggetto in tutte e due le premesse non potremmo trarre conclusioni così semplici : se per esempio avessimo queste due premesse “tutti i vegetali sono verdi ” e “tutte le rane sono verdi” finiremmo per dire “tutte le rane sono vegetali” : il medio (rane) è soggetto in tutte e due le proposizioni . In questo caso teoricamente non lo si può neanche chiamare termine medio . La logica , come detto , ci consente di evitare errori perchè separa le forme dai contenuti ; nel passato ci fu chi disse “quel tale ha quel carattere ed è delinquente” “tu hai quel carattere” “di conseguenza sei delinquente” : è sbagliatissimi perchè il termine medio (carattere) è solo predicato . Secondo Aristotele il termine medio serve a spiegare il dioti , il perchè di un qualcosa . Si è però più volte notato che in realtà le conclusioni spesso non derivano dalle premesse : nel nostro caso per dire che gli uomini sono mortali non è necessario dire che sono animali e gli animali ono mortali : tutti sappiamo che gli uomini sono mortali anche senza effettuare questo ragionamento . Sappiamo per altre vie che l’uomo è mortale (per esempio per il fatto che tutti gli uomini esistiti sono morti) , però il sillogismo ci fa capire il legame logico tra le varie proposizioni : ci consente di acquisire il dioti e non solo l’oti ; sappiamo tutti che l’uomo è mortale , ma per capire il perchè occorre il sillogismo . Ciò che ci fa capire il perchè (ed in parte vi si identifica) è il termine medio : il puro e semplice oti (gli uomini sono mortali) non dimostra l’inutilità del sillogismo : è un pò come un sistema . In altre parole il sillogismo non ci fa capire la verità , ma i nessi tra le verità . Perchè gli uomini sono mortali ? La risposta è nel termine medio : perchè sono animali . La struttura del sillogismo è DEDUTTIVA : si parte da verità universali per dimostrare realtà particolari . Il termine deduzione deriva dal latino “deduco” (de+duco = tiro giù da una verità che sta più in alto una verità che sta più in basso) . Ma che origine hanno le premesse ? Possono avere due origini differenti : a) possono essere conclusioni : ogni premessa infatti può essere conclusione di altre premesse : è comunque un processo che non può andare avanti all’infinito . b) In molti casi le premesse generali derivano da processi induttivi (arrivo cioè da casi particolari a casi più generali) ; la conoscenza è un pò come un circolo , ma non vizioso : da casi generali si passa a casi più specifici e viceversa ; sarebbe un circolo vizioso se per arrivare a verità generali si dovessero analizzare tutti i casi : ad esempio se per dimostrare che “tutti gli animali sono mortali” dovessi esaminare uno ad uno tutti gli animali esistenti (ed esistiti) sono mortali : ma non è così ! Aristotele ritiene che mediante processi astrattivi , con un certo numeri di esempi si possa cogliere un’essenza generale comune a tutti gli elementi di una specie : come per Platone , anche per Aristotele esistono realtà universali che vengono compartecipate da tanti individui : per lui però sono forme e non idee: la forma uomo è in tutti gli uomini : se l’essenza uomo è caratterizzata dalla mortalità posso arrivare a tirar fuori da un pò di casi che tutti gli uomini sono mortali . Per capire questo non ho bisogno di andare a vedere che tutti gli uomini esistiti sono morti : da singoli casi con l’astrazione e cogliendo le caratteristiche (sfruttando solo quelle comuni) posso arrivare a dire che tutti gli uomini sono mortali : questo anche se analizzo solo tre uomini : tutti e tre han la forma uomo : se son morti quei tre tutti quanti gli uomini sono mortali : passo dal particolare all’universale . Anche Socrate , per dire , anche se adesso è ancora vivo , è un mortale perchè tutti gli uomini lo sono : dimostro con l’induzione . Quindi abbiamo detto che non è un circolo vizioso perchè non vado ad esaminare tutti gli uomini del mondo , ma solo alcuni : arrivo a dire che è mortale Socrate che non era nel gruppo di coloro che ho analizzato : però arrivo a dire che anche lui è mortale . Per Aristotele esistono gli UNIVERSALI , che a differenza di quanto era per Platone sono calati nella materia : se in un tale colgo l’essenza universale dell’uomo , questo processo vale per qualsiasi uomo . L’intelletto per Aristotele ha funzione DIMOSTRATIVA : consente , partendo da determinati principi , di arrrivare a conseguenze . Ma abbiamo detto che il sillogismo può essere di vari tipi : quello scientifico è quello che parte da premesse vere per arrivare a conclusioni vere . Aristotele fa notare che mentre se una premessa le conclusioni sono vere , se invece le premesse sono false non sempre le conclusioni sono false . Ad esempio , posso arrivae a dire che le rane sono verdi dicendo che sono vegetali . Tutte le rane sono vegetali , tutti i vegetali sono verdi , di conseguenza tutte le rane sono verdi . Si può in qualche misura argomentare in modo contrario : quando le conclusioni son false , allora anche le premesse sono false (argomentazione per assurdo) , ma se mi trovo di fronte a conclusioni vere non sempre le premesse sono vere . Il sillogismo scientifico presuppone che oltre al dimostrare correttamente , ci sia l’intelletto , il saper cogliere principi : c’è la dimostrazione come argomentazione , l’intelletto per cogliere principi : la scienza raccoglie ambedue . Il numero di casi per l’induzione non è sempre lo stesso : per i casi empirici ne occorrono un pò : Aristotele crede di poter stabilire una realazione tra il fatto che un animale sia longevo e il fatto che sia dotato di cistifellea : cita così diverse specie animali e la durata della loro vita . Ma in alcuni frangenti basta un caso solo : è il caso della geometria . Con l’induzione si arriva a tante cose : per Aristotele attraverso l’intelletto si arriva a principi comuni validi per tutte le scienze , e ad altri validi solo per alcune scienze : i principi della geometria per esempio riguardano solo le qualità spaziali . Facciamo un piccolo riassunto : il sillogismo è lo strumento principale della scienza : la scienza è quindi dimostrazione . Ma si può dimostrare tutto ? Nasce qui il problema dell’assunzione delle premesse ; certamente molte premesse di determinati sillogismi (come abbiamo già detto) sono a loro volta conclusioni di altri sillogismi , ma se si vuole evitare di andare all’infinito alla ricerca di premesse , che debbono costituire il saldo punto di partenza della scienza ,occorre rintracciare un tipo di premesse la cui verità non richieda necessariamente una dimostrazione . Occorre quindi uno strumento , diverso dalla dimostrazione , in grado di coglierle nella loro verità . A questa funzione presiede l’intelletto . Esso è dunque una disposizione non innata , ma acquisibile con l’esercizio , a cogliere l’universale per via non dimostrativa . Esso coglie i primi principi indimostrabili che stanno alla base di ogni scienza per via induttiva . Ecco quindi la distinzione di cui parlavamo tra principi propri di ogni singola scienza (quali per la geometria la definizione degli enti e delle figure geometriche , per l’aritmetica la definizione dei numeri in pari , dispari …) e i principi comuni a tutte le scienze (per esempio “il tutto è maggiore della parte” o “Se da uguali sono sottratti uguali , i resti sono uguali):essi hanno una caratteristica non devono essere dimostrati . Ciascuna scienza li usa in relazione agli oggetti specifici di sua competenza : per esempio la geometria in relazione alle grandezze geometriche , l’aritmetica in relazion ai numeri , e così via . Aristotele trova tre principi fondamentali da cui nessuna scienza può prescindere : 1) IDENTITA’ 2) CONTRADDIZIONE 3) TERZO ESCLUSO . 1) A è A e non può essere non-A 2)Aristotele dà 2 formulazioni a questo principio a)è impossibile che la stessa cosa sia e non sia al tempo stesso (sembra uguale a quello di identità , ma non lo è) b) è impossibile che una stessa cosa appartenga e non appartenga nello stesso tempo alla stessa cosa . c)A o è B o non è B : non c’è una terza possibilità : delle due proposizioni contradditorie una deve essere per forza vera . Questi sono i principi generaliossimi della logica : aristotele fa notare che non sono dimostrabili (come abbiamo detto anche noi) ; a rigore non si possono neppure cogliere bene per via induttiva . Aristotele argomenta in loro favore con la CONFUTAZIONE : non dimostra la verità , ma fa notare che sarebbe impossibile ragionare senza di loro ; non solo , è anche impossibile argomentare contro questi tre principi . E’ un caso di dimostrazione indiretta (quasi per assurdo) . Aristotele è il primo autore che ammetta una autonomia reciproca delle scienze : per Platone esisteva una sola scienza : chi sapeva i principi , sapeva tutto . Con Aristotele incomincia quel processo per cui le varie scienze hanno acquisito autonomia dal sapere centrale e dalla filosofia . In Aristotele la filosofia è la filosofia , ma poi c’è l’albero della scienza , dove c’è un tronco centrale ma anche tante ramificazioni . Aristotele riconosce sì una certa autonomia alle varie scienze , ma come i rami di un albero sono in stretto contatto con il tronco centrale , così le varie scienze sono imparentate con un tronco centrale : la filosofia e la logica : da notare che i principi della logica sono in buona parte gli stessi della filosofia . Prendiamo per esempio le tesi di Parmenide ed in particolare il principio della contraddizione : in termini logici si dice che non c’è contraddizione , ma sul piano filosofico-ontologico si dice che è impossibile che lo stesso soggetto abbia caratteristiche contradditorie : per noi come per Aristotele le leggi del pensiero e della realtà sono le stesse . Aristotele fa vedere cose della realtà anche nell’ambito della logica , in forma logica . A quei tempi tutto era diverso : pensiamo ai Pitagorici che si stupivano che ciò che scopriva la matematica corrispondeva alla realtà : il teorema di Pitagora vale su un triangolo astratto (sull’idea di triangolo, secondo Platone ) e poi su quelli reali .
LA DIALETTICA
In Aristotele la parola DIALETTICA ha significato diverso rispetto a Platone : per Platone era un sinonimo di filosofia , per Aristotele significa “ragionamento che implica una dimostrazione con gli altri” . Posso sì dedurre ed indurre da solo , ma la dialettica implica un rapporto con gli altri : è quel ragionamento che parte non da ciò che è vero perchè colto col sillogismo ed il ragionamento scientifico , ma da punti di partenza (premesse) prese per buone nel contesto in cui si parla : Aristotele dice “le premesse usate dai più o dagli esperti o dalla maggioranza degli esperti ” : non è una verità assoluta , ma un modo per cominciare la discussione di una tematica . E’ interessante notare che Aristotele abbia inventato il sillogismo ma che l’abbia usato davvero poco : usa di più gli argomenti dialettici : prende dei punti condivisi da molti e li discute : quando si cimenta nella ricerca delle quattro cause , parte dai punti di vista dei presocratici (coloro che vissero prima di Socrate ) .Agli occhi di Aristotele la conoscenza è una sorta di processo collettivo nel quale si trovano coinvolti gli uomini del passato e del presente . Quindi partiva dalle premesse dei suoi predecessori e ci ragionava sopra discutendo se potevano essere accettate o no . Aristotele crede di partire dai PHAINOMENA (“fenomeni” , ciò che appare all’esperienza) : questo conferma il fatto che Aristotele sia un empirista : per lui la mente è una “tabula rasa” da riempire con le esperienze . Comunque fanno parte dei “phainomena” non solo le esperienze , ma anche le opinioni altrui : Aristotele anche quando studia gli organismi riproduttivi , non si serve solo delle esperienze personali , ma anche dei pareri degli antichi . Lo studia comincia ad essere mescolanza di esperienze personali e ragionamenti con il libro : è proprio con Aristotele che il libro diventa strumento di sapere : ci fornisce quel materiale di elaborazione degli altri , ciò che è stato scritto . Ma se per conoscere si usano queste tecniche , il sillogismo che valore ha ? Il meccanismo per scoprire la verità è la dialettica , quello per stabilire i nessi delle realtà è il sillogismo , che ci fornisce il dioti .
ESSERE E SOSTANZA
A livello teorico abbiamo distinto fisica da metafisica : sia il sillogismo sia la dialettica rientrano nella metafisica , la pretesa di cogliere ciò che sta al di là delle cose fisiche . L’essenza c’è anche nella fisica . La fisica studia gli oggetti che esistono di per sè ma sono mutevoli (è l’opposto della matematica) ; la metafisica studia tutto l’essere in quanto essere ma anche l’essere che esiste ed è immutabile (la divinità) ; in pratica studiamo la metafisica come ontologia : se è studio dell’essere in quanto essere si occupa anche di oggetti fisici . Ma che cos’è l’essere ? L’essere può essere ricondotto alla sostanza . Dire “che cosa è l’essere?” si può ricondurre a “che cosa è la sostanza?” . Per rispondere Aristotele si pone un problema : ” essere” ha significato univoco o biunivoco ? (in realtà “biunivoco” e “univoco” sono termini medioevali) Aristotele risponde che non è nè univoco nè biunivoco , ha significati analogici ; a questo punto Aristotele fa un esempio servendosi dell’aggettivo greco “salutare” : è salutare tutto ciò che ha a che fare con la salute , il clima , una persona , un cibo … Il ragionamento che ne consegue è che se ci chiediamo se è univoco o biunivoco il significato dell’essere , dobbiamo rispondere che non è nè l’uno nè l’altro : non può avere sempre lo stesso significato , ma comunque i vari significati sono tra loro imparentati perchè si riferiscono tutti ad un unico concetto , la salute . L’essere è analogico : tutti i significati di essre si appoggiano alla “sostanza” , il significato più importante . Aristotele fa poi un discorso a cavallo tra realtà e logica : le cose possono avere una miriade di caratteristiche ; è vero che posso predicare in maniera sterminata , ma le tipologie si possono ridurre a poche possibilità , le CATEGORIE (in totale 8 o 10 : in realtà erano 8 , ma il 10 suonava meglio …):in Greco categoria significa “predicato” : le categorie sono quindi 8 tipi di predicazioni che si possono fare : prendiamo ad esempio Socrate : 1) SOSTANZA ? Socrate 2)QUANTITA’? Un metro e mezzo 3) QUALITA’ ? Bianco o filosofo 4) RELAZIONE ? Figlio di Sofronisco 5)LUOGO ? In carcere 6) TEMPO ? L’anno della morte 7) SITUAZIONE ? Star seduto 8) AVERE ? Un mantello (Aristotele ne aggiunge poi due giusto per far cifra tonda e arrivare a 10 : 9)AGIRE? Bagnare 10)SUBIRE? L’essere bagnato). Tra le categorie la più importante è appunto la sostanza : tutte la altre infatti devono per forza essere predicate di qualcosa , ossia appunto di una sostanza . Per esempio “bianco” o “un metro e mezzo” possono essere predicati alla sostanza “Socrate” .Il loro essere è sempre in riferimento ad una sostanza , e dipende da essa . Ma la stessa cosa non vale necessariamente per tutte le sostanze . A questo proposito Aristotele distingue nello scritto “Sulle categorie ” tra sostanze prime e sostanze seconde . La sostanza prima , per esempio “questo uomo qui” (l’individuo Socrate ) non può mai essere predicata di un’altra sostanza nè esistere in un’altra sostanza . Le sostanze seconde invece , ossia le specie (per esempio , uomo) e i generi ( per esempio , animale), possono essere predicate delle sostanze prime . Per esempio è possibile dire ” Socrate è uomo” . Secondo Aristotele , Platone aveva commesso l’errore di attribuire esistenza autonoma ai predicati , ossia alle sostanze seconde che in realtà esistono soltanto in riferimento a sostanze individuali .Ma viene spontaneo chiedersi quale sia la differenza tra universale e sostanza : Aristotele stesso si pone questa domanda e cerca di dare una risposta ne “La metafisica” ; egli dice che la sostanza di una cosa è quella che è caratteristica di quella cosa , che non inerisce ad un’altra cosa . L’universale invece è comune , perchè infatti si dice universale ciò che per natura inerisce a più cose . Quindi di che cosa sarà sostanza l’universale ? Infatti l’universale o sarà la sostanza di tutte le cose alle quali inerisce , o non sarà la sostanza di nessuna . Ma non può essere la sostanza di tutte ; se sarà la sostanza di una sola cosa , allora anche tutte le altre cose saranno quest’unica cosa , poichè le cose che hanno un’unica sostanza ed un’unica essenza sostanziale sono esse stesse un’unica cosa : è un ragionamento per assurdo , si assume cioè come premessa che l’universale sia sostanza . Inoltre si dice sostanza ciò che non può essere predicato di un soggetto (nel caso delle sostanze prime) , mentre l’universale si predica sempre di un soggetto . Aristotele arriva alla conclusione che gli universali (che Platone chiamava idee) non possano esistere separatamente dalle sostanze : “uomo” non esiste come entità separata dalle sostanze singole , ” Socrate ” , ” Platone ” , ” Gorgia ” … Ci sono 8 modi per dire l’essere ma non equivoci : tutti si riconnettono all’essere come sostanza : perchè? Non esistono le qualità al di fuori delle quantità : pensiamo al quadrato : di per sè non esiste , esiste solo come processo di astrazione di un libro per esempio . Il libro è blu : il blu esiste sempre nella misura in cui inerisce alla quantità (il libro) : il libro esiste di per sè sempre . Le categorie risultano dunque 7 + 1 (la sostanza) . Ci sono poi le cose che esistono come qualità delle sostanze (il blu , il quadrato …)Il significato principale dell’essere è la sostanza : ma più precisamente la sostanza individuale ; emerge qui un’altra grande differenza tra Platone e Aristotele : per Platone esistevano più gli universali (le idee) che gli individuali : l’idea di cavallo esisteva più del cavallo stesso : le idee si calavano nel mondo sensibile . Per Aristotele invece esistevano di più gli enti empirici rispetto a quelli astratti : ciò che una cosa è sta nella cosa stessa e non al di fuori di essa ; è una visione IMMANENTE , mentre quella platonica è trascendente . Ciò che propriamente esiste sono gli enti singoli : il significato principale dell’essere è la sostanza , ciò che è effettivamente . La sostanza è ciò a cui le qualità ineriscono . Il quaderno però (esempio di sostanza ) può essere due cose diverse : 1) può essere il quaderno che ho in mano “hic et nunc” (qui e adesso , in Greco “tòde ti”) 2)può anche essere la categoria generale dei quaderni : di fronte ad una persona posso dire “Caio” (per esempio), che è il nome proprio della persona o “uomo” che è la categoria alla quale appartiene : in entrambe i casi indico la sostanza con entrambe i nomi : quand’è che si indica la sostanza prima di cui abbiamo già parlato ? Quando si cita ciò che è “hic et nunc” : quando dico che la sostanza è il significato dell’essere , devo dire che il significato primo dell’essere è la sostanza prima . Come si può distinguere sostanza prima da sostanza seconda ? La sostanza prima è sempre e solo soggetto : se dico “il libro è blu” è sostanza prima perchè soggetto ; se però dico “quest’oggetto è un libro” è sostanza seconda perchè “libro” è predicato . Se dico ” Socrate è uomo” non può fungere che da soggetto e da sostanza prima : anche se dico “questo qui è Socrate” in fondo è soggetto . Le sostanze seconde possono essere SPECIE e GENERI : Socrate è sostanza prima , “uomo” è la specie , “animale” è il genere : ci sono più livelli di generità . Un buon modo per distinguere specie da genere è che se ho una specie non la si può suddividere ulteriormente se non in casi singoli : da uomo posso solo passare a Socrate , Platone … Il genere (animale) invece è ulteriormente divisibile . Questo ci aiuta a capire che cosa significa per Aristotele definire : non posso definire Socrate , ma l’uomo : definire è indicare la specie , la divisione ultima . Platone si serviva invece della diairesis . Aristotele punta su genere-specie : si individua il genere prossimo , cioè il genere immediatamente successivo , più generale dopo la specie : nel genere animale devo indicare la caratteristica che separa quel genere dagli altri : nel caso del genere animale bisogna dire per indicare l’uomo “animale razionale” . Si trova la differenza che contraddistingue l’elemento dal resto della specie . Le sostanze dunque sono in senso primario e non in funzione di qualcos’altro . Se dico ” Socrate è magro” , l’esser magro di Socrate è un caso individuale della qualità generale dell’essere magro . Ma questa qualità generale , la magrezza , non è una sostanza . Infatti mentre la sostanza (ad esempio Socrate ) può esistere senza la qualità di magrezza , la magrezza non può esistere senza la sostanza a cui è riferita . In questo caso la nozione di sostanza si distingue da quella di ACCIDENTE : una sostanza ha molte proprietà accidentali , vale a dire proprietà che essa può avere o non avere , senza che l’averle o il non averle comprometta il suo essere quella sostanza determinata . Queste considerazioni portano Aristotele lontano dalla dottrina delle idee platonica . Per Platone ci sono cose bianche perchè c’è l’idea di bianchezza che viene compartecipata ; per Aristotele la bianchezza è perchè ci sono cose bianche , ossia sostanze dotate della qualità di bianchezza . Così il numero 3 esiste perchè esistono gruppi di tre cose . L’universale (il tre , la bianchezza , l’uomo…) , che è oggetto della scienza , non ha esistenza separata dalle cose sensibili , come aveva preteso Platone , ma esiste nelle sostanze individuali . Ritorniamo allo studio dell’accidente : ogni specie ha determinate caratteristiche che appartengono agli individui della specie sempre o “epì tò polù” (per lo più) ; i cani hanno sempre o per lo più quattro gambe . La sostanza di ogni specie indica ciò che hanno sempre o quasi sempre (epì tò polù) : ma Aristotele non si interessa delle singole differenze . L’uomo ha sempre o per lo più due occhi perchè fa parte della sua natura : ma non fa parte della sua natura che siano blu , verdi … Ecco allora che ci troviamo di fronte agli accidenti , quelle cose che non sono nè sempre nè epì tò polù : possono esserci .
MUTAMENTO E SINOLI
I concetti fondamentali della fisica sono legati al mutamento e al movimento : infatti gli enti fisici sono quelli che esistono di per sè , ma che sono mutevoli . Il termine greco che designa il movimento è “kìnesis” : in realtà sarebbe più appropriato tradurlo con ” mutamento-movimento” : certi mutamenti vanno infatti ricondotti al movimento : prendiamo ad esempio il crescere di un animale , forma di mutamento : le sue particelle si muovono e fanno sì che lui cambi . Il mutamento però può avvenire solo sotto 4 categorie : 1) luogo : è il più banale ; la penna era qui , ora è lì : si è spostata . 2) quantità : un essere che cresce muta di quantità 3)qualità : abbronzandosi , per esempio , si muta di colore e quindi di qualità . 4)sostanza : è il mutamento più radicale : quando un animale nasce passa dal non essere all’essere e viceversa quando muore passa dall’essere al non essere . Il movimento inerisce alle cose fisiche : ma non necessariamente dove c’è movimento c’è corruzione : il mutamento avviene non per forza sotto tutte e 4 le categorie : è solo con il mutamento di sostanza che c’è corruzione . Gli astri , per esempio , mutano solo di luogo e non di sostanza : per questo per Aristotele sono eterni . Per lui ci sono propriamente tre enti : a) SUBLUNARE : è il nostro mondo , che sta al di sotto della luna ;esso muta sotto tutte e 4 le cause e per questo è corruttibile . b)CELESTI : gli enti celesti per Aristotele sono eterni : mutano solo di luogo . Gli enti celesti sono quegli enti che vanno dalla luna in sù . c) DIO : non muta affatto , in nessuna delle 4 categorie . Aristotele rifiuta la seconda navigazione platonica e orienta le sue indagini interamente sul mondo sensibile . Ma come funziona il mutamento ? Una prima spiegazione la troviamo nel binomio forma-materia : mentre Platone parlava di idee , Aristotele parla invece di forma : è come se Aristotele immanentizzasse le idee nella realtà . E’ interessante notare che Platone le idee le chiamava o “eidos” o “idea” (tutti e due i termini derivano da “orao” , vedere : le idee erano quelle cose che si vedevano non con gli occhi , ma con l’intelletto ) ; Aristotele dal canto suo traduce “forma” con due parole : “morfè” o “eidos” : si è sempre cercato di evitare di mettere in gioco la stessa parola nei due autori e così per Platone parliamo di idee e con Aristotele di forma : ma in realtà tutti e due usano la stessa parola (eidos) : infatti l’idea di idea c’era anche in Aristotele , ma lui la calava totalmente nella realtà . Aristotele è arrivato a dire che la sostanza è il significato principale dell’essere : ma la sostanza come è fatta ? I predecessori avevano individuato due cose tra loro distinte : a)i Presocratici avevano individuato la materia : ciò di cui una cosa è fatta . b) Platone aveva individuato la forma che una cosa ha : Platone diceva che ciò che faceva un cavallo non era la materia ma la forma . Aristotele non accetta nè la A nè la B : l’idea di cavallo da sola non esiste , ma neppure la pura e semplice materia da sola . Per essere una sostanza deve essere una sostanza specifica ed in più deve essere caratterizzata da una struttura specifica che mi consenta di dire “questo è un cavallo” . Un quaderno è un quaderno perchè c’è della materia ed in più c’è la forma , la struttura che me lo fa individuare come quaderno . Si tratta di un vero BINOMIO materia-forma (Aristotele lo chiama “sinolo” da sun+olos=un tutt’uno di materia e forma) ; ogni sostanza fisica è un binomio di materia e forma : non è un semplice aggregato : per Platone un uomo era fatto di anima e corpo : l’anima era una realtà a parte , tant’è che il corpo per lei era una prigione . Per Platone erano due materie separate . Per Aristotele è totalmente differente la questione : l’uomo è un sinolo , un binomio di anima e corpo . Non si può dividere la materia dalla forma : è una realtà inscindibile; senza il binomio non può esistere la sostanza ; questo implica la mortalità dell’uomo : l’uomo è un sinolo di materia e forma : quando si scioglie una componente (il corpo) si rompe tutto . La forma è quel carattere comune a tutti gli enti di una determinata specie : la forma uomo è presente in tutti gli uomini . Prendiamo un gatto : cosa è che rende quel gatto diverso dagli altri gatti ? E’ la materia , che fa sì che lui sia , esista ; la forma fa sì che lui sia un gatto e non un cane . La materia individua la forma : la forma gatto non esiste da nessuna parte : essa è solo in tutti i gatti esistenti , ma di per sè non esiste . Quando il gatto muore la forma e la materia si disperdono : in realtà la forma non sparisce perchè è in tutti gli altri gatti (anche in quelli che l’han procreato) . Aristotele è un FISSISTA : le specie , secondo lui , sono sempre esistite e sempre esisteranno . In ogni trasformazione c’è sempre qualcosa che cambia , che si trasforma : è la materia (o SOSTRATO , dal latino “substratum” = ciò che giace sotto ; dal greco “upokeimenon”).Facciamo un esempio : una persona va al sole e diventa scura : c’è un sostrato che muta , pur restando in fondo lo stesso : in questo caso il sostrato è la persona stessa : è ciò che permane nella trasformazione . Si passa dalla privazione di una forma all’acquisizione di una forma . Facciamo un esempio : nella procreazione Aristotele (come Platone ) era convinto che la madre fornisse la materia ed il padre la forma : la materia passa dal non possedere la forma del padre ad avere la forma del padre . Dunque abbiamo in gioco : a)il sostrato (o materia) b) la privazione di forma c) l’acquisizione di forma . Il concetto di materia è puramente relativo : ogni processo non riguarda mai la materia pura : uno che si abbronza , passa dalla privazione di colorito all’acquisizione di colorito : la persona funge da sostrato , ciò che perdura nel mutamento . La materia della persona che si abbronza passa dalla mancanza di una forma all’acquisizione di una forma (l’abbronzatura) : la persona è già strutturata , è un sinolo di forma e materia . Aristotele parla allora di materia prima (“prote ule”) , della materia priva di forma , senza il sinolo : è un concetto solo teoretico : in realtà in ogni ente c’è sempre il binomio . Ogni processo parte da qualcosa che funge da materia pura priva di forma per arrivare ad acquisire la forma : però in realtà la materia che deve acquisire la forma , è già un sinolo di materia e forma . Nel nostro caso la persona che si abbronza funge da sostrato : deve acquisire la forma abbronzatura : funge quindi da materia pura , ma in realtà è già un sinolo di forma e materia . Ha già cioè subito un processo di formazione dal padre e dalla madre . E’ quindi passato da privazione abbronzatura ad acquisizione abbronzatura : ma qualcuno potrebbe dire (giustamente) “è passato da acquisizione pallore a privazione pallore” . Noi infatti abbiamo una concezione meccanicistica : le cose che avvengono in natura non sono nè buone nè cattive : Aristotele è un finalista e per lui la natura non fa nulla invano : tutto ciò che fa ha uno scopo (positivo) . Aristotele ha dunque una concezione finalistica (o teleologica) della natura : ogni ente la forma la porta dentro di sè e tende a realizzarla il più possibile . Per Aristotele le cose negative non hanno forma (come per Platone non c’era l’idea di cose negative , come il fango o il capello) . Per noi il processo con cui si nasce è analogo a quello con cui si muore : in entrambe i casi da una forma si passa ad un’altra . Per Platone la morte è un processo degenerativo . Aristotele analizza il movimento vedendolo come il passaggio di un sostrato da privazione di una forma ad acquisizione di quella forma . Comunque questi tre aspetti si possono ricondurre a due : infatti sia privazione sia acquisizione sono riferiti alla forma : sono privazione e acquisizione di forma .
LE 4 CAUSE
Il cambiamento lo si può anche vedere sotto la celebre dottrina delle 4 cause :
1)materiale : indica ciò di cui una cosa è fatta (nel caso di una statua , per esempio , il bronzo)
2)efficiente (o motrice) : indica ciò che mette in moto la cosa , ciò che fa avvenire il processo (nel caso di una statua , lo scultore) .
3) Formale : indica la forma che acquisirà (forma di statua) .
4)Finale : indica lo scopo per cui è fatta (nel caso della statua , per venerare la divinità ). Aristotele utilizza le 4 cause per gli enti naturali , ma si serve di esempi del mondo artificiale-umano perchè così può rendere più visibili cose che nel mondo naturale sono meno visibili . In effetti che in natura ci sia il finalismo è difficile dimostrarlo : invece , un architetto che fa una casa la fa per mettere al riparo delle persone . Nella natura il finalismo è immanente . In Platone il fine stava al di fuori delle cose stesse (consisteva nell’imitare le idee nel miglior modo possibile) . In Aristotele l’essenza delle cose è nelle cose stesse e l’essenza è un qualcosa di dinamico : non è solo ciò che un cavallo è , ma anche ciò che mira ad essere (un cavallo mira ad essere un buon cavallo). Per Aristotele il mondo fisico non va svalutato come era per Platone : è proprio nel mondo fisico che si trova l’essenza delle cose . Aristotele sa bene che anche il mondo naturale è finalistico , che un fiore ha il suo scopo , ma sa anche che è meno evidente rispetto al caso della casa . Anche Aristotele , un pò come Talete con il magnete , prende esempi significativi per poi estenderli all’intera realtà . Nel mondo artificiale , poi , le cause sono caratterizzate dal fatto di essere totalmente separate e distinte le une dalle altre;prendiamo il caso della casa : c’è il materiale (i mattoni , il cemento… emerge come la materia sia un concetto relativo : il mattone è già un sinolo di materia e forma , ma funge da materia prima ), l’architetto (che è la causa efficiente : mette in moto la materia) , la forma (che l’architetto ha in mente) e lo scopo (far vivere delle persone all’interno) . Le opere biologiche di Aristotele sono molto importanti perchè da lì ha derivato le sue ideologie : per esempio , i fenomeni riproduttivi animali : la madre fornisce la materia , il padre la forma (la madre fornisce la materia priva di forma,quindi è causa materiale : tutte le altre cause sono nel padre : egli possiede già la forma da dare ed è quindi causa formale , è causa efficiente perchè mette in moto il processo fecondando , ed è pure causa finale : lo scopo dell’uomo è essere uomo ) . L’essenza è quindi , come abbiamo detto , ciò che una cosa è , ma anche ciò che mira ad essere ; in fin dei conti le cause sono riconducibili a due principi : la forma e la materia . Per Aristotele gli enti naturali hanno dentro di sè il principio del movimento : nel caso delle produzioni tecniche è esterno .
POTENZA E ATTO
Un altro modo con cui Aristotele spiega il movimento è quello della POTENZA e dell’ATTO : questa coppia è un altro modo per ammazzare Parmenide : già Platone aveva commesso il parricidio di Parmenide introducendo l’essere diversamente . Aristotele lavora però nel campo del cambiamento : dall’essere una cosa al non essere più quella cosa e viceversa . Introduce quindi la coppia potenza-atto . Aristotele fa notare che quando qualcosa cambia non passa solo da privazione ad acquisizione , ma subisce anche un altro processo : in partenza era potenzialmente quello che poi è diventato effettivamente . La pianta è trasformazione del seme : il sostrato da privazione di forma albero passa ad acquisizione di forma albero : ma si può anche dire che il seme è un albero in potenza : può diventare albero , come può non diventarlo . Il seme può quindi diventare albero : da albero potenziale diventa albero attuale . Aristotele afferma che questa coppia spiega anche una cosa che nella forma di cambiamento sostrato,privazione,acquisizione non era spiegata : non sempre il seme diventa albero . Certo un seme di quercia ha più possibilità di diventare albero rispetto ad un chicco di grano : il primo è un albero in potenza , il secondo no . Ci sono quindi varie canalizzazioni : prima si deve appurare che sia un albero in potenza (il chicco di grano non può esserlo) , poi occorre che ci siano le condizioni favorevoli perchè diventi albero attuale . Un uovo di struzzo sarà per forza struzzo in potenza e non potrà mai diventare gallina . Aristotele insiste particolarmente sul fatto che ogni cosa per passare da potenza ad atto ha bisogno di qualcosa che sia già in atto : l’uovo di struzzo , per esempio , per diventare struzzo attuale ha bisogno di essere fecondato da uno struzzo già struzzo , uno struzzo attuale . Se non intervengono i fattori necessari alla realizzazione del processo , esso non avviene . Il processo di canalizzazione è molto meno forte nel mondo artificiale rispetto al mondo naturale (a differenza del finalismo) : se ad esempio prendiamo un pezzo di legno , a differenza di uno struzzo , può diventare non tutto , ma più cose : un tavolo , una sedia , un mobile … E’ interessante ricordare che Aristotele ha dato una sua risposta al quesito “è nato prima l’uovo o la gallina ? ” : lui rispose che nacque prima il gallo ; questa domanda era problematica pure per lui (ricordiamo che era un fissista) ; questa domanda può anche essere interpretata come “è nato prima l’atto (la gallina) o la potenza (l’uovo) ?” . Aristotele a questo punto fa notare che l’atto sta prima della potenza ontologicamente e concettualmente : non possiamo definire fino in fondo un uovo se non specifichiamo di che cosa è (di gallina , di struzzo…) : se invece diciamo gallina tutti capiamo senza problemi . L’uovo non è quindi definibile perfettamente se non faccio riferimento all’atto , se non dico che è una gallina in potenza (per definirlo ho quindi bisogno di conoscere l’atto) . La potenza ha come fine l’atto , ma l’atto non ha come fine la potenza . Un bambino è un uomo in potenza : questa teoria però ha creato problemi ed esagerazioni sul piano pedagogico (soprattutto nella pedagogia gesuita) : si è negata l’autonomia delle varie età basandosi sul fatto che il fine è essere uomo . Anche nella storia si fa spesso così : si valuta ciò che viene prima in funzione di ciò che viene dopo : così è anche per i Presocratici , che sono stati appellati in questo modo in funzione della venuta di Socrate , negando loro autonomia . Sul piano ontologico abbiamo visto che , ad esempio , l’uovo per diventare gallina deve essere fecondato da un gallo già in atto .
IL COSMO
Addentriamoci ora nella cosmologia aristotelica : di che cosa è fatto il mondo ? In ultima istanza sarà fatto di forma e materia , come tutto il resto : ma sono concetti puramente teoretici e relativi : non esiste mai (o quasi) materia senza forma o forma senza materia . Aristotele riprende Empedocle ed individua 4 sinoli elementari : acqua , terra , cielo , fuoco . Ciascuno di questi sinoli è caratterizzato dal possedere due delle quattro qualità base : secco e umido , caldo e freddo . La terra per esempio è fredda e secca , il fuoco è caldo e secco e così via . Ma dove sarebbero questi sinoli elementari ? Prendiamo un qualsiasi elemento di questo mondo : ad esempio un uomo : la materia sono i suoi organi , la forma è il modo in cui sono stati strutturati ; prendiamo ora il suo cuore : anch’esso è un sinolo di materia e forma : la materia è il tessuto , la forma è quella del cuore . Ora prendiamo il tessuto : anche lui è sinolo di materia e forma : la materia sono i quattro elementi , la forma è la proporzione in cui sono stati mescolati . Prendiamo ora l’acqua (uno dei 4 elementi) : quale è la materia e quale è la forma ? Qui la separazione può essere solo concettuale : si può dire che essa è fatta di materia prima (prote ule) : abbiamo già detto che però in realtà il sinolo materia forma è inscindibile . Oltre alla materia prima troviamo anche due coppie di realtà : il caldo e il freddo ; il secco e l’umido : combinando queste 4 coppie si potrebbero teoricamente ottenere 6 cose , ma in realtà se combino il caldo con il freddo e il secco con l’umido non mi ricavo niente : così sono solo 4 le coppie combinabili . Ogni accoppiamento caratterizza ciascuno dei 4 elementi : abbiamo già detto che la terra è caratterizzata dall’essere fredda e secca . I 4 elementi sono la base dalla cui aggregazione e disgregazione deriva tutto il resto : sembra uguale ad Empedocle , ma in realtà non è così : per Aristotele , infatti , non sono le parti ultime della realtà (che invece sono le coppie caldo-freddo e secco-umido) : di conseguenza gli elementi possono trasformarsi gli uni negli altri , ad esempio tramite processi di evaporazione o di congelamento : mediante questi processi si possono spiegare , tra l’altro , i fenomeni metereologici . Ogni elemento può trasformarsi immediatamente in quello con cui ha una caratteristica in comune acquisendo l’altra . Per esempio la terra ha in comune con il fuoco il fatto di essere secca , però lei è fredda mentre il fuoco è calda : acquisendo il calore diventa fuoco . Gli elementi hanno poi un’altra caratteristica : il peso . Due elementi sono leggeri (fuoco,aria) , due pesanti (acqua,terra) . Il PESO per Aristotele è la tendenza ad andare verso il centro della terra (che per lui è pure centro dell’universo) : il basso in generale è il centro della terra . Noi pensiamo che il centro della luna sia sulla luna , Aristotele invece pensa che sia sulla terra . Per lui alto e basso hanno valore assoluto : il basso è il centro della terra . Tutti i corpi tendono o a scendere o a salire : sono i movimenti naturali . Ogni elemento si muove per propria natura in una direzione determinata dal suo peso : ciascuno di essi ha dunque un proprio LUOGO NATURALE , al quale tende . Quindi il luogo naturale di ogni elemento corrisponde al suo peso : in ordine di peso stanno così : 1)terra 2)acqua 3)aria 4)fuoco . Da notare che il finalismo vale perfino per le realtà più elementari : se il fine del cavallo è essere cavallo , quale è il fine della terra (uno a caso dei 4 elementi) ? Il suo fine è comportarsi come le compete , stare cioè verso Terra . Il finalismo dei 4 elementi è tendere ciascuno al proprio luogo naturale . Facciamo un esempio : prendiamo un libro ; esso è fatto di terra (di materia , insomma) : se lo mettiamo per terra non si muove perchè è nel suo luogo naturale . Se lo alziamo e lo portiamo in aria e poi lo lasciamo , esso cade perchè l’aria non è il suo luogo naturale e tende quindi a ritornare alla sua collocazione . Lo stesso discorso vale per una bottiglia d’aria messa in acqua : essa tende a salire (dal momento che l’acqua non è il luogo naturale dell’aria) per raggiungere l’aria . Aristotele dice che ci sono due tipi di movimenti a) Quelli che riportano gli elementi ai loro luoghi naturali b) Quelli violenti o contro natura : posso lanciare una pietra in aria o mettere una bottiglia piena d’aria sott’acqua : la pietra ricade e la bottiglia risale . Se tiriamo una penna per aria , noi sappiamo che per un pò sale in quanto le diamo un impulso che la fa salire per un pò : per Aristotele non è così . Lui è convinto che ogni cosa che si muove è mossa da altre (da una causa efficiente) : non ammette che una cosa tenda a mantenere lo stato in cui viene posta (principio di inerzia) ; Questo vale sia per i moti naturali sia per quelli violenti . Aristotele dice che se lancio in aria una penna essa trascina movimenti circostanti e composti : viene qui messo in gioco l’ambiente : è l’ambiente che secondo Aristotele porta su per un pò la penna . Facciamo qualche osservazione : se Aristotele ammette quest’idea , vuol dire che nega l’esistenza del vuoto : non esiste neanche come vuoto relativo (come era per Democrito ) : se ci fosse il vuoto salirebbe all’infinito . Il principio di inerzia mi dice che se conferisco movimento ad un corpo , esso tende a tenere quel moto all’infinito : questo significa che sia quiete sia moto sono stati : se un oggetto si muove quindi ciò che va spiegato è perchè si fermi : dovrebbe per il principio di inerzia proseguire in quel moto all’infinito . Bisogna quindi spiegare il mutamento di stato (da moto passa ad inerzia) . Per Aristotele invece non va spiegata la quiete ma il movimento , che è una forma di cambiamento : è un passaggio da potenza ad atto : la penna è qui ma potrebbe essere lì ; la sposto ed ecco che è lì . Il mutamento-movimento per Aristotele richiede una causa . Per noi va invece spiegata l’accelerazione , il cambiamento di velocità . Il lancio della penna mi spiega che acquista un movimento teoricamente infinito ; per Aristotele è normalissimo che la penna dopo un pò cada : essa tende al suo luogo naturale : quello che per lui va spiegato è perchè per un pò essa tenda a salire . Per Aristotele la quiete è uno stato , il movimento un mutamento (ed i mutamenti vanno spiegati) . Per noi sono entrambe stati . Abbiamo detto che si accusò Aristotele di essere poco attento alla realtà : qui abbiamo una prova per smentire quest’affermazione : infatti la realtà a riguardo della penna sembra proprio dare ragione a lui e non a noi . Guardiamo ora alla concezione cosmologica aristotelica : Aristotele sostiene il geocentrismo : la terra , in quanto corpo più pesante , occupa il centro dell’universo . Da notare che il mondo di Aristotele è un mondo finito : a partire dai Pitagorici era prevalsa l’idea che l’infinito fosse qualcosa di negativo (diversamente da come la pensava Anassimandro) . Il finito è quindi sinonimo di perfezione . Aristotele dice poi che c’è un centro : ci sono i luoghi naturali e alcuni corpi tendono al centro , altri alla periferia . Se ci sono un basso e un alto ci deve per forza essere anche un centro : se esistono gli elementi ed i luoghi naturali , allora il mondo è finito . Nell’infinito infatti non ci sono nè l’alto nè il basso . Ma attenzione , si può capovolgere il ragionamento : l’infinito esiste , quindi l’alto ed il basso non ci sono . Aristotele parte però dal presupposto che il basso e l’alto esistano . E’ un pò come per Melisso : le sue tesi vennero riprese dagli Atomisti per capovolgere le tesi eleatiche . In sostanza Aristotele nega l’esistenza di più universi : Democrito e Anassimandro invece la sostenevano . Se la tendenza è di andare al centro della terra non ci devono essere altri universi altrimenti collasserebbero tutti al centro della terra : Aristotele si serve della dimostrazione per assurdo : se esistesse un altro mondo esso sarebbe costituito dagli stessi elementi del nostro : ma in base alla dottrina dei luoghi naturali ciascun elemento tenderebbe ad esso e quindi la terra di questo secondo universo tenderebbe a congiungersi con la terra del nostro universo e così tutti gli altri elementi ; il carattere finito dell’universo è contrassegnato dalla sua perfezione . I 4 elementi spiegano il funzionamento del mondo sublunare , che per Aristotele è assai differente da quello celeste : il sublunare è caratterizzato dai 4 elementi , il cui destino è di nascita e di morte . Essendo una realtà fisica , per essere eterno dovrebbe avere un movimento eterno , che però non ha : il movimento del mondo è infatti rettilineo : l’eternità non può identificarsi con qualcosa di rettilineo . Così il destino degli enti fisici è di nascita e di morte . Una forma di eternità sul nostro mondo può essere reperita nelle specie , che sono eterne (Platone diceva che l’eros era un tentativo degli enti mortali di eternarsi) , o nei 4 elementi che si mutano tra loro . Queste cose godono di una eternità indiretta . Il mondo celeste (quello che va dalla luna in sù) è differente : a quei tempi si pensava che fosse immutabile perchè per intere generazioni si vedevano costellazioni immutate , sempre disposte nello stesso modo . Solo le comete si muovevano , ma Aristotele pensava che esse fossero un fenomeno metereologico del mondo sublunare . Quindi il mondo celeste per Aristotele è immutabile : abbiamo detto che il mutamento può essere secondo 4 qualità e Aristotele credeva che fossero gli altri pianeti a ruotare intorno alla terra e non viceversa (come invece aveva ipotizzato Platone ) : ma se si muovono devono per forza mutare e quindi non sono eterni , direbbe qualcuno . Aristotele però dice che il loro è un movimento circolare , che ritorna su se stesso . E’ un movimento che non comporta alcuna forma di corruzione : Platone aveva parlato del movimento circolare come immagine mobile dell’eternità : Aristotele riprende questa concezione . Aristotele dice che il mondo sublunare è costituito da un quinto elemento , l’ETERE , privo di peso e dotato di movimento circolare : di esso sono dotati i corpi celesti . Dicevamo che per Aristotele il vuoto non c’è : come non esiste nel mondo sublunare , così non esiste fuori dall’universo : per lui tutto è pieno . Ma fuori dell’universo cosa c’è ? La risposta di Aristotele è “niente” , che è diverso dal vuoto : finisce proprio l’universo . Se ci fosse il vuoto ci dovrebbe essere un luogo che lo contiene , un contenitore di vuoto : per Aristotele proprio non c’è niente ! L’universo non è in nesun luogo perchè : Aristotele definisce un luogo come la superficie contenuta da qualcosa : ma dato che nulla può contenere l’universo , esso non è in nessun luogo . Se non è in nessun luogo non è nel vuoto . Non è un nulla fisico , ma un nulla metafisico . La finitezza stessa della materia impedisce che ci sia uno spazio infinito . La fisica moderna ha fatto marcia indietro perchè tende a dire che l’universo non è nè finito nè infinito . Aristotele invece è convinto al cento per cento che sia finito e che non ci sia vuoto nè nel mondo sublunare nè nell’intero universo . L’infinito abbiamo visto che esiste solo potenzialmente nei numeri : essi non sono nè finiti nè infiniti . Ma come funziona il cosmo aristotelico ? Il mondo sublunare è costituito da 4 sfere ; poi ci sono la luna e gli astri . L’universo nel suo insieme è una grande sfera . Dalla luna fino al confine estremo tutto è fatto di etere . L’equilibrio dell’universo è dato dall’orbita : ci sono 2 forze , una che spinge per far andare il tutto sulla retta (come va il mondo sublunare) , l’altra che spinge per far cadere : le due forze contendono e ne consegue che l’universo giri su se stesso . La luna non è nient’altro che un oggetto incastrato nell’etere che ruota intorno alla terra : la luna è conficcata nella sfera dell’etere . In sostanza è tutta la sfera che ruota e non solo la luna : essa ruota proprio perchè ruota la sfera . Aristotele distingue i PIANETI dalle STELLE FISSE , che hanno la caratteristica di girare tutte insieme . I pianeti , invece , vagano per conto loro (il termine pianeta in greco significa letteralmente “vagante”) .Per ogni sfera ci sono pianeti ed ogni gruppo di sfere fa muovere un pianeta . Ma quali sono i pianeti ? Il sole , la luna ed altri ancora , come Mercurio . Come abbiamo detto Aristotele dà per scontato che le realtà celesti siano immutabili : egli arriva ad ammettere la circolarità e la regolarità partendo dal presupposto che fossero immutabili ; da questo derivava che avessero movimenti circolari : il movimento circolare è infatti quello che suggerisce maggiormente l’idea di eternità , come già aveva notato Platone . Chiaramente non erano dati osservativi , perchè Aristotele vedeva che i pianeti son fermi e a volte in movimento , a volte accelerano , a volte rallentano : per motivare questi moti apparentemente irregolari Aristotele doveva ricorrere a più sfere concentriche che insieme muovevano un pianeta (ogni gruppo di sfere muove il suo pianeta). Il movimento di ogni pianeta era ottenuto con la combinazione di più sfere ed ogni sfera era legata a sua volta a più sfere : ne consegue che Aristotele arrivi ad ammettere che non siano le 4 che abbiamo detto più quelle necessarie a muovere un pianeta (che , per dire , erano 3) : in tutto erano circa 47 o 55. Aristotele acquisì queste idee da Eucnosso di Cnide , un platonico . Ricapitolando , Il sistema aristotelico ç di ” sfere concentriche ” , ossia c’ era la Terra in mezzo e poi una serie di sfere l’ una concentrica all’ altra ; ogni pianeta é mosso dalla combinazione di movimenti di molte sfere ( le sfere sono molte di più rispetto ai pianeti perchè per muovere ogni pianeta occorre un numero consistente di sfere ) . Questo serve essenzialmente per un motivo : per rendere compatibile ciò che si vede con ciò che si pensa . L’ apparenza dei fenomeni é un movimento non regolare dei pianeti : dalla Terra abbiamo l’ impressione di un movimento del cielo delle stelle fisse ; le stelle sono fissate tutte sulla ” pelle dell’ universo ” alla stessa distanza , senza profondità differenti . Noi oggi sappiamo che in realtà non é il cielo che gira intorno alla Terra , ma é la Terra che gira intorno al suo asse ( movimento di rotazione ) . Poi ci sono i pianeti , ossia le stelle vaganti , così dette perchè a differenza delle stelle fisse che sono attaccate sulla parete del mondo , esse vagano . Il movimento di questi pianeti é apparentemente irregolare , perchè é vero che vanno in una determinata direzione , ma a velocità diverse a seconda delle occasioni ( a volte si fermano o addirittura sembrano tornare indietro ) ; le costellazioni , é interessante notare , sono pure illusioni ottiche perchè ci sembrano stelle allineate , ma non é così : sono disposte in profondità e non sullo stesso piano , come sembra ; per rendere compatibile questa situazione fenomenica con le convinzione ammesse all’ epoca Aristotele inventa il suo sistema ” a sfere ” : se ad ogni pianeta fosse corrisposta una sfera sola allora ci sarebbe dovuto essere un moto regolare ( che però in realtà non c’ é ) come quello delle stelle fisse ; così Aristotele aveva dovuto introdurre più sfere che davano combinazioni di movimenti in modo tale che il movimento delle combinazioni di sfere fosse apparentemente irregolare , ma questa apparente irregolarità é compatibile con alcune convinzioni metafisiche di Aristotele : il cielo é fatto di sfere che girano attorno al proprio asse . Doveva risolvere questa apparente irregolarità in un insieme di movimenti regolari che ne davano uno ai nostri occhi irregolare ; Aristotele era profondamente convinto che il movimento dei pianeti fosse dato dalla combinazione dei movimenti delle sfere , cosa che oggi sappiamo essere sbagliata : l’ unico metodo a sua disposizione era assommare un tot di movimenti regolari che ne davano uno apparentemente irregolare ; il tutto poi doveva essere compatibile con la centralità della Terra . Le sfere rappresentano l’eternità , o meglio , un’eternità speciale . Sia la realtà sublunare sia quella celeste ha una sua forma di eternità : il mondo sublunare ha un’eternità specifica , che cogliamo soprattutto nell’eternità delle specie , il mondo celeste ha una eternità numerica : tra queste due forme di eternità intercorre una forma di rapporto : la ciclicità degli enti celesti detta l’alternarsi delle stagioni : possiamo quindi affermare che la ciclicità specifica è in gran parte dettata da quella numerica . Dopo aver esaminato il moto dei pianeti e delle stelle dobbiamo spiegare che cosa é che causa questo movimento perchè , come abbiamo già detto , per Aristotele dove c’è movimento ci deve essere per forza qualcosa che muove ( causa efficiente ) e questo concetto é ben espresso nella frase ” omne movens ab alio movetur ” : anche il movimento celeste va quindi spiegato . Quale è la prima cosa che muove tutta la realtà celeste (Aristotele dice :”quale è il primo mobile ?”) ? La risposta sta nel CIELO DELLE STELLE FISSE ( cui abbiamo già accennato ) , una specie di pelle dell’universo : le stelle sono infatti fissate nel cielo . Ma se il cielo delle stelle fisse muove tutto il resto , vuol dire che anche lui si muove : dove c’è movimento c’è qualcosa che muove : quindi qualcosa deve mettere in moto il cielo delle stelle fisse . Sembra che si possa andare avanti all’infinito nella ricerca del “primo motore” (ciò che per primo ha messo in movimento tutto) . Qualcuno potrebbe dire : ma non c’è un movimento ciclico che possa spiegare tutto ? Aristotele dice di no . Bisogna trovare un punto fisso che muove senza essere mosso . Se A è causato da B , B non ha bisogno di motivazioni oppure si fa riferimento a C e poi a D . Ma andare all’infinito alla ricerca delle spiegazioni è un processo privo di senso . Come nella logica occorreva trovare qualcosa che fosse così e non avesse bisogno di spiegazioni : chi pretende che tutto debba essere dimostrato , secondo , Aristotele è una persona con cui non si può ragionare . Si deve quindi trovare qualcosa che causi il movimento ma che non venga mosso , una causa che causi senza essere causata . Ebbene una cosa che muove , paradossalmente , può non essere mossa . Esiste quindi un primo motore che pur senza essere mosso e senza muoversi mette in moto l’intero universo , oltre che se stesso ( é cioè ” causa sui ” ) : è il ” motore immobile ” , come lo chiama Aristotele : esso si identifica con la DIVINITA’ .
IL DIO
Abbiamo già detto che Aristotele aveva risposto alla domanda “che cosa esiste” dicendo “intanto esistono indubbiamente le cose fisiche che vediamo intorno a noi” : ora arriva a dimostrare l’esistenza di una realtà immateriale . Il movimento dei cieli abbiamo detto che è eterno (proprio perchè il cielo è eterno) : se il movimento è eterno , allora il motore è dotato di pura attualità ed è privo di potenza : essa infatti implica che una cosa possa accadere , ma anche che possa non accadere . Un qualcosa fatto di potenza e atto è destinato a fermarsi prima o poi . Il motore immobile (la divinità) è quindi atto allo stato puro . Ma sappiamo che l’atto si identifica con la forma e la potenza si identifica con la materia : di conseguenza la divinità è forma allo stato puro : non è un sinolo di materia e forma . Abbiamo detto che nella concatenazione dei motori bisogna per forza arrivare ad un qualcosa che muova senza essere mosso sennò si andrebbe avanti nella ricerca all’infinito . A questo punto quindi Aristotele introduce la divinità . Questo motore deve poi essere eterno perchè deve giustificare il movimento eterno delle sfere celesti . La divinità è l’unica realtà immateriale che Aristotele individui . Abbiamo già detto che la divinità è l’oggetto principale della filosofia prima , che ha le istanze di ontologia e di teologia . Ma se la divinità è una realtà immateriale , come fa a muovere , visto che il movimento avviene per contatto ? Aristotele risponde che la divinità muove il cielo delle stelle fisse non come causa efficiente , bensì come causa finale : se fosse causa efficiente , la divinità dovrebbe effettivamente agire sul mondo spostandolo . Ma questo è impossibile perchè è una realtà immateriale . Ma c’è anche un’altra motivazione , altrettanto importante : la divinità proprio perchè è una realtà suprema non può “interessarsi” e quindi agire effettivamente sul mondo : la divinità non fa nulla direttamente sul mondo , non ha una volontà d’azione sul mondo . Ha un’attività tutta sua e particolare che si svolge interamente dentro di lui . Agire sul mondo significherebbe autodiminuirsi : una realtà superiore quale la divinità che si occupa di una realtà inferiore quale è il nostro mondo sarebbe un controsenso , una forma di autodiminuzione della divinità stessa . Sarebbe un’ imperfezione della divinità . La divinità agisce sul mondo come “oggetto di amore e desiderio” : come la cosa amata attrae chi la ama , così la divinità attrae il mondo . Quando una cosa attrae qualcuno non si può propriamente dire che la cosa agisca su questo qualcuno , anche se in un certo senso è causa (finale) del movimento : è per quella cosa che quel qualcuno muove . Così la divinità è causa del movimento dei cieli e quindi indirettamente dell’intero universo (ricordiamoci che la ciclicità del movimento dei cieli è poi causa della ciclicità delle stagioni che a sua volta influisce sulla ciclicità particolare del mondo sublunare : la riproduzione che rende le specie eterne) . La divinità diventa quindi la causa (finale) del movimento dell’intero universo , quindi la si può chiamare motore immobile o causa incausata . La divinità non produce l’universo dal nulla , come fa invece nella tradizione ebraico-cristiana , nè lo plasma , come faceva invece il demiurgo platonico : lo mette semplicemente in moto . Non ha quindi nessun rapporto causale con l’esistenza del mondo , ma ha solo rapporto causale (finale) con il movimento del mondo . Cosa vuol dire che la divinità attrae il mondo ? Non bisogna pensare che sia come un cane che sente il cibo e gli si avvicina , perchè così non quadrerebbero alcune cose : l’universo si sposterebbe , e per andare dove ? La divinità è priva di materia e quindi non sta in nessun luogo , dato che è puramente formale . Bisogna quindi rettificare che il primo mobile cerca di avvicinarsi alla divinità nel senso che cerca di imitarla . L’avvicinarsi del mondo alla divinità va visto come un tentativo del mondo di assimilarsi alla divinità . Ma cosa vuol dire assimilarsi alla divinità ? Abbiamo visto che la caratteristica fondamentale della divinità è la sua eternità , data dalla mancanza di materia e di potenza . Come fa la realtà fisica ad imitare , ad assimilarsi ad una realtà immateriale ed eterna ? La risposta sta nel moto circolare , la miglior imitazione di eternità da parte degli enti fisici in movimento . Perchè il cielo delle stelle fisse gira ? Perchè è imitazione dell’eternità divina . Questo è il moto del primo mobile , ma come si muovono le sfere successive ? Qui i passi di Aristotele non sono chiarissimi (ricordiamoci che si tratta di appunti) . Ci sono due ipotesi : 1) che si muova per attrito : una volta che si muove il cielo delle stelle fisse , tutti gli altri cieli inferiori si muovono per attrito . Ma è poco probabile quest’ipotesi perchè è vero che tutte le sfere si muovono in modo circolare , ma il movimento è dato dalla combinazione di più movimenti , tutti circolari , ma gli uni differenti dagli altri . Se andasse davvero per attrito , le sfere avrebbero tutte la stessa direzione . 2) Già Platone ipotizzava che i cieli fossero realtà viventi ed intelligenti : per lui movimento era sinonimo di vita ed in più movimenti così ordinati presupponevano un’intelligenza . Aristotele riprende in sostanza questa teoria (in maniera meno animistica) : è probabile che pensasse che non solo il primo mobile imita la divinità col moto circolare , ma anche le sfere inferiori , a modo loro , operano alla stassa maniera , ciascuna secondo la propria natura . Dato che ciascuna lo fa secondo la propria natura , è evidente che lo fanno in modo diverso : ci sono quindi movimenti differenti e questo implica che ogni sfera abbia un qualcosa di molto simile ad un’anima : le sfere celesti sono dotate di una specie di anima . Quest’idea dell’intelligenza celeste aristotelica viene in qualche modo tradotta nell’intelligenza angelica di Dante : gli angeli del Paradiso che muovono le sfere celesti , sono proprio dei governatori di queste sfere . E’ la traduzione in chiave cristiana della teoria aristotelica . Ma la divinità cosa fa in buona fine ? Certo non agisce sul mondo in modo provvidenziale . E’ stato detto che l’ateismo ha due varianti : a) c’è l’ateismo nel senso più classico , che è la nagazione dell’esistenza di dio . b) Ma si può parlare di ateismo anche quando si dice che dio non si occupa del mondo . Gli epicurei per esempio non negavano l’esistenza degli dei , ma dicevano che proprio perchè erano perfetti non si occupavano del mondo dell’uomo : sarebbe un abbassamento delle divinità . E’ un ateismo più sfumato . Aristotele assume una posizione che è una via di mezzo : anche per lui la divinità non si occupa del mondo , ma tuttavia lo governa : si configura come causa finale ultima : tutto il finalismo che governa l’intera realtà ha il suo punto di riferimento nella divinità , che è quindi garante dell’ordine e della regolarità , ma non in senso attivo : non c’è nessuna provvidenza . Governa il mondo perchè il mondo cerca di imitarlo . Dante conclude la Divina Commedia dicendo “… l’amor che muove il cielo e le altre stelle” : da notare che c’è un richiamo ad Aristotele , ma attenzione : Dante sta parlando dell’ l’amore di Dio (genitivo soggettivo ) , l’amore che dio prova per gli uomini : Aristotele invece dice l’amore di dio , ma con il genitivo oggettivo : l’amore nei confronti di dio : è l’amore che il mondo prova per dio che lo fa muovere . La divinità aristotelica non è provvidenziale e non la si può pregare : la preghiera di Aristotele è l’intera sua opera , in particolare le parti biologiche : c’è chi l’ha definita una preghiera apofantica : non è una preghiera con cui si prega e si chiede , ma con cui si illustra la perfezione dell’universo . Nel mondo classico non c’era nè politeismo nè monoteismo : anche in Aristotele è così : c’è la divinità come realtà suprema , ma in un certo senso le intelligenze celesti sono divinità minori : c’è quindi una sorta di mescolanza tra monoteismo e politeismo . La divinità non si occupa del mondo , ma non può non fare niente . La perfezione e la felicità sono per Aristotele legate all’attività e quindi anche la divinità deve fare qualcosa : ha un’attività tutta interna a se stessa . L’attività suprema per Aristotele è il pensare , quindi la divinità è essenzialmente una mente . Ma a che cosa pensa ? Di sicuro non pensa ad una realtà inferiore come l’universo e quindi pensa solo a se stesso . Emerge qui la definizione della divinità come “pensiero di pensiero” . Tutto questo Aristotele lo spiega nella Metafisica :
‘ Dal momento che è possibile che le cose stiano nel modo da noi prospettato -del resto, se si respinge questa nostra spiegazione, tutte le cose deriverebbero dalla notte o dal -tutto-insieme’ o dal non-essere – si possono ritenere risolte tutte le precedenti aporie; esiste, quindi, qualcosa che è sempre mosso secondo un moto incessante, e questo modo è la conversione circolare (e ciò risulta con evidenza non solo in virtù di un ragionamento, ma in base ai fatti), e di conseguenza si deve ammettere l’eternità del primo cielo. Ed esiste, pertanto, anche qualcosa che provoca il moto del primo cielo. Ma dal momento che ciò che subisce e provoca il movimento è un intermedio, c’è tuttavia un qualcosa che provoca il movimento senza essere mosso, un qualcosa di eterno che è, insieme, sostanza e atto. Un movimento di tal genere è provocato sia da ciò che è oggetto di desiderio sia da ciò che è oggetto di pensiero. Ma questi due oggetti, se vengono intesi nella loro accezione più elevata, sono tra loro identici. Infatti, è oggetto del nostro desiderio il bello nel suo manifestarsi, mentre è oggetto principale della nostra volontà il bello nella sua autenticità; ed è più esatto ritenere che noi desideriamo una cosa perché ci si mostra bella, anziché ritenere che essa ci sembri bella per il solo fatto che noi la desideriamo: principio è, infatti, il pensiero. Ma il pensiero è mosso dall’intellegibile, e una delle due serie di contrari è intellegibile per propria essenza, e il primo posto di questa serie è riservato alla sostanza e, nell’ambito di questa, occupa il primo posto quella sostanza che è semplice ed è in-atto ( e l’uno e il semplice non sono la medesima cosa, dato che il termine uno sta ad indicare che un dato oggetto è misura di qualche altro, mentre il termine semplice sta ad indicare che l’oggetto stesso è in un determinato stato). Ma tanto il bello quanto ciò che per la sua essenza è desiderabile rientrano nella medesima categoria di contrari; e quel che occupa il primo posto della serie è sempre pttimo o analogo all’ottimo. La presenza di una causa finale negli esseri immobili è provata dall’esame diairetico del termine: infatti, la causa finale non è solo in vista di qualcosa, ma è anche proprietà di qualcosa, e, mentre nella prima accezione non può avere esistenza tra gli esseri immobili, nella seconda accezione può esistere tra essi. Ed essa produce il movimento come fa un oggetto amato, mentre le altre cose producono il movimento perché sono esse stesse mosse. E così, una cosa che è mossa può essere anche altrimenti da come essa è, e di conseguenza il primo mobile, quantunque sia in atto, può -limitatamente al luogo, anche se non alla sostanza- trovarsi in uno stato diverso, in virtù del solo fatto che è mosso; ma, poiché c’è qualcosa che produce il movimento senza essere, esso stesso, mosso ed essendo in atto, non è possibile che questo qualcosa sia mai altrimenti da come è. Infatti, il primo dei cangiamenti è il moto locale, e, nell’ambito di questo, ha il primato la conversione circolare, e il moto di quest’ultima è prodotto dal primo motore. Il primo motore, dunque, è un essere necessariamente esistente e, in quanto la sua esistenza è necessaria, si identifica col bene e, sotto questo profilo, è principio. Il termine ‘necessario’, infatti, si usa nelle tre accezioni seguenti: come ciò che è per violenza perché si oppone all’impulso naturale, come ciò senza di cui non può esistere il bene e, infine, come ciò che non può essere altrimenti da come è, ma solo in un unico e semplice modo. E’ questo, dunque, il principio da cui dipendono il cielo e la natura. Ed esso è una vita simile a quella che, per breve tempo, è per noi la migliore. Esso è, invero, eternamente in questo stato (cosa impossibile per noi!), poiché il suo atto è anche piacere (e per questo motivo il ridestarsi, il provare una sensazione, il pensare sono atti molto piacevoli, e in grazia di questi atti anche speranze e ricordi arrecano piacere). E il pensiero nella sua essenza ha per oggetto quel che, nella propria essenza, è ottimo, e quanto più esso è autenticamente se stesso, tanto più ha come suo oggetto quel che è ottimo nel modo più autentico. L’intelletto pensa se stesso per partecipazione dell’intellegibile, giacchè esso stesso diventa intellegibile venendo a contatto col suo oggetto e pensandolo, di modo che l’intelletto e intellegibile vengono ad identificarsi. E’, infatti, l’intelletto il ricettacolo dell’intellegibile, ossia dell’essenza, e l’intelletto, nel momento in cui ha il possesso del suo oggetto, è in atto, e di conseguenza l’atto, piuttosto che la potenza, è ciò che di divino l’intelletto sembra possedere, e l’atto della contemplazione è cosa piacevole e buona al massimo grado. Se, pertanto, Dio è sempre in quello stato di beatitudine in cui noi veniamo a trovarci solo talvolta, un tale stato è meraviglioso; e se la beatitudine di Dio è ancora maggiore, essa è oggetto di meraviglia ancora più grande. Ma Dio è, appunto, in tale stato! Ed è sua proprietà la vita, perché l’atto dell’intelletto è vita, ed egli appunto è quest’atto, e l’atto divino, nella sua essenza, è vita ottima ed eterna. Noi affermiamo, allora, che Dio è un essere vivente, sicchè a Dio appartengono vita e durata continua ed eterna: tutto questo, appunto, è Dio! ‘ (Metafisica, 12.7.1072a19-1072b30)
L’ANIMA E IL VIVENTE
Vediamo ora il pensiero di Aristotele a riguardo del vivente e dell’anima : Aristotele ha scritto parecchi libri a riguardo : “Historia animalium” , “De partibus animalium” , “De generatione animalium” , “Parva naturalia” , “De motu animalium” … Le opere biologiche sono importanti perchè i concetti fondamentali della metafisica derivano da qui in Aristotele . Il concetto di movimento , per esempio , è particolarmente evidente nel mondo naturale . La riproduzione degli animali deve avergli dato lo spunto per formulare la teoria della privazione forma , acquisizione forma , sostrato … Le realtà viventi sono realtà fisiche e quindi dotate di materia e forma : nella fattispecie la materia e la forma di cui è composto un sinolo vivente sono quelle che comunemente chiamiamo anima e corpo . L’anima non è una realtà fisica ultima : è fatta di materia e forma . Sono dotati di anima gli uomini , gli animali e le piante . L’anima è la forma particolare che hanno gli esseri viventi . Questo significa che non c’è una differenza qualitativa radicale tra le cose inorganiche e gli esseri viventi , c’è solo una differenza quantitativa : l’anima non è altro che un tipo di forma particolarmente complesso . Facciamo un esempio : anche gli elementi hanno forma : la forma della terra è l’essere fredda e secca . Se metto insieme alcuni o tutti e 4 gli elementi ottengo una realtà complessa . Significa aggiungere sempre aspetti formali nuovi : la terra ha solo quei 2 aspetti formali , se mescolo con alcuni dei 4 elementi ottengo una realtà complessa e composta : ottengo un tessuto ; se aggrego tessuti diversi posso ottenere un organo . Allora significa aggiungere sempre aspetti formali nuovi . Se prendo un pò di muscolo , un pò di tessuto tendineo ed un pò di tessuto osseo ottengo per esempio una mano : non è la stessa cosa che i tessuti di cui è fatta : c’è un elemento formale in più . C’è una differenza : a livello di elemento l’aspetto formale di quelli che abbiamo detto ; a livello di tessuti etc. l’elemento formale che si aggiunge è il modo in cui sono combinati : i tessuti da Aristotele vengono chiamati parti OMEOMERE , cioè sono parti che quando vengono divise sono costituite della stessa materia : se divido un muscolo in 2 parti , ottengo 2 parti di muscolo . Significa “parti simili” . Se invece ho una mano , che è la combinazione di tessuti ed è un ORGANO , essa si chiama parte non omeomere , non simili tra loro : se divido una mano , non ottengo 2 mani , bensì più tessuti differenti . Se metto insieme diversi organi ottengo un SISTEMA (ad esempio il sistema nervoso , o quello respiratorio) e se invece unisco tutti i sistemi ottengo un ORGANISMO complesso . Aristotele dice che l’anima è ” l’atto puro di un corpo che ha la vita in potenza ” : in un corpo costituito da tessuti , organi e sistemi , l’anima è la forma di quel corpo lì , non di un corpo qualsiasi , ad esempio un libro che non ha la struttura adatta per avere un’anima . Tutte le cose hanno una forma , ma solo le cose strutturate in maniera complessa (complessa = capace di svolgere tante funzioni diverse ; una penna non può fare che cadere ; un corpo vivente , una pianta , svolge diverse funzioni) hanno un’anima ; questo consente ad Aristotele di negare la reincarnazione dell’anima , che invece sosteneva Platone : la trasmigrazione presupponeva che ogni anima potesse starsene da sola ; e poi non può andare da qualsiasi parte l’anima : per Platone l’anima poteva finire in un corpo femminile , nel corpo di un animale … Questo per Aristotele è impossibile perchè un’anima è strettamente connessa ad un corpo : la forma vale solo per un corpo . Per Platone anima e corpo sono due cose distinte , una abita nell’altra : per Aristotele l’anima non è una sostanza , è una forma : la sostanza è solo il sinolo materia-forma . Di conseguenza viene negata la trasmigrazione delle anime , dove ogni forma andava in ogni corpo ; ma viene anche negata l’immortalità dell’anima : se l’anima è la forma di un corpo vivente , quando il sinolo si rompe , la forma non può vivere da sola (solo quella divina può) : essa vive solo calata nella materia . Certo abbiamo detto che la forma uomo non muore quando muore il singolo uomo : continua ad esistere in tutti gli altri uomini . Non si può però parlare di sopravvivenza individuale . Abbiamo già visto che il mondo aristotelico è dominato dal finalismo , che emerge soprattutto nel mondo biologico : i cavalli hanno gli zoccoli per poter camminare su determinati terreni . Il finalismo non è però perfetto : è un pò come per Platone : c’è di mezzo la materia che interferisce : è quella cosa priva di forma necessaria a far realizzare le forme ; per Aristotele vale ancora di più che per Platone che le forme per esistere abbiano bisogno della materia : per Platone infatti c’erano le idee che esistevano di per sè . La materia fa sì che le cose materiali siano destinate a morire . E’ con Aristotele che la parola ULE (materia) assume il significato di materia : essa infatti prima significava legname ed aveva la stessa derivazione del latino “silva” , senza la v e la s : il legname suggerisce proprio l’idea di materiale da costruzione . Tutto quel che nasce è destinato a perire ; certo è vero che “la natura non fa nulla invano” , come ripete sempre Aristotele , tutto è finalizzato ; tutto è dotato di forma e quindi tutto è bello per Aristotele anche l’insetto più ripugnante ha una sua forma e quindi va apprezzato . Va però detto che la natura può fare tutto , ma con quello che ha a disposizione : Aristotele è convinto che nel metabolismo degli esseri viventi si producano materiali di scarto : tra di essi Aristotele annovera pure le produzioni di carattere corneo : le unghie , i capelli : non vengono prodotte per un fine ; ci sono anche produzioni casuali : ma la natura per quanto può usa tutto ciò che ha a disposizione : ha a disposizione questi scarti e lei li usa per i capelli e le unghie . Non tutto quindi è finalizzato : utilizzando ciò che ha a disposizione la natura fa del suo meglio , ma non sempre ci riesce . Ad esempio : la riproduzione è un processo finalistico (dare la forma paterna) : se tutto funzionasse bene i figli sarebbero tutti maschi : ma dato che la materia è elemento di imperfezione , può succedere che nascano femmine o bambini difettosi . Può succedere che non assomigli al padre , nè a nessun parente : quando la forma non riesce a dominare la materia allora si verificano questi casi . Non c’è un salto netto tra mondo vivente e mondo non vivente , così come non c’è un salto netto tra mondo vivente superiore (uomini) e mondo vivente inferiore (piante , animali): entrambe sono costituiti dal sinolo materia-forma . E’ interessante il fatto che Aristotele credesse nella generazione spontanea : credeva che gli animali superiori si riproducessero in maniera sessuata , mentre che gli esseri inferiori (come i piccoli insetti) si generassero spontaneamente : Aristotele non era in grado di vedere che in realtà si riproducono con le uova , le larve … Lui ipotizzava che l’energia del sole fosse in grado di far passare in certe occasioni dal mondo inorganico al mondo organico . Diceva che nelle acque stagnanti riscaldate dal sole potevano generarsi organismi viventi . Ovviamente questa idea si basava sul fatto che non ci fosse un salto netto tra mondo organico e mondo inorganico : era solo una differenza di complessità . Naturalmente Aristotele aveva torto , come spesso accadeva (Aristotele va ricordato che non era riuscito a capire che cosa fossero effettivamente i fossili) : si scoprì nel ‘600 che in realtà c’erano le uova , la larve e quant’altro mediante un esperimento : misero della carne in un barattolo privo di contatti con l’esterno : la carne andò in putrefazione , ma non nacquero gli organismi perchè gli insetti non poterono depositare le larve . Nel ‘600 però si arrivò ad una conclusione giusta in merito alle circostanze , però in generale meno giusta di quanto si possa pensare : veniva negata ogni forma di passaggio dal mondo inorganico a quello organico , come se il mondo organico fosse differente qualitativamente . In realtà non è così : la scienza moderna ci suggerisce che in qualche situazione questo passaggio si è verificato . Aristotele non aveva concettualmente torto : l’idea di fondo era giusta . Questo consente di dire che certe cose che per un verso sono progresso , per un altro non lo sono e viceversa . Dunque abbiamo detto che gli organismi viventi hanno un’anima : Platone aveva parlato di 3 parti dell’anima (la biga alata) : Aristotele fa un discorso che presenta analogie con quello platonico , ma che in realtà è diverso : non parla di 3 parti dell’anima , ma di tipi diversi di anima , alcuni più semplici , altri più complessi . I più semplici presentano determinate funzioni , quelli più complessi presentano accanto alle funzioni più semplici possedute dagli altri , alcune funzioni più complesse . Aristotele parla di tre tipi di anima : 1) VEGETATIVA 2) SENSITIVA 3) INTELLETTIVA . Apparentemente sembra che parli di 3 anime diverse : in realtà sono 3 tipologie di anime dotate alcune di poche funzioni , altre di più funzioni . In sostanza lui divide i vegetali dagli animali , dall’uomo . I vegetali hanno l’anima vegetativa ; non possiede nè le funzioni intellettive nè quelle sensitive (alle quali sono connesse le funzioni del movimento) : la pianta ha solo la funzione vegetativa , si nutre , cresce e si riproduce . Sono anime vegetative perchè hanno solo l’anima vegetativa . Gli animali possiedono altre funzioni , per cui la loro anima è sensitiva : ma attenzione , l’anima sensitiva oltre a possedere le funzioni vegetative possiede ulteriori funzioni . L’anima sensitiva fa sì che gli animali mangino , crescano , si riproducano (come le piante) ma in più provino sensazioni ed abbiano (di conseguenza) il movimento perchè solo l’animale sentendo che là c’è il cibo si muove per prenderlo . L’uomo ha l’anima intellettiva : non è un’anima che si aggiunge , è solo un’anima più complessa : possiede le funzioni vegetative (come piante e animali) , quelle sensitive (come gli animali) ed in più possiede la funzione intellettiva , la capacità di ragionare ed universalizzare : scire per causas e generalizzare . Le anime si distinguono quantitativamente e non qualitativamente . E’ interessante notare che queste anime vengano chiamate con la funzione che le contraddistingue dalle altre : l’anima sensitiva possiede anche le funzioni vegetative , ma ciò che caratterizza l’animale è il fatto di provare sensazioni . Così l’anima intellettiva caratterizza l’uomo per la facoltà di ragionare : vuol dire che l’uomo non è caratterizzato dal fatto di vivere , ma di pensare . Il pensare è l’essenza dell’uomo . Infatti è quello che lo contraddistingue dagli altri animali : è un animale razionale .
IL NOUS POIETIKOS
A riguardo dell’intelletto umano è nata una delle questioni più complesse della storia della riflessione , questo perchè Aristotele ci fornisce poche informazioni e non chiarissime : abbiamo visto la questione della potenza e dell’atto : ogni cosa che passa dalla potenza all’atto , ha bisogno per far questo dell’intervento di qualcosa già in atto . Questo vale anche per i processi conoscitivi : l’uomo è senziente in potenza finchè non ha una percezione specifica ; così il blu di un libro è un sensibile in potenza finchè non viene percepito : finchè la mia capacità di vedere non si incontra con il colore , io rimango un senziente in potenza ed il blu sensibile in potenza . Quando si incontrano io divento senziente in atto ed il blu sensibile in atto : vale anche per l’intelletto ; nella mia anima si forma la forma sensibile dell’oggetto che vedo , vale a dire la forma senza materia : la forma sensibile in potenza è diventata forma sensibile in atto . Una volta che ho una forma sensibile (o più di una) , devo fare un ulteriore passaggio che non è percepire il libro , ma pensarlo . Pensare e conoscere vuol dire secondo l’universale . Vuol dire deprivare una forma sensibile dalle sue caratteristiche specifiche che ne fanno la forma di quel particolare oggetto per cogliere quell’aspetto generale che ne fa una forma intellegibile : incontro una persona (sensibile in potenza) e diventa sensibile in atto , io senziente in atto : nella mia mente entra la sua forma con le sue caratteristiche specifiche e sensibili ; la capacità intellettiva è quella che fa un altro passaggio : fa passare la forma sensibile in atto al livello atto : conoscere nella persona che incontro la forma uomo (tramite l’induzione) : tolgo le caratteristiche specifiche per arrivare al generale . La forma sensibile in atto è quindi forma intellegibile in potenza : le forme sensibili di tizio e di caio , possono diventare il punto di partenza per il processo di astrazione che mi porta alla forma uomo . Potenzialmente la forma di tizio è forma uomo . L’intelletto in potenza diventa intelletto in atto : l’intelletto in potenza inizialmente è una tabula rasa : prima di arricchirsi con esperienze è vuoto . Ma l’intelletto per passare da potenza ad atto deve avere l’aiuto di qualcosa già in atto ed ecco che Aristotele fa riferimento ad un intelletto definito POIETIKOS (intelletto attivo o produttivo) : io ho intelletto in potenza ; con le esperienze sensibili diventa intelletto in atto : ma ci deve essere qualcosa in atto che consenta il passaggio : ecco il “nous poietikos” (che compare una volta sola in tutte le opere di Aristotele) , quel qualcosa che essendo già in atto (ha cioè già in atto tutte le forme)mi consente il passaggio ; che cosa sia il nous poietikos Aristotele lo dice solo di sfuggita : dice che è qualcosa che sopravviene dall’esterno ed è incorruttibile . Da questa frase buttata lì da migliaia di anni si discute : le possibilità sono diverse : 1) é una parte dell’anima umana : ma se è parte dell’anima umana , sembra che ci sia un pezzetto di anima umana immortale , che già quando nasciamo ha tutte le forme . 2) Questo nous poietikos è uno solo , esterno all’anima : a questo punto è una divinità , ma è la stessa che abbiamo incontrata nella cosmolgia ? Cadremmo di nuovo in contraddizione , perchè quella là pensava solo a se stessa . Qui aiuta gli uomini a pensare , è provvidenziale . Alessandro di Afrodisia diede la prima interpretazione : il nous poietikos è parte dell’individuo e quando si muore muore anch’esso . Averroè dirà che il nous poietikos si identifica con la divinità : è unico e separato . Accettata quest’ipotesi viene comunque negata l’immortalità dell’anima : il nous poietikos è qualcosa al di fuori dell’uomo . Averroè diceva “chi pensa è immortale , chi non pensa crepa” : se pensando si partecipa dell’attività del nous poietikos si partecipa all’immortalità del nous poietikos : si ha una forma di immortalità .
LA POLITICA
La politica riguarda il comportamento della società , mentre l’etica quello del singolo . In Platone il cittadino e l’uomo erano ancora grosso modo un tutt’uno , ma con Aristotele la distinzione si accentua . Aristotele dedica un libro alla politica (“La politica”) . Il punto di partenza è la frase famosa “l’uomo è per natura un animale politico” ; Aristotele dice che non sono politici nè gli animali nè gli dei : solo l’uomo lo è . Cosa significa quest’espressione ? Vuol dire sia che per natura è legato ad una vita comunitaria con gli altri sia che la forma tipica della vita sociale è la polis (termine dal quale deriva la parola politica) . Aristotele come sappiamo ha vissuto rapporti stretti con la Macedonia : tuttavia la politica di Alessandro Magno ha poco a che fare con il pensiero di Aristotele : è legato all’idea che l’uomo è legato alla polis e Alessandro Magno è la nagazione della polis . Aristotele innanzitutto fa notare una cosa : aqltri animali vivono in società , ma è un fatto istintivo : in loro manca l’aspetto organizzativo . Dire che l’uomo per natura è un animale politico significa anche implicitamente negare il cosiddetto “CONTRATTUALISMO” , la tesi secondo la quale lo stato è un contratto , una convenzione fatta a tavolino dagli uomini , che si rendono conto che stare insieme è vantaggioso . Aristotele la pensa diversamente : è un’attitudine naturale ; è vero che gli uomini si raggruppano anche per interesse , per trarre vantaggi : nessuno può fare tutto bene e da sè ed è meglio che ciascuno si specializzi in un’attività . Ma non è un processo convenzionale , bensì è spontaneo . Aristotele dice poi che il fatto di vivere insieme non è solo dettato da esigenze materiali : anche se l’uomo avesse tutto ciò di cui ha bisogno e fosse autonomo tenderebbe lo stesso a vivere insieme ad altri . Vi è una spontanea voglia di stare insieme . L’uomo tende quindi ad aggregarsi in modo naturale : i contrattualisti dicevano che ogni uomo era un atomo nella società . Il carattere naturale per Aristotele comporta il carattere gradualistico : vede nella polis l’ultima gradino dei processi aggregativi : prima c’è il villaggio , e prima ancora la famiglia , il nucleo naturale dei processi di aggregazione sociale , il cui culmine è nella polis . Che la famiglia sia un’associazione naturale e precedente alla polis è un’affermazione importante perchè ha influenzato molto la dottrina cattolica sulla famiglia . La famiglia è la società naturale e primordiale : è nata prima e autonomamente e quindi ha dei suoi diritti . Quando Aristotele parla della famiglia la chiama OIKOS (casa) : è interessante perchè la famiglia è il nucleo primario non solo sul piano degli affetti , ma anche sul piano economico : economia infatti significa regolamentazione dell’oikos . Quando Aristotele parla della famiglia cita 4 figure : padre , madre , figli e schiavi , che svolgevano attività agricole e di servizio per la casa . Anche nella famiglia si formano diversi rapporti di autorità : il padre (il pater familias latino) ha diversi rapporti di autorità sulla moglie , sui figli e sugli schiavi . Il rapporto nei confronti dei figli è temporaneo e dura finchè essi non crescono ; il rapporto nei confronti degli schiavi è permanente . A noi pare sconcertante il concetto di schiavitù , ma Aristotele cerca di fornire argomentazioni valide : tuttavia , lui stesso si accorge di alcune contraddizioni . Lui dice che la schiavitù è un qualcosa di naturale e necessario (da notare che Aristotele tende molto di più di Platone ad accettare le cose come sono : non ci dice come Platone come dovrebbe essere il mondo , ma come è effettivamente) ; anche nello studio della politica Aristotele parte dai phainomena , dalle documentazioni storiche per poi fare confronti tra le varie forme di governo : raccolse tantissime costituzioni e fece le sue considerazioni . Come giustifica la schiavitù ? Dice che esistono individui per natura liberi ed altri per natura schiavi ; l’argomentazione è fondata sulla capacità di deliberare , di ragionare ; Aristotele dice che c’è una parte dell’umanità capace a mettere in pratica le sue capacità mentali (in potenza le abbiamo tutti , si tratta di farle passare in atto ) e una parte che non è capace : non sa fare scelte razionali . Se è così , dice Aristotele , è meglio non solo per i padroni , ma anche per gli schiavi stessi essere schiavi (va ricordato che la schiavitù greca era molto meno pesante di quella romana) : una persona incapace di governarsi autonomamente trae solo benefici dall’essere governata da qualcun altro . Aristotele arriva a definire lo schiavo STRUMENTO INANIMATO . Il vero problema è che in concreto non si diventa schiavi per il fatto che non si è in grado di pensare : si diventa schiavi con le guerre : chi perde diventa schiavo , chi vince diventa padrone . Ricordiamoci che Platone stesso aveva rischiato di diventare schiavo perchè era stato catturato dai pirati : certo Platone in quanto a pensare ne sapeva qualcosa … Aristotele se ne rende conto ma non trova altre via di uscita . Aristotele è stato il fondatore della scienza economica : uno dei concetti fondamentali da lui elaborati è la concezione del denaro e delle sue funzioni . Per lui esistono due modi per usare il denaro , una legittima , l’altra no . L’economia è il governo della casa , il processo con cui si procurano i beni per far funzionare bene la casa . Naturalmente bisogna fare acquisti e scambi : c’è il baratto ma anche l’uso della moneta . Le idee di Aristotele sul denaro verranno addirittura riprese da Marx : l’uso del denaro è legittimo se viene usato per fare acquisti , ma diventa illegittimo se lo si usa non come mezzo ma come fine , quando cioè non lo uso più per fare acquisti ma per accumularlo : Aristotele quindi condanna l’accumulazione (in Greco “crematistikà”) . E’ un uso contro natura del denaro ; questo concetto di secondo natura e contro natura è sempre presente in Aristotele . La natura del denaro , la sua essenza è quella di essere mezzo di scambio . E’ una condanna ante litteram del capitalismo . Passiamo all’analisi politica vera e propria : opera anche lui una catalogazione delle forme di governo . E’ una catalogazione abbastanza simile a quella operata da Platone nel “Politico” : la distinzione tra forme di governo negative e positive è data dal fatto che chi governa governi per l’interesse pubblico o personale . La monarchia è la forma di governo dove il singolo governa per il bene di tutti ; la tirannide quella dove il singolo governa per il proprio bene . L’aristocrazia e l’oligarchia sono lo stesso e così anche la democrazia e la politeia . La democrazia è il governo dei molti : la collettività può governare negli interessi di tutti (politeia) o in quelli della maggioranza che governa (la democrazia) . La politeia è la costituzione per eccellenza (secondo Aristotele) ; in realtà bisogna fare attenzione al fatto che Aristotele divida secondo due criteri politici : a)numerico : governano tanti , pochi… b)sociologico : la democrazia non è solo il governo dei più , ma anche il governo del demos (popolo) : anche in Italiano l’espressione popolo ha duplice valenza : può essere governo della popolazione , ma anche governo del popolo inteso come parte inferiore della società . Condanna la democrazia perchè è il governo della maggioranza popolare , socialmente inferiore , che tende a governare per il proprio interesse , varando leggi a proprio interesse . Per Aristotele la miglior forma di governo è la politeia , la democrazia positiva , quando i più governano bene . La politeia viene vista secondo un criterio quantitativo , ma anche secondo un criterio sociale : Aristotele dice che tutti accetteremmo che fosse uno solo a governare se egli avesse più virtù di tutti gli altri messi insieme : sarebbe il miglior governo , ma è puramente astratto . Nella politeia , per quanto la maggior parte delle persone abbia virtù mediocri , tutto sommato mettendole insieme qualcosa si ottiene : messi insieme non saranno gran chè , ma insieme riusciranno a far funzionare il governo . Sul piano della sociologia come si caratterizza la politeia ? Per il prevalere del ceto medio : la politeia è una democrazia moderata , del ceto medio . Il motivo principale è che è una società non polarizzata , dove non c’è netta distinzione tra ricchi e poveri : una società troppo polarizzata è instabile perchè in perenne conflitto . Quindi sarà una società più stabile ; ma c’è poi un effetto paradossale : noi siamo abituati all’idea che una democrazia funziona tanto meglio quanto più è compartecipata : Aristotele fa un ragionamento opposto . In sostanza dice in maniera più realistica quanto Platone aveva detto nella “Repubblica” : il ceto medio non ha alcun interesse a governare (come i filosofi per Platone ) ; se diamo il potere al ceto medio , è presumibile che esso sarà poco attirato dal governo perchè ha una sua attività economica . Parteciperà moderatamente : Aristotele ha in mente una democrazia tranquilla .
L’ETICA
Passiamo ora all’etica : primo concetto fondamentale è quello di felicità ; l’etica di Aristotele è un’etica eudaimonistica (che mira alla felicità) . Va però fatta una distinzione tra etica EUDAIMONISTICA ed EDONISTICA (che mira al piacere) : Aristotele tende a descrivere come l’uomo si comporta e non come dovrebbe comportarsi . Dice che l’uomo mira alla felicità ; l’etica edonistica è una variante dell’etica eudaimonistica . L’etica epicurea sarà edonistica : l’uomo cerca il piacere . Aristotele non nega che il piacere abbia la sua importanza ; ma la felicità non è il piacere , è qualcosa di più ampio che contiene anche il piacere . L’etica di Aristotele è eudaimonistica ma non edonistica . Il ragionamento di Aristotele è questo : deve arrivare a capire quale è il fine ultimo dell’uomo . Quindi dice che bisogna distinguere i fini in sè ed i fini che mirano a realizzarne altri : è vero che ciascuno ha fini personali , ma in realtà il fine ultimo di tutti è la felicità : cosa vuoi fare ? voglio acquisire un titolo di studio . Ma non è un fine in se stesso : lo fai in funzione di qualcos’altro . Per svolgere una professione . Non è un fine ultimo : lo fai per fare qualcos’altro : per avere soldi . Ma coi soldi voglio andare in vacanza . Ma perchè vuoi andare in vacanza ? Per fare cose che mi piacciono . Perchè vuoi fare quelle cose ? Perchè così sono felice . La felicità è il fine ultimo dell’uomo . Il piacere non è il fine ultimo , ma accompagna e perfeziona ogni attività e sarà tanto migliore quanto migliore è l’attività che esso accompagna . La felicità non viene mai concepita come far niente : è sempre legata all’attività , sia fisica sia intellettiva : la felicità è l’atto di un’azione ben riuscita . Il piacere si accompagna a queste situazioni . Che cos’è la felicità per l’uomo ? La felicità deriva dall’esercizio di un’attività e visto che la specificità dell’uomo è la razionalità , si può dire che la felicità derivi dall’esercizio della ragione . Per gli animali in teoria non si può parlare di felicità , ma comunque la felicità di un cavallo , per esempio , è fare il cavallo . Lo stesso in un certo senso vale per l’uomo . E’ meglio essere sani che malati , belli che brutti e così via , ma non è l’elemento centrale : l’elemento centrale è fare l’uomo , esecitare la ragione . Esercitare la ragione vorrà dire due cose distinte . Aristotele ha distinto ragione teoretica (quella che ci fa conoscere) da ragione pratica (quella in grado di goverrnare razionalmente il nostro comportamento ) . Questa distinziona delle funzioni della ragione governa la distinzione delle due tipologie di VIRTU’: la parola virtù va intesa in senso più generico da come siamo abituati : in Greco è “aretè” ed è l’eccellenza , ciò che fa sì che l’uomo sia veramente uomo , esercitando al meglio le facoltà che gli sono proprie . Ci sono le virtù etiche e le virtù dianoetiche , che riguardano la ragione , la virtù teoretica di per se stessa : le etiche riguardano l’uso della ragione volto a finalità pratiche , mentre le dianoetiche riguardano l’uso della ragione di per se stessa . Le etiche invece hanno a che fare con il costume , l’ethos (il mos latino) . Sono legate a funzioni pratiche . Aristotele considera le virtù etiche come “habitus” , la tendenza di fondo a comportarsi in un determinato modo . Nella fattispecie la virtù è habitus a comportarsi secondo la medietà : la mediocritas latina , la via di mezzo , l’evitare gli estremi . Aristotele in greco la chiama “MESOTES” , la capacità a tenere il giusto mezzo . La virtù è quindi in generale la disposizione costante a cogliere la via di mezzo sempre . Cosa vuol dire ? Ricordiamoci che quella aristotelica (come quella platonica) è l’etica della metriopazia , del controllo delle passioni . Rispetto ad ogni passioni bisogna evitare sia l’eccesso sia l’eliminazione . Per passione intendiamo quegli istinti naturali che la ragione deve saper controllare . Prendiamo come esempio la virtù del coraggio : consisterà in una habitus a mantenere il giusto mezzo di fronte ad una paura . Quale è il giusto mezzo ? Non la codardia , ma nemmeno la temerarietà . Consisterà in una medietà . La medietà di cui parla Aristotele è più qualitativa che quantitativa : l’esempio classico di Aristotele è quello della generosità : non si deve nè essere avari nè prodighi (lo dice anche Dante nel settimo canto dell’Inferno) : la generosità consiste nel dare il giusto . Se essere prodighi vuol dire dare 10 denari ed essere avari vuol dire darne 2 , non è che la generosità consista nel darne 6 (che è la media matematica) : il giusto mezzo è qualcosa di molto più sfumato . Essere generosi vuol dire cogliere il giusto comportamento in ogni singola circostanza . Non è sempre la metà : a volte può essere di più , a volte meno . Chiaro che la generosoità per chi ha tanti soldi è diversa rispetto a chi ne ha pochi . Il problema è questo : l’habitus è innato o acquisito ? Don Abbondio avrebbe optato per la prima ipotesi : il coraggio se non lo si ha non può nascere da sè . Aristotele non sarebbe d’accordo : per lui infatti c’è il problema di un’apparenza di circolo vizioso che lui vuole risolvere . Quale è ? E’ questa : compirà azioni coraggiose chi è coraggioso ; però è anche vero che è compiendo azioni coraggiose che si acquisisce l’habitus . Quindi c’è un circolo vizioso apparente : chi è coraggioso compie azioni coraggiose , chi compie azioni coraggiose diventa coraggioso . In realtà è molto meno vizioso di quel che sembri : è evidente che solo chi sa suonare il pianoforte suona bene il pianoforte . E’ anche vero che non c’è altra maniera per imparare a suonare il pianoforte che suonare il pianoforte . In realtà cosa è che realmente succede ? In una sorta di circolarità aperta mi si dice a livello teorico come fare un accordo con il piano : si acquisiscono pian piano le basi fino ad arrivare a suonare autonomamente . Non è un circolo vizioso . E’ presumibile che Aristotele intendesse dire che ci fossero proprio momenti in cui mettersi a tavolino e studiare il da farsi . La ragione pratica mi fa scegliere il comportamento giusto . Aristotele individua poi il concetto di giustizia distributiva e commutativa . E’ un concetto già intuito da Platone : la giustizia distributiva è quella che distribuisce secondo certi parametri ; quella commutativa è quella che distribuisce in parti uguali . La giustizia distributiva distribuisce determinate cose a gruppi di persone : denaro , onore , potere … Ma secondo quale criterio ? Aristotele sottolinea che i criteri variano a seconda del regime . I regimi democratici distribuivano il potere in base alla cittadinanza , quelli oligarchici in base alla ricchezza e così via . La commutativa è quella che regola gli scambi : non è una questione di proporzione , ma di uguaglianza . In poche parole , mentre con la distributiva ci sarà chi riceverà di più e chi di meno a seconda dei criteri in vigore , con la commutativa non è così : negli atti di compravendita non conta che una persona sia nobile , bella ricca e altro … Se io vendo una cosa voglio che mi si dia in cambio lo stesso valore : è irrilevante se sono più ricco , più bello … Aristotele dice che questo vale sia per i contratti volontari (come quello di compravendita) sia per quelli involontari . Lui definisce il furto “contratto involontario” : uno prende ad un altro una cosa che l’altro non è disposto a dargli ; però vale anche qui la giustizia commutativa : bisogna punire il ladro in modo equivalente al danno che la vittima ha subito e questo vale per tutti . Da notare una cosa : è uno dei tanti modi di concepire la punizione , ma non è il solo . Poi Aristotele fa una classificazione delle virtù dianoetiche , che corrisponde all’elenco dei diversi tipi di scienze : l’arte (tekne) , la saggezza (phronesis) , la scienza , l’intelletto e la sapienza . Apparentemente non corrisponde : le scienze erano 3 e qui troviamo 5 nomi . In realtà in pratica corrisponde : sono 5 virtù del sapere . L’arte corrisponde alle scienze poietiche (è un sapere che mira a produrre) , la saggezza corrisponde alle scienze pratiche (saggezza è ben diverso da sapienza : è il sapere che mi permette di governare il mio comportamento) , tutte le altre 3 corrispondono alle teoretiche : la sapienza è la somma di scienza ed intelletto : l’intelletto è la capacità di cogliere i principi di una dimostrazione , la scienza è la capacità di dimostrare . Mettendo insieme queste due facoltà ottengo la sapienza . C’è una sovrapposizione tra le scienze etiche e tra le dianoetiche : la saggezza : è una forma del sapere , ma essendo forma di sapoere che riguarda il saper fare , il comportarsi è chiaro che è la ragione che mi consente di sviluppare le virtù etiche : le scelte umane si fanno con la saggezza . Il tema conclusivo dell’etica è l’AMICIZIA : ci son diversi tipi di amicizia : a) per utilità : sono amico di uno perchè ne traggo vantaggi ; b) per piacere : sono amico di uno perchè mi fa piacere (magari è una persona divertente); c) amicizia disinteressata , fondata sulla virtù : lega i buoni ed i buoni naturalmente . L’amicizia non è necessariamente legata all’utilità o al piacere ; come nella politica dicevamo che l’uomo per natura è animale politico , qui l’uomo per natura cerca amicizie , è animale socievole . Nessun uomo fa a meno di avere amicizie . La vera amicizia è quella fondata sulla virtù : è l’unica che lega buoni con buoni . Aristotele fa notare che se anche l’uomo potesse fare a meno da un punto di vista pratico delle amicizie , tenderebbe ugualmente ad averne . La conclusione è incentrata sulla ricerca del modello ultimo di vita da imitare . Fa una distinzione che in Platone non c’era : Platone era molto socratico ed il sapiente platonico era quello che sapeva e che era giusto di conseguenza . In Aristotele c’è collegamento tra scienza e virtù , ma non una sovrapposizione (come invece c’era per Platone ); sul piano umano il modello di vita è quello fondato sulle virtù etiche : il modello del buon cittadino . In realtà però le virtù dianoetiche sono superiori , però il seguire perfettamente le virtù dianoetiche è un qualcosa di sovraumano . Chi è il modello del sapiente che segue la virtù dianoetica ? La divinità . Essa pensa sempre e all’oggetto supremo : una vita contemplativa , di studio , intellettuale . E’ ancora superiore rispetto al cittadino , ma è sovraumano : anche il filosofo che cerca di seguire le virtù dianoetiche si avvicina alla divinità . Ma la divinità svolge quell’attività di continuo , il filosofo lo può fare solo in qualche momento : ha esigenze biologiche , politiche , economiche … Solo in pochi momenti gode della virtù divina . E’ una posizione intermedia quella di Aristotele . Il sapiente è ancorato al divino in primo luogo perchè gli oggetti del suo sapere sono divini : egli infatti cerca di scoprire i principi e le cause che sono all’origine del mondo . Va poi detto che la divinità stessa è l’esatta proiezione della vita del sapiente : il pensare , la “theoria” , è l’attività propria della divinità , che però a differenza del sapiente , la esercita ininterrottamente .
L’ETICA
Passiamo ora all’etica : primo concetto fondamentale è quello di felicità ; l’etica di Aristotele è un’etica eudaimonistica (che mira alla felicità) . Va però fatta una distinzione tra etica EUDAIMONISTICA ed EDONISTICA (che mira al piacere) : Aristotele tende a descrivere come l’uomo si comporta e non come dovrebbe comportarsi . Dice che l’uomo mira alla felicità ; l’etica edonistica è una variante dell’etica eudaimonistica . L’etica epicurea sarà edonistica : l’uomo cerca il piacere . Aristotele non nega che il piacere abbia la sua importanza ; ma la felicità non è il piacere , è qualcosa di più ampio che contiene anche il piacere . L’etica di Aristotele è eudaimonistica ma non edonistica . Il ragionamento di Aristotele è questo : deve arrivare a capire quale è il fine ultimo dell’uomo . Quindi dice che bisogna distinguere i fini in sè ed i fini che mirano a realizzarne altri : è vero che ciascuno ha fini personali , ma in realtà il fine ultimo di tutti è la felicità : cosa vuoi fare ? voglio acquisire un titolo di studio . Ma non è un fine in se stesso : lo fai in funzione di qualcos’altro . Per svolgere una professione . Non è un fine ultimo : lo fai per fare qualcos’altro : per avere soldi . Ma coi soldi voglio andare in vacanza . Ma perchè vuoi andare in vacanza ? Per fare cose che mi piacciono . Perchè vuoi fare quelle cose ? Perchè così sono felice . La felicità è il fine ultimo dell’uomo . Il piacere non è il fine ultimo , ma accompagna e perfeziona ogni attività e sarà tanto migliore quanto migliore è l’attività che esso accompagna . La felicità non viene mai concepita come far niente : è sempre legata all’attività , sia fisica sia intellettiva : la felicità è l’atto di un’azione ben riuscita . Il piacere si accompagna a queste situazioni . Che cos’è la felicità per l’uomo ? La felicità deriva dall’esercizio di un’attività e visto che la specificità dell’uomo è la razionalità , si può dire che la felicità derivi dall’esercizio della ragione . Per gli animali in teoria non si può parlare di felicità , ma comunque la felicità di un cavallo , per esempio , è fare il cavallo . Lo stesso in un certo senso vale per l’uomo . E’ meglio essere sani che malati , belli che brutti e così via , ma non è l’elemento centrale : l’elemento centrale è fare l’uomo , esecitare la ragione . Esercitare la ragione vorrà dire due cose distinte . Aristotele ha distinto ragione teoretica (quella che ci fa conoscere) da ragione pratica (quella in grado di goverrnare razionalmente il nostro comportamento ) . Questa distinziona delle funzioni della ragione governa la distinzione delle due tipologie di VIRTU’: la parola virtù va intesa in senso più generico da come siamo abituati : in Greco è “aretè” ed è l’eccellenza , ciò che fa sì che l’uomo sia veramente uomo , esercitando al meglio le facoltà che gli sono proprie . Ci sono le virtù etiche e le virtù dianoetiche , che riguardano la ragione , la virtù teoretica di per se stessa : le etiche riguardano l’uso della ragione volto a finalità pratiche , mentre le dianoetiche riguardano l’uso della ragione di per se stessa . Le etiche invece hanno a che fare con il costume , l’ethos (il mos latino) . Sono legate a funzioni pratiche . Aristotele considera le virtù etiche come “habitus” , la tendenza di fondo a comportarsi in un determinato modo . Nella fattispecie la virtù è habitus a comportarsi secondo la medietà : la mediocritas latina , la via di mezzo , l’evitare gli estremi . Aristotele in greco la chiama “MESOTES” , la capacità a tenere il giusto mezzo . La virtù è quindi in generale la disposizione costante a cogliere la via di mezzo sempre . Cosa vuol dire ? Ricordiamoci che quella aristotelica (come quella platonica) è l’etica della metriopazia , del controllo delle passioni . Rispetto ad ogni passioni bisogna evitare sia l’eccesso sia l’eliminazione . Per passione intendiamo quegli istinti naturali che la ragione deve saper controllare . Prendiamo come esempio la virtù del coraggio : consisterà in una habitus a mantenere il giusto mezzo di fronte ad una paura . Quale è il giusto mezzo ? Non la codardia , ma nemmeno la temerarietà . Consisterà in una medietà . La medietà di cui parla Aristotele è più qualitativa che quantitativa : l’esempio classico di Aristotele è quello della generosità : non si deve nè essere avari nè prodighi (lo dice anche Dante nel settimo canto dell’Inferno) : la generosità consiste nel dare il giusto . Se essere prodighi vuol dire dare 10 denari ed essere avari vuol dire darne 2 , non è che la generosità consista nel darne 6 (che è la media matematica) : il giusto mezzo è qualcosa di molto più sfumato . Essere generosi vuol dire cogliere il giusto comportamento in ogni singola circostanza . Non è sempre la metà : a volte può essere di più , a volte meno . Chiaro che la generosoità per chi ha tanti soldi è diversa rispetto a chi ne ha pochi . Il problema è questo : l’habitus è innato o acquisito ? Don Abbondio avrebbe optato per la prima ipotesi : il coraggio se non lo si ha non può nascere da sè . Aristotele non sarebbe d’accordo : per lui infatti c’è il problema di un’apparenza di circolo vizioso che lui vuole risolvere . Quale è ? E’ questa : compirà azioni coraggiose chi è coraggioso ; però è anche vero che è compiendo azioni coraggiose che si acquisisce l’habitus . Quindi c’è un circolo vizioso apparente : chi è coraggioso compie azioni coraggiose , chi compie azioni coraggiose diventa coraggioso . In realtà è molto meno vizioso di quel che sembri : è evidente che solo chi sa suonare il pianoforte suona bene il pianoforte . E’ anche vero che non c’è altra maniera per imparare a suonare il pianoforte che suonare il pianoforte . In realtà cosa è che realmente succede ? In una sorta di circolarità aperta mi si dice a livello teorico come fare un accordo con il piano : si acquisiscono pian piano le basi fino ad arrivare a suonare autonomamente . Non è un circolo vizioso . E’ presumibile che Aristotele intendesse dire che ci fossero proprio momenti in cui mettersi a tavolino e studiare il da farsi . La ragione pratica mi fa scegliere il comportamento giusto . Aristotele individua poi il concetto di giustizia distributiva e commutativa . E’ un concetto già intuito da Platone : la giustizia distributiva è quella che distribuisce secondo certi parametri ; quella commutativa è quella che distribuisce in parti uguali . La giustizia distributiva distribuisce determinate cose a gruppi di persone : denaro , onore , potere … Ma secondo quale criterio ? Aristotele sottolinea che i criteri variano a seconda del regime . I regimi democratici distribuivano il potere in base alla cittadinanza , quelli oligarchici in base alla ricchezza e così via . La commutativa è quella che regola gli scambi : non è una questione di proporzione , ma di uguaglianza . In poche parole , mentre con la distributiva ci sarà chi riceverà di più e chi di meno a seconda dei criteri in vigore , con la commutativa non è così : negli atti di compravendita non conta che una persona sia nobile , bella ricca e altro … Se io vendo una cosa voglio che mi si dia in cambio lo stesso valore : è irrilevante se sono più ricco , più bello … Aristotele dice che questo vale sia per i contratti volontari (come quello di compravendita) sia per quelli involontari . Lui definisce il furto “contratto involontario” : uno prende ad un altro una cosa che l’altro non è disposto a dargli ; però vale anche qui la giustizia commutativa : bisogna punire il ladro in modo equivalente al danno che la vittima ha subito e questo vale per tutti . Da notare una cosa : è uno dei tanti modi di concepire la punizione , ma non è il solo . Poi Aristotele fa una classificazione delle virtù dianoetiche , che corrisponde all’elenco dei diversi tipi di scienze : l’arte (tekne) , la saggezza (phronesis) , la scienza , l’intelletto e la sapienza . Apparentemente non corrisponde : le scienze erano 3 e qui troviamo 5 nomi . In realtà in pratica corrisponde : sono 5 virtù del sapere . L’arte corrisponde alle scienze poietiche (è un sapere che mira a produrre) , la saggezza corrisponde alle scienze pratiche (saggezza è ben diverso da sapienza : è il sapere che mi permette di governare il mio comportamento) , tutte le altre 3 corrispondono alle teoretiche : la sapienza è la somma di scienza ed intelletto : l’intelletto è la capacità di cogliere i principi di una dimostrazione , la scienza è la capacità di dimostrare . Mettendo insieme queste due facoltà ottengo la sapienza . C’è una sovrapposizione tra le scienze etiche e tra le dianoetiche : la saggezza : è una forma del sapere , ma essendo forma di sapoere che riguarda il saper fare , il comportarsi è chiaro che è la ragione che mi consente di sviluppare le virtù etiche : le scelte umane si fanno con la saggezza . Il tema conclusivo dell’etica è l’AMICIZIA : ci son diversi tipi di amicizia : a) per utilità : sono amico di uno perchè ne traggo vantaggi ; b) per piacere : sono amico di uno perchè mi fa piacere (magari è una persona divertente); c) amicizia disinteressata , fondata sulla virtù : lega i buoni ed i buoni naturalmente . L’amicizia non è necessariamente legata all’utilità o al piacere ; come nella politica dicevamo che l’uomo per natura è animale politico , qui l’uomo per natura cerca amicizie , è animale socievole . Nessun uomo fa a meno di avere amicizie . La vera amicizia è quella fondata sulla virtù : è l’unica che lega buoni con buoni . Aristotele fa notare che se anche l’uomo potesse fare a meno da un punto di vista pratico delle amicizie , tenderebbe ugualmente ad averne . La conclusione è incentrata sulla ricerca del modello ultimo di vita da imitare . Fa una distinzione che in Platone non c’era : Platone era molto socratico ed il sapiente platonico era quello che sapeva e che era giusto di conseguenza . In Aristotele c’è collegamento tra scienza e virtù , ma non una sovrapposizione (come invece c’era per Platone ); sul piano umano il modello di vita è quello fondato sulle virtù etiche : il modello del buon cittadino . In realtà però le virtù dianoetiche sono superiori , però il seguire perfettamente le virtù dianoetiche è un qualcosa di sovraumano . Chi è il modello del sapiente che segue la virtù dianoetica ? La divinità . Essa pensa sempre e all’oggetto supremo : una vita contemplativa , di studio , intellettuale . E’ ancora superiore rispetto al cittadino , ma è sovraumano : anche il filosofo che cerca di seguire le virtù dianoetiche si avvicina alla divinità . Ma la divinità svolge quell’attività di continuo , il filosofo lo può fare solo in qualche momento : ha esigenze biologiche , politiche , economiche … Solo in pochi momenti gode della virtù divina . E’ una posizione intermedia quella di Aristotele . Il sapiente è ancorato al divino in primo luogo perchè gli oggetti del suo sapere sono divini : egli infatti cerca di scoprire i principi e le cause che sono all’origine del mondo . Va poi detto che la divinità stessa è l’esatta proiezione della vita del sapiente : il pensare , la “theoria” , è l’attività propria della divinità , che però a differenza del sapiente , la esercita ininterrottamente .
LA PEDAGOGIA
A cura di GUIDO MARENCO .
Aristotele, come č noto, scrisse un mare di trattati su di un mare di argomenti, ma i suoi interventi specifici sul problema dell’educazione risultano sempre inseriti in altri testi ed altri contesti. Ciň potrebbe ingenerare la convinzione di uno scarso interesse del filosofo per la pedagogia, mentre č vero il contrario: Aristotele fu in pratica un maestro ed un insegnante di tipo nuovo, inventň un modello di “scuola attiva”, cioč di scuola che stimolava l’autonoma iniziativa degli allievi, che era forse il primo della storia, il Liceo, ed all’interno di questo modello propose un approccio agli studi tipicamente moderno e scientifico, basato sia sulla specializzazione della ricerca per aree tematiche, sia sulla osservazione e sulla raccolta dei “dati”. In piů possiamo osservare che tutta la produzione filosofica dello stagirita č in qualche modo una “pedagogia” rivolta agli adulti, quasi una forma di moderna educazione permanente. In questo dunque egli rinnovň ed innovň una tradizione preesistente, quella della paidčia, cioč della cultura come abito mentale del buon cittadino, contrapposto sia al “rustico”, cioč all’uomo di campagna incolto, sia al “barbaro”, cioč al non Greco. In Platone il tema della paidčia č trattato diffusamente nella “Repubblica” e genera insieme approvazione da un lato, e istintivi dissensi dall’altro, specie per le teorizzazioni piuttosto artificiose sulla liquidazione della famiglia, la comunanza delle donne, l’allevamento programmato dei futuri cittadini-automi, piů che cittadini autonomi e responsabili. Aristotele prende indubbiamente le distanze da questo modello in quanto egli comprende che in generale il fine dell’educazione non č quello di formare dei buoni governanti di cittadini non autosufficienti, ma buoni cittadini autosufficienti in grado di scegliersi i governanti. In pratica egli comprese che il fine dell’educazione non puň essere subordinato ad una selezione preventiva. Si semina e chi raccoglie č piů bravo di chi non raccoglie. Tra chi raccoglie poi vi sarŕ chi sceglie di studiare: a questi sarŕ dato di piů. (ad esempio, nel modello del Liceo, la possibilitŕ di frequentare i corsi del mattino) Non solo: egli teorizzň anche una distinzione tra “l’esser buono” ed “esser buon cittadino”, comprendendo che, in fondo, anche l’uomo non buono puň adattarsi ad alcune regole di convivenza, se queste diventano un’abitudine. Si tratta, in fondo, di una vera “teoria” della democrazia, l’unica vera teoria accettabile ancor oggi. Questo č vero anche se, per la veritŕ, Aristotele non parlň della democrazia come forma di governo migliore rispetto alle altre. Tuttavia č anche vero che egli criticň le forme di governo assolutistiche, tiranniche e totalitarie e, probabilmente, rinvenne nei libri di Platone dedicati allo stato un principio di totalitarismo, ovvero non solo una dittatura che vieta alcune libertŕ, ma una forma di governo che pretende di prescrivere la vita di ognuno, dicendo in anticipo come deve essere e cosa si deve fare persino nella sfera privata. In Politica II,2 Aristotele osserva in proposito che << E’ evidente, dunque, da queste considerazioni, che lo stato (la polis) per sua natura non deve avere quell’unitŕ di cui parlano alcuni e che quel che si vanta come il piů grande bene, in realtŕ li distrugge: e invero č il bene di ciascuna cosa che conserva ciascuna cosa. Pure in un altro modo si dimostra che cercare una eccessiva unitŕ per lo stato non č il meglio. Infatti la famiglia č piů autosufficiente dell’individuo, lo stato piů della famiglia e uno stato vuol essere veramente tale quando la comunitŕ dei suoi componenti arriva ad essere ormai autosufficiente:se quindi č preferibile una maggiore autosufficienza sarŕ preferibile pure una unitŕ meno stretta ad una piů stretta.>> Anche in Aristotele, pertanto, l’educazione dell’uomo coincide con la formazione civica del cittadino, ma in chiave di convivenza democratica. La felicitŕ č possibile se un individuo si realizza. Il fine dell”educazione č aiutare l’individuo a realizzarsi. Alcuni individui, i migliori, si realizzano solo se scelgono (ed hanno la possibilitŕ di farlo) una vita teoretica. Per questo la tematica educativa, da un lato, si allarga smisuratamente alla attivitŕ teoretica distinta da quello etico-pratica, e sembra quindi proporre quanto vi sia di piů disdicevole nella vita umana: la scissione tra teoria e pratica. Ma in realtŕ la riflessione teoretica interessa eminentemente la vita pratica ed č ormai consolidato che solo attraverso il distanziamento dalle cose che le possiamo pensare obiettivamente. Dall’altro lato Aristotele coglie indubbiamente una necessitŕ reale dell’individuo, quantomeno di alcuni individui, cioč il bisogno di conoscenza come fattore primario ed elemento costituitivo e necessario della stessa “felicitŕ” umana. Ovviamente questo amore per il “sapere” non puň essere inteso in senso restrittivo, come amore per la sola “filosofia” come la conosciamo e la intendiamo oggi. Il sapere era per Aristotele conoscenza universale (potremmo dire “enciclopedica”) e interessava in modo unitario tutte le possibili discipline, dalla “fisica”, cioč la natura, all'”etica”, cioč le forme della convivenza umana e politica, dalla matematica alla biologia, dalla retorica alla poetica ( e quindi l’arte della rappresentazione), dalla ginnastica alla musica. La particolare attenzione riservata al linguaggio nei libri raccolti nell’Organon testimonia poi di una importanza decisiva della dialettica, dell’analitica e della logica in quanto aspetti diversi di un medesimo sapere, quello della comunicazione dotata di senso. E’ certamente dall’Organon, oltre che dai libri di psicologia, che possiamo dedurre le basi della conoscenza in Aristotele, e quindi riformulare un percorso in qualche modo organico che abbracci l’insieme dei metodi e dei contenuti pedagogici dello stagirita. Lungi dal voler restringere il campo della filosofia ( e della pedagogia) ad una semplice analitica, resta da dire che il compito dell’educatore in generale č con Aristotele delineato: portare l’individuo all’autosufficienza, offrirgli una cultura sia generale che specialistica per aiutarlo nella realizzazione.
IL TEMPO
Nel IV libro della Fisica (Fisica, IV, 10, 218 a) Aristotele tratta l’ annosissimo problema del tempo , lasciatogli in eredità da Platone : si potrebbe sostenere, dice, che il tempo non esiste, dato che è composto di passato e di futuro, di cui l’uno non esiste più quando l’altro non esiste ancora . Egli pero respinge questa teoria. Il tempo, dice, è moto che ammette una numerazione . Potremmo anche chiedere, continua, se il tempo potrebbe esistere senza l’anima, dato che non ci puo esser nulla da contare se non c’è nessuno che conta, e il tempo implica la numerazione. Sembra che egli pensi al tempo come a un determinato numero di ore, di giorni e di anni. Alcune cose, aggiunge, sono eterne, nel senso che non sono nel tempo; probabilmente pensa a cose del tipo dei numeri o delle verità matematiche : che 2 + 2 = 4 é sempre stato così e sempre sarà così , anche con un improvviso annichilimento della realtà . C’è sempre stato il movimento, e sempre ci sarà, perchè non ci puo esser tempo senza movimento, e tutti ammettono che il tempo sia increato. Su questo punto, i seguaci cristiani di Aristotele furono obbligati a dissentire da lui, dato che la Bibbia ci dice che l’universo ebbe un inizio. Il concetto di eternità , che é centrale in Aristotele , non può che essere disapprovato dai Cristiani , la cui teoria consiste nel fatto che Dio decise di creare il mondo ad un certo momento ; ne consegue che il mondo non é eterno , anzi é destinato a perire . D’ altronde , spiega Aristotele , le sfere dei pianeti non fanno nient’ altro che imitare nel loro moto circolare l’ eternità di Dio : quale é il moto che meglio rappresenta di quello circolare l’ eternità ? Il moto circolare infatti non ha inizio e non ha fine , arriva da dove é partito . Le sfere rappresentano l’eternità , o meglio , un’eternità speciale . Sia la realtà sublunare sia quella celeste ha una sua forma di eternità : il mondo sublunare ha un’eternità specifica , che cogliamo soprattutto nell’eternità delle specie , il mondo celeste ha una eternità numerica : tra queste due forme di eternità intercorre una forma di rapporto : la ciclicità degli enti celesti detta l’alternarsi delle stagioni : possiamo quindi affermare che la ciclicità specifica è in gran parte dettata da quella numerica . Sant’ Agostino dirà : “Non ci fu dunque un tempo, durante il quale avresti fatto nulla, poichè il tempo stesso l’hai fatto tu; e non vi è un tempo eterno con te […]” (Agostino, Confessioni, libro XI, cap. 27, risposta 17) (Fisica, IV, 10, 217 b, 34) Che dunque o non esista affatto, o che esista a stento e in modo oscuro, si potrebbe supporre da queste considerazioni. In effetti, una parte di esso è stata e non è, una parte sarà e non è ancora. Aristotele dice che l’infinito esiste solo come potenza o in potenza. Infinito in potenza è, ad esempio, il numero, perché è possibile aggiungere a qualsivoglia numero sempre un ulteriore numero senza che si arrivi a un numero estremo al di là del quale non si possa più andare; infinito in potenza è anche lo spazio, perché è divisibile all ‘infinito, in quanto il risultato della divisione è sempre una grandezza che, come tale , è ulteriormente divisibile ; infinito potenziale, infine, è anche il tempo, che non può esistere tutto insieme attualmente, ma si svolge e si accresce senza fine. Aristotele nega che esista un infinito in atto. Aristotele diceva che il tempo è la condizione del prima e del dopo e l’anima effettua l’operazione del contare. Oggi diremmo la memoria.
RIASSUNTO Metafìsica
Non è facile parlare della “Metafisica”. In primo luogo perché non ci troviamo di fronte ad un’opera filosofica nel vero senso della parola, ma, piuttosto, ad un insieme di scritti di diverse età riuniti insieme in parte dallo stesso Aristotele, in parte da editori successivi. In secondo luogo perché, come tutte le opere aristoteliche che ci sono pervenute, si tratta di uno scritto non destinato alla pubblicazione, ma ad uso scolastico; ci troviamo cioè di fronte non ad un’opera definita, rivista ed esauriente, ma di fronte ad una raccolta di appunti stringati che Aristotele sviluppava poi a lezione. Insomma, più che di un’opera in senso pieno, si tratta di un vero e proprio zibaldone filosofico, privo di unità letteraria e di unitarietà di gestazione cronologica, ma unitario dal punto di vista speculativo – almeno nei suoi concetti portanti: alla tesi di Werner Jaeger, secondo cui la “Metafisica” costituirebbe un’inorganica unione di scritti diversi e composti in età differenti si contrappone quella di Giovanni Reale, per il quale invece l’opera aristotelica ha una sua profonda unitarietà. Il primo grande problema in cui si imbatte il lettore della “Metafisica”, è il titolo: non solo non fu Aristotele ad intitolare “Metafisica” quest’insieme di scritti, ma addirittura egli ignorava il termine, che fu invece adoperato dai suoi editori di età successive. In particolare, pare che possa essere stato Andronico a coniare il termine e ad attribuirlo allo scritto aristotelico; in questo senso, τα μετα τα φυσικα avrebbe un senso banalmente editoriale di “cose (meglio, “libri”) che vengono dopo quelli di fisica”; vale a dire che, nell’edizione di Andronico, gli scritti aristotelici di fisica occupavano una posizione preminente. Ma è possibile anche una seconda interpretazione del titolo aristotelico, riferibile ad Eudemo di Rodi (discepolo di Aristotele stesso) ed esulante dal significato meramente editoriale voluto da Andronico. In questa nuova accezione, τα μετα τα φυσικα si colora di un nuovo significato: μετα in greco può sia significare “dopo” sia “sopra”, cosicchè il titolo dell’opera aristotelica vorrebbe dire “cose che stanno dopo quelle fisiche” o “cose che stanno sopra quelle fisiche”. Secondo la prima possibilità, parrebbe che il nostro spirito sia strutturato in maniera tale da indagare dapprima le realtà fisicamente concrete e, solo in un secondo tempo (cioè dopo aver su di esse proiettato la propria indagine), passare all’investigazione su quelle non sensibili; si tratterebbe dunque di una scienza che viene dopo quella fisica. Nella seconda accezione, quella secondo cui μετα starebbe a significare “sopra”, metafisica sarebbe l’indagine delle realtà che stanno sopra quelle fisiche: si tratterebbe dunque della conoscenza di una realtà trascendente. La sovrapposizione di questi due possibili significati (μετα sia come “dopo” sia come “sopra”) è a molti studiosi sembrata inopportuna, ma, se letta in trasparenza, pare alquanto adeguata, non solo perché il testo aristotelico giustifica ampiamente entrambe le possibili traduzioni, ma anche perché le due accezioni di μετα sono, in qualche modo, compresenti e integrantisi a vicende. Il primo libro dell’opera, strutturata in quattordici libri, si apre con un incipit famosissimo, destinato a diventare quasi proverbiale (ancora Dante, nel Convivio, lo riprende con entusiasmo): παντες ανθροποι του ειδέναι ορεγονται φυσει (tutti gli uomini tendono per natura alla conoscenza). Che tutti gli uomini aspirino al conseguimento del sapere, per loro inclinazione naturale, appare ad Aristotele evidente da una prova (σημειον) assolutamente inconfutabile: l’amore fine a se stesso che essi hanno per le sensazioni, alle quali non rinuncerebbero per nulla al mondo. Ammettendo per assurdo che esse non abbiano alcuna utilità, ci sarebbe qualcuno di noi disposto a privarsi delle sensazioni che l’accompagnano ogni istante? Certo che no. In particolare, quella che è più cara agli uomini è la vista, che non a caso è quella che – più di ogni altra – ci permette di conoscere. Tutti gli animali sono forniti di sensazione: come precisa nel suo scritto sull’anima (Περι ψυχης), tutti gli animali, anche i più semplici, sono almeno dotati del senso del tatto, indispensabile per la vita; in ciò risiede la differenza dal mondo vegetale, vivente anch’esso, ma incapace di avere sensazioni. La natura ha fornito ogni animale di sensazioni, ma non a tutti ha concesso che da esse nascesse la memoria, in virtù della quale si può imparare: è infatti dall’accumulo di dati nella memoria che è possibile apprendere gradualmente. L’esser privi della memoria, però, non implica necessariamente la mancanza di intelligenza, tutt’al più comporta l’impossibilità di imparare, impossibilità che caratterizza anche tutti quegli animali che, seppur provvisti di memoria, mancano dell’udito. E’ questo il caso dell’ape: essa è indubbiamente un animale intelligente, perché agisce in vista di fini ben precisi, e per di più è in grado di memorizzare immagini; ma, ciononostante, – specifica Aristotele – non è dotata dell’udito e quindi non potrà mai apprendere. L’uomo, dal canto suo, sta su un gradino superiore rispetto a tutti gli altri animali, i quali vivono di immagini sensibili e di ricordi, ma non di tecnica e di ragionamenti (τεχνη και λογισμοις): dalla memorizzazione delle esperienze, gli uomini sono in grado di produrre la scienza e la tecnica, formando giudizi generali a partire da casi individuali. L’esempio che a tal proposito adduce Aristotele è illuminante: se Callia è affetto da una certa malattia, l’esperienza mi attesterà che questa data cura ha precedentemente giovato ad altri uomini affetti dalla stessa malattia; la tecnica, invece, mi suggerirà che a tutti i malati di quel tipo giova quella certa cura. Ma sembra che la differenza tra tecnica ed esperienza (differenza che risiede nel fatto che l’esperienza conosce i particolari, la tecnica gli universali) sia minima, quasi inesistente: e in effetti Aristotele nota come chi ha acquisito una nutrita serie di esperienze, pur mancando della teoria, può avere successo, di sicuro più di chi è dotato di teoria ma privo di esperienza. Chi ha la teoria, conosce i casi universali; chi ha l’esperienza conosce invece i casi singoli e ha maggior successo in campo medico (ma non solo medico) perché la cura è sempre destinata ai casi singoli (Socrate, Callia, ecc: mai all’uomo, all’animale, ecc). Ciò non toglie, tuttavia, che la tecnica sia incommensurabilmente superiore rispetto all’esperienza, giacchè – a differenza di questa – rende conto delle cause ed è trasmissibile attraverso l’insegnamento: chi possiede esclusivamente l’esperienza, infatti, non sa né render conto del perché né insegnare ad altri le proprie acquisizioni. Anche chi ne ha fatto esperienza sa che quel determinato rimedio alla data malattia è stato efficace in una pluralità di casi, ma non sa perché e non è in grado di trasmetterlo ad altri. Anche la tecnica, però, non rappresenta per Aristotele il vertice del sapere: questo perchè la tecnica, in tutte le sue manifestazioni, è subordinata a fini diversi dalla conoscenza ed è destinata – ciò vale per le prime tecniche inventate dagli uomini – a soddisfare i bisogni primari e a garantire la sopravvivenza. Il loro scopo è dunque l’utilità, ma anche arti, inventate successivamente, come per esempio la musica, pur non avendo come fine l’utilità, hanno tuttavia un fine diverso dalla conoscenza: esse mirano infatti a produrre piacere o diletto. Al di sopra delle tecniche si colloca, dunque, una forma di conoscenza che ha di mira soltanto se stessa: il conoscere per il conoscere, ossia la conoscenza disinteressata, veramente libera, non subordinata a fini esterni ad essa. Questa è la σοφια, il sapere più alto, a cui mira la filosofia. Un autentico sapere che renda conto delle cause e dei principi e che non serva a nulla: proprio perché libera da ogni vincolo di servitù, la σοφια è il sapere più nobile (degno di un Dio), che più d’ogni altro merita di essere seguito: “è evidente che, come diciamo uomo libero colui che è fine a se stesso e non è asservito ad altri, così questa sola, tra tutte le altre scienze, la diciamo libera: essa sola, infatti, è fine a se stessa” (982 b 25). Tanto più che, come Aristotele ripete anche in altri suoi scritti, l’uomo è per natura “animale razionale”, che trova la propria massima realizzazione nel pensare. In tal modo, Aristotele ha elaborato una nozione di sapere ormai lontana dal significato arcaico di sapere come saper fare, cioè di un sapere legato e funzionale al produrre. Ma come nasce la filosofia? Aristotele, qui in sintonia con Platone, ravvisa nella meraviglia il motore dell’indagine filosofica: è a causa della meraviglia (δια το θαυμαζειν) che è scattata l’esigenza di porsi domande e tentare di rispondere ad esse; è di fronte a cose meravigliose (quali i fenomeni lunari e solari, o la generazione dell’universo) perché inesplicabili che l’uomo ha cominciato ad esercitare la filosofia, δια το φευγειν την αγνοιαν (“per sfuggire all’ignoranza”). Di fronte ad una cosa sconosciuta, che desta in noi un senso di meraviglia, proviamo a rispondere essenzialmente a due domande: che cos’è? perché è? E la filosofia nasce appunto come tentativo di fornire una risposta a queste imbarazzanti domande, che non possiamo affatto eludere, giacchè è la nostra stessa natura di esseri miranti al sapere che ce le impone e non s’acquieta finchè non ha risposto ad esse. La filosofia è dunque tenuta non solo a spiegare il “che cosa” (τι), ma anche il “perché” (διοτι) e, sotto questo profilo, si configura come ricerca delle cause: i medioevali diranno, con un motto divenuto proverbiale ma che rispecchia fedelmente la prospettiva aristotelica, che “verum scire est scire per causas”. Fin tanto che ignoriamo le cause che le producono, anche le cose più banali (come una marionetta che si muove, dice Aristotele) è per noi fonte di incredibile meraviglia: una volta spiegato il “perché” di quelle cose, la meraviglia intorno ad esse cessa, viene sconfitta e cede il passo alla conoscenza. Ma chi è assillato dal dubbio ed è animato dalla meraviglia, riconosce apertamente di non sapere, giacchè – se sapesse – non si troverebbe in tale condizione: ed è per questo motivo che, in un certo senso, anche l’amante dei miti (φιλομυθος) è una sorta di filosofo; anche il mito, infatti, è costruito intorno a cose che destano stupore e che ci spingono alla ricerca delle cause che le han prodotte, anche se – a differenza della filosofia – si tratta di un’indagine extra- razionale, che percorre vie alternative a quelle dettate dalla ragione:
“Gli uomini hanno cominciato a filosofare, ora come in origine, a causa della meraviglia: mentre da principio restavano meravigliati di fronte alle difficoltà più semplici, in seguito, progredendo a poco a poco, giunsero a porsi problemi sempre maggiori: per esempio i problemi riguardanti i fenomeni della luna e quelli del sole e degli altri astri, o i problemi riguardanti la generazione dell’intero universo. Ora, chi prova un senso di dubbio e di meraviglia riconosce di non sapere; ed è per questo che anche colui che ama il mito è, in certo qual modo, filosofo: il mito, infatti, è costituito da un insieme di cose che destano meraviglia. Cosicchè, se gli uomini hanno filosofato per liberarsi dall’ignoranza, è evidente che ricercano il conoscere solo al fine di sapere e non per conseguire qualche utilità pratica. E il modo stesso in cui si sono svolti i fatti lo dimostra: quando già c’era pressochè tutto ciò che necessitava alla vita ed anche all’agiatezza ed al benessere, allora si incominciò a ricercare questa forma di conoscenza. E’ evidente, dunque, che noi non la ricerchiamo per nessun vantaggio che sia estraneo ad essa; e, anzi, è evidente che, come diciamo uomo libero colui che è fine a se stesso e non è asservito ad altri, così questa sola, tra tutte le altre scienze, la diciamo libera: essa sola, infatti, è fine a se stessa”. (A2 982b) In questo modo, la prospettiva anassagorea, che dava maggiore importanza al “saper fare” (τεχνη) rispetto al “sapere” in quanto tale (σοφια), viene capovolta. Da tutte queste considerazioni, Aristotele evince che sia necessario indagare sulle “cause prime”, giacchè possiamo dire di conoscere veramente una cosa solamente se ne conosciamo le cause: ma che cosa dobbiamo intendere per “cause” (τα αιτια)? Ve ne sono ben di quattro tipi, spiega Aristotele, sostenendo orgogliosamente la propria superiorità rispetto a tutta la tradizione precedente, che non è pervenuta a elaborare una teoria completa della causalità: se Platone aveva indicato nelle idee, ossia in oggetti puramente intelligibili, le vere cause di tutto quanto è e avviene anche nell’ambito del mondo sensibile. Aristotele non si discosta dal mondo materiale che ci sta dinanzi: ora (ma anche nella “Fisica”, cui Aristotele stesso rimanda) spiega come, in un primo senso, la causa sia la sostanza e l’essenza delle cose (causa materiale). E’ causa della statua di bronzo il bronzo stesso di cui essa è fatta, ossia la materia; ma esso, da solo, non costituisce ancora la statua; perché essa ci sia, occorre che il bronzo assuma una determinata forma: anche la forma dunque è causa (causa formale), insieme alla materia, della statua di bronzo. La forma è data dall’essenza, che viene indicata mediante la definizione, la quale, a sua volta, denota proprio che cos’è un oggetto (in questo caso la statua). D’altra parte, né la materia da sé è in grado di assumere quella determinata forma né quella determinata forma è in grado di imporsi da sé a quella determinata materia. Perché avvenga questa connessione tra materia e forma occorre un agente (causa del movimento o causa motrice): nell’esempio della statua sarà l’artefice di essa, capace con la sua azione di far assumere quella determinata forma al bronzo. L’artefice, però, non produce la forma; è invece la conoscenza della forma a guidare la sua azione produttrice. In quanto causa efficiente, l’artefice è infatti guidato, nella sua azione manipolatrice del bronzo, dal fine che egli intende realizzare, ossia appunto la statua di bronzo. Da questo punto di vista, la statua, nel suo compimento, è la causa finale del processo in cui si attua l’imposizione di una determinata forma a una determinata materia: essa è ciò a cui mira l’artefice nella sua produzione. Queste considerazioni valgono, secondo Aristotele, in generale per l’agire umano, che è intenzionalmente diretto verso scopi, ma valgono anche per le entità del mondo naturale. La differenza decisiva è che nel caso della natura l’agente del processo è interno agli stessi oggetti naturali, e non esterno come è nel caso delle produzioni tecniche. Ma ad Aristotele pare bene ripercorrere anche le dottrine sulla causa delineate dai suoi predecessori, per poter trovare nuovi generi di causalità o conferma di quelle da lui stesso rinvenute: ci troviamo così improvvisamente proiettati in una vera e propria “storia della filosofia”, la prima che sia mai stata stesa. Si tratta di un procedimento argomentativo caro allo Stagirita e lo ritroviamo in moltissimi altri suoi scritti (Περι ψυχης, Περι ουρανou, ecc): ciò è in buona parte dovuto al fatto che per Aristotele la conoscenza è un sapere che coinvolge in una proficua collaborazione gli uomini del presente e quelli del passato, con la conseguenza che la tradizione non è una voce morta e spentasi per sempre, ma, al contrario, un qualcosa che ci chiama di continuo. In origine, la causa venne intesa in senso materiale, come principio da cui deriva la realtà nelle sue più svariate sfumature: d’accordo su questo punto, gli antichi filosofi entravano però in conflitto quando si trattava di determinare quale effettivamente fosse tale principio che sta alla base della realtà. Così Talete lo individuò nell’acqua – forse perché i semi sono sempre umidi-, Anassimene e Diogene nell’aria, Ippaso ed Eraclito nel fuoco, Empedocle in quattro elementi (terra, acqua, aria e fuoco), Anassagora in un’infinità di semi, e così via. Ma l’errore che accomuna tutti questi filosofi è da Aristotele ravvisato nel loro essersi fermati alla causa materiale, senza spingersi oltre e, soprattutto, senza render conto del mutamento dei principi nella realtà: essi non sono stati in grado di cogliere il principio del movimento e, pertanto, la loro ricerca si è arenata. Con un occhio di riguardo Aristotele si sofferma sulle tesi di Empedocle e di Anassagora: il primo, intravedendo nell’Amore e nell’Odio i due principi motori della realtà, pare aver colto, seppure in modo sfumato e maldestro, la causa del movimento; Anassagora, dal canto suo, è stato in grado, con straordinaria raffinatezza, di individuare in un’Intelligenza cosmica (Νους) il principio ordinatore del cosmo; ma egli ha tuttavia sbagliato nella misura in cui non si è servito in maniera adeguata di questo principio, in particolare nel non aver riconosciuto in esso alcun finalismo (Platone stesso muoveva ad Anassagora accuse simili nel “Fedone”) ma un puro e semplice deus ex machina. L’intuizione anassagorea, insomma, era buona, ma non è stata portata fino in fondo. Democrito, invece, e il suo collega Leucippo hanno individuato negli atomi e nel vuoto (da loro assimilati all’essere e al non-essere parmenideo) i principi in grado di spiegare la realtà quale appare ai nostri occhi: anch’essi, però, non han reso giustizia al principio del movimento, né tantomeno alla causa finale. Le aggregazioni che avvengono tra gli atomi che si muovono nel vuoto, infatti, non sono in vista di alcun fine, ma sono rette da una rigida necessità deterministica. Dopo Democrito, Aristotele prende in considerazione le teorie dei Pitagorici, i quali hanno ravvisato nel numero il principio della realtà, forse muovendo dalla constatazione che ad accomunare tutti gli enti è la loro misurabilità. L’impiego “mistico” che essi fanno dei numeri pare però poco convincente e, spesso, contraddittorio, come quando asseriscono che l’essenza del doppio e l’essenza del due sono la stessa cosa. Come diretta erede del pitagorismo, Aristotele indaga la filosofia di Platone, mettendone in luce la forte derivazione cratilea: muovendo dall’indagine socratica del τι εστιν, Platone si accorse dell’impossibilità di dare definizioni stabili in un mondo instabile e continuamente cangiante quale è il nostro; e perciò ricorse ad un mondo ultrasensibile, regno dell’essere in senso pieno (l’essere parmenideo) e non soggetto al divenire. Le cose del nostro mondo sarebbero pallide copie che partecipano delle Idee della realtà intelligibile: ma in questa sua teoria (direttamente mutuata dai Pitagorici) Platone – nota Aristotele – non ha spiegato che cosa realmente si debba intendere per “partecipazione” (μεθεξις) e, soprattutto, al di là delle sue stravaganti dissertazioni sui Numeri, ha fatto uso di due sole cause, quella formale e quella materiale. Dopo questa rapida carrellata di teorie dei predecessori, Aristotele si sofferma diffusamente, caso per caso, sugli errori da loro commessi: in generale, al di là delle specifiche differenze, i naturalisti sbagliano a sostenere la sola esistenza di realtà corporee, ignorano la causa del movimento e peccano di ingenuità quando additano come principio uno qualsiasi dei corpi semplici (sia esso l’acqua, o il fuoco, o l’aria). Lo Stagirita si riserva per ultima la critica al platonismo, nella quale dà il meglio di sé: in primis, egli nota come non sussistano prove effettive dell’esistenza delle Idee postulate da Platone; inoltre dal “Sofista” risultava anche che esistessero Idee di relazioni (l’idea di “diverso”, di “uguale”, ecc), il che appare non solo ridicolo, ma addirittura impossibile e facilmente confutabile dispiegando l’arma argomentativa del “terzo uomo”, di cui Aristotele fa più volte ricorso, nei suoi scritti, per demolire la dottrina delle Idee: se l’uomo è tale perché partecipa dell’Idea di uomo, quest’ultima, a sua volta, dovrà essere tale perché partecipa di un “terzo” uomo; e così via, all’infinito. Ma Aristotele si pone anche una domanda non da poco circa la teoria delle Idee: che vantaggio comporta agli esseri sensibili? Le Idee, infatti, non causano alcun movimento né giovano alla conoscenza delle cose né al fatto che esse sussistano. Se poi le Idee sono numeri, in che modo potranno mai essere cause? Aristotele sferra una serie di accuse anche piuttosto tecniche a Platone, facendo leva sulla sua dottrina dei Numeri Ideali e sulle assurdità che ne conseguono: la nota conclusione a cui perviene è che le Idee non hanno esistenza autonoma, ma sono, piuttosto, un’astrazione operata dal nostro intelletto; sicchè vedo tre cavalli non già perché vi è una partecipazione del sensibile ad una fantomatica Idea del tre situata in qualche luogo sperduto al di là dei sensi; al contrario, ricavo l’idea del tre dall’aver visto gruppi di tre cavalli, di tre case, e così via. Pur avendo aspramente criticato le dottrine dei suoi predecessori, Aristotele apprezza il loro lavoro, inteso come un’inesauribile fonte di spunti e di idee: la dottrina delle “quattro cause”, ad esempio, fu da essi intravista, anche se in maniera poco chiara, e questo perché “la filosofia primitiva sembra che balbetti su tutte le cose, essendo essa giovane e ai suoi primi passi” (993 a 15). In apertura del brevissimo secondo libro (per alcuni aspetti appendice del primo), troviamo un’acuta considerazione sulla ricerca della verità: essa è, al contempo, un qualcosa di facile e di difficile; difficile perché è impossibile cogliere del tutto la verità, ma facile perché è altrettanto impossibile non coglierla del tutto. Sebbene sia impossibile che ciascuno di noi raggiunga da solo il possesso della verità, resta vero che, collaborando, gli uomini possono riuscire a dare contributi considerevoli: per questo motivo dobbiamo essere grati ai filosofi precedenti – dice lo Stagirita-, poiché ci hanno lasciato in eredità contributi preziosissimi per ricostruire il mosaico della verità. Quest’ultima non sarebbe di per sé difficile da scoprire, poiché essa è riposta nelle cose e non è nelle cose che risiede la difficoltà: siamo piuttosto noi che, come le nottole (Hegel si ricorderà di questo paragone) non vedono alla luce del sole, non riusciamo a cogliere ciò che ci è alla mano, sotto gli occhi. La fiducia di Aristotele nei sensi è incredibilmente forte: mai nessun filosofo ne aveva nutrita tanta, solo Epicuro lo eguaglierà. Fatte queste considerazioni preliminari, lo Stagirita torna sui punti discussi nel libro primo, in particolare sulla causalità, che sta alla base del conoscere (“noi non conosciamo il vero senza conoscere la causa”, 993 a 23): in particolare, egli insiste su come le cause siano necessariamente finite, sia per numero sia per specie; se così non fosse, si dovrebbe andare all’infinito nella conoscenza, senza mai raggiungere alcun risultato. Il metodo da seguire, poi, non può essere unico per tutte le scienze, ma dovrà basarsi sugli oggetti in questione: di metodi Aristotele ne individua due, uno soggettivo e uno oggettivo. Come esempio di “soggettività” possiamo pensare all’assuefazione che ciascuno di noi ha verso un certo modo di procedere e che vorrebbe estendere a tutti gli altri: ma ciò è, oggettivamente, impossibile, poiché non ci si potrà muovere in ambito matematico e fisico con lo stesso metodo. Il libro terzo è il libro delle “aporie”, ossia delle problematiche (ne vengono presentate una quindicina) in cui ci si imbatte quando si fa metafisica: la difficoltà ha valore costruttivo, poiché è solo attraverso essa che si può passare dal non sapere al sapere; in questo senso, raggiungere la verità consiste nel superare la difficoltà, proprio come quando ci troviamo a dover sciogliere un nodo: la difficoltà è il nodo, lo scioglimento è la soluzione. Chi non sa e non si imbatte in difficoltà alcuna, è pertanto condannato a rimanere nell’ignoranza. Ma da dove nascono tali difficoltà? Soprattutto dalle opinioni degli altri pensatori, dai dubbi sollevati da essi e dalle contraddizioni in cui sono inciampati e che restano irrisolte: viene dunque ribadita la necessità di conoscere il pensiero altrui, in particolare quello dei predecessori, poiché è solo conoscendo ciò che essi han detto e dove hanno sbagliato che possiamo, a nostra volta, formulare soluzioni alle domande da loro poste e lasciate irrisolte. Concretamente ecco le aporie: 1] studiare i diversi tipi di cause è ufficio di una sola scienza o di diverse? 2] Lo studio dei principi delle sostanze e di quelli della dimostrazione spetta alla stessa scienza o a scienze diverse? 3] Lo studio di tutte le sostanze compete ad una o a più scienze? 4] La scienza orbita intorno alle sole sostanze, o anche agli accidenti? 5] Esistono anche sostanze non sensibili? E se si, esse sono di un solo genere oppure no? 6] I principi primi sono i generi o gli elementi materiali? 7] I principi primi sono i generi sommi oppure generi infimi? 8] Se esistono solo sostanze individuali, come è possibile la scienza? 9] L’unità dei principi è specifica oppure generica? 10] I principi delle cose corruttibili sono gli stessi di quelle incorruttibili? 11] l’Ente e l’Uno sono sostanze delle cose? 12] I numeri e gli enti geometrici sono sostanze? 13] Perché, al di là dei sensibili e degli intermediari, c’è bisogno di trovare altri enti, come le Idee di Platone? 14] Gli elementi sono in potenza o in atto? 15] I principi sono universali o individuali? E’ facile capire come il tema centrale delle aporie sia quello delle cause e dei principi: ogni aporia è presentata da una tesi (desunta dai naturalisti) a cui è contrapposta un’antitesi (desunta da Platone), ma nessuna delle due regge (viene messa in luce l’assurdità che deriverebbe se una delle due fosse valida). Si tratta pertanto, secondo Aristotele, di aprirsi una nuova strada, che tenga conto sia della tesi sia dell’antitesi, ma che non resti impigliata in esse e nei loro errori; ed è ciò che lo Stagirita fa nei libri successivi, dove dipana a poco a poco il groviglio dei problemi affiorati in questo terzo libro. Di tutte e quindici, spicca la quinta aporia, con la quale ci si domanda la possibilità dell’esistenza di realtà trascendentali, ovvero meta-fisiche (istanza che ritorna con insistenza nell’ottava e nella tredicesima aporia). Del resto, ogni questione inerente ai principi può ridursi alla questione se i principi siano materiali o no. Il quarto libro è uno dei più famosi, in quanto è in esso che emergono gli aspetti salienti del pensiero aristotelico: viene data una definizione di metafisica, poi una di essere, in seguito viene affrontato il tema degli “assiomi” e, infine, viene preso in esame il “principio di non contraddizione” mediante la confutazione (ελεγχος) di coloro che lo negano. Ma procediamo con ordine: in apertura del quarto libro, troviamo scritto che εστιν επιστημη τις η θεωρει το ον η ον και τα τουτο υπάρχοντα καθ’ αυτό (“c’è una scienza che considera l’essere in quanto essere e le proprietà che gli competono in quanto tale”). Tale è, appunto, la metafisica: il suo oggetto di indagine è “l’essere in quanto essere”, ossia l’intero della realtà, e condurre una tale investigazione significa trovare le cause che lo giustificano. Dove sta la differenza tra la metafisica e le altre scienze? Nel fatto che, mentre queste ultime sono conoscenze di una “parte” della realtà (sono cioè conoscenze settoriali e parziali della realtà), la metafisica abbraccia con la sua indagine l’intera realtà, nel tentativo di cogliere non le singole parti e i singoli aspetti, ma i “principi supremi”. In connessione col concetto di “essere”, Aristotele studia quello di “uno”, giacchè quest’ultimo è convertibile in quello di essere (“ens et unum convertuntur” diranno i medioevali): ne consegue che il metafisico dovrà anche studiare i concetti di “diverso”, di “identico”, di “simile”, e di tutti gli altri che sono connessi a quello di uno. Prendendo le mosse dall’essere come intero compatto, lo Stagirita affronta la questione del principio di non contraddizione: ma, ancor prima, fa un excursus sui “settori” particolari dell’essere, ossia su quelle porzioni di realtà che vengono prese in esame dalle singole scienze. Chi esercita le varie scienze fa uso di principi e di assunti valenti per singoli ambiti della realtà, ma, accanto ad essi, si avvale di “assiomi” validi per l’intero ambito dell’essere (“essi sono propri dell’essere in quanto essere”, 1005 a). Ma se essi sono comuni all’intera realtà, quale scienza dovrà occuparsene? La metafisica, dice Aristotele, poiché è l’unica ad avere come campo d’indagine l’intero essere, tanto più che le altre scienze fanno uso di tali assiomi ma non dicono nulla su di essi (proprio perché essi non ineriscono ad un ristretto ambito di realtà). Al contrario, la metafisica non solo fa uso di essi, ma di essi si occupa in maniera sistematica. Ma, in concreto, quali sono questi assiomi universalmente validi? Il principale di essi è il “principio di non contraddizione”, che può essere formulato in una miriade di modi, e Aristotele così esprime: “è impossibile che la stessa cosa, ad un tempo, appartenga e non appartenga ad una medesima cosa, secondo lo stesso rispetto”. Di tutti gli assiomi, questo è il più saldo, giacchè nessuno si sognerebbe di sostenere che una stessa cosa sia e non sia (ad es. “A è A e non-A”); ma il principio di non contraddizione è al contempo legge dell’essere e legge del pensiero: è infatti impossibile sia che la stessa cosa appartenga e non appartenga ad una medesima cosa, sia pensare che la medesima cosa sia e non sia. Vi è dunque una profonda corrispondenza tra pensato e reale: del resto, essendo il principio di non contraddizione un principio valido per l’essere in quanto essere, è naturale ch’esso valga anche per la struttura mentale dell’uomo, la quale rientra a pieno titolo nell’essere. In tempi più recenti, Kant prenderà in un certo senso le mosse dall’identità aristotelica di pensato e reale ricorrendo alle “dodici categorie”, valide per la mente umana ma anche per la realtà (sarà anzi la stessa mente umana ad impiegarle per leggere la realtà, a differenza di quanto crede Aristotele). Il principio di contraddizione è il più valido di tutti ed è anzi quello da cui tutti gli altri derivano: esso sta alla base di ogni possibilità di ragionamento e di dimostrazione; in quanto è il “principio primo” da cui derivano tutti gli altri, esso è indimostrato e indimostrabile, ma deve necessariamente essere ammesso (a meno che non si voglia prolungare all’infinito la ricerca di un principio); qualora qualcuno, intestardito, voglia provare a dimostrarlo, si troverà inevitabilmente a far uso di esso nella sua dimostrazione! Il che è evidentemente assurdo. Da ciò si può evincere come tutti, intuitivamente, sappiamo cosa esso sia e ce ne serviamo abitualmente. Eppure ci sono stati filosofi che l’hanno respinto, negandogli ogni validità argomentativa: ad avviso di costoro, è possibile affermare che una stessa cosa può essere e non essere e, conseguentemente, pensare che una stessa cosa può essere e non essere. Contro questi avversari, non si può esibire una dimostrazione del principio di non contraddizione, giacchè – come abbiam detto – esso è indimostrato; si può tuttavia percorrere una strada alternativa e vincente: quella dell’ ελεγχος, ossia della confutazione dell’avversario, mettendo in evidenza come il discorso del negatore del principio di non contraddizione non riesca nemmeno a costituirsi, giacchè, per costituirsi, dovrebbe fare ricorso allo stesso principio di non contraddizione. Non appena l’avversario apre bocca, infatti, dice qualcosa e se a questo qualcosa annette un senso, allora dice qualcosa di determinato che, proprio perché determinato, non potrà essere la sua negazione. In fin dei conti, chi nega il principio di contraddizione (e Aristotele ha soprattutto in mente i sofisti, primi fra tutti Gorgia e Protagora), per essere coerente, dovrebbe star zitto e non pensare: il che equivarrebbe a regredire allo stadio di vegetale. D’accordo almeno in questo con il maestro Platone, lo Stagirita respinge senza mezzi termini le tesi dei sofisti (a cui dedica lo scritto “Confutazioni sofistiche”): alla tesi anti-protagorea “se è tutto vero, allora è vero anche che esiste il falso e che ciò che dice Protagora è menzogna” e a quella anti-gorgiana “se tutto è falso, allora anche ciò che dice Gorgia lo è”, egli ne affianca ora una nuova: il sofista, negatore del principio di non contraddizione, non appena apre bocca sconfessa già le proprie posizioni. Aristotele non si accontenta della dimostrazione a favore del principio di non contraddizione poc’anzi esposta e ne squaderna un’altra: nel suo significato più forte, l’essere è sostanza, dove per “sostanza” (ουσια) dobbiamo intendere tutto ciò che esiste di per sé; negare il principio di non contraddizione vuol dire, come sappiamo, negare l’essere in generale; ma vorrà anche dire negare l’essere nel significato di sostanza. Sicchè l’essenza di “uomo” sarà anche essenza di “non-uomo”: ma, negando la sostanza, tutto si riduce ad “accidente”, dove per accidente dobbiamo intendere tutto ciò che esiste nella misura in cui inerisce ad una sostanza (il rosso, il caldo, ecc, sono accidenti perché esistono in riferimento ad una sostanza: una casa rossa, un libro rosso, ecc); se dunque togliamo la sostanza dovrebbe restare solo l’accidente, ma quest’ultimo, per esistere, ha sempre bisogno di una sostanza a cui inerire, cosicchè – venuta meno la sostanza cadrà anche l’accidente e, con esso, tutto l’essere. Molti pensatori, poi, hanno negato il principio di non contraddizione facendo leva sulla contraddittorietà del reale, sul suo fluire incessante e sulla sua assenza di stabilità: partendo da queste considerazioni, essi hanno universalizzato la questione, arrivando a sostenere l’instabilità dell’intero essere. Ma Aristotele avverte: “dovremo dimostrare che esiste una realtà immobile e dovremo convincerli di questo”: la pretesa di fare dell’essere intero un qualcosa di instabile perché instabile è il mondo sensibile viene dunque stigmatizzata ed è nel libro dodicesimo che lo Stagirita dimostrerà l’esistenza dell’enigmatico “motore immobile”. Derivante dal principio di non contraddizione è pure quello del “terzo escluso”, così formulato: “non è neppure possibile che fra i due contraddittori ci sia un termine medio, ma è necessario o affermare o negare, di un medesimo oggetto, uno solo dei contraddittori”. Se il primo libro costituiva la prima “storia della filosofia” mai scritta, il quinto libro si configura invece come il primo dizionario filosofico che sia mai stato realizzato: Aristotele vi discute il significato dei termini cardinali che vengono impiegati in filosofia, provando a considerarli sotto diversi punti di vista. Il primo vocabolo preso in considerazione è quell’ αρχη (“principio”) alla cui ricerca si erano dedicati i φυσιολογοι, i primi filosofi della natura (Talete, Anassimene, Anassimandro): vediamo nel dettaglio quali sono le parole su cui lo Stagirita concentra la propria attenzione: * αρχη (principio): ciò da cui una cosa comincia (così l’avevano inteso i filosofi naturalisti); il punto di partenza migliore; la causa efficiente; il potere di far muovere qualcosa; ciò da cui si parte per conoscere qualcosa; * αιτιον (causa): la materia; la forma; il principio del movimento; il fine; *στοιχειον (elemento): il costitutivo primo di cui son fatte le cose; ciò che è piccolo, semplice ed indivisibile (gli atomi di Democrito); * φυσις (natura): la generazione delle cose che crescono; il principio interno della cosa; il principio di movimento intrinseco; il principio materiale; ogni sostanza;
* αναγκαίον (necessario): ciò senza di cui il vivente non può vivere; ciò che costringe; ciò che non può essere diversamente da come è; la dimostrazione (in quanto le conclusioni non possono essere che come sono); * εν (uno): a) unità accidentale: sostanza con un accidente (es. “Corisco” e il “musico”), due accidenti (“musico” e “giusto”), una sostanza insieme ad un accidente ma rispetto alla medesima sostanza considerata assieme ad un altro accidente (“Corisco musico” e “Corisco giusto”), la sostanza con un accidente rispetto alla medesima sostanza (“Corisco musico” e “Corisco”), lo stesso caso di prima ma letto in universale (“uomo musico” e “uomo”); b) unità essenziali: quando sono continue, quando è identico di specie il loro sostrato, quando è identico il loro genere, quando è identica la loro definizione; c) misura prima di un genere; * το ον (l’essere): in senso accidentale (“il giusto è musico”), per sé (vi rientrano tutti i sensi delle categorie), l’essere come vero (“Socrate è musico”: intendiamo come “è vero che Socrate è musico”); potenza e atto; * ουσια (sostanza): i corpi semplici; la causa immanente dei corpi semplici; i limiti del corpo (vale per alcuni filosofi, non per Aristotele); l’essenza delle cose; * τα αυτα / διαφορα (identico/differente): due cose sono identiche o accidentalmente o essenzialmente; due cose sono diverse in senso opposto a quello per cui si dicono identiche; differenti sono due cose che sono diverse ma che fra loro hanno qualche identità; simili sono due cose che hanno tutte le affezioni identiche; dissimili quelle opposte; * αντικειμενα / εναντια / ετερα / τα αυτα (opposto, contrario, diverso, identico) * προτερα και υστερα (prima e dopo): anteriori e posteriori si dicono le cose a seconda che siano o no più vicine (in base allo spazio, al tempo, al movimento, alla potenza, all’ordine) ad un determinato principio; ma le cose si dicono posteriori o anteriori anche in riferimento alla conoscenza e, nella fattispecie, secondo la nozione definitoria (l’universale sta prima del particolare) oppure secondo la sensazione (i particolari stanno prima degli universali); sono poi anteriori le proprietà delle cose anteriori; infine, anteriori sono le cose secondo la natura e secondo la sostanza (il sostrato e la sostanza vengon prima degli attributi; le cose sono anteriori per la potenza, posteriori per l’atto); * δυναμις (potenza, possibilità, possibile): principio di movimento, principio per cui la cosa è mossa, capacità di condurre a termine una cosa bene o secondo volontà, la capacità di una cosa di essere mutata in bene, lo stato per cui le cose sono immutabili in peggio; impotente è invece ciò che corrisponde all’impotenza oppure ciò che corrisponde all’impossibile (dove impossibile è ciò il cui contrario è necessariamente vero);
* ποσον (quantità): quantità è ciò che è divisibile in parti ad esso interne, di cui ciascuna è un qualcosa di determinato; la quantità può essere a) numerabile (e allora è una pluralità), b) misurabile (e allora è una grandezza). Inoltre, ci sono quantità per sé (la linea) e quantità per accidente (il tempo e il movimento); * ποιον (qualità): differenza della sostanza di una cosa, ciò che appartiene all’essenza del numero, le affezioni della sostanza soggette a mutamento, la virtù il vizio il bene il male; * προς τι (relazione): relative sono quelle cose che stanno fra loro 1] come ciò che eccede rispetto a ciò che è ecceduto, 2] come l’agente rispetto al paziente, 3] come il misurabile rispetto alla misura; * τελειον (perfetto): perfetto (o completo) è ciò che ha tutte le parti che deve avere, ciò che non è superato da altro nell’abilità che gli è propria, ciò che possiede il fine che gli compete; * περας (limite): limite è il termine estremo di ogni cosa, la forma di una grandezza, il fine di ogni cosa, la sostanza delle cose; * το καθ’ ο / το καθ’ αυτό (ciò per cui / per sè): “ciò per cui” designa l’essenza di ogni cosa, il sostrato, la causa finale, la causa efficiente, la posizione; “ciò che è per sé” significa invece l’essenza, le note nell’essenza, le proprietà originarie di una cosa, ciò che non ha altra causa fuori di sé, ciò che appartiene ad un solo tipo di soggetto; * διαθεσις (disposizione): disposizione vuol dire ordinamento di parti a) secondo il luogo, b) secondo la potenza, c) secondo la forma; * εξις (abito): abito significa 1] l’attività di ciò che possiede e di ciò che è posseduto; 2] la disposizione per la quale una cosa è ben o mal disposta, 3] ciò che è parte di una disposizione del tipo tratteggiato sopra; * παθος (affezione): affezione significa una qualità per cui una cosa può alterarsi, le alterazioni medesime già in atto, le alterazioni dannose, le grandi sventure; * στερησις (privazione): privazione designa a) una cosa priva di qualche caratteristica che dovrebbe (o potrebbe) avere per natura in un dato momento, b) quando c’è sottrazione violenta di qualcosa, c) quando troviamo la a privativa, d) quando una cosa è difficile a farsi, e) quando vi è assoluta mancanza di una cosa; * το εχειν (l’avere): avere significa tenere in propria balia, l’avere da parte del ricettacolo ciò che è nel ricettacolo, il contenere del contenente rispetto al contenuto, tenere qualcosa in modo tale che non possa muoversi; * το εκ τίνος είναι (il derivare da qualcosa): derivare vuol dire 1] il derivare dal proprio sostrato, 2] il derivare da causa efficiente, 3] derivare dall’insieme di materia e forma, 4] derivare dalla forma, 5] il derivare da una parte delle cose appena indicate, 6] il derivare temporalmente da un evento; * μερος (parte): parte significa ciò in cui la quantità è divisibile, ciò in cui la forma è divisibile, ciò in cui il tutto è divisibile, gli elementi che costituiscono la definizione; * ολον (intero): intero vuol dire ciò che non manca di alcuna parte, ciò che contiene le cose che contiene, quando le parti mutano senza produrre differenze; * κολοβον (mutilo): vengono presi in esame i requisiti che una cosa deve avere per potersi dire mutila (dev’essere una quantità, dev’essere continua, dev’essere privata di una parte non essenziale); * γενος (genere): genere indica la generazione continua di esseri della stessa specie, la stirpe, il sostrato delle differenze, il costitutivo primo delle definizioni; * ψευδος (falso): falso indica una cosa falsa, una cosa non unita o non unibile (perché illusoria), una enunciazione o una nozione falsa, un uomo che ama mentire; * συμβεβηκος (accidente): accidente è ciò che può essere detto di una cosa e le appartiene ma non sempre o per lo più; ma è anche ciò che inerisce ad una cosa pur non rientrando nella sua essenza. E’ evidente come tutti questi termini siano focali nell’indagine che Aristotele ha fin qui condotto e condurrà oltre: troviamo l’uno, la sostanza, le cause, e molti altri. Puo’ sembrar strano, almeno al lettore moderno, che venga improvvisamente interrotta la ricerca sulla metafisica e ci sia una pausa in cui viene delineato un lessico filosofico: ciò risulterà più comprensibile se facciamo riferimento al valore polisemantico e troppo spesso ambiguo di quei termini; sicchè pare quasi che Aristotele abbia voluto momentaneamente sospendere la sua indagine per delucidare quelle parole poco chiare, gettando luce – una volta per tutte – sui reali significati da attribuire ad esse. L’indagine aristotelica riprende il suo cammino con il sesto libro, che si apre all’insegna di una netta divisione tra le scienze e con l’assoluta preminenza della metafisica, ora però intesa come teologia: tutte le scienze, pur nella loro fondamentale importanza, sono segnate dall’imprescindibile limite di indagare esclusivamente su porzioni che abbracciano una parte della realtà (così la matematica si occupa dei numeri, la fisica del mondo sensibile, e così via), mentre l’investigazione metafisica investe l’essere in quanto essere ed ha per oggetto proprio le cause e i principi dell’essere stesso, nonché l’essenza: quest’ultima, infatti, è dalle altre scienze data per scontata, cosicché esse partono da essa senza dimostrarla. La metafisica dimostra principi validi in assoluto, per tutto l’essere; le altre scienze, viceversa, si occupano di principi valevoli solamente per determinati ambiti dell’essere: esse, poi, fanno uso di postulati, ossia accettano principi senza dimostrarli, mentre invece la metafisica (“filosofia prima”) rende conto di ogni cosa e, soprattutto, dell’essenza e della sostanza. Aristotele, a differenza di Platone, prospetta un’incredibile varietà di scienze, ciascuna dotata del proprio campo di indagine: le scienze possono essere di tre tipi, a) teoretiche (fisica, matematica, metafisica) b) poietiche c) pratiche (etica, politica) ed è partendo da questa tripartizione che muove ora lo Stagirita. La fisica si occupa di enti esistenti di per sé e dotati di materia e movimento; la matematica ha per oggetto enti non esistenti di per sé ma immobili. Infine, la terza e la più elevata delle scienze teoretiche è quella che si occupa di enti separati (esistenti di per sé) e immobili, quindi né materiali né sensibili: si tratta della teologia. La “filosofia prima”, dunque, pare ora passare da scienza universalissima, occupantesi dell’essere in quanto essere, a scienza “particolare” (teologia), che si occupa esclusivamente dell’immobile e dell’immateriale. Aristotele si accorge di questa contraddizione e cerca di superarla: non c’è alcuna contraddizione, perché la filosofia prima è universale e lo è proprio in quanto si occupa della sostanza sovrasensibile (Dio, il “motore immobile”), la quale altro non è se non “sostanza prima”; da ciò consegue che la teologia è necessariamente “filosofia prima” e, poiché “prima”, le compete l’indagine di tutto l’essere e delle proprietà che ad esso competono. Ribadito dunque, con rinnovato vigore, come il compito della “filosofia prima” (intesa sia come teologia sia come metafisica) sia l’investigazione sull’essere, Aristotele passa concretamente alla trattazione dell’essere, riprendendo molti punti dei libri precedenti e, soprattutto, la distinzione operata nel libro quinto tra 1) essere accidentale, 2) essere come “vero” (e non-essere come “falso”), 3) essere come categorie, 4) essere come atto (εντελεχεια) e potenza (δυναμις). Sono questi i quattro significati precipui dell’essere: partendo dal primo – essere “accidentale” -, lo Stagirita nota come esso non possa assolutamente costituire l’oggetto proprio della metafisica per due ordini di ragioni: a] perché si tratta di un essere “debolissimo”: di esso non può esserci non-essere, dal momento che le cose naturali (che sono esseri sostanziali) si generano e si corrompono, mentre questo non avviene nell’accidente. Si tratta allora di chiarire quale sia la natura dell’accidente: e Aristotele distingue rigorosamente tra esseri che sono “di necessità e sempre” (εξ αναγκης και αει) ed esseri che sono “per lo più” (επι το πολυ). Ma se non tutto avviene necessariamente ed esistono cose che avvengono “per lo più” (e non sempre), allora esisteranno anche esseri che sono solo “talvolta” (ποτε). Da ciò deriva che l’accidente, propriamente, non è né sempre né per lo più, ma talvolta: “per esempio, né sempre né per lo più il bianco è musico; ma, poiché talvolta accade, allora sarà per accidente” (E 2 1027 11). La causa dell’accidente viene da Aristotele individuata nella materia, che in quanto essere potenziale ed indeterminato – dà luogo alle possibilità che qualcosa sia in modo diverso dal sempre o dal per lo più; b] dell’essere “accidente” – è facile arguirlo – non può esserci scienza alcuna, giacchè la scienza riguarda ciò che è sempre (αει) ο per lo più (επι το πολυ): se così non fosse come sarebbe possibile imparare ed insegnare ad altri? Del resto, che non possa esserci scienza dell’accidente, lo attesta il fatto stesso che né la scienza pratica, né la poietica né la teorica si occupano di esso. Tuttavia, se esistono gli accidenti, allora vorrà dire che esisteranno anche cause accidentali, cioè diverse da quelle che producono ciò che è “sempre” o “per lo più”: per chiarire questo punto, Aristotele ricorre ad esempi concreti, in riferimento ad eventi sia passati sia futuri; egli mette in luce come, risalendo nella catena delle cause ed effetti, si giunga ad “un certo evento” da cui prende le mosse la catena dei successivi eventi. Tale “certo evento”, pertanto, costituisce la causa di essi, ma non è tale da possedere una determinata e precisa ragione d’essere: è un qualcosa che esula da ogni regola necessaria ed è, dunque, fortuito (potrebbe verificarsi come non verificarsi). Ma questo evento causa dell’accidente – rientra nella sfera delle cause formali, finali o efficienti? Aristotele lascia irrisolto questo interrogativo, poiché esso richiederebbe un’apposita trattazione: sia sufficiente l’aver stabilito il funzionamento dell’ “accidentale”, il quale impera nell’agire umano, giacchè ogni nostra azione potrebbe avvenire diversamente da come avviene (a differenza di quanto avviene nel mondo che sta sopra la luna). Aristotele, in chiusura del libro sesto, rivolge l’attenzione all’essere concepito come “vero” e al non-essere come “falso”: il vero sta nel connettere le cose connesse (o anche nel dividere quelle divise), il falso sta nel dividere le cose non divise (o nell’unire quelle non unite); ma tutto questo avviene solo all’interno della mente umana e, perciò, l’essere come vero e il non-essere come falso si riducono ad “affezioni” della mente e da ciò consegue che, oltre all’essere come accidente, anche l’essere come vero non merita di essere oggetto dell’indagine del metafisico: “questi modi di essere dobbiamo dunque lasciarli da parte e, invece, dobbiamo indagare le cause ed i principi dell’essere in quanto essere” (E 4 1028 a 3). Agli altri significati dell’essere è in buona parte dedicato il libro settimo, che si apre con la constatazione che “το ον λεγεται πολλαχώς” (“l’essere ha molteplici significati”): se nel sesto libro si erano trattati i significati “deboli” dell’essere (accidentale e come vero), ora si prendono in esame quelli “forti”, in primo luogo l’essere delle categorie. La prima cosa da notare è che, pur essendo dieci, tutte le categorie, nel loro essere, dipendono direttamente dall’essere della prima, che è la sostanza (ουσια): di un soggetto, per esempio Socrate, ci si può chiedere che cos’è o quali sono le sue qualità o quanto è alto o dov’è e così via e le risposte a queste domande indicano ciò che si può predicare del soggetto. Ognuna di esse indica un tipo diverso di predicati, ciascuno dei quali è una categoria, ossia un modo di κατηγορευειν (“predicare”) intorno al soggetto. Secondo Aristotele esse sono dieci: sostanza (per esempio, Socrate o uomo), quantità (un metro e mezzo), qualità (bianco o filosofo), relazione (figlio di Sofronisco), luogo (nel carcere), tempo (l’anno della morte), situazione (star seduto), avere (indossare il mantello), agire (bagnare), subire (essere bagnato). Classificare queste categorie o predicati equivale, per Aristotele, a classificare cose o eventi: per esempio, dire che Socrate è nel carcere, dove la categoria di luogo è predicato del soggetto Socrate, comporta che il carcere è un luogo. Il mondo stesso, allora, si configurerà agli occhi di Aristotele come un insieme di sostanze individuali (Socrate, la casa, il cavallo, ecc), ciascuna delle quali è un τοδη τι, un “questa cosa qui” che ho dinanzi. Tutte le altre categorie esistono in riferimento alla categoria di sostanza: se non ci fosse quella, non potrebbero nemmeno esserci esse. Infatti, forse che potrebbe esistere il “bianco” se non ci fosse una sostanza a cui inerire? Similmente, potrebbe esistere “l’essere alto un metro e mezzo” se non in riferimento ad una sostanza (ad esempio, Socrate)? Certo che no, risponde Aristotele. Da tutto ciò deriva che il problema dell’essere può e deve essere inteso come problema della sostanza, cosicchè la domanda “che cos’è l’essere?” deve essere letta come “che cos’è la sostanza?” ed è, di fatto, ciò che hanno fatto sempre anche i filosofi precedenti; Heidegger noterà come l’intuizione di Aristotele, ossia l’esigenza di indagare l’essere in quanto essere, è brillante, ma il filosofo greco ha peccato quando dall’indagine dell’essere è scivolato a quella della sostanza. Aristotele, nel tentativo di connotare la sostanza, fornisce una miriade di definizioni, che spesso sembrano perfino contraddittorie: il primo problema ch’egli si pone è di marca teologica e consiste nel domandarsi di qual genere siano le sostanze esistenti. Dobbiamo ammettere che esistano solo sostanze “materiali”, cioè di genere sensibile, o è meglio ipotizzare che, accanto ad esse, ve ne siano anche di sovrasensibili? Questa problematica era già affiorata nel terzo libro, quello delle aporie, in cui la tesi “naturalistica” di chi non vedeva altra sostanza all’infuori di quella materiale era contrapposta all’antitesi platonica del mondo delle idee. Non sembra sbagliato sostenere che è questo il problema centrale della “Metafisica”, quello intorno al quale ruota l’intera opera, e che troverà una definitiva soluzione in positivo nel libro dodicesimo, quando verrà ammessa l’esistenza di un Dio assolutamente immateriale. Ma, oltre a chiarire di quale genere sia la sostanza (materiale? sovrasensibile? ambo le cose?), è bene domandarsi anche che cosa essa sia: che cos’è la sostanza? E’ materia? E’ forma? E’ sintesi delle due cose (συνολον)? A rigore, nota Aristotele, dev’essere prima affrontato il problema del “che cosa” sia la sostanza rispetto a quello del “di che genere” essa sia: poiché è solo muovendo dalla comprensione dell’essenza di una cosa che si possono predicare le caratteristiche che le competono. L’indagine di Aristotele, come sempre, parte anche in questo caso dai φαινομενα, ossia dalle cose come sembrano: e, sotto questo profilo, a tutti (filosofi passati e presenti) sembra che le cose sensibili siano sostanze, cosicchè sarà opportuno avviare l’investigazione a partire da quelle. La domanda sull’essenza della sostanza è duplice: a) quali sostanze esistono? (e la risposta verrà data nel libro dodicesimo); b) che cos’è la sostanza in generale? A questa seconda domanda, lo Stagirita prova a rispondere in questo libro, anche se in verità le risposte ch’egli fornisce tendono ad aprire più problemi di quanti non ne risolvano. In prima istanza, pare che cinque possano essere le definizioni di sostanza: 1] ciò che non inerisce ad altro e che, pertanto, non si predica di altro; 2] ciò che sussiste separatamente dal resto (χωριστον); 3] ciò che è un alcunchè di determinato (τοδη τι); 4] ciò che è dotato di intrinseca unità (una molteplicità disposta in maniera unitaria); 5] ciò che è dotato di atto e di attualità (ενεργεια). In base alle cinque definizioni fornite, si potrà dire che la materia (υλη) è sostanza? Se guardiamo alla 1º definizione, parrebbe di sì: la materia, infatti, non inerisce ad altro né di altro si predica; eppure, concentrando l’attenzione sulle successive definizioni, si apre un ventaglio di problemi non da poco: la materia non può sussistere separatamente dal resto (come vorrebbe la 2º definizione), giacchè la troviamo sempre congiuntamente con la forma (non troviamo mai materia amorfa). La 3º definizione, poi, dice che dev’essere qualcosa di determinato la sostanza: ma la materia non lo è, o, meglio, è determinata solo nella misura in cui è accompagnata dalla forma; e non è neppure qualcosa di intrinsecamente unitario (4º definizione), poiché se a noi pare unitaria è solo in virtù della forma. Infine, non risponde neppure alle richieste della 5º definizione: infatti la forma, non la materia è atto; dal canto suo, la materia è potenza: infatti, un blocco di marmo (materia che supponiamo priva di forma) è potenzialmente tantissime cose (una statua, una mensola, ecc), ossia può (δυναται) diventare una statua, una mensola, ecc. a patto che intervenga la forma: la quale farà sì che la materia, da statua in potenza, diventi statua in atto. Da questo percorso fra le note definitorie della sostanza si evince come la materia sia sostanza solo in senso debolissimo (cioè solo stando alla 1º definizione). A loro volta, la forma (μορφη) e il sinolo (συνολον) rispondono alle richieste delle cinque definizioni? Sì, risponde Aristotele, e pertanto possono essere tranquillamente qualificati come sostanze. Al contrario, le Idee di Platone – ridotte dallo Stagirita a meri “universali” – non rientrano affatto nel novero delle sostanze. Da un punto di vista strettamente empirico, il sinolo sembra essere la sostanza per eccellenza, ma, se spostiamo il baricentro dell’indagine su un piano metafisico, ci accorgeremo di come la forma sia principio, causa e ragion d’essere, cioè fondamento, con la conseguenza che il sinolo stesso è da essa causato e fondato. Appare dunque evidente come per noi, empiricamente, il sinolo sia la sostanza in senso pieno, giacchè abbiamo sempre e comunque a che fare con composti (aggregati di materia e forma), ma come “in sé e per natura” – ovvero metafisicamente – sia la forma a rivestire il ruolo di sostanza in senso preminente. In questo modo, viene istituita una specie di scala gerarchica in base alla quale la materia è la sostanza in senso “debole”, il sinolo è un gradino al di sopra, poiché costituito da materia e forma; e, infine, al vertice della scala, sta la forma, in quanto principio, ragion d’essere e causa del sinolo. A questo punto, Aristotele fa un’affermazione quasi solenne e mistica, asserendo che la forma è “la causa prima dell’essere”, giacchè è la forma che, collegando e determinando gli enti materiali, fa essere le varie cose. L’inizio del libro ottavo vuol presentarsi come una sorta di ricapitolazione dei punti discussi nel libro precedente, un’appendice ragionata: la ricerca si è spostata dall’essere alla sostanza, sulla cui natura però permangono forti dubbi e ambiguità, tant’è che al di là degli elementi comuni ravvisati da tutti i pensatori – ogni filosofo l’ha intesa in modo pressochè diverso da ogni altro. La materia – definita nel libro settimo come una sostanza “debole” – è ora additata da Aristotele come di fondamentale importanza per poter capire il mutamento a cui son soggetti gli enti fisici, poiché – affinchè ci sia mutamento – deve per forza esserci materia: il mutamento (μεταβολη) consiste appunto nel passaggio da un sostrato ad un altro. Come potrebbe verificarsi il mutamento locale, quello di accrescimento e di diminuzione, quello di generazione e corruzione, nonché quello di alterazione, senza la materia? Rispetto al settimo, l’ottavo libro guarda la materia e la forma alla luce della distinzione tra potenza e atto: la superiorità della forma sulla materia viene ribadita nella nuova veste della superiorità dell’atto sulla potenza; sembrerebbe che ogni cosa, per passare in atto, debba prima attraversare lo stadio della potenza, ma questo non è vero in assoluto: al contrario, ogni cosa in potenza, per poter passare in atto, necessita l’azione di un qualcosa che sia già in atto (così l’uovo – gallina in potenza – ha bisogno dell’azione di una gallina già in atto per poter raggiungere anch’esso lo stato attuale). Aristotele spiega che l’essenza (ουσια) e la forma (μορφη) coincidono, ovvero che l’essenza e la cosa intesa come forma sono la stessa cosa (così l’essenza dell’anima e l’anima sono un tutt’uno). Il libro nono è dedicato pressochè interamente alle nozioni di potenza (δυναμις) e atto (εντελεχεια): sembrerebbe, allora, non avere rapporti con le parti precedenti dell’opera, ma non è così; infatti, se guardiamo ai vari significati dell’essere, tracciati nel libro sesto, ci accorgiamo che, tra i tanti, campeggiava anche quello dell’essere secondo la potenza e l’atto. Ora Aristotele concentra proprio su tale problematica la propria attenzione: nel libro sesto aveva trattato dell’essere nei suoi significati “deboli” (accidente e vero), nel settimo e nell’ottavo aveva invece indagato sull’essere come categoria e come sostanza. Ora, a conclusione del percorso preannunciato nel libro sesto, non resta che esaminare l’essere come potenza e come atto: per capire che cosa sia l’essere secondo potenza e atto sarà tuttavia opportuno comprendere preventivamente che cosa realmente si debba intendere per potenza e atto, in modo tale da dissipare ogni dubbio a riguardo. Abbiamo già accennato a come l’atto stia prima della potenza (perché ogni cosa in potenza ha bisogno di qualche cosa in atto che la faccia a sua volta passare in atto), ma ciò non toglie che nella sua trattazione Aristotele si soffermi prima sulla potenza, poiché siamo abituati a vedere le cose prima in potenza, e poi in atto (pensiamo all’uomo come attualizzazione del bambino: il bambino, per noi, viene cronologicamente prima, giacchè ciascuno, prima di diventare uomo, deve passare per la fase di bambino). Quali sono, dunque, i significati di “potenza”? Innanzitutto essa significa il principio di movimento o mutamento attivo che è in un altro o nella cosa in quanto altra; in secondo luogo, significa il principio di movimento o mutamento passivo che è in un altro o nella cosa in quanto altra; in terzo luogo, “potenza” significa la proprietà per cui un ente è in grado di non patire mutamento in peggio, cioè distruzione per opera di un altro ente o di sé in quanto altro. Infine, “potenza” designerà tanto la capacità di agire o patire in generale, quanto quella di agire o patire in modo conveniente. Ma potenza attiva e potenza passiva finiscono per coincidere, soprattutto se pensiamo che un qualsivoglia ente è dotato di potenza se può far patire un altro ente o patire esso stesso ad opera di un altro ente. Impotenza sarà invece la privazione (στερησις) di potenza. Esistono poi potenze razionali (δυναμεις μετα λόγου) e potenze irrazionali (δυναμεις αλογοι), dove la differenza sta nel fatto che quelle razionali sono reperibili esclusivamente in quegli enti equipaggiati della ragione (rientrano in questa categoria anche le scienze poietiche); solo le potenze razionali, poi, possono produrre ambedue i propri contrari, mentre le irrazionali solo uno: così il freddo (potenza irrazionale) può produrre solo il freddo e in nessun caso il caldo, mentre la medicina (potenza razionale) è al contempo scienza della salute e della malattia. Ciò comporta che, nel caso delle potenze razionali, intervenga un principio tale da decidere l’attualizzazione di uno dei contrari: tale principio risponde al nome di desiderio e di scelta razionale. La potenza, oltre ad essere principio del movimento, corrisponde alla materia: tuttavia, ogni movimento è atto e, contemporaneamente, la forma e la sostanza sono “atto” (ενεργεια ο εντελεχεια hanno il medesimo significato). Ciò però non comporta che atto e potenza si identifichino, come invece credevano i Megarici, ad avviso dei quali c’è la potenza quando c’è l’atto (per cui ha potenza di costruire solo chi sta costruendo in atto). La dottrina megarica, se accettata, porta a conseguenze assurde, in quanto se la potenza è l’atto – nessuno potrà mai possedere alcuna arte, dal momento che il costruttore, non appena smette di costruire, viene a perdere la sua arte, e così via; inoltre, non potrà esistere alcun sensibile (freddo, caldo, ecc) se non sarà sentito in atto e, contemporaneamente, non sarà possibile dire che possiede sensibilità, se non chi sente in atto (chi cessa di vedere o sentire diventa così immediatamente cieco o sordo). Infine, dall’ammissione della teoria megarica, consegue che ciò che non è attualmente viene ad essere impossibile (impossibile ogni movimento, ogni forma di divenire). Aristotele evince dalle assurdità a cui conduce la dottrina megarica la necessità di distinguere potenza e atto come due realtà esistenti e diverse fra loro. Ma bisogna stare attenti quando si adopera la nozione di potenza, poiché si rischia di cadere in un duplice errore: 1] affermare che una cosa non è in potenza se non è già in atto; 2] affermare che una cosa è in potenza ma non si realizzerà mai. Dire che una cosa ha potenza (δυναμις) equivale a dire che è possibile (δυνατον), ossia che può concretizzarsi, ed affermando che ciò che è in potenza non potrà mai realizzarsi (cioè passare in atto) equivale ad eliminare l’impossibile (αδυνατον): infatti, se dico che un bambino può diventare uomo, ma non lo diventerà mai, sto di fatto negando ogni caso di impossibilità. Ciò significa che la possibilità reale di una cosa e la sua attualizzazione risultano inscindibili, giacchè, data l’una, è insieme data pure l’altra. Aristotele nota che ci sono potenze congenite (che ci accompagnano fin dalla nascita: ad es. le potenze dei sensi) e potenze acquisite (che sono poi quelle razionali, acquisibili con il ragionamento, con l’abitudine e con l’insegnamento: ad es. le arti e le scienze poietiche). Ora, portata a compimento la trattazione della potenza in relazione al movimento (e i brevissimi cenni all’atto), lo Stagirita analizza con attenzione l’atto e la potenza in chiave metafisica: l’atto viene ora definito come l’esistenza stessa della cosa e ciò implica ch’esso possa essere definito esclusivamente presupponendolo. L’esempio a cui ricorre Aristotele è quello della statua in legno di Ermete: in potenza, essa è un blocco di legno che può diventare un mare magnum di cose (un tavolo, una sedia, una statua, ecc), in atto esso diventa una statua scolpita. Ma, nonostante la puntigliosità riposta in quest’esempio, Aristotele non si sente ancora soddisfatto e, pertanto, si propone di distinguere con maggiore attenzione le cose quando sono in potenza dalle cose quando sono in atto e, per fare ciò, si avvale di un argomentare serratissimo: quand’è che una cosa è in potenza? Prestando la nostra attenzione alla sfera dell’arte, diremo che una cosa è in potenza quando l’artista voglia agire e non si frappongano impedimenti esterni; fuor dal campo dell’arte, quand’è che le cose di natura (aventi in sé il principio della generazione) sono in potenza? La loro attualizzazione – spiega Aristotele – dipende dalla loro stessa natura, il che significa ch’esse sono in potenza quando non c’è nessun impedimento esterno. Così sarà lecito affermare che la terra non è uomo in potenza, ma potrà esserlo qualora diventi seme e quest’ultimo sia stato immesso nel corpo della femmina: in questa situazione, il seme potrà dirsi uomo in potenza. Dal concetto di potenza ora delineato si ricava come, quando diciamo che il tavolo è fatto di legno, il legno è un tavolo in potenza: sicchè, se dico X è fatto di Y, allora potrò anche dire che Y è un X in potenza. Ma, stando a quanto Aristotele ha finora detto, sembrerebbe che la potenza goda di priorità rispetto all’atto, il che è l’esatto contrario di quanto desidera sostenere lo Stagirita: ed è per questo che, nel paragrafo VIII, imbandisce una serie di argomentazioni a sostegno della sua tesi, spiegando come l’atto sia anteriore alla potenza a) per la nozione (possiamo sapere di che cosa X è potenza solo quando sappiamo l’atto cui X tende: ad es., posso sapere che cosa è l’uovo solo se so che cosa è la gallina), b) per il tempo (se considero l’individuo, allora la potenza sta prima, giacchè, prima di essere uomo in atto, è uomo in potenza; ma se considero la specie dell’individuo, allora vien prima l’atto, poiché l’individuo in potenza necessita sempre di un individuo in atto per passare a sua volta in atto), c) per la sostanza (l’atto, in quanto forma, è regola, principio e condizione della potenza; e inoltre, essendo l’atto il modo d’essere tipico degli enti incorruttibili, sarà anteriore alla potenza). L’atto è, secondo Aristotele, superiore alla potenza non solo concettualmente, ma anche assiologicamente: l’atto della salute è migliore della potenza della salute, giacchè quest’ultima può, passando in atto, sia diventare salute sia malattia. Se ne dovrebbe tuttavia ricavare che, invertendo il discorso, l’atto della malattia è peggiore della potenza della malattia, giacchè quest’ultima, passando in atto, può sì diventare malattia, ma anche salute. Aristotele si sbarazza di questa possibile obiezione facendo leva sulle entità incorruttibili: esse per loro natura puro atto – non sono affette né da male né da mancanza e, pertanto, ciò significa che il male e la mancanza sono componenti proprie della potenza. Perfino in matematica l’atto sta prima della potenza, tant’è che i teoremi geometrici si dimostrano con l’attività, ovvero con quelle opportune divisioni e operazioni che li rendono evidenti in atto. Il nono libro si chiude con un ritorno di Aristotele sul problema dell’essere come vero e del non-essere come falso: il vero dice ora lo Stagirita – risiede nel rispecchiare le cose come stanno, cosicchè se noi pensiamo le cose come esse stanno, allora siamo nel vero; chi parte dal presupposto che noi pensiamo le cose in un modo e, di conseguenza, esse stanno in quel modo, cade in errore (stoccata a Platone, ma estendibile – ante litteram – anche a Kant). Il libro decimo prende le mosse dalla quarta aporia che Aristotele ha presentato nel libro terzo: l’indagine metafisica verte esclusivamente intorno alle sostanze o, piuttosto, anche intorno alle proprietà che ad esse ineriscono? Su quale scienza, poi, grava il compito di investigare sul medesimo, sul diverso, sul simile, sul dissimile, sulla contrarietà, sul prima, sul poi e sulle altre nozioni di questo tipo? Il libro quarto risolveva il problema in maniera positiva, giocando la carta della convertibilità dell’essere e dell’uno e quella della connessione di tutte le nozioni citate (diverso, simile, dissimile, ecc) con l’uno, cosicchè alla scienza che studia la sostanza e l’essere compete anche lo studio di tali nozioni. Proprio sull’uno e sui concetti ad esso connessi proietta la propria indagine il libro decimo: infatti, dopo aver esaminato attentamente l’essere in quanto essere e cui si articola, è bene prendere in nella molteplicità dei significati in considerazione alcune di quelle nozioni che, poiché si riferiscono all’uno, competono all’essere (l’uno e l’essere sono convertibili) e, pertanto, hanno piena cittadinanza in sede metafisica. Aristotele rimanda, per una più acuta comprensione dell’argomento, ad un suo scritto – andato perduto – dal titolo “La distinzione dei contrari”, a cui peraltro già rimandava nel libro quarto; se l’essere è caratterizzato da una incredibile molteplicità di significati ed è convertibile con l’uno, ciò significa che anche l’uno avrà tale molteplicità di significati ed è proprio su questi (intesi a mo’ di nozioni) che viene proiettata ora l’attenzione dello Stagirita. L’uno ha quattro significati (da non confondersi però con l'”essenza dell’unità”): è il continuo, è ciò che è un tutto, è l’unità specifica, è l’unità numerica. Successivamente, Aristotele si affatica molto per spiegare come l’uno non sia sostanza ma predicato (a dispetto di quel che credevano i Platonici e i Pitagorici): come l’essere, anche l’uno è un universale e, in quanto tale, non può in alcun modo essere sostanza; e poi, così come l’essere, in tutte le categorie, è essere di qualche cosa di determinato, ugualmente l’uno, in ogni categoria, è sempre determinato, sicchè potrà essere non già “sostanza per sé”, bensì una “determinata sostanza” (un uomo, un cavallo, ecc). Dopo aver successivamente esaminato il rapporto che intercorre tra l’uno e il molteplice (rapporto che verrà anche ripreso più avanti), lo Stagirita passa a considerare la contraddittorietà, che è la massima differenza che ci possa essere e che, in quanto tale, può aver luogo solo fra due termini (i contrari sono così sempre due). Nei paragrafi che vengon dopo, egli si addentra sempre più nello specifico, quasi come se la sua speculazione tendesse ad avvitarsi su se stessa: tratta dell’opposizione dell’uguale al grande e al piccolo, dell’opposizione dell’uno ai molti (riprendendo una tematica prospettata in precedenza), dei termini intermedi, della “differenza specifica” (data da una contrarietà nell’essenza), e, infine, della differenza che distingue il corruttibile dall’incorruttibile (operando a tal proposito un’ennesima distruzione della teoria platonica delle Idee). Il libro undicesimo si presenta al lettore come un riassunto generale dei libri precedenti: l’inizio si riallaccia esplicitamente al libro primo, poiché Aristotele ribadisce che la sapienza è scienza avente per oggetto i principi (la metafisica si occupa dell’essere in quanto essere, a differenza di come operano le altre scienze), mentre, subito dopo, lo Stagirita riprende dal libro terzo la problematica delle aporie e dal quarto il tema della molteplicità dei significati dell’essere. Sembra quasi che Aristotele si stia qui spianando il terreno per il libro successivo, al cui centro vi sarà quella sostanza immobile, eterna e trascendente che è Dio: non a caso, lo stesso Stagirita apre qualche spiraglio qua è là, da cui è possibile presagire l’incombere dell’argomento che starà alla base del successivo libro. Ciò che risulta però più sorprendente è la forte presenza di passi tratti dalla “Fisica” e dislocati un po’ ovunque: in particolare, gli ultimi due paragrafi si riagganciano a tale scritto e, soprattutto, all’essere come potenza e atto in connessione con la dottrina del movimento e del mutamento, lasciando ai primi capitoli del libro seguente il compito di fare il punto sulla dottrina della sostanza. Ci imbattiamo anche in una sintetica trattazione dell’infinito (απειρον) – rigorosamente condotta in funzione della potenza e dell’atto, la quale pare ancora una volta un preludio al libro dodicesimo, in cui Aristotele scarterà l’ipotesi che Dio sia infinito poiché, se lo fosse, non potrebbe essere atto puro: l’infinito, infatti, esiste sempre e solo potenzialmente (pensiamo all’infinito numerico). Vengono proposte diverse definizioni di infinito (che ritroviamo nel libro III della “Fisica”): è infinito ciò che non è possibile percorrere (così come la voce è invisibile), ciò che si può percorrere ma senza fine, ciò che difficilmente si può percorrere, ciò che è percorribile ma non è percorso; inoltre c’è infinito per addizione (προσθεσις) oppure per sottrazione (αφαιρεσις). Viene subito precisato come un “infinito in sé”, distinto dalle cose sensibili, non possa esistere, poiché altrimenti dovrebbero pure esistere numeri e grandezze in sé (chiara allusione a Platone); a quest’argomentazione, Aristotele ne aggiunge altre, che mettono in luce come l’infinito esista solo potenzialmente. Scendendo più nei particolari, il libro undicesimo mette l’accento su alcune questioni di primaria importanza: ad esempio, Aristotele spiega come matematica e fisica siano parti della filosofia (giacchè quest’ultima è scienza dell’essere in quanto tale), come il principio di non contraddizione non possa in alcun caso essere confutato, come l’accidente sia connesso al caso (su cui si sofferma soprattutto nella “Fisica”), come l’attività del motore in atto coincida con quella del mosso. Il libro dodicesimo pare essere il traguardo dell’intera “Metafisica”, in quanto dà finalmente risposta a quelle domande che Aristotele si poneva fin dall’inizio dell’opera: viene infatti risolto quello che è stato definito come “il problema per eccellenza della metafisica”, ovvero il problema teologico (che fa dell’ontologia una meta-fisica). Viene finalmente dimostrata l’esistenza di una sostanza sovrasensibile (metafisica appunto) e ne vengono delineate le caratteristiche essenziali, cosicchè il libro dodicesimo si configura come la mèta del percorso aristotelico, quel libro senza il quale l’intera “Metafisica” perderebbe il suo significato. Del resto, moltissimi dei concetti trattati nei libri precedenti si richiamavano, in qualche modo, ad una dimensione teologica: pensiamo alla difesa del principio di non contraddizione, o allo studio dei significati dell’essere o, ancora, alla trattazione della sostanza. Nel primo paragrafo, viene posto l’accento sull’esistenza di tre diversi tipi di sostanza: quella corruttibile (gli animali, le piante, ecc), quella sensibile incorruttibile (i cieli), e quella soprasensibile, immobile ed eterna (Dio); le prime due sostanze sono oggetto d’indagine, rispettivamente, della fisica e dell’astronomia; la terza della metafisica. Soffermando l’attenzione su quella sensibile, la caratteristica che meglio la contraddistingue è il suo essere soggetta al mutamento, il quale avviene fra contrari e presuppone l’esistenza di qualcosa che faccia da sostrato (passando da un contrario ad un altro); più che di “mutamento” sarebbe opportuno parlare di “mutamenti”, giacchè ne esistono di quattro tipi: secondo la sostanza (generazione e corruzione), secondo la qualità (alterazione), secondo la quantità (aumento e diminuzione), secondo il luogo (spostamento). A mutare è la materia (senza di essa non ci sarebbe il mutamento), la quale è in potenza e, proprio in virtù di ciò, è ambedue i contrari e può mutare. I corpi celesti, però, non sono affetti da tutti e quattro i tipi di mutamento: anzi, essi sono oggetto esclusivamente del movimento di spostamento (giacchè li vediamo muoversi in cielo), e non cambiano né sostanzialmente né qualitativamente né quantitativamente. Riprendendo in buona parte quanto detto nel libro settimo, Aristotele si concentra ora sulla forma, la quale come la materia – né si genera né si corrompe ma presiede al mutamento; affinchè esso si verifichi, è altresì necessario l’intervento della causa efficiente, ossia di un’altra sostanza avente lo stesso nome o la stessa natura di quella su cui agisce (in campo naturale, l’uomo genera l’uomo, il cavallo genera il cavallo; nel campo delle produzioni umane, la casa materiale deriva dalla forma di casa). E a questo punto, lo Stagirita ne approfitta per distruggere per l’ennesima volta la dottrina platonica delle Idee, mettendo in evidenza come la forma (che Platone aveva chiamato “Idea”) non possa mai sussistere autonomamente e in maniera distaccata dalle cose: sicchè, non c’è la forma “uomo” di cui gli altri uomini sono imitazione, né c’è la forma “casa”; al contrario, la forma sta nelle cose stesse, che appunto sono “sinolo” di materia e forma, cosicchè la forma “uomo” non è esistente in maniera autonoma, ma è un’astrazione operata dalla nostra mente. Nel paragrafo IV, troviamo una spiegazione di come le cause e i principi delle cose siano individualmente diversi ma analogicamente identici: se in concreto i principi di cose diverse sono diversi, sono invece gli stessi per analogia, poiché ogni cosa ha una forma, una privazione e una materia. Al di là delle quattro cause, tuttavia, ne esiste una universale che ad esse è superiore: si tratta dell’essere assolutamente primo che muove ogni cosa, Dio. Poiché tutto ciò che non è sostanza esiste solo nella sostanza o in riferimento ad essa, allora le cause della sostanza sono, a maggior ragione, anche causa di tutto il resto e, in particolare, l’atto e la potenza costituiscono il principio dell’intera realtà; Aristotele chiarisce, a tal proposito, come all’atto si riducano la forma e la privazione, mentre alla potenza la materia, con la conseguenza che le cause efficienti sono potenze nel senso che sono forze capaci di agire e non nel senso in cui è potenza la materia (poiché da ciò deriverebbero conseguenze paradossali). Seguendo questo percorso, Aristotele si è sgombrato la strada e può ora, finalmente, introdurre la dimostrazione dell’esistenza di una sostanza soprasensibile, immobile ed eterna, che muove l’universo senza a sua volta essere mossa. Dopo aver spiegato come le sostanze abbiano priorità su tutti gli altri modi di essere, lo Stagirita nota che se esse fossero corruttibili, allora non esisterebbe nulla di incorruttibile; ma tale tesi è smentita dall’esistenza del tempo e del movimento, entrambi incorruttibili per loro natura. Ma per poter effettivamente argomentare in favore dell’esistenza del movimento incorruttibile, eterno e, quindi, continuo occorre dimostrare l’esistenza di un “principio motore”, il quale per poter produrre un moto eterno deve essere eterno e per poter produrre un moto continuo – deve essere sempre in atto. Ne consegue, pertanto, che il “primo motore” sarà atto puro ed eterno, privo di materia e di potenza, nonostante questa tesi possa in apparenza essere fatta scricchiolare dal fatto che come abbiamo visto – la potenza vien prima dell’atto; però lo stesso Aristotele aveva precedentemente spiegato come è sì vero che le cose, per passare all’atto, debbano prima essere in potenza (la pianta in atto prima deve passare per lo stadio di seme, cioè di pianta in potenza), ma aveva altresi fatto notare come ogni cosa, per passare dalla potenza all’atto, necessiti dell’intervento di qualcosa già in atto, cosicchè a rigore – l’atto sta prima della potenza (la gallina viene prima rispetto all’uovo). In tale prospettiva, Aristotele può criticare aspramente i naturalisti e i teologi per aver fatto derivare tutto dalla notte e dal caos (cioè dalla potenza), senza accorgersi che questi non si sarebbero potuti muovere senza l’azione di una causa già in atto; molto migliore appare, allora, l’interpretazione di Leucippo e di Platone – i quali ammisero un movimento eterno (che per l’appunto è atto) -, anche se difettosa nel momento in cui non seppero giustificare in alcun modo quanto sostenevano. Perfino Anassagora ed Empedocle colsero intuitivamente l’anteriorità dell’atto quando ammisero, rispettivamente, il Nous e l’Amore e l’Odio. Dopo questo breve excursus sulle altrui dottrine, Aristotele torna alla sua, mettendo in luce come, se l’atto vien prima della potenza, allora esistettero sempre le medesime cose; sorge tuttavia, a questo punto, un serio problema: se tutto è eternamente, come si spiegano la generazione, la corruzione e il fatto che le cose son sempre avvenute con la sostanza? Una via d’uscita per non incappare in un vicolo cieco sta nell’ammettere che a) la causa della costanza delle cose del mondo sia un qualcosa che agisce sempre nello stesso modo (tale è il primo cielo), b) la causa delle generazioni e delle corruzioni sia un qualcosa che agisce in maniera sempre diversa (tale è il sole, che, nel suo moto in cerchio obliquo, si avvicina e si allontana periodicamente alla terra). Infine, per spiegare la generazione, la corruzione e la loro regolarità, sarà sufficiente far riferimento al cerchio obliquo e al primo cielo. Quest’ultimo, però, che muove di moto continuo ed eterno, non può muovere se stesso, poiché tutto ciò che muove è mosso da altro (i medioevali diranno che “omne movens ab alio movetur”), cosicchè sarà necessario individuare un principio primo che muova restando immobile: “Dal momento che è possibile che le cose stiano nel modo da noi prospettato -del resto, se si respinge questa nostra spiegazione, tutte le cose deriverebbero dalla notte o dal -tutto-insieme o dal non-essere – si possono ritenere risolte tutte le precedenti aporie; esiste, quindi, qualcosa che è sempre mosso secondo un moto incessante, e questo modo è la conversione circolare (e ciò risulta con evidenza non solo in virtù di un ragionamento, ma in base ai fatti), e di conseguenza si deve ammettere l’eternità del primo cielo. Ed esiste, pertanto, anche qualcosa che provoca il moto del primo cielo. Ma dal momento che ciò che subisce e provoca il movimento è un intermedio, c’è tuttavia un qualcosa che provoca il movimento senza essere mosso, un qualcosa di eterno che è, insieme, sostanza e atto”. (A 6/7 1072 a 19-25) Ma come è possibile che qualcosa causi il movimento senza a sua volta essere in movimento? Aristotele, per meglio chiarire come ciò sia possibile, ricorre all’esempio dell’oggetto amato, che è oggetto di desiderio e di amore e, quindi, corrisponde al fine a cui tendere: esso, pur non muovendosi, fa muovere l’amante, il quale prova amore e ad esso tende. “Un movimento di tal genere è provocato sia da ciò che è oggetto di desiderio sia da ciò che è oggetto di pensiero. Ma questi due oggetti, se vengono intesi nella loro accezione più elevata, sono tra loro identici. Infatti, è oggetto del nostro desiderio il bello nel suo manifestarsi, mentre è oggetto principale della nostra volontà il bello nella sua autenticità; ed è più esatto ritenere che noi desideriamo una cosa perché ci si mostra bella, anziché ritenere che essa ci sembri bella per il solo fatto che noi la desideriamo: principio è, infatti, il pensiero. Ma il pensiero è mosso dall’intelligibile, e una delle due serie di contrari è intelligibile per propria essenza, e il primo posto di questa serie è riservato alla sostanza e, nell’ambito di questa, occupa il primo posto quella sostanza che è semplice ed è in-atto (e l’uno e il semplice non sono la medesima cosa, dato che il termine uno sta ad indicare che un dato oggetto è misura di qualche altro, mentre il termine semplice sta ad indicare che l’oggetto stesso è in un determinato stato). Ma tanto il bello quanto ciò che per la sua essenza è desiderabile rientrano nella medesima categoria di contrari; e quel che occupa il primo posto della serie è sempre ottimo o analogo all’ottimo. La presenza di una causa finale negli esseri immobili è provata dall’esame diairetico del termine: infatti, la causa finale non è solo in vista di qualcosa, ma è anche proprietà di qualcosa, e, mentre nella prima accezione non può avere esistenza tra gli esseri immobili, nella seconda accezione può esistere tra essi. Ed essa produce il movimento come fa un oggetto amato, mentre le altre cose producono il movimento perché sono esse stesse mosse. E così, una cosa che è mossa può essere anche altrimenti da come essa è, e di conseguenza il primo mobile, quantunque sia in atto, può -limitatamente al luogo, anche se non alla sostanza- trovarsi in uno stato diverso, in virtù del solo fatto che è mosso; ma, poiché c’è qualcosa che produce il movimento senza essere, esso stesso, mosso ed essendo in atto, non è possibile che questo qualcosa sia mai altrimenti da come è. Infatti, il primo dei cangiamenti è il moto locale, e, nell’ambito di questo, ha il primato la conversione circolare, e il moto di quest’ultima è prodotto dal primo motore”. (A 6/7 1072 a 25-1072 b) Poiché tale principio è immobile, non potrà essere diversamente da come è: ciò significa che è necessario e ne dipendono il cielo e la natura. “Il primo motore, dunque, è un essere necessariamente esistente e, in quanto la sua esistenza è necessaria, si identifica col bene e, sotto questo profilo, è principio. Il termine ‘necessario’, infatti, si usa nelle tre accezioni seguenti: come ciò che è per violenza perché si oppone all’impulso naturale, come ciò senza di cui non può esistere il bene e, infine, come ciò che non può essere altrimenti da come è, ma solo in un unico e semplice modo. E’ questo, dunque, il principio da cui dipendono il cielo e la natura”. (Λ 6/7 1072 b 10-14) Egli è vita, vita perfetta ed eccellente: è pensiero e, in quanto perfetto, pensa solo ciò che è perfetto, poiché se pensasse ad altro corromperebbe la propria perfezione; Egli, , cosicchè in Lui intelligenza ed dunque, pensa a se stesso ed è “pensiero di pensiero” (νοησις νοησεως). In questo modo, l’intelligibile cede il passo all’intelligenza intelligibile finiscono per coincidere, con la conseguenza che la Sua vita consiste in tale attività noetica che Gli garantisce la massima felicità possibile, poiché nulla più del pensare rende felici. L’argomentazione di Aristotele è, sotto questo profilo, serratissima e si inerpica con agilità per sentieri impervi e difficili: se Dio è pensiero, non può pensare “nulla”, altrimenti sarebbe nella stessa condizione del dormiente; allo stesso tempo, però, non può pensare nulla di superiore a Sé, giacchè è Egli stesso il vertice della realtà; se poi pensasse qualcosa di superiore, allora Egli non sarebbe più la sostanza eccellente. Al contrario, l’intelletto divino pensa esclusivamente ciò che è più appunto – “divino”, il che equivale a dire ch’Egli pensa ciò che non muta: infatti, “il mutamento è sempre verso il peggio” (εις χειρον η μεταβολη, Λ 9, 1074 b 26) e ciò comporterebbe , tra l’altro, un movimento in Dio. Aristotele arriva a sostenere che la natura del pensare divino è atto puro, scevro da ogni potenzialità, poiché – se le cose stessero diversamente – l’ininterrotto pensare di Dio costituirebbe per Lui una fatica (il che è indiscutibilmente assurdo) e l’intelligibile che fa passare in atto l’intelligenza sarebbe migliore dell’intelligenza stessa (la quale non sarebbe più la cosa più eccellente). Vorrà allora dire che l’intelligenza divina non potrà far altro che pensare se stessa: ecco perché Dio è “pensiero di pensiero”, tanto più che la coincidenza fra pensare e pensato è in Dio possibile e non contraddittoria poiché tutto ciò che non ha materia ammette la coincidenza in parola. Aristotele dice espressamente che l’oggetto del pensiero di Dio è “semplice”, poiché immateriale, e in assoluta unità per l’intera eternità. Se poi l’intelligenza umana raggiunge il suo apice quando pensa non le parti, ma il tutto, allora – a maggior ragione – ciò varrà anche per Dio. Come Aristotele puntualizza nell'”Etica Nicomachea” la differenza fondamentale per quel che riguarda l’attività poetica esercitata tra Dio e il filosofo sta nel fatto che Dio può esercitarla ininterrottamente, mentre il filosofo – in bilico tra l’esser Dio e l’esser bestia – deve accontentarsi di pensare il più possibile, ma mai senza interruzioni, poiché, in quanto animale, ha esigenze biologiche, politiche ed economiche a cui far fronte: pertanto egli solo in pochi momenti gode della virtù divina, e, nella fattispecie, nei momenti di tempo libero (σχολη). E’ una posizione intermedia quella di Aristotele: il sapiente, infatti, è saldamente ancorato al divino per il fatto che gli oggetti del suo sapere sono divini (come Aristotele ha spiegato nel libro primo della “Metafisica”); infatti cerca di scoprire i principi e le cause che sono all’origine del mondo. Ma, sotto una luce diversa, la divinità stessa è l’esatta proiezione della vita del sapiente e la θεωρια è il Suo tratto essenziale. “Ed esso è una vita simile a quella che, per breve tempo, è per noi la migliore. Esso è, invero, eternamente in questo stato (cosa impossibile per noi!), poiché il suo atto è anche piacere (e per questo motivo il ridestarsi, il provare una sensazione, il pensare sono atti molto piacevoli, e in grazia di questi atti anche speranze e ricordi arrecano piacere). E il pensiero nella sua essenza ha per oggetto quel che, nella propria essenza, è ottimo, e quanto più esso è autenticamente se stesso, tanto più ha come suo oggetto quel che è ottimo nel modo più autentico. L’intelletto pensa se stesso per partecipazione dell’intelligibile, giacchè esso stesso diventa intelligibile venendo a contatto col suo oggetto e pensandolo, di modo che l’intelletto e intelligibile vengono ad identificarsi. E’, infatti, l’intelletto il ricettacolo dell’intelligibile, ossia dell’essenza, e l’intelletto, nel momento in cui ha il possesso del suo oggetto, è in atto, e di conseguenza l’atto, piuttosto che la potenza, è ciò che di divino l’intelletto sembra possedere, e l’atto della contemplazione è cosa piacevole e buona al massimo grado. Se, pertanto, Dio è sempre in quello stato di beatitudine in cui noi veniamo a trovarci solo talvolta, un tale stato è meraviglioso; e se la beatitudine di Dio è ancora maggiore, essa è oggetto di meraviglia ancora più grande. Ma Dio è, appunto, in tale stato! Ed è sua proprietà la vita, perché l’atto dell’intelletto è vita, ed egli appunto è quest’atto, e l’atto divino, nella sua essenza, è vita ottima ed eterna. Noi affermiamo, allora, che Dio è un essere vivente, sicchè a Dio appartengono vita e durata continua ed eterna: tutto questo, appunto, è Dio!” (Л 6/7 1072 b 15-30) Egli, poi, è privo di grandezza, senza parti ed indivisibile, impassibile ed inalterabile, ed è anche somma bellezza e sommo bene ed è per questo che i Pitagorici e Speusippo commettono un grave errore asserendo che la bellezza e il bene siano situati non nel principio ma in ciò che da esso scaturisce; il loro errore trae origine da un’errata interpretazione della realtà, giacchè essi non sono stati in grado di capire come i principi delle sostanze siano essi stessi sostanze in atto che, quindi, contengono in sé quelle stesse perfezioni delle sostanze che producono. Sorge però, a questo punto, un nuovo, inquietante dilemma: dimostrata l’esistenza di un “motore immobile”, che è “pensiero di pensiero” e che, perciò, conduce costantemente quell’ottima vita che a noi uomini è concesso seguire solo a intermittenze, dobbiamo infatti chiederci se, oltre ad Esso, esistano altre sostanze soprasensibili. Si tratta di percorrere una strada sostanzialmente nuova, giacchè in questo campo i predecessori si sono mossi confusamente, senza dar risposte o, nella migliore delle ipotesi, dandone di assolutamente imprecise ed evasive. Oltre al movimento del “cielo delle stelle fisse” (il cui moto produce la successione di giorno e notte ed è causato dall’azione di Dio come causa finale), esistono anche i moti dei pianeti, anch’essi eterni, e anch’essi postulanti qualcosa che li muova: si dovrà pertanto ammettere che, oltre al “motore immobile”, esistano altre sostanze soprasensibili che mettano in movimento anche i pianeti? Nel caso si risponda affermativamente, quante saranno tali sostanze? Tante quanti i movimenti si dovrà rispondere; occorre dunque chiedersi quanti siano questi ultimi, tenendo presente che un’unica sfera è sufficiente per muovere le stelle fisse ma, per quel che riguarda i pianeti, non bastano tante sfere quanti essi sono, poiché per spiegare alcune irregolarità e cambiamenti di posizione in essi riscontrabili si dovranno supporre parecchie sfere per ciascuno; i moti di tali sfere, combinandosi, daranno luogo alla risultante che osserviamo in cielo. Eudosso ritenne che fossero necessarie tre sfere per render conto del moto della luna, tre per quello del sole, e quattro per ciascun altro pianeta, arrivando ad un totale di ventisei sfere; dal canto suo, Callippo ha provveduto ad aumentare di due il numero di sfere della luna e del sole, di una quelle di Marte, di Venere e di Mercurio, raggiungendo un totale di trentatrè sfere. Ciò, tuttavia, non è ancora sufficiente, dal momento che, alle sfere di Callippo, se ne dovranno aggiungere una folta schiera con moto a ritroso, per neutralizzare l’influsso dei moti di un pianeta su quelli del successivo, con un aumento complessivo di ventidue sfere; in totale, stando così le cose, si arriverebbe a cinquantacinque sfere (le trentatrè di Callippo più le ventidue con moto a ritroso ammesse da Aristotele). Da questo complesso ragionamento si dovrebbe, a rigore, ricavare che le sostanze sovrasensibili siano cinquantacinque; ma come si spiega, in una tale abbondanza, l’evidente unità del cielo? L’unica maniera per non entrare in contraddizione risiede, nella prospettiva aristotelica, nell’ammettere l’unicità di Dio, facendo da Lui dipendere l’intero cielo; del resto, che quest’ultimo sia eterno e retto da un principio divino è cosa nota agli uomini fin dagli albori della storia e che si è trasmessa – in forma mitica, ma comunque veritiera nel suo contenuto di fondo – di generazione in generazione fino ai tempi di Aristotele. In chiusura del libro dodicesimo, lo Stagirita affronta la questione del modo di essere del bene (το αγαθον) ε dell’ottimo (το αριστον) nell’universo, mettendo in luce le difficoltà in cui precipitano le dottrine metafisiche elaborate dai φυσιολογοι e dai Platonici stessi. Aristotele spiega come il bene e l’ottimo esistano sia come ordine immanente alle cose, sia come principio che le trascende; in modo analogo, il bene di un esercito sta sia nell’ordine sia nel comandante. Oltre a questo esempio desunto dal mondo militare, lo Stagirita ne impiega un altro, estrapolato dall’ambito dell’οικος: l’ordine dell’universo può essere accostato a quello di una casa, dove, in misura diversa e a diverso livello, le singole cose contribuiscono all’ordine e al bene del tutto. In un’ottica di questo genere, cade in errore chi avanza la pretesa di porre i contrari come principi delle cose (Aristotele attacca soprattutto Empedocle). Anche Speusippo, del resto, sbaglia nella misura in cui pone come indipendenti tra loro i vari piani della realtà; l’errore dei Platonici e dei Presocratici risiede soprattutto nell’aver ravvisato una molteplicità di principi esplicativi della realtà, ed è a tal proposito che Aristotele ad essi oppone la necessità che il principio supremo sia unico, terminando il libro con un celebre verso di Omero (Iliade, II, 204): “ουκ αγαθον πολυκοιρανιη: εις κοιρανος εστω” (“il governo di molti non è buono; uno solo sia il comandante”), con il quale viene tacciato Tersite, esponente del δημος. Con la trattazione della sostanza soprasensibile che muove il mondo come oggetto di desiderio e di amore (e non come soggetto, come crederanno i medioevali e Dante stesso), potrebbe considerarsi chiusa la “Metafisica”, poiché gli ultimi due libri che la compongono risultano trascurabili se inseriti nell’economia del tutto: non è un caso che nel Medioevo non venissero letti. In effetti, essi hanno carattere marcatamente storico e sono destinati a destare l’attenzione soprattutto dell’attento storico, in quanto è in essi racchiusa un’aspra polemica contro la teoria platonica delle Idee e dei Numeri. Il libro tredicesimo traccia uno schema generale da seguire in questa polemica anti-platonica, con la quale Aristotele chiude i conti con il maestro: in primo luogo, verranno affrontate le problematiche dei Numeri e del presunto statuto ontologico attribuito ad essi da Platone; in secondo luogo, avremo un’accurata trattazione delle Idee come esistenti “in sé e per sé”, quali appunto erano state concepite da Platone; infine, come sintesi conclusiva, verrà analizzata l’eventualità che Numeri e Idee possano costituire il principio degli esseri. Argomentando contro le Idee e contro i Numeri, Aristotele trova ulteriori prove che depongono a favore dell’esistenza di quelle sostanze da lui riconosciute nel libro precedente: quelle ammesse da Platone, magicamente esistenti in un fantomatico mondo intelligibile non meglio identificato, non esistono né potrebbero, poiché comporterebbero una sfilza di contraddizioni insuperabili. In particolare, allo Stagirita pare assurdo parlare di “Enti matematici” esistenti in maniera autonoma e, quindi, separatamente dalle cose sensibili: come si può pensare che il tre esista “in sé” e poi esistano gruppi di tre cose nella misura in cui esse “partecipano” del tre ideale? Con quest’accesa critica, Aristotele demolisce l’eventualità platonica dell’esistenza “ideale” degli enti matematici, ma non lo fa certo per dimostrare ch’essi esistano come realtà fisiche (poiché ciò sarebbe altrettanto assurdo): al contrario come già aveva spiegato nel libro sesto – gli enti matematici sono un qualcosa di esistente nelle cose sensibili secondo il modo di essere potenziale e che il nostro pensiero separa mediante l’astrazione. Scendendo più nei particolari, non esiste un tre in sé, un bianco in sé, un piccolo in sé, ma esistono gruppi di tre cose, cavalli bianchi, case piccole. Di fronte a queste realtà, il nostro pensiero opera un’astrazione, ossia – in un certo senso una sottrazione (αφαιρεσις): ho dinanzi tre uomini, sottraggo ad essi il colore della pelle, dei capelli, l’altezza, il peso, ecc, e spogliatili di ogni caratteristica – che cosa resta? Resta il fatto che sono tre. Non sono dunque partito da un’Idea di tre autonomamente esistente per poi rintracciarla anche nel mondo di quaggiù; al contrario, partito dalle cose sensibili che mi circondano, ho da esse ricavato la nozione di tre. Si tratta pertanto – spiega Aristotele – di “enti di ragione”, che sussistono in atto esclusivamente nella mente umana, poiché l’uomo può astrarre da tutte le particolarità delle cose e guardare le cose stesse solo come corpi a tre dimensioni, oppure solo come superfici, come lunghezze, come unità indivisibili, come punti, come unità pure. Gli oggetti matematici non hanno esistenza autonoma, ma non per questo sono irreali, poiché esistono potenzialmente nelle cose ed è poi la riflessione matematica a separarli nell’atto in cui considera le cose solo come grandezze o numeri. Aristotele critica poi pesantemente tutti coloro che hanno rimproverato alle matematiche di non avere nulla a che fare con il bello o con il bene: trattando delle forme supreme, hanno necessariamente a che fare con il bello, inteso come ordine, simmetria e definito. La critica aristotelica si sposta ora dai Numeri alle Idee in sé considerate, introdotte da Platone per superare le difficoltà imposte dalla dottrina eraclitea del divenire incessante: ha ragione Eraclito a dire che tutte le cose divengono senza tregua, ma non sono esse a costituire l’oggetto della scienza, bensì sono quegli enti immutabili ed eterni che popolano il mondo intelligibile. Così facendo, Platone ha trasformato in entità separate i concetti logici socratici, cosicchè le Idee non sarebbero altro che le entificazioni e le ipostatizzazioni dei concetti e delle definizioni. Alla martellante domanda socratica “τι εστι;” (“che cosa è” la bellezza, il coraggio, la virtù, ecc), Platone ha risposto sostanzializzando gli oggetti in questione e facendo cosi nascere l’Idea di Bellezza, l’Idea di Coraggio, l’Idea di Virtù, e così via, cogliendo le quali è possibile dire che cosa sia bello, giusto, virtuoso. Sotto questo profilo, allora, è secondo Aristotele molto migliore l’indagine condotta da Socrate rispetto a quella platonica: Socrate ha indagato senza sconfinare al di fuori dell’etica, ricercando la definizione universale a proposito di ciascuna delle virtù morali e impiegando il procedimento induttivo (risalendo dai casi particolari di virtù alla virtù in quanto tale). Aristotele fa di lui l’ ευρετης dei ragionamenti induttivi e delle definizioni universali, attribuendogli il merito di non concepire gli universali come separati (come invece fecero i Platonici). Dopo aver delineato i punti deboli della dottrina delle Idee, Aristotele torna – con una certa insistenza – sulla teoria platonica dei Numeri Ideali e sulle innumerevoli aporie che insorgono dalla loro ammissione. Il libro quattordicesimo, che chiude l’opera, si apre, ancora una volta, all’insegna di una critica dei principi ammessi dai Platonici, una critica condotta per cinque vie argomentative: in primo luogo, lo Stagirita mette in luce le assurdità derivanti dall’ammissione dei contrari come principi di tutte le cose (non possono essere “realtà prime”, poiché necessitano essi stessi di un sostrato a cui inerire, né possono essere sostanze, perché alla sostanza nulla è contrario: dunque non sono principi); dei due contrari ammessi dai Platonici, l’Uno è dai Platonici inteso come forma, l’altro come materia; i Platonici, poi, non hanno chiarito quale sia il contrario dell’Uno; Aristotele, poi, nota come ammettere l’Uno come sostanza sia contraddittorio, giacchè l’Uno, per esistere, necessita sempre di una sostanza cui inerire (un cavallo, una casa, un albero, ecc). Da ultimo, lo Stagirita dichiara guerra al “principio materiale” postulato dai Platonici (il molto e il poco, il grande e il piccolo, ecc) attaccando armato di cinque argomentazioni cogenti: a) sono affezioni, non sostrati; b) sono relazioni, ossia rientrano in quella categoria (la “relazione”) dotata del minor tasso di essere; c) la relazione non può essere materia, poiché non può essere potenza; d) il molto e il poco si predicano di ciò di cui dovrebbero essere elementi; e) il poco si predica del due e il molto si predica dei numeri più grandi. Aristotele ritorna poi sulla questione dei “numeri”, criticando ancora una volta Platone e i suoi seguaci (soprattutto Speusippo e Senocrate) che hanno ad essi attribuito esistenza autonoma e separata (il tre in sé, e così via): molto migliore è la prospettiva pitagorica, che se non altro concepisce i numeri come immanenti alle cose. Successivamente lo Stagirita prende in esame un’altra problematica non da poco: se il Bene di cui Platone parla nella “Repubblica” nasca solo dallo sviluppo concreto delle cose o, piuttosto, se sia il principio da cui le cose scaturiscono. La risposta data da Aristotele è che il bene appartiene al principio e che quest’ultimo è sostanza autosufficiente e indipendente (proprio perché è Bene). Gli ultimi due paragrafi del capitolo quattordicesimo sono nuovamente dedicati al problema dei numeri in Platone, e Aristotele muove ad essi una critica con la quale avvalora ulteriormente le proprie teorie, secondo le quali i numeri sono un qualcosa di ricavabile per astrazione: non esiste il tre in sé, bensì esistono gruppi di tre cose (tre cavalli, tre uomini, ecc) ed è da essi che – per astrazione estrapoliamo il concetto di tre.
ETICA NICOMACEA
Proponiamo qui uno schematico riassunto dell’Etica a Nicomaco di Aristotele. L’opera, divisa in dieci libri, venne così intitolata perché fu il figlio di Aristotele, Nicomaco, a raccogliere e divulgare le lezioni tenute dal padre. Soprattutto nei libri V, VI e vi si notano frequenti interpolazioni e manipolazioni dovute a discepoli del maestro e a successivi compilatori. L’opera fu pubblicata perla prima volta, insieme al corpus delle altre opere aristoteliche, da Andronico di Rodi (50-60 a.C.).
LIBRO I
I primi due libri dell’Etica e capp. 1-6 del terzo sono dedicati a definire l’oggetto della ricerca morale che è il bene dell’uomo, inteso non astrattamente, ma come il massimo dei beni che si può acquisire e realizzare attraverso l’azione. Per Aristotele l’etica è una scienza eminentemente pratica e in essa il sapere deve essere finalizzato all’agire. In questo senso, radicale è la critica rivolta a Platone, che considera ontologicamente il bene come Idea suprema e, come tale, inattingibile dall’uomo. E il sommo bene a cui ogni individuo tende è la felicità (ευδαιμονια). Ciascuno, però, l’intende a suo modo: chi la ripone nel piacere (εδονη) e nel godimento; chi nella ricchezza; chi nell’onore, chi, invece, nella vita contemplativa (βιος θεορητικος). Ma il vero bene, e con esso la vera felicità è qualcosa di perfetto, termine ultimo a cui si richiamano tutte le determinazioni particolari: “Ciò che è sufficiente in se stesso è ciò che, pur essendo da solo, rende la vita sceglibile e non bisognosa di nulla; ora, una cosa di questo genere noi riteniamo che è la felicità”, la quale consiste in “un’attività dell’anima razionale secondo virtù e, se le virtù sono molteplici, secondo la più eccellente e la perfetta”. Dalla felicità l’indagine si sposta quindi alla virtù. Un’importante distinzione viene fatta, nell’ambito delle virtù umane, tra le virtù dianoetiche, che sono proprie della parte intellettuale dell’anima, e le virtù etiche che corrispondono alla parte appetitiva dell’anima, in quanto guidata dalla ragione.
LIBRO II
Nel secondo libro Aristotele si sofferma a esaminare la natura di tali virtù: esse le virtù sono del carattere e derivano dall’abitudine, da cui hanno tratto anche il nome (“etiche” da ηθος) e non si possiedono per natura, anche se per natura l’uomo ha la capacità di acquisirle, e si determinano soltanto in base ad una serie azioni di una certa qualità; esse consistono nella “disposizione a scegliere il “giusto mezzo” adeguato alla nostra natura, quale è determinato dalla ragione, e quale potrebbe determinarlo il saggio”. Il giusto mezzo si trova tra due estremi, di cui uno è vizioso per eccesso e l’altro per difetto, cosicché, nel passare ad enumerare le singole virtù Aristotele considera: • il coraggio come giusto mezzo tra la viltà e la temerarietà, • la temperanza come giusto mezzo tra intemperanza e insensibilità, • la liberalità come giusto mezzo tra avarizia e prodigalità, • la magnanimità come giusto mezzo tra la vanità e l’umiltà, • la mansuetudine come giusto mezzo tra l’irascibilità e l’indolenza. • La virtù principale, comunque, è la giustizia a cui sarà dedicato l’intero quinto libro.
LIBRO III
Il terzo libro concerne l’atto pratico, al fine di definire la volontarietà e l’involontarietà dell’azione: “Poiché involontario è ciò che si compie per costrizione e per ignoranza, si converrà che volontario è ciò il cui principio risiede nel soggetto, il quale conosce le condizioni particolari in cui si svolge l’azione”. E’ chiaro, quindi, come per Aristotele la virtù e la malvagità dipendono soltanto dall’individuo, il quale è libero di scegliere in quanto “è il principio e il padre dei suoi atti come dei suoi figli”.
LIBRO IV
Il libro quarto è dedicato all’esame di particolari virtù etiche, già enumerate nel secondo libro.
LIBRO V Il libro quinto tratta della giustizia, la virtù intera e perfetta: “La giustizia è la virtù più efficace, e né la stella della sera, né quella del mattino sono cosi meravigliose, e citando il proverbio diciamo:Nella giustizia ogni virtù si raccoglie in una sola. Ed è una virtù perfetta al più alto grado perché chi la possiede è in grado di usare la virtù anche verso gli altri e non soltanto verso se stesso”. Esiste una giustizia distributiva a cui compete di dispensare onori o altri beni agli appartenenti alla stessa comunità secondo i meriti di ciascuno, ed essa è simile ad una proposizione geometrica in quanto le ricompense e gli onori distribuiti a due individui stanno in rapporto tra di loro, come i rispettivi meriti di costoro. Esiste poi una giustizia correttiva simile ad una proposizione aritmetica, il cui compito è di pareggiare i vantaggi e gli svantaggi nei rapporti contrattuali tra gli uomini sia volontari che involontari. Sulla giustizia è fondato, inoltre, il diritto che Aristotele distingue in diritto privato e diritto pubblico, a sua volta distinto in diritto legittimo, che è quello fissato dalle leggi vigenti nei vari stati, e in diritto naturale, che è il migliore in quanto è “ciò che ha la stessa forza dappertutto ed è indipendente dalla diversità delle opinioni”. Viene, poi, definita l’equità, la cui natura “è la rettificazione della legge là dove si rivela insufficiente per il suo carattere universale”; cosicché il giusto e l’equo sono la stessa cosa in quanto l’equo è superiore non al giusto in sé, ma al giusto formulato dalla legge, che nella sua universalità è soggetta all’errore.
LIBRO VI Il sesto libro contiene la trattazione delle virtù dianoetiche, che sono proprie dell’anima razionale. Esse sono la scienza, l’arte, la saggezza, l’intelligenza, la sapienza. La scienza (επιστημη) è “una disposizione che dirige la dimostrazione” ed ha per oggetto ciò che non può essere diversamente da quello che è, vale a dire il necessario e l’eterno; l’arte (τεχνη) è “una disposizione accompagnata da ragionamento vero che dirige il produrre” ed è diversa, pertanto, dalla disposizione che dirige l’agire, in cui consiste la saggezza, che è definita “come l’abito pratico razionale che concerne ciò che è bene o male per l’uomo” ed ha una natura mutevole al pari dell’uomo; l’intelligenza è un abito razionale che ha la facoltà di intuire i principi primi di tutte le scienze, nonché i “termini ultimi”, i fini, cioè, a cui deve indirizzarsi l’azione, e insieme con la scienza costituisce la sapienza (σοφια), che è il grado più elevato e universale del sapere, in quanto è “insieme scienza e intelligenza delle cose più alte per natura” e, come tale, è ben distinto dalla saggezza. LIBRO VII Il settimo libro tratta della temperanza e dell’intemperanza, della fermezza di carattere e della mollezza, e in ultimo, del piacere, definito “l’atto di un abito che è conforme a natura”. In questo senso il piacere, come disposizione libera e costante, svincolata dalla sensibilità, rappresenta il fondamento della felicità.
LIBRI VIII e IX
L’ottavo e il nono libro sono dedicati all’amicizia, che Aristotele considera “una cosa non soltanto necessaria, ma anche bella”, in quanto “nessuno sceglierebbe di vivere senza alici, anche se fosse provvisto in abbondanza di tutti gli altri beni”: “L’amicizia è una virtù o s’accompagna alla virtù; inoltre essa è cosa necessarissima per la vita. Infatti nessuno sceglierebbe di vivere senza amici, anche se avesse tutti gli altri beni (e infatti sembra che proprio i ricchi e coloro che posseggono cariche e poteri abbiano soprattutto bisogno di amici; infatti quale utilità vi è in questa prosperità, se è tolta la possibilità di beneficare, la quale sorge ed è lodata soprattutto verso gli amici? O come essa potrebbe esser salvaguardata e conservata senza amici? Infatti quanto più essa è grande, tanto più è malsicura). E si ritiene che gli amici siano il solo rifugio nella povertà e nelle altre disgrazie; e ai giovani l’amicizia è d’aiuto per non errare, ai vecchi per assistenza e per la loro insufficienza ad agire a causa della loro debolezza, a quelli che sono nel pieno delle forze per le belle azioni”. Tre sono le specie dell’amicizia a seconda che sia fondata sul piacere reciproco, sull’utile o sulla virtù: “Tre dunque sono le specie di amicizie, come tre sono le specie di qualità suscettibili d’amicizia: e a ciascuna di esse corrisponde un ricambio di amicizia non nascosto. E coloro che si amano reciprocamente si vogliono reciprocamente del bene, riguardo a ciò per cui si amano. Quelli dunque che si amano reciprocamente a causa dell’utile non si amano per se stessi, bensì in quanto deriva loro reciprocamente un qualche bene; similmente anche quelli che si amano a causa del piacere. (…) L’amicizia perfetta è quella dei buoni e dei simili nella virtù. Costoro infatti si vogliono bene reciprocamente in quanto sono buoni, e sono buoni di per sé; e coloro che vogliono bene agli amici proprio per gli amici stessi sono gli autentici amici (infatti essi sono tali di per se stessi e non accidentalmente); quindi la loro amicizia dura finché essi sono buoni, e la virtù è qualcosa di stabile; e ciascuno è buono sia in senso assoluto sia per l’amico. Infatti i buoni sono sia buoni in senso assoluto, sia utili reciprocamente”. Mentre quella fondata sul piacere e sull’utile si rivela accidentale e cessa quando il piacere o l’utile vengono meno, quella invece fondata sulla virtù è perfetta ed è la più stabile ferma. Ci sono poi tante specie di amicizia quante sono le comunità organizzate della società civile; ma in ultima istanza è nella comunità politica, che ha per fine l’utile comune, che devono essere individuate le condizioni più generali dell’amicizia. E per ogni tipo di configurazione istituzionale si hanno forme diverse di amicizia. Aristotele si sofferma qui ad indagare sui diversi gradi di amicizia e di giustizia che si realizzano nella varie costituzioni, rette e degeneri, concludendo che “a poca si ridicono le amicizie e il giusto nelle tirannidi, mentre nelle democrazie la loro importanza è grande, giacché molte sono le cose comuni a coloro che sono uguali”. L’indagine si sposta poi all’interno delle comunità domestiche per analizzare i vari rapporti tra i componenti del nucleo familiare, stabilendo dei nessi tra tali amicizie e quelle contratte nelle varie comunità politiche.
LIBRO X
L’ultimo libro completa la determinazione della felicità e definisce in che cosa consista il sommo bene. Se la felicità è fondata sull’agire secondo virtù e se si considera che le virtù dianoetiche sono superiori a quelle etiche e, in particolare, che la virtù più alta è quella teoretica, che culmina nella sapienza, cioè nella vita contemplativa. La contemplazione (θεορια), infatti, è l’attività più elevata in quanto è attività dell’intelletto; è l’attività più continua e che dà più piacere, perché i piaceri della filosofia sono i più intensi e i più sicuri; è l’attività più autosufficiente perché il sapere basta a se stesso e nulla deve ricercare fuori di sé per coltivare al sua sapienza; è l’attività che si ama in se stessa, perché ha in sé, nella contemplazione, il suo fine unico. Infine è l’attività svolta da Dio stesso, che è “pensiero di pensiero” e che pensa senza soluzione di continuità: nella misura in cui esercita il pensiero che è la caratteristica che rende l’uomo veramente tale, l’uomo partecipa della vita divina; tuttavia, in quanto essere naturale, l’uomo non può esercitare senza interruzione l’attività contemplativa, giacchè deve sopperire ai bisogni fisici che la natura gli impone (il soddisfacimento della fame, della sete, ecc).
IL DE ANIMA
Se di Platone ci sono pervenuti pressoché tutti gli scritti, ciò non vale per Aristotele, di cui possediamo solamente quegli scritti la cui destinazione era il pubblico interno alla sua scuola. Si tratta di scritti stringati e concisi, probabilmente di appunti che Aristotele sviluppava poi a lezione; più difficile, invece, che si tratti di appunti presi dai suoi studenti durante le lezioni da lui tenute. Lo scritto “Sull’anima” (“De anima” in latino, “Περι ψυχης” in greco) rientra fra queste opere a noi giunte: esso si articola in tre libri, dei quali il primo pone l’attenzione su quali siano i problemi da risolvere nell’indagine sull’anima. Il primo problema in cui ci si imbatte è la definizione dell’anima: che cos’è? Aristotele, per poter rispondere adeguatamente a tale domanda, ritiene indispensabile effettuare una ricognizione preliminare su quanto han detto sull’argomento i suoi predecessori e sottoporre le loro tesi ad analisi critica (incontriamo un procedimento simile anche nella “Metafisica”). Nel secondo libro, dopo aver ripercorso le definizioni precedenti e i loro difetti, lo Stagirita arriva a formulare la propria definizione di “anima” e a tratteggiarne le funzioni: proprio alle funzioni dell’anima sono dedicati il libro secondo (in particolare alla percezione sensibile) e il libro terzo (con particolare attenzione all’attività intellettiva dell’anima). Nel primo capitolo del primo libro, Aristotele afferma che quella che si accinge ad intraprendere è una ιστορια, ossia un’ “indagine” diretta sull’anima (ψυχη): si tratta – egli prosegue – di una forma di sapere che rientra fra quelle più importanti; infatti, riteniamo comunemente che le forme di sapere più importanti siano quelle che si distinguono o perché hanno maggior rigore o perché si occupano degli oggetti migliori e più stupefacenti. Su cosa sia il “sapere rigoroso”, Aristotele si era già soffermato negli “Analitici secondi”, in cui era giunto alla conclusione che un sapere può dirsi rigoroso se dimostrabile con catene di ragionamenti (ossia con sillogismi): ora, nello studio dell’anima, è evidente che non può esserci quel rigore che troviamo nello studio della geometria o della matematica. Tuttavia, pur mancando il rigore, lo studio dell’anima è nobilitato dal fatto che l’oggetto di tale indagine è costituito da una delle cose più stupefacenti che ci siano: l’anima. Questo è particolarmente rilevante perché nelle prime pagine della “Metafisica” Aristotele indicava nella meraviglia (το θαυμαζειν) il motore della ricerca, giacché si desidera conoscere una cosa perché essa desta in noi stupore (i corpi celesti o l’incommensurabilità della diagonale del quadrato): una volta scoperta la causa di queste cose che producono in noi meraviglia, non ci si stupisce più. Questo discorso, naturalmente, vale anche per l’anima: perché ci sono entità animate e altre non animate? Perché non esiste solo l’inanimato o solo l’animato, ma è come se convivessero due mondi antitetici? Secondo Aristotele, capire l’anima aiuta anche a capire gli animali (per i quali lo Stagirita è particolarmente interessato, come dimostrano i numerosi suoi scritti in materia): in senso lato, dunque, l’indagine sull’anima rientra nell’indagine sulla natura. ” Ci prefiggiamo di considerare e conoscere la sua [dell’anima] natura (φυσις) e essenza (ουσια) e, poi, tutte le caratteristiche che le competono “: tali caratteristiche sono, in particolare, le affezioni e le proprietà in virtù delle quali l’anima è quella che è. Prima di chiedersi quale sia il suo compito, è bene domandarsi che cosa sia l’anima e scoprirlo è una delle cose più difficili: bisogna anche chiarire quale procedura si debba impiegare nell’investigazione, chiarendo, soprattutto, se si tratti di un metodo comune ad altre indagini o specifico dell’anima. Ammettiamo che sia un metodo comune, dimostrativo, che inferisce conclusioni a partire da premesse, o, magari, che proceda per divisione, come immaginava Platone nel “Sofista”, quando si domandava che cosa fosse la pesca con la lenza: si tratta di inserire la pesca con la lenza in un genere più ampio, 1′ “arte” (τεχνη); ma l’arte si suddivide in “arte di acquisizione” e “arte di produzione” e, ovviamente, la pesca si colloca nell’ambito dell’arte di acquisizione. Operando successive divisioni si giungerà alla definizione di pesca con la lenza: ma come si può applicare questo metodo (o anche quello dimostrativo ) all’anima? E’ assolutamente impossibile, poiché tutti e due i metodi partono da principi che non sono gli stessi per tutte le discipline (diversi, infatti, sono i principi da cui partire per studiare l’anima, la fisica e la matematica). Aristotele nota, piuttosto acutamente, come di fronte al problema dell’anima si apra un ventaglio di soluzioni tutte accettabili: ci troviamo dunque di fronte a delle απορίαι, ossia a dei vicoli ciechi senza possibilità di uscita. La prima “aporia” in cui ci si imbatte riguarda la stessa definizione dell’anima: in quale genere si trovi e che cosa sia, se sia sostanza o qualità o quantità o altra categoria (secondo quanto Aristotele aveva insegnato nelle “Categorie”). L’anima potrebbe essere una “sostanza prima”, ossia un τοδε τι, un “questa cosa qui” in carne e ossa; ma potrebbe anche essere una “sostanza seconda” (ossia una specie), del tipo “uomo” o “cavallo”; ma, infine, nulla vieta di pensare che essa sia solo un predicato, come ad esempio lo è il colore “rosso”, che esiste nella misura in cui esiste una sostanza prima (non ci sarebbe infatti il rosso se non ci fossero cose rosse). Ma c’è anche un’altra aporia: ammesso che l’anima sia un ente, occorre chiedersi che tipo di ente sia e per rispondere Aristotele si avvale di una distinzione da lui operata in altri scritti: quella tra potenza (δυναμις) e atto (εντελεχεια), secondo la quale il marmo è una statua in potenza (nel senso che può diventare statua) e la statua è atto, cioè realizzazione compiuta del marmo. Ora, l’anima, intesa come ente, è potenza o atto? Ci si imbatte però in una nuova aporia: ammettendo che l’anima sia un’entità, essa è fatta di parti o priva di parti? E, nel caso in cui sia costituita da parti, che rapporto sussiste tra il tutto e le singole parti? Sarà un rapporto come quello tra le parti della pietra (per cui se spacco la pietra in parti ho altre pietre) o sarà invece un rapporto come quello tra l’uomo e le sue parti (per cui se tolgo all’uomo una parte del suo corpo non ho un altro uomo)? Secondo Platone (stando a ciò che egli asseriva nel “Fedro” e nella “Repubblica”), l’anima è tripartita (parte razionale, parte impetuosa e parte desiderativa); secondo gli Stoici, essa sarà assolutamente unitaria. Ma c’è anche un’altra aporia non da poco: esiste un solo tipo di anima o ne esistono più d’uno? Aristotele si pone questo interrogativo perché ha di fronte a sé una sfilza di indagini sull’anima (condotte dai suoi predecessori) che mettevano l’accento su come solo l’uomo, propriamente, fosse dotato di anima. Lo Stagirita, sotto questo profilo, capovolge quest’idea comune e sostiene che anche gli animali e le piante hanno l’anima: bisogna tuttavia chiedersi di che tipo di anima si tratti. Posto che vi siano molte specie di anima, è possibile dare un’unica definizione che valga per tutte o bisognerà dare una definizione diversa per ogni singolo tipo di anima, così come per ogni tipo di essere (uomo, cavallo, casa, ecc)? Aristotele cercherà, in qualche modo e non senza difficoltà, di formulare una definizione universalmente valida. Ammesso invece che l’anima sia una sola ma costituita da più parti (come credeva Platone), dobbiamo prima esaminare le parti o l’anima nel suo insieme? E prima le parti o le funzioni di esse? Vale a dire: bisogna prima proiettare l’indagine sull’intelletto o sull’intellezione? Prima i colori o prima la percezione dei colori? E’ come se vi fosse un rapporto ermeneutico fra il tutto e le parti: da un lato, infatti, se ho colto l’oggetto su cui sto investigando (ossia l’anima), sarà più facile cogliere le cause delle cose che le accadono (le passioni, ecc); ma, dall’altro, se colgo la causa delle cose che le succedono, sarà allora possibile risalire alla comprensione dell’anima. E le cose che accadono nell’anima sono proprie solo di essa o anche di quella particolare cosa che possiede l’anima, ossia il corpo? Anima e corpo sono separati e indipendenti (come credevano Platone e i Pitagorici) o sono strettamente connessi per cui se cessa di esistere uno, cessa di esistere anche l’altro? In che senso il corpo possiede l’anima? Aristotele nota, a tal proposito, come la maggior parte delle affezioni dell’anima non potrebbero avvenire senza il corpo: ad esempio, secondo gli insegnamenti della medicina dell’epoca, la collera altro non è se non l’ebollizione del sangue, il che non potrebbe accadere se non avessimo il corpo. Aristotele pare più perplesso per quel che riguarda il pensiero, che assomiglia molto ad un’affezione dell’anima: in prima analisi, si potrebbe essere portati a dire che il pensiero è indipendente dal corpo; eppure anche il pensiero, in qualche modo, deve per forza passare dal corpo e, per spiegare ciò, Aristotele ricorre alla nozione di “immaginazione” (φαντασια), intesa come l’accogliere ciò che appare ai sensi. Che il pensiero passi dal corpo appare evidente se pensiamo a quando, dopo aver visto un oggetto sensibile (una casa, un cavallo, ecc), lo ripensiamo senza averlo davanti. Ci sono, dunque, passioni (παθη) che riguardano l’anima e non il corpo? E su cosa si esercita l’attività del pensiero? Gli oggetti del pensiero vengono da Aristotele definiti “intelligibili” e altro non sono se non le nozioni universali (uomo, bello, giusto, ecc): ma il punto di partenza per ogni conoscenza è la sfera sensibile, che ci mette in contatto con entità sensibili individuali collocate nel tempo e nello spazio; infatti, non posso mai vedere l’uomo, ma sempre e solo singoli uomini (Gorgia, Platone, Socrate, ecc) e arrivo alla nozione universale di uomo operando un’astrazione. Tra pensiero e percezione, tuttavia, – nota Aristotele – esiste una zona di mezzo, che sta a metà strada fra le due: si tratta della fantasia (“immaginazione”), strettamente connessa con la memoria: vedo Socrate in carne ed ossa, poi se se ne va, ma, ciononostante, io conservo la sua immagine nella mia mente grazie alla memoria. E quindi il pensiero rivolge la sua attenzione a queste immagini sedimentate nella memoria: ma se esso, per agire, non può non operare sulle immagini presenti nella memoria, ciò significa che il pensiero non può essere esercitato a prescindere dal corpo. Aristotele, in tale prospettiva, sembra escludere la possibilità che l’anima possa sopravvivere dopo la morte del corpo (staccandosi in tal modo dalla tradizione platonica), poiché le due entità sono talmente dipendenti l’una dall’altra che, morta una, non può che morire anche l’altra. Infatti, se tutte le affezioni dell’anima sono in qualche modo connesse al corpo, allora l’anima non è distinta dal corpo: e, come dirà Aristotele più avanti, l’anima sarà un’ attualizzazione (εντελεχεια) di certe funzioni, cosicchè la posizione aristotelica potrà essere etichettata come “funzionalismo” (giacchè concepisce l’anima come una serie di funzioni connesse al corpo). E’ curioso notare come lo Stagirita ritenga che il cervello non sia il punto centrale della nostra riflessione, ma, in fin dei conti, un semplice organo di raffreddamento, meno importante rispetto al cuore (sede dei sentimenti). ” Se allora tra le attività o affezioni dell’anima ce n’è qualcuna che le sia propria, l’anima potrebbe avere esistenza autonoma; ma se non ce n’è nessuna che le sia propria, non sarà separabile “: se si trovasse una qualche attività dell’anima assolutamente indipendente dal corpo, allora sarebbe possibile ammettere la separabilità dell’anima dal corpo, ma, poiché Aristotele non ne rinviene alcuna (“sembra che anche le affezioni dell’anima abbiano tutte un legame con il corpo “), allora è costretto a riconoscere l’inseparabilità dei due. E, di conseguenza, con il perire del corpo cessa di esistere anche l’anima. Che tra anima e corpo intercorra un rapporto strettissimo appare anche evidente dal fatto che non appena si verificano affezioni dell’anima il corpo subisce modifiche: a seconda che io provi gioia o dolore, infatti, il corpo si modifica in un modo o in un altro. Questa considerazione implica una conseguenza di notevole importanza: in quanto connesse al corpo, le affezioni dell’anima possono essere indagate dallo studioso della natura (ο φυσικος), il quale si occuperà, in particolare, materialmente delle produzioni corporee delle affezioni (l’amore, la paura, ecc); tuttavia, non basta conoscere la produzione, bensì bisogna comprendere le cause, ossia occorre anche sapere che cosa siano l’amore o la paura, e ciò compete, propriamente, al filosofo. E anche per capire che cosa sia una determinata cosa (supponiamo una casa), possiamo condurre o un’indagine fisica (incentrata sulla causa materiale: la casa è un insieme di certi materiali) o un’indagine dialettica (incentrata sulla causa finale: la casa è fatta per ripararsi dalle intemperie). Aristotele chiama la procedura che intende seguire διαπορείσθαι (il porre problemi) e, in primo luogo, compie un’esplorazione delle posizioni assunte in materia di anima dai suoi predecessori, per vedere se essi sono stati in grado di risolvere qualche problema: dopo aver introdotto l’argomento di cui si occuperà nello scritto, il resto del libro I è dedicato alla discussione di queste posizioni; in particolare, Aristotele si propone di prendere in considerazione le δοξαι, le “opinioni”. E nello scritto “Topici” aveva sostenuto che le discussioni filosofiche devo partire sì da opinioni, ma non da opinioni qualunque: bensì da quelle su cui tutti gli uomini o la maggior parte di essi si trovano d’accordo oppure da quelle espresse dalle persone più competenti in quell’ambito (tali opinioni sono dette ενδοξαι, ossia “illustri”). Pertanto, parlando dell’anima, non essendoci alcun punto su cui concordano tutti gli uomini, Aristotele fa riferimento alle “illustri” opinioni sostenute dai filosofi della natura a lui precedenti (poiché, come abbiamo detto, l’anima è in qualche modo connessa alla natura): e tali opinioni possono essere suddivise in due gruppi. Infatti, al di là delle specificità delle argomentazioni dei singoli pensatori, tutti, bene o male, hanno finito per intendere l’anima come causa del movimento oppure come causa della percezione (oppure, più raramente, come causa di entrambe le attività). Nel II libro del “De anima”, Aristotele afferma in merito: ” pare che l’essere animato si distingua dall’inanimato soprattutto per due proprietà: movimento e percezione “. Partendo dall’analisi del primo gruppo, è facile capire il percorso attraverso il quale si è arrivati a tale posizione: infatti, la prima grande differenza che distingue gli esseri animati da quelli inanimati è che solo i primi si muovono da sé, con l’inevitabile conseguenza che l’anima dev’essere quel qualcosa che conferisce il movimento. La strada percorsa dai pensatori del secondo gruppo è diversa: a loro avviso, la grande differenza tra esseri animati ed esseri inanimati risiede nel fatto che solo i primi sono dotati di percezioni. Aristotele non si trova d’accordo con l’inferenza tratta da chi sostiene che il movimento sia ciò che distingue l’animato dall’inanimato: ad avviso di costoro, infatti, dalla constatazione che ciò che si muove da sé è dotato di anima, deriva necessariamente che l’anima stessa sia in movimento incessante, partendo dalla premessa che una cosa può muoverne un’altra solamente se essa stessa è già in movimento. Ma Aristotele smaschera queste posizioni servendosi della causa finale e mettendo in luce come vi siano casi in cui ciò che muove non è mosso: in particolare, nel XII libro della “Metafisica”, per spiegare l’immobilità del “motore immobile”, ricorreva ad un esempio particolarmente soddisfacente: un oggetto che amiamo ci fa muovere verso di lui senza che esso debba per forza muoversi. Il primo dei predecessori su cui Aristotele si sofferma è Democrito, ad avviso del quale ” l’anima è una specie di fuoco e di calore “: il pensatore di Abdera era probabilmente giunto a questa conclusione partendo dalla constatazione che un corpo morto (e quindi privo di anima) è inevitabilmente freddo. Al contrario, un’entità viva è calda, sicché dev’essere l’anima a fornire tale calore. Secondo Democrito l’anima, come ogni altra cosa, è costituita da atomi; gli atomi di cui essa è composta, però, sono sferici e quindi più mobili e veloci; e, potendosi muovere rapidamente, producono calore: ecco perché l’anima è calore e gli atomi che la compongono assomigliano, in qualche misura, al pulviscolo sospeso in aria che noi scorgiamo quando penetrano dalle finestre i raggi del sole. In tale prospettiva, ad avviso di Democrito, la respirazione è ciò che contraddistingue gli esseri animati da quelli inanimati: espirare significa buttar fuori atomi di anima, e se non ci fosse l’inspirazione, attraverso la quale vengono introdotti atomi di anima, il nostro corpo si disgregherebbe in brevissimo tempo (perché verrebbero espulsi tutti gli atomi dell’anima). Secondo Aristotele, anche l’interpretazione dell’anima data dai Pitagorici è, grosso modo, su questa linea. Anassagora, invece, ha identificato l’anima con l’Intelletto cosmico, che mette in movimento ogni cosa. Dal canto suo, Platone rientra nel novero di quei pensatori che hanno inteso l’anima come un’entità che si muove da sé: soprattutto nel “Fedro”, egli dimostrava l’immortalità dell’anima a partire dal suo movimento, mettendo in evidenza come un qualcosa che per sua natura partecipa del movimento non può in alcun modo partecipare della morte (intesa come negazione del movimento stesso). Senocrate, discepolo di Platone, aveva invece enigmaticamente asserito che l’anima fosse un numero che muove se stesso. Dopo essersi soffermato sull’attribuzione, effettuata dai pensatori a lui precedenti, del movimento all’anima, Aristotele si sofferma dunque sull’anima intesa come capacità di percepire. In questo secondo gruppo di posizioni rientrano tutti coloro che hanno letto nella percezione la caratteristica peculiare dell’anima e tra questi pensatori spicca la figura di Empedocle da Agrigento, il quale (anche se nei suoi frammenti che possediamo non compare mai la parola ψυχη) individua un parallelismo tra macrocosmo e microcosmo in virtù del quale l’anima umana è costituita da quattro elementi (“radici”) e percepisce la realtà esterna perché anche quest’ultima è composta dai medesimi quattro principi. Nella sua trattazione, Aristotele riporta integralmente un passo dal poema di Empedocle: ” con la terra conosciamo la terra, con l’acqua l’acqua, col fuoco il fuoco distruttore, con l’etere l’etere divino, con l’amore l’amore divino, con la discordia la malvagia discordia “; è il simile che conosce il simile. Accanto ad Empedocle, Aristotele pone Platone e le sue teorie presenti nel “Timeo”, in cui l’anima è concepita come un insieme costituito da elementi che (e qui sta la differenza precipua rispetto ad Empedocle), a loro volta, sono costituiti da poliedri. E’ interessante il fatto che lo Stagirita, all’improvviso, citi il suo proprio scritto Περι φιλοσοφιας (“Sulla filosofia”) – andato perduto – in cui troviamo una bislacca commistione di teorie geometriche ed aritmetiche impiegate per spiegare l’anima e il mondo. Ma, accanto a questi due gruppi di pensatori, ve n’è un terzo, composto da tutti coloro che hanno riconosciuto come caratteristiche fondamentali dell’anima sia il movimento sia la percezione: il principale esponente di questa compagine è Senocrate, che successe a Speusippo nella direzione dell’Accademia e che definì l’anima come ” numero che muove se stesso “; da un lato, l’anima è, ai suoi occhi, in movimento, ma, dall’altro, è numero. Ma tra i 1 pensatori antichi – nota Aristotele – alcuni hanno inteso l’anima come corporea (Democrito), altri invece come incorporea (Platone, Senocrate), altri hanno mescolato le due componenti; alcuni, poi, l’hanno concepita come unica, altri invece come composta da molte parti. Ora Aristotele, dopo aver fatto questa carrellata di opinioni illustri, può, al principio del II libro, esporre la propria tesi: in particolare, egli attua la tecnica della confutazione per dimostrare l’inconsistenza delle posizioni di coloro che hanno sostenuto che l’anima è in movimento. Forse – egli nota – non solo è falso che l’anima sia in movimento, ma addirittura impossibile; ragionando per assurdo, ammettiamo che l’anima si muova: ne consegue quanto segue. In primo luogo, due sono i possibili modi in cui essa può muoversi: o per virtù propria o perché mossa da un’altra cosa. Per comprendere meglio questo punto, pensiamo ad una nave: essa si muove da sé; ma il passeggero che sta seduto su di essa si muove perché è la nave che si muove. L’anima, dal canto suo, muove e si muove: ma in che senso? Nel senso della nave o del passeggero su di essa? Ammettiamo che si muova da sé, come la nave: ma allora dobbiamo fare un’altra distinzione, poiché la κινησις (“movimento”) avviene in quattro modi diversi. Infatti, è spostamento da un luogo ad un altro, ma non solo; è anche qualunque forma di mutamento: ad esempio, l’ingrassare o il dimagrire implicano uno spostamento di materia. E ciò vale anche per qualsiasi assunzione o perdita di qualità; infine, il quarto ed ultimo (nonché il più radicale) modo in cui avviene la κινησις consiste nel nascere e nel morire (movimento sostanziale). Ma allora l’anima di quale di questi quattro tipi di κινησις si muove? Ed è tutta l’anima a muoversi di tutti questi movimenti o solamente di uno o di alcuni? Ammettiamo che, oltre a muoversi da sé, essa si muova di tutti e quattro questi movimenti: occorre ammettere che il movimento implica uno spazio, poiché senza di esso il movimento non può avvenire (gli atomisti ammettevano il vuoto ma Aristotele lo rifiuta). L’anima, pertanto, dovrà avere uno spazio in cui muoversi: chi sostiene l’immaterialità dell’anima si trova a questo punto in serie difficoltà, perché è assurdo dover ammettere che un qualcosa di immateriale si muova nello spazio. Inoltre, le potrà accadere ciò che accade a qualunque cosa in movimento: i moti violenti (o costrittivi). Esempio di moto violento è quello della pietra scagliata verso l’alto: essa, dopo essere salita per un tratto in virtù dell’impeto impressole, cade a terra, verso il suo luogo naturale; anche l’anima, quindi, è soggetta a moti violenti? E se si, di che genere di moto violento? Attribuendo all’anima il movimento autonomo e, con esso, i movimenti violenti, ci si trova sotto scacco: il movimento secondo natura dell’anima tende verso l’alto (come quello del fuoco) o verso il basso (come quello della terra)? Ammettiamo, poi, che essa muova il corpo e che questo si muova per traslazione (spostamento da un luogo all’altro): ne consegue che anche l’anima cambia luogo, ma ciò contraddice coloro che propugnano l’immortalità dell’anima. E se essa muta luogo, lo muta nella sua totalità o solo in parte? Se si riconosce che l’anima è in grado di spostarsi, bisogna per forza riconoscere anche che essa possa uscire dal corpo: quindi, dopo la morte, l’anima può uscire dal nostro corpo e infilarsi in un altro. Se l’anima muove se stessa, anch’essa si muoverà e quindi dovrà necessariamente sdoppiarsi (compie e subisce il movimento) e in tal modo essa uscirebbe da sé, sarebbe una εκστασις (“venir fuori di sè”). Lo stesso modo in cui si muovono gli animali genera parecchie difficoltà, nota Aristotele; come causa motrice, l’anima ha la προαιρεσις, la “scelta libera” e, in tale prospettiva, il meccanicismo democriteo, che non lascia spazio alla libertà, va respinto. Anche il “Timeo” platonico è, sotto questo profilo, problematico: in quest’opera, Platone ammette che il cosmo stesso sia dotato di un’anima che, muovendosi circolarmente, metta in moto anche l’universo corporeo; l’anima sarebbe composta di elementi in rapporti armonici, per cui ai rapporti del cielo corrisponderebbe il movimento dell’anima. Ma ciò è riduttivo, in quanto induce a identificare l’anima con l’intelletto: secondo tale definizioni, gli animali e le piante sarebbero inanimati, alla stregua delle pietre. Platone, in realtà, sosteneva l’esistenza di altre anime (sensitive) che non si muovevano circolarmente: contro questa posizione, Aristotele muove una sfilza di obbiezioni che invocano la divisibilità all’infinito delle grandezze; gli stessi rapporti armonici su cui Platone costruisce il suo ragionamento restano poco chiari e alquanto problematici. Ma si deve paragonare il pensiero ad un movimento o ad uno stato di quiete? Platone connette il movimento dell’anima a quello rotativo del cielo ma non spiega né la causa finale né quella efficiente di tale moto rotatorio. Tuttavia, si può anche ammettere che l’anima si muova non già per virtù sua, bensì perché mossa da altro: ciò sembra possibile soprattutto in riferimento alla percezione, in quanto percepiamo un oggetto nella misura in cui esso agisce su di noi. E poi c’è un’altra grave lacuna: tutti i pensatori anteriori rispetto ad Aristotele, hanno connesso l’anima al corpo, senza però spiegare con chiarezza la causa di tale collegamento; perché, dunque, l’anima è collegata al corpo? Quale è la condizione del corpo alla quale l’anima è legata? Aristotele dice che ” sembra ” (δοκει) che ciascun corpo abbia una forma propria e ciò implica che non è detto che ogni corpo abbia un’anima. I pensatori del passato, nota con sdegno Aristotele, dovevano allora spiegare quali corpi potessero avere l’anima e quali no, sennò si potrebbe essere indotti a ritenere che anche una pietra possa esserne dotata. Quale dovrà essere, quindi, la struttura del corpo suscettibile di possedere un’anima? Nel capitolo 4 del libro I, Aristotele prosegue con le obbiezioni, scagliandosi soprattutto contro la concezione secondo la quale l’anima altro non è se non un’armonia che tiene uniti gli elementi che costituiscono il corpo; si tratta di una tesi platonica, esposta nel “Fedone”, ma criticata da Platone stesso, poiché, come conseguenza, porta alla negazione dell’immortalità dell’anima (venuto meno il corpo, infatti, cessa di esistere anche l’armonia tra i suoi elementi). Se invece intendiamo l’anima come una sostanza che viene ad aggiungersi al corpo, alla pari di un vestito, non si deve ammettere – notava Platone – che essa, col trascorrere del tempo, si logori fino a dissolversi? Aristotele, memore di queste riflessioni del suo maestro, dice: ” sembra poi che l’intelletto sopraggiunga come una sostanza e che non si corrompa. In effetti, potrebbe corrompersi specialmente per l’indebolimento che consegue alla vecchiaia” (A4, 409). Secondo quanto afferma qui Aristotele, l’intelletto, una volta che sia venuto meno il corpo, non potrà più svolgere la propria attività; certo, l’intelletto come sostanza non si corrompe, ma, ciononostante, l’attività di pensiero che egli svolge è possibile solo in relazione al corpo dotato dell’intelletto; sicché, quando viene a mancare il corpo, l’intelletto permane ma non pensa più: esso è una sostanza che non si logora, poiché – come dice Aristotele – è” sopraggiunto ” (è però difficile capire da dove sia giunto). Le funzioni che esso svolgeva, infatti, non erano solo sue, bensi condivise con il corpo: e se ammettiamo l’incorruttibilità dell’intelletto, allora possiamo dire che esso è “forse qualcosa di più divino e di impassibile “. Il corpo muore, l’intelletto no: ma Aristotele non sta parlando dei singoli intelletti (il mio, il tuo, quello di Socrate, ecc), ma di qualcosa di più profondo (nella comprensione del quale la critica si è sbizzarrita, soprattutto quella araba). Nel libro II, dicevamo, Aristotele propone la sua concezione dell’anima e la correda di potenti argomentazioni. Proprio nelle prime righe, egli asserisce: “riprendiamo ora la strada come dall’inizio “, nel tentativo di determinare che cosa sia l’anima e quale sia il suo concetto ” più generale”, più comune, ossia quello che può abbracciare sotto di sé tutti i tipi di anima. Lo Stagirita afferma che, fra i tanti significati del verbo “è” ve n’è uno primario, da cui tutti gli altri derivano, un significato focale”, come ha detto uno studioso di Aristotele: tale significato profondo sta nella sostanza (ουσια); una cosa è se è una sostanza. Per capire meglio ciò, esaminiamo una sostanza qualunque, ad esempio una sfera di bronzo: che cosa è? Posso rispondere in svariati modi: in primo luogo, posso dire “è bronzo”, indicando il materiale di cui è costituito l’oggetto (colgo cioè l’oggetto sotto l’aspetto della materia, υλη); ma limitarsi a rispondere dicendo “è bronzo” è evidentemente sbagliato, poiché esistono altre cose di bronzo che non sono quella sostanza. Oltre alla materia, dunque, si deve anche indicare la forma (μορφη): nel caso della sfera di bronzo, l’essere sferico. La sostanza, secondo Aristotele, è sempre un τοδε τι, un “questa cosa qui”, ossia la cosa materialmente presente sotto i miei occhi. Nel II libro, dunque, Aristotele prova a dare una definizione generale di anima e ad analizzarla criticamente: anima sarà, a suo avviso, l’avere la funzione del riprodursi e la possibilità di avere percezioni sensibili. Si tratta, però, di definire in concreto cosa sia l’anima e, per farlo, lo Stagirita introduce la nozione di ουσια (“sostanza”), ossia quel qualcosa che fa sì che un ente sia ciò che è propriamente. Tale concetto può essere, tuttavia, inteso secondo svariate modalità: ad esempio, posso dire che “sostanza” del tavolo è essere materia (legno), oppure essere forma rettangolare, o, ancora, essere una materia connessa ad una forma, ossia un insieme (συνολον) delle due cose. Da questa concezione emerge un universo popolato da un enorme numero di sostanze individuali. Ora, Aristotele traccia un’identità tra la materia e la potenza (δυναμις), poiché nota come dalla materia ad esempio, un pezzo di marmo) possa (δυναται) derivare una molteplicità di cose (il tavolo, la statua, il tempio, ecc); e a far sì che il pezzo di marmo diventi un preciso oggetto (ad esempio, una statua) è la forma, la quale corrisponde quindi all’atto, ossia alla realizzazione. E con quest’attrezzatura concettuale Aristotele può dare una spiegazione (e di fatto lo fa) dell’intera realtà: egli paragona il rapporto tra potenza e atto al rapporto tra il possedere una scienza e farne effettivamente uso. Se, ad esempio, ho appreso la grammatica, posso dire di possederla allo stato potenziale: solo quando la applico concretamente essa viene messa in atto operativamente. Ora, per tratteggiare una definizione dell’anima, riprende questi precetti e, in particolare, quello di sostanza: comunemente si intendono come sostanze i corpi, cioè quelle realtà che sussistono effettivamente; tra essi, poi, constatiamo che alcuni hanno la vita, altri no. E, nota Aristotele, in prima analisi ciò che ci induce a dire che alcuni corpi sono animati e altri no il fatto che solo quelli animati crescono, si nutrono, deperiscono, si riproducono, ecc. Ed è a questo punto che diventa lecito chiedersi che cosa sia a conferire a tali corpi la vita: saranno vivi perché possiedono la materia? O perché hanno la forma? Aristotele risponde che essi sono vivi perché dotati di entrambe le cose, sia della forma, sia della materia, dove la materia è costituita dal corpo, la forma dall’anima. Quest’ultima, infatti, è quel qualcosa che fa sì che la materia si animi, abbia vita e sia un corpo vivente: ” di conseguenza ogni corpo naturalmente dotato di vita sarà sostanza e lo sarà precisamente nel senso di sostanza composta [di materia e forma] “. Ma, poiché si tratta di un corpo di una determinata specie, e precisamente di un corpo che ha la vita, allora ne conseguirà che l’anima non è il corpo, giacchè altrimenti anche le pietre – dotate di corpo – dovrebbero avere un’anima. Allora il corpo è un sostrato (υποκειμενον, “che giace sotto”), un soggetto (dal latino “sub-iactum”), ossia è la materia che “sta sotto”, che soggiace alla forma e, in quanto tale, è indeterminata. Il corpo, quindi, accoglie l’anima, cioè la forma: ” necessariamente dunque l’anima è sostanza, nel senso che è forma di un corpo naturale che ha la vita in potenza. Ora, tale sostanza è atto, e pertanto l’anima è atto del corpo che s’è detto “. L’anima, pertanto, è sostanza nel senso di “forma” di un corpo dotato potenzialmente (e non attualmente) della vita: ma di poter accogliere la forma “anima” non sono in grado tutti i corpi (ad esempio, non lo è una pietra), ma solo i corpi di un certo tipo, quelli cioè che hanno la potenzialità di ricevere la forma “anima” che porta all’attualizzazione della vita. In particolare, deve essere un corpo tale da possedere organi: ed è grazie all’anima che la vita, da in potenza, passa in atto, anche se questa distinzione potenza/atto è semplicemente concettuale, non cronologica Ma in che senso l’anima è atto? Nello stesso senso in cui noi facciamo grammatica in atto? Aristotele si rende conto che ciò non è possibile e che è assolutamente assurdo dire che, durante il sonno, l’uomo non ha l’anima, assurdo come dire che quando non si pratica la geometria non la si possiede. Al contrario, noi abbiamo l’anima sempre, anche se quando dormiamo essa non è attiva nelle sue funzioni, c’è ma non è in atto: ” atto poi si dice in due sensi: o come la conoscenza [= possesso della conoscenza] o anche come esercizio di essa; ed è chiaro che l’anima è atto nel senso in cui lo è la conoscenza […]. Perciò l’anima è l’atto primo di un corpo naturale che ha la vita in potenza. Ma tale corpo è quello che è dotato di organi “. E la parola oργανον presente nel testo (che è poi la stessa con la quale verranno denominati gli scritti aristotelici di logica) significa, letteralmente, “strumento”, sicchè un corpo è dotato di parti, ciascuna delle quali è “strumento” dotato di una sua funzione, una sua operazione psichica, cioè propria dell’anima. Ecco che comincia a farsi più chiara la connessione tra anima e corpo: e, in quest’ottica, Aristotele trae una prima importante conseguenza, enunciando che, in quanto dotate di vita, anche le piante hanno un’anima e ciò è provato dal fatto che esse abbiano organi (le radici, ad esempio), ossia “parti” che consentono loro di crescere, di assumere nutrimento e di riprodursi: ” organi sono anche le parti delle piante, ma incredibilmente semplici ” (412 b). Il nutrirsi, il crescere e il riprodursi sono funzioni semplicissime, che vengono svolte – seppur in modi diversi – anche da altri esseri animati, quali gli animali e l’uomo: oltre alle piante, infatti, anche agli uomini e agli animali compete, evidentemente, la funzione nutritiva dell’anima; solo che non è l’unica presente in essi – e qui sta la differenza rispetto alle piante. Infatti, nell’animale troviamo anche la funzione sensitiva, e nell’uomo – oltre a quella nutritiva e a quella sensitiva – quella razionale. In tale prospettiva, quindi, il problema dell’unità anima-corpo non si pone neanche, poiché la vita si ha sempre e solo come insieme delle due cose, che non possono mai stare tra loro separate, alla pari della cera e della figura. ” E’ quindi manifesto che l’anima (ed alcune sue parti, se per sua natura è divisibile in parti) non è separabile dal corpo, giacché l’attività di alcune sue parti è l’atto delle corrispondenti parti del corpo “: in altri termini, secondo Aristotele, gli occhi possono vedere, le orecchie udire solo se c’è l’anima, e così via; ciò significa che l’occhio, l’orecchio, ecc., non può vedere o sentire in potenza, e perché veda o senta in atto occorre che ci sia l’anima. ” Ciononostante nulla impedisce che almeno alcune parti siano separabili, in quanto non sono atto di nessun corpo “; la definizione di anima come corpo che può avere la vita in potenza è una definizione generale, valida universalmente per tutti i corpi viventi. E ora Aristotele scende nei particolari, domandandosi quale sia l’anima delle piante, quale quella degli animali e, infine, quale quella dell’uomo. Quindi, dopo la qualificazione generale della nozione di anima, è giunto il momento di indagare su che cosa caratterizzi le singole classi di viventi (piante, animali, uomo). Aristotele, tuttavia, si sofferma ancora (nel II e nel III paragrafo) sulla nozione di anima, precisando come una buona definizione non si limiti a mostrare che cosa sia una determinata cosa, bensì esibisca anche la causa, ovvero il perché quella cosa è tale: ” gli enunciati delle definizioni sono simili alle conclusioni ” (413). Per lo Stagirita, un buon ragionamento deve partire da premesse vere per approdare a conclusioni altrettanto vere: un ragionamento di questo tipo rende conto della causa. Se infatti dico che “tutti gli uomini sono mortali”, posso motivarlo adducendo come causa il fatto che “tutti gli uomini sono animali” e che “tutti gli animali sono mortali”. Quindi, come si evince facilmente dall’esempio che abbiamo appena fatto, una buona definizione corrisponde alla conclusione di un sillogismo, giacché è solo in tal modo che si può render conto delle cause. Fatte queste considerazioni, Aristotele riprende la ricerca da lui lasciata in sospeso, ritornando su punti già assodati e arricchendoli: riprendendo, in particolare, la distinzione tra essere animato ed essere inanimato (distinzione racchiusa nel fatto che l’uno vive, l’altro no), nota acutamente come l’espressione “vita” sia carica di svariati significati. Allora Aristotele spiega come sia lecito dire che un essere vive se ad esso appartiene anche una sola di queste caratteristiche: l’intelletto, la sensazione, il movimento e la quiete del luogo, e inoltre il mutamento nel senso della nutrizione e della crescita. Ne consegue, naturalmente, che ad essere viva non è solo l’entità pensante, ossia l’uomo: anche le piante vivono, poiché crescono in più direzioni, anzi ” in tutte le direzioni ” e ciò vale finché riescono ad assorbire nutrimento La funzione nutritiva pertanto costituisce già essa stessa una prima forma di anima e Aristotele nota come vi siano parecchi corpi che vivono in virtù di quest’unica funzione: ” questa facoltà può esistere indipendentemente dalle altre, mentre è impossibile negli esseri mortali, che le altre esistano indipendentemente da essa “. Affiora efficacemente come il vivente si strutturi come una lunga scala di esseri animati (la “scala naturae”), tant’è che vi sono animali che si trovano ai confini del regno vegetale: pensiamo a certi animaletti dotati di conchiglia, che non si muovono, abbarbicati agli scogli. Ma ciò che, in ogni caso, contraddistingue l’animale dalla pianta è la sensazione, garantita dal possesso di organi di percezione: non c’è animale che ne sia sprovvisto, perfino il più semplice che si possa immaginare; tutti, anche quelli più prossimi alle piante, hanno almeno un organo di percezione: il tatto. E in una pagina magnifica del “De partibus animalium”, Aristotele dice che non vi è nessuna cosa che sia indegna di essere conosciuta, perfino un verme. “L’anima è il principio delle facoltà che abbiamo detto” ed è da esse determinata (anima nutritiva perché si nutre, sensitiva perché ha sensazioni, intellettiva perché formula pensieri). A questo punto, il filosofo greco si domanda se l’anima sia suddivisa in parti e se esse – ammettendo che esistano – siano da essa separabili e, nel caso lo siano, se lo sono solo concettualmente o anche materialmente. E l’analisi che è un atteggiamento peculiare delle piante, in virtù del Aristotele conduce tiene conto delle distinzioni acquisite tra piante, animali e uomini: una prima cosa da constatare quale è possibile staccare da esse dei pezzi ed essi continueranno a vivere indipendentemente dalla pianta (pensiamo agli “innesti”). Perfino i vermi possono essere tagliati in parti e ciascuna di esse continuerà a vivere per conto suo. Ciò sembra avvalorare l’ipotesi della costituzione in parti dell’anima e della separabilità delle medesime: l’anima di questi vermi o di tali piante è, pertanto, una in atto, ma molteplice in potenza. Se l’anima ha sensazioni, poi, si può pensare che abbia la φαντασια, la capacità di conservare le immagini acquisite con i sensi. L’animale, nota Aristotele, si muove verso qualcosa, in primo luogo verso il cibo: anche nell’uomo troviamo una ορεξις, un’ “appetizione”, ma in tal caso è l’intelletto ad essere il motore. Dove ci sono il piacere e il dolore c’è anche il desiderio, inteso come ricerca di ciò che procura piacere e di ciò che scaccia il dolore: a un tale desiderio, dunque, si associa la ορεξις, che si esprime mediante il movimento. Preso atto dell’inseparabilità dell’anima dal corpo, pare che essere da esso disgiunto: l’intelletto, infatti, è eterno, c’è da sempre, alla pari della specie “cavallo”, “uomo”, “cane”, ecc. Ma sorge spontanea la solamente l’intelletto possa domanda: allora tale intelletto è unico o ce ne sono tanti, uno per ciascuno di noi? Essendo esso una forma e per di più unica, ne consegue che l’intelletto è unico per tutti gli uomini (tesi sulla quale insisteranno soprattutto – in età medioevale – gli interpreti arabi di Aristotele). Ne risulta che le singole parti che formano l’anima (nutritiva, sensitiva, razionale) sono separabili solo a livello concettuale (ossia per funzioni), ma non a livello concreto: e a conclusione del paragrafo II, lo Stagirita tenta di dare una definizione di anima che tenga in considerazione la causalità: l’anima è ciò in virtù di cui viviamo e percepiamo, dove la causa sta appunto nel “ciò in virtù di cui”. Tale espressione, però, è bivalente, poiché non spiega cosa sia ciò mediante cui conosciamo. Cos’è, dunque, quel qualcosa che ci fa conoscere? Conosciamo perché possediamo le conoscenze, ma anche perché abbiamo l’anima: così come siamo sani perché abbiamo la salute, ma anche grazie ad una determinata parte del corpo. In tale prospettiva, la conoscenza e la salute vanno intese come atto del soggetto ricettivo (υποκειμενον) che accoglie la conoscenza (funzione dell’anima razionale) e la salute (funzione del corpo). Dunque, la conoscenza e la salute sono le forme connesse all’anima e al corpo. Ciò mediante cui viviamo e percepiamo è l’anima, intesa come causa di determinate operazioni connesse ad un dato corpo. “Perciò è corretta l’opinione di quelli che sostengono che l’anima non è un corpo, ma non esista senza il corpo “: l’anima, senz’altro, non è un corpo; essa è, piuttosto, una proprietà, un “qualcosa” (τι) del corpo; naturalmente, non ogni corpo può accogliere una determinata funzione, come invece Aristotele a lui precedenti. Si deve trattare, viceversa, di un corpo adatto, dotato degli organi appropriati. Focalizzando l’indagine sull’uomo, ad esso competono tutte e tre le avveniva secondo i colleghi di funzioni dell’anima: egli, infatti, si nutre e cresce (funzione nutritiva), ha sensazioni (funzione sensitiva) e, in più, è dotato del pensiero (funzione intellettiva), che può essere quindi individuato come caratteristica tipicamente umana, che contraddistingue l’uomo da ogni altro ente (tant’è che la definizione più appropriata di uomo è quella di “animale razionale”). Grazie alla funzione sensitiva, l’uomo prova il piacere e il dolore e, di conseguenza, anche il desiderio (επιθυμια ), ossia 1′ ορεξις verso ciò che dà piacere. La volontà, invece, non è intendibile come επιθυμια, ma come ορεξις, in quanto è tendenza non solo verso il piacere, ma anche – talvolta – verso il dolore: ad esempio, posso volermi sottoporre ad un doloroso inrervento chirurgico. Nel paragrafo IV, Aristotele concentra la propria attenzione sulla facoltà nutritiva dell’anima, provando a darne una definizione e indagando su tutto ciò che è legato ad essa. Prima di poter dire che cosa sia tale facoltà, occorre descriverne l’attività connessa: infatti, solamente se so cos’è il nutrimento potrà capire che cos’è la funzione nutritiva, giacchè ” le attività e le funzioni dal punto di vista logico sono anteriori alle facoltà “. Ciò perché la nutrizione è in atto, la facoltà di nutrirsi è in potenza: non è un caso che, in greco, δυναμις designi tanto la “potenza” quanto la “facoltà”. Ma vi è un’altra priorità: rispetto all’attività stessa, ci devono già essere prioritariamente gli oggetti con cui la facoltà in questione ha a che fare; cosicchè è vero che il nutrirsi sta prima della facoltà di nutrirsi, ma ciò non toglie che il nutrirsi venga dopo al fatto che esistano oggetti di cui nutrirsi (il cibo). Similmente, perché io veda occorre che vi siano oggetti da vedere; perché io senta, oggetti da sentire. Detto questo, è bene puntualizzare come anche le piante si riproducono (oltre a nutrirsi), ossia generano esseri viventi a loro simili (” uomo genera uomo “, ama ripetere Aristotele). Da questa concezione, è facile capire come l’immortalità, negata ai singoli, sia invece garantita alle specie: e ciò grazie alla ri-produzione, ossia alla possibilità che ogni esemplare ha di produrre un altro sé (ri-produzione), rendendo possibile l’eternità della sua specie. La riproduzione, pertanto, è la funzione più naturale degli esseri viventi, i quali la attuano per realizzare un “fine” dal duplice valore: assicurare la continuità della specie e partecipare all’eterno. “Poiché questi esseri non possono partecipare con continuità dell’eterno e del divino, in quanto nessun essere corruttibile è in grado di sopravvivere identico e unico di numero “: tematica, questa, che riaffiora nel X libro dell’ “Etica nicomachea”; la natura sa che ciascuno vorrebbe protrarsi in eterno e allora concede, come unica possibilità affinchè ciò avvenga, la riproduzione: ” ciascuno ne partecipa per quanto gli è possibile, chi più e chi meno, e non sopravvive a se stesso, ma in un individuo simile “. Da queste considerazioni, si evince come, per Aristotele, perfino il fatto che un essere generi un essere a sé simile non è cosa ovvia, ma genera quella meraviglia che costituisce la causa scatenante dell’indagine filosofica. Analogamente, egli chiarisce in che senso si può dire che l’anima è causa e principio del corpo vivente: se vogliamo attribuirle tale funzione di causalità, allora dobbiamo capire che cosa effettivamente intendiamo per “causa” (αιτια ), con un procedimento affine a quello seguito nella definizione di “sostanza” e di “anima”. Essa non risponde al “che cosa?”, ma al “perché?”: ciò significa che non rende conto dell’ οτι (“che”), ma del διοτι (“perchè”). In particolare, la causa è quel qualcosa che permette di spiegare il perché di una cosa, ma, al contempo, è anche ciò che la fa essere in senso compiuto. Tre sono i significati attribuibili al termine “causa”: altrove, Aristotele ne attribuisce anche un quarto, corrispondente alla causa materiale, ma in questo contesto lo tralascia, giacchè non ha senso parlare di “materia” a proposito dell’anima. ” Causa e principio si dicono in molti sensi e in confronto a ciò l’anima si dice causa nei tre modi che abbiamo distinto “: come “principio del movimento” (όθεν κινησις), come “fine”, come essenza (ουσια) dei corpi animati. E Aristotele analizza caso per caso queste tre definizioni in riferimento all’anima: ” che l’anima sia causa come essenza è evidente: infatti, la sostanza è per tutte le cose la causa del loro essere [cioè del fatto che esistano e siano quel che sono] “; ma, nel caso specifico degli esseri viventi, il loro essere sta nel vivere e causa del vivere è appunto l’anima, non il corpo (poiché infatti di esso anche le pietre sono dotate). ” E’poi evidente che l’anima è causa anche come fine “: a tal proposito, Aristotele fa un parallelo tra il modo in cui agisce l’intelletto e quello in cui agisce la natura. Così come l’intelletto agisce in vista di qualcosa, ossia mi induce ad agire affinchè finalisticamente io raggiunga un obiettivo, similmente anche la natura ” non fa nulla invano “, non è frutto del caso (per quel che riguarda gli avvenimenti che si verificano sempre ο επι το πολυ, “per lo più”). Tutti i processi naturali, dunque, si verificano secondo una certa regolarità e in vista di determinati fini, come avviene per la generazione degli animali: così certi viventi hanno i polmoni per poter respirare e l’uomo non è l’animale superiore perché ha la mano (come credeva Anassagora), ma ha la mano perché è l’animale superiore, ossia per poter esplicare al meglio le sue funzioni che lo rendono superiore. ” Tutti i corpi naturali sono strumenti (οργανα) dell’anima “, strumenti nel senso che servono per realizzare quelle determinate funzioni psichiche; in quest’ottica, l’anima è il fine del corpo, ciò che fa sì che esso sia sfruttato in quel modo. Sicchè Aristotele potrà affermare, in altri scritti, che la mano è ” lo strumento degli strumenti “, poiché serve all’uomo da strumento per utilizzare gli altri strumenti. Sbaglia, dunque, Anassagora a ritenere che l’organo crei la funzione; al contrario, è la funzione che crea l’organo (per vedere abbiamo gli occhi, per udire le orecchie, e così via): e tutto ciò per compiere le funzioni psichiche (nutrirsi e riprodursi per le piante; nutrirsi, riprodursi e avere sensazioni per gli animali; nutrirsi, riprodursi, avere sensazioni e pensare per gli uomini). Infine, il terzo tipo di causa è quella da cui ha origine il movimento: “l’anima costituisce la prima origine del movimento locale “; si muove perché tende a qualcosa. Successivamente, Aristotele critica alcune concezioni di come avvengono i processi di nutrizione e crescita: in particolare, la prospettiva di Empedocle, ad avviso del quale sarebbe il movimento dei quattro elementi che compongono il mondo a far sì che si verifichi la nutrizione; ma anche la teoria di coloro che hanno visto in un solo elemento (il fuoco) il fattore che dà la nutrizione. Del resto, Aristotele stesso, in alcuni scritti, parla di πεψις, di cozione del cibo che avviene grazie ad un calore interno (quasi come se ci fosse il fuoco in noi) che riscalda il cibo che ingeriamo. La vera causa della nutrizione, a dispetto di tutte queste stravaganti fantasticherie, è l’anima (nutritiva), la quale permette al corpo di nutrirsi e di svilupparsi: ed è a questo punto che lo Stagirita si chiede se la nutrizione avvenga per assunzione di ingredienti a noi simili o contrari a quelli del nostro corpo. Già Anassagora si domandava come fosse possibile che, mangiando pane, noi cresciamo in carne ed ossa e rispondeva sostenendo che, in qualunque oggetto anche se in diverse proporzioni -, sono presenti infiniti “semi” di tutte le cose, cosicchè mangiando un pezzo di pane ingoio anche semi di carne, di ossa, ecc. Ora, Aristotele dice che, nel momento in cui si forma un organismo, esso ha bisogno anche del suo contrario, ma, una volta diventato adulto, assume solo più il simile a se stesso. Fatte queste considerazioni, l’attenzione del filosofo greco viene proiettata sulla funzione sensitiva dell’anima, funzione che presiede ai cinque organi di senso: in particolare, il paragrafo V è dedicato all’ αισθησις, e, in primo luogo, Aristotele chiarisce come la percezione sensibile consista in un κινείσθαι, in un “essere mosso”, in un πασχειν, un “subire” qualcosa: precisamente, subisco l’azione di un oggetto esterno che mi altera. Ne consegue che la sensazione sarà un qualcosa di passivo, ricettivo che accoglie ciò che proviene da fuori. ” Infatti la sensazione consiste nell’essere mossi e nel subire un’azione, giacchè sembra che sia una sorta di alterazione “: e Aristotele si serve di un’aporia per chiarire la passività della sensazione. Infatti egli si chiede: perché non ha luogo la percezione degli organi percettori? Perché quando vedo coi miei occhi gli oggetti del mondo non vedo i miei occhi stessi? Perché essi, se non ci sono oggetti esterni, non percepiscono nulla (pur essendo costituiti dagli stessi quattro elementi che compongono il resto del mondo)? La risposta è che la facoltà sensitiva propria di questo tipo di anima è una δυναμις, una “potenzialità”; infatti, abbiamo la facoltà percettiva ma non nel senso che percepiamo costantemente in atto, bensì nel senso che la esercitiamo in certi momenti ma, anche quando non la esercitiamo, ne restiamo pur sempre in possesso. E da che cosa dipende che in certi casi percepiamo e in certi altri no? Dal fatto che in quel momento è presente in atto l’oggetto corrispondente a quella determinata facoltà percettiva: ho di fronte a me una casa e, dunque, posso percepirla visivamente e a far passare la potenzialità del vedere in atto è l’oggetto esterno (cioè la casa), così come il combustibile non può bruciare senza il comburente. Tutto cambia, però, se parliamo dell’intelletto: grazie ad esso, pensiamo secondo il nostro volere, senza che le cose pensate siano concretamente di fronte a noi. La percezione si trova quindi in una duplice condizione (in potenza e in atto) e lo stesso vale per un oggetto sensibile: qualsiasi oggetto può (potenzialmente) essere visto e se, effettivamente, viene visto, allora è visibile in atto. ” Il movimento è una specie di atto, benché imperfetto “: qui Aristotele fa riferimento alla nozione di movimento, il quale è passaggio dalla potenza all’atto, e diventa compiuto solo alla fine. Ora, ogni essere che subisce un’azione ed è mosso, lo è ad opera di un oggetto in atto. Ma come mai, allora, vedo un oggetto giallo? Esso è diverso rispetto alla mia pupilla: a tal proposito, c’è un passo in cui Aristotele sembra suggerire che la mia stessa pupilla diventa gialla, cioè simile all’oggetto visibile, come se ci fosse qualcosa che assimila le proprietà dell’oggetto visto e la funzione. Aristotele fa ancora una volta presente come il concetto di potenza sia complesso, poichè articolato in più livelli non facilmente distinguibili: così l’uomo in quanto uomo, fin dalla nascita, è potenzialmente dotato del sapere, anche se non ha ancora acquisito nessuna nozione. Ma anche l’uomo dotato di sapere, non potrà applicarlo incessantemente: nel momento in cui non lo applica, ne è dotato potenzialmente; quando poi lo applicherà concretamente, allora il suo sapere passerà dalla potenza all’atto. ” Riguardo alla potenza e all’atto è necessario operare una distinzione, poichè ora ne abbiamo discusso in maniera sommaria. Un essere è conoscente o al modo che diremmo conoscente l’uomo, perchè è uno degli esseri che conoscono e che detengono il sapere; oppure al modo che diciamo ormai conoscente colui che possiede la conoscenza della grammatica. Costoro non si trovano in potenza alla stessa maniera, ma il primo perchè il suo genere e la sua materia sono di un certo tipo, il secondo perchè, qualora lo desideri, può esercitare la sua conoscenza, purchè qualche cosa di esterno non glielo impedisca. ” [417 a]. E Aristotele dice che colui che acquisisce il sapere che, in quanto uomo, possedeva potenzialmente fin dalla nascita, ” subisce un’alterazione mediante l’apprendimento “: anche quest’espressione come il termine “potenza” – presenta un duplice significato. Infatti, posso subire un’azione o in modo tale che essa mi danneggi o, viceversa, che mi rafforzi: sicchè il ” το πασχειν ” (“il subire”) può designare una particolare forma di distruzione che io subisco per l’azione di un qualcosa a me contrario o può designare un rafforzamento del mio stato. In quest’ottica, colui che conosce passa da conoscente in potenza a conoscente in atto, ma non per alterazione distruttiva, bensì rafforzativa: ” pertanto non è corretto affermare che chi pensa, quando pensa, come pure l’architetto, quando costruisce, subiscono un’alterazione “. Sottolineando come l’apprendimento non sia tanto dato dall’azione di un oggetto esterno, quanto piuttosto da un passaggio, tutto interno al soggetto, da ignoranza a conoscenza, Aristotele è mosso da suggestioni platoniche (pensiamo a quando nel “Menone” si diceva che conoscere è ricordare). Dunque, se c’è un solo significato della parola “alterazione” (intesa come distruzione), allora nella conoscenza, propriamente, non può esserci alterazione: se invece diamo a tale termine anche il significato di “rafforzamento”, di cambiamento in meglio, allora si potrà dire che anche il processo conoscitivo è una forma di alterazione, di passaggio dall’ignoranza alla conoscenza. E il primo mutamento a cui è soggetto un ente dotato di anima sensitiva è l’essere prodotto dal genitore: una volta generato, l’individuo possiede già la sensazione allo stesso modo in cui possiede – potenzialmente – la scienza. Tuttavia, vi è una differenza imprescindibile tra la sensazione e la conoscenza: nella prima, a produrre l’atto sensitivo sono gli oggetti esterni (vedo perchè ci sono oggetti esterni che producono in me il passaggio da vedente in potenza a vedente in atto); sarà invece la φαντασια a lavorare pur senza la presenza di oggetti esterni. La scienza, invece, non ha di fronte a sè oggetti esterni: cosicchè, se la sensazione ha a che fare con oggetti singolari (le entità individuali) – e la stessa ossatura dell’universo è costituita da entità singole -, la scienza
ha per oggetto gli universali, i quali si trovano nell’anima stessa e non esternamente (come invece credeva Platone, che attribuiva esistenza autonoma alle Idee). Il soggetto – nota Aristotele – può pensare qualsiasi oggetto quando lo vuole, ma ciò non toglie che non pensa l’oggetto in carne e ossa, bensì l’immagine di quell’oggetto. E’ infatti il sensibile in atto che fa sì che l’immagine in potenza passi anch’essa in atto e, in questa prospettiva, è di fondamentale importanza capire che cosa siano gli oggetti sensibili e in quanti modi possa essere percepita una cosa. La prima grande distinzione operata dallo Stagirita è tra oggetto sensibile “per sè” (καθ’ αυτό ) e oggetto sensibile per accidente (κατα συμβεβηκος ). Propri (ιδια) sono poi quei sensibili che competono a ciascun senso, giacchè ciascuno dei cinque sensi ha come oggetto qualcosa di specifico, che può essere solo da esso percepito. Così solo l’udito può percepire i suoni, solo il gusto i sapori, solo l’olfatto gli odori: e la vista? Quali sono i suoi “sensibili propri”? Aristotele risponde che essa ha per oggetto i colori. Egli introduce poi, sul piano gnoseologico, un’importante novità, asserendo che il senso – se funzionante – non sbaglia mai. Infatti, l’udito non potrà mai sbagliare nell’attestare che sta percependo un suono, e lo stesso vale per gli altri sensi: ciascuno di essi giudica (κρινει ) il suo oggetto proprio e non si inganna nel dire che sente un suono, vede un colore, fiuta un odore, ecc. Tuttavia, l’errore nasce quando, ad esempio, ci si domanda “che cos’è che ha quel colore?” o “dov’è quella cosa che ha quel colore?”. Ma, se ogni senso percepisce solo i suoi sensibili propri, come si spiega il fatto che percepiamo gli oggetti nel loro complesso? Aristotele risolve questa apparente contraddizione introducendo, accanto ai sensibili propri, i sensibili comuni (κοινα ), i quali non sono legati ad un solo senso. Di sensibili comuni Aristotele ne individua parecchi: il movimento, la quiete, il numero, la figura, la grandezza. Aristotele, però, non dà indicazione sugli errori: è tuttavia verosimile pensare ch’egli ritenga che già coi sensibili comuni siano possibili errori (posso ingannarmi nel percepire un movimento). Gli errori si verificano soprattutto nei sensibili per accidente: se, infatti, vedo una macchia bianca e dico “è il figlio di Diare”, la vista percepisce il colore bianco, ma che quel bianco sia il figlio di Diare lo percepisce per accidente. Infatti, se effettivamente è il figlio di Diare, allora si tratta di una percezione corretta; se, invece, non è il figlio di Diare, allora si tratta di una percezione sbagliata. In altri termini, la vista non sbaglia nel vedere la macchia bianca, ma sbaglia nell’associarla alla persona, visto che al bianco capita per accidente di essere il figlio di Diare. “Perciò non subiamo alcuna azione dell’ente sensibile in quanto tale “: ma l’ente sensibile cui allude Aristotele è il colore o il figlio di Diare? E’ verosimile che sia il figlio di Diare. Sensibili per accidente sono quegli oggetti che possono essere percepiti casualmente, ossia può succedere che vengano percepiti: e Aristotele si sofferma diffusamente su ciascuno dei cinque sensi e sui loro sensibili propri. Il sensibile proprio della vista è – come abbiamo detto – il colore che si trova sulla superficie dell’oggetto visto, ma, accanto al colore, Aristotele pone anche il fosforescente (cioè la luminosità che si percepisce al buio); tra l’oggetto percepito e l’organo percipiente si trova un medium, un qualcosa di intermedio che Aristotele chiama “il trasparente” (τι διαφανες ), che è connesso alla luce: quest’ultima, infatti, è l’attualizzazione del trasparente stesso. Ed è grazie al medium che vediamo la luce: perché si possa vedere, infatti, ci vuole la luce e, oltre ad essa, il medium trasparente che sta tra il colore e l’occhio: nel caso della vista tale medium è dato dall’aria (ma anche dall’acqua). In altri termini, il medium è mosso dall’oggetto e a sua volta muove il soggetto percipiente. Ne consegue che il colore dell’oggetto esercita un’azione non tanto sull’occhio, quanto piuttosto sul medium, modificando il trasparente illuminato: e questa modificazione produce a sua volta un’azione sull’occhio. Aristotele fa riferimento al medium anche per poter spiegare la visione di oggetti a distanza e per differenziarsi dall’atomismo (per il quale la percezione era data da pellicole atomiche che si allontanavano dagli oggetti per raggiungere i nostri sensi). Naturalmente, il discorso del medium interposto tra gli oggetti e i sensi vale non solo per la vista, ma per tutti i sensi: ogni senso ha il suo medium privilegiato, così ad esempio per la vista è l’aria, per l’udito anche, e così via. Aristotele mostra qualche riserva per l’olfatto, perché è vero che sembra che esso abbia il suo medium nell’aria, però è anche vero che – attraverso i suoi studi zoologici – Aristotele ha scoperto che diversi animali acquatici hanno l’odorato. Dopo essersi soffermato sulla vista (che di tutti i sensi è quello che gli pare più importante, come egli stesso confessa nella “Metafisica”), lo Stagirita passa all’udito, avente per sensibile proprio i suoni. Esso è la percussione di un corpo solido su un altro corpo solido e il medium è dato dall’aria (ma anche dall’acqua). L’orecchio stesso contiene aria congenita in movimento e la voce è prodotta da tutti quegli animali in grado di respirare. L’olfatto, dal canto suo, ha per sensibile proprio l’odore. Più complicato è invece il gusto, che ha per oggetto il sapore: infatti sembra essere un qualcosa ai confini con il tatto, poiché per avvenire ha bisogno del contatto con l’oggetto; ma Aristotele dimostrerà e lo vedremo poco più avanti – come tatto e gusto siano due sensi diversi. Di tutti e cinque, il tatto è, a suo avviso, il senso più problematico, poiché sembra che il suo sensibile proprio non sia uno solo: gli altri quattro sensi, infatti, hanno solo un sensibile proprio; eppure se ci pensiamo è vero che, ad esempio, la vista ha per oggetto esclusivamente il colore, tuttavia, di fatto, ne vede una quantità illimitata, così come l’udito ode un’infinità di suoni diversissimi (acuti, gravi, forti, deboli…). Il tatto però sembra riferirsi sì ad una molteplicità di oggetti tangibili, ma anche opposti tra loro: possiamo infatti sentire per contatto il freddo e il caldo, il secco e l’umido, il duro e il molle; indicare quale tra questi sia il sensibile proprio del tatto non è facile (è la temperatura? Il grado di durezza? O piuttosto quello di umidità?). Un altro problema sorge nel momento in cui si vuole definire quale sia il suo medium: pare che non esista; infatti, il tatto avviene per contatto diretto e immediato (senza medium appunto) tra l’oggetto e il soggetto. E Aristotele, in merito, propone alcune risposte acute: supponendo di avere la mano coperta da un guanto, posso ugualmente toccare e avere percezioni; ciò significa che, anche col tatto, deve esserci un medium che svolga le funzioni del guanto. Aristotele individua tale medium nella carne, cosicchè l’organo del tatto (l’analogo degli occhi, delle orecchie, del naso, della lingua) è interno, giacchè non può identificarsi con il medium (ossia con la carne). Eppure pare che Aristotele finisca in un vicolo cieco: infatti, anche la lingua – che è un organo a tutti gli effetti – è fatta di carne e, per di più, percepisce sia i sapori (dolce, amaro, ecc) sia le cose tattili (freddo, caldo, umido, secco, ecc); tuttavia, i sapori vengono direttamente percepiti dalla carne che costituisce la lingua, mentre quando sente il caldo, il freddo, ecc, la carne funge solo da medium. Questo permette ad Aristotele di spiegare la differenza tra il gusto e il tatto (nel primo la carne della lingua è organo, nel secondo è medium). Nel tatto, poi, succede una cosa particolarissima: percepiamo il medium insieme all’oggetto, così come il giavellotto colpisce lo scudo e questo, a sua volta, colpisce immediatamente chi lo sorregge. I sensibili propri del tatto – dice Aristotele – sono le quattro qualità, e la percezione si verifica (ossia passa in atto) in relazione alle qualità che abbiamo in noi: così, ad esempio, per percepire qualcosa di caldo dobbiamo noi stessi essere meno caldi dell’oggetto percepito, altrimenti se fossimo ugualmente caldi non riusciremmo a percepirlo. Questo processo, però, non deve spingersi oltre un certo limite: il caldo o il freddo non devono essere eccessivamente intensi, altrimenti l’organo sensoriale ne verrebbe danneggiato; lo stesso vale per i sensibili propri di ciascun senso. In chiusura del secondo libro, Aristotele dà una celebre definizione della sensazione: ” da un punto di vista generale, riguardo ad ogni sensazione, si deve ritenere che il senso è ciò che è atto ad assumere le forme sensibili senza la materia, come la cera riceve l’impronta dell’anello senza il ferro o l’oro: riceve bensì l’impronta dell’oro o del bronzo, ma non in quanto è oro o bronzo. Analogamente il senso, rispetto a ciascun sensibile, subisce l’azione di ciò che ha colore o sapore o suono, ma non in quanto si tratti di ciascuno di questi oggetti, bensì in quanto l’oggetto possiede una determinata qualità e secondo la forma ” [424 a 15]. Il senso, dell’oggetto da cui riceve la sensazione, riceve la forma, non la materia (altrimenti ogni percezione sarebbe un inghiottire l’oggetto dentro di sé); e il paragone di Aristotele è calzante: riprendendo l’antica metafora – tematizzata da Platone nel Teeteto – con cui l’anima veniva accostata ad una tavoletta di cera e le impressioni alle forme che si imprimono sulla cera stessa, lo Stagirita dice che come la cera riceve l’impronta (σημειον) dell’anello, ma non il materiale di cui è costituito, così i sensi ricevono la forma degli oggetti; anche se, altrove, Aristotele dice enigmaticamente che quando vediamo il giallo forse è la stessa pupilla a colorarsi di giallo. Fatte queste considerazioni, si può sostenere che “l’organo e la capacità di percepire sono la stessa cosa “, anche se ” la loro essenza è diversa ” (poiché l’organo è una grandezza, ossia ha dimensioni, mentre la capacità percettiva è una facoltà). Ciò aiuta anche a capire perché le piante non abbiano sensazioni: certo, in fondo anch’esse subiscono azioni per contatto (con l’aria, con gli oggetti, ecc), ma non percepiscono, poiché la loro passività non riguarda la forma, ma la materia; subiscono cioè l’azione della materia dell’oggetto, ma non sono in grado (e qui sta la differenza rispetto agli animali e all’uomo) di riceverne la forma. Le piante – nota Aristotele – non hanno una medietà (μεσοτητα), nella quale avere percezioni: l’uomo e gli animali invece, ne sono dotati e tale medietà consente in quel particolare stadio che sta nell’eccesso in più (che distrugge gli organi sensoriali) e nell’eccesso in meno. Le piante, poi, non hanno nemmeno un principio capace di ricevere le forme sensibili. Il terzo libro è incentrato sulla funzione intellettiva dell’anima, prerogativa dei soli uomini. Prima di entrare in medias res, tuttavia, Aristotele si occupa della fantasia e, ancor prima, di due importantissimi problemi: i sensi deputati alla percezione sono solo cinque o ne esistono altri? Come si spiega, poi, che io, soggetto percipiente, possa avere la percezione di percepire, ad esempio percepire che sto vedendo? Occorre ipotizzare l’esistenza di un altro senso che percepisca che sto vedendo? O, piuttosto, è il senso stesso che si auto-percepisce? Aristotele è molto preciso nel fornire le risposte a questi interrogativi: non esistono altri sensi all’infuori dei cinque; e se ci manca un senso, allora, necessariamente, mancherà anche l’organo percipiente corrispondente. Se poi esistesse un ipotetico sesto senso, allora dovrebbe anche esistere un suo organo suo specifico, mediante il quale esercitare la sua attività. In un certo senso, si potrebbe far leva sui sensibili comuni per ammettere un ulteriore senso: chi mi vieta di pensare che il movimento, la quiete, ecc, siano percepiti da un sesto senso? Ma Aristotele nega ciò: con tutti e cinque i sensi – e non con un sesto senso – percepiamo il movimento, la grandezza, la figura, e la quiete (intesa come assenza di movimento) e il numero come negazione del continuo (grandezze continue sono quelle geometriche, poiché hanno oggetti infinitamente divisibili, come le rette; grandezze discontinue sono i numeri, poiché tra 1 e 2 non c’è nulla, secondo Aristotele; e ½ è solo un rapporto, non un numero). E’ assolutamente impossibile che esista un sensibile speciale per i sensibili comuni: se ci fosse, percepiremmo i sensibili comuni in modo analogo a quello in cui percepiamo il dolce con la vista. Infatti, posso dire di percepire il dolce con la vista, quando ad esempio vedo una torta esposta in vetrina: ciò accade perché ho già percepito con il gusto, in altre occasioni, che fosse dolce. ” Questo ci è possibile perché ci troviamo ad avere la percezione di entrambi questi sensibili, mediante la quale li riconosciamo nello stesso tempo in cui si presentano insieme. Se non fosse così, non percepiremmo i sensibili comuni in nessun’altra maniera che accidentalmente “. La percezione dei sensibili comuni, pertanto, è comune attraverso più sensi e non avviene accidentalmente, e non richiede un senso speciale: è l’interazione dei vari sensi che mi permette di percepire i sensibili comuni. Così della bile percepiamo che è gialla e amara: con gli occhi percepiamo che è gialla, con il gusto che è amara; ma ciò non toglie che l’oggetto (la bile) sia uno solo. Non esiste, dunque, un ulteriore senso capace di percepire insieme che la bile è gialla e amara. Ed è per questo motivo che nasce l’errore: vedo che una cosa è gialla e dico “è bile” senza averla gustata: l’errore nasce quindi nell’istituire connessioni, poiché esse non sempre sono corrette. Nel primo paragrafo del III libro, Aristotele ha dunque affrontato (e confutato) l’eventualità di un sesto senso: resta però il problema della coordinazione dei sensi e, a ciò collegato, il problema della percezione della percezione (cui è dedicato il secondo paragrafo). Occorre ammettere l’esistenza di un ulteriore senso che percepisca di percepire o, piuttosto, è il senso stesso a percepire e a percepire di percepire? In altri termini, quando vedo un oggetto percepisco anche che lo sto vedendo: che siano gli occhi a percepire l’oggetto, è evidente; ma che cos’è che percepisce il fatto che sto percependo con gli occhi? Anche qui Aristotele nega radicalmente l’eventualità di un sesto senso e fa riferimento ad una specie di “senso comune” ravvisato nel cuore (e non nel cervello) per poter spiegare la percezione della percezione. Nasce subito una difficoltà: se vedere significa – come Aristotele ha mostrato nel II libro – percepire colori, come si può ammettere che la vista percepisca – oltre ai colori – la sua azione di vedente? Esisterà un senso in grado di percepire sia la vista sia i colori? Ma allora, in questo caso, avremmo due sensi con lo stesso oggetto: sia la vista sia questo ipotetico altro senso vedrebbero, infatti, i colori e, in più, quest’ultimo percepirebbe anche la percezione di vedere. Se cosi fosse, tuttavia, avremmo una clamorosa smentita del principio che sta alla base della fisica aristotelica, cioè che la natura non fa nulla invano: sarebbe infatti una cosa assolutamente inutile produrre due sensi aventi per oggetto la medesima cosa. Sembra forse più percorribile la strada dell’ammissione che un senso possa avere per oggetto se stesso, la percezione della propria attività. Del resto, un altro forte argomento contro l’esistenza di un ulteriore senso è dato dalla regressione all’infinito: se ammetto che oltre alla vista esista un altro senso che percepisca la vista stessa, mi troverò costretto ad ammettere ancora un altro senso che percepisca di percepire la vista; e così all’infinito. Questa argomentazione (impiegata da Aristotele anche per argomentare in favore del “motore immobile”) sconfessa definitivamente la possibilità di ulteriori sensi rispetto ai cinque: sorge però una nuova aporia. Se la vista, infatti, è dotata della capacità di auto-percezione, e il suo oggetto proprio è il colore, allora questa capacità di auto-percezione dovrà necessariamente essere dotata anch’essa di colore. ” Se infatti percepire con la vista è vedere, e si vede il colore o l’oggetto che lo possiede, qualora si veda ciò che vede, ciò che vede per primo sarà colorato ” [425 b 14]. Per superare questa difficoltà, Aristotele introduce due argomentazioni: la prima fa leva sul fatto che ” percepire con la vista non ha un unico significato, giacchè anche quando non stiamo vedendo con la vista distinguiamo il buio e la luce, ma non allo stesso modo “. Anche al buio, infatti, ci rendiamo perfettamente conto che stiamo vedendo, distinguiamo cioè il buio dalla luce, abbiamo coscienza della vista anche quando non c’è la luce, anche se in quel dato momento non vediamo in atto. Aristotele usa il verbo κρινομεν, “distinguiamo”, ma anche “giudichiamo” il buio e la luce, poiché conoscere significa cogliere le differenze. La seconda argomentazione viene così formulata: ” inoltre anche ciò che vede è in certo modo colorato, poiché ciascun organo sensorio è capace di assumere il sensibile senza la materia. “. Aristotele, però, non spiega in che modo ” ciò che vede è colorato “: altrove, pare sostenere che, quando ad esempio l’occhio vede un oggetto giallo, sia la pupilla stessa a divenire gialla, ossia ad assumere la colorazione dell’oggetto percepito. Tuttavia ciò pare in contrasto con quanto detto prima, che cioè l’organo riceve solo la forma dell’oggetto: forse, tuttavia, Aristotele intende il colore dell’oggetto solo come forma. A questo punto, Aristotele fa notare come le forme sensibili delle cose percepite persistano in noi, anche quando la materia non c’è più: dopo aver osservato una casa gialla, io conservo dentro di me 1′ “immagine” (φαντασμα) – cioè la forma sensibile – della casa stessa, cosicchè posso pensarla anche quando non ho più la casa di fronte a me; ” ed è per questo motivo che, anche quando i sensibili non sono presenti, le sensazioni e le immagini permangono nei sensori “. L’oggetto visto e la vista passano in atto simultaneamente, pur non essendo essi la stessa cosa: in potenza restano distinti (il suono è infatti altra cosa dall’udito), ma, passando in atto, fanno un tutt’uno; ciò spiega l’unitarietà dell’atto percettivo, il quale deve tuttavia essere inteso come composto da due ingredienti: l’organo e l’oggetto esterno. Resta da chiarire dove abbia luogo quest’attualizzazione: Aristotele dice che essa avviene in colui che percepisce, non nell’oggetto; ciò pare piuttosto credibile, poiché in effetti all’oggetto visibile non accade nulla nell’essere visto, resta tale e quale; ad essere veramente interessato è solamente il soggetto percipiente, che ingloba la forma dell’oggetto percepito. In modo del tutto analogo, il movimento si produce non in ciò che lo causa, ma in ciò che lo subisce, e nella percezione ” il suono in atto e l’udito in atto devono trovarsi in ciò che li possiede in potenza “. C’è dunque simmetria tra ciò che muove e ciò che è mosso, per cui ciò che muove non deve necessariamente avere movimento (così il “motore immobile” mette in moto l’universo senza essere esso stesso in moto). Poiché il passare in atto del sensibile e il passare in atto della facoltà di percepire sono il medesimo atto, ” è necessario che simultaneamente si conservino e cessino “: con ciò, Aristotele attacca i “fisiologi”, ovvero i primi indagatori della natura, rinfacciando loro di aver ingenuamente creduto che bianco e nero non esistessero senza la vista che li percepisce (la stoccata è diretta soprattutto contro Democrito); tali qualità, invece, esistono anche negli oggetti percepibili, anche se solo potenzialmente. Passano in atto quando vengono effettivamente percepiti dai soggetti dotati di anima sensitiva, ma posseggono già in potenza le loro qualità (bianco, nero, ecc); anche perché – se fosse come crede Democrito – saremmo noi gli agenti che producono il colore, mentre in realtà, per Aristotele, nel percepire siamo piuttosto passivi. Egli ha già accennato a come, per percepire la differenza tra due sensibili propri di sensi diversi, non occorra un ulteriore senso, ma basti la coordinazione tra i sensi interessati: così, per cogliere la differenza tra dolce e bianco, non si deve ricorrere ad un ulteriore senso in grado di percepire sia il dolce sia il bianco, ma occorre far riferimento al coordinamento tra la vista e il gusto. ” Ciascun senso si riferisce ad un oggetto sensibile, trovandosi nell’organo sensorio in quanto tale, e discrimina le differenze del proprio oggetto sensibile: ad esempio, la vista distingue il bianco e il nero, il gusto il dolce e l’amaro, e la stessa cosa si verifica per gli altri sensi. Ma poiché noi distinguiamo sia il bianco sia il dolce e ciascuno dei sensibili in rapporto a ciascun altro, con che cosa percepiamo che essi differiscono ” [426 b 9]. Ciascun senso, pertanto, percepisce i suoi sensibili propri, ma con che cosa percepiamo che il bianco è differente dal dolce? Per distinguerli (giacchè si tratta di sensibili) occorre una percezione: in particolare, Aristotele esclude che sia la carne ad essere responsabile (poiché sennò la distinzione tra bianco e dolce dovrebbe avvenire per contatto; ma noi possiamo vedere il bianco anche da lontano). ” Ora non è possibile giudicare per mezzo di sensi separati che il dolce è diverso dal bianco, ma entrambi gli oggetti devono manifestarsi a qualcosa di unico. […] E’ dunque evidente che non è possibile giudicare sensibili separati mediante sensi separati “. Appare evidente come sia arduo stabilire chi percepisca la differenza tra sensibili; il gusto percepisce il dolce, la vista il bianco: e la differenza tra i due? Così come se io percepisco il dolce e tu il bianco, non possiamo dire se siano diversi, poichè ci vuole qualcosa che lo attesti, similmente, se il gusto percepisce il dolce, la vista il bianco, né la vista né il gusto può dire che il dolce sia differente dal bianco. Bisogna dunque ammettere un coordinamento tra i sensi stessi, in virtù del quale le informazioni provenienti da uno si connettano a quelle provenienti da un altro. Il discorso coinvolge anche la sfera temporale: nella proposizione “io dico ora che il bianco è diverso dal dolce”, il termine “ora” qualifica il momento in cui io predico la diversità tra bianco e dolce; tale proposizione non è però uguale a “io dico che ora il bianco è diverso dal dolce”, poiché il termine “ora” in questa proposizione svolge una diversa funzione, caratterizza che bianco e dolce sono diversi in un dato momento. Per Aristotele, le due cose coincidono: la simultaneità è sia nella diversità tra bianco e dolce, sia nel momento in cui la predico; ne consegue che non è accidentale. Dico simultaneamente che x è dolce e y è bianco e lo sono ora: ” di conseguenza tale cosa è inseparabile ed opera in un tempo inseparabile”. Successivamente, Aristotele precisa che questa cosa unica discriminatrice delle differenze è un qualcosa di unitario ma che si distingue nelle sue funzioni discriminatrici. Sempre nel III libro del “De anima”, Aristotele si sofferma con particolare attenzione sulla φαντασια, distinguendola nettamente dalle funzioni percettive (anche se ad esse strettamente connessa, in quanto i φαντασματα, ossia le “immagini”, si formano in qualche modo in ambito sensibile). Si tratta di una delle prime riflessioni articolate della storia sull’immaginazione, di quel ponte che collega il sensibile al pensiero. Lo Stagirita inizia la sua indagine su tale facoltà con un parallelo tra il pensare (κινησιςνοειν, φρονειν) e il percepire: il punto di partenza è, ancora una volta, dato dalle opinioni comuni, secondo le quali il pensare e l’intelligenza sono come una percezione sensibile, sicchè pensare è come avere percezioni. Aristotele conduce quest’indagine in quanto mosso dalla convinzione che sia nel pensiero sia nella percezione l’anima distingua e conosca le cose: la percezione e l’intelligenza, infatti, κρινουσι, ossia “giudicano” e “discriminano”. Tale analogia tra pensare e percepire sembra trovar conferma anche nelle teorie formulate dai predecessori di Aristotele, in particolare Omero e, soprattutto, Empedocle: a loro avviso, pensare e percepire sono la stessa cosa, poiché il pensiero stesso è indisgiungibilmente legato al corpo, quasi come se fosse un’attività corporea alla pari del percepire. Ma ciò di cui essi han taciuto, senza dare spiegazione, è come avvenga l’errore: secondo la teoria empedoclea del simile che conosce il simile, sembra che l’errore sia impossibile; eppure l’esperienza comune attesta che esso si verifica assai spesso. Le paradossali conseguenze che derivavano dalla tesi di Empedocle erano sintetizzabili nell’ammissione dell’infallibilità dei sensi: questa tesi è attribuita da Platone (nel “Teeteto”) al sofista Protagora, per il quale il miele è dolce per colui al quale appare tale, ed è amaro per colui a cui invece appare amaro. L’unica alternativa possibile stava nell’ammettere l’errore come contatto del simile col dissimile, ma ciò comportava una marea di nuovi problemi (in primo luogo la nozione stessa di “dissimile”). Da tutto ciò risulta chiaro che ” intelligenza e sensazione non sono la stessa cosa “: questo punto viene da Aristotele inferito a partire dal fatto che gli animali hanno la sensazione (ed è ciò che li distingue dalle piante) ma non per questo l’intelligenza. Lo stesso discorso vale per il pensiero (nel cui ambito rientrano la scienza, l’opinione vera e la saggezza): a questo punto, Aristotele introduce un altro argomento a sostegno della propria tesi. Giacché la percezione dei “sensibili propri” è sempre vera, mentre il pensiero è suscettibile di essere vero o falso, ne consegue che pensiero e percezione non possono essere identificati; al contrario, il pensiero sarà presente esclusivamente in quegli animali dotati di ragione (λογος). Dalle argomentazioni aristoteliche emerge come il pensiero e la sensazione siano tra loro apparentati dalla comune funzione conoscitiva, ma, ciononostante, restano due cose radicalmente distinte. A cavallo tra le due realtà sta – secondo lo Stagirita – l’immaginazione (φαντασια), cioè la sfera in cui appaiono immagini (φαντασματα): fin dall’inizio, Aristotele precisa che l’immaginazione va distinta tanto dalla sensazione quanto dal pensiero, e in questo modo egli complica notevolmente la mappa psichica rispetto ai suoi predecessori. Il primo aspetto su cui concentra la sua attenzione il filosofo greco è come l’immaginazione, pur non identificandosi con la sensazione, sia ad essa connessa: ” l’immaginazione è infatti diversa sia dalla sensazione sia dal pensiero, però non esiste senza sensazione, e senza di essa non c’è apprensione intellettiva “. Gli oggetti propri dell’immaginazione si costituiscono a partire da percezioni sensibili: è infatti solo dopo aver empiricamente percepito Socrate che posso crearmi, dentro di me, una sua immagine. E del resto ogni operazione mentale, ogni apprensione intellettiva (Aristotele usa il termine υποληψις, letteralmente “assumere come vero qualcosa da altro”) può aver luogo solo a partire dall’immagine: se ne evince che non può esserci immagine senza percezione e che non può esserci pensiero senza immagine. Infatti, i concetti universali (l’uomo, il cavallo, la giustizia, ecc) non possono essere conosciuti se non a partire da immagini, poiché mi è impossibile crearmi il concetto universale di uomo o di cavallo se non ho raccolto dentro di me una nutrita serie di immagini di uomo o di cavallo. Ma tali immagini sono rese possibili grazie all’esperienza, giacchè si formano a partire dalla percezione sensibile dei singoli uomini o cavalli. Ben si capisce la funzione di ponte tra la sensazione e il pensiero rivestita dalla φαντασια: memore della lezione aristotelica sarà Kant stesso, quando – nella “Critica della ragion pura” – parlerà di “schematismo trascendentale” come zona di confine tra il sensibile e il pensiero. Il richiamare dentro di noi una determinata immagine è un atto libero, nota Aristotele; siamo cioè noi a scegliere liberamente di rievocare l’immagine che desideriamo (ad esempio, ho visto Socrate: ora non lo vedo più, ma posso decidere di ridestare la sua immagine dentro di me): ” quest’affezione dipende infatti da noi, quando lo vogliamo ” [427 b 18]. Avere un’opinione, invece, ” non dipende da noi “: essa è come abbiamo detto – una υποληψιςe ha la proprietà di essere vera o falsa in base alla sua confrontabilità coi fatti, cosicchè è strettamente connessa con la realtà esterna; l’immagine, dal canto suo, non ha bisogno di confronti con la realtà esterna, è un qualcosa di a me interno e, pertanto, posso rievocarla quando voglio. Per dimostrare che l’opinione e la fantasia sono due cose diverse, Aristotele oltre ad argomentare che la fantasia è libera, l’opinione no mette in luce la strettissima connessione tra emozione ed opinione, facendo notare come la connessione tra emozione ed immaginazione sia assai meno stretta: se vedo coi miei occhi (ambito dell’opinione) una scena orribile nella realtà, essa suscita in me un’emozione di terrore che invece non necessariamente suscita se la vedo rappresentata in un dipinto o a teatro (ambito dell’immaginazione). Ne consegue, dunque, che l’opinione si accompagna sempre all’emozione corrispondente; l’immaginazione no: ” quando siamo dell’opinione che una cosa è paurosa o temibile, proviamo immediatamente l’emozione corrispondente, e così pure quando riteniamo che una cosa è rassicurante, mentre nel caso dell’immaginazione ci troviamo in una situazione analoga a quella di vedere cose temibili o rassicuranti in un dipinto ” [427 b 21]. Aristotele distingue l’immaginazione anche da altre operazioni, quali la sensazione, la scienza e l’intelletto. In particolare, per mettere in evidenza come essa si distingua dalla sensazione, si avvale di ben cinque argomentazioni: 1] ” la sensazione o è potenza o atto, come la vista e la visione, mentre qualcosa può apparire benchè né l’una né l’altra sia in questione, come avviene per le immagini dei sogni ” [428 a 6]. Mi può apparire qualcosa anche se in quel momento non esercito la vista né ho la possibilità di vedere, proprio come avviene nei sogni: mi appaiono immagini né in potenza né in atto. 2] ” La sensazione è sempre presente, mentre l’immaginazione no “: perché ci sia la percezione, l’oggetto deve essere presente ai sensi (vedo la casa perché è presente agli occhi; sento i rumori perché sono presenti alle orecchie); però posso avere immagini anche di oggetti lontanissimi dai nostri sensi (posso avere l’immagine di Sparta pur essendo io ad Atene). Del resto, ” se fossero la stessa cosa in atto, l’immaginazione dovrebbe trovarsi in tutti i bruti ed invece sembra di no “: con queste parole, Aristotele intende dire che, se sensazione e immaginazione coincidessero, allora laddove c’è la sensazione dovrebbe necessariamente anche esserci l’immaginazione. Eppure esistono esseri dotati dell’una, ma non dell’altra: Aristotele adduce l’esempio del verme, fornito di sensazione ma non di immaginazione; come esempio di esseri dotati di entrambe le cose, cita invece l’ape e la formica, ma potrebbe anche citare il cane, che riconosce il padrone poiché porta dentro di sé la sua immagine. 3] Le percezioni sono sempre vere, mentre la maggior parte delle immagini sono false (pensiamo soprattutto a quelle dei sogni). 4] Aristotele mette in luce come l’espressione “apparire” (φαινεσθαι) sia fuorviante, perché ambigua. Quando vedo arrivare Socrate e affermo “mi appare un uomo”, sto commettendo un errore linguistico, poiché dovrei in realtà affermare “vedo Socrate”, giacchè ne ho percezione, non immagine. Tutt’al più è accettabile l’espressione “mi appare un uomo” quando lo vedo da distante ma non sono certo che effettivamente sia un uomo – il che testimonia, tra l’altro, come le immagini non per forza siano vere. ” Non è quando esercitiamo con precisione la nostra attività su un oggetto percepibile che diciamo che quest’oggetto ci ‘appare’ essere un uomo, ma piuttosto quando non lo percepiamo chiaramente “. 5]” Appaiono immagini visive anche a chi tiene gli occhi chiusi “: se tengo gli occhi chiusi, non ho percezione visiva di nulla, ma posso tuttavia avere immagini. Dopo aver operato – nei cinque punti appena illustrati – la distinzione tra sensazione e immaginazione, Aristotele si propone di distinguere l’immaginazione dall’intelletto e dalla scienza, caratterizzati anch’essi – come le percezioni – dal non sbagliare mai; essi, tuttavia, sono superiori alle percezioni e sono ” abiti che sono sempre nel vero “; nell’ “Etica Nicomachea”, dirà che abiti sono le virtù, ossia quelle abitudini che si consolidano con l’essere compiute. Una volta che ho acquisito la scienza, sono sempre nel vero: se dimostrassi che essa sbaglia, non sarebbe più scienza. Rispetto alla scienza e all’intelletto, che sono sempre nel vero, l’immaginazione è come abbiam visto – suscettibile di essere vera o falsa: ne consegue, naturalmente, che scienza e intelletto non sono identificabili con l’immaginazione. Detto questo, Aristotele torna nuovamente sull’opinione, il punto che più di ogni altro lo tormenta: ciò è in parte dovuto al fatto che Platone aveva fatto indebitamente rientrare l’opinione nell’immaginazione, senza rendersi conto dell’insuperabile differenza che le distanzia. Lo Stagirita sottolinea come l’opinione sia sempre accompagnata dalla convinzione (πιστις, il “credere che”), poiché quando dico “egli è buono” lo dico perché sono convinto che effettivamente egli sia buono. In molti animali, però, è presente l’immaginazione, ma non la convinzione e, di conseguenza, nemmeno l’opinione: è il caso delle api e delle formiche, ad esempio. Del resto, affinchè ci sia la convinzione, è necessario che ci sia anche la ragione, della quale sono dotati solamente gli uomini. Ciò avvalora la tesi aristotelica secondo cui l’opinione non è l’immaginazione: se infatti le due cose coincidessero, tutti gli esseri dotati di immaginazione dovrebbero anche avere l’opinione, ma ciò non è possibile. ” Resta allora da vedere se è opinione, poiché l’opinione si presenta come vera o come falsa. Ora all’opinione consegue la convinzione (non è infatti possibile avere un’opinione su ciò di cui sembra che non si sia convinti), e mentre nessun bruto ha la convinzione, in molti c’è l’immaginazione “. L’opinione, nota Aristotele, è o parallela alla sensazione, o prodotta da una sensazione, o intreccio (συμπλοκη) di opinione e sensazione. Se così non fosse, l’immaginazione e l’opinione si troverebbero ad avere i medesimi oggetti, e l’immaginazione sarebbe l’intreccio dell’opinione del bianco e della sensazione del bianco. Come esempio, pensiamo al sole: esso mi appare piccolissimo, eppure so che è enorme; la percezione è diversa, dunque, dall’opinione, pur riguardando lo stesso oggetto (nel nostro caso: il sole). Ne consegue che l’immaginazione non è l’intreccio di opinione e sensazione, poiché esse attestano cose diverse: ” ne segue allora o che si è abbandonata l’opinione vera che si aveva, benchè l’oggetto sia rimasto lo stesso e non ci si sia dimenticati di quell’opinione né si sia rimasti persuasi del contrario, oppure, se la si conserva ancora, necessariamente la stessa opinione sarà vera e falsa. Ma l’opinione potrebbe diventare falsa soltanto qualora l’oggetto mutasse a nostra insaputa. Pertanto l’immaginazione non è una di queste attività né risulta da esse ” [428 b 5]. Infatti, l’opinione o è vera o è falsa: non è data una terza possibilità. Sgombrato il terreno dalla possibilità di confondere l’immaginazione con la sensazione o con l’opinione, Aristotele ritiene possibile definire meglio l’immaginazione stessa: essa è ” una specie di movimento”, una κινησις prodotta dalla percezione sensibile: ” se allora nessun’altra cosa possiede le caratteristiche suddette eccetto l’immaginazione (ed essa è ciò che s’è detto), l’immaginazione sarà un movimento risultante dalla sensazione in atto” [429 a 1]. Percependo un oggetto, esso agisce su di noi e produce un movimento che si trasmette nel sangue e giunge fino al cuore. Il fatto che l’immaginazione sia un movimento spiega anche perché le immagini spesso siano sfocate: in particolare, le immagini oniriche sono da Aristotele accostate all’effetto delle pietre lanciate nello stagno. Ad attivare il movimento che dà luogo all’immaginazione è la percezione sensibile, la quale permette il formarsi di immagini che persistono anche quando la percezione non sussiste più (pur rimandando le immagini continuamente all’oggetto percepito): la centralità della percezione implica, naturalmente, che l’immaginazione sia prerogativa esclusivamente di quegli enti dotati di anima sensitiva (gli animali e l’uomo). La fantasia è anche un importante strumento per subire e compiere azioni: la stessa appetizione può essere guidata o dall’intelletto (che mi dà indicazioni su come orientarmi per raggiungere un determinato obiettivo) o dalla φαντασια stessa, sennò non si spiegherebbe perché anche gli animali abbiano appetizioni (il cane che si muove alla ricerca del cibo, ad esempio). In che senso, però, un’immagine può essere vera o falsa? Vedendo un oggetto, subito nella mente si forma un’immagine del medesimo, immagine che sarà vera fin tanto che sto vedendo l’oggetto; quando la sensazione cessa, l’immagine può sfocarsi e sbiadirsi, diventando in tal modo falsa (ossia non rispecchiante l’oggetto percepito). Nelle sensazioni per accidente – dove cioè la percezione stessa può essere falsa, poiché l’oggetto sensibile è troppo distante dai sensi, nel caso in cui la percezione sia falsa, allora l’immagine stessa che si forma sarà inevitabilmente falsa. Aristotele si sofferma anche – seppur di sfuggita – sull’etimologia del termine fantasia, mettendo in mostra come si colleghi a φαινω (“appaio”), che a sua volta è strettamente connesso a φαος (“luce”), privilegiando ancora una volta la sfera legata alla vista. A questo punto lo Stagirita, dopo aver trattato la facoltà nutritiva e quella sensitiva, passa alla facoltà intellettiva dell’anima, facoltà di cui solo l’uomo è provvisto: in linea preliminare, tale funzione è quella con cui l’anima conosce e pensa. Fatta questa prima precisazione, Aristotele analizza come si generi (γινεται) il pensiero e in tal senso la sua prima mossa consiste – come abbiamo già detto – nel considerare il pensiero come il percepire sensibile. Come la percezione ha luogo in quanto i vari sensi subiscono l’azione degli oggetti sensibili, così il pensiero ha luogo subendo l’azione degli oggetti intelligibili, ossia di quegli oggetti non coglibili dai sensi. Ma che cosa significa che l’intelletto, pensando, subisce un’azione? Come la vista in potenza passa in atto nel momento in cui c’è l’oggetto visibile, così il pensiero in potenza passa in atto quando c’è l’oggetto intelligibile; in altri termini, il pensiero – non essendo strettamente connesso al corpo (lo è solo attraverso mediazioni) – subisce azioni da parte degli intelligibili, che, per loro natura, non sono corporei. Sotto questo profilo, l’intelletto è δεικτικον του είδος, “ricettivo della forma”, dove la “forma” in questione non è più quella sensibile, ma quella intelligibile (ossia, per fare un esempio, la nozione universale di uomo). Ciò implica che, per Aristotele, la conoscenza non sia produttiva, ma ricettiva: l’intelletto non produce concetti di suo (come sarà invece per l’idealismo), bensì si limita ad accogliere le forme provenienti dal mondo esterno, e non già presenti dentro di noi (come invece credeva Platone, soprattutto nel “Menone”). L’analogia che Aristotele fa tra pensiero e sensibile richiama alla memoria quella fatta da Platone, nella “Repubblica”, tra Bene e idee: Platone diceva che, come nel nostro mondo la luce del sole ci permette di vedere le cose, così l’idea del Bene ci permette di “vedere” le altre idee; ora Aristotele afferma che il pensiero accoglie le forme così come i sensi ricevono le percezioni. Resta da chiarire in che senso l’immaginazione sia un ponte che congiunge il sensibile al pensiero: l’immagine è, secondo Aristotele, sempre meno vivida rispetto all’oggetto sensibile da essa rispecchiato; essa tende a sfocarsi, a perdere definizione ed è probabile che secondo Aristotele sia così che nascono i concetti universali: le immagini che porto dentro di me di diversi uomini (Socrate, Gorgia, Democrito, ecc) tendono a sfocarsi e a farsi sbiadite, con il risultato che si possono solo più cogliere i tratti comuni alle varie immagini. La funzione di cerniera tra sensibile e pensiero assolta dall’immaginazione potrebbe anche essere un’altra: quando mi trovo in una biblioteca, coi miei occhi vedo solo una determinata porzione della biblioteca stessa, eppure riesco ad avere una nozione di biblioteca come insieme unitario; ciò avviene grazie all’immaginazione. A questo punto, per meglio chiarire come possa originarsi il pensiero, Aristotele riprende la nota tesi di Anassagora, secondo la quale esisterebbe un Intelletto cosmico (Νους) dotato di un potere assoluto conferitogli dal non essere mescolato con le altre cose (altrimenti sarebbe impedito nel suo agire libero, αυτοκρατωρ). Aristotele interpreta la tesi anassagorea in termini conoscitivi: la condizione affinchè l’intelletto possa conoscere è di non essere mescolato al resto, ossia tutte le cose devono essere da esso distinte. Tra l’altro Aristotele opera una forte connessione tra conoscere e potere (” perché domini, ossia perché conosca “, 429 a 18), in virtù della quale chi conosce una cosa è in grado di padroneggiarla, mentre chi la ignora ne è padroneggiato. Sembra dunque chiaro che il vous, quella funzione con cui l’anima intellettiva pensa e conosce, non è alcuno degli enti intelligibili prima di pensarli: è solo pensandoli che fa tutt’uno con essi (diventa cioè conoscenza in atto dell’universale). Aristotele conclude che, se le cose stanno così, non è ragionevole ritenere che l’intelletto sia mescolato con il corpo, poiché altrimenti si troverebbe a subire le proprietà corporee (diverrebbe cioè caldo, freddo, ecc) e disporrebbe a sua volta di un organo percettivo per percepire le qualità. Sotto questo profilo, lo Stagirita si sente più vicino ai Platonici piuttosto che ai Presocratici, i quali avevano identificato l’intelletto con la percezione: i Platonici, dal canto loro, ” sostengono che l’anima è il luogo delle forme, solo che tale non è l’intera anima, ma quella intellettiva, ed essa non è in atto, ma in potenza le forme” [429 a 27]. Per Aristotele è vero quanto han sostenuto i Platonici, ossia che le idee han sede nell’anima, ma è bene chiarire meglio in che senso, poiché non è corretto in tal caso parlare di “anima” in generale; l’affermazione platonica va ristretta solo all’anima intellettiva, in cui le idee risiedono potenzialmente (non sono cioè già tutte presenti, per cui si tratta di risvegliarle, come invece credeva Platone). Fatta questa precisazione, Aristotele affronta il problema dell’απαθηια della funzione sensitiva e intellettiva: tale απαθητα (letteralmente “assenza di passioni”) non va ugualmente intesa per le due funzioni, e per meglio chiarire questo punto, il filosofo adduce un esempio. Quando percepiamo coi sensi un qualcosa di eccessivamente forte, la nostra facoltà percettiva viene quasi a cessare: ” il senso non è in grado di percepire dopo l’azione di un sensibile troppo intenso ” [429 b]. Così, dopo aver udito un rumore troppo forte, le nostre orecchie non sentono più per un po’ di tempo; dopo aver visto una luce troppo intensa, i nostri occhi cessano di vedere per qualche minuto. Però per le operazioni intellettive avviene l’opposto: se conosco nozioni intensissime, ciò non mi impedisce di conoscerne altre meno intense; anzi, le conoscerò ancora meglio, perché la mia facoltà intellettiva si è acuita: “l’intelletto, quando ha pensato qualcosa di molto intelligibile, non è meno, ma anzi più capace di pensare gli intelligibili inferiori, giacchè la facoltà sensitiva non è indipendente dal corpo, mentre l’intelletto è separato ” [429 b 3]. Il procedere opposto di intelletto e percezione testimonia, secondo Aristotele, che l’intelletto è una funzione separata dal corpo, la percezione no. A questo punto, il filosofo greco introduce il problema della possibilità dell’intelletto di conoscere se stesso: poiché esso conosce tutti gli intelligibili in atto, allora può pensare se stesso. Cosa significa? Probabilmente – non è sicuro – che è in grado di conoscere se stesso come conoscente le nozioni universali intelligibili. Su questo punto, comunque, Aristotele tornerà ancora all’interno della trattazione dell’anima. Egli ritiene opportuno specificare le caratteristiche di questi oggetti intelligibili, per meglio differenziarli da quelli sensibili: conduce un’analisi soprattutto in riferimento a due classi, quella degli oggetti fisici e quella degli oggetti matematici. Come esempio di oggetto fisico, prende la carne: essa è percepibile mediante i sensi, e, rispetto alla sua materialità, possiamo distinguere la sua essenza; si dovrà dire che l’essenza della carne è, a sua volta, un pezzo di carne? No, è evidente. E’, al contrario, una nozione universale che esula dalla materia, ed è la forma che fa sì che essa sia, effettivamente, carne e non qualcos’altro. Questa distinzione aristotelica avrà gran successo: ancora Heidegger, nel Novecento, dirà in apertura del suo scritto sulla tecnica che un conto è la tecnica, un conto è l’essenza della tecnica. Come esempio di oggetti matematici, possiamo considerare invece i numeri: anch’essi hanno – come la carne una materia, ma si tratta di una “materia intelligibile”. Prendendo come riferimento una linea, si può infatti notare come essa abbia una sua forma (la linearità), ma anche una sua materia (l’essere caratterizzata dal continuo, che le permette di essere infinitamente divisibile). Ritornando all’esempio della carne, è con la percezione sensibile che conosciamo i pezzi di carne, mentre con la conoscenza intellettuale ne conosciamo l’essenza, ossia veniamo a conoscere che cosa sia la carne in generale. ” Poiché sono diverse la grandezza e l’essenza della grandezza, come l’acqua e l’essenza dell’acqua (e ciò vale per molti altri casi, benchè non per tutti, giacchè in alcuni essi s’identificano), il soggetto giudica l’essenza della carne e la carne o con qualcosa di diverso o con qualcosa che si trova in una diversa condizione. Infatti la carne non esiste senza la materia, ma, come il camuso, è una determinata forma in una determinata materia” [429 b 11]. Chi “distingue” (κρινει) carne ed essenza di carne distingue tra materia ed essenza: con la facoltà percettiva giudica il caldo e il freddo, e tutte le qualità delle quali la carne è rapporto proporzionale, mentre con un’altra facoltà (cioè con l’intelletto) discrimina l’essenza della carne, priva della possibilità di essere calda, fredda, ecc. Passiamo all’esempio degli oggetti matematici: a riguardo, Aristotele parla di ” enti ottenuti per astrazione ” [429 b 19], dove la parola “astrazione” in greco è αφαιρεσις, che letteralmente significa “sottrazione”. Come si origina questa astrazione/sottrazione? A partire dagli enti fisici: quando del tavolo materiale che mi sta dinanzi considero solo alcuni aspetti (ad esempio la superficie), prescindendo da altri. Sottraendo dal tavolo gli aspetti materiali, i colori, la temperatura, ecc, ottengo il concetto di rettangolo. Ciò comporta che il rettangolo, di per sé, non esiste (come invece credeva Platone); bensì esistono oggetti fisici rettangolari; lo stesso discorso vale per i numeri: non esiste il “tre” in sé, bensì esistono gruppi di tre tavoli, di tre sedie, ecc. In questo modo, sarà dunque possibile distinguere tra retta del tavolo sensibile ed essenza del rettangolo: la prima è conosciuta coi sensi, la seconda con l’intelletto. ” Inoltre, nel caso degli enti ottenuti per astrazione, la retta è analoga al camuso (perché è unita al continuo), mentre la sua essenza, se l’essenza della retta è diversa dalla retta, è qualcosa di differente, e potrebbe essere la diade” [429 b 21]: in che senso potrebbe essere la diade, ossia due punti? Secondo Aristotele, posso distinguere una retta da una superficie in base ai punti: collegando due punti ottengo una retta; collegandone tre, ottengo invece una superficie. Il che fa supporre che secondo lo Stagirita l’aritmetica sia prioritaria rispetto alla geometria, poiché – secondo l’insegnamento pitagorico – all’uno corrisponde un punto, al due due punti (e quindi una retta), al tre tre punti (e quindi una superficie), al quattro quattro punti (e quindi un solido). Se ne trae la conclusione che la carne e la retta non esistono separati dalla materia cui ineriscono, in quanto separati da essa diventano intelligibili e, dunque, conoscibili solo dall’intelletto. Il paragrafo si chiude con due aporie, che Aristotele prova a superare: la prima deriva dall’ammissione che l’intelletto non subisca azioni, la seconda dall’ammissione della possibilità dell’intelletto di conoscere se stesso. ” Qualora l’intelletto sia semplice e impassibile, e non abbia nulla in comune con alcunchè, come afferma Anassagora, in che modo penserà, se il pensare è una sorta di subire?” [429 b 24]: se l’intelletto non è mescolato alla realtà, allora come fa a pensare, se il pensare è subire l’azione degli oggetti intelligibili? Non vuol forse significare che tra intelletto e intelligibili non v’è nulla in comune? La seconda aporia viene così formulata dallo Stagirita: ” l’intelletto è esso stesso intelligibile? “. La difficoltà a sua volta, si articola in due corni: o vengo a dire che l’intelletto è intelligibile di per se stesso, indipendentemente dagli oggetti con cui ha a che fare; in questo caso, ci sarà solo un tipo di intelligibile e allora – conseguenza assurda – ogni intelligibile sarà a sua volta intelletto. Oppure l’intelletto conosce se stesso come conosce le altre cose, ossia mediante un’affezione corporea: ma in questo caso, esso sarà mescolato con il corporeo, il che è in contraddizione con la tesi di partenza. La soluzione proposta da Aristotele a queste problematiche poggia ancora una volta sulla distinzione tra potenza e atto: l’intelletto è gli oggetti intelligibili, ma solo in potenza, mentre in atto è un intelligibile solo se pensa quel determinato intelligibile; per farsi meglio capire, Aristotele ricorre al paragone – desunto dal “Teeteto” platonico – con la tavoletta di cera: la tavoletta di cera è, potenzialmente, tutti gli oggetti che le saranno impressi; allo stesso modo, l’intelletto può potenzialmente ricevere tutti gli intelligibili, ma finchè essi non vengono effettivamente ricevuti, non li possiede (a differenza della concezione platonica, per cui son già tutti presenti e si tratta solo di risvegliarli). Ne consegue che l’elemento comune tra intelletto e intelligibili – elemento che consente un rapporto fra le due realtà – è la loro potenzialità: infatti, l’intelletto può conoscere gli intelligibili, e questi possono essere conosciuti dall’intelletto; ciò comporta che l’intelletto può solo subire un’azione, cioè il passare da in potenza a in atto, e ciò avviene grazie all’intervento degli intelligibili. Risolta in questo modo la prima aporia, Aristotele passa alla risoluzione della seconda: l’intelletto è esso stesso conoscibile intellettualmente allo stesso modo in cui sono conoscibili tutti gli oggetti intelligibili. Infatti, colui che pensa e l’oggetto pensato vengono inevitabilmente a coincidere in atto, facendo un tutt’uno. Sicchè si può affermare che la conoscenza dell’universale X coincide con l’universale X stesso (solo mentalmente possono essere distinte le due cose). Negli oggetti dotati di materia, invece, gli intelligibili (la nozione universale di tavolo, di sedia, di uomo, ecc) sono presenti solo potenzialmente, sono conoscibili solamente grazie ad un’operazione intellettuale che prescinda dalla materia astraendo. Di conseguenza, si evita l’assurdità poc’anzi proposta, quella cioè della coincidenza dell’intelletto con gli intelligibili, per cui ogni intelligibile sarebbe esso stesso l’intelletto, ossia quella facoltà che fa conoscere gli intelligibili senza far riferimento alla materia. Come abbiamo accennato, l’intelletto può conoscere se stesso come dotato di facoltà di conoscere gli intelligibili: ma i problemi non sono finiti. Infatti, dopo aver prospettato e risolto le due aporie, Aristotele tratta, nel paragrafo successivo, un problema intorno al quale prolifereranno innumerevoli scritti nel corso della storia (da Alessandro di Afrodisia a Simplicio, da Filopone ad Averroè a Pomponazzi). Infatti, sembra che Aristotele, distinto l’intelletto in atto da quello in potenza, introduca la nozione di intelletto ποιητικος , “produttivo”. Questa dottrina viene esposta in maniera criptica e sintetica, ma, ciononostante, si evince come esso non sia una prerogativa dei singoli individui, ma un qualcosa di unico per tutta la specie umana (per tutti gli uomini passati, presenti e futuri). C’è anche stato chi ha letto nell’intelletto attivo la divinità stessa. Entrambe le interpretazioni concordano sul fatto che Aristotele riconosca in quest’intelletto produttivo (e non in quello di cui son dotati i singoli) la prerogativa dell’immortalità: ciò si ricondurrebbe, in qualche modo, all’impianto generale della filosofia aristotelica, secondo la quale a poter partecipare dell’eternità sono non i singoli, ma le specie; l’intelletto passivo di cui ciascuno di noi è dotato sarebbe dunque destinato a perire; mentre quello produttivo, comune a tutta la specie, dovrebbe perdurare in eterno. Aristotele, nell’analizzare l’intelletto, fa notare come tutto ciò che appartiene alla natura abbia determinate caratteristiche, tra le quali rientra l’avere una materia propria; essa è, potenzialmente, un mare magnum di cose (il marmo, infatti, è potenzialmente tutte le cose che col marmo possono essere create). Ma, accanto a questa causa materiale, c’è quella che lo Stagirita chiama causa “produttiva” (ποιητικον), ο “efficiente”, come la chiama nella “Fisica”. Essa, rispetto alla materia, produce tutte le cose che sono in potenza nella materia, cosicchè la statua di marmo è causa produttiva che fa sì che dal marmo derivino tutti gli oggetti possibili che possono essere fatti col marmo. Sotto questo profilo, la natura e l’attività tecnica procedono in maniera analoga, cioè attraverso la materia e la generazione di effetti: ma questo stesso discorso vale anche per l’anima, dove sarà possibile trovare una causa produttiva. Applichiamo ciò all’intelletto: al concetto di materia corrisponde quello di potenza, sicchè la materia dell’intelletto – cioè l’analogo del marmo – sarà l’intelletto potenziale, analogo alla materia nel senso che è potenzialmente tutte le cose (cioè tutte le nozioni intelligibili). Il grosso problema che si deve affrontare è che, accanto alla materia, deve esserci una causa produttrice, un intelletto che ad essa corrisponda. Quale è? Aristotele è, in questo caso, più criptico del previsto e, per chiarire la differenza tra intelletto produttivo e intelletto potenziale, asserisce – memore della metafora impiegata da Platone nella Repubblica che l’intelletto produttivo è una luce, poiché anche ” la luce rende i colori che sono in potenza in atto ” [430 a 17]. La luce è ciò che fa sì che i colori – potenzialmente visibili – siano effettivamente visti in atto; e cos’è che svolge mansioni analoghe alla luce nella sfera intelligibile? Per Platone era la verità; da Aristotele giacchè non esistono idee come esseri universali a sé stanti – questa funzione della luce è attribuita all’intelletto produttivo, una sorta di luce che permette alle nozioni intelligibili di essere conosciute in atto. Ma qui cominciano a nascere le prime difficoltà; prima fra tutte: che cos’è questo intelletto produttivo? Chi ce l’ha? E’ – risponde lo Stagirita – un intelletto separabile, o, meglio, separato (χωριστος) dal corpo, è impassibile (cioè non subisce azioni), non è mescolato, essendo “atto per essenza”. Il suo modo di essere specifico è di essere in atto, ossia non in potenza.
LA FISICA
Le dottrine fisiche elaborate da Aristotele occupano una posizione assolutamente centrale nella cultura che va dal mondo greco fino alle soglie dell’età moderna, quando s’è verificata quella “rivoluzione scientifica” che ha avuto in Copernico e in Galilei i suoi eroi: Platone aveva rigettato la possibilità di una scienza della natura, in quanto convinto che questa fosse soggetta a quell’incessante fluire tematizzato da Cratilo, e aveva sostenuto che del mondo naturale potesse esservi non già επιστημη, bensì δοξα; lo stesso Timeo, che pure era un dialogo interamente dedicato alla φυσις, si configurava come un racconto immaginifico privo di ogni qualsivoglia carattere veritativo. E’ stato Aristotele ad assumersi il compito di fondare la fisica come scienza, ancorchè la fisica da lui fondata sia lontanissima da quella moderna, che tutto matematizza: si tratta, al contrario, di una fisica qualitativa (anche qui in contrasto con Platone), che non di rado tende a trapassare in metafisica. Ed è nel VI libro della Metafisica che lo Stagirita, proponendo la sua classificazione delle scienze, non solo presenta la fisica come scienza a pieno titolo, ma addirittura la inserisce nel novero delle “scienze teoretiche” (insieme alla matematica e alla προτη φιλοσοφια, ossia la metafisica), le quali, avendo per fine il sapere stesso, sono disinteressate e, in ciò, risiede la loro superiorità: dal canto loro, invece, le “scienze pratiche” (etica e politica) hanno per fine un’azione, mentre le “scienze poietiche” mirano alla produzione di ποιουμενα, ossia di oggetti. Proprio in Metafisica VI, 1025 b 25 scrive Aristotele: “Pertanto, se ogni conoscenza razionale è o pratica o poietica o teoretica, la fisica dovrà essere conoscenza teoretica, ma conoscenza teoretica di quel genere di essere che ha potenza di muoversi e della sostanza intesa secondo la forma, ma prevalentemente considerata come non separabile dalla materia. […] Se tutti gli oggetti della fisica si intendono in modo simile al camuso, come per esempio naso, occhio, viso, carne, orecchio, animale in generale, foglia, radice, corteccia, pianta in generale (infatti non è possibile dare definizione di alcuna di queste cose senza il movimento, ma esse hanno sempre materia), allora è chiaro come si debba ricercare e definire l’essenza in sede di ricerca fisica, ed è altresì chiaro perché sia compito del fisico speculare anche su una parte dell’anima che non esiste senza la materia. Da tutto ciò risulta allora evidente che la fisica è una scienza teoretica”.
Per Platone, proprio perché rivolta alle cose transeunti e passeggere di questo mondo, la fisica non può assurgere al grado di scienza: ciò non vale per Aristotele, ad avviso del quale è possibile studiare le cose nel loro divenire. Ciò non toglie, però, che la fisica – a differenza della metafisica, che studia l’essere in quanto tale – sia una scienza particolare, giacché si occupa solo dell’essere in movimento e, perciò, difetta di universalità: oltre ad occuparsi dei corpi terreni, caratterizzati dall’essere passeggeri e non eterni, Aristotele fa rientrare nel campo d’indagine della fisica anche lo studio dei corpi celesti. Con quest’operazione, egli pone l’astronomia come scienza fisica e non come scienza matematica (quale era per Platone), poiché gli astri sono anch’essi corpi in movimento, benché a differenza dei corpi terrestri non siano soggetti al divenire, ma esistenti sempre e necessariamente (in quanto composti non già dei quattro elementi, bensì dell’etere). Ne segue che gli orizzonti della fisica finiscono per spaziare dalla terra al cielo, dai corpi viventi degli animali all’anima. Il confine tra il mondo terrestre – popolato dai corpi in divenire e quello celeste – popolato dai corpi eterni – è segnato dalla luna, che divide appunto il mondo sublunare da quello sopralunare. Le scienze teoretiche riguardano cose esistenti necessariamente, ma all’interno della fisica è ritagliato uno spazio anche per i corpi passeggeri e non eterni: le pietre, gli uomini e gli animali possono infatti non esistere e, in ogni caso, sono perituri; essi tuttavia rispondono ad una modalità dell’essere che è επι το πολυ (per lo più), per cui gli uomini, invecchiando, diventano per lo più canuti. Nell’ambito del mondo fisico terrestre, allora, pur non valendo la necessità assoluta, ciò non di meno vale la necessità condizionale, tale per cui, se si verifica una tale condizione, si verifica un tale effetto (ad esempio: se invecchio, mi vengono i capelli bianchi). Sicchè i corpi del mondo fisico di questa terra presenta caratteristiche fluttuanti (il colore degli occhi, dei capelli, l’altezza, ecc), con l’inevitabile conseguenza che, a differenza della matematica, la conoscenza fisica non potrà mai essere esatta né potrà fare ricorso a dimostrazioni analitico/deduttive (Platone riduce invece nel Timeo gli elementi fisici a enti geometrici matematicamente studiabili). La fisica difetta dunque di universalità, di esattezza e di necessità: come ogni altra conoscenza, anche quella fisica procede per cause e quali siano tali cause Aristotele lo spiega nel II libro cap.3 della Fisica, per poi riprenderlo nel I della Metafisica: le quattro cause che egli individua non sono che le risposte da fornire quando ci si interroga sulla natura di qualche cosa e tale dottrina è evidentemente dedotta dall’osservazione diretta dei corpi: osservandoli, si nota infatti che essi rispondono a quattro diversi punti di vista, ovvero risultano dalla convergenza di quattro cause. Infatti, le cose hanno una materia, sono prodotte da qualcuno, sono tali perché hanno una forma che le individua e hanno uno scopo per il quale sono venute ad essere: qui in sintonia con Platone, Aristotele crede che la struttura eretta sia stata data all’uomo affinché egli possa contemplare le realtà superne; ma Aristotele non dimentica che le cose hanno anche una materia che le condiziona: così l’uomo può stare in piedi perché possiede calore e il calore tende appunto verso l’alto. La materia e la forma non sono secondo Aristotele – separabili l’una dall’altra, col che egli si distingue nettamente dalla posizione platonica, per cui le forme (ειδη) sarebbero radicalmente distinte dalla materia (υλη); inoltre l’assetto fisico di ogni cosa è tale perché deve rispondere ad un dato fine e la forma è quella che è perché è stata organizzata in vista di tale fine. Solo chi conosce tutte e quattro le cause delle cose può essere insignito del titolo di φυσικος (fisico), giacchè egli solo è in grado di indicare di che cosa le cose sono fatte, a quale fine tendono, quale forma hanno, che cosa le ha messe in moto. Il punto nodale nella trattazione fisica condotta dallo Stagirita riguarda la teleologia: la natura tende a un fine, o, piuttosto, in essa tutto avviene secondo le bizzarre regole del caso? A questa domanda, Platone aveva risposto giocando la carta del finalismo provvidenzialistico, ipotizzando l’esistenza di un “Divino artefice” (il Demiurgo del Timeo) tale da contemplare le idee eterne e calarle nella materia nel miglior modo possibile: il mondo che ne derivava era il migliore tra i mondi possibili, interamente retto da fili divini, una sorta di opera d’arte infallibile in cui tutto era retto da fili divini. La soluzione di Aristotele è assai diversa: il provvidenzialismo platonico è messo al bando per due ragioni. In primis, perché la natura non è affatto divina e Aristotele ne paragona l’attività a quella tecnica; a differenza della tecnica divina (che è infallibile), la tecnica umana è soggetta a fallire: similmente, in natura non tutto avviene in maniera perfetta. Come il grammatico può commettere errori o come il medico può prescrivere farmaci inadeguati, così la natura può parimenti compiere errori, benché il suo agire sia sempre e comunque orientato al meglio: tale principio viene da Aristotele dedotto a partire dalla biologia, dove si registrano casi di veri e propri mostri (ad esempio esseri con parti mancanti o in sovrappiù) e devianze dalla norma della natura che vuole che gli uomini nascano per lo più in un certo modo. La possibilità dell’errore della natura è resa possibile dal fatto che si tratta di un ambito di cose materiali e, come abbiamo poc’anzi detto, la materia non sempre si lascia dominare dalla forma, a volte le oppone resistenza (tale è ad esempio il caso della mano con quattro dita anziché cinque). Sicchè, a partire da queste considerazioni, lo Stagirita dovrà prendere in esame il fattore “casualità”, e lo farà nel libro II cap.4-5-6, addivenendo alla conclusione che “il caso rientra nel novero delle cause”, intendendo con ciò dire che anche quel che accade per caso ha pur sempre una sua causa, anche se l’effetto risulta derivare da una causa diversa da quella in forza della quale solitamente accade: ossia avviene per accidente (κατα συμβεβηκως). Può dunque accidentalmente accadere che, nel corso della generazione, la materia non si lasci plasmare e ne nasca un mostro. L’individuo di sesso femminile è esso stesso agli occhi di Aristotele un caso di errore della natura, un mostro prodotto dal caso: agendo sul sangue mestruale, il seme maschile forma la materia ed è a questo punto che può verificarsi la devianza; nascere femmina è, appunto, una devianza, ma si tratta pur sempre di una “mostruosità necessaria” al fine di perpetuare la specie. Occupandosi la fisica di corpi in movimento, Aristotele si affatica a lungo sulla nozione di movimento (l’intero libro III è dedicato a tale tematica): riconoscendo quattro possibili modalità di κινησις (locale, sostanziale, quantitativo, qualitativo), egli smaschera definitivamente l’eleatismo parmenideo. Il moto locale è caratterizzato da un’unica direzione dall’alto verso il basso, o viceversa. A ciò vale per il mondo sublunare, poiché i corpi di quello sopralunare sono invece dotati di moto semplice (ovvero circolare: spuntano e tramontano sempre nel medesimo punto) in forza della particolare materia che li costituisce: si tratta non già dei quattro elementi empedoclei che stanno alla base dei corpi sublunari, bensì di quella materia incorruttibile che Aristotele chiama etere. Agli occhi di Aristotele, i corpi si distinguono in semplici e in composti, ed entrambe le categorie cadono nel campo d’indagine della fisica: alla base di tutti i corpi che popolano il mondo sublunare stanno i quattro elementi individuati da Empedocle: a tal proposito, Aristotele rigetta tanto gli atomi di Democrito quanto i solidi del Timeo platonico. Se infatti alla base dei corpi fossero gli atomi, allora i corpi risulterebbero meri insiemi di punti, cosicché potrebbero disgregarsi in qualsiasi momento. Platone compie innegabilmente un passo avanti quando assume come elementi i solidi scomponibili, ma ciononostante la sua proposta resta insufficiente poiché i solidi non sono in grado di subire alcunché né di aggregarsi per dare composti. Solo Empedocle, ravvisando nell’acqua, nella terra, nel fuoco e nell’aria i quattro elementi stanti alla base del reale ha colto la verità: tali quattro elementi, infatti, rendono perfettamente conto e del divenire e dell’aggregarsi dei corpi, giacchè si tratta di elementi divisibili in parti che mantengono lo stesso nome dell’elemento di partenza (ogni parte di terra è sempre terra, e così via). Inoltre essi sono elementi primi nel senso che non sono composti da altri, possono subire affezioni e trasformazioni reciproche (l’acqua che passa allo stato aeriforme), accrescere, diminuire, mutare luogo. Non stupisce pertanto che Aristotele dedichi buona parte della Fisica al loro studio. Tuttavia sbaglia Empedocle nella misura in cui li concepisce come principi (e non come meri elementi), giacché, così facendo, egli finisce per riconoscerli come eterni: ma da ciò che è eterno non può in alcun caso nascere il mutevole e il transeunte, ovvero tutto ciò che popola questo mondo. I quattro elementi rappresentano per Aristotele materia in un determinato stato (allo stato di terra, di acqua, di fuoco, di aria) e presuppongono un sostrato potenziale comune da cui vengono ad essere per effetto di fattori ambientali come il caldo e il freddo. Tale sostrato materiale non esiste indipendentemente da essi: di per sé, i quattro elementi non sono eterni; eterna è invece la loro vicenda di trasformazione, poiché eternamente si trasformano l’uno nell’altro. Dal moto dei corpi semplici dipende direttamente anche l’assetto di del mondo terrestre, risultante costituito in base alla disposizione dei quattro elementi stessi (la cui disposizione è legata alle caratteristiche fisiche di ciascun elemento). Il mondo sublunare (di natura sferica, che è la migliore tra quelle possibili) viene così a configurarsi come una serie di cerchi concentrici al cui centro sta l’elemento più pesante (la terra) e alla periferia quello più leggero (il fuoco), con in mezzo l’acqua e più leggera l’aria. In base a tale disposizione si spiegano anche i moti che si verificano nel mondo sublunare, che possono essere moti secondo natura (φυσει) e moti violenti (βια): una pietra lasciata cadere tende a muoversi di un moto naturale verso il basso, ma se la scagliamo verso l’alto essa procede per un tratto in direzione opposta al suo luogo naturale (muovendosi con un moto contro natura), fino a che non avrà esaurito la spinta e ricadrà a terra. I corpi celesti, invece, si muovono di moto circolare. La luna segna il confine tra i due mondi (sublunare e sopralunare), ma tra essi non c’è separazione netta: c’è anzi una zona intermedia in cui si situano i fattori meteorologici, che sono da Aristotele spiegati con le vicissitudini cui vanno incontro i quattro elementi. Pur verificandosi una tantum (il terremoto o l’arcobaleno non accadono certo quotidianamente), sono fenomeni dotati di una loro spiegazione razionale facente capo ai quattro elementi: sono secondo Aristotele causati dal particolare moto del Sole, il quale avvicinandosi o allontanandosi dalla Terra fa sì che gli elementi si trasformino e diano vita alle stelle cadenti, alle comete, ecc. Aristotele parla a più riprese del moto solare come causa dei moti sublunari: egli si guarda bene dal parlare di “calore” o di “luce” del Sole, giacché ciò significherebbe ammettere che anch’esso stante al di sopra della luna è costituito dai quattro elementi. Ne segue allora che il garante della vicenda ciclica del mondo sublunare (il Sole) è esso stesso sopralunare, e dunque dotato di moto circolare e perfetto. Gli individui sublunari che popolano il nostro mondo (uomini, animali, piante) sono mortali come individui (poiché costituiti dai quattro elementi), ma eterno è il loro processo di generazione e corruzione, cosicché il singolo uomo è perituro, ma la specie umana è eterna (l’atto stesso con cui si ama e ci si riproduce non è che un anelito all’eternità). I corpi celesti non si muovono però tutti allo stesso modo: ciascuno di essi descrive nel suo tragitto una sfera e l’insieme complessivo di tali sfere dà un insieme concentrico che ha al suo centro la Terra stessa (in ciò risiede il geocentrismo aristotelico). Come la Terra occupa il centro del mondo, così la periferia è occupata dal “cielo delle stelle fisse”, che chiude l’estremità del mondo. Le stelle fisse hanno moto eterno, circolare e semplice: via via che dall’alto si scende verso la luna, i moti dei pianeti presentano sempre maggiori irregolarità (tali sono appunto i moti apparenti) di velocità e di regradazioni. Per rendere conto di essi, Aristotele ricorre a più espedienti e argomentazioni teoriche: il problema che più di ogni altro lo interessa è che ciascuno di tali corpi celesti ha anche più d’un solo moto, cosicché diventa difficile spiegare quale realmente sia la causa prima che sta alla base di tali moti. In tale ottica, Aristotele si domanda perfino se gli astri abbiano un’anima – giacchè l’anima, come insegnava Platone stesso, è principio del movimento – e, nel rispondere negativamente, egli chiude definitivamente i conti col Timeo, nel quale si affermava esplicitamente che i pianeti fossero animati, intelligenti e divini. Pur negando l’anima ai corpi celesti, resta intatto il problema riguardante la causa del loro moto: quale è il principio motore che mette in movimento i corpi celesti? Nel XII libro della Metafisica, Aristotele propone ben due diverse possibili risoluzioni del problema: dapprima egli riconosce che ogni sfera ha un proprio motore dotato di determinate caratteristiche: deve essere una sostanza – sennò non può causare il moto di un’altra sostanza, deve essere anteriore al corpo mosso e deve muovere sempre altrimenti non può causare l’immutabile e perenne moto degli astri-, deve essere atto puro, giacchè se fosse potenza potrebbe ora muovere, ora no. Ma se è solo atto ed esclude la potenza, allora esclude anche il movimento e il mutamento (che della potenza sono tipici): sarà allora un motore immobile, che muove senza essere mosso. Dopo aver esposto questa teoria secondo la quale molteplici sarebbero i motori immobili (uno per ogni sfera), Aristotele – appena un capitolo dopo cambia radicalmente prospettiva e riconosce esplicitamente la possibilità di un motore immobile unico per tutte le sfere celesti. Questo primo motore immobile, in quanto privo di potenza, è anche privo di materia ed è da Aristotele identificato con la divinità. Da ciò segue una struttura gerarchica del cosmo, poiché dall’unico motore immobile “si dirama” l’intero universo: la metafora del diramarsi è impiegata da Aristotele anche in sede biologica per spiegare il rapporto tra le vene e il cuore, che è un rapporto di unione tale per cui le vene si diramano dal corpo senza distaccarsene; similmente, il motore immobile non è staccato dal mondo, e l’universo stesso non è che una totalità in movimento incessante. L’identificazione del motore immobile con la divinità non implica tuttavia un rapporto provvidenziale tra quest’ultima e il mondo, come invece era nel Timeo: il dio di Aristotele, lungi dall’organizzare provvidenzialmente il mondo, sta fermo ed è causa finale del moto del “primo mobile”, ovvero del “cielo delle stelle fisse”, che a lui tende come al proprio fine. In accordo col libro XII della Metafisica, Aristotele sostiene nel libro VIII della Fisica che il motore immobile deve essere presupposto come causa in grado di spiegare il moto del mondo: la divinità muove il mondo stando ferma, ovvero causa il moto dell’universo come causa finale (giacché, se fosse causa efficiente, sarebbe essa stessa in movimento), poiché a lei tende come l’amante verso l’oggetto amato – il “primo cielo”. Ma se la divinità è immobile, in che cosa consiste la sua attività? Essendo il pensiero la migliore attività in assoluto, la divinità non farà altro che pensare (essa è, in questo senso, la proiezione a livello cosmico del filosofo) e, più precisamente, non farà altro che pensare a se stessa, poiché, se pensasse ad altro, ritornerebbe quella nozione di potenza che abbiamo bandito dalla sfera divina: dio è per Aristotele νοησις νοησεως (“pensiero di pensiero”). In netta opposizione all’atomismo e alla sua infinità dei mondi, Aristotele difende a spada tratta l’unicità del mondo: il mondo è uno ed eterno, assolutamente incorruttibile (l’errore del Timeo è ravvisato nell’aver posto il mondo come generato e, insieme, eterno, senza tener conto che il generato è necessariamente perituro). In difesa dell’unicità del mondo, Aristotele dice – nel De caelo – che, se ci fossero altri mondi, essi sarebbero necessariamente costituiti dagli stessi quattro elementi che formano il nostro; ma allora tali elementi tenderebbero a disporsi nei luoghi naturali del nostro mondo, cosicché se ne deve concludere che tutta la materia è già contenuta nel nostro unico mondo.
Commento Libro I
Nel primo capitolo dell’opera, Aristotele esordisce asserendo che vi è scienza soltanto laddove vi è conoscenza dei principi, degli elementi e delle cause: poiché la fisica è una scienza, allora anch’essa dovrà, di necessità, conoscerli. Sicchè vedere le cose nel loro manifestarsi fenomenico non è ancora una forma di sapere in senso pieno, pur avendo una sua dignità nel processo cognitivo: occorre invece individuare con precisione quei principi insiti nelle cose stesse che, se colti, guidano la nostra conoscenza, che sarà dunque immanente alle cose perché immanenti ad esse sono i principi stessi (la critica a Platone è evidente). Per natura, il processo conoscitivo muove da ciò che è più conoscibile per noi a ciò che è più conoscibile di per sé: e ciò che per noi è dapprima più conoscibile è l’insieme confuso, ossia l’indifferenziato: solo in un secondo tempo, grazie alla scoperta dei principi, degli elementi e delle cause, si può pervenire alla conoscenza dell’articolato e del differenziato, che è più conoscibile di per sé. L’ambito dell’indifferenziato a cui qui Aristotele allude è quello dell’esperienza sensibile e della sensazione, che sono le vie conoscitive più immediate e, in ogni caso, da non rigettare: come Aristotele spiega nel De anima, la conoscenza sensibile degli oggetti è assolutamente veritiera, almeno per i “sensibili propri” di ciascun senso: infatti, quando gli occhi vedono il giallo, lo percepiscono secondo verità, e ciò in virtù del fatto il giallo in potenza diviene giallo in atto e, al contempo, gli occhi, da veggenti in potenza, diventano veggenti in atto. E’ pur vero che un margine d’errore si ha quando nel processo conoscitivo sono coinvolti più sensi, come quando si percepiscono oggetti in movimento. Da tutto ciò appare ovvio che la conoscenza non può che partire dalla sensazione: dalla reiterazione della sensazione sorge l’esperienza, che è appunto una collezione di sensazioni che mi portano a conoscere il “che” delle cose. Ma l’esperienza tende ancora ad avere carattere indifferenziato e non connesso casualmente, ragion per cui è opportuno spingersi al di là di essa. Il fatto che ciò che per noi è inizialmente più chiaro sia in realtà confuso e indistinto è da Aristotele avvalorato con due esempi calzanti: i bambini, nei loro primi anni di vita, chiamano “mamma” tutte le donne indistintamente e solo col passare del tempo introducono distinzioni; similmente, la parola “cerchio” può essere riferita a più cose, prima che se ne dia una definizione. Il primo capitolo, dunque, chiarisce come la conoscenza scientifica abbia per oggetto principi, elementi e cause e come dunque anche la fisica – che è scienza a tutti gli effetti non si sottragga a ciò. La conoscenza procede dal più chiaro per noi al più chiaro per natura: ma il più chiaro per noi è un caotico indistinto privo di differenziazioni, è l’esperienza allo stato puro; spetta alla scienza che è conoscenza del “perché” porre ordine, in forza della conoscenza dei principi, delle cause e degli elementi. Il capitolo secondo si interroga su quali effettivamente siano tali principi: con un procedimento tipico del suo filosofare, Aristotele fa ora una ricognizione sulle tesi sostenute in merito dai predecessori, per desumere da esse quanto hanno di buono e per criticare ciò che esse presentano di inaccettabile. A tal proposito, egli elabora una vera e propria “matrice dei principi”, prospettando tutte le possibili posizioni sulla questione: chi sostiene che il principio è uno, può assumerlo come immobile (l’eleatismo) o in movimento (gli Ionici); chi sostiene che i principi siano molti, può assumerli come infiniti (Anassagora) o finiti (Empedocle). Si tratta ora di considerare una per una queste possibili posizioni storicamente sostenute dai predecessori: quella che resisterà al fuoco della confutazione, sarà quella autentica, giacchè, oltre ad esse, non ve ne sono altre. Quella che Aristotele qui intraprende è un’indagine dialettica, volta a mostrare l’inconsistenza delle tesi sostenute dagli altri: in particolare, egli prende le mosse dall’eleatismo, che, con la sua presa di posizione, aveva segnato un’intera epoca: la presa di posizione parmenidea aveva destituito di ogni legittimità la fisica, bollando come doxastica ogni presunta conoscenza di questo mondo; la via di quanti parlano di divenire, perché abbagliati dai sensi, è per Parmenide l’erronea via della δοξα, quella via in cui si finisce per mescolare indebitamente l’essere al non essere ammettendo il divenire. Dalla confutazione dell’eleatismo dipende la vita della fisica, come Aristotele sa bene: e non è un caso che egli, spesso benevolo verso chi l’ha preceduto, riveli un’acuta insofferenza (come ha rilevato Emanuele Severino) verso Parmenide. Stando all’asserto parmenideo, “ciò che è, è uno e immobile”: propriamente, non è una tesi sui principi, ma, di fatto, contiene una presa di posizione su di essi. E’ dunque un dovere prioritario smascherare l’eleatismo, se si vuole salvare la fisica. Ma non è impresa facile, poiché l’asserto parmenideo pare incrollabile sul piano logico: per vincere la battaglia, Aristotele deve far ricorso a tutto il proprio armamentario filosofico, dalla nozione di categorie a quella di potenza/atto (il che avvalora la tesi secondo cui la Fisica sarebbe uno scritto composto nella maturità). In primo luogo, Aristotele valuta il tenore degli argomenti eleatici: “ricercare se l’essere è uno e immobile non è fare ricerche sulla natura”, egli rileva, poiché la natura come attesta l’induzione è il regno della varietà e del movimento; indagare alla maniera eleatica equivale a eliminare i principi: la nozione stessa di principio, infatti, comporta dualità, in quanto implica un principio e, accanto ad esso, la cosa di cui è principio; sicché gli eleati, riducendo all’unità i principi, finiscono per neutralizzare la fisica stessa, giacché non è più possibile render conto del mutamento në della pluralità. Aristotele sostiene di trovarsi nella stessa posizione di un geometra a cui sono contestati i principi della sua scienza: egli non deve chiarire i suoi principi a chi li nega, ma ciò non di meno deve fare ricorso ad una scienza comune (la dialettica) con cui smascherare in maniera confutatoria (ελεγκτικώς) il negatore di tali principi, giacchè essi sono discutibili solo “dall’esterno” (in quanto mai dimostrabili). In questo modo, ossia confutando la negazione eleatica dei principi, procederà Aristotele: egli mostra come tanto Melisso quanto Parmenide conducano ragionamenti “inconcludenti” (ασυλλογιστοι) e sostenuti “per amor di discusstone” (λογου χαριν), cosicché la loro viene a configurarsi come una posizione eristica, volta cioè per usare la riuscita immagine dell’ Eutidemo platonico-a stordire a suon di pugni in faccia l’avversario, con una verbositä vuota e capziosa. Essendo Melisso oltremodo “rozzo” (φορτικος) – e tale aggettivo infamante lo accompagna per tutto il primo libro nell’argomentare, sarà bene partire da lui: innanzitutto, Aristotele ci chiede di assumere per il momento (in seguito lo dimostrerà) che le cose di natura sono o tutte o alcune in movimento, come attesta l’induzione. Già qui la tesi eleatica che va contro l’induzione potrebbe dirsi sconfessata: ma lo Stagirita non si accontenta e, per riportare una vittoria su tutta la linea, accampa altri argomenti. Ancor prima di appuntare la sua attenzione sul “rozzo” Melisso, egli fa un rilievo sull’eleatismo in generale: poiché “l’essere si dice in molti modi” (το ον λεγεται πολλαχώς), in che senso, per gli eleati, tutte le cose sono una? L’uno in questione è sostanza, qualità, quantità, o altro? Tutte le cose sono un’unica sostanza o, piuttosto, l’uno è una sola qualità (bianco, caldo, freddo, ecc)? Aristotele sta qui facendo leva sulla propria dottrina delle categorie, dietro alle quali c’è la fondamentale distinzione del verbo essere che nella categoria della sostanza ha valore esistenziale (ad es. Socrate è), mentre in tutte le altre ha valore copulativo (Socrate è bianco, è alto, è di 30 anni, ecc): la distinzione dei due valori esistenziale e copulativo – del verbo essere è in realtà una scoperta del Sofista platonico, in cui era salvata la molteplicità del mondo delle idee a non quella del mondo reale, che veniva a configurarsi come un mostruoso miscuglio di essere e di non-essere, secondo la bella immagine (Repubblica, V 478 e seguenti), secondo cui c’è un uomo che non è un uomo (è un eunuco), che tira una pietra che non è una pietra (una pomice) ad un uccello che non è un uccello (un pipistrello) che sta su una pianta che non è una pianta (una canna). Aristotele, dal canto suo, grazie alla coppia potenza/atto e alle categorie, salva l’intera realtà nella sua variegata pluralità: il mondo quale ci si manifesta nella natura è in senso pieno e il suo essere si dice in una pluralità di modi (πολλαχώς), tutti in qualche modo connessi fra loro, così come si dice che è salutare tanto una cura quanto l’aria di mare o una lezione (in tutti i casi v’è riferimento ad un quid di unico). Se gli eleati dicono che ciò che è (to ov) è uno nel senso di qualità o di quantità, allora si cade nell’assurdo, poiché la qualità e la quantità esistono solamente nella misura in cui si riferiscono ad una sostanza; e ciò vale anche nella sfera linguistica, oltre che in quella fisica (in virtù del fatto che pensiamo e predichiamo l’essere che è): si può infatti dire che Socrate è bello o che è musico nella misura in cui v’è un soggetto (Socrate) a cui i predicati (l’esser bello e musico) ineriscono. Se invece per gli eleati ciò che è, è come sostanza, allora non potrà avere alcuna quantità o qualità, sennò non sarebbe più uno, bensì sarebbe due (appunto la quantità e la qualità). In questo modo, crolla la tesi eleatica: non è ragionevole affermare che ciò che è sia uno. Melisso, nella sua rozzezza, è precipitato in assurdità anche maggiori: egli sostiene che ciò che è, è infinito (απειρον), ossia illimitato, giacchè se avesse limiti, allora avrebbe qualcosa fuori di sé e quel qualcosa sarebbe il non-essere. Stando così le cose nota Aristotele, ne consegue che ciò che è è una quantità, dal momento che l’infinito rientra in tale categoria: ma se è solo una quantità, allora non esiste (poiché non v’è quantità senza sostanza); se invece è quantità di una sostanza, allora non è più uno (è quantità ed è sostanza, ossia è due cose). Del resto, come l’essere, anche l’uno si dice in molti modi: si può infatti dire che una cosa è una nel senso della continuità (è cioè un aggregato unitario comprendente al proprio interno diverse parti), oppure dell’indivisibilità (tali erano gli atomi di Democrito: assolutamente indivisibili), o ancora della definizione (“l’uomo è animale bipede”: la definizione, pur essendo unitaria, ricomprende al proprio interno varie parti). In quale di questi sensi, allora, gli eleati sostengono l’unicità dell’essere? Nel senso dell’indivisibilità? Se così fosse, allora l’essere sarebbe uno in senso assoluto e non potrebbe essere infinito o finito (quale lo intendeva Parmenide): più in generale, non potrebbe avere alcuna qualità o quantità. E’ allora uno nel senso della continuità? In tal caso, non sarebbe più uno, giacchè sarebbe un coacervo di parti tenute insieme. Sarà dunque uno nel senso della definizione, come quando si dice che “l’uomo è animale bipede”? Se così fosse, gli eleati finirebbero per sostenere la stessa posizione confusionaria di Eraclito: se infatti per definizione tutto è uno, allora ne segue che “uomo” è “cavallo”, “buono” è “cattivo”, ecc. Ci si troverebbe insomma costretti ad ammettere la coincidenza degli opposti fatta valere da Eraclito e ne emergerebbe per dirla con Hegel una notte in cui tutte le vacche sono nere. L’unica soluzione possibile pare allora, in siffatta prospettiva, quella di Antistene e dell’οικειος λογος (“discorso appropriato”), per cui sarebbero possibili solamente “giudizi identici” del tipo: “uomo è uomo”, “bello è bello”, “Socrate è Socrate”. Sul finale del capitolo, Aristotele fa una pausa, perché consapevole dello spessore delle tesi eleatiche: esse sollevano problemi non solo per l’επιστημη φυσεως, ma anche per il linguaggio. Proprio per queste ragioni (in particolare per non contravvenire al divieto parmenideo), Licofrone un sofista della seconda generazione e, dunque, particolarmente attento ai problemi linguistici – eliminò l’espressione “è” dal giudizio, e molti altri, per non dire “l’uomo è bianco”, dicevano “l’uomo biancheggia”. La soluzione che Aristotele avanza di fronte al gravoso ostacolo eleatico è racchiusa in due punti centrali: in primis, si deve comprendere – sulla scia del Platone “parricida” di Parmenide che il verbo essere ha due diverse valenze (una copulativa, l’altra esistenziale), per cui dire “il tavolo è” è cosa ben diversa dal dire “il tavolo è rosso”; in secundis, si tratta di tenere a mente che l’essere e l’uno si dicono in molti sensi e che il divenire non implica quell’indebito passaggio dall’essere al non-essere e viceversa: il blocco di marmo che diventa una statua non passa dall’essere (marmo) al non essere, per poi tornare all’essere (come statua); esso invece passa dall’essere statua in potenza all’essere statua in atto. In questo modo, in forza dei concetti di potenza e di atto, è aggirata l’aporia eleatica. Le cose sono molte per definizione (dire che “Socrate è bello e musico” il bello e il musico sono due cose diverse, ma riferentisi entrambe alla medesima sostanza) e per divisione (una totalità è sempre una totalità comprendente molte parti). Occorre poi operare una distinzione rileva lo Stagirita – tra la “generazione assoluta” e la “alterazione”: caso di “generazione assoluta” è quello della nascita di un vivente che viene generato: esso viene ad essere da qualcosa che in certo senso già è (è in potenza) e che al contempo non è (non è in atto), senza che ciò implichi quel passaggio dal non essere all’essere stigmatizzato da Parmenide; la stessa alterazione (che si ha quando una sostanza muta le proprie qualità, come nel caso in cui “Socrate diventa musico”) comporta il permanere della sostanza e il mutare esclusivamente delle qualità che le ineriscono. Perché mai, poi, il rozzo Melisso ha sostenuto che l’essere è uno e, per ciò stesso, immobile? Se anche supponiamo che l’acqua sia una, non è forse lecito ammettere che essa si muova in sé? Melisso obiettava ai suoi contestatori che, se l’essere si muovesse, si muoverebbe verso ciò che non è, ossia verso il non-essere: da ciò egli inferiva l’immobilità assoluta dell’essere. Anche qui Aristotele obietta con un argomento ad personam: occorre operare una distinzione tra i casi in cui a muoversi è il tutto (come nel caso in cui cammino) e quelli in cui a muoversi è la parte (come nel caso in cui, stando fermo, muovo il braccio); da ciò egli fa seguire che anche ciò che è uno può muoversi, a patto che si muova in sé (come il braccio rispetto al corpo). Inoltre l’essere non potrà nemmeno essere uno neppure per specie (ειδος), giacché “specie unica” è quella del cavallo, del leone, dell’uomo ecc. e se l’essere fosse uno nel senso della specie, allora tutte le cose sarebbero cavalli, o leoni, o uomini. Rispetto a quella eleatica, è assai più corretta la via battuta dai fisici, ad avviso dei quali l’uno è principio materiale stante alla base di ciò che è e diviene: dai moti dell’αρχη materiale deriva la realtà nella sua molteplice interezza. Dopo aver distrutto le tesi accampate da Melisso, Aristotele passa all’esame di quelle fatte valere dal venerando Parmenide, il cui “scioglimento (λυσις) si risolve nel mettere in luce come il suo ragionamento sia ασυμπερατος, ossia tale da non addivenire ad una conclusione cogente. Falsa è la premessa per cui το ον λεγεται απλως, e altrettanto false e fuorvianti sono le conclusioni raggiunte: erra Parmenide nel sostenere che l’essere si dice in un solo modo, giacchè l’induzione attesta che esso si predica in più modi. A questo punto, Aristotele ci invita a supporre che το ον sia uno nel senso di essere bianco: anche in questo caso, non se ne potrà inferire che v’è una sola cosa bianca, poiché in natura le cose bianche sono tante; ne segue allora che la nozione di bianco non è uno né per continuità (si riferisce infatti a molte cose) né per definizione (il bianco si predica sempre di una sostanza: non esiste il bianco, bensì esistono sostanze bianche). Non avendo colto la distinzione tra essere come sostanza ed essere come predicato, Parmenide è facilmente confutabile: egli confonde gli accidenti (συμβεβηκοι) con la sostanza (υποκειμενον), azzerando la possibilità di far entrare ciò che è in una qualunque mediazione; il riconoscere stesso che το ον è un sostrato con accidenti significa parlare πολλαχώς dell’essere. Liquidate le tesi eleatiche nei capitoli secondo e terzo, Aristotele passa ad esaminare quelle dei fisici in senso proprio, rilevando, in apertura del capitolo quarto, che sussistono due grandi scuole di pensiero sulla natura: da un lato, v’è chi pone un sostrato unico e fa derivare il molteplice dai processi di modificazione che coinvolgono quest’unico sostrato: è questo, ad esempio, il caso di Anassimene, che ha ravvisato nell’aria l’αρχη originario, e ha poi individuato nella rarefazione e nella condensazione i due stati contrari assumendo i quali il principio origina l’intera realtà. L’aver ravvisato nella materia il principio del reale è un aspetto altamente positivo – nota Aristotele nel primo libro della Metafisica, anche se il limite di questi antichi filosofi dev’essere scorto nel loro essersi limitati alla causa materiale, senza neppure intravedere le altre tre. Al pari dell’υποκειμενον ammesso da Aristotele, Ι’αρχη riconosciuto da questi antichi permane stabilmente e identico a sé al di sotto dei mutamenti che interessano le sue proprietà, cosicché nulla nasce, nulla perisce e tutto si trasforma. Così Socrate diventa bello e musico senza che il sostrato vari: a cambiare non è la sostanza, ma le qualità che ad essa ineriscono. La seconda grande scuola di pensiero sulla natura è quella costituita da quanti hanno ammesso un originario sostrato indistinto da cui sarebbero nate in seguito le diverse articolazioni del reale: tale era l’απειρον di Anassimandro, il μιγμα di Anassagora e il caos primitivo ammesso da Empedocle. Secondo costoro, tutte le cose sono già presenti nell’indistinto iniziale ed emergono dalla struttura profonda della realtà in virtù di un processo che qui Aristotele qualifica come “secrezione”. Tralasciando Anassimandro, lo Stagirita si concentra su Empedocle e su Anassagora: il primo ha fatto derivare dall’indistinto originario quattro “radici” che, dotate delle caratteristiche parmenidee dell’immutabilità e dell’eternità, si combinano e danno vita, per processi di generazione e corruzione, al reale quale ci si manifesta; dal canto suo, Anassagora ha fatto derivare dall’indistinto originario infiniti “semi”. Aristotele, a questo punto, deve confutare una delle due tesi: ed egli non esita ad attaccare quella anassagorea degli infiniti principi, mettendo in evidenza le assurdità che derivano dalla sua ammissione. Ne segue, allora, che la tesi vera è quella di Empedocle, l’unica che ha retto al fuoco della confutazione: i principi non sono né uno né infiniti, bensì molti; e in seguito lo Stagirita spiegherà quanti e quali sono. Se si assume un’infinità di principi, come fa Anassagora, allora ciò che da essi deriverà non potrà in alcun caso essere un alcunché di determinato e, pertanto, sfuggirà sempre alla conoscenza. La tesi anassagorea, pertanto, deve essere rigettata. Improvvisamente e a sorpresa, Aristotele cita anche Platone, inserendolo a pieno titolo fra quanti hanno condotto indagini sulla natura: il che non può non cogliere alla sprovvista, in quanto come è noto Platone non ha mai inserito, nei suoi dialoghi, la fisica fra le scienze; in realtà, tutto si spiega se teniamo a mente che quello che qui Aristotele ci presenta non è il Platone scritto dei dialoghi, ma è invece quello degli αγραφα δογματα, ossia delle “dottrine non scritte” dibattute oralmente nell’Accademia (e dunque udite da Aristotele stesso). In particolare, stando a quanto Aristotele qui (ma anche in Metafisica, I) riferisce, Platone avrebbe agito in maniera simile ai fisici: come materia, egli avrebbe assunto il grande e il piccolo, come forma avrebbe invece assunto l’uno. E’ questa quella che è passata alla storia come la dottrina non scritta della “diade indefinita”, secondo cui al Bene coincidente con l’unità assoluta e con la forma – sarebbe contrapposto il Male, coincidente con la dualità e l’indeterminatezza della materia. Tuttavia vi sono anche notevoli differenze rispetto ai fisici ionici: se questi assumevano un solo principio materiale e due diverse forme, Platone, invece, ammette un solo principio formale e ben due principi materiali. Così facendo, però, egli scivola in assurdità incredibili: se infatti si ammette la duplicità della materia, nello spiegare il mutamento si dovrà riconoscere che essa è passata da uno stato ad un altro, ossia si è annullata, il che è assurdo. Molto più corretta è la posizione dei fisici, delineando la quale Aristotele chiarisce anche la propria: occorre ammettere un numero finito di principi, nella fattispecie tre, giacché se se ne ammette uno (alla maniera eleatica) non si può render conto della natura, se se ne ammettono infiniti (sulle orme di Anassagora) tutto diventa inconoscibile e indeterminato, se se ne ammettono solo due allora, nel divenire, uno dei due si annulla. Tre è il numero dei principi: in particolare essi sono la materia (υλη), la forma (ειδος) e la privazione di forma (στερησις). La materia è sempre materia dotata di forma in atto, ma in potenza può assumere la forma contraria: così un blocco di marmo in potenza può essere tanto una statua quanto un tavolo; assumendo la giusta forma, cessa di essere tavolo (in ciò sta la privazione della forma) e diventa statua in atto. Ogni sostrato ha in atto una data forma e non la sua opposta, sicchè v’è privazione (στερησις) di quest’ultima: così, Socrate è bianco in atto e, dunque, non è nero (solo in potenza possono convivere le due forme contrarie).
LIBRO II
Nel secondo libro della Fisica Aristotele entra in medias res ed indaga sulla natura, forte delle acquisizioni guadagnate nel primo libro: per chiarire che cosa si debba intendere per natura, egli instaura un efficace raffronto con l’ambito delle τεχναι, un campo indubbiamente a noi più vicino; anche qui, vale l’assunto secondo cui la conoscenza deve procedere da ciò che è più chiaro per noi (in questo caso, le tecniche) a ciò che è più chiaro per natura (la φυσις). L’accostamento della natura al mondo della tecnica non è una novità in sede filosofica: già Platone vi aveva fatto largamente ricorso, allorché nel Timeo e nelle Leggi (libro X) qualificava il mondo stesso come un’opera d’arte infallibilmente perfetta, in quanto realizzata da un artefice divino. Dal canto suo, Aristotele capovolge il modello platonico e studia la natura in analogia con la tecnica non già sulla base di una presunta identificazione tra le due, bensì sulla base della loro comune fallibilità: infatti, tanto la tecnica quanto la natura non sono sorrette da fili divini e, per ciò, sono suscettibili di errori; mirano sempre al raggiungimento di un fine identificatesi con il bene, ma non sempre riescono a concretizzarlo, giacché ostacolate dall’indeterminatezza recalcitrante della materia. E così, come un medico può sbagliare nel somministrare una data medicina, similmente la natura può commettere errori, dando vita a vere e proprie mostruosità. Per chiarire che cos’è la natura, nel capitolo primo Aristotele opera un’importante distinzione tra le cose che sono “per natura” e quelle che sono “per tecnica”: per natura sono gli animali e le loro parti, le piante, gli uomini e gli elementi; e ciò che non è per natura, è per tecnica: infatti, un tavolo o un mantello sono il frutto della produzione da parte di qualcosa di ad essi esterno (l’artigiano) ed è da quel qualcosa che dipende il loro essere e il loro non essere. Al contrario, le cose di natura hanno in se stesse il principio del moto e della quiete, ossia possono autonomamente spostarsi (tale è il caso dell’uomo che cammina), accrescersi e diminuire, alterarsi, ecc. Aristotele qualifica questa innata tendenza delle cose “per natura” a muoversi con il termine ορμη, che letteralmente significa “impulso”, “tendenza”: ciò sta a significare che “le cose per natura” hanno in sé tale impulso a mutare e si tratta di una tendenza non accidentale, ma che anzi appartiene πρωτως και κατα αυτο (in maniera originaria e di per sé). Per meglio chiarire questo punto oscuro, Aristotele paragona la natura a un medico: quando questi cura se stesso, lo fa in maniera accidentale (si trova infatti per accidente ad essere e medico e paziente), mentre quando cura gli altri ciò avviene in maniera propria e non accidentale; e la natura si trova per l’appunto nelle stesse condizioni di un medico che cura gli altri: essa possiede dunque le proprie caratteristiche in maniera non accidentale. Nelle opere biologiche, l’immagine della natura come un medico ritorna, ma stravolta, giacché in tali scritti Aristotele va accostando la natura ad un medico che cura se stesso, a significare che la natura, lungi dall’essere infallibile (quale invece la concepiva Platone), commette errori ma sa anche curarli da sé, proprio come il medico che si auto-medica. Ben diversa è la situazione per quel che concerne gli oggetti della tecnica: essi hanno il principio del moto e della quiete non in sé, bensì in un oggetto esterno, come rivela il caso del letto che si muove esclusivamente se mosso dall’artigiano. Così concepita, la natura è il regno della mobilità, della processualità e dell’attività. Le cose che sono per natura possono essere o secondo natura (κατα φυσιν) ο contro natura (παρα φυσιν), così come – ritorna l’analogia con le tecniche un paio di scarpe possono essere prodotte o a regola d’arte o in disaccordo con l’arte, nel caso in cui abbiano la suola mal fatta; in maniera del tutto analoga, nella riproduzione umana che è un processo di natura – può nascere un uomo come natura richiede (e ciò avviene επι το πολυ) oppure può nascere un mostro con due cuori o con una mano avente quattro dita anziché cinque. Ciò avviene in virtù del fatto che in natura v’è un margine di accidentalità dipendente dalla materia, la quale non sempre si lascia plasmare dalla forma: in questa maniera, è riconfermata la tesi antiplatonica secondo cui la natura non è un’opera d’arte perfetta, ma è piuttosto l’insieme delle cose che sono per natura e che mirano al meglio (ossia all’acquisizione della forma che ad esse si addice) e che non sempre lo raggiungono perché ostacolate dalla materia. Così, επι το πολυ l’uomo nasce dotato di una data forma, ma ciò non esclude una zona d’ombra entro la quale il processo generativo devia e nasce un mostro rientrante anch’esso nelle cose di natura, ancorché nell’accezione di “contro natura”. E’ questo il “finalismo imperfetto” (perché non sempre tale da realizzarsi) che Galeno ravvisava in Aristotele, preferendo in forza di ciò Platone con suo modello provvidenzialistico. Un ipotetico oppositore potrebbe chiedere ad Aristotele di dimostrare l’esistenza della natura. Ma chiediamoci è dimostrabile che ci sia la natura? Aristotele risponde negativamente: una siffatta dimostrazione sarebbe ridicola e, insieme, assurda, in primis perché l’evidenza stessa attesta l’esistenza di una pluralità di enti forniti del principio del movimento e, in secundis, perché chi volesse intraprendere tale dimostrazione si troverebbe nella stessa condizione di un cieco che volesse disquisire sui colori, rivelando di non saper distinguere tra evidenza e non evidenza; come si può, infatti, dimostrare l’evidente (la natura) attraverso ciò che evidente non è? Riconosciuta dunque l’indimostrabilità della natura, Aristotele si interroga su quanti e quali siano i sensi in cui di essa si può parlare. Gli antichi ionici hanno tutti ammesso che la natura si identificasse con la materia; ad esempio, il sofista Antifonte, nel suo scritto Sulla verità, spiegava che se si seppellisse un letto di legno e, per putrefazione, potesse nascere qualcosa, allora ne nascerebbe del legno, e non un letto: da ciò egli evinceva come, propriamente, la natura è la materia, mentre la forma si riduce al rango del νομος. Dal canto suo, Aristotele non nega affatto che la natura sia la materia, ma si spinge oltre: a suo avviso, infatti, l’assunzione di una forma da parte della materia non è un qualcosa di accidentale (come credeva invece Antifonte), ma è anzi l’attualizzazione di una determinata potenzialità, il realizzarsi in senso pieno del fine per cui il processo si è avviato. In questo senso, lo Stagirita si colloca a metà strada tra il materialismo e l’idealismo, senza abbracciare integralmente nessuna delle due posizioni. Come un prodotto della tecnica è tale solo se si realizza in accordo con la tecnica stessa e acquisisce in atto la forma (cioè il fine), ugualmente i prodotti della natura sono in accordo con la natura stessa quando acquisiscono la forma (ossia il fine) che ad essi compete per natura; e così, prodotti come ossa o sangue non sono ancora propriamente natura fino a che non passano all’atto, acquisendo la giusta forma. Ne segue allora che natura è soprattutto la forma, giacché si può parlare in senso pieno di prodotti naturali solo quando essi sono in atto, ossia quando sono dotati di forma, e ciò in base all’acquisizione aristotelica (tematizzata in Metafisica, IX) secondo cui l’atto si identifica con la forma, la potenza con la materia. La potenzialità della materia, infatti, è tale per cui essa può essere diversamente da come dovrebbe ed è per questa ragione che può capitare che nascano mostri. Nell’esempio del letto addotto da Antifonte, si può per assurdo ammettere che sia vero che, in senso proprio, la tecnica è materia; ma nel caso della natura ciò non è valido, poiché dall’uomo non nasce materia informata, bensì nasce l’uomo (ανθρωπος γεννα ανθρωπος, “uomo genera uoто”, ama ripetere Aristotele), che è appunto materia formata. Il fatto stesso che la fine e il fine (dunque la forma) del prodotto coincidano, avvalora ulteriormente la tesi secondo cui la natura è forma. Mentre la medicina e, in generale, le tecniche mirano a produrre qualcosa di esterno (la statuaria produce statue, la medicina la salute, ecc), dal canto suo “la natura è una via verso la natura”, il che sta a significare che in natura il processo va da natura a natura (l’uomo genera l’uomo, il cavallo il cavallo, ecc). Si apre a questo punto un problema non da poco: che dobbiamo fare della “privazione di forma” ammessa nel primo libro come terzo principio accanto alla forma e alla materia? Su questo punto Aristotele è come non mai enigmatico: “anche la privazione di forma è, in certo senso, forma”, egli dice, forse a sottolineare come anch’essa sia determinante nel processo, giacché se si dice “Socrate non è caldo” (dove il “non essere caldo” è privazione della forma) è come se stessi effettuando una determinazione, ancorché in senso negativo. Per questa via, è recuperata e mantenuta valida anche la privazione della forma. Riconoscere in natura la priorità della forma sulla materia non significa ammettere che il fisico debba limitarsi a studiare le forme: la natura infatti si dà sempre come forme calate nella materia, ossia come “sinoli” di materia e forma, ragion per cui il fisico dovrà per l’appunto occuparsi di composti di materia e forma. Per meglio chiarire che cosa sia la natura, Aristotele traccia – nel secondo capitolo – una serie di distinzioni tra la fisica, la matematica e la filosofia prima, come egli fa anche nel libro sesto della Metafisica (che forse è coevo). Nel VI libro della Metafisica, tuttavia, il referente della partizione delle scienze è la “filosofia prima” (là identificata con la teologia), cui in questo secondo capitolo del libro II della Fisica dedica poco spazio; molto ne dedica invece alla matematica e alla fisica, concedendosi anche il lusso di dileggiare gli “amici delle idee” (ovvero i Platonici), chiamandoli con distacco “loro”. Come è noto, nel VI della Metafisica, Aristotele esaltava la superiorità della filosofia prima sulle altre scienze in forza della sua universalità e finiva poi per farla coincidere con quella τεολογικη επιστημη avente per oggetto niente poco di meno che Dio. Ora, in questo passo della Fisica Aristotele asserisce che la metafisica si occupa non già di Dio, bensì delle forme, rinnegando quanto aveva a suo tempo detto nel VI della Metafisica: come si può spiegare questa mutata prospettiva? Forse ammettendo che lo Stagirita, ai tempi del VI della Metafisica, fosse ancora nella cerchia dei Platonici e, dunque, portato ad ammettere la separazione tra forma e materia e a dare ampio spazio all’investigazione teologica. Quando compone la Fisica, egli si è ormai definitivamente congedato dal platonismo e, pertanto, egli torna a tracciare le differenze tra le tre scienze teoretiche alla luce delle nuove acquisizioni da lui guadagnate: le tre discipline egli ora argomenta si atteggiano diversamente verso la natura e il crinale della distinzione tra le tre è da individuarsi nella nozione di separazione. La fisica e la matematica paiono, prima facie, avere un comune campo d’indagine e di applicazione, giacchè entrambe proiettano la loro indagine sulle figure fisiche: eppure, se esaminate in trasparenza, esse rivelano notevoli differenze nella misura in cui la matematica studia quelle proprietà dei corpi (studiate anche dal fisico) facendo astrazione dai corpi naturali, ovvero studiandole come se fossero forme a sé stanti (dai corpi quadrati ricava, per astrazione, la forma di quadrato e opera su di essa); ciò significa che il matematico separa le forme dai corpi (che sono dotati di moto e di materia) e le ipostatizza, cosicché egli finisce per indagare sull’essere non in movimento. Dal canto suo, il fisico studia forme nella materia, ossia corpi materiali e dotati di moto. A questo punto, tracciata la distinzione tra fisica e matematica, Aristotele scocca i suoi dardi contro i sostenitori delle idee: anch’essi, alla stregua dei matematici, operano astrazioni, privando i corpi fisici delle loro proprietà materiali e considerandoli come Idee (le quali, così intese, non sono se non sensibili considerati in sé e senza materia). Anch’essi, dunque, fanno astrazione, ma in maniera meramente inconsapevole e illegittima, dal momento che rileva Aristotele le forme non sono mai separabili, se non per “sottrazione” astrattiva (αφαιρησις). Tra la matematica e la fisica vi è uno stuolo di scienze intermedie, tutte degne di attenzione: vi è la geometria, che studia le linee fisiche in maniera matematica; vi è l’ottica, che studia in modo matematico la luce del sole; vi è l’armonica, avente per oggetto i suoni, studiati su base matematica; e, infine, vi è l’astronomia, che investiga sui corpi celesti. Tutte queste discipline, collocate da Aristotele a metà strada tra fisica e matematica, erano state dal Platone della Repubblica ascritte nel curriculum del filosofo. Resta ora da chiarire, in via definitiva, che cosa studi realmente la fisica: materia? Forma? O, piuttosto, sinoli di materia e forma? Se la fisica studia sinoli, allora studia la natura sia come materia sia come forma. Ma indagare e sulla materia e sulla forma è compito di una o di due diverse scienze? Se studiasse esclusivamente la materia, allora avrebbero ragione gli antichi fisici ionici, che avevano identificato la materia con la natura; ma rileva Aristotele se la tecnica imita la natura, allora si dovrà assumere che la fisica studia sia la forma sa la materia. Infatti, nel campo delle tecniche, l’artigiano che deve produrre un artefatto, deve innanzitutto sapere con precisione cosa fare, ossia deve avere in mente la forma da conferire alla materia; parimenti, il fisico dovrà considerare e la materia e la forma. Ne segue allora che la fisica è la scienza avente per oggetto la natura intesa sia come forma sia come materia. L’acquisizione della forma, infatti, è in ogni processo naturale il τελος cui tende il processo, avviatosi appunto per la realizzazione di un fine coincidente con l’acquisizione della giusta forma. Successivamente Aristotele argomenta che vi sono tecniche “che fanno la materia” (è il caso del vasaio che produce l’argilla con cui fabbrica il vaso) e tecniche “che plasmano la materia” trovandola già esistente (è il caso del fabbro che plasma il bronzo): questa distinzione rivela come le tecniche abbiano sempre e comunque a che fare con la materia, alla quale tentano di conferire una data forma e in ciò risiede il fine del loro operato. Similmente, anche la natura ha sempre a che fare con la materia, anche se, rispetto alla tecnica, presenta una notevole differenza: infatti, se nella tecnica la produzione degli oggetti non è il fine ultimo, il quale invece siamo noi uomini (produciamo infatti sedie, tavoli, carri, ecc in vista del nostro utile), nel caso della natura, viceversa, il fine ultimo è l’acquisizione della forma da parte delle cose che sono per natura. In questa maniera, lo Stagirita ha individuato due diverse nozioni di fine: da un lato, il “fine per sé”, e, dall’altro, il “fine per noi” (coincidente con l’utile); così dicendo, egli fa crollare il mito dell’antropocentrismo greco, secondo cui l’intera attività della natura avverrebbe, al pari di quella tecnica, in vista dell’uomo. Inoltre Aristotele – sulla scia del Platone del Cratilo opera un’altrettanto importante distinzione tra “tecniche di produzione” e “tecniche d’uso”: tecnica di produzione è quella del falegname, il quale, per plasmare il timone, deve sapere che materiale impiegare e quale forma conferirgli; tecnica d’uso è invece quella del timoniere, il quale deve sapere come usare il timone. Pur essendo più sfumata che in Platone, anche in Aristotele è in certa misura presente un’assiologia in forza della quale le tecniche d’uso sono superiori a quelle di produzione, giacchè solo le prime conoscono realmente il fine e la forma dell’oggetto prodotto. Anche in sede etica Aristotele parla di gerarchia dei fini: in particolare, egli nota come le azioni umane tendano sempre a dei fini (al vivere bene, all’onore, ecc), tutti riferiti al fine supremo: la felicità. Dal capitolo secondo del secondo libro della Fisica emerge dunque in maniera definitiva quanti e quali siano gli oggetti studiati dal fisico: egli è chiamato ad occuparsi di sostanze materiali (sinoli di materia e forma) in movimento, sicché la sua indagine spazia dalla terra al cielo. Anche gli astri, infatti, rientrano nel suo campo di investigazione, in quanto sono anch’essi corpi in movimento, ancorché si tratti di un movimento sui generis: se gli oggetti del mondo sublunare si muovono lungo direzioni contrarie (l’alto e il basso) ed è proprio da ciò che nascono i movimenti contrari di generazione e corruzione, gli oggetti del mondo sopralunare, dal canto loro, sono composti di etere, una particolare materia non soggetta a corruzione e tale da spiegare il loro moto circolare. Per render chiaro il campo di indagine del fisico, Aristotele fa ricorso ad un’immagine enigmatica: “l’uomo genera l’uomo e anche il sole”; con ciò, egli intende dire che la generazione dell’uomo è influenzata anche dall’ambiente e, non da ultimo, dagli astri. Addirittura nello studio proprio del fisico rientra anche l’indagine intorno alla salute e alla malattia, come Aristotele rileva nei suoi scritti a carattere biologico: così facendo, egli si oppone a quella tradizione inaugurata da Ippocrate nella Medicina antica, secondo la quale spetterebbe al medico lo studio della natura. Da quanto finora detto, appare chiaro che il fisico di Aristotele deve occuparsi della forma e della materia: ma domandiamoci sono sufficienti queste due cause o occorre trovarne altre? A rispondere a questo interrogativo provvede il capitolo terzo del libro secondo, dedicato alla celebre dottrina delle quattro cause: essa è presentata (seppur cursoriamente) anche nel primo libro della Metafisica, ove lo Stagirita rimanda direttamente alla Fisica. Eppure, anche leggendo la Fisica si ha l’impressione che la dottrina delle quattro cause venga affrontata come se già codificata altrove: si può pertanto supporre che si trattasse di una teoria a lungo discussa oralmente nel Liceo, anche alla luce del fatto che essa, pur con qualche differenza, è presentata da Platone stesso nel suo Filebo. Sorvolando su tali questioni filologiche, passiamo all’esame della dottrina: come Aristotele aveva annunciato nell’incipit dell’opera, si può avere reale conoscenza delle cose solo quando si è in grado di mostrare le cause che le hanno portate ad essere; questa concezione sarà espressa dai Medievali nella formula verum scire est scire per causas. L’esperienza, che nasce dalla reiterazione della sensazione, ci dice solo che (οτι) il fuoco brucia o che i gravi cadono, senza mai spiegarci perché (δια τι) ciò avvenga: non ci fornisce cioè la causa. Per rispondere alla domanda “perché il fuoco brucia?” o “perché i gravi cadono?” occorre individuare le quattro cause, aventi fra loro relazioni specifiche: la prima è la causa materiale, la quale spiega di che cosa è costituito l’oggetto in questione. La seconda è la causa formale, che rende conto della forma assunta dall’oggetto in questione, cogliendone l’essenza, il τι ην ειναι (letteralmente “che cos’era l’essere”: l’imperfetto segnala la permanenza della sostanza). C’è poi la causa efficiente, ovvero ciò ad opera di cui una cosa viene ad essere. Infine, v’è la causa finale, ossia il fine in vista di cui la cosa viene ad essere. Dopo aver presentato le quattro cause e aver chiarito che non sono riducibili le une alle altre, Aristotele rileva che ogni cosa può avere più cause: ad esempio, causa della statua bronzea sono tanto il bronzo quanto lo scultore che l’ha prodotta. Inoltre, egli nota che la causa di una cosa può al contempo essere effetto di un’altra: ad esempio, la fatica è causa (efficiente) dell’irrobustirsi, e l’irrobustirsi è causa (finale) della fatica. Inoltre una causa può dare effetti opposti: così la presenza del nocchiero è causa della salvezza della nave, mentre la sua assenza è causa della distruzione della nave; col che, è reintrodotta a pieno titolo la “privazione della forma”. Aristotele ci tiene poi a precisare i rapporti che legano indissolubilmente tra loro le quattro cause: affinché si realizzi il fine, occorre che vi sia una materia e che acquisisca una data forma; ma, affinché il processo si avvii, occorre che vi sia una causa tale da metterlo in moto: tale è la causa del movimento (detta anche causa efficiente). In questo modo, lo Stagirita si contrappone all’intero mondo greco, che, seppur in maniere diverse, non aveva mai legato tra loro le cause: in particolare, Platone si era ostinato a tenere tra loro disgiunte la materia e la forma, senza accorgersi di quella loro unione resa possibile dalla causa efficiente. A questo punto, Aristotele inizia una discussione molto tecnica e particolareggiata sulle varie cause: in primis, egli distingue tra “cause generali” (ad esempio, l’arte medica) e “cause particolari” (ad esempio, il medico); in secundis, egli distingue tra “cause proprie” (ad esempio, lo scultore) e “cause accidentali”: egli arriva ad individuare un totale di sei diversi tipi di cause: 1) cause particolari (ad esempio, lo scultore); 2) cause secondo il genere (ad esempio, l’arte della scultura); 3) cause accidentali (ad esempio, Policleto: capita che lo scultore sia Policleto); 4) cause accidentali secondo il genere (ad esempio, l’uomo è causa della statua); 5) cause particolari accidentali (ad esempio, l’uomo bianco è causa della statua); 6) cause secondo il genere accidentale secondo il genere (ad esempio, l’essere mortale è causa della statua). Naturalmente, tutte queste cause possono essere sia in potenza sia in atto, cosicché da sei diventano dodici. Con tale partizione delle cause, lo Stagirita ha introdotto il tema dell’accidentalità, mostrando come sia accidentale, ad esempio, il fatto che lo scultore sia Policleto oppure un uomo bianco. E al tema dell’accidentalità sono dedicati i capitoli che vanno dal quarto al settimo. Per parlare di accidentalità, egli impiega due termini distinti e dotati di significati diversi: τυχη ε αυτοματον. “Tuche” è la casualità che riguarda il mondo dell’agire umano, mentre “automaton” è il regno della casualità in generale e, nella fattispecie, delle cose inanimate. Ma quando si può dire che un avvenimento si verifica per “tuche”? L’esempio addotto da Aristotele è assai chiaro: supponiamo che un tale si rechi in piazza per fare una passeggiata e che, inaspettatamente, si imbatta in un tizio da cui deve riscuotere un debito; ciò avviene appunto per “tuche”. Per capire che cosa siano invece gli avvenimenti per “automaton”, supponiamo che da una finestra precipiti una pietra e che colpisca un passante ferendolo; naturalmente la pietra non aveva alcuna intenzionalità (a differenza del creditore dell’esempio di poc’anzi), è precipitata indipendentemente da scelte o da deliberazioni. Dopo aver introdotto le nozioni di τύχη ε αυτοματον, Aristotele si chiede se essi debbano o meno essere inseriti nel novero delle cause: sono davvero due cause? E, in caso positivo, sono riducibili fra loro? Che cosa sono realmente? Per rispondere a questi interrogativi, Aristotele parte ancora una volta dalle indagini condotte dai suoi predecessori, riconoscendo essenzialmente tre posizioni: 1) v’è chi nega la realtà della tuche e dell’automaton, asserendo che la causa degli eventi è sempre determinata in maniera necessaria; secondo i sostenitori di questa posizione (da identificarsi presumibilmente in Anassagora, Empedocle e, forse, Leucippo), molte cose che avvengono per necessità sfuggono alla nostra conoscenza, cosicchè noi, per ignoranza, diciamo che sono avvenute per caso. Ma costoro – obietta Aristotele – hanno indubbiamente peccato di leggerezza, giacchè sono andati contro l’evidenza, la quale attesta che molte cose si verificano per caso; inoltre, essi sono stati incoerenti, perché, pur negando che il caso sia una realtà, finiscono di fatto per ammettere cause fortuite (è questo il caso di Empedocle, il quale sostiene che nulla avviene a caso e che poi, contraddicendosi, ammette che l’aria possa ora star qui, ora li, senza cause necessarie). 2) C’è poi chi asserisce che nel mondo sublunare nulla avviene a caso ma al contempo ammette che il cielo e gli infiniti mondi siano frutto del caso: tale era la posizione sostenuta da Democrito, ad avviso del quale il mondo nascerebbe dall’aggregazione casuale degli atomi. Aristotele bolla come assurda questa posizione: “questa teoria, oltre ad essere assurda anche per altre ragioni, è ancora più assurda perché noi osserviamo che nel cielo nulla avviene per caso, mentre nelle cose che, secondo loro, non avvengono fortuitamente, molte ne capitano accidentalmente per fortuna” (196 b); infatti, nella prospettiva dello Stagirita, il caso è ammissibile nel mondo sublunare, ove la forma incontra l’ostacolo frapposto dalla materia, ma non nel mondo sovralunare, ove tutto avviene in maniera necessaria e rigorosa. 3) L’ultima posizione è quella di quanti sostengono che tuche e automaton sono sì cause, ma in conoscibili alla mente umana e demoniche. Aristotele intrattiene un atteggiamento dialettico verso queste tre diverse posizioni: contro i negatori della casualità, egli mostra che tuche e automaton sono cause; contro Democrito, egli mostra che hanno senso solo se riferite al mondo sublunare; contro chi qualifica tuche e automaton come forze demoniche, Aristotele mette in luce come esse siano sì inconoscibili, ma non per ciò tali da rimandare ad un’entità sovrannaturale e demonica. Il capitolo quinto è interamente dedicato alla τυχη: essa è causa di eventi che non sono né necessari né usuali, bensì rari, tali da verificarsi una tantum. Ma dire che si verificano sporadicamente non significa negare ch’essi abbiano una causa: anzi, si può addirittura sostenere che, al pari di tutti gli altri eventi, anche quelli per tuche si verificano in vista di un fine oppure no; in particolare, capita che si producano per accidente eventi che, solitamente, si producono in vista di un determinato fine. Tale è il caso del creditore che si reca in piazza per fare una passeggiata ma che, inaspettatamente, incontra il suo debitore: si verifica per accidente ciò che solitamente avviene intenzionalmente in vista di un fine, giacchè di solito il creditore si reca in piazza di sua libera iniziativa al fine di riscuotere il credito. Aristotele rileva poi che le cause di un evento casuale possono essere indeterminate nel numero: ciò ha portato taluni a credere che il caso sia indeterminato e imperscrutabile per la mente umana. Inoltre, riconoscere l’esistenza dell’accidentalità conforta Aristotele nella sua convinzione che in natura non tutti i fini si realizzino sempre e necessariamente: ciò vale tanto nell’ambito della φυσις quanto in quello delle πραξεις umane, cosicché fisica ed etica riguardano parimenti l’ambito di ciò che può accadere. In realtà, propriamente tuche e automaton non sono causa di nulla, poiché l’evento occasionato ha sempre una sua causa propria: ciò però non toglie che il caso esista, a patto che distinguiamo – sulle orme del capitolo terzo tra “cause proprie” e “cause accidentali”; così, causa propria della casa è il costruttore, ma può capitare accidentalmente che a costruirla sia un musico. Del resto l’indeterminatezza propria del caso fa pensare che esso sia imperscrutabile e inaccessibile alla mente umana: e ciò a ragion veduta, nota Aristotele, poiché il caso non si verifica né sempre né per lo più, ma “talvolta” (ποτε), sicché esso è irrazionale (giacchè ciò che non è né sempre né per lo più non può essere afferrato dalla ragione). Come notava nel capitolo quarto, il fatto che il caso sia imponderabile e indeterminato (benché prodotto da una causa) ha indotto alcuni a ritenere che esso sia indeterminatezza in senso assoluto, il che è in parte vero: il caso è sì indeterminatezza (“la fortuna è incostante” si usa dire), ma non in senso assoluto, dal momento che anche tra le cause accidentali alcune sono più prossime all’oggetto, altre più lontane da esso. Negare il caso, del resto, equivale a negare l’evidenza dei fatti: tutti noi, infatti, parliamo di sfortuna (ατυχια), di buona fortuna (ευτυχια) e di mala fortuna (δυστυχια) a seconda degli eventi che ci capitano; essi a noi paiono avvenire per cause fortuite, mentre in realtà accadono sempre e comunque in vista di un fine, il quale è estrinseco e improprio rispetto a quello usuale. Così noi siamo soliti dire che chi trova un tesoro è fortunato, quando in realtà ciò non è che il risultato di un’attività specifica (lo scavare). E’ interessante rilevare come, nell’Etica a Eudemo, Aristotele citi il caso di Priamo, ovvero dell’uomo virtuosissimo ma sfortunato: ciò ad indicare come la virtù, da sola, non sia sufficiente a garantire la felicità, che deve essere sempre accompagnata da ευτυχια. Il fatto che la fortuna e la sfortuna esistano è d’altro canto avvalorato dai rovesci di fortuna che tutti quanti sperimentiamo. Il capitolo sesto distingue meglio tra tuche e automaton: la prima riguarda le azioni che dipende dall’uomo compiere o meno; il secondo, invece, coincide con la casualità lato sensu, in particolare con quella degli enti non equipaggiati di ragione. Interessante è il collegamento instaurato da Aristotele tra ευτυχια ε ευδαιμονία (felicità): l’uomo conquista la felicità a caro prezzo, acquisendo preventivamente la virtù, la capacità di pensare e di godere dei beni procacciati dalla fortuna (essere sani anziché malati, ricchi anziché poveri, e così via). Poi egli nota che gli eventi per tuche sono ricompresi nel più ampio campo dell’automaton: si tratta di un campo più vasto perché riguardante enti che non paiono agire per deliberazione, ossia che non possono perseguire intenzionalmente i loro fini. In tal senso, l’automaton riguarda gli enti di natura e gli esseri privi di ragione (ad esempio i bambini) e può essere definito come “ciò che si produce spontaneamente”. Ciò non toglie che anche gli eventi per automaton avvengano in vista di un ben preciso fine. Ciò detto, lo Stagirita rileva che gli eventi per automaton accadono “invano” (ματην), quasi come se egli volesse stabilire un’analogia etimologica tra αυτοματον ε ματην. Per spiegare questo punto, egli adduce un esempio: supponiamo che un tale esca a fare una passeggiata per avere la salute e che, passeggiando, si verifichi un’eclissi solare: egli non passeggiava affinchè si verificasse l’eclissi, ma ciononostante capita che essa si realizzi; noi diciamo che è intervenuto il caso. Similmente, la pietra cade non già per ferire il passante, bensì perché è pesante. Sembra che l’eclissi solare e il ferire siano i fini (giacchè interferiscono col vero fine), cosicché si può dire che i fini reali (ad esempio la salute) siano invano. Occorre a questo punto domandarsi dove si collochi l’automaton nella sfera delle categorie della natura: Aristotele distingue tra ciò che avviene secondo natura (κατα φυσιν) e ciò che avviene contro natura (παρα φυσιν). Infatti, vi sono eventi che si realizzano compiendo il fine al quale tendeva la natura (e il fine della natura è sempre l’acquisizione della giusta forma), ma, accanto ad essi, ve ne sono altri (assai rari) che si realizzano contrariamente a come natura richiede (ad esempio, la generazione dei mostri). Se la materia, nella sua indeterminatezza, si lascia vincere dalla forma, allora il processo avviene secondo natura; ma se la materia oppone resistenza ed è recalcitrante, allora il processo avviene contro natura. Da quanto detto, risulta chiaro come tuche e automaton siano cause secondarie, posticce e inferiori: in altri termini, il caso è il volto oscuro della finalità. Nel capitolo settimo, Aristotele torna ancora una volta a precisare quale sia il campo di indagine del fisico: questi deve studiare le quattro cause, poiché esse forniscono una spiegazione scientifica del reale. Ciò detto, lo Stagirita si dilunga nel resto del capitolo a fare alcune importanti precisazioni: innanzitutto, egli mostra come talvolta la causa motrice, quella formale e quella finale coincidano; così dicendo, egli nobilita la causa motrice, la quale avvia il processo. Egli nota poi come si possa parlare πολλαχώς di “causa efficiente prima”: ci può infatti essere una causa motrice a sua volta mossa (tale è il seme che è causa della generazione) e, accanto ad essa, una causa motrice immobile (tale è il “motore immobile”, che muove senza essere mosso). Allo studio del motore immobile sono dedicati il libro VIII della Fisica e, con notevoli differenze, il libro XII della Metafisica: nel mondo sublunare constatiamo che ogni cosa è a sua volta mossa da altre cose, a loro mosse da altre; affinché il processo non vada all’infinito (αναγκη στηναι, “bisogna fermarsi”), occorre ammettere un “motore immobile”, ovvero un qualcosa che muova senza a sua volta essere mosso. E ciò che muove senza essere mosso non è propriamente oggetto d’indagine della fisica, la quale come abbiamo visto – si occupa di corpi in movimento (sia corruttibili sia incorruttibili); spetta invece alla “filosofia prima” e alla matematica proiettare la loro indagine su ciò che non si muove. Il motore immobile – dice qui Aristotele – è πρωτον παντων: ora, dobbiamo intendere che esso è “primo di tutte le cose” oppure dobbiamo intendere che esso è “primo di tutti [i motori]”? Nel primo caso, attribuiamo ad Aristotele la tesi secondo cui tutto si muove in vista del motore immobile; ma lo stesso Aristotele ci dice altrove (nel De caelo) che a muoversi direttamente in vista del motore immobile è solamente il “primo mobile”, cioè il cielo delle stelle fisse. E’ dunque preferibile la seconda chiave interpretativa, quella secondo cui il motore immobile è “primo di tutti i motori”: in questo senso, ammettiamo l’esistenza di un primo motore immobile rispetto alla serie di tutti gli altri motori. In quanto immobile, esso non avrà materia – la quale è causa di mutamento e, di conseguenza, non avrà potenza: sarà allora “atto puro” e muoverà il “primo mobile” come causa finale, proprio come l’amato muove l’amante. Il capitolo ottavo giustifica in maniera dialettica la posizione teleologica sposata da Aristotele. Egli introduce il tema intavolando le possibili obiezioni degli avversari: è davvero necessaria, per spiegare la natura, l’introduzione di una causa finale? Ci si para dinanzi, in questa maniera, un’απορια, ovvero letteralmente una strada senza via d’uscita: Aristotele prima la espone, poi spiega perché essa non è sostenibile e, infine, illustra le ragioni per cui è necessario introdurre la causa finale nello studio della natura. E del resto nel libro III della Metafisica egli aveva tracciato una vera e propria metodologia per trattare le aporie: bisogna innanzitutto formulare l’aporia (απορειν), poi analizzarla criticamente (διαπορειν), infine risolverla (ευπορειν). L’aporia in questione può così essere formulata: “che cosa vieta che la natura agisca senza alcun fine e non in vista del meglio, bensì come piove Zeus, non per far crescere il frumento, ma per necessità?” (198 b). Forse questo problema era stato sollevato nel Liceo, nel corso delle lezioni, da qualche allievo di Aristotele, ma non è sicuro: certo è che questo negatore del finalismo sta anticipando le critiche che verranno mosse alla teleologia da Lucrezio e da Spinosa. Sicuramente curiosa è l’espressione “Zeus piove”, che compare nella formulazione dell’aporia: perché mai un meccanicista dovrebbe servirsi di una tale espressione? Il suo scopo polemico è in realtà fin troppo evidente: egli vuole contrapporsi a quei provvidenzialisti secondo cui tutto (perfino la crescita del frumento) avviene in virtù di un intervento divino; questa teleologia antropocentrica, secondo cui il grano cresce per intervento divino e in vista dell’uomo, è quella che Senofonte, nei suoi scritti, attribuisce a Socrate, e non è senz’altro un caso che in tali scritti l’espressione “Zeus piove” ricorra spesso. Ci troviamo dunque di fronte a due schieramenti fra loro contrapposti: come nel Sofista platonico si fronteggiavano i materialisti e gli “amici delle idee”, qui si fronteggiano i sostenitori del finalismo provvidenzialistico e i meccanicisti estremi. A tutta prima, paiono aver ragione i meccanicisti: come possono infatti i provvidenzialisti spiegare il fatto che talvolta quel frumento che, a loro avviso, Zeus fa crescere in vista dell’uomo, marcisca sull’aia e intere famiglie vadano in rovina? Per i meccanicisti tanto il fatto che il grano cresca quanto il fatto che esso marcisca sull’aja è spiegabile nei termini della necessità: la pioggia precinita ogni qual volta accade che l’aria calda si sollevi in alto e si raffreddi, trasformandosi così in acqua e facendo ora crescere, ora marcire il grano. Aristotele non intende negare la posizione meccanicista: egli è anzi convinto dell’esistenza di una necessità in natura e, non a caso, egli propone (nei Meteorologici) una spiegazione della pioggia uguale a quella dei meccanicisti, senza introdurre alcuna causa finale. Nella Fisica, tuttavia, egli non si accontenta della spiegazione meccanicistica – che pure non dev’essere rigettata e introduce la causa finale. I meccanicisti, per argomentare in difesa della loro posizione, adducono oltre a quello della pioggia un altro esempio interessante, desunto dal microcosmo: poiché accade che i denti abbiano una data forma, allora è possibile esercitare con essi la funzione del masticare; secondo tale interpretazione, sarebbe la materia a determinare l’insorgere della funzione, e non viceversa. Ora, negli scritti biologici Aristotele capovolge questa posizione e arriva a sostenere che, in forza del fatto che i denti debbono svolgere la funzione del masticare, allora accade che abbiano tale forma, adatta a svolgere la funzione. In questo quadro rientra anche la nota polemica con Anassagora, secondo cui l’uomo sarebbe il più intelligente tra gli animali perché dotato delle mani: per Aristotele, viceversa, l’uomo è dotato delle mani perché è il più intelligente degli animali. I meccanicisti citano poi come loro illustre antecedente Empedocle di Agrigento, che aveva parlato di “buoi dalla faccia umana”: a suo avviso, prima di assumere le forme attuali, gli animali avevano forme mostruose poiché le loro parti si generavano separatamente le une dalle altre e, una volta formatesi, si univano casualmente; solo gli animali che assumevano la forma più adatta alla sopravvivenza restavano in vita e, in questo modo, i buoi dal volto umano sono scomparsi. Naturalmente Aristotele non può accettare una siffatta posizione e non esita ad attaccare Empedocle, rinfacciandogli di non aver capito che la generazione parte dal seme paterno ed è un processo di differenziazione dall’indistinto. Crollato l’esempio dei buoi col volto umano, Aristotele deve comunque fronteggiare gli altri esempi per far salva la causa finale nel regno della φυσις: egli nota come tanto l’esperienza quanto il ragionamento depongano a suo favore. Ancora una volta, egli ricorre all’analogia con le tecniche: come con la tecnica, così anche in natura tutto avviene sempre o per lo più, cosicché in senso propria nulla avviene a caso; capita infatti che per lo più piova d’inverno, ma ciò non di meno può capitare che si metta a piovere nella calura estiva. Sicchè se ne evince che le cose che avvengono in natura saranno o per caso o per finalità: ma dal momento che abbiamo scartato il caso, si dovrà riconoscere che in natura tutto avviene in maniera finalistica. E del resto argomenta Aristotele se il processo avviene per gradi ed è casuale, come mai si verifica sempre con gli stessi passaggi, seguendo la stessa scansione? Tecnica e natura procedono analogamente: in ambo i casi, la generazione richiede un processo ben finalizzato. Tuttavia, se è evidente che le tecniche agiscono in vista di un fine (si costruisce la casa al fine di dare riparo alla gente), ciò è meno evidente per il regno della natura: ma a tal proposito Aristotele dice che se, per assurdo, una casa si generasse non per tecnica, ma per natura, ciò non di meno essa verrebbe ad essere tale e quale a come viene ad essere adesso per tecnica. Fin qui Aristotele ha provato la finalità della natura servendosi del ragionamento; ora egli provvede ad addurre anche esempi concreti e, in veste di eccezionale biologo, può addurne a volontà: la finalità della natura appare evidente se soffermiamo la nostra attenzione su tutti quegli animali che, pur sprovvisti di ragione, compiono operazioni assai complesse e ben finalizzate, come il ragno che tesse la tela o la formica che accumula il cibo. Questi animali agiscono in vista di ben determinati fini e non già in forza dell’intelligenza o della deliberazione, bensì in virtù della natura stessa, che mira sempre ad un fine. Perfino nelle piante si riscontra il finalismo: le foglie sono finalizzate a proteggere il frutto, le radici invece a nutrirle; addirittura, negli scritti biologici, Aristotele asserisce che le radici delle piante svolgono la stessa mansione della testa degli uomini, cosicché le piante sono come degli uomini a testa in giù. Dire che la natura procede sempre in vista di un fine non vuol dire riconoscere che tale fine sempre si realizzi: come nell’ambito delle tecniche capita che il medico sbagli a prescrivere il farmaco o capita che il grammatico sbagli a scrivere una parola, così talvolta anche la natura commette errori (αμαρτηματα) e non riesce a raggiungere il fine. In certo senso, l’attività della natura può essere accostata al tiro al bersaglio: mira sempre a colpire il bersaglio, ma non sempre vi riesce, in particolare quando la materia oppone resistenza. Per meglio esplicitare questo punto, Aristotele recupera l’esempio dei buoi dal volto umano: la generazione – egli nota – può talvolta procedere non dal simile (“uomo genera uomo”) ma dal dissimile (dal bue nasce un bue col volto umano), e ciò in forza del fatto che il seme può corrompersi. Ad ogni livello della natura è riscontrabile il finalismo: esso però appare più che mai evidente nell’uomo, che, oltre a vivere (ζην), può vivere bene (ευζην), perché dotato di intelligenza. Un eventuale obiettore potrebbe argomentare che, non essendo un’attività deliberativa, la natura non è orientata ad alcun fine: Aristotele risponde asserendo che neppure la tecnica è deliberativa; essa è, invece, costruttiva (la deliberazione vale nell’etica), tant’è che la costruzione di navi è finalizzata a produrre navi e non a deliberare. Similmente agisce la natura, la quale assomiglia a “un uomo che medica se stesso” (199 b): con ciò Aristotele intende dire che la natura è in grado, con le sole proprie forze, di riparare ai propri errori, senza per ciò essere intelligente o deliberativa. Nel De partibus animalium, lo Stagirita adduce in merito un esempio particolarmente chiarificante: la natura ha prodotto nell’uomo l’epiglottide per riparare ad un errore commesso; infatti, l’epiglottide altro non è se non un coperchio che impedisce che, quando si beve, i liquidi imbocchino una via sbagliata. Il capitolo nono, con cui si chiudono il secondo libro e la nostra trattazione, affronta ancora il tema della necessità della natura, alla luce della finalità riconosciuta come elemento essenziale della φυσις. ΙΙ capitolo nove, con cui si chiude il secondo libro, affronta in via definitiva il problema della necessità in natura: la necessità esiste “per ipotesi” o “in assoluto”? Alla luce del fatto che i predecessori (Democrito in primis) hanno individuato nella necessità una causa imprescindibile, occorre ora stabilire se essa esista in natura in maniera totalmente incondizionata (ossia in senso assoluto) oppure in maniera condizionale (ossia per ipotesi). Aristotele non ha alcun dubbio sul fatto che, in natura, la necessità debba essere identificata con la natura: ma tale necessità si chiede Aristotele esiste in maniera incondizionata oppure condizionata? Se fosse vero il primo caso, allora avrebbe ragione Democrito ad ammettere in natura il meccanicismo assoluto, senza margini di libertà: in tal caso, il muro che abbiamo di fronte si spiega sulla base degli elementi di cui consta, ovvero viene ad essere quale è perché i corpi pesanti si distribuiscono verso il basso, cosicché il legno sta in alto in quanto leggero, mentre le pietre si dispongono in basso in quanto pesanti. Il meccanicismo materialistico, nella sua veste democritea, è qui il grande nemico dello Stagirita: è vero – egli rileva – che il muro non può venire ad essere senza pietre e legno (ossia non può essere senza la materia), ma ciò non toglie che esso venga ad essere in vista di fornire un riparo alla gente (ossia in vista di un ben preciso fine). In questo senso, egli, ricorrendo ancora una volta ad esempi desunti dal mondo delle tecniche, sostiene che il muro non può venire ad essere senza materia, ma neanche senza una causa finale: sicchè, indagando sul perché il muro sia venuto ad essere, dobbiamo indicarne il τελος. Non è infatti sufficiente rispondere, a chi ci chiede “perché c’è il muro?”, asserendo che esso c’è perché vi sono pietre e legno: bisogna anche rispondere che esso c’è al fine di dar riparo, esibendo in tal maniera la causa finale. Perché possa realizzare il suo scopo – cioè dar riparo, occorre inoltre che il muro abbia la materia adatta e,a 1 contempo, la giusta forma (ad esempio, la casa, per riparare, deve avere il tetto in alto e le fondamenta in basso). Da tutto ciò segue che non è la materia a spiegare il perché del muro, ma è il perché del muro (ossia il fine) a render conto della materia impiegata: infatti, se il muro deve dar riparo, allora occorre che abbia pietre e legno. In altri termini, la materia, qualora non si conosca il fine del muro, non ha alcun senso. Ciò vale anche e a maggior ragione nel caso dell’uomo, nel quale la materia deve essere tale per cui si possa raggiungere il fine per cui l’uomo stesso è venuto ad essere. Tale fine coincide secondo Aristotele col pensiero: l’uomo è venuto ad essere per pensare e dunque, affinché ciò si realizzi, occorre che abbia la stazione eretta e la testa separata dal resto del corpo. In questo modo, la necessità della materia è riscattata dalla finalità: e il fine, all’interno della sequenza, si realizza sempre per ultimo (non a caso il termine τελος indica tanto il fine quanto la fine), ma in realtà è, in senso logico, ciò che viene prima di ogni altra cosa (il muro nasce al fine di riparare). Sulla base di ciò, lo Stagirita può rispondere alla domanda con cui si apriva il capitolo: la necessità della materia e, dunque, della natura è una necessità ipotetica. È vero che la presenza della materia condiziona il realizzarsi del fine (il quale può non realizzarsi se la materia pone ostacoli), ma è altrettanto vero che è il fine a giustificare la presenza della materia, e non viceversa (se il muro deve riparare, allora dovrà esser fatto di pietre e legno). Ciò vale per ogni cosa e Aristotele adduce un esempio che gli è caro, poiché ritorna più volte nei suoi scritti: la sega è quel che è perché deve segare e dunque, per poter soddisfare quel fine, deve essere di ferro e di forma sagomata. Sicchè l’elemento di necessità risiede nella materia, mentre l’elemento di finalità nella forma finale, secondo la formula “se x, allora y” (ad esempio, se la sega serve a segare, allora deve essere di ferro, altrimenti il fine non si realizza). Naturalmente, affinché la materia acquisisca la forma, occorre una causa efficiente che avvii il processo. Aristotele ha dunque trovato un modo per condizionare il necessario: la necessità resta sì imprescindibile (giacché la natura è anche materia), ma è condizionata dal fine, nel senso che da esso dipende. Sorge però una difficoltà nella comprensione del testo, in forza del fatto che lo stile aristotelico è spesso troppo denso e stringato: egli si propone di instaurare un accostamento tra la necessità di natura e quella della matematica (tutto il secondo libro è percorso da costanti paragoni con l’ambito della matematica), al fine di escludere ogni possibile interpretazione matematizzante del mondo (in conflitto col Timeo platonico). Lo Stagirita muove infatti dalla convinzione che l’esattezza della matematica sia impossibile nell’ambito della fisica, giacchè qui vi è la materia con la sua indeterminatezza: pertanto, anche nella fisica c’è il rapporto causa/effetto, ma è indebolito dalla presenza della materia. Anche la matematica presenta la necessità: ad esempio, “poiché la linea retta è tale, allora il triangolo avrà necessariamente la somma degli angoli interni pari a due angoli retti”. La grande differenza sta però nel fatto che, nel caso della fisica, il fine viene prima (in senso logico), mentre in matematica il fine viene dopo (alla fine della dimostrazione). Ben emerge qui la concezione aristotelica della materia come “strumento” (οργανov) in vista della realizzazione del fine: significativo è, a tal proposito, il passo del De anima in cui lo Stagirita definisce il corpo come “strumento dell’anima”. Anche nell’ambito delle “azioni” umane (πραξεις), ossia nell’ambito dell’etica, v’è un principio da cui discendono le conseguenze; tale principio coincide con la “deliberazione” (προαιρησις) a compiere una data azione; e tuttavia l’etica è il regno non già del necessario (ancorché in forma indebolita, come è nella fisica), bensì del possibile: l’azione derivante dal principio dipende da me, cosicché è possibile. Nella natura, invece, manca ogni forma di deliberazione, altrimenti ci troveremmo costretti ad ammettere che la natura è intelligente: dalla mancanza di deliberazione, qualcuno potrebbe inferire che la natura non opera in visti di fini; ma Aristotele esclude questa eventualità ricorrendo ad un’efficace analogia con le tecniche. Anch’esse, infatti, producono, ma non deliberano: e, ciò non di meno, nessuno si sognerebbe mai di sostenere che il letto o la casa sono nati senza alcuna finalità. Il capitolo si chiude con un rilievo alquanto interessante: le cose di natura e di tecnica si portano al materia anche nella definizione; se deve tagliare, la sega dovrà essere fatta di ferro e avere forma sagomata, cosicché, quando dovrò definire la sega, non potrò che dire che essa è fatta di ferro.
RIFLESSIONI DI ARISTOTELE
Gli uomini hanno cominciato a filosofare, ora come in origine, a causa della meraviglia: mentre da principio restavano meravigliati di fronte alle difficoltà più semplici, in seguito, progredendo a poco a poco, giunsero a porsi problemi sempre maggiori: per esempio i problemi riguardanti i fenomeni della luna e quelli del sole e degli altri astri, o i problemi riguardanti la generazione dell’intero universo. Ora, chi prova un senso di dubbio e di meraviglia riconosce di non sapere; ed è per questo che anche colui che ama il mito è, in certo qual modo, filosofo: il mito, infatti, è costituito da un insieme di cose che destano meraviglia. Cosicchè, se gli uomini hanno filosofato per liberarsi dall’ignoranza, è evidente che ricercano il conoscere solo al fine di sapere e non per conseguire qualche utilità pratica. E il modo stesso in cui si sono svolti i fatti lo dimostra: quando già c’era pressochè tutto ciò che necessitava alla vita ed anche all’agiatezza ed al benessere, allora si incominciò a ricercare questa forma di conoscenza. E’ evidente, dunque, che noi non la ricerchiamo per nessun vantaggio che sia estraneo ad essa; e, anzi, è evidente che, come diciamo uomo libero colui che è fine a se stesso e non è asservito ad altri, così questa sola, tra tutte le altre scienze, la diciamo libera: essa sola, infatti, è fine a se stessa. (Aristotele, Metafisica I,2,982b)
La filosofia non serve a nulla,dirai;ma sappi che proprio perchè priva del legame di servitù é il sapere più nobile.
Verum scire est scire per causas .
Lo scopo del lavoro è quello di guadagnarsi il tempo libero.
La bellezza è la miglior lettera di raccomandazione per una donna.
Amicus Plato, sed magis amica veritas.
Se c’e’ soluzione perché ti preoccupi? Se non c’é soluzione perché ti preoccupi?
La speranza é un sogno ad occhi aperti .
Primum vivere, deinde philosophari.
Se per amore del denaro si viaggia fino alle colonne d’Eracle e ci si espone a molti rischi, perchè non si dovrebbe affrontare qualche fatica e qualche spesa per la filosofia?
Se si deve filosofare, si deve filosofare e se non si deve filosofare, si deve filosofare; in ogni caso dunque si deve filosofare. Se infatti la filosofia esiste, siamo certamente tenuti a filosofare, dal momento che essa esiste; se invece non esiste, anche in questo caso siamo tenuti a cercare come mai la filosofia non esiste, e cercando facciamo filosofia, dal momento che la ricerca è la causa e l’origine della filosofia.
Sedendo et quiescendo efficitur sapiens .
La natura non fa nulla invano.
Non bisogna dar retta a coloro che consigliano all’uomo, perchè è mortale, di limitarsi a pensare cose umane e mortali; anzi, al contrario, per quanto è possibile, bisogna comportarsi da immortali, e fare di tutto per vivere secondo la parte più nobile che è in noi.
Privato della percezione e dell’intelligenza, l’uomo diventa simile ad una pianta; se gli si sottrae l’intelligenza soltanto, si trasforma in un animale; se è liberato, invece, dall’irrazionale, ma persiste nell’intelletto, diventa simile a dio. (Protreptico)
Chiunque può arrabbiarsi: questo è facile. Ma arrabbiarsi con la persona giusta, e nel grado giusto, ed al momento giusto, e per lo scopo giusto, e nel modo giusto: questo non è nelle possibilità di chiunque e non è facile.
Cos’è un amico? Una singola anima che vive in due corpi.
Coloro che si dedicano alla filosofia non ne hanno dagli uomini una ricompensa che li possa spronare a tali sforzi.
Chi si accinge a diventare un buon capo, deve prima essere stato sotto un capo.
Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendolo.
Il filosofo soltanto vive mirando costantemente alla natura ed al divino. Come il buon capitano di una nave, egli ormeggia la sua vita a ciò che è eterno e costante, là getta l’ancora e vive padrone di sè.
La conoscenza e il pensiero filosofico costituiscono dunque il compito proprio dell’anima. Questa è la cosa più desiderabile per noi, paragonabile, io credo alla vista, che certamente si apprezzerebbe anche nel caso in cui grazie ad essa non si ottenesse altro risultato se non appunto e soltanto il vedere.
Dio è troppo perfetto per poter pensare ad altro che a se stesso.
È nella natura del desiderio di non poter essere soddisfatto.
Esercitare liberamente il proprio ingegno, ecco la vera felicità.
Gli uomini colti sono superiori agli incolti nella stessa misura in cui i vivi sono superiori ai morti.
Il saggio cerca di raggiungere l’assenza di dolore, non il piacere.
In tutte le cose della natura esiste qualcosa di meraviglioso.
La comunità politica migliore è formata da cittadini della classe media.
La cultura è il miglior viatico per la vecchiaia.
La libertà è la base di uno stato democratico.
L’attività filosofica ha un grande vantaggio rispetto a tutte le altre; non si ha cioè bisogno di un particolare strumento, nè di una sede particolare per esercitarla, ma in qualunque punto della terra uno si ponga all’opera con il pensiero, dovunque gli sarà allo stesso modo possibile afferrare la verità, come se essa fosse presente. Così dunque è provato che è possibile dedicarsi alla filosofia, che essa è il maggiore di tutti i beni, e che è facile conseguirla. Per tutti questi motivi, vale la pena di coltivarla con passione.
Le radici della cultura sono amare, ma i frutti sono dolci.
L’uomo è per natura animale politico.
Tutte le altre scienze saranno più necessarie di questa (della metafisica), ma nessuna sarà superiore. (Metafisica, I,2,982b)
Non esiste grande genio senza una dose di follia.
Tutti gli uomini, per natura, aspirano alla conoscenza.
Siamo tutti portati a dirigere la nostra ricerca non in relazione all’argomento in sè, ma piuttosto in relazione alle opinioni dei nostri antagonisti; e anche quando interroghiamo noi stessi portiamo l’indagine solo fino al punto in cui non intravediamo più obiezioni.
I vecchi sono due volte bambini.
Non dobbiamo perciò preoccuparci se la filosofia non si dimostra utile o vantaggiosa perchè non affermiamo innanzi tutto che sia vantaggiosa, ma piuttosto che è buona, e che la si debba scegliere non per qualcos’altro, ma per se stessa.
L’IMITAZIONE NEI GENERI LETTERARI
Si può difatti, impiegando i medesimi mezzi e i medesimi oggetti, farsi a volte imitatore in maniera espositiva, sia divenendo un poco un’altra persona come fa Omero, sia restando sé stesso senza cambiare; e altre volte invece si possono presentare tutti in azione e all’opera quelli che fanno l’imitazione. Dunque l’imitazione, come dicemmo nelle premesse, si realizza con queste tre differenze, che consistono nei mezzi e negli oggetti e nella maniera. Quindi Sòfocle, sotto certo aspetto, è imitatore identico ad Omero, perché entrambi raffigurano uomini egregi, e sotto altro aspetto è identico ad Aristòfane, perché entrambi raffigurano persone che agiscono drammaticamente. Di qui appunto si dice che deriva il nome di dramma, perché è un’imitazione in forma drammatica. (Dell’arte poetica)
LA DEMOCRAZIA
Il presupposto della costituzione democratica è la libertà, tanto che si dice che solo con questa costituzione è possibile godere della libertà, che si afferma essere il fine di ogni democrazia. Una delle caratteristiche della libertà è che le stesse persone in parte siano comandate e in parte comandino. […]Questi dunque sono i caratteri comuni a tutte le democrazie, e da quella che unanimemente si concorda essere la giustizia secondo i canoni democratici (cioè che tutti abbiano lo stesso secondo il numero) deriva quella che più di ogni altra sembra essere democrazia e governo di popolo. L’uguaglianza consiste nel fatto che non comandino più i poveri dei ricchi, che non siano sovrani i primi soltanto, ma tutti secondo rapporti numerici di uguaglianza. E questo sarebbe l’unico modo per ritenere realizzate l’uguaglianza e la libertà nella costituzione. (Aristotele, Politica)
ZENONE E IL MOVIMENTO
Tutto ciò, dice, che è lungo uno spazio uguale a sé o è in quiete o si muove: ma è impossibile che si muova lungo uno spazio uguale a sé: dunque è in quiete. Ora, la freccia che si muove, siccome si trova lungo uno spazio uguale a sé in ciascuno degli spazi di tempo durante i quali si muove, sarà in quiete; se è in quiete in tutti gli istanti di tempo che sono infiniti, sarà in quiete anche in tutto il tempo. Ma si era posto che essa fosse in movimento: dunque la freccia in movimento sarà in quiete.
L’AMICIZIA
L’amicizia è una virtù o s’accompagna alla virtù; inoltre essa è cosa necessarissima per la vita. Infatti nessuno sceglierebbe di vivere senza amici, anche se avesse tutti gli altri beni (e infatti sembra che proprio i ricchi e coloro che posseggono cariche e poteri abbiano soprattutto bisogno di amici; infatti quale utilità vi è in questa prosperità, se è tolta la possibilità di beneficare, la quale sorge ed è lodata soprattutto verso gli amici? O come essa potrebbe esser salvaguardata e conservata senza amici? Infatti quanto più essa è grande, tanto più è malsicura). E si ritiene che gli amici siano il solo rifugio nella povertà e nelle altre disgrazie; e ai giovani l’amicizia è d’aiuto per non errare, ai vecchi per assistenza e per la loro insufficienza ad agire a causa della loro debolezza, a quelli che sono nel pieno delle forze per le belle azioni. […] Tre dunque sono le specie di amicizie, come tre sono le specie di qualità suscettibili d’amicizia: e a ciascuna di esse corrisponde un ricambio di amicizia non nascosto. E coloro che si amano reciprocamente si vogliono reciprocamente del bene, riguardo a ciò per cui si amano. Quelli dunque che si amano reciprocamente a causa dell’utile non si amano per se stessi, bensì in quanto deriva loro reciprocamente un qualche bene; similmente anche quelli che si amano a causa del piacere. (…)L’amicizia perfetta è quella dei buoni e dei simili nella virtù. Costoro infatti si vogliono bene reciprocamente in quanto sono buoni, e sono buoni di per sé; e coloro che vogliono bene agli amici proprio per gli amici stessi sono gli autentici amici (infatti essi sono tali di per se stessi e non accidentalmente); quindi la loro amicizia dura finché essi sono buoni, e la virtù è qualcosa di stabile; e ciascuno è buono sia in senso assoluto sia per l’amico. Infatti i buoni sono sia buoni in senso assoluto, sia utili reciprocamente. (Etica Nicomachea)
LA ROTAZIONE DELLE CARICHE
Poiché ogni comunità politica consta di governanti e di governati, bisogna vedere se, vita natural durante, essi debbano essere persone diverse oppure se debbano essere le stesse persone; perché, evidentemente, da questa divisione dovrà dipendere anche l’educazione. […]Che i governanti debbano differire dai governati non v’è alcun dubbio; come essi debbano differire e come partecipare del potere, è cosa che deve vedere il legislatore e della quale si è già detto. (Politica)
L’UOMO, ANIMALE PARLANTE
Perciò è chiaro che l’uomo è un animale più socievole di qualsiasi ape e di qualsiasi altro animale che vive in greggi. Infatti, secondo quanto sosteniamo, la natura non fa nulla invano, e l’uomo è l’unico animale che abbia la favella: la voce è segno del piacere e del dolore e perciò l’hanno anche gli altri animali, in quanto la loro natura giunge fino ad avere e a significare agli altri la sensazione del piacere e del dolore; invece la parola serve a indicare l’utile e il dannoso, e perciò anche il giusto e l’ingiusto. E questo è proprio dell’uomo rispetto agli altri animali: esser l’unico ad aver nozione del bene e del male, del giusto e dell’ingiusto e così via. (Politica)
IL PRINCIPIO DI NON-CONTRADDIZIONE
Il principio più sicuro di tutti è quello intorno al quale è impossibile essere nel falso. Questo principio è necessariamente il più conoscibile,[…] e non ipotetico, perché non è una ipotesi il principio che deve necessariamente possedere chi voglia comprendere una qualsiasi delle cose che sono, e quando si vuole arrivare a conoscere qualcosa, è necessario possedere già ciò che si deve necessariamente conoscere per conoscere una cosa qualsiasi. […] È impossibile che la stessa cosa insieme inerisca e non inerisca alla medesima cosa e secondo il medesimo rispetto; e si aggiungano tutte le altre determinazioni che si potranno aggiungere per evitare difficoltà di carattere dialettico.[…]Nessuno può ritenere che la medesima cosa sia e non sia, come alcuni credono che dicesse Eraclito. (Metafisica)
LA SCIENZA E LA DIMOSTRAZIONE
Se, pertanto, il conoscere è quale abbiamo posto, è necessario anche che la conoscenza apodittica proceda da cose vere, prime, immediate, più note, anteriori e cause della conclusione: ché in questo modo i principi saranno propri di ciò che si dimostra. […] E chi vorrà possedere la scienza che procede mediante dimostrazione non soltanto deve rendere maggiormente noti i principi e credere maggiormente ad essi che a ciò che è dimostrato, ma nient’altro dev’essere per lui più credibile e più noto che gli opposti dei principi dai quali procederà il sillogismo dell’errore contrario, se davvero chi conosce in senso assoluto deve essere inamovibile. (Analitici secondi)
LA METAFISICA, STUDIO DELL’ESSERE IN QUANTO ESSERE
C’è una scienza che studia l’essere-in-quanto-essere e le proprietà che gli sono inerenti per la sua stessa natura. Questa scienza non si identifica con nessuna delle cosiddette scienze particolari, giacché nessuna delle altre ha come suo universale oggetto di indagine l’essere-in-quanto-essere, ma ciascuna di esse ritaglia per proprio conto una qualche parte di essere e ne studia gli attributi, come fanno, ad esempio, le scienze matematiche. E poiché noi stiamo cercando i principi e le cause supreme, non v’è dubbio che questi principi e queste cause sono propri di una certa realtà in virtù della sua stessa natura. Se, pertanto, proprio su questi principi avessero spinto la loro indagine quei filosofi che si diedero a ricercare gli elementi delle cose esistenti, allora anche gli elementi di cui essi hanno parlato sarebbero stati propri dell’essere-in-quanto-essere e non dell’essere-per-accidente; ecco perché anche noi dobbiamo riuscire a comprendere quali sono le cause prime dell’essere-in-quanto-essere. (Metafisica E, 1, G, 1)
DIO
Dal momento che è possibile che le cose stiano nel modo da noi prospettato -del resto, se si respinge questa nostra spiegazione, tutte le cose deriverebbero dalla notte o dal -tutto-insieme’ o dal non-essere – si possono ritenere risolte tutte le precedenti aporie; esiste, quindi, qualcosa che è sempre mosso secondo un moto incessante, e questo modo è la conversione circolare (e ciò risulta con evidenza non solo in virtù di un ragionamento, ma in base ai fatti), e di conseguenza si deve ammettere l’eternità del primo cielo. Ed esiste, pertanto, anche qualcosa che provoca il moto del primo cielo. Ma dal momento che ciò che subisce e provoca il movimento è un intermedio, c’è tuttavia un qualcosa che provoca il movimento senza essere mosso, un qualcosa di eterno che è, insieme, sostanza e atto. Un movimento di tal genere è provocato sia da ciò che è oggetto di desiderio sia da ciò che è oggetto di pensiero. Ma questi due oggetti, se vengono intesi nella loro accezione più elevata, sono tra loro identici. Infatti, è oggetto del nostro desiderio il bello nel suo manifestarsi, mentre è oggetto principale della nostra volontà il bello nella sua autenticità; ed è più esatto ritenere che noi desideriamo una cosa perché ci si mostra bella, anziché ritenere che essa ci sembri bella per il solo fatto che noi la desideriamo: principio è, infatti, il pensiero. Ma il pensiero è mosso dall’intellegibile, e una delle due serie di contrari è intellegibile per propria essenza, e il primo posto di questa serie è riservato alla sostanza e, nell’ambito di questa, occupa il primo posto quella sostanza che è semplice ed è in-atto ( e l’uno e il semplice non sono la medesima cosa, dato che il termine uno sta ad indicare che un dato oggetto è misura di qualche altro, mentre il termine semplice sta ad indicare che l’oggetto stesso è in un determinato stato). Ma tanto il bello quanto ciò che per la sua essenza è desiderabile rientrano nella medesima categoria di contrari; e quel che occupa il primo posto della serie è sempre pttimo o analogo all’ottimo. La presenza di una causa finale negli esseri immobili è provata dall’esame diairetico del termine: infatti, la causa finale non è solo in vista di qualcosa, ma è anche proprietà di qualcosa, e, mentre nella prima accezione non può avere esistenza tra gli esseri immobili, nella seconda accezione può esistere tra essi. Ed essa produce il movimento come fa un oggetto amato, mentre le altre cose producono il movimento perché sono esse stesse mosse. E così, una cosa che è mossa può essere anche altrimenti da come essa è, e di conseguenza il primo mobile, quantunque sia in atto, può -limitatamente al luogo, anche se non alla sostanza- trovarsi in uno stato diverso, in virtù del solo fatto che è mosso; ma, poiché c’è qualcosa che produce il movimento senza essere, esso stesso, mosso ed essendo in atto, non è possibile che questo qualcosa sia mai altrimenti da come è. Infatti, il primo dei cangiamenti è il moto locale, e, nell’ambito di questo, ha il primato la conversione circolare, e il moto di quest’ultima è prodotto dal primo motore. Il primo motore, dunque, è un essere necessariamente esistente e, in quanto la sua esistenza è necessaria, si identifica col bene e, sotto questo profilo, è principio. Il termine ‘necessario’, infatti, si usa nelle tre accezioni seguenti: come ciò che è per violenza perché si oppone all’impulso naturale, come ciò senza di cui non può esistere il bene e, infine, come ciò che non può essere altrimenti da come è, ma solo in un unico e semplice modo. E’ questo, dunque, il principio da cui dipendono il cielo e la natura. Ed esso è una vita simile a quella che, per breve tempo, è per noi la migliore. Esso è, invero, eternamente in questo stato (cosa impossibile per noi!), poiché il suo atto è anche piacere (e per questo motivo il ridestarsi, il provare una sensazione, il pensare sono atti molto piacevoli, e in grazia di questi atti anche speranze e ricordi arrecano piacere). E il pensiero nella sua essenza ha per oggetto quel che, nella propria essenza, è ottimo, e quanto più esso è autenticamente se stesso, tanto più ha come suo oggetto quel che è ottimo nel modo più autentico. L’intelletto pensa se stesso per partecipazione dell’intellegibile, giacchè esso stesso diventa intellegibile venendo a contatto col suo oggetto e pensandolo, di modo che l’intelletto e intellegibile vengono ad identificarsi. E’, infatti, l’intelletto il ricettacolo dell’intellegibile, ossia dell’essenza, e l’intelletto, nel momento in cui ha il possesso del suo oggetto, è in atto, e di conseguenza l’atto, piuttosto che la potenza, è ciò che di divino l’intelletto sembra possedere, e l’atto della contemplazione è cosa piacevole e buona al massimo grado. Se, pertanto, Dio è sempre in quello stato di beatitudine in cui noi veniamo a trovarci solo talvolta, un tale stato è meraviglioso; e se la beatitudine di Dio è ancora maggiore, essa è oggetto di meraviglia ancora più grande. Ma Dio è, appunto, in tale stato! Ed è sua proprietà la vita, perché l’atto dell’intelletto è vita, ed egli appunto è quest’atto, e l’atto divino, nella sua essenza, è vita ottima ed eterna. Noi affermiamo, allora, che Dio è un essere vivente, sicchè a Dio appartengono vita e durata continua ed eterna: tutto questo, appunto, è Dio! (Metafisica, 12.7.1072a19-1072b30)
SILLOGISMI E DIALETTICA
Ebbene, sillogismo è un discorso nel quale, poste alcune cose, qualcosa di diverso da ciò che è stabilito segue di necessità in forza di ciò che è stabilito. Vi è dunque una dimostrazione quando il sillogismo proceda da asserzioni vere e prime, oppure da asserzioni tali che hanno assunto il principio della conoscenza ad esse relativa in forza di certe asserzioni vere e prime; dialettico è invece il sillogismo che argomenta da opinioni notevoli. […] E, complessivamente, su tutte le cose di cui abbiamo parlato e su quelle di cui, dopo queste, parleremo, ci basti aver definito in questa misura, poiché di nessuna di esse ci proponiamo di produrre la nozione rigorosa, ma vogliamo trattarne quanto basta in un abbozzo, ritenendo completamente sufficiente, secondo la presente trattazione, il poter riconoscere come che sia ciascuna di esse. (Topici)
IL PRIMATO DELLA VITA PRATICA
Veniamo ora a quelli che ammettono che la vita virtuosa è preferibile a ogni altra, sebbene poi siano in disaccordo sul modo di realizzarla.[…] I primi dicono senza dubbio il vero quando asseriscono che la vita dell’uomo libero è migliore di quella del padrone, perché servirsi dello schiavo in quanto tale non ha nulla di nobile e il comandare le cose necessarie non ha nulla di bello. Ma non è corretto credere che ogni autorità sia dispotica perché la differenza che c’è tra l’autorità esercitata su uomini liberi e quella esercitata sugli schiavi non è minore di quella che intercorre tra un uomo libero per natura e uno schiavo per natura, come del resto abbiamo già precisato nei primi discorsi. Non è vero che si debba esaltare l’astensione dall’azione al di sopra dell’azione stessa, perché la felicità è attività e l’attività di uomini giusti e temperanti dà compimento a molte belle cose.(Politica)
GIUSTIZIA ED UGUAGLIANZA
Poiché l’uomo ingiusto è colui che non osserva l’uguaglianza e ciò che è ingiusto è ineguale, è chiaro che esiste anche una via di mezzo di ciò che è ineguale: questa è l’uguaglianza poiché in qualsiasi azione esista il più e il meno, vi esiste anche l’uguale. Se dunque ciò che è ingiusto è ineguale, ciò che è giusto è uguale; il che appunto è comunemente riconosciuto da tutti anche senza un ragionamento. E poiché l’uguale si trova in una posizione intermedia, anche ciò che è giusto sarà un medio. Ma ciò che è uguale si trova almeno di due termini. È pertanto necessario che ciò che è giusto sia medio uguale e in rapporto a qualcosa, cioè sia giusto per qualcuno; e in quanto medio, che lo sia tra alcune cose (cioè il più e il meno) e in quanto uguale, per due cose, in quanto giusto, per alcune persone.[…] E l’uguaglianza per coloro per i quali è giusto e per le cose nelle quali è giusto sarà la stessa: quale è il rapporto che esiste tra queste ultime cose,[…] tale è il rapporto esistente tra le persone. (Etica Nicomachea)
IL BENE DELL’INDIVIDUO E IL BENE DELLA CITTA’
Si converrà che su di esso verte la scienza più importante ed “architettonica” in massimo grado; e tale è evidentemente la politica.[…] e vediamo inoltre che sono subordinate a questa le più apprezzate capacità, quali la strategia, l’economia, la retorica; e poiché la politica si serve delle altre scienze pratiche e per legge stabilisce inoltre che cosa si debba fare e da quali cose si debba astenersi, il suo fine comprenderà anche quelli delle altre e, di conseguenza, sarà il bene propriamente umano. Difatti se il bene per il singolo individuo e per la città sono la stessa cosa, conseguire e mantenere quello della città è chiaramente cosa più grande e più vicina al fine, poiché tale bene è, sì, amabile relativamente al singolo individuo, ma anche più bello e più divino in relazione ad un popolo e a delle città. E dunque la nostra ricerca, che è una ricerca politica, è volta verso tali obiettivi. (Etica Nicomachea)
PROPOSIZIONI VERE E FALSE
Non è […] possibile che ci sia qualcosa tra due proposizioni contraddittorie, ma è necessario affermare o negare una cosa di un’altra, quali che esse siano. Questo risulta chiaro quando si sia definito che cos’è il vero e che cos’è il falso. Infatti il dire che l’essere non è, o che il non-essere è, è falso; il dire che l’essere è, e che il non-essere non è, è vero: perciò chi dice “è” o “non è” o dice il vero o dice il falso; ma né dell’essere né del non-essere si può dire “non è o è”. (Metafisica IV, 7, 1011 b 22)
IL NUMERO DEL MOVIMENTO SECONDO IL PRIMA E IL POI
Poiché il mosso si muove da un punto verso un altro punto, e ogni grandezza è continua, il movimento segue alla grandezza. Infatti, poiché la grandezza è continua, è continuo anche il movimento; e per il fatto che lo è il movimento, è continuo anche il tempo, giacché la quantità del tempo trascorso è proporzionata a quella del movimento. […]Pertanto, quando noi percepiamo l’istante come unità e non già come un prima e un poi nel movimento e neppure come quell’entità che sia la fine del prima e il principio del poi, allora non ci sembra che alcun tempo abbia compiuto il suo corso, in quanto non vi è neppure movimento. Quando, invece, percepiamo il prima e il poi, allora diciamo che il tempo c’è. Questo, in realtà, è il tempo: il numero del movimento secondo il prima e il poi. (Fisica, D,10 e G,11)
LA CATARSI DELL’ARTE
Tragedia è dunque mimesi di un’azione seria e compiuta in se stessa, con una certa estensione; in un linguaggio abbellito di varie specie di abbellimenti, ma ciascuno a suo luogo nelle parti diverse; in forma drammatica e non narrativa; la quale, mediante una serie di casi che suscitano pietà e terrore, ha per effetto di sollevare e purificare l’animo da siffatte passioni. (Poetica, 6)
LA TRAGEDIA
L’epopea e la tragedia, come pure la commedia e la poesia ditirambica, e gran parte dell’auletica e della citaristica, tutte quante, considerate da un unico punto di vista, sono mimesi [o arti di imitazione]. Ma differiscono tra loro per tre aspetti: e cioè in quanto o imitano con mezzi diversi, o imitano cose diverse, o imitano in maniera diversa e non allo stesso modo. […] Infatti lo storico e il poeta non differiscono perché l’uno scriva in versi e l’altro in prosa […]: la vera differenza è questa, che lo storico descrive fatti realmente accaduti, il poeta fatti che possono accadere. Perciò la poesia è qualche cosa di più filosofico e di più` elevato della storia; la poesia tende piuttosto a rappresentare l’universale, la storia il particolare. (Poetica, 1,4 e 9)
ARISTOTELE NELL’ACCADEMIA
A cura di Alessandra Quintiliani
Aristotele nell’Accademia platonica
Sintesi delle interpretazioni sul primo periodo della produzione filosofica aristotelica
1. La questione delle opere essoteriche di Aristotele
Una singolare concomitanza di eventi storici ci ha fatto pervenire di Aristotele solamente l’espressione dell’attività scolastica. Della produzione filosofica aristotelica, infatti, ci sono giunti integralmente solo i trattati del Corpus, ossia gli scritti sistematici che Aristotele compose per il suo insegnamento. Oltre a queste opere, dette acroamatiche o esoteriche, – perché destinate agli ascoltatori interni alla scuola -, il filosofo scrisse anche dei dialoghi destinati al pubblico, che lui stesso chiamò essoterici e di cui noi possediamo solo alcuni frammenti.
Per uno strano caso, però, le opere pubblicate, scritte durante la permanenza di Aristotele in Accademia, furono dimenticate e soppiantate in seguito alla pubblicazione dei trattati, avvenuta a Roma per opera di Andronico da Rodi nel I sec. a.C. I trattati, infatti, di cui si erano perse le tracce per molto tempo, furono ritrovati da un bibliofilo ateniese, Apellicone di Teo, in una cantina appartenuta ai discepoli di Neleo, – figlio del platonico Corisco -, che divenne un fervente seguace di Aristotele ad Asso. Apellicone, che acquistò i manoscritti di Aristotele a peso d’oro, li riportò ad Atene e ne fece varie copie. Fu poi Silla ad impadronirsene dopo l’occupazione di Atene nell’84 a. C. e a portarli a Roma, dove appunto furono ordinati da Andronico.
L’Aristotele perduto, cioè l’Aristotele dei dialoghi giovanili, fu, però, quello letto, conosciuto, ammirato ed avversato dai commentatori e dai filosofi sino alla tarda età imperiale, quando appunto, gli scritti di scuola, ritrovati e studiati, riuscirono a prevalere. Le opere della maturità, infatti, – caratterizzate da una rigorosa scientificità e contenenti teorie considerate molto diverse e spesso in contrasto con quelle esposte negli altri scritti, per molti versi vicini alla filosofia di Platone -, furono ritenute le sole che esponessero la vera dottrina aristotelica con il conseguente disconoscimento dei dialoghi pubblicati, che di lì a poco si persero. Ettore Bignone nel suo fondamentale testo, L’Aristotele perduto e la formazione filosofica di Epicuro (2 voll., Firenze, La Nuova Italia, 1936) dimostra, attraverso un’analisi puntuale della polemica epicurea nei riguardi di Aristotele, come di questo si siano letti nel periodo fra la morte di Teofrasto e l’età di Silla solo i dialoghi pubblicati. Anche per Epicuro, quindi, il “vero” Aristotele era quello delle opere essoteriche ed in particolar modo del Protreptico, che era stato considerato il proclama dell’aristotelismo. Egli polemizzò così con il filosofo assertore dell’immortalità e divinità dell’anima, di platonica memoria, e di quella dottrina del conoscere come reminiscenza, che invalidava tutto il conoscere fenomenico e sensibile; tutte dottrine queste assenti nei trattati, che il filosofo epicureo come tanti altri filosofi e commentatori non ebbero modo di leggere.
La distinzione tra le due diverse categorie di scritti, essoterici ed esoterici o acroamatici, risalente già al tempo di Silla, è stata accettata dalla maggioranza degli studiosi moderni.
In particolare la tesi di W. Jaeger non può non essere esaminata, poiché con il suo celeberrimo testo Aristoteles, Grundlegung einer Geschichte seiner Entwicklung del 1923, segnò una svolta decisiva nella storia degli studi aristotelici. Partendo da un’intuizione di Zeller, – che pensò ad una evoluzione filosofica di Aristotele da una prima adesione al platonismo ad un lento distaccamento fino a raggiungere una autonoma dottrina -, egli cercò di ricostruire la genesi e lo sviluppo delle dottrine filosofiche, avvalendosi anche dell’aiuto delle notizie sulla vita e in generale sull’ambiente storico del filosofo.
Uno dei risultati più importanti dello studioso tedesco, che inaugurò il cosiddetto metodo storico-genetico, fu la delineazione di tre grandi periodi nella vita dello Stagirita, a cui corrisponderebbero altrettante fasi di sviluppo del pensiero:
– il periodo accademico, – che va dall’ingresso di Aristotele in Accademia fino alla morte di Platone (367 – 347 a. C.) -, contrassegnato da un’adesione pressoché totale al pensiero del maestro;
– gli anni di viaggio, – che Aristotele trascorse in Asia Minore e in Macedonia (347 – 335 a. C.) -, in cui si assiste ad un atteggiamento di transizione e di critica nei confronti di Platone;
– l’età dell’insegnamento, – che è il periodo trascorso da Aristotele ad Atene come fondatore del Liceo (335 – 323 a. C.) -, a cui corrisponde l’elaborazione di un proprio sistema filosofico del tutto indipendente dal platonismo.
Secondo questa schematizzazione dello sviluppo filosofico di Aristotele, – sostenuta anche da E. Bignone, F. Nuyens e P. Moraux -, le opere pubblicate, di genere dialettico, apparterrebbero alla prima fase del suo pensiero di stampo platonico, caratterizzata dalla problematica teologica e dall’uso dei miti. Nella prospettiva evolutiva jaegeriana, però, questa limitatezza cronologica comportava conseguentemente una limitazione dell’autentico significato di tali opere: le opere pubblicate, in quanto appartenenti alla fase platonica dello Stagirita, non sarebbero espressione del “vero” Aristotele, cioè dell’Aristotele scientifico ed antimetafisico, quale emerge dai maturi trattati del Corpus, nei quali la posizione platonica è ampiamente superata.
Quest’ultima tesi è stata accettata come dogma indiscutibile fino agli anni cinquanta, quando ulteriori sviluppi negli studi aristotelici hanno mostrato come l’Aristotele jaegeriano sia stato superato in molti punti. Il riconoscimento della non immunità del paradigma proposto da Jaeger, tuttavia, ha reso necessario cercare di rispondere nuovamente alla domanda circa l’effettivo rapporto fra gli scritti di Aristotele pubblicati, ma ora perduti, e gli scritti non destinati alla pubblicazione, che sono giunti fino a noi.
A tal proposito fondamentale fu la nuova teoria proposta da I. Düring. Questi, dedicatosi in particolar modo allo studio delle opere giovanili, si persuase che in esse non vi fosse alcuna traccia di adesione da parte di Aristotele alla fondamentale dottrina platonica delle idee separate, attestando in tal modo una certa indipendenza intellettuale dello Stagirita dal maestro anche nella prima produzione. Secondo Düring, infatti, durante il periodo accademico Aristotele avrebbe subito, oltre all’influenza di Platone, quella di scienziati come Eudosso e Filistione, dai quali sarebbe stato indotto all’osservazione del particolare.
L’interpretazione sostenuta da questo studioso, in tal modo, non stima che vi siano divergenze rilevanti tra le opere perdute e quelle conservate. Nato il sospetto che il metodo storico-genetico, innaugurato da Jaeger, si fondasse su una specie di circolo vizioso, – per cui ciascuno dei suoi fautori, muovendo da una personale concezione dell’evoluzione di Aristotele, assegnava le opere all’uno o all’altro periodo della vita del filosofo -, si è così progressivamente affermata, grazie all’opera Aristoteles, Darstellung und Interpretation seines Denkens (Heidelberg, 1966) di Düring, l’ipotesi che nello Stagirita non ci sia stata un’evoluzione dal platonismo all’empirismo o dall’empirismo al platonismo, ma una costante unione, in tutti i periodi della sua vita, di entrambe le tendenze.
La mancata adesione di Aristotele alla dottrina delle idee, l’atteggiamento critico nei confronti di alcune teorie di Platone e la presa di coscienza da parte dello Stagirita di una propria autonoma posizione filosofica, – sia pure nell’ambito di un fondamentale e irriducibile platonismo, riscontrabile nell’esigenza di trovare dei principi supremi, capaci di rendere ragione della totalità del mondo dell’esperienza -, hanno contribuito in Düring all’elaborazione di una cronologia delle opere aristoteliche. L’aspetto più innovativo di questa è il fatto che lo studioso consideri risalenti al periodo accademico gran parte, se non della redazione definitiva, almeno del nucleo originario dei vari scritti che compongono il Corpus.
La conseguenza che deriva da ciò è che lo sviluppo del pensiero aristotelico si decide interamente già nel periodo accademico, quindi a contatto con Platone.
La distinzione fra opere essoteriche ed esoteriche, inoltre, a suo avviso, non autorizzerebbe a supporre né una differenza dottrinale, né un diverso grado di rigore tra questi scritti, ma solo una eterogeneità di metodo, dialettico negli scritti essoterici e dimostrativo in quelli esoterici. “Non abbiamo inoltre, – scrive Düring nell’opera citata-, alcun fondamento per supporre che nelle numerose opere che sono andate perdute (Aristotele) abbia esposto opinioni diverse o si sia occupato di settori della scienza diversi da quelli illustrati nelle opere conservate. Non esiste, in questo senso, un “Aristotele perduto””.
“Dobbiamo tenere fermo,- sostiene ancora -, che Aristotele nei dialoghi e nelle opere didattiche scritte nello stesso periodo espose sostanzialmente la stessa filosofia. Un’ottima prova ne è già il fatto che talvolta egli fa riferimento ai suoi exoterikoi logoi per corroborare quella che in quel momento è la sua argomentazione”.
Le principali opinioni antiche e moderne relative al rapporto fra gli scritti pubblicati e i trattati, comunque, concordano nel ritenere che le opere essoteriche siano quelle destinate al pubblico e scritte con uno stile brillante, ma senza troppo rigore scientifico, mentre quelle esoteriche sono quelle destinate alla scuola e scritte in modo sistematico, anche se a volte oscure.
La questione dei exoterikoi logoi, tuttavia, è stata ripresa anche dalla recente storiografia filosofica per arrivare a conclusioni ben diverse da queste. In particolar modo Iannone e Bos hanno tentato di leggere tale problema da una diversa prospettiva.
Iannone, ad esempio, inizia la sua ricerca dai richiami ai logoi essoterici contenuti nelle opere aristoteliche che noi possediamo, desumendo da questi quella che a suo parere è la vera interpretazione di logos exoterikos. I passi contenenti tali richiami sono otto e precisamente:
– Metaph M. 1, 1077 a, 26 – 29;
– Eth. Nic. A, 13, 1102 a, 26 – 28;
– Eth. Nic. Z, 4, 1140 a, 6 – 8;
– Polit. G , 4, 1278 b, 31 – 32;
– Polit. H, 1, 1323 a, 22 – 24;
– Eth. Eud. A, 1, 1217 b, 17 – 19;
– Eth. Eud. B, 1, 1218 b, 33 – 35;
– Phys. IV, 10, 217 b, 29 – 31.
Partendo da quest’ultimo passo, che ritiene più importante di tutti, Iannone afferma che Aristotele con l’espressione exoterikoi logoi non si riferisce a degli scritti, ma a dei ragionamenti presenti nelle opere stesse. Ricordando come l’aggettivo exoterikos derivi direttamente dall’avverbio éxo (fuori) ed attribuendo così ad exoterikos il senso letterale, giunge ad affermare nella sua ricerca intitolata proprio I logoi essoterici di Aristotele (a. a. 1954 – 55) che “i logoi exoterikoi sono discorsi che, per il fondo, non appartengono propriamente al nocciolo della questione, ma (…) sono ragionamenti esterni e quindi preliminari, proeminali”.
Dall’esame dei rimanenti passi lo studioso crede possibile concludere che Aristotele con exoterikos logos faccia riferimento al primo libro dell’opera stessa, che costituisce sempre un’introduzione e un proemio alla trattazione vera e propria.
Scopo di queste sue ricerche è negare che esistano le cosiddette opere essoteriche, diverse da quelle del Corpus. Egli crede ormai improponibile l’identificazione dei logoi exoterikoi con i dialoghi giovanili e la “légendaire double doctrine” degli scritti pubblicati e di quelli non pubblicati. (vedi: A. Iannone, Les oeuvres de jeunesse d’Aristote et les Logoi Exoterikoi, in Rivista di Cultura Classica e Medioevale, I, 1959, p. 207)
Non nascondendo inoltre di essere d’accordo con quanti nutrono dubbi sul valore dei frammenti e delle testimonianze dei dialoghi perduti, perché indirette ed incerte, e credendo nello spirito sistematico di Aristotele, egli, pur ammettendo la possibilità che questi abbia composto durante la giovinezza saggi ed esercitazioni, nega che il filosofo ne abbia tenuto conto nei trattati.
Un recente approccio alle opere perdute di Aristotele, in aperta polemica con le teorie di Jaeger, è stato proposto dallo studioso olandese A. P. Bos in molti suoi lavori. Egli crede che l’interpretazione jaegeriana non sia più sostenibile. Essa, infatti, suppone che Aristotele per secoli sia stato altamente ammirato nell’antichità sulla base di scritti che non contenevano la sua vera filosofia, ma che riflettevano solo opinioni che egli stesso in seguito avrebbe considerato superate. È difficile credere, poi, che Aristotele nella sua maturità filosofica abbia smesso di esporre e di pubblicare le sue teorie in una forma letteraria raffinata, riservando il suo pensiero esclusivamente ad appunti di scuola. Bos, inoltre, è convinto che proprio negli scritti scolastici del Corpus Aristotele faccia spesso riferimento ai suoi scritti pubblicati, indicando in essi la chiarificazione necessaria di alcuni punti della sua dottrina.
Quindi, ad avviso di E. Perioli “attraverso una complessa ed articolata ricostruzione del contenuto delle opere perdute di Aristotele, (…), Bos intende mostrare come queste opere siano l’espressione di riflessioni filosofiche autonome di Aristotele, nelle quali lo Stagirita aveva già fermamente stabilito tutta una serie di dottrine centrali della sua filosofia, così come noi le conosciamo dai trattati del Corpus”. Ricordando teorie quali la duplice teologia di un supremo dio trascendente e di una pluralità di dèi cosmici, il rifiuto della generazione del cosmo, la dottrina del quinto elemento, la distinzione tra attività teoretica ed attività pratica, l’idea che il nous umano possa esistere separatamente, presenti nelle opere giovanili, lo studioso è volto a cancellare quella frattura che la critica ha sempre visto tra questi scritti e quelli della maturità. Secondo Bos, infatti, la filosofia delle opere perdute di Aristotele non è stata sostituita dai trattati, ma in essi è sempre presupposta. Questi, anzi, sono stati composti per integrare e completare le dottrine dei dialoghi, i quali si differenziano dalle opere di scuola non per il contenuto ma per lo stile ed il metodo adottato. In effetti, come Bos afferma alla pag. 377 di Teologia cosmica e metacosmica nella filosofia greca e nello gnosticismo, “in questi dialoghi perduti Aristotele non esprimeva una concezione filosofica platonizzante, risalente alla prima fase del suo pensiero ed in seguito abbandonata, e certamente una concezione che lo stesso Platone aveva già rifiutato”.
Le opere pubblicate, a suo parere, differirebbero dai trattati del Corpus per l’uso di una prospettiva mitica e sovraumana circa la realtà dell’esistenza umana, prospettiva assente nelle opere di scuola, basate su una ricerca condotta fysikòs (secondo le leggi della natura).
Da tutto questo Bos desume una spiegazione filosofica della scomparsa dei dialoghi giovanili. “Potremo concludere, – scrive nell’opera già citata -, che la cerchia ristretta di studiosi di professione giunse ad avvertire una frattura così enorme, in termini di verificabilità, fra le concezioni mitiche, da un lato, e le concezioni argomentate e fondate sulla base della comune esperienza, dall’altro, che l’uso dei miti, anche nella forma di miti filosofici, venne gradualmente respinto come inaccettabile da un punto di vista filosofico, e ciò come parte di un generale rifiuto di qualsiasi ricorso ad una conoscenza sovraumana”.
Un discorso a parte merita l’interpretazione che dà lo studioso dell’espressione exoterikoi logoi. Rovesciando la tesi generale su tale problema, Bos crede che tale espressione non stia ad indicare le opere divulgative per coloro che sono fuori della scuola, ma quegli scritti che hanno per oggetto ta éxo, ossia quella realtà che in Aristotele trascende la fysis (natura), ed in questo senso sta al di fuori della sfera della realtà fisica.
A supporto di tale tesi lo studioso fa un esame del ruolo filosofico del termine ta éxo, in Platone ed in Aristotele, particolarmente nel Fedro (247 A – 249 C) e nel De Caelo (I, 9).
Bos, inoltre, sottolinea come l’assenza nelle opere aristoteliche della spiegazione dell’espressione exoterikoi logoi, – che Aristotele stesso ha creato e che sembra essere familiare al suo uditorio -, sia stato influenzato dalla considerazione maggiore che l’Aristotele dei trattati ha avuto rispetto a quello dei dialoghi.
Tutte queste recenti proposte interpretative, essendo tra loro differenti, debbono comunque essere considerate come ipotesi significative con cui confrontare i precedenti risultati, per un avanzamento più completo degli studi sullo Stagirita.
2. L’ingresso di Aristotele in Accademia
Aristotele entrò in Accademia nel 367 a. C., anno in cui Platone affrontò il suo secondo viaggio in Sicilia dopo l’invito di Dione, – parente del tiranno di Siracusa, Dionisio il vecchio, morto lo stesso anno -, che si era convertito agli ideali politici di Platone durante il suo primo soggiorno nell’isola.
L’assenza di Platone da Atene durò fino al 364 a. C. e la reggenza della scuola in questi tre anni fu affidata ad Eudosso di Cnido, uno scienziato molto versatile, competente in matematica, astronomia, geografia, etnologia, medicina e filosofia, che influenzò notevolmente la formazione del giovane filosofo, come pure l’orientamento della scuola. E Aristotele stesso, molto tempo dopo, ricorderà nell’Etica Nicomachea l’impressione avuta da quanti conobbero Eudosso. “I suoi ragionamenti, – egli affermerà -, avean acquistato fede più per la virtù dei suoi costumi che per se stessi: poiché appariva di un’insolita temperanza; onde sembra che in tal modo ragionasse (identificando il bene col piacere), non perché amante del piacere, ma perché così la cosa stesse veramente”.
Eudosso in filosofia venne considerato platonico, ma in realtà si distaccò non poco dal platonismo per quanto riguarda, ad esempio, la dottrina delle idee, la teoria sul piacere e quella sulle sfere astrali, di cui ipotizzava la loro concentricità e la diversità delle rotazioni per spiegarne i moti irregolari.
Questo potrebbe essere una prova del fatto che il vero platonismo comportava non tanto l’accettazione dogmatica di determinate dottrine, quanto la discussione libera dei problemi posti da Platone all’interno della scuola: una conferma potrebbe essere che platonici significava essenzialmente credere nella filosofia come ideale supremo di vita e come guida nella vita pratica.
Proprio alla comprensione della caratteristica essenziale dell’Accademia rispetto ad altre scuole, non ultima quella isocratea, si sono dedicati vari studiosi. Le ipotesi che emergono sono sostanzialmente tre:
– Platone, tornato dal primo viaggio a Siracusa, acquistò un terreno nei pressi del ginnasio, – situato nella zona consacrata all’eroe Akádemos o Hekàdemos -, dove vi avrebbe fatto costruire un santuario dedicato alle Muse e dei locali per abitazione. Il fatto che nell’Accademia sorgesse un santuario e che vi si celebrassero i giorni in cui i greci ritenevano che fossero nati Artemide ed Apollo, ha portato alcuni critici a ritenere la scuola platonica un thiasos, cioè un associazione di culto.
– Di differente avviso sono lo Stenzel e lo Jaeger, i quali credono di ravvisare nell’Accademia antica una scuola di formazione politica. L’aspetto politico fu fondamentale nella vita e nel pensiero di Platone, che dopo la condanna di Socrate e la sfiducia nella politica ateniese si persuase della necessità di preparare adeguatamente i giovani filosofi alla vita politica, nella convinzione che solo i filosofi al potere avrebbero potuto migliorare le condizioni degli uomini. Venendo alla sua scuola giovani da tutte le parti dell’Ellade, Platone favorì il formarsi di circoli platonici nelle loro città per cercare di realizzare quello stato ideale che non era riuscito a formare ad Atene.
– Chi, invece, ha voluto scorgere nell’Accademia un’istituzione, in cui lo scopo principale fosse la ricerca scientifica, fu Usener, il quale concepì la scuola come una sorta di moderna università, dove vi era un regolare programma di lezioni e di seminari. A supporto della sua tesi Usener ricorda un famoso frammento del comico Epicrate (fr.11 = T. Kock) ove in modo caricaturale si descrivono gli accademici intenti nella definizione di vari animali e piante.
3. Cenni sulla situazione filosofica nell’Accademia durante la permanenza di Aristotele e l’inizio della sua produzione letteraria
Aristotele si trattenne in Accademia venti anni, quindi fino a quando compì i trentasette anni d’età nel 347 a. C.
Anche se non abbiamo notizie certe degli studi da lui compiuti nella scuola, si può ipotizzare che per i primi tre anni, trascorsi sotto lo scolarcato di Eudosso, studiò fondamentalmente matematica, per poi seguire il programma descritto da Platone nella Repubblica.
Probabilmente, però, gli insuccessi, incontrati da Platone a Siracusa nei suoi viaggi, determinarono una svolta nella sua vita e nel carattere della sua scuola. I dialoghi scritti da Platone dopo il 367, detti dialoghi “dialettici” (Parmenide, Sofista, Teeteto, Filebo, Politico), nonché il Timeo e le Leggi, rivelano infatti, differentemente dai precedenti, un interesse minore per la costruzione di uno stato ideale e un interesse crescente per problemi di logica, di dialettica e anche di scienze naturali. È ipotizzabile quindi che anche l’Accademia si sia orientata verso questa nuova rotta. Aristotele quindi incontrò un Platone ormai prevalentemente dialettico, volto al ripensamento della sua fondamentale teoria delle idee, su cui aveva basato tutto il suo sistema e a cui non rinunciò mai.
Aristotele, di fatto, soggiornò in Accademia in un periodo molto fecondo, ricco di dibattiti e discussioni tra il maestro e i suoi discepoli, dei quali alcuni rifiutarono o interpretarono diversamente la dottrina delle idee, a cui pure Platone soprattutto nel Parmenide e nel Sofista aveva mosso gravi critiche.
Che l’impostazione della paideía platonica su basi scientifico-dialettiche abbia appagato il giovane Aristotele potrebbe essere desunto da quella che sembra essere la sua prima opera, intitolata Grillo o Sulla Retorica. In essa lo Stagirita, prendendo spunto da una serie di scritti retorici composti per celebrare Grillo, figlio di Senofonte, morto nel 362 a. C. nella battaglia di Mantinea, polemizzava contro la retorica intesa come arte, tesi teorizzata dal sofista Gorgia e ripresa da Isocrate.
Pertanto il Grillo, che è la più antica opera databile di Aristotele, probabilmente scritta tra il 360 e il 358 a. C., rappresenta la netta presa di posizione da parte del filosofo a favore della paideía platonica contro quella isocratea, che si fondava sulla retorica. L’opera, quindi, non è uno dei tanti scritti per onorare la memoria di Grillo, ma è portavoce della reazione ai molti elogi funebri, scritti da vari retori in occasione della morte di lui. Il numero eccessivo di questi elogi e l’intento servile da cui erano animati probabilmente diedero l’impressione ad Aristotele che la retorica mirasse principalmente ad agire sugli affetti, la parte irrazionale dell’anima, allo scopo di giungere ad un successo pratico.
Questa tesi aristotelica era stata sostenuta già molti anni prima da Platone nel Gorgia, dove egli aveva affermato che la retorica non era una téchne, cioè un’arte, né una scienza, ma esclusivamente una forma di adulazione. Il Grillo dovette riscuotere molti consensi nell’Accademia al punto che Aristotele venne incaricato di tenere un corso ufficiale di retorica, durante il quale probabilmente mostrò, come fece già Platone nel Fedro, che la retorica per acquistare valore dovesse fondarsi sulla dialettica. Questo corso come pure il Grillo dovettero avere ampio successo, se il discepolo di Isocrate, Cefisodoro, e Isocrate stesso risposero al giovane filosofo nelle rispettive opere, Contro Aristotele e Antidosis.
Lo studio della dialettica, finalizzata alla discussione filosofica probabilmente portò il giovane Aristotele a partecipare al grande dibattito che si svolgeva nell’Accademia in quel periodo intorno alla dottrina platonica delle idee. Documento del suo interesse per tale problematica è il trattato intitolato Sulle idee (Peri Ideon), che quasi certamente risale al periodo accademico, essendo richiamato dallo stesso Aristotele nel I libro della Metafisica. Inoltre, il trattato, riallaciandosi al Parmenide di Platone, composto dopo il 365 a. C., verosimilmente fu scritto intorno al 360 a. C.
Il Peri Ideon è andato perduto ed i pochi frammenti, che ci sono giunti, ci sono stati trasmessi dal più grande commentatore aristotelico dell’antichità, Alessandro d’Afrodisia (II – III sec. d. C.), uno degli ultimi studiosi che ebbe la possibilità di leggerlo e utilizzarlo per il suo commentario alla Metafisica.
Come si era ricordato prima, nel periodo successivo al ritorno di Platone da Siracusa, il problema del rapporto tra idee e cose, – posto nel Parmenide e ripreso, cercandone una soluzione, nel Sofista -, dovette provocare diverse discussioni fra i componenti dell’Accademia, tanto più che il rapporto di partecipazione o imitazione tra idee e cose, proposto da Platone, non ottenne adesioni.
Molto probabilmente parteciparono a questo dibattito Eudosso, Speusippo, Senocrate ed Aristotele stesso.
Eudosso sostenne che tra le idee e le cose non ci fosse né quella separazione, né quel rapporto di partecipazione o di modello-copia che Platone aveva proposto in differenti dialoghi, ma al contrario un legame più stretto che egli indicava con il termine mixis, mescolanza. Le idee e le cose non sono separate, ma sono mescolate tra loro. Questa teoria di Eudosso è una critica alla separazione delle idee, che questi considerava un grande impedimento per dar ragione a quel rapporto tra quei due mondi separati, che però Platone riteneva necessario.
Si potrebbe pensare che Aristotele avesse avuto una certa simpatia nei confronti di questa dottrina, perché anch’egli come Eudosso criticò la separazione delle idee e tentò di unire la forma e la materia giungendo alla formulazione della dottrina del sinolo, ma non è così. Secondo Aristotele, infatti, la soluzione proposta da Eudosso è foriera di molti equivoci, al punto che egli rivolge a tale tesi ben otto critiche, che Alessandro d’Afrodisia riporta nel suo commento alla Metafisica aristotelica.
Il pensiero di Speusippo e Senocrate, come pure quello di tutta l’Accademia antica, non è facilmente enucleabile. Oltre ad alcuni frammenti rimastici, infatti, noi abbiamo conoscenza di tali pensatori attraverso Aristotele o attraverso la dossografia, due tramiti che offrono scarsa garanzia di attendibilità.
Al fine, però, di avvicinarci il più possibile alla vera concezione speusippea e senocratea è necessario far riferimento agli ultimi sviluppi della dottrina platonica. Ciò servirà, inoltre, ad inquadrare maggiormente il Peri Ideon e l’altro trattato, contemporaneo a questo, il Peri Thagathou (Sul Bene).
Nell’ultima fase del suo pensiero, come si è già ricordato, Platone aveva sottoposto la teoria delle idee ad un radicale ripensamento indirizzato in seguito su interessi di tipo matematico-pitagorico e cosmologico, di cui si ha traccia nel Filebo e nel Timeo. Servendosi probabilmente della relazione delle contrarietà, – esposta nel Parmenide -, e del concetto di relativo e della scoperta dei cinque generi sommi, – di cui si parla nel Sofista -, Platone introduce nel Filebo l’antitesi fondamentale, ripresa dal pitagorismo, tra illimitato (apeiron) e limite (peras), che conduce all’affermazione delle proporzioni numeriche. Problematico è certamente in questo testo il rapporto delle idee con la teoria del limite e dell’illimitato, poiché esso determina certamente un ordine di carattere numerico, che si ritrova anche nel Timeo. In questo dialogo, infatti, risultano mescolati secondo proporzioni matematiche i termini di quest’antitesi come pure i “generi” del Sofista, ed inoltre, qui, sono proprio le figure geometriche a dare ordini alla chora (materia) disordinata.
Ora, il Peri Ideon, il Peri Thagathou e soprattutto i libri I e XIII della Metafisica, – la cui stesura, ricordiamo, non è stata unitaria ma ha avuto sviluppi differenti -, contengono esposizioni e critiche di dottrine attribuite a Platone o ai platonici. Secondo Aristotele, Platone ammetteva due tipi di sostanze sovrasensibili: le idee e gli enti matematici. Mentre sul primo punto Aristotele riferisce nozioni più o meno note anche attraverso i dialoghi platonici, il secondo apre una questione molto complessa: a prima vista, esso, infatti, non trova riscontro nelle opere platoniche.
Aristotele afferma che per Platone esistono numeri matematici, intermedi tra le cose e le idee, e numeri ideali che sono identici con le idee. Se la corrispondenza del carattere intermedio dei numeri matematici con le teorie dei dialoghi, pur problematica, sembra sostenibile, come crede Ross nel suo Plato’s Theory of Ideas (1951); l’identificazione delle idee con i numeri rappresenterebbe una radicale innovazione della teoria delle idee nota attraverso i dialoghi. E ciò che più disorienta è il fatto che Aristotele non si dilunga su questo aspetto, assumendolo quasi come noto. Nella Metafisica, ad esempio, l’attribuzione esplicita a Platone dell’identità tra numeri e idee è presente in soli due passi: I, 6, 987 b, 14-22 e XIII, 9, 1086 a, 11-13, più frequentemente è citata tale teoria senza una precisa attribuzione a Platone.
Questi inoltre spiega come Platone sostenesse che le idee sono causa delle cose, che gli elementi delle idee sono elementi di tutte le cose, che questi elementi delle idee, detti principi, sono il grande-piccolo da un lato e l’uno dall’altro, e che le idee-numeri nascono per partecipazione di questi principi. Anche nel Peri Thagathou, – rispetto al quale i commentatori sono concordi nel dichiarare che avrebbe contenuto la relazione, scritta da Aristotele, di un corso orale (acroasis) tenuto da Platone sul bene -, sono esposte quest’ultime concezioni. Le idee, essendo una molteplicità, hanno bisogno di un’ulteriore giustificazione: così Platone per dare ragione di questa molteplicità ritenne necessario dedurle da principi superiori. Tali principi erano appunto l’Uno e la Diade indefinita o del grande-piccolo, il primo dei quali aveva la funzione di principio formale e il secondo di principio materiale. L’Uno e la Diade insieme erano la causa delle idee-numeri, delle idee, e a loro volta le idee erano causa delle cose. Dalle parole di Aristotele si deduce, così, che tutta la realtà, sia quella ideale sia quella sensibile, dipende da questi due soli principi, l’Uno che funge da elemento unificante ed ordinatore delle cose e la Diade che è l’elemento moltiplicante.
Dal momento che questa dottrina chiaramente attribuita da Aristotele al suo maestro non sembra trovare nei dialoghi di quest’ultimo un esplicito riscontro, si sono sviluppate diverse ipotesi per cercare di risolvere questo enigma, se si vuole usare la felice espressione dello studioso H. Cherniss.
Una particolarmente suggestiva è quella che crede nell’esistenza di dottrine non scritte, – i cosiddetti agrafa dogmata -, che avrebbero contenuto la vera filosofia platonica, destinata ad una ristretta cerchia di uditori, presumibilmente i suoi discepoli. Questa soluzione, che presuppone un Platone esoterico, è stata accolta, sviluppata ed argomentata dalla scuola di Tubinga, in particolar modo da Gaiser, Krämer e Szlezák, che hanno negato che i dialoghi platonici avessero contenuto la dottrina somma del filosofo, espressa in modo compiuto in un suo insegnamento orale. Essi, infatti, ricordano molti passi dei dialoghi in cui Platone non solo sottolinea, come nel Fedro col mito egiziano di Theuth, la superiorità del discorso orale rispetto a quello scritto, ma afferma esplicitamente nella Lettera VII di non aver mai messo per iscritto la sua vera dottrina. I dialoghi, così, interpretati secondo questa nuova ottica, avrebbero solo una funzione propedeutica o introduttiva alle dottrine non scritte.
Un’altra ipotesi sostiene che quella dottrina, che non è contenuta nei dialoghi e di cui testimonia Aristotele, sia frutto di un fraintendimento di quest’ultimo. Di tale avviso sembra essere H. Cherniss, che dopo aver mostrato la non attendibilità di Aristotele come storico della filosofia e in generale come storico del platonismo, afferma chiaramente nel testo The Ridde of the Early Academy (p. 34) che “la teoria delle idee-numeri non sia stata affatto di Platone, ma solo una interpretazione di Aristotele (…)”. Egli sottolinea, quindi, come l’identificazione delle idee con i numeri sia frutto piuttosto di un’interpretazione critica aristotelica del pensiero accademico. Cherniss, così, nel suo testo ricorda come Platone dal primo dialogo fino all’ultimo consideri la dottrina delle idee la pietra angolare del suo pensiero. Le idee, chiamate notorie nel Fedone al passo 100 b, compaiono nel Filebo, nel Timeo e finanche nelle Leggi. Da ciò e dalla discrepanza fondamentale tra la teoria delle idee presente negli scritti platonici e quella riferita da Aristotele, egli trae il maggiore sostegno per definire “sospetta” la testimonianza aristotelica, probabilmente influenzata dalle critiche a Platone di Speusippo e di Senocrate.
Ross, invece, rifacendosi parzialmente alla tesi di una erronea interpretazione aristotelica, crede che per questo particolare problema essa debba essere limitata all’interpretazione dell’espressione “il grande-piccolo”, che egli ritenne indicasse due cose, una grande e una piccola. Da questa comprensione distorta discenderebbe la sua descrizione del grande-piccolo, nella quale non si dice che esso fornisce pluralità, ma che “duplica”. Egli, poi, ipotizza nella generazione dei numeri ideali di Platone una corrispondenza dell’Uno e della Diade rispettivamente con il “limite” e l’”illimitato” del Filebo, che risolverebbe in parte l’assenza dai dialoghi di queste teorie. Ross crede inoltre possibile che alcune critiche di Aristotele siano dirette non tanto contro ciò che aveva sostenuto Platone, quanto piuttosto contro ciò che Speusippo e Senocrate ipotizzarono egli avesse voluto dire o contro qualche nuova teoria sorta all’interno dell’Accademia. Egli, tuttavia, pur ammettendo che Aristotele in alcuni punti abbia frainteso la dottrina di Platone, sostiene che i suoi molteplici riferimenti agli agrafa dogmata dovevano avere un termine reale e questo non poteva essere che il corso orale sul Bene, attestato anche da Aristosseno.
Giannantoni, infine, pur ritenendo autentica la Lettera VII di Platone, non condivide l’interpretazione degli studiosi di Tubinga, sottolineando come Platone in questo testo si riferisca ad una esposizione sommaria, sintetica e “per formule” del suo pensiero. Il filosofo, infatti, ricorda Giannantoni, ha sempre rifuggito da ogni esposizione scolastica e sistematica della sua filosofia, che ha consegnato a quello strumento letterario, il dialogo, che meglio rifletteva il dialogo parlato. Probabilmente, prosegue lo studioso, Platone nella Lettera VII si riferisce a composizioni di “contrabbando”, scritte da persone differenti da coloro che frequentavano la sua scuola.
Anche volendo prescindere dal fatto che diventerebbe difficile spiegare come mai il filosofo abbia scritto tanto e abbia scritto opere in cui la filosofia successiva ha riconosciuto un alto contenuto speculativo, egli ritiene queste dottrine orali, – di cui si hanno più testimonianze -, come l’estrema fase di sviluppo del pensiero platonico, in cui ancora deve essere ben definito ciò che spetta propriamente a Platone e ciò che deve essere attribuito piuttosto ai suoi discepoli.
A questo punto, avendo discusso degli ultimi sviluppi della dottrina platonica, è possibile esaminare il pensiero di Speusippo e di Senocrate.
Speusippo, primo scolarca dell’Accademia dopo la morte di Platone, rifiutò totalmente la dottrina delle idee.
“Secondo Aristotele, Speusippo si sarebbe reso conto delle infinite difficoltà connesse alla dottrina degli eide (idee) e della artificiosità, e quindi arbitrarietà, della fissazione di un eidos (idea) unitario di natura intuitiva (…). É probabile che Speusippo, sviluppando la tarda dialettica platonica del metodo diairetico, abbia sentito acutamente la contraddizione interna fra questa dialettica divisoria, una volta che la si consideri nel suo riferimento ontologico e non la si riduca a semplice esercizio logico-linguistico, e la fissazione unitaria dell’eidos come monas (unità), quale è ancora riaffermata nel Filebo” (M. Isnardi Parente, Studi sull’Accademia Platonica Antica, pp. 13-14). Egli accettò tuttavia un punto fondamentale della teoria platonica, e cioè l’esistenza di essenze separate al di là del mondo sensibile, i numeri, cui però non attribuì alcun rapporto con le cose.
La dottrina di Speusippo, infatti, prevedeva una funzione privilegiata del numero come proton ton onton (primo delle cose esistenti) e primo intellegibile, avente come principi l’uno e il molteplice nella loro forma astratta, elementi di tutti i numeri.
Per questa teoria Aristotele lo accomunò al pitagorismo, dottrina a cui, come si è notato, anche Platone si rifece nell’ultima fase speculativa. A tal proposito, però, bisogna ricordare che per i pitagorici il numero non era separato o trascendente rispetto alle cose sensibili, mentre lo era per il platonismo pitagorizzante di Speusippo, che in tal modo poteva affermare il carattere trascendente degli enti matematici. Presupposto più propriamente pitagorico, invece, è quello secondo cui la serie dei numeri non inizia dallo en (uno), che non è precisamente numero, ma solo avvio della serie numerica, che si costituisce dal due e dal tre.
L’Accademia raggiunse il suo punto più alto di tensione interna con Senocrate, il secondo scolarca della scuola dopo Platone. Mentre Speusippo, infatti, ebbe il coraggio di rifiutare decisamente la fondamentale teoria platonica delle idee, dando alla dottrina dei principi e degli enti matematici la netta priorità, Senocrate intese invece cercare una conciliazione di queste due dottrine, delle idee e dei principi. In tal modo, quindi, egli oscillò sempre fra la presentazione delle idee nella formulazione platonica ortodossa e la teoria dei principi, giungendo poi ad una totale identificazione delle idee con i numeri. A differenza, quindi, di Platone, che distingueva i numeri ideali da quelli matematici, e di Speusippo, che considerava solo i numeri matematici, Senocrate identificò idee, numeri matematici e divinità. A conferma di questa sua tesi si può ricordare, ad esempio, che egli chiamò l’anima “un numero che muove se stesso” e che, prendendo spunto dal carattere matematico dell’ordinamento dell’universo del Timeo, dedusse la natura matematica delle forme. I numeri, infatti, concepiti come asòmata (= senza corpo) non sono distinguibili dalle incorporee ed intellegibili forme ideali. Tutto questo può essere senza dubbio inserito nella tradizione pitagorizzante dell’ultimo platonismo e della prima Accademia, considerando, ad esempio, che vari studiosi hanno ritenuto possibile che le lezioni orali di Platone fossero una reazione del filosofo a posizioni estreme dei suoi discepoli.
Per quanto riguarda, infine, la posizione di Aristotele nei confronti della teoria delle idee, rivolgeremo un breve accenno solo al Peri Ideon. Servendosi di argomenti che già circolavano in Accademia e di obiezioni più rigorose, Aristotele criticò vari punti della dottrina platonica, mettendone in evidenza anche aporie. Egli avversò non tanto l’universalità delle idee quanto la loro separazione dalle cose sensibili, mettendo in luce, ad esempio, tutti i problemi concernenti la predicazione. Aristotele ritenne che gli argomenti addotti dai sostenitori delle idee fossero passibili di una comune obiezione: quella, cioè, di non dimostrare l’esistenza di idee separate, ma solo l’esistenza di universali distinti dai particolari. Inoltre, se essi avessero dimostrato veramente le idee separate, avrebbero condotto a porre idee anche di cose che gli stessi platonici escludevano.
In generale si ha l’impressione che Aristotele nel Peri Ideon non abbia rivolto le sue critiche veramente contro la dottrina delle idee, ma contro gli argomenti usati dai suoi sostenitori e soprattutto contro la separazione, le cui aporie erano già state messe in luce dallo stesso Platone nel Parmenide e che è in fondo l’obiezione fondamentale mossa da Aristotele a Platone nella Metafisica.
Egli, inoltre, ha sottolineato come per tenere ferma la dottrina delle idee, bisognerebbe eliminare la dottrina dei principi, non totalmente conciliabile con l’originaria teoria delle idee. Anche in questo caso, Aristotele accogliendo di questa dottrina l’affermazione di un principio materiale opposto ad uno formale, ha richiamato nuovamente l’attenzione sulla necessità di superare la separazione fra idee e cose.
Egli, quindi, criticando tale separazione e trasformando il concetto di eidos in quello di morfe, cioè di forma non separabile dalla materia, ma immanente ad essa, ha dato alla teoria platonica un esito del tutto diverso da quello avuto con la teoria dei numeri di Speusippo e Senocrate.
I futuri sviluppi dei problemi della predicazione, del concetto di sostanza, di accidente, di forma, di essenza e di materia, – di cui si occuperà di lì a poco nelle Categorie -, le critiche alla dottrina platonica di Aristotele come degli altri accademici mostrano come l’Accademia fosse fondata sul “dialeghestai socratico” e come la formulazione di una dottrina propria dello Stagirita fosse avvenuta gradualmente, iniziando negli anni della sua permanenza alla scuola platonica.
Bibliografia essenziale
a – Le opere in traduzione italiana.
Aristotele, I Frammenti, a cura di G. Giannantoni, in Aristotele, Opere, vol. 11, Roma-Bari, Laterza, 1988.
Aristotele, La Metafisica, a cura di G. Reale, Napoli, 1968, 2 voll.
Aristotele, La Metafisica, traduzione di A. Russo, in Aristotele, Opere, vol. 6, Roma-Bari, Laterza, 1988.
Aristotele, La Metafisica, a cura di C. A. Viano, Torino, UTET, 1974.
Platone, Il Fedone, a cura di B. Centrone, Roma-Bari, Laterza, 1991.
Platone, Il Fedone, traduzione di M. Valgimigli, in Platone, Opere complete, vol. 1, Roma-Bari, Laterza, 1990.
Platone, Il Fedro, traduzione di P. Pucci, in Platone, Opere complete, vol. 3, Roma-Bari, Laterza, 1989.
Platone, Il Parmenide, in Platone, Opere complete, vol. 3, Roma-Bari, Laterza, 1989.
Platone, Il Sofista, in Paltone, Opere complete, vol.2, Roma – Bari, Laterza, 1989.
Platone, Il Timeo, con testo greco a fronte, a cura di G. Reale, Milano, Rusconi, 1994.
AA. VV., I Presocratici. Testimonianze e frammenti, 2 voll., Roma-Bari, Laterza, 1990, traduzione dal testo di Diels-Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker, Griechisch und deutsch, Berlin, 1951-52.
b – I commentari moderni.
Aristotelis Fragmenta selecta, recognovit brevique adnotatione critica instruxit W. D. Ross, Oxford Univ. Press, 19551, 1988.
Aristotle’s Metaphysics, with translation and commentary by W. D. Ross, 2 voll., Oxford Univ. Press, 19241, 1970.
Plato’s Phaedo, translated by J. Burnet, Oxford Univ. Press, 19001, 1958.
Plato’s Phaedo, with translation and commentary by R. Hackforth, Cambridge, 1960.
Plato Phaedo, edited by C. J. Rowe, Cambridge, 1993.
Plato’s Phaedrus, with translation and commentary by R. Hackforth, Cambridge, 1952.
Plato: Phaedrus, with translation and commentary by C. J. Rowe, Warminster, 19861, 1988.
c – Studi critici.
E. Berti, La filosofia del primo Aristotele, Padova, Cedam, 1962..
E. Berti, Profilo di Aristotele, Roma, Nuova Universale Studium, 1985.
E. Bignone, L’Aristotele perduto e la formazione filosofica di Epicuro, 2 voll., Firenze, La Nuova Italia, 1936.
A. P. Bos, Exoterikoi logoi and Enkyklioi logoi in the Corpus aristotelicum and origion of idea of the Enkiklios paideia, in Journal of the History of Ideas, 1989, L, 2, pp. 179-198.
A. P. Bos, Teologia cosmica e metacosmica nella filosofia greca e nello gnosticismo, in Rivista di Filosofia Neoscolastica, 1992, LXXXIV, 2-3, pp. 369-382.
A. P. Bos, Teologia cosmica e metacosmica. Per una nuova interpretazione dei dialoghi perduti giovanili, Milano, Vita e Pensiero, 1991, trad. ital. di E. Peroli da: A. P. Bos, Cosmic and meta-cosmic theology in Aristotle’s lost dialogues, Leiden, 1989.
H. Cherniss, L’enigma dell’Accademia antica, Firenze, La Nuova Italia, 1974, trad. ital. di L. Ferrero da: H. Cherniss, The Riddle of the Early Academy, Univ. of California Press, 1945.
I. Düring, Aristotele, Milano, Murzia, 1976, trad. ital. di P. Donini da: I Düring, Aristoteles. Darstellung und Interpretation seines Denkens, Heidelberg, 1966.
M. Isnardi-Parente, Studi sull’Accademia anntica platonica, Firenze, Olschki, 1979.
A. Jannone, I Logoi Essoterici di Aristotele, Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, a.a. 1954-55, tomo CXIII, pp. 1-31.
A. Jannone, Les oeuvres des jeunesse d’Aristote et les Logoi Essoterikoi, in Rivista di Cultura Classica e Medioevale, 1959, I, pp. 197-207.
W. Jaeger, Aristotele. Prime linee di una storia della sua evoluzione spirituale, trad. ital. di G. Calogero, Firenze, La Nuova Italia, 1984, versione autorizzata di G. Calogero, ristampa anastatica tratta dall’edizione pubblicata nel 1935 nella collana “Il pensiero storico”. Titolo originale dell’opera: Aristoteles. Grundlegung einer Geschichte seiner Entwicklung, Berlin, 1923.
R. Marten, Esoterik und Exoterik, in Esoterik und Exoterik der Philosophie, Basel, 1977, pp. 13-31.
P. Moraux, A la recherche de l’Aristote perdu. Le dialogue “Sur la justice”, Louvain, 1957.
P. Moraux, Les listes anciennes des ouvrages d’Aristote, Louvain, 1951.
E. Peroli, Una nuova interpretazione delle opere perdute di Aristotele, in Rivista di filosofia, 1991, pp. 495-511.
G. Reale, Storia della filosofia antica, 5 voll., Milano, Vita e Pensiero, 1975-801, 19948.
INTRODUZIONE AL “DE PHILOSOPHIA” E AL “PROTREPTICO”
A cura di Alessandra Quintiliani
Il De Philosophia e il Protreptico di Aristotele: due dialoghi perduti
Questa esposizione è volta all’esame, seppure sommario, di due tra più noti scritti essoterici di Aristotele: il De Philosophia e il Protreptico. Scritti in forma dialogica, fanno parte di quella produzione giovanile che ci permette – nonostante le limitazioni dovute alla scarsità dei frammenti superstiti – di seguire al meglio l’evoluzione dottrinale del filosofo e di stabilire l’esistenza o meno di un periodo di adesione al platonismo nella vita di Aristotele.
1. De Philosophia
1.1. La datazione
A causa dell’esiguo numero di frammenti giunti fino a noi e dell’incertezza sulle informazioni cronologiche, è molto difficile collocare con esattezza quali opere giovanili appartengono al periodo successivo ai due trattati Sulle Idee e Sul Bene.
Tuttavia, avendo come riferimento questi scritti e confrontando le loro dottrine con quelle dell’ultima produzione platonica, – di cui spesso ci sono richiami -, è possibile arrivare ad una approssimativa data di composizione.
Per quanto riguarda specificatamente il De philosophia, due sono le ipotesi più significative circa la datazione dell’opera. L’una è stata avanzata da Jaeger e accettata, per esempio, in parte da Unterstainer, l’altra è stata proposta da Theiler, trovando in seguito il supporto degli studi compiuti da Bignone, Nuyens, P. Moraux, Düring, Berti.
Secondo Jaeger, il dialogo, – rifiutando la dottrina delle idee separate e delle idee-numeri ed essendo su questo punto parallelo al I libro della Metafisica -, sarebbe posteriore alla morte di Platone, – a cui Aristotele alluderebbe nel fr. 6 -, e sarebbe stato composto quindi durante il soggiorno di Aristotele ad Asso (348/47 – 345/44 a.C.). Lo studioso, infatti, non ha ritenuto possibile che il filosofo avesse criticato una fondamentale teoria del maestro, quando questi era ancora in vita. Questa ipotesi è stata applicata da Jaeger anche ai due trattati Sulle Idee e Sul Bene, usualmente datati tra il 357/356 e il 355 a.C.
Prima del lavoro di Jaeger, invece, il Sulla Filosofia era generalmente considerato anteriore alla morte di Platone. A questa posizione si sono rifatti gli studiosi, – a cui si deve la seconda ipotesi sulla probabile datazione dello scritto aristotelico -, secondo i quali esso risalirebbe all’ultimo periodo della vita di Platone e sarebbe precedente anche ad un altro dialogo giovanile aristotelico, il Protreptico.
Tentare di stabilire il più correttamente possibile la data del De philosophia è di un’importanza notevole, dal momento che essa segna un certo significativo distacco da parte di Aristotele da alcuni aspetti della filosofia platonica. Egli, infatti, non solo riprende la critica della dottrina delle idee, ma espone una complessa concezione intorno al sapere, alla cosmologia, alla teologia e all’anima, che già rispecchia il grado di profondità raggiunto dal filosofo nella speculazione, ormai distante dal platonismo.
Tuttavia, esistono alcuni punti di contatto tra alcune teorie del Sulla Filosofia, – specialmente quelle del III libro, che contiene la prima “teologia” aristotelica -, ed alcune dell’ultimo Platone. In particolar modo questo scritto è stato generalmente confrontato con il Timeo, – composto dopo il 360 a.C., forse tra il 358-57 -, da alcuni considerato la probabile fonte o punto di partenza sia del De philosophia stesso, sia degli ultimi libri delle Leggi.
Il Timeo aveva sviluppato l’idea che il mondo sensibile fosse penetrato dall’ordine, dalla misura e dalla proporzione. Questa introduzione del numero e della misura avevano permesso una valorizzazione del mondo sensibile nel pensiero di Platone, cambiandone la visione ed attenuando quel pessimismo riscontrabile nel Fedone o in altri dialoghi della maturità.
Aristotele terrà conto di queste concezioni e di quelle analoghe del Filebo e nel De philosophia semplificherà la costruzione platonica, cercando di attenuare il contrasto tra il modello e la copia, estendendo al mondo sensibile ad esempio la prerogativa di quello ideale: l’eternità.
Da ciò si può congetturare, quindi, che il De Philosophia, denotando qualche richiamo al Timeo, sia stato scritto qualche tempo dopo quest’ultimo, probabilmente nel 355 o nel 354 a.C. A conferma di tale tesi, inoltre, si dovrebbe ricordare che la distanza tra il De Philosophia e Sul Bene non dovette essere molta, se ambedue presero spunto da teorie del Filebo e del Timeo e se il II libro del De Philosophia presuppone il trattato Sul Bene, riassumendolo e criticandolo.
1. 2. Il contenuto
Dopo aver concluso con gli studi superiori l’avviamento alla dialettica, in un primo tempo, – ossia con i dialoghi Sulle Idee e Sul Bene, che hanno il carattere di opere interne all’Accademia -, Aristotele approfondì i problemi riguardanti le idee e i principi supremi della realtà, nel modo in cui erano stati posti dal platonismo. In seguito ritenne necessario rendere nota, mediante la pubblicazione del dialogo De Philosophia, la sua posizione circa la sofia in generale ed i principi supremi che ne formano l’oggetto, criticando prima alcuni punti del platonismo e sviluppandone poi lo spunto per lui più fecondo, la trascendenza del divino.
L’opera è divisa in tre libri: nel primo Aristotele, attraverso una rassegna storica, ha enucleato il concetto di filosofia come conoscenza dei principi supremi della realtà; nel secondo ha criticato la dottrina delle idee e delle idee-numeri; nel terzo, infine, ha presentato la sua teologia e cosmogonia, introducendo molte novità rispetto al problema della trascendenza, vista non nel mondo delle idee, bensì nella “… prima e somma divinità (…)” (De Phil., fr. 1 Ross).
Dal momento che proprio i frammenti conservati del III libro contengono dottrine specifiche e nuove rispetto alla precedente produzione aristotelica, l’attenzione sarà rivolta su questi e in particolar modo su quelli riguardanti la nozione di anima.
Il fr. 26, riportato da Cicerone nel I libro del suo De natura deorum, è l’unico che si riferisca esplicitamente al III libro del De Philosophia. Senza entrare nell’ambito delle questioni che il brano ha posto, è necessario sottolineare come questo testo indichi chiaramente l’oggetto proprio III libro del De philosophia, attestando come in esso Aristotele si occupasse del problema del divino.
Nel testo si afferma che: “Aristotele nel terzo libro della sua opera Della filosofia molte cose confonde dissentendo dal suo maestro Platone. Ora infatti attribuisce tutta la divinità ad una mente, ora dice che il mondo stesso è dio, ora prepone al mondo un altro essere e gli affida il compito di reggere e governare il moto del mondo per mezzo di certe rivoluzioni e ritorni all’indietro, talora dice che dio è l’etere (il calore del cielo), non comprendendo che il cielo è una parte di quel mondo che altrove ha designato come dio (…)” (De Phil., fr. 26 Ross).
Stando alle affermazioni di Cicerone sembra che Aristotele trattasse in modo molto complesso il problema del divino, al punto da far supporre che tale argomento fosse presente nell’intero libro.
Questo frammento, come pure altri, pur trattando dell’esistenza di dio, non ne offre una vera e propria dimostrazione razionale. Tale dimostrazione si trova nel già citato fr. 16, costituito dal commento di Simplicio ad un brano del De caelo, in cui Aristotele espone sinteticamente una prova dell’immutabilità di dio.
In questo testo la dimostrazione dell’esistenza di dio come ottimo, – secondo Jaeger identica a quella denominata argumentum ex gradibus nei pensatori della Scolastica -, è condotta al fine di provare l’immutabilità di dio.
La dimostrazione secondo cui dio è ottimo costituisce, infatti, la premessa di quella secondo cui dio è immutabile. Se effettivamente la causa e il fine del mutamento è sempre il migliore, l’ottimo sarà sempre causa prima e fine ultimo di ogni mutamento degli altri enti, restando esso immutabile poiché perfetto.
Pur essendo questo argomento analogo a quello contenuto nella Repubblica di Platone (380 d – 381 c), come ricorda lo stesso Simplicio, c’è chi, come Berti, vede nel fr. 16 “contenuta implicitamente la famosa dottrina aristotelica del motore immobile, che muove tutte le cose come causa finale”. Egli, inoltre, crede che tale concezione sia presente, – assieme a quella di un dio cosmico, cioè il mondo stesso e in particolar modo, come si vedrà, la parte eterea di esso -, nel già esaminato fr. 26.
Di causa finale e della natura come fine tratta anche il fr. 28, desunto dalla Fisica aristotelica, che ben si ricollega al tema del precedente testo.
Da queste testimonianze e dal fr. 17 si può affermare che nel De Philosophia, la dimostrazione dell’esistenza di dio è condotta maggiormente attraverso prove di tipo teleologico e che dio è concepito come causa finale del cosmo. Respingendo, quindi, per questo aspetto la compagnia del Timeo platonico, ove il mondo è costruito dal demiurgo secondo il modello ideale, qui Aristotele sembra caratterizzare un dio “demiurgo” autore dell’ordine, non tanto come creatore, ma quanto come fine.
Che il dio inteso come puro pensiero, motore immobile e causa finale del cosmo, sia il vero concetto di dio del giovane Aristotele, è confermato, secondo Berti, dall’unico frammento conservato di un’altra opera giovanile, intitolata Sulla preghiera. Alle fine di esso, infatti, scrive Simplicio, Aristotele avrebbe concluso “che il dio o è intelligenza o qualcosa al di là dell’intelligenza” ( Sulla Preghiera, fr. 1 Ross).
Conseguenza della tesi secondo la quale dio sarebbe autore dell’ordine cosmico, come espressione della sua perfezione, è la dottrina dell’eternità del mondo, presente in più frammenti, presumibilmente appartenenti al III libro del De philosophia. I più importanti sono riportati da Filone nella sua opera De aeternitate mundi, dove, dopo aver esposto la dottrina stoica delle conflagrazioni cosmiche, contrappone la tesi aristotelica.
“Aristotele, devotamente e piamente opponendosi, diceva che l’universo è ingenerato e incorruttibile e accusava di terribile ateismo coloro che ritenevano il contrario e pensavano invece che non differisce in nulla da un manufatto questo dio visibile, questo universo divino che veramente abbraccia il sole, la luna e ogni altro pianeta e ogni altra stella fissa (…)”. (De Phil., fr. 1 Ross)
Da questo brano traspare una certa intonazione religiosa con cui il filosofo sostiene l’eternità del mondo. Questa, infatti, è ammessa per non accomunare l’ordine dell’universo ad un qualsiasi manufatto umano. Il cosmo, così, nel suo ordine è rivelatore dell’esistenza della divinità ed è talmente perfetto da essere considerato anch’esso in un certo senso divino. L’affermazione dell’eternità del mondo, tuttavia, non muta il carattere di subordinazione del mondo a dio, che anzi è necessaria poiché il mondo è manifestazione della divinità.
La teoria dell’eternità del mondo, – che si ritrova nella Fisica insieme alle tesi sul geocentrismo e sulla finitezza dello spazio, cardini fondamentali della concezione aristotelica dell’universo -, segna una novità rispetto al platonismo. Nel Timeo, infatti, Platone aveva affermato che tutto il cosmo non è stato sempre, ma è stato creato, cominciando da un principio, per opera di un artefice o Demiurgo, che lo ha formato a imitazione del modello eterno.
Secondo Jaeger la dottrina esposta nel De Philosophia è in netto contrasto con quella di Platone ed è la prova della rottura di Aristotele dal maestro. A tal proposito si dovrebbe notare, tuttavia, che nel testo sopra riportato le critiche aristoteliche non sembrano riferirsi con certezza a Platone, anzi probabilmente, come crede lo stesso Jaeger, sono rivolte agli atomisti. Inoltre, Platone nel Timeo al passo 37 d non affermò mai che il mondo dovesse perire; anzi nell’opera si legge che esso fu generato cercando di renderlo eterno come il modello ideale. In base a quest’ultima concezione, Bignone crede di poter affermare che Aristotele dovesse sentirsi vero interprete, e non critico, della dottrina di Platone, poiché insistendo sull’eternità del mondo, egli attestava il grande valore della tesi platonica della divinità del cosmo ordinato, sebbene giustificata diversamente dalla dottrina delle idee.
La tesi dell’eternità del mondo è attribuita ad Aristotele anche da Cicerone nel fr. 20 Ross del De Philosophia, dove si legge: “e una volta che questo tuo sapiente stoico ti avrà esposto punto per punto queste dottrine, verrà Aristotele, e fondendo l’aureo fiume della sua eloquenza, e ti dirà che quello è un insensato: giacché il mondo non ha mai avuto origine, poiché non vi è stato alcun inizio, per il sopravvenire di una nuova decisione, di un’opera così eccellente (…)”.
Poiché qui Aristotele sembra proporre anche un argomento contro la generazione del mondo, “si potrebbe credere di essere di fronte al più netto contrasto con la dottrina di Platone, invece ancora una volta si deve constatare una profonda dipendenza dello scolaro dagli insegnamenti del maestro. La ragione per cui Aristotele esclude che il mondo abbia avuto un inizio temporale è infatti l’impossibilità che un’opera così perfetta dipenda da un disegno concepito ad un certo momento e dunque non eterno. È questo il medesimo discorso fatto da Platone nel Timeo (29 a), dove si afferma che il mondo, essendo così bello, deve necessariamente avere per modello una realtà eterna, ossia il mondo ideale”. ( E. Berti, p. 363). Le due dottrine, quindi, sembrerebbero avere uno stesso fondamento, ossia quel convincimento platonico che la perfezione è propria dell’eterno: la sola differenza consisterebbe, quindi, nel rigetto da parte di Aristotele delle idee separate.
Strettamente collegata alle tesi sul divino e sull’eternità del mondo è la concezione della divinità degli astri. Di questa abbiamo testimonianza da Cicerone, il quale attesta quanto segue: “Le stelle poi occupano la zona eterea. E poiché questa è la più sottile di tutte ed è sempre in movimento e sempre mantiene la sua forza vitale, è necessario che quell’essere vivente che vi nasca sia di prontissima sensibilità e di prontissimo movimento. Per la qual cosa, dal momento che sono gli astri a nascere nell’etere, è logico che in essi siano insite sensibilità e intelligenza. Dal che risulta che gli astri devono essere ritenuti nel numero delle divinità (…)”. (De Phil., fr 21 Ross)
Dal testo emerge chiaramente l’animazione degli astri, i quali, essendo esseri animati posseggono la conoscenza, sia sensibile che intellettiva, ed il movimento. Essi, inoltre, vengono detti divini, poiché hanno le facoltà proprie degli esseri animati in un grado superiore. Queste tesi erano già state enunciate da Platone nel Timeo (38 e; 40 b), ma nel Peri Philosophia troviamo una prova della divinità degli astri assente dall’opera platonica. Aristotele, infatti, qui inserisce un nuovo elemento, l’etere, distinto dai quattro tradizionali, – terra, acqua, aria e fuoco -, più sottile e più mobile di tutti ed adatto più di ogni altro alla generazione degli esseri animati.
L’etere non sembra essere presente in nessuno dei dialoghi sicuramente platonici, fatta eccezione per un passo dell’Epinomide (981 c) sulla cui autenticità, però, ci sono forti dubbi. Nello stesso Timeo, inoltre, al passo 40 a dove vi è un elenco delle specie degli esseri viventi, si afferma che gli astri sono formati di fuoco. C’è chi, tuttavia, scorge nel passo 55 c di quest’opera un accenno alla dottrina dell’etere, dal momento che Platone afferma: “essendoci ancora una sola e quinta combinazione, di essa si servì dio per l’universo quando ne fece il disegno finale“.
In ogni modo, la dottrina di un quinto elemento più divino, di cui è formata la regione celeste, eterna e incorruttibile, non soggetta al divenire, caratterizzerà anche le teorie fisiche della maturità sugli elementi della realtà naturale.
Dall’inserimento di questo nuovo elemento, l’etere, non soggetto a generazione e corruzione, deriva l’incorruttibilità dei corpi celesti stessi.
Questi, nella seconda parte del fr. 21, vengono caratterizzati per il movimento volontario, fattore che maggiormente contribuisce a sottolinearne la divinità.
Divinità che Aristotele ribadisce, – come attesta Nemesio nel medesimo fr. 21 -, anche attraverso l’attribuzione agli astri del moto circolare. Essendo, infatti, questo movimento perfetto, poiché il suo inizio coincide con la sua fine, esso potrà caratterizzare solamente i corpi celesti.
I restanti frammenti riguardano la concezione dell’anima.
Un insieme di testimonianze, riportate per lo più da Cicerone e raccolte nel fr. 27, attribuisce al filosofo una particolare dottrina dell’anima, che ha causato notevoli difficoltà agli studiosi.
In una di esse si legge: “Aristotele (…) dopo aver considerato quei quattro ormai noti generi di principi, dai quali tutto ha origine, ritiene che vi sia una certa quinta natura, dalla quale deriva l’intelligenza (quintam quandam naturam…, e qua sit mens); pensare, infatti, e prevedere e imparare e insegnare e scoprire qualcosa e così via numerose altre cose, ricordarsi, amare e odiare, desiderare e temere, soffrire e godere: tutte queste cose e altre a queste simili egli ritiene che non possano essere insite in alcuno di quei quattro generi; aggiunge quindi un quinto genere privo di nome e così con nuovo nome chiama lo stesso animo endelecheia quasi fosse un certo movimento continuato e perenne (quintum genus adhibet vacans nomine et sic ipsum animum endelecheian appellat novo nomine quasi quandam continuatam motionem et perennem)“. ( De Phil., fr. 27 Ross)
Dal testo qui riportato risulta che Aristotele, ritenendo che le attività psichiche non potessero avere come principio i quattro elementi tradizionali a causa del loro carattere materiale, inserì una quinta quandam natura, che sarebbe stata propria dell’anima. Questa particolare natura sarebbe stata priva di nome, mentre l’anima sarebbe stata denominata con un nuovo termine, endelecheia, che, a detta di Cicerone, avrebbe significato un movimento continuato e perenne.
In un altro passo Cicerone sembra considerare la possibilità che l’anima sia “quella quinta natura non nominata, piuttosto che non compresa” (De Phil., fr. 27 Ross). In un terzo passo troviamo quanto segue: “se poi vi è una certa quinta natura, per la prima volta introdotta da Aristotele, questa è propria degli dei e delle anime. (…) Nessuna origine delle anime può essere rinvenuta nella terra. (…) E così qualsiasi è la cosa che sente, conosce, vive e vegeta, è necessario che essa sia celeste e divina e perciò stesso eterna. Né invero la stessa divinità, quale è intesa da noi, può essere intesa in altro modo se non come una certa mente separata e libera, distaccata da ogni commistura mortale, che tutto sente e muove, essa stessa fornita di un moto sempiterno. Di questo genere e di questa natura è l’intelligenza umana” ( De Phil., fr. 27 Ross).
Rispetto al precedente frammento questo testo introduce l’identificazione della natura divina con la natura della mente umana, affermando che essa è dotata di movimento eterno.
Le testimonianze qui riportate attribuiscono ad Aristotele una dottrina secondo cui l’anima possiede una particolare natura, diversa dai quattro elementi materiali, per cui sarebbe dotata di un movimento continuo, che ne giustificherebbe la denominazione di endelecheia.
La parola endelecheia, che deriva da en (uno) e delechos (lunghezza, sostantivo poi eliminato da mekos), significa appunto continuità, perpetuità.
Questa dottrina dell’endelecheia da alcuni critici è stata paragonata e messa in contrasto con quella natura dell’entelécheia (forma, atto del corpo), presente nel De Anima. Lo Heitz si convinse, ad esempio, che Cicerone fraintese il concetto di entelécheia, mutandolo in quello di endelecheia. Lo studioso, quindi, erroneamente corresse il testo ciceroniano in entelécheia, condannando come non esatta la testimonianza dello scrittore latino.
Fu il Bignone, in seguito, a rimettere ordine nella questione e a dimostrare che le testimonianze di Cicerone dovessero essere considerate veramente dottrine appartenenti al De Philosophia, essenzialmente diverse da quelle esposte nel De Anima. Lo studioso, infatti, si disse sicuro che Cicerone nei capitoli delle Tusculane, dove è presente la dottrina dell’anima endelecheia, seguisse fedelmente l’Aristotele delle opere pubblicate, di cui, per suo tramite, è possibile ricostruirne un’importante parte.
Studiando il concetto di endelecheia, Bignone mise in luce il carattere platonico-accademico dell’anima quinta natura come ciò che si muove da sé e che è principio di moto continuo e perenne. Egli ha ricordato, infatti, che la teoria dell’anima come “ciò che si muove da sé” (autokineton) o come “ciò che è sempre in movimento” (aeikineton) era già presente nel Fedro di Platone (245 c 6 sgg.), come prova della immortalità dell’anima stessa. A conferma del fatto che tale dottrina fosse professata dall’Accademia, Bignone ha ricordato Senocrate, il quale definiva l’anima come “il numero che muove se stesso” ( Senocrate, fr. 60).
“L’anima dunque – secondo lo studioso – è, per il primo Aristotele, immortale, per la sua endelecheia, per la sua stessa essenza che è la continuità. L’endelecheia basta per ciò come predicato all’anima, anche senza l’eterno moto, per determinare la suprema essenza”.
La designazione della quinta natura come vacans nomine trova riscontro, secondo Bignone, in Epicuro, il quale, per una probabile influenza aristotelica, inserì nella costituzione dell’anima un elemento akatonomaston, cioè appunto senza nome. Questa testimonianza epicurea è per noi molto importante perché prova che Cicerone con l’espressione vacans nomine traduce il termine greco akatonomastos, avendo quindi in mente il preciso testo greco di Aristotele. Tale termine greco, d’altronde, è presente anche nella testimonianza di Clemente Romano, inserita nel fr. 27. E’ significativo che mentre di questa dottrina aristotelica troviamo un palese riflesso in Epicuro, della dottrina dell’anima propria del periodo di scuola non si trovi alcun riferimento, neppure polemico. Ciò conferma, nuovamente, che per lungo tempo di Aristotele si conobbero solo le opere essoteriche, e che Epicuro avversò appunto queste opere, le sole che ebbe modo di leggere.
Concludendo la sua ricerca sull’anima quinta natura, Bignone sottolinea nuovamente come la dottrina dell’endelecheia del primo Aristotele non ha nulla a che fare con quella della maturo Aristotele dell’anima entelécheia, e deriva da quella platonico-accademica dell’anima come autokineton. Il concetto dell’anima endelecheia, abbandonato da Aristotele stesso in quanto designava continuità di esistenza, verrà soppiantato da quello di entelécheia, quale forma e atto del corpo organico, in accordo con la dottrina matura dell’anima, che non può sopravvivere alla dissoluzione del corpo nella morte. L’anima entelécheia, infatti, non può far parte che di un solo corpo, del suo corpo, e non passare di corpo in corpo.
Un contributo alla comprensione della nuova dottrina esposta nel De philosophia fu in seguito offerto dagli studi di S. Mariotti. L’accostamento dell’anima agli astri (“quintum genus, e quo essent astra mentesque …“), – presente in un’altra testimonianza di Cicerone, il fr. 27 Ross del De Phil.-, aveva fatto pensare che il quinto genere, di cui l’anima è costituita, fosse l’etere, già nominato in altri frammenti ed introdotto come elemento del cielo e degli astri.
Poiché l’etere è di natura materiale, anche se particolarissima, l’anima, qualora sia composta di questo elemento, sarebbe materiale.
L’identificazione dell’anima con l’etere avrebbe così comportato notevoli difficoltà, segnando una fase materialista nell’evoluzione della psicologia di Aristotele, che sarebbe in contrasto non solo con la sua filosofia della maturità, ma anche con quella delle opere giovanili, in particolare con quella dell’Eudemo dove l’anima è detta eidos ti, forma semplice. Tale incongruenza fu evidenziata, appunto, dal Mariotti, il quale credette di poter dimostrare che i passi che accennano alla quinta natura propria dell’anima e quelli che si riferiscono all’etere quinto elemento espongono due differenti dottrine. Secondo lo studioso, infatti, le due dottrine sono diverse e facilmente distinguibili: “da un lato la quinta natura vacans nomine, introdotta soltanto per giustificare i fenomeni spirituali (v. fr. 27), dall’altro il quinto elemento aither (etere), sostanza eterna del cielo e dei corpi celesti (v. frr. 21 e 26)”.
I due gruppi di testimonianze sarebbero segno, così, non solo di una diversa designazione dell’elemento, detto akatonomaston nel primo gruppo e aither nel secondo, ma anche di un’essenziale differenza dottrinale.
L’akatonomaston e l’etere sarebbero, a parere di Mariotti, due differenti formulazioni della dottrina della pempte ousia (quinta essenza), presente già nell’Accademia negli ultimi anni di vita di Platone. Esse “debbono rispecchiare due momenti diversi dell’evoluzione di Aristotele nei confronti della quinta essentia”. ( S. Mariotti) Egli, così, conclude che possa appartenere al De Philosophia solo la dottrina dell’etere e che le testimonianze sull’anima endelecheia e akatonomaston si riferiscano molto probabilmente all’Eudemo, ritenendo quest’opera anteriore al De philosophia, in base alla datazione dello Jaeger.
A tale interpretazione si oppose Berti, sottolineando l’attendibilità delle testimonianze di Cicerone e ritenendo le espressioni quintum genus e quinta natura riferimenti all’etere: “ha senso parlare di un quinto solo nell’ambito di un genere unico che comprenda altre quattro specie, ossia i quattro elementi tradizionali”. L’etere deve essere quindi inteso come un principio materiale. Poiché l’anima non può essere un principio materiale, Berti crede che l’identificazione di anima ed etere, attribuita ad Aristotele, sia una deviazione di alcuni elementi già visti del Timeo platonico e che la dottrina della quinta essenza non sia genuinamente aristotelica.
Un testo fondamentale ancor oggi per la completezza e la vastità dei riferimenti è lo studio condotto sulla quinta essentia da P. Moraux, apparso nel 1963 nella famosa Pauly-Wissowa.
Già nella prima pagina del suo testo, Moraux, – dopo aver ricordato come Aristotele presenti la dottrina della pempte ousia come propria -, affronta subito il problema dell’interpretazione materialistica della psicologia, che deriverebbe dall’identificazione della sostanza dell’anima con l’etere. Egli crede poco probabile l’attribuzione ad Aristotele di una simile psicologia materialistica, sottolineando come “negli ultimi anni si è pensato, sulla base di informazioni antiche poco affidabili, di poter trovare quest’identità (tra sostanza dell’anima ed etere) già nei dialoghi giovanili di Aristotele, oggi andati perduti”. Egli, infatti, ritiene quest’identità della sostanza dell’anima con la sostanza celeste uno sviluppo della dottrina della quinta essenza avutosi subito dopo Aristotele.
“La speculazione ellenistica sull’origine divino-celeste dell’anima e sul suo ritorno agli dei astrali dopo la morte, con la particolare miscela di elementi platonici, stoici e popolari, sembra aver influenzato gli antichi scrittori e storiografi, spingendoli ad attribuire ad Aristotele una forma posteriore della dottrina della quinta essenza”. Lo studioso, inoltre, rammenta come molti peripatetici, avvicinandosi al materialismo stoico, considerassero l’anima un corpo etereo. Chi esamina, invece, lo sviluppo della dottrina del nous in tutto il Corpus aristotelico si rende conto che il carattere immateriale delle operazioni psicologiche non viene mai messo in dubbio. Lo Stagirita ha basato, infatti, la sua noetica sempre sull’immaterialità del pensiero, pur ammettendo relazioni tra il pensiero e le altre attività dell’anima condizionata dal corpo. Ritenendo possibile l’esistenza di una fase materialistica nella psicologia aristotelica, si negherebbe conseguentemente il presupposto fondamentale in Aristotele dell’immaterialità del pensiero. Moraux, quindi, in base a tutti questi elementi ha sostenuto l’impossibilità di un’identificazione delle sostanze dell’anima con l’etere, sostanza celeste.
Dopo aver esaminato le teorie di Feracide di Siro, dei pitagorici in generale e di Filolao in particolare, secondo alcuni studiosi precursori della dottrina della quinta essenza, egli esamina il passo 53 e sgg. del Timeo, su cui la speculazione posteriore si è basata per dichiarare Platone stesso fondatore di questa teoria. Secondo Timeo 53 e sgg. le molecole dei quattro elementi tradizionali hanno le forme dei quattro poliedri regolari: il fuoco ha la forma del tetraedro, l’aria quella dell’ottaedro, l’acqua quella dell’icosaedro e la terra quella del cubo. Del restante poliedro regolare, il dodecaedro, al passo 55 c 6 si dice che il dio se ne servì per decorare l’universo. Platone nel Timeo si era avvalso degli sviluppi della stereometria, – della cui condizione deplorevole in Rep. VII, 528 a-d si lamentava -, e della prova definitiva, fornita dal matematico Teeteto (415-369 a.C.), sull’esistenza di soli cinque poliedri regolari. Proprio la tarda datazione di questa scoperta potrebbe essere una prova, secondo Moraux, del fatto che i pitagorici erano impossibilitati a formulare una dottrina del quinto elemento. Egli concede tutt’al più che “se la dottrina dei cinque elementi risale ai primi pitagorici, si è sviluppata del tutto indipendentemente da ogni riflessione matematica” .
Poiché sembra che Platone non si riferisca alla formazione delle molecole di un eventuale quinto corpo e che egli poco prima abbia nominato solo i quattro elementi tradizionali, Moraux non è d’accordo con quei studiosi che vogliono vedere nel brano del Timeo un insegnamento sul quinto elemento. Egli se mai concede che Platone possa aver indicato la strada verso questa dottrina, ma non averla percorsa interamente. Solo nell’Epinomide, infatti, scritto da Filippo di Opunte, l’etere, che non era noto a Platone come elemento a se stante ( nel Timeo, al passo 58 d, Platone afferma che, come del fuoco, ci sono numerose specie anche dell’aria, di cui la parte più pura è chiamata “etere”), diventa un quinto elemento, ripristinando, come appare al passo 981 b, la corrispondenza tra gli elementi naturali e i poliedri.
Il fatto che nell’Epinomide vi sia un quinto elemento prova, secondo Moraux, che nell’Accademia vi fossero innumerevoli discussioni su tale questione. Egli, quindi, non ritiene opportuno considerare il De Philosophia come il primo testo in cui sia presente la dottrina del quinto elemento, non considerando molto probabile, inoltre, che qui Aristotele abbia definito l’etere come pempton soma (quinto elemento).
Lo studioso, quindi, prosegue il suo lavoro esaminando la natura dell’etere negli scritti del Corpus aristotelico che ci sono giunti, per poi farne una trattazione in quelli perduti, in modo specifico nel De Philosophia.
Egli innanzitutto afferma che “gli sforzi dei commentatori antichi, che volevano ricostruire da queste osservazioni sparse una teoria sistematica, sono partiti dal presupposto sbagliato che Aristotele avesse concepito una dottrina organica della quinta essentia“. Moraux sostiene, infatti, che Aristotele abbia sostenuto nei dialoghi andati perduti una forma del tutto diversa della quinta essenza rispetto a ciò che apprendiamo dalle opere tramandateci.
Mentre nel De caelo, infatti, Aristotele ha dedotto l’esistenza di un primo corpo, dell’etere, considerandolo la materia degli astri o delle sfere astrali, nel De philosophia sembra aver parlato di una quinta natura, raffrontata ai quattro elementi tradizionali, come sostanza dell’anima o della ragione. Tuttavia, l’espressione caeli ardor, traduzione latina di aither, presente nel fr. 26 del De philosophia stesso, mostra come già qui si parlasse di una sostanza degli astri, – l’etere -, che Aristotele considerava dio o almeno divina, più o meno come egli dirà più tardi nel De caelo. Poiché, però, dal fr. 21 risulterebbe che il movimento degli astri sia volontario, il caeli ardor, o etere, del quale sono composti gli astri, sarebbe allora una specie di sostanza spirituale o dell’anima con una divina capacità di percezione (“caeli divinus ille sensus“). Nel De caelo, infatti, Aristotele, modificando la sua concezione precedente, considererà l’etere la causa del movimento degli astri, negando ad esso i fenomeni di coscienza dell’anima.
Egli, inoltre, non crede possibile trovare nelle testimonianze ciceroniane la benché minima prova che l’etere sia una sostanza spirituale o una sostanza dell’anima, poiché non viene mai detto che quel divinus ille sensus degli astri sia riconducibile all’etere. Moraux, quindi, conclude affermando che nel De Philosophia “è altamente probabile che l’etere non era concepito come sostanza dell’anima, bensì come un elemento molto sottile e mobile, che causava proprio grazie alla sua sottigliezza e mobilità l’alta intelligenza degli esseri viventi, cioè degli astri, che hanno origine in esso”.
Egli, infine, sottolineando l’eterogeneità della dottrina sulla sostanza dell’anima e di quella sull’etere, esclude che le nuove posizioni nel campo psicologico e in quello fisico si trovino in uno stesso dialogo. “Poiché la dottrina dell’etere viene riferita esplicitamente al De philosophia, si può presumere che la dottrina psicologica dell’akatonomaston era riferita nel dialogo Eudemo“.
Moraux in questo modo concorda su questo punto con le tesi del Mariotti, già delineate, ricordando anche che i dossografi e le fonti più tarde spesso hanno scambiato le due dottrine l’una con l’altra. I peripatetici tra Statone ed Andronico, prendendo spesso conoscenza dell’aristotelismo dalla tradizione piuttosto che dalle opere dello Stagirita, correvano il rischio di sostenere idee fortemente influenzate da concezioni contemporanee.
Le nuove forme, che la dottrina della quinta essenza assumeva sotto l’influsso della Stoa e del Neoplatonismo, venivano, così, spesso attribuite al fondatore della dottrina.
Unterstainer, ad esempio, concordando con le teorie di Luck, crede accettabile l’ipotesi secondo cui Cicerone abbia ricevuto la dottrina aristotelica attraverso il filtro di Antioco di Ascalonia, che a sua volta trasse determinati motivi da Posidonio.
Secondo lo studioso i risultati delle ricerche, quindi, sembrerebbero essere a sfavore della tesi dell’identità di sostanza dell’anima e corpo astrale negli scritti giovanili di Aristotele.
2. Protreptico
2.1. Ricostruzione del testo
Il Protreptico o Esortazione alla filosofia è stato il più letto ed apprezzato di tutti gli scritti pubblicati di Aristotele. La sua sorte, tuttavia, è stata alquanto singolare: pur essendo, infatti, una delle opere di cui si è conservato un minor numero di frammenti sicuri, la ricostruzione del suo testo ha avuto un’estensione maggiore degli altri scritti pubblicati.
Originariamente si disponeva solo dell’indicazione nei cataloghi di un’opera dal titolo Protreptico e di due testimonianze, rispettivamente di Zenone stoico, riportato da Stobeo, e di Alessandro d’Afrodisia. Decisiva fu a tal proposito l’ipotesi avanzata da Bywater nel 1869, che credette possibile trovare ampi brani del Protreptico aristotelico nell’omonimo libro di Giamblico, – in cui essi erano insieme a numerosi estratti da dialoghi platonici -, dal capitolo V al capitolo XII.
Le tesi di Bywater, che non si era reso conto della basilare scoperta fatta per un nuovo approccio alla ricostruzione dell’opera aristotelica, furono in seguito accolte pressoché nella loro interezza. Lo stesso Jaeger ha ritenuto derivante dal Protreptico aristotelico tutta la parte dello scritto di Giamblico considerata da Bywater, eccezioni fatta per il capitolo V e l’ultima parte del capitolo XII.
L’autenticità degli estratti di Giamblico sarebbe stata definitivamente acquisita, se il Rabinowitz non fosse intervenuto nel dibattito apportando teorie del tutto opposte a quelle ormai accettate dalla maggior parte degli studiosi. Egli, innanzitutto, ha eliminato la possibilità di utilizzare l’Hortensius ciceroniano, – di cui si era servito Bernays come opera modellata sul Protreptico aristotelico -, per ricostruire l’opera perduta dello Stagirita. Quindi ha fatto altrettanto con il Protreptico di Giamblico, mostrando l’originalità di questo autore nell’esposizione delle fonti e sottolineando come il capitolo VI della sua opera derivi da vari dialoghi platonici e dall’interpretazione di certe dottrine avanzate da Speusippo e da altri Accademici. Il risultato finale del suo studio, perciò, è stato l’impossibilità di poter effettuare una ricostruzione sufficientemente sicura del Protreptico aristotelico.
Düring, tuttavia, attraverso un’analisi metodologica, stilistica e linguistica, ha avversato l’ipotesi del Rabinowitz, ribadendo la possibilità di interpretare il Protreptico sulla base degli estratti di Giamblico. Questi, inoltre, ha insistito nell’affermare che tutti i testi rilevanti di Giamblico offrono l’impressione che questi non solo avesse diretto accesso al Protreptico di Aristotele, ma che egli avesse anche copiato verbatim tutti i passaggi direttamente dall’originale aristotelico. Düring ha verificato, infatti, che fra circa settecento termini particolarmente significativi usati da Giamblico nelle parti attribuite ad Aristotele, solo dodici non compaiono nell’Index aristotelicus del Bonitz.
2.2. La datazione
Il primo frammento del Protreptico è contenuto in un brano tratto Dall’epitome degli scritti di Telete, riportato da Stobeo, il quale riferisce una testimonianza di Zenone stoico, secondo la quale il cinico Cratete avrebbe letto nella bottega del calzolaio Filisco “il Protreptico che Aristotele indirizzò a Temisone, re di Cipro, in cui si diceva che nessuno altro più di lui si trovava ad avere un maggior numero di buone qualità per filosofare: possedeva infatti grandi ricchezze per poterne spendere in queste cose, e per di più godeva di ottima reputazione (…)” ( Protr., fr. 1 Ross).
Cercare di determinare il più possibile l’identità di Temisone, a cui appunto l’opera era dedicata, sarà di aiuto per collocare cronologicamente il Protreptico. Nel testo si legge semplicemente che questi era ton Kyprion Basilea (re dei Ciprioti); poiché poco prima del coinvolgimento di Cipro nella guerra contro i Persiani esistevano nell’isola nove grandi città, è probabile che Temisone regnasse su una di queste. Verosimilmente Aristotele entrò in contatto con Temisone, di cui forse divenne amico, tramite Eudemo, – a cui era dedicato l’omonimo dialogo -, suo amico originario di Cipro.
“In questo caso – scrive Berti -la composizione del Protreptico, dedicato o indirizzato a Temisone, dovette avvenire in un periodo non lontano da quello dell’amicizia fra Aristotele e Eudemo, quindi non molto tempo dopo la morte di Eudemo, accaduta nel 354″.
Un’ulteriore ipotesi potrebbe essere che la relazione tra Aristotele e Temisone fosse iniziata in seguito ai contatti sia culturali che politici venutisi ad instaurare tra i prìncipi ciprioti ed Atene verso la metà del IV secolo a.C. Per quanto riguarda, infatti, l’aspetto culturale è noto che Isocrate scrisse tre opere esortative ai prìncipi di Salamina, in Cipro. Questa notizia e il fatto che anche Aristotele indirizzò la sua opera ad un principe di Cipro sono elementi da non sottovalutare. Si può dedurre, infatti, da ciò che Aristotele, riprendendo la polemica contro la scuola isocratea ed il suo programma, – iniziata con il Grillo e qui estremizzata -, volesse portare il pensiero accademico dove era penetrato quello isocrateo.
Per quanto riguarda, invece, l’aspetto politico, dobbiamo ricordare la guerra, sopra citata, in cui fra il 351 e il 350 a.C. Cipro fu coinvolta contro i Persiani. È probabile, quindi, che prima di tale conflitto le relazioni fra Atene e Cipro si fossero intensificate notevolmente.
In ogni modo la conseguenza di tali ipotesi è che il Protreptico verosimilmente fu composto verso il 351-350 a.C., quindi durante il periodo accademico di Aristotele.
Tale datazione, inoltre, trova conferma dal fatto che nel fr. 12 del Protreptico stesso, – come vedremo meglio in seguito -, pare sia contenuta una risposta di Aristotele all’Antidosis di Isocrate. Ciò offre, così, un termine post quem per la collocazione dello scritto aristotelico, ossia l’anno 353 a.C., in cui appunto fu composta l’Antidosis, o il 352, anno in cui l’opera dovette essere nota in tutti gli ambienti culturali di Atene. È probabile, quindi, che Aristotele abbia scritto la sua esortazione poco dopo, altrimenti la sua polemica antiisocratea avrebbe perso la sua efficacia. Anche in base a questa notizia, di nuovo, si arriva all’anno 351 a.C., come data probabile di composizione, confermando i risultati precedenti.
2.3. Il contenuto
Il Protreptico non è un dialogo, ma più propriamente un’esortazione alla filosofia. Esso è una proclamazione entusiastica dell’ideale platonico della vita filosofica, il bios theoretikos, quale valore supremo e guida orientatrice anche della vita pratica. Così, una serie di argomentazioni dimostrative mira a sostenere ed a giustificare questa tesi centrale.
Aristotele chiarisce questo concetto nel fr. 5, proponendosi di mostrare che la scienza, la fronesis, è il più grande dei beni. Questa tesi era già stata sostenuta da Platone e molto significativo è che qui Aristotele usi il termine fronesis per designare appunto il concetto di scienza, come aveva fatto il suo maestro.
Nella seconda parte di questo frammento lo Stagirita, volendo riportare la discussione sulla filosofia, introduce il termine sofia (sapienza, filosofia), che egli considera sinonimo ed aspetto teoretico di fronesis.
Con tono esortativo, quindi, il filosofo afferma che la sofia è fra i massimi beni e dunque non bisogna fuggirla se si desidera vivere bene e far seguire agli altri non le opinioni dei più ma il vero sapere. La scienza che ha per fine supremo la theoria, ossia la pura speculazione, inoltre, è scienza più di quelle che hanno per fine qualche altra cosa, ossia le scienze poietiche, perché ha come scopo lo stesso conoscere, ed è più desiderabile delle altre, perché ha come fine se stessa, mentre le altre hanno per fine qualcosa di diverso.
Anche il capitolo VII del Protreptico di Giamblico è dedicato alla dimostrazione del valore supremo della filosofia rispetto a tutte le altre attività umane, mettendo in rilievo che il filosofare è desiderabile per se stesso, che esso è utile alla vita e che rende felici. La dimostrazione ha inizio col fr. 6, il quale si avvia con una famosa divisione delle parti dell’uomo e dell’anima: “e inoltre una parte di noi è l’anima e una parte è il corpo, l’una comanda e l’altra è comandata, l’una si serve dell’altra e l’altra sottostà come uno strumento. E l’uso di ciò che è comandato e di ciò che è strumento è sempre disposto in relazione a ciò che comanda e ne fa uso. Nell’anima poi ciò che comanda e giudica per noi è la ragione, mentre il resto ubbidisce e per natura è comandato. (…) Dunque l’anima è migliore del corpo (infatti è più adatta al comando) e nell’anima quella parte che possiede la ragione e il pensiero (…)” (Protr., fr. 6 Ross).
Da questo brano emergono due nozioni fondamentali: la concezione strumentalistica dei rapporti tra anima e corpo e la bipartizione dell’anima.
Del primo punto si è occupato per primo Nuyens, evidenziando come alla netta opposizione fra anima e corpo presente dell’Eudemo si sia sostituita nel Protreptico una collaborazione fra questi elementi. Qui il corpo, infatti, non è più un impedimento, ma uno strumento per l’azione dell’anima. Tale concezione, a suo avviso, segnerebbe un passo avanti nell’evoluzione di Aristotele dal platonismo verso una propria filosofia, che per quanto riguarda la psicologia è stata caratterizzata nel De Anima da una concezione ileomorfica.
Questa teoria è stata in seguito criticata da vari studiosi, i quali hanno osservato che lo stesso Platone nella Repubblica, reputando l’anima parte egemonica, implicava una concezione strumentalistica dei suoi rapporti col corpo. Tutto questo potrebbe significare che l’opposizione fra anima e corpo stabilita nell’Eudemo – per usare un’affermazione di Berti – “può dipendere dall’intento consolatorio del dialogo, naturalmente rivolto ad accentuare la finalità ultraterrena dell’anima, e comunque non può implicare un’adesione speculativamente impegnata ad una concezione contrastante con quella esposta nel Protreptico e con quella dello stesso Platone”.
Anche per quanto riguarda il secondo punto, cioè la bipartizione dell’anima, è possibile trovare dei precedenti in Platone.
Pur essendo l’anima tripartita in razionale (logistikon), animosa (thymoeides) e appetitiva (epithymetikon), come appare chiaramente in Repubblica, IV, 435 b sgg., in Fedro 246 a sgg. e in Timeo 69 c-71 a, vi è in Platone una certa tendenza a trasformare la divisione tripartita in quella bipartita, assumendo il thymoeides nell’epithymetikon. In Repubblica X, 608 d sgg. egli distingue la parte razionale dalle altre due unite insieme, in virtù della sua immortalità, ed in Timeo 65 a, 72 d afferma che questa è la divisione più importante.
La bipartizione dell’anima, caratteristica del Protreptico, è stata comunque abbandonata e criticata nel De Anima, specificatamente al passo 432 a 24-26, opera di intento prettamente scientifico, assente nei dialoghi giovanili.
Proseguendo nel ragionamento, discutendo sulla virtù Aristotele sottolinea come l’anima sia migliore del corpo, – poiché è più capace di comandare -, e come la ragione, o il pensiero, sia la parte migliore dell’anima. Aristotele, quindi, stabilendo attraverso la distinzione fra le parti dell’uomo e dell’anima una gerarchia di valori, consistenti nelle virtù proprie delle singole parti, pone al suo vertice la virtù della parte razionale, ossia della fronesis. La supremazia della parte razionale dell’anima viene ribadita da Aristotele, anche se in un’altra ottica, anche nel fr. 10 c. Qui, infatti, si legge: “nulla vi è di divino o di beato per gli uomini, se non ciò che è solo degno di attenzione e di cura, e cioè quanto vi è in noi di intelligenza e di saggezza; solo questo di noi sembra infatti essere immortale e solo questo divino (…)“.
Tale passo, in cui chiaramente si attribuisce l’immortalità al solo nous, è stato utilizzato da alcuni studiosi, tra cui Berti, come prova del fatto che nelle opere perdute, e nell’Eudemo in particolare, Aristotele considerasse immortale non l’intera anima, ma solo la parte razionale di essa come nel trattato della maturità, il De Anima. Questo brano, infatti, costituirebbe un riscontro di alcune affermazioni sul nous che nell’Eudemo si trovano,- come si è già avuto modo di sottolineare -, esclusivamente in un frammento, il fr. 2. Secondo tale testimonianza gli argomenti più degni di credito intorno all’immortalità dell’anima in Aristotele potrebbero adattarsi facilmente alla sola mente. Di diverso avviso è lo Jaeger, che crede che l’immortalità sostenuta nell’Eudemo sia da riferirsi all’intera anima. Tuttavia, per quanto riguarda il Protreptico riconosce il maggior valore che viene dato al nous.
Circa l’affermazione secondo cui noi siamo soltanto la parte razionale dell’anima, – affermazione interpretata dal Nuyens come residuo della psicologia dualistica dell’Eudemo, coesistente ma irriducibile alla nuova psicologia strumentalistica del Protreptico -, si deve notare che Aristotele pone questa alternativa accanto a quella che noi siamo soprattutto, ma non solo, la parte razionale, senza decidersi per nessuna delle due.
Particolarmente interessante è l’osservazione fatta da Aristotele verso la fine del fr. 6, – dopo aver individuato l’ergon (opera) proprio dell’uomo nella conoscenza al più alto grado, nella theoria -, a proposito della parte conoscitiva dell’anima. Essa, sostiene il filosofo, può essere sia separata sia unita alle altre.
Su quest’affermazione si è basato Berti, – che considera il Protreptico come la sintesi della filosofia del primo Aristotele ed il programma di tutta la sua attività futura -, per dire che “con queste parole Aristotele mostra chiaramente che fra la psicologia dell’Eudemo, che considera la parte razionale dell’anima, cioè il nous, come sostanza autonoma, e la psicologia del De Anima, che considera l’anima forma del corpo, inseparabile da esso, non c’è contraddizione. Quella che nell’Eudemo è sostanza separata non è l’intera anima, ma solo la parte razionale, e quella che nel De Anima è inseparabile dal corpo non è la parte razionale, ma il resto dell’anima. Pertanto la parte razionale può stare sia separata che unita al resto dell’anima e, con questa, al corpo”.
Ancora in un altro testo, il fr. 10 b, Aristotele affronta il rapporto fra anima e corpo, con un profondo pessimismo, che caratterizza anche il precedente brano, il fr. 10 a. Il filosofo, infatti, avendo terminato le argomentazioni razionali per dimostrare il valore della filosofia, conclude la sua esortazione mediante un richiamo all’esperienza vissuta di ogni uomo.
Se ben guardiamo, ricorda lo Stagirita, ci rendiamo conto che le cose ritenute grandi dagli uomini sono solo illusorie, o più letteralmente, sono solo un gioco d’ombre (skiagrafian).
“Onde opportunamente si dice che nulla è l’uomo e che nulla è saldo tra le cose umane“. ( Protr., fr. 10 a Ross)
É in questo contesto che Aristotele riguardo all’unione dell’anima al corpo afferma: “noi siamo soggetti ad un supplizio analogo a quello di coloro che in altri tempi, quando cadevano nelle mani dei pirati Etruschi, erano uccisi con meditata crudeltà: i loro corpi ancora vivi erano infatti congiunti a cadaveri facendo combaciare con la massima esattezza possibile fronte a fronte le varie parti. Così le nostre anime sono riunite con i corpi, come i vivi sono congiunti con i morti“. (Protr., fr. 10 b Ross)
Le considerazioni espresse in questi due testi sono state spesso interpretate come manifestazione di un profondo pessimismo. Soprattutto “il richiamo, quale paragone, alla tortura che i pirati etruschi infliggevano ai prigionieri (…) è di una espressività icastica orripilante. Platone non ha mai trovato un’immagine così efficace precisa e impressionante. La convinzione dell’immortalità e la sete dell’al di là è più bruciante ancora che nell’Eudemo; il pessimismo sulla vita terrena si è espresso in accenti e con immagini che sarà raro ritrovare nella storia dell’umanità”. (G. Soleri)
Eppure, in altri casi, il riconoscimento della vanità e della fuggevolezza delle cose terrene e l’infelicità della condizione umana dovuta ai legami dell’anima col corpo sono stati interpretati come richiami all’insufficienza dei beni terreni in relazione alla felicità dell’uomo e in confronto con la grandezza e l’eternità dei valori cui mira la filosofia. Ancora una volta, quindi, la filosofia è intesa quale mezzo per una piena comprensione del mondo e quale massimo bene.
Il fr. 11 del Protreptico contiene delle nozioni che saranno decisive nel successivo pensiero aristotelico; vi è presente, infatti, in nuce la dottrina teleologica sulla natura. Qui Aristotele prosegue la dimostrazione del valore sommo della fronesis, mostrando come la tendenza che ciascuna cosa possiede è in virtù della natura. “Delle cose che sono generate, – si legge -, alcune sono generate da una certa intelligenza e arte, per esempio, la casa e la nave (la causa di entrambe è infatti un’arte determinata e l’intelligenza); altre sono generate non per arte alcuna ma per natura: degli esseri viventi e delle piante, infatti, la causa è la natura e per natura sono generate tutte le cose di tal specie; altre però sono generate anche per caso, e sono tutte quelle che non sono generate né per arte, né per natura, né da necessità, e tutte queste cose, molto numerose, noi diciamo che sono generate per caso (…)“. ( Protr., fr. 11 Ross)
La tripartizione delle cause per cui si generano le cose ritorna costantemente nelle opere della maturità, ad es. nei passi VII, 7, 1032 a 12 e XII, 3, 1070 a 6 della Metafisica, ma, come sottolinea lo Jaeger, mai con tanta chiarezza ed energia come in questo luogo.
Se si continua ad andare avanti nell’esame di questo frammento, risulterà evidente innanzitutto l’esclusione di ogni finalità dal caso e per converso il ritrovamento di una finalità nell’arte. Proprio sulla presenza della finalità nell’arte, che Aristotele ritiene una nozione ormai già assunta, si basa la dimostrazione della finalità della natura. Le nozioni fondamentali in questo passo, dunque, sono essenzialmente l’imitazione della natura da parte dell’arte ed il finalismo della natura.
Come si è già ricordato nel precedente capitolo, un segno della presenza di questa nuova nozione in Aristotele si ha già nel De Philosophia, precisamente nel fr. 21 e soprattutto nel fr. 17. Qui i concetti di kata fysin (secondo natura) e para fysin (contro natura) equivalgono rispettivamente a quelli di kosmos (ordine) e akosmia (disordine), per cui la fysis è intesa come ordine razionale. Anche nel Protreptico ciò che è conforme a natura (to kata fysin) si genera in vista di un fine. La natura è allora la direzione, l’orientamento, verso un fine, l’ordine avente come suo principio un fine a cui tendere, l’organizzazione degli enti in vista del fine proprio.
Basandosi su ciò, Aristotele potrà ribadire il valore della fronesis, evidenziando come il fine naturale dell’uomo sia il fronein e mostrando nuovamente come tutto l’ordine naturale, organizzato secondo una successione gerarchica ascendente, sia regolato dalla razionalità.
Finora Aristotele ha mostrato che la filosofia è possibile, vantaggiosa e buona. Ora, secondo la consuetudine delle esortazioni, egli dimostra che essa è anche utile alla vita pratica e piacevole. A tale scopo è dedicato il resto del Protreptico.
Nel fr. 12, tuttavia, Aristotele pone una pregiudiziale, dichiarando che la filosofia, prima che utile, è buona, ossia vale per se stessa, il che conta più dell’utilità. “Ma il ricercare di ogni scienza un qualche risultato che sia diverso dalla scienza stessa e che questa scienza debba essere utile è proprio di chi assolutamente ignora la distanza che c’è, fin dall’origine, tra le cose buone e le necessarie: questa distanza è la maggiore possibile. Infatti alcune cose, senza le quali è impossibile vivere, le amiamo in vista di qualcosa di diverso da esse: e queste bisogna chiamarle necessarie e cause concomitanti; altre invece le amiamo per se stesse, anche se non ne consegua nulla di diverso, e queste dobbiamo chiamarle propriamente beni. Non è possibile infatti che una determinata cosa meriti di essere scelta in vista di un’altra, questa in vista di un’altra ancora e così proseguendo andare all’infinito: a un certo momento, invece, questo passaggio si ferma. Sarebbe quindi del tutto ridicolo cercare di ogni cosa un’utilità diversa dalla cosa stessa, e domandare: “che cosa ci è giovevole?”, “che cosa ci è utile?”. Giacché in verità, così ritengo, colui che ponesse queste domande non assomiglierebbe in nulla ad uno che conosce ciò che è bello e buono né ad uno che sa riconoscere che cosa è causa e che cosa è concomitante (…)“. ( Protr., fr. 12 Ross) Il tono chiaramente polemico del passo fa supporre che Aristotele qui stia criticando una posizione ben definita, contro la quale difendere l’ideale di vita puramente teoretica. Quasi sicuramente tale posizione non può che essere quella di Isocrate e della sua scuola.
Nel Protreptico Aristotele, a differenza di quanto fatto nel Grillo, cerca di battere Isocrate non criticando il modello su cui si basa la retorica dell’avversario, ma mostrando il valore primario della filosofia, su cui poggia tutta la paideía platonica. E Isocrate nell’Antidosis, – scritto nel 353 a.C. -, aveva attaccato aspramente proprio questo valore. Egli nel testo aveva affermato che le discipline degli Accademici non hanno nulla di utile né agli affari privati né a quelli pubblici, e non giovano all’azione pratica. Questi, infatti, riponeva il valore del sapere nella sua sola utilità pratica.
La coincidenza fra questa posizione e quella attaccata da Aristotele nel fr. 12 del Protreptico è perfetta, per dubitare che qui egli si riferisca appunto al Isocrate.
In base alle ultime cose evidenziate ed al tono generale dell’opera, concludendo, si può ribadire che il Protreptico sottolinei la superiorità della teoresi sulla prassi e il valore autonomo della contemplazione speculativa, tesi fondamentale del pensiero aristotelico.
Bibliografia essenziale
a – Le opere in traduzione italiana.
Aristotele, I Frammenti, a cura di G. Giannantoni, in Aristotele, Opere, vol. 11, Roma-Bari, Laterza, 1988.
Aristotele, La Metafisica, a cura di G. Reale, Napoli, 1968, 2 voll.
Aristotele, La Metafisica, traduzione di A. Russo, in Aristotele, Opere, vol. 6, Roma-Bari, Laterza, 1988.
Aristotele, La Metafisica, a cura di C. A. Viano, Torino, UTET, 1974.
Platone, Il Timeo, con testo greco a fronte, a cura di G. Reale, Milano, Rusconi, 1994.
Senocrate, I Frammenti, testo greco, introduzione, traduzione e commentario a cura di M. Isnardi-Parente, Napoli, Bibliopolis, 1982.
Speusippo, I Frammenti, testo greco, introduzione, traduzione e commentario a cura di M. Isnardi-Parente, Napoli, Bibliopolis, 1980.
b – I commentari moderni.
Aristotelis De Anima, recognovit brevique adnotatione critica instruxit W. D. Ross, Oxford Univ. Press, 19611, 1988.
Aristotelis Fragmenta selecta, recognovit brevique adnotatione critica instruxit W. D. Ross, Oxford Univ. Press, 19551, 1988.
Aristotle’s Metaphysics, with translation and commentary by W. D. Ross, 2 voll., Oxford Univ. Press, 19241, 1970.
c – Indici e Lessici.
Index Aristotelicus di H. Bonitz, nel V vol. dell’edizione delle opere di Aristotele dell’Accademia di Berlino. Riproduzione anastatica: H. Bonitz, Index Aristotelicus, Wissenschaftlische Buchgesellschaft, Darmstadt, 1955.
Lexicon Platonicum, sive vocum Platonicarum index, condidit D. Fridericus Astius, Lipsiae, 3 voll., 1835-38; ristampa anastatica in 2 voll., Wissenschaftlische Buchgesellschaft, Darmstadt, 1956.
L. Brandwood, A Word Index to Plato, Maney, Leeds, 1976.
d – Studi critici.
E. Berti, Aristotele: dalla dialettica alla filosofia prima, Padova, Cedam, 1977.
E. Berti, La filosofia del primo Aristotele, Padova, Cedam, 1962.
E. Berti, Il concetto di “sostanza prima” nel libro Z della Metafisica, in Rivista di filosofia, 1989, LXXX, 1, pp. 4-23.
E. Berti, Profilo di Aristotele, Roma, Nuova Universale Studium, 1985.
A. P. Bos, Teologia cosmica e metacosmica. Per una nuova interpretazione dei dialoghi perduti giovanili, Milano, Vita e Pensiero, 1991, trad. ital. di E. Peroli da: A. P. Bos, Cosmic and meta-cosmic theology in Aristotle’s lost dialogues, Leiden, 1989.
B. Dumolin, Recherches sur le premier Aristote. Eudème, De la philosophie, Protreptique, Paris Vrin, 1981.
I. Düring, Aristotele, Milano, Murzia, 1976, trad. ital. di P. Donini da: I Düring, Aristoteles. Darstellung und Interpretation seines Denkens, Heidelberg, 1966.
K. Gaiser, Platons Ungeschriebene Lehre. Studien zu systematischen und geschichtlichen Begründung der Wissenschaften in der Platonischen Schule. Mit einen Anhang: Testimonia Platonica. Quellentexte zur Schule und mündlichen Lehre Platons, Stuttgart, 19631, 1968.
M. Isnardi-Parente, Studi sull’Accademia anntica platonica, Firenze, Olschki, 1979.
W. Jaeger, Aristotele. Prime linee di una storia della sua evoluzione spirituale, trad. ital. di G. Calogero, Firenze, La Nuova Italia, 1984, versione autorizzata di G. Calogero, ristampa anastatica tratta dall’edizione pubblicata nel 1935 nella collana “Il pensiero storico”. Titolo originale dell’opera: Aristoteles. Grundlegung einer Geschichte seiner Entwicklung, Berlin, 1923.
Ch. Lefèvre, “Quinta natura” et psycologie aristotélicienne, in Revue Philosophique de Louvain, 1971, LXIX, pp. 5-43.
S. Mariotti, La Quinta Essentia nell’Aristotele perduto e nell’Accademia, in Rivista di filologia e di istruzione classica, n.s. 18, 1940, pp. 179-189.
P. Moraux, A la recherche de l’Aristote perdu. Le dialogue “Sur la justice”, Louvain, 1957.
P. Moraux, Les listes anciennes des ouvrages d’Aristote, Louvain, 1951.
P. Moraux, sotto la voce: “Quinta Essentia”, nella Pauly-Wissowa, R. E., Hb. Bd 47, Stuttgart, 1963, pp. 1171-1266.
E. Peroli, Una nuova interpretazione delle opere perdute di Aristotele, in Rivista di filosofia, 1991, pp. 495-511.
G. Reale, Introduzione a Aristotele, Roma-Bari, Laterza, 1989.
G. Reale, Storia della filosofia antica, 5 voll., Milano, Vita e Pensiero, 1975-801, 19948.
G. Soleri, L’immortalità dell’anima in Aristotele, Torino, 1952.
M. Untersteiner, Aristotele. Della filosofia, Roma, Ed. di Storia e Letteratura, 1963.
LA TEORIA DEL SOGNO
A cura di Alessandra Quintiliani
La teoria del sogno in Aristotele
Noi uomini trascorriamo circa la metà della nostra esistenza tra le braccia di Morfeo.
Questo è tanto più vero se si pensa che il sonno inizia – sorprendentemente – già nell’utero materno: dal settimo mese di gestazione si rileva, infatti, nel feto l’avvicendamento di brevi periodi di sonno a periodi di risveglio.
L’individuo adulto, invece, dorme – quando non sopraggiungano impedimenti esterni o problematiche legate alla salute – in media otto ore a notte, cioè un terzo della giornata. Ed il ritmo sonno-veglia, – che è presente sia nel mondo vegetale che in quello animale -, scandisce la vita biologica del singolo, permettendo il recupero psico-fisiologico del corpo.
In realtà, gli studiosi non hanno ancora compreso perché esista il sonno. Se, infatti, il sonno fosse solamente un meccanismo creato dal corpo per recuperare le energie disperse durante la veglia, potrebbe essere sufficiente un semplice riposo in cui fossero però presenti le attività tipiche della veglia. Alcuni sostengono, quindi, che il sonno sia nato durante l’evoluzione come strategia di “risparmio” delle energie. Nella notte, infatti, il metabolismo e la temperatura corporea si abbassano, per cui si potrebbe ipotizzare che il sonno abbia un senso legato più a necessità del cervello che non a quello dell’organismo. Molti ricercatori ritengono, così, che durante il sonno il cervello abbia modo di riorganizzare i suoi sistemi: un po’ come fa un computer che riorganizza i suoi documenti sul disco rigido. Il sonno, secondo questa teoria, potrebbe essere utile per permettere al cervello di immagazzinare la memoria di tutto quello che è accaduto durante il giorno.
Esistono, però, anche altre ipotesi che individuano, per esempio, nel sonno uno strumento fondamentale per la difesa del nostro sistema immunitario. Ed, in effetti, quando si hanno infezioni virali in corso, come può essere una semplice influenza, l’organismo è stimolato maggiormente al sonno da sostanze create ad hoc dal sistema immunitario.
Nonostante gli studi compiuti, tuttavia, la scienza non riesce ancora a dar ragione in maniera completa al valore del sonno per l’essere umano. L’unica certezza è che esso costituisca una funzione essenziale per l’uomo.
Ora, durante il sonno l’uomo sogna. Ogni individuo sogna in media un’ora e mezza a notte durante la fase più profonda del sonno, la cosiddetta fase REM (Rapid Eyes Moviments), durante la quale – come indica la sigla – gli occhi si muovono rapidamente, la respirazione si modifica ed il battito cardiaco aumenta.
Gli studiosi, soprattutto quelli moderni (1), hanno da sempre nutrito uno spiccato interesse verso i sogni, soprattutto sulla loro origine e sul loro significato, poiché rivelatori di alcuni meccanismi del funzionamento del cervello. In realtà – come per il sonno – ancora non siamo riusciti a comprendere perché esista il sogno e quale sia la sua utilità.
Anche i ricercatori antichi, in effetti, non sono stati meno attratti dalla natura e dal senso dell’attività onirica.
Nell’antichità il sonno ha affascinato e prodotto domande spesso in relazione all’interpretazione dei sogni e delle esperienze estatiche in esso prodotti.
“L’uomo ha in comune con pochissimi mammiferi superiori il curioso privilegio della cittadinanza di due mondi; egli, infatti, incontra ogni giorno alternativamente due distinti tipi di esperienza – ypar (veglia) e onar (sogno) li chiamavano i Greci – ciascuno con la propria logica e i propri limiti, e non ha ragione di ritenere l’uno più valido dell’altro. Il mondo dello stato di veglia ha, sì, certi vantaggi di concretezza e continuità, ma le sue possibilità sociali sono assai ristrette: vi incontriamo soltanto i nostri conoscenti, mentre nel mondo dei sogni si possono avvicinare, sia pure di sfuggita, gli amici lontani, i morti, gli dèi; normalmente è l’unica esperienza che ci sottrae alla tirannia penosa e incomprensibile del tempo e dello spazio” (2).
L’antichità in generale, – come pure oggi molte popolazioni primitive -, ha attribuito ad alcuni tipi di esperienze oniriche una realtà pari a quella dello stato di veglia, anche se qualitativamente diversa da essa. Si pensi solamente agli egizi o alla cultura giudaico-cristiana o, ancora, a quella islamica, in cui i sogni spesso apparivano come messaggi di dio.
Basti ricordare a mo’ di esempio il brano del Nuovo Testamento in cui un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe, avvertendolo di fuggire in Egitto con Maria e Gesù, poiché Erode aveva ordinato l’uccisione dei bambini di Betlemme dai due anni in giù (3).
Anche i Greci non si differenziarono in questo dalle civiltà loro contemporanee, ci basta far riferimento ai poemi omerici, dove quasi tutte le descrizioni dei sogni vengono trattate come realtà oggettive, spesso come manifestazioni del divino.
“Il carattere “divino” dei sogni greci, tuttavia, non sembra dipendere esclusivamente dall’identità manifesta della figura onirica: era importante anche l’immediatezza (enárgeia) del messaggio. In vari sogni, in Omero, il dio o eidolon appare al sognatore sotto le sembianze di un amico vivo” (4).
Spesso il sogno “divino” tanto atteso veniva perfino provocato attraverso tecniche particolari, quali l’isolamento, la preghiera, il digiuno e l’incubazione (5) o una combinazione di queste pratiche.
Il sogno, poi, era ritenuto anche un’esperienza avuta dall’anima, uscita temporaneamente fuori dal corpo.
Se restringiamo il campo della nostra ricerca ad Aristotele, si noterà come il sogno sia stato spesso al centro delle sue indagini, soprattutto nella prima produzione intellettuale. Ed, anzi, è possibile collocare le affermazioni di Aristotele più propriamente nel rapporto tra l’anima e l’esperienza onirica.
Alcuni dei frammenti di due opere essoteriche quali l’Eudemo e il De philosophia e alcuni degli otto brevi trattati di storia naturale, chiamati appunto Parva Naturalia, quali Sui sogni, Sulle divinazioni nel sonno e Del sonno e della veglia, testimoniano come il filosofo si sia occupato di tale relazione, fornendo un contributo rigoroso molto importante.
1. De Somno et vigilia
Partiamo proprio dai Parva Naturalia che, composti in una fase intermedia, rivestono assieme agli altri scritti di filosofia della natura appartenenti all’ultimo periodo ateniese, come il De generatione et corruptione, la Historia animalium o il De partibus animalium, un ruolo storico molto importante. Gli studi condotti sulla biologia, la genetica, la fisiologia degli animali, la meteorologia, infatti, costituiscono la testimonianza del un nuovo interesse per la ricerca sperimentale e per la raccolta di dati empirici, che hanno portato allo sviluppo di una nuova concezione della scienza.
Iniziamo ora dall’opera De Somno et vigilia (6), che contiene affermazioni molto utili a comprendere le definizioni che Aristotele fornisce sul sonno. Il filosofo reputa il sonno e la veglia, poiché sono opposti, appartenere alla medesima parte dell’animale e considera il sonno come una privazione della veglia. Infatti, scrive al passo 454a, che possiamo riconoscere con lo stesso criterio quando un individuo è sveglio o dorme:
“In realtà riteniamo che sta sveglio chi ha le sensazioni e che chiunque sta sveglio percepisce qualunque stimolo gli venga dall’esterno o si formi in lui. Ora, se lo stato di veglia in nient’altro consiste che nell’esercitare le sensazioni, è chiaro che con quella parte di anima con cui hanno le sensazioni gli animali sono svegli quando sono svegli, e dormano quando dormono.”
Proseguendo l’esame del testo, dal passo 454 b al passo 455 b 20, risulta evidente che il filosofo considera il dormire una necessità degli animali in genere. Ogni essere che veglia, infatti, deve avere la possibilità di dormire, dal momento che non è possibile che resti sempre in attività. Ugualmente nessun animale può sempre dormire.
Interessante è, poi, la definizione del sonno come affezione della parte sensitiva:
“Dunque che tutti gli esseri viventi partecipano del sonno è chiaro da queste considerazioni. L’animale, infatti, è definito dal possesso della sensazione, e diciamo che il sonno è in qualche modo l’immobilità e quasi la paralisi della sensibilità, mentre la veglia ne è lo scioglimento e la liberazione. (…)
Poiché è impossibile nel modo più assoluto che un animale mentre dorme eserciti qualsivoglia sensazione, è chiaro che nello stato chiamato sonno tutti i sensi si trovano nella stessa condizione. (…)
E’ chiaro quindi per molte ragioni che il sonno non consiste in ciò che i sensi stanno inattivi e non se ne fa uso, o che non sono in grado di sentire. (…)
Il sonno sopraggiunge quando l’impossibilità di usare i sensi colpisce non un sensorio qualunque, né per un motivo qualunque, ma, come s’è detto adesso, l’organo primario (il tatto) mediante il quale uno sente tutte le cose.“
Nell’ultima parte del testo, dove si afferma chiaramente che il sonno ha per scopo quello di preservare la vita animale, è interessante vedere come il filosofo consideri il sonno prodotto dall’evaporazione dovuta al cibo.
“In realtà si produce il sonno quando l’elemento corporeo viene trascinato in alto dal calore attraverso le vene fino alla testa. (…)
L’animale si sveglia quando la digestione è terminata, quando cioè il calore che in grande quantità era stato concentrato dalle regioni vicine entro un piccolo spazio prevale e il sangue più corposo è separato da quello più puro. (…)
Si è detto, dunque, qual è la causa del sonno: esso consiste nella recessione in massa compatta dell’elemento corporeo trascinato in alt dal calore naturale verso l’organo sensoriale primario – e che cos’è il sonno – esso è la paralisi dell’organo sensoriale primario che lo rende incapace di agire e che si produce necessariamente in vista della conservazione dell’animale (perché non può esistere l’animale se non si realizzano le condizioni che lo rendono tale): ora il riposo lo conserva.“
2. Sui sogni
Anche il breve saggio Sui Sogni ci fornisce elementi interessanti per ricostruire la teoria aristotelica del sonno, soprattutto sul modo di prodursi del sogno.
Aristotele apre il trattato affermando la necessità di ricercare a quale facoltà, intellettiva o sensitiva, appartenga appunto il sogno.
Egli ritiene che l’attività onirica non possa appartenere né alla facoltà opinativa, né a quella intellettiva e neppure a quella sensitiva, quest’ultima assolutamente intesa (7). Se fosse così, infatti, durante il sonno l’individuo avrebbe la possibilità di vedere o ascoltare, mentre in realtà nel sonno non si vede, non si ascolta, insomma non si percepisce niente (8). D’altra parte è chiaro che i sensi subiscono comunque degli stimoli, come se si trovassero nello stato di veglia.
Ciò premesso, resta l’esigenza di procedere nella ricerca.
Esaminiamo i passi 459 a 10 –25 e 459 b 1 – 10:
“Bisogna quindi esaminare come e in che modo si produce il sogno. Resti stabilito, e ciò è del resto evidente, che il sognare è un’affezione della facoltà sensitiva, se è vero che lo è anche il sonno, perché non ad una facoltà degli animali appartiene il sonno, a un’altra il sognare, ma alla stessa. Dell’immaginazione si è trattato nei libri Sull’Anima e si è dimostrato che la facoltà immaginativa è la stessa che la sensitiva, ma che la nozione della facoltà immaginativa è diversa da quella della facoltà sensitiva: l’immaginazione in realtà è un movimento prodotto dal senso quand’è in atto: ora il sogno par che sia un’immagine (e noi diciamo sogno l’immagine prodotta durante il sonno sia in maniera assoluta, sia in qualche maniera): è chiaro, pertanto, che il sognare appartiene alla facoltà sensitiva, e le appartiene in quanto è immaginativa.
Che cos’è il sogno e come si produce si può ottimamente determinare da ciò che capita nel sonno. I sensibili producono in noi la sensazione in rapporto a ciascun sensorio e l’affezione provocata da loro non rimane nei sensori soltanto mentre la sensazione è in atto, ma anche quand’ è passata. (…) Si deve fare una supposizione simile per l’alterazione: ciò che è riscaldato dal calore riscalda quel che gli sta accanto e così il calore si trasmette fino al principio. Di conseguenza anche nell’organo in cui si dà la sensazione deve necessariamente avvenire questo, dal momento che la sensazione in atto è, in qualche modo, una alterazione. Perciò l’impressione non è negli organi di senso solo mentre percepiscono, ma anche quando hanno cessato di percepire ed è nel profondo e sulla superficie. Ciò diventa evidente quando abbiamo di una cosa una sensazione continua: se mutiamo sensazione, l’antica impressione ci segue, come quando, ad esempio, si passa dal sole al buio: capita allora di non vedere niente, perché il movimento causato negli occhi dalla luce permane ancora. E se siamo stati a guardare molto tempo un colore, o bianco o giallo, lo stesso colore apparirà su qualunque cosa poseremo lo sguardo.”
Ancora, al passo 460 b 30 si legge:
“Non solo mentre stiamo svegli ci sono in noi i movimenti prodotti dalle sensazioni, vengano esse dal di fuori o dal di dentro del nostro corpo, ma anche quando si produce quello stato che si chiama sonno – anzi allora appaiono di più.”
Ed anche al passo 462 a 30 si ribadisce che:
“… il vero sogno è un’immagine che proviene dal movimento delle sensazioni, quando si dorme – e si intende dormire nel senso stretto del termine.”
3. De Divinatione per somnum
Per quanto attiene più propriamente al sogno, invece, Aristotele sembra aver accettato due specie di sogni premonitori: i sogni che danno prescienza delle condizioni di salute di colui che sogna, e i sogni che producono il proprio adempimento, suggerendo a colui che sogna determinate azioni.
Leggiamo il brano del De divinatione per somnum, passo 463 a 4 e seguenti, dove questa distinzione è affermata in maniera chiara da Aristotele:
“Ma allora è vero che tra i sogni alcuni sono cause, altri segni, ad esempio di quel che capita al corpo? I medici più acuti dicono che bisogna badare con molta attenzione ai sogni – ed è ragionevole che così la pensino anche coloro che, pur non avendo pratica dell’arte, ricercano e approfondiscono la verità. Gli stimoli che si producono di giorno, a meno che non siano molto grandi e forti, ci sfuggono di fronte a quelli più grandi della veglia. Nel sonno succede il contrario, perché anche i piccoli stimoli sembrano grandi. (…)
Di conseguenza, poiché gli inizi di tutte le cose sono piccoli, è chiaro che lo sono anche gli inizi delle malattie e degli altri accidenti che devono prodursi nel corpo. E’ evidente, quindi, che tali sintomi sono manifesti più nel sonno che nello stato di veglia. E’ in verità non è assurdo che talune immagini che si presentano nel sonno siano causa di azioni proprie a ciascuno di noi. (…)
Così pure è necessario che i movimenti che hanno luogo nel sonno siano spesso gli inizi delle azioni fatte poi durante il giorno, giacché anche qui l’idea di queste azioni si trova agevolata la strada delle rappresentazioni della notte.”
Nel testo che segue, ai passi 463 b 15 seguenti e 464 a 20 e seguenti, Aristotele, invece, nega l’esistenza dei sogni mandati dagli dèi (theopempta), argomentando che se questi volessero trasmettere cognizioni agli uomini, lo farebbero di giorno, scegliendo con maggior cura i destinatari. Vediamo come si esprime il filosofo:
“Poiché, in generale, anche alcuni animali oltre l’uomo sognano, i sogni non possono essere mandati da dio, e non esistono in vista di tale scopo: sono quindi opera demoniaca, perché la natura è demoniaca, non divina. Ed ecco la prova: uomini veramente semplici sono capaci di prevedere e hanno vividi sogni: ciò dimostra che non è dio che manda i sogni, ma tutti quelli che hanno natura ciarliera e strabiliare vedono visioni di ogni sorta. Dal momento che essi sono soggetti a stimoli numerosi e di ogni sorta, riescono ad avere casualmente visioni simili agli eventi e indovinano in questo come chi gioca a pari e dispari, perché anche a questo proposito si dice: “A furia di tirare, una volta o l’altra ce la farai”: lo stesso succede qui. Non è affatto assurdo, quindi, che molti sogni non si realizzino, come non si realizzano certi sintomi che si hanno nel corpo o certi segni celesti, quelli ad esempio, che preannunciano piogge o venti. (…)
Questi impulsi producono delle immagini che permettono la previsione di quel che può capitare in tali casi. Ed è per questo che tali fenomeni si verificano negli uomini ordinari e non in quelli più saggi. Di giorno si verificherebbero anche nei saggi, se fosse dio a mandarli. Ma, com’è la cosa, è naturale che siano gli uomini ordinari a prevedere, perché il pensiero di costoro non è portato alla riflessione, ma, per così dire, è deserto e vuoto di tutto, e, una volta stimolato, è condotto secondo l’impulso stesso.”
4. Eudemo e De Philosophia
Anche l’Eudemo, opera dialogica della prima produzione aristotelica, ci fornisce interessanti indicazioni sulla concezione del sogno elaborata dal filosofo.
Come si intuisce dal suo sottotitolo De Anima, questo è un testo interamente dedicato alla trattazione dell’anima, in cui la dottrina dell’immortalità presumibilmente trova la sua formulazione giovanile più completa. E ciò, del resto, è perfettamente coerente col motivo che ha spinto il filosofo a comporre tale testo: la morte dell’accademico ed amico Eudemo di Cipro, caduto con molta probabilità negli scontri del 354 a. C. per la liberazione di Siracusa dal tiranno Dioniso il giovane.
Prima di passare all’esame dei frammenti che ci interessano per la nostra trattazione, è opportuno ricordare brevemente l’evoluzione della teoria psicologia di Aristotele. Nella prima fase della sua produzione il filosofo sembra aderire pienamente alle dottrine del suo maestro Platone: l’affermazione del dualismo corpo – anima, la vita dell’anima nel corpo (soma) come in una prigione (sema), la realtà di una vita ultraterrena dell’anima, il ritenere la morte come un ritorno dell’anima in patria, il considerare la vita terrena come un esilio, sono infatti teorie platoniche, di derivazione orfico-pitagorica, esposte da Platone soprattutto nel Gorgia e nel Fedone.
Queste concezioni appaiono in contrasto con quelle espresse nelle opere della maturità, soprattutto nel De Anima, dove è assente il carattere ascetico e pessimistico specifico del primo periodo, e dove Aristotele rifiuta tale impostazione. Quasi tutti gli studiosi concordano, infatti, nel ritenere questo testo testimonianza di una dottrina molto distante da quella esposta nei dialoghi giovanili.
Lo scopo del De Anima è quello di considerare e conoscere la natura e l’essenza dell’anima, e successivamente tutte le caratteristiche che le competono.
Nel secondo libro, dopo un’introduzione e un’analisi storico-critica delle dottrine dei predecessori, che vengono inizialmente riportate e poi criticate, troviamo la definizione di anima.
Afferma Aristotele che “”l’anima è sostanza (ousia), nel senso che è forma (eidos) di un corpo naturale che ha la vita in potenza. Ora tale sostanza (ousia) è atto (entelecheia), e pertanto l’anima è atto (entelecheia) del corpo che s’è detto” (9).
“Perciò l’anima è atto (entelecheia) primo di un corpo naturale che ha la vita in potenza” (10). L’anima, quindi, spiega il filosofo, “è sostanza (ousia) nel senso di forma (kata ton logon), ovvero è essenza (to ti en einai) di un determinato corpo” (11).
Da queste citazioni si intuisce chiaramente che la psicologia del De Anima è caratterizzata da una concezione ileomorfica, che cioè concepisce l’anima e il corpo come la forma e la materia di un’unica sostanza, cioè appunto del vivente. Aristotele, infatti, non concepisce l’unione dell’anima col corpo come un’unità accidentale, quale può essere quella del pilota con la nave, ma come un’unità sostanziale. Il corpo, dunque, non sussiste indipendentemente dall’anima, benché rimanga ugualmente reale la distinzione tra l’anima, come principio formale, efficiente e finale, e il corpo, come entità materiale e strumentale. Il vivente è un essere ed una sostanza unitaria, e l’anima è la sua forma o principio vivificatore, ovvero è il principio dell’organizzazione e del funzionamento del corpo. Dal momento che è forma del composto vivente, l’anima è inseparabile dal corpo e cessa di esistere con la dissoluzione di quest’ultimo. In tal modo ogni tipo di dualismo di genere pitagorico-platonico tra l’anima e il corpo, presente nella fase giovanile, viene negato e superato.
Dopo aver ribadito che l’essere animato si distingue dall’inanimato per il fatto che vive, Aristotele ammette l’esistenza di tre distinte specie di anima, che sono definite dalle loro rispettive e peculiari facoltà: l’anima nutritiva, propria delle piante, l’anima sensitiva, propria degli animali, e l’anima intellettiva, propria dell’uomo. Il rapporto che vige fra questi tre tipi di anima è quello di una successione, secondo il quale l’anima inferiore è contenuta potenzialmente in quella superiore, poiché quest’ultima, oltre ad essere in grado di svolgere le funzioni che le sono proprie, è capace di adempiere anche quelle dell’anima inferiore.
A questo punto, però, al dualismo tra anima e corpo presente nelle opere giovanili se ne sostituisce uno nuovo, quando Aristotele passa alla trattazione del processo conoscitivo: quello dell’anima, forma immanente e corruttibile del corpo, e dell’intelletto separato ed eterno. Oggetto della conoscenza intellettuale, infatti, sono le essenze intelligibili ed eterne, che presuppongono l’esistenza di un intelletto attivo, immutabile, eterno e separato, contenente in atto le essenze intelligibili e separate. Con questa teoria, quindi, Aristotele non solo riafferma il suo platonismo, ma ripropone altresì la questione dell’immortalità dell’anima.
Dopo queste necessarie precisazioni, torniamo ora all’Eudemo. Una testimonianza di Cicerone desunta dal De divinatione ad Brutum, – il fr 1 del dialogo -, oltre ad avvalorare l’ipotesi della datazione dell’opera, ci narra di un sogno premonitore avuto da Eudemo. Nel testo si legge che Aristotele “scrive che Eudemo di Cipro, suo amico, mentre stava compiendo un viaggio verso la Macedonia, giunse a Fere (…) governata con dominio crudele dal tiranno Alessandro. In quella città dunque Eudemo si ammalò così gravemente che tutti i medici avevano perso ormai ogni fiducia di poterlo salvare. Ecco, però, che nel sonno gli sembrò che un giovane di aspetto particolarmente bello gli dicesse ciò che sarebbe accaduto, e cioè che in breve tempo avrebbe riacquistato le forze, che, trascorsi pochi giorni, il tiranno Alessandro sarebbe morto e che lui stesso, Eudemo, al termine di cinque anni sarebbe tornato in patria. E scrive Aristotele che le prime predizioni invero trovarono quasi subito conferma. Eudemo guarì e il tiranno fu ucciso dai fratelli della moglie. Poi, essendo quasi trascorso il quinto anno e nutrendo perciò Eudemo, in conseguenza del sogno, la speranza di tornare in patria a Cipro dalla Sicilia, accadde che Eudemo morì davanti a Siracusa. In conseguenza di ciò quel sogno fu così interpretato, che l’anima di Eudemo, quando si separò dal corpo, allora sembrasse tornare in patria .
Tale passo, oltre a fornire una sommaria indicazione sul tema e l’intento del dialogo, evidenzia due problematiche filosofiche di notevole valore: il ruolo profetico dei sogni o delle apparizioni e l’interpretazione della morte come ritorno dell’anima in patria.
Così, per quanto riguarda più propriamente il primo punto, Aristotele mostra di credere che gli annunci ricevuti in sogno dal suo amico Eudemo si avverarono. Ciò appare, infatti, chiaramente dalla lettura del brano ciceroniano appena riportato. D’altra parte il filosofo non negò mai la possibilità che i sogni fossero veritieri.
Questa tesi, tuttavia, non è nuova. La troviamo già esposta nel De Philosophia, – opera composta presumibilmente tra il 355 ed il 354 a. C. durante il soggiorno ad Asso -, che segna un significativo distacco da parte di Aristotele da alcuni aspetti della filosofia platonica. Egli, infatti, qui non solo riprende la critica della dottrina delle idee, ma espone una complessa concezione intorno al sapere, alla cosmologia, alla teologia e all’anima, che già rispecchia il grado di profondità raggiunto dal filosofo nella speculazione, ormai distante dal platonismo. Dopo gli scritti Sulle idee e Sul Bene, – che hanno il carattere di opere interne all’Accademia -, Aristotele ritenne necessario rendere nota, mediante la pubblicazione del dialogo De Philosophia, la sua posizione circa la sophia in generale ed i suoi principi supremi, criticando prima alcuni punti del platonismo e sviluppandone poi lo spunto per lui più fecondo: la trascendenza del divino.
Nel fr. 12 si trova l’esposizione del valore profetico dei sogni e si legge quanto segue:
“Aristotele dice che la nozione degli dèi ha negli uomini una duplice origine, da ciò che accade nell’anima e nei corpi celesti. Più precisamente, da ciò che accade nell’anima in virtù dell’ispirazione e del potere profetico, propri di essa, che si producono nel sonno. Quando, infatti, egli dice, nel sonno l’ anima si raccoglie in se stessa, allora essa, assumendo la sua vera e propria natura, profetizza e presagisce il futuro. Tale è anche allorché, nel momento della morte, si separa dal corpo. E quindi approva il poeta Omero per aver osservato questo: rappresentò infatti Patroclo che, nel momento di essere ucciso, presagì l’uccisione di Ettore, e Ettore che presagì la fine di Achille. Da fatti di questo genere, egli dice, gli uomini sospettarono che esistesse qualcosa di divino, che è in sé simile all’anima e più di tutte le altre cose è oggetto di scienza. (…)
Pertanto, quando per il sonno l’animo è separato dal contatto e dal contagio del corpo, allora esso si ricorda delle cose passate, vede quelle presenti e prevede quelle future; giace infatti il corpo di colui che dorme come fosse il corpo di un morto, mentre l’animo è sveglio e vive …. E così ancora più divino è nel momento in cui la morte si avvicina.”
L’accostamento in questo passo del sonno alla morte è evidente: il sonno rimane l’esperienza dei viventi che più si avvicina alla morte, stato in cui l’anima è massimamente libera. Qui, infatti, Aristotele afferma che il sonno o l’avvicinarsi della morte non solo non diminuiscono l’esercizio delle facoltà razionali, ma anzi permettono all’anima di raccogliersi in se stessa ed assumere la sua propria natura, il che comporta la capacità di prevedere il futuro. Di conseguenza la divinazione è vista come il raggiungimento della pienezza della razionalità, non attribuibile ad un intervento divino, ma alla natura propria dell’anima.
Anche l’Eudemo, secondo alcuni studiosi come Enrico Berti, conterrebbe implicitamente le teorie del De philosophia, ribadendo, così, che lo stato di relativa separazione dal corpo, in cui l’anima si viene a trovare nel sonno o in prossimità della morte, è ciò che permette a questa di presagire il futuro.
Proseguendo l’esame dell’Eudemo, non si può non ricordare il fr. 11, che peraltro manca dalle raccolte dei frammenti aristotelici curate rispettivamente da Walzer e da Rose. In tale testo, – tardo, poiché tramandato dal filosofo arabo Al-Kindi – , si legge quanto segue:
“Aristotele racconta di un re greco, la cui anima era riuscita a raggiungere lo stato di estasi e che per parecchi giorni rimase in uno stato che non era né di vita né di morte. Quando ritornò in sé egli riferì agli astanti varie cose del mondo invisibile e raccontò ciò che aveva visto: anime, forme e angeli; ed egli dette la prova di ciò preannunciando di conoscere quanto a lungo ciascuno di loro sarebbe vissuto. Tutto questo egli disse per dare la prova e nessuno superò lo spazio della vita che egli aveva assegnato. (…) E ogni cosa accadde come egli aveva detto: Aristotele afferma che la ragione di ciò era nel fatto che la sua anima aveva acquistato tali conoscenze, appunto perché era stata sul punto di liberarsi dal suo corpo ed era stata in certa misura separata da esso e così aveva potuto vedere ciò che aveva visto. E quali meraviglie di gran lunga più grandi del mondo celeste egli avrebbe potuto vedere, se egli avesse realmente abbandonato il suo corpo.“
In questo passo l’esperienza estatica, – come il sonno in altri frammenti -, viene presentata come un’esperienza “limite”, una situazione simile alla morte o di morte apparente. L’anima del re greco si era in una certa misura distaccata dal corpo, ma non in modo tale da causarne la morte. In questa condizione l’anima di questo re ha potuto acquistare una conoscenza che non può essere posseduta dai comuni mortali. Ciò implica, tra l’altro, che Aristotele considerava il corpo come un impedimento per l’anima nell’attuazione di una “potenzialità” di cui essa potrebbe essere provvista. L’anima qui è rappresentata, infatti, come ostacolata nelle sue operazioni dal legame col corpo, che lo ostacola nell’acquisizione della conoscenza.
Importante sottolineare in questo frammento il fatto che l’anima del re greco, nella condizione descritta, acquisti facoltà mantiche. Le affermazioni di Al-Kindi, infatti, vanno a costituire un’ulteriore conferma alle notizie forniteci dal precedente brano dell’Eudemo e a quelle del fr. 12 a del De philosophia .
Un ulteriore punto da sottolineare, inoltre, è costituito dalle ultime righe del passo in questione ( fr. 11):
“E quali meraviglie di gran lunga più grandi del mondo celeste egli avrebbe potuto vedere, se egli avesse realmente abbandonato il suo corpo!”
Queste sembrano indicare il fatto che il legame dell’anima col corpo del re non sia stato reciso in modo definitivo, impedendo di conseguenza all’anima stessa di ascendere alle regioni più alte della regione celeste e di raggiungere, così, la forma più elevata di conoscenza. In questo caso, il brano in questione sembra indicare due livelli di liberazione dell’anima, che corrispondono a due livelli di “ascesa” dell’anima: finché persistono legami, anche se minimi, con il corpo, l’anima non può raggiungere i supremi livelli a cui essa potenzialmente può ascendere.
Note
(1) Si pensi, solo per citarne i più noti, a Freud e Jung.
(2) E. Dodds, The Greeks and the Irrational, Univ. of California Press, 1951, trad. it., E. Dodds, I Greci e l’Irrazionale, Firenze, La Nuova Italia, (1959), 1978, p. 119.
(3) Vangelo di Matteo, Fuga in Egitto, 2, 13 – 19.
(4) Ivi, p. 133.
(5) L’incubazione, – cioè il dormire in un luogo sacro -, era praticata in Egitto già dal XV sec. a. C. ed era molto utilizzata sia per ottenere sogni divinatori dai morti sia per ottenere guarigioni. Quest’ultimo fine era proprio della cosiddetta incubazione medica, che ebbe nel V sec. a. C. una importante rinascita quando il culto di Asclepio assunse dimensioni in tutta la Grecia.
(6) I brani riportati da questo punto in poi sono tratti dalle Edizioni Laterza, Aristotele, volumi 4 ed 11.
(7) Dei sogni, passo 459 a 10
(8) Dei sogni, passo 459 a
(9) De Anima, 412 a 19-21.
(10) Ivi., 412 a 27-28.
(11) Ivi, 412 b 10.
L’uso “scientifico” della dialettica in Aristotele
A cura di Enrico Berti
1. I diversi usi della dialettica secondo Top. 12
Il noto passo di Topici I 2, 101 a 34-b 4, in cui Aristotele afferma l’utilità del suo trattato, cioè della conoscenza della dialettica, per il progresso delle scienze e per la ricerca dei loro principi, è stato quasi sempre sottovalutato. Anche gli interpreti più recenti, che cercano di rivalutare la dialettica, gli dedicano un’attenzione molto limitata¹, oppure vi scorgono semplicemente l’esposizione di un processo di induzione (επαγωγη)2, o lo considerano insufficiente a giustificare ciò che esso afferma³, o infine lo riferiscono solo a una forma particolare di dialettica, cioè alla “peirastica”4. D’altra parte coloro che criticano tale rivalutazione propongono di dividere il passo in questione in due parti, separando l’affermazione dell’utilità della dialettica per le scienze “filosofiche” dall’affermazione della sua utilità per la ricerca dei principi di tutte le scienze. Sulla base di questa separazione essi considerano la prima parte del passo come il prolungamento diretto della dialettica platonica, e la seconda come espressione di un punto di vista più maturo, che presupporrebbe la teoria della scienza sviluppata negli Analitici posteriori³; o, al contrario, considerano la prima parte come concernente argomenti che non sono essi stessi dialettici, e la seconda come il residuo di una versione più antica, cioè platonica, dei Topici; o infine vedono nella prima parte una preparazione alle teorie scientifiche e nella seconda una semplice discussione concernente i principi comuni7. Ora, anzitutto è possibile dimostrare che il passo in questione non allude a due differenti “utilità” della dialettica, ma si riferisce a una sola e medesima utilità. Un primo argomento a sostegno di questa tesi è il fatto che, all’inizio del capitolo, Aristotele indica nel numero di tre, e non di quattro, le attività per le quali il suo trattato è “utile” (χρησιμος ): la ginnastica intellettuale (γυμνασια), gli incontri occasionali (εντευξεις) e le scienze di carattere filosofico (αικατα φιλοσοφιαν επιστημαι)8. Questo argomento tuttavia non è decisivo, perché l’allusione all’utilità concernente la ricerca dei principi, che certi interpreti considerano come la quarta, potrebbe essere stata introdotta dopo la prima redazione del testo, per mezzo della congiunzione ετιδε. Ma in questo caso si dovrebbero supporre strati redazionali successivi, il che richiederebbe di essere dimostrato. D’altra parte la distinzione tra le scienze di carattere filosofico (αικατα φιλοσοφιαν επιστημαι), alle quali si riferirebbe la terza utilità, e la totalità delle scienze (101 a 37: εκστην, 101 b 3: απασων), alla quale si riferirebbe la quarta 10, non ha alcun fondamento, perché per Aristotele non c’è differenza tra le “scienze” (επιστημαι) in generale e la “filosofia” (φιλοσοφια) 11, come risulta dal fatto che egli, per distinguere dalle altre scienze quella che noi chiamiamo semplicemente “filosofia”, deve chiamarla “filosofia prima”12. Di conseguenza l’espressione αικατα φιλοσοφιαν επιστημαι non allude a un tipo particolare di scienze, ma significa semplicemente le scienze propriamente dette, cioè tutte le scienze in quanto producono un vero sapere (φιλοσοφια 13. Ma l’argomento decisivo a sostegno dell’unità fra la terza e la presunta quarta utilità della dialettica, a mio avviso, è la connessione stretta che esiste tra la vocazione “esaminatrice” della dialettica (101 b 3: exetastkh γαρουσα), considerata come causa della sua capacità di condurre ai principi, e dunque di esprimere la sua quarta utilità, e la sua attitudine a “sviluppare le aporie argomentando in entrambi i sensi” (101 a 35: προς αμφοτερα διαπορησαι, in utramque partem disserere), che le permette di “discernere più facilmente il vero e il falso in ogni cosa”, in cui consiste la sua terza utilità. Questa connessione risulta molto chiaramente da un passo dell’Etica Eudemea, dove Aristotele afferma che a proposito di certe opinioni nessun uomo sano di spirito vorrebbe “sviluppare delle aporie” (διαπορησειν ), mentre a proposito delle aporie proprie a ciascun oggetto di studio “è bene esaminare a fondo (εξεταζειν ) le opinioni” che le producono 14. Qui non c’è dubbio che διαπορησαι ed εξεταζειν sono termini pressoché sinonimi15. Anche il contesto di questo passo è analogo a quello di Top. I 2: sia nell’Etica Eudemea, infatti, che in un passo ulteriore di Top. I Aristotele osserva che certe opinioni, quelle dei bambini, o degli ammalati, o dei pazzi, non hanno bisogno di essere esaminate, ma solo di essere corrette per mezzo di un rimprovero (κολασις) ο di un rinvio all’esperienza dei sensi 16. E le linee immediatamente successive al passo di Eth. Eud. I, cioè la celebre affermazione che “le confutazioni (ελεγχοι) degli avversari sono dimostrazioni (αποδειξεις ) dei discorsi che sono stati loro opposti”, confermano la connessione tra διαπορήσαι, εξεταζειν ed ελεγχειν, che sono le operazioni caratteristiche della dialettica, connessione che collega le due presunte utilità della dialettica per le scienze filosofiche al contesto degli Elenchi sofistici, cioè alla “peirastica”, come è stato giustamente sottolineato 17. Se tutto ciò è vero, non siamo in presenza di due utilità diverse, ma la dialettica è utile alle scienze di carattere filosofico, cioè alla scienze in generale, sia perché, sviluppando le aporie in entrambi i sensi, ci fa discernere più facilmente il vero ed il falso, sia perché, grazie alla sua vocazione esaminatrice, essa ci apre l’accesso ai principi di tutte le discipline. Anzi l’esame (εξετασις) delle diverse opinioni consiste propriamente nel considerare ciascuna opinione e la sua negazione, in modo da formare un’aporia, e nello sviluppare questa aporia in entrambi i sensi, cioè nel dedurre le conseguenze che derivano dalle due opposte opinioni che la formano. Se le conseguenze di una di queste due opinioni sono confutate, cioè se approdano a una contraddizione (“deduzione della contraddizione” è la definizione di confutazione 18), la loro confutazione equivale alla dimostrazione dell’opinione opposta. In questo modo la dialettica ci permette di discernere più facilmente il vero e il falso, cioè l’opinione vera e quella falsa. Ebbene, questa operazione è la stessa che conduce alla scoperta dei principi di tutte le scienze, cioè che permette di discernere, tra le diverse opinioni che sono, per così dire, i candidati al titolo di principi di una scienza, quali sono vere, e dunque sono dei veri principi, e quali non lo sono. Ma quali sono le premesse a partire dalle quali la dialettica giunge a confutare un’opinione e dunque a dimostrare l’opinione a essa opposta? Aristotele lo dice molto chiaramente a proposito della ricerca dei principi, affermando che, poiché i principi sono ciò che è primo rispetto a tutto il resto, è impossibile dirne qualche cosa a partire da altri principi, e di conseguenza non si può farlo che a partire dalle “opinioni degne di stima a proposito di ciascuna di queste cose” (101 b 1: διαδετων περι εκαστα ενδοξων). “Questo compito – aggiunge immediatamente Aristotele – è proprio della sola dialettica, o almeno di essa principalmente”, dunque non si tratta di impiegare, nella ricerca dei principi, un tipo speciale di dialettica, una dialettica per così dire più “scientifica”, quale sarebbe secondo qualcuno la “peirastica”, la quale partirebbe da un tipo speciale di ενδοξα cioè gli ενδοξοτατα menzionati negli Elenchi sofistici19 Non si tratta nemmeno di un procedimento “non dialettico”, quale sarebbe quello che Aristotele impiega nel libro B della Metafisica, deducendo le conseguenze di entrambi i corni delle aporie, come è stato sostenuto20. Si tratta del procedimento normale della dialettica, che deduce delle conclusioni a partire da opinioni degne di stima (èndoxa), e che è sempre lo stesso, sia nella sua funzione “ginnastica”, a cui si riferisce la sua prima utilità, sia nella sua funzione “omiletica” (per usare il linguaggio di Brunschwig), a cui si riferisce la sua seconda utilità21. La sola differenza che rimane al di là del procedimento, che è lo stesso tra l’impiego della dialettica a proposito di tesi che non sono principi e il suo impiego a proposito dei principi, è che nel primo caso la dialettica non è indispensabile, mentre nel secondo sembra esserlo. Ciò risulta dal fatto che, quando non si ha a che fare con i principi, come dice Aristotele, lo sviluppo delle aporie in entrambi i sensi permette di discernere il vero e il falso “più facilmente” (ραον): dunque ci sono anche delle altre possibilità, cioè di discernere il vero e il falso meno facilmente, per mezzo di altri procedimenti che, dovendo appartenere alle scienze propriamente dette, potranno essere la dimostrazione a partire da principi o a partire da altre tesi già dimostrate. Invece, quando si ha a che fare con i principi, non si dispone di alcuna premessa interna alla scienza in questione da cui partire, e pertanto la dialettica è il solo procedimento di cui si dispone per cercare i principi. A dire il vero Aristotele afferma che tale compito è “proprio della sola dialettica, o almeno di essa principalmente” (ιδιον ημαλιστα οικειον ). Si potrebbe scorgere in quest’ultima espressione un’allusione ad altri procedimenti che permettono di scoprire i principi, per esempio all’induzione (επαγωγη), a cui il celebre ultimo capitolo degli Analitici posteriori (II 19) attribuisce precisamente il compito di stabilire i principi delle scienze. Ma, poiché il compito menzionato in Top. I 2 consiste nel partire da èndoxa, il che non accade nel caso dell’induzione, si deve considerare l’espressione ιδιον ημαλιστα οικειον come pleonastica, oppure come avente un significato diverso da quello che le abbiamo dato. Infatti, oltre a significare che il compito in questione appartiene alla sola dialettica o ad essa principalmente, essa può significare che tale compito, cioè la discussione a partire dagli èndoxa, è il solo o il principale compito della dialettica22. In ogni caso resta stabilito che la dialettica permette di scoprire i principi per mezzo del suo procedimento “normale”, cioè lo sviluppo delle aporie a partire dagli èndoxa.
2. Il problema della “base epistemologica” della dialettica
E’ per questo che si pone il problema della “base epistemologica” (come l’ha chiamata Bolton) della dialettica, cioè la domanda: come è possibile che la dialettica, partendo sempre da semplici opinioni degne di stima (èndoxa), giunga a discernere il vero dal falso o, più ancora, a scoprire i principi di tutte le scienze? Bisogna confessare che nei Topici Aristotele non dà alcuna spiegazione di questo fatto, come è stato giustamente sottolineato da Brunschwig. Ma io credo che non la dia nemmeno negli Elenchi sofistici, come invece pretende Bolton, non perché al tempo della composizione di queste opere egli fosse ancora troppo giovane e possedesse soltanto una dialettica “debole”, come sostiene Irwin, ma perché la spiegazione di quella che chiamerei la funzione “scientifica” della dialettica non era compito né dei Topici, che hanno per oggetto la descrizione della dialettica in generale, né degli Elenchi sofistici, che hanno per oggetto lo smascheramento dell’impiego sofistico della dialettica, in particolare della confutazione. L’illustrazione dell’uso scientifico della dialettica deve essere cercata là dove quest’uso si dispiega, cioè nei trattati scientifici. Tra questi ve ne sono alcuni in cui Aristotele fornisce dei chiarimenti concernenti il suo metodo. Si tratta di passi molto noti, come quello di Etica Nicomachea VII 1, che concerne l’impiego degli èndoxa, o di passi meno noti, come quelli dell’Etica Eudemea che sto per discutere, o di passi noti ma quasi mai utilizzati a questo scopo, come il libro B della Metafisica, e di altri ancora, presenti in trattati diversi 23. Non si può dire, quindi, che il metodo in questione appartenga esclusivamente alla filosofia pratica24.
A proposito di Metaph. B tutti sanno che il metodo qui impiegato da Aristotele è chiamato διαφορησαι, esattamente come quello menzionato nei Topici a proposito dell’utilità scientifica della dialettica, e che esso consiste nel dedurre le conseguenze dei due corni delle aporie, per vedere se esse approdano a delle contraddizioni. Quasi tutti considerano questo metodo come dialettico, ma quasi nessuno ha osservato che Aristotele in esso ricorre a dei veri èndoxa, come esige la dialettica. Consideriamo, per esempio, la prima aporia, che consiste nel chiedersi se lo studio di tutti i generi di cause, cioè delle cause materiali, formali, motrici e finali, spetti a una sola e medesima scienza, oppure a molte. Aristotele esamina in primo luogo la tesi secondo la quale questo studio spetterebbe a una sola scienza e le obietta immediatamente: “come potrebbe spettare a una sola scienza conoscere i principi, dato che essi non sono contrari tra di loro?”25. Si tratta evidentemente di una domanda retorica, che significa: spetta a una sola scienza conoscere i contrari, ma i principi, o le cause, non sono contrari, dunque lo studio di essi non spetta a una sola scienza. Qui abbiamo una contraddizione tra la tesi considerata e una conseguenza che abbiamo tratto, dunque la tesi in questione è stata confutata. Ma da dove abbiamo tratto questa conseguenza? Dall’affermazione che spetta a una sola scienza conoscere i contrari. Ebbene, questa affermazione è uno dei più celebri èndoxa citati da Aristotele, perché essa è l’esempio stesso che il filosofo fa nei Topici per illustrare che cos’è una premessa dialettica, cioè un èndoxon messo in forma interrogativa26. In secondo luogo Aristotele esamina la tesi opposta alla prima, cioè l’affermazione che lo studio delle diverse cause appartiene a più scienze. A questa tesi egli obietta che ciascuna delle scienze concernenti i diversi tipi di cause ha diritto al nome di “sapienza” (σοφια) e, pertanto, può sembrare che esse formino tutte una sola e medesima scienza. Per esempio, la scienza della causa finale ha diritto ad essere considerata come la scienza sovrana e dominatrice, alla quale tutte le altre devono obbedire, perché conosce il fine in vista del quale bisogna agire, e la scienza dominatrice coincide con la sapienza27. Ora, quest’ultima affermazione si fonda su una delle celebri “assunzioni” (υποληψεις) esposte nel libro A a proposito della sapienza, secondo la quale “una scienza dominatrice è più sapienza di quella che le è subordinata”, e non è il sapiente che deve obbedire ad altri, ma è a lui che deve obbedire chi è meno sapiente 28. Non c’è dubbio, mi pare, che questo giudizio sia un èndoxon, quindi la confutazione della tesi in questione è sviluppata sulla base di un èndoxon. Ma si potrebbe continuare con altri esempi. Dato, allora, che la base delle confutazioni dialettiche è sempre costituita dagli èndoxa, bisogna vedere qual è il valore di verità di questi èndoxa per risolvere il problema della base epistemologica della dialettica e dunque per comprendere qual è la sua utilità per le scienze. La definizione di èndoxon è quella, notissima, dell’inizio dei Topici, cioè: “le opinioni (τα δοκούντα) condivise da tutti, o dalla maggior parte, o dai competenti (τοις σοφοις), e tra questi da tutti, o dalla maggior parte, o dai più noti e stimati (ενδοξοις) “29. Come è stato più volte notato, questa definizione ammette diversi gradi di “endossalità”, secondo un criterio che è al tempo stesso quantitativo e qualitativo, cioè che tiene conto sia della quantità dei soggetti che condividono l’èndoxon (tutti o la maggior parte), sia della loro qualità (i competenti, i più noti, i più stimati)30. Questa concezione “gerarchica” (termine impiegato da Brunschwig in occasione del suo seminario tenuto a Padova il 27 maggio 1994) degli èndoxa permette di risolvere gli eventuali conflitti che possono aver luogo tra gli èndoxa e di scegliere come premesse delle deduzioni dialettiche quelli che hanno il grado più alto di endossalità. Questi ultimi sono senza dubbio gli endoxòtata di cui parlano gli Elenchi sofistici e che, secondo Bolton, sono le premesse della peirastica, cioè della dialettica più “scientifica”. Ma questo grado non è ancora sufficiente per assicurare agli èndoxa un valore di verità e dunque per risolvere il problema della base epistemologica della dialettica. È possibile, infatti, non solo che gli èndoxa siano falsi, ma che lo siano anche gli endoxòtata. La prima possibilità risulta chiaramente da un passo famoso, in cui Aristotele ammette esplicitamente la possibilità di una deduzione a partire da premesse “false ma endossali” (εκψευδων ενδοξωνδε) e chiama questa deduzione “puramente logica” (λογικος), cioè appunto dialettica 31. Non serve a nulla invocare, come qualcuno ha fatto, a sostegno della verità degli èndoxa la distinzione, fatta da Aristotele all’inizio dei Topici, tra gli èndoxa reali, cioè autentici, che formano le premesse delle deduzioni dialettiche, e gli èndoxa apparenti, che formano le premesse delle deduzioni eristiche (εκφαινομενων ενδοξωνμηοντωνδε)32. Infatti la ψευδους φυσις (101 a 1) che appartiene a questi ultimi non è una falsità che si opponga ad un presunto valore di verità degli èndoxa autentici, ma è semplicemente un’apparenza (100 b 27-28: φαντασιαν) di endossalità che si oppone alla vera endossalità degli èndoxa autentici35. La seconda possibilità, cioè la possibilità che anche gli endoxòtata siano falsi, risulta mi sembra dall’analisi che Aristotele fa dell’argomento sillogistico più sottile”, o più intrigante (συλλογιστικος μεν λογος δριμύτατος, argumentatio argutissima), cioè l’argomento capace di distruggere, a partire da premesse condivise in grado massimo (εξοτιμαλιστα δοκούντων), una conclusione in grado massimo endossale (οτι μαλιστα δοκούντων ενδοξον) 34. Qui non siamo interessati alla natura o al valore di questo argomento, che secondo alcuni avrebbe per esempio la forma seguente: “tutte le madri amano i loro figli (èndoxon), Medea era madre (altro èndoxon), dunque Medea amava i suoi figli” (conclusione che distrugge l’èndoxon secondo il quale Medea non amava i suoi figli); oppure: “tutte le madri amano i loro figli (èndoxon), Medea non amava i suoi figli (altro èndoxon), dunque Medea non era madre” (conclusione che distrugge l’èndoxon secondo il quale Medea era madre) 35. Secondo altri interpreti questo argomento sembra produrre vere antinomie, quali il paradosso di Epimenide o quelli di Russell36. Ciò che ci interessa notare è che in ogni caso, se una conclusione endossale al massimo può essere correttamente distrutta a partire da una premessa endossale al massimo, questa premessa e questa conclusione sono incompatibili, e dunque, in base al principio di non-contraddizione, è impossibile che esse siano entrambe vere. Ciò significa che, poiché entrambe sono endossali al massimo, anche gli èndoxa in grado massimo, cioè gli endoxòtata, possono essere falsi37. Il grado di endossalità delle sue premesse dunque, malgrado ciò che ne ha detto Bolton, non è sufficiente per assicurare alla dialettica una base epistemologica adeguata a renderla utile alle scienze.
3. La coerenza con la maggior parte degli èndoxa
La tesi che sottopongo alla discussione nella presente occasione, e che non mi sembra essere stata ancora considerata, è che il criterio indicato da Aristotele come sufficiente per attribuire agli èndoxa un valore di verità, e dunque alla dialettica una base epistemologica soddisfacente perché essa possa essere utile alle scienze, non è costituito dal grado di endossalità delle sue premesse, ma dalla loro coerenza, non però semplicemente con altri èndoxa, bensì con “la maggior parte” di essi. In altre parole, ciò che rende degno di fiducia un èndoxon, dal punto di vista delle scienze, non è il suo grado di endossalità, cioè la quantità o la qualità delle persone che lo condividono, ma la quantità e la qualità degli altri èndoxa con i quali esso è o non è compatibile. Se si adotta la distinzione tra le interpretazioni “fondazionalistiche” e le interpretazioni “coerentistiche” della dialettica aristotelica, che è stata recentemente proposta, collocherei la mia tra queste ultime, ma sottolineando che per Aristotele la coerenza di una proposizione con la maggior parte degli èndoxa è anche un segno della sua verità 38. Il passo principale, ma non l’unico, sul quale fondo questa interpretazione è quello celeberrimo del VII libro dell’Etica Nicomachea, dove Aristotele, illustrando il metodo della sua trattazione sull’incontinenza, dichiara: Noi dobbiamo, come a proposito degli altri oggetti, dopo avere esposto i pareri (τι θεντας τα φαινομενα) relativi a questo e dopo avere anzitutto sviluppato le aporie (και πρωτον διαπορησαντας) che essi sollevano, mostrare per mezzo di questo procedimento (ουτω δεικνύναι) preferibilmente tutti gli èndoxa concernenti queste passioni o, se non è possibile, la maggior parte ed i più importanti (τα πλειστακαι κυριωτατα); poiché, qualora si risolvano le difficoltà (λυηταιτετα δυσχερη) e insieme si lascino sussistere (και καταλειπηται) gli èndoxa, si sarà dimostrato in modo sufficiente (δεδειγμενον ανει ηικανως) 39. Qui interpreto i phainòmena alla maniera di Owen, cioè come le diverse opinioni espresse a proposito di un determinato oggetto40, significato reso perfettamente dall’italiano “pareri”, che conserva la derivazione dal verbo “apparire” (φαινεσθαι); ma non li identifico interamente, come fanno altri studiosi41, con gli èndoxa di cui parla il medesimo passo. I phainòmena intesi come opinioni, infatti, comprendono gli èndoxa come una classe di opinioni più particolare, ma non si limitano ad essi. Essi comprendono, così come i dokounta, dei quali sono sinonimi, anche le opinioni non endossali, per esempio le tesi di singoli filosofi, le quali talvolta sono paradossali42. In quanto tali, i phainòmena concernenti un particolare oggetto sono sottoposti all’esame dialettico, cioè sono disposti in modo da formare delle aporie, ovvero dei “problemi” intesi nel senso tecnico che Aristotele precisa nei Topici 43. Questi a loro volta sono sviluppati per mezzo della deduzione delle conseguenze dei due corni del dilemma che li costituisce, in modo che si possa vedere se tali conseguenze approdano o no a una contraddizione. Gli èndoxa invece non sono sottoposti ad alcun esame, perché essi formano le premesse, intese nel senso tecnico di premesse dialettiche44, a partire dalle quali, prese insieme con le tesi che costituiscono le aporie, si deducono le conseguenze di queste; oppure essi sono sottoposti ad esame solo nella misura in cui si confrontano con essi le conseguenze dedotte dalle opinioni esaminate 45. L’espressione “mostrare per mezzo di questo procedimento”, usata da Aristotele nel passo citato, non può avere altro significato che quello di “preservare”, cioè “lasciare sussistere” gli èndoxa, impiegata nello stesso passo due linee più avanti, ed il procedimento che essa indica non deve essere confuso con quello indicato dall’espressione “si sarà dimostrato in modo sufficiente”, posta a conclusione del passo. Quest’ultima, infatti, riguarda la dimostrazione di quella, tra le tesi che sono sottoposte all’esame dialettico, cioè tra i phainòmena, che si intende fare propria, mentre la prima espressione indica una delle due condizioni richieste per questa dimostrazione. Queste due condizioni sono, come dice Aristotele, da un lato (τε) la risoluzione delle difficoltà e dall’altro (και) la preservazione degli èndoxa. Ciascuna di queste due condizioni è necessaria, ma non sufficiente, per la dimostrazione di una tesi. La preservazione degli èndoxa, di tutti o – nel caso di un conflitto tra èndoxa, determinato dal fatto che alcuni di essi, come abbiamo visto, possono essere falsi della maggior parte e dei più importanti, è la condizione necessaria per dedurre dalla tesi esaminata tutte le sue conseguenze. In quanto tale, questa condizione non permette ancora di individuare, fra due tesi opposte, quale è vera e quale è falsa, perché entrambe le tesi, combinate con un èndoxon compatibile con tutti gli altri o con la maggior parte ed i più importanti, possono produrre delle conseguenze compatibili con essi46. A questo punto interviene l’altra condizione, cioè la risoluzione delle difficoltà. Questa espressione indica la confutazione della tesi opposta a quella che si vuole dimostrare47, ma tale confutazione deve essere fatta anch’essa, beninteso, a partire da uno dei molti èndoxa compresi in tutti quelli che riguardano l’oggetto in questione, o nella maggior parte e nei più importanti di essi, i quali sono compatibili tra loro, e consiste nel dedurre da questa tesi conseguenze incompatibili con qualcuno di essi. Ora, se si riesce a mostrare non solo che una tesi lascia sussistere questi èndoxa, ma anche che la tesi opposta, la quale costituisce per essa una difficoltà, può essere confutata, e quindi questa difficoltà può essere risolta, a partire dallo stesso insieme di èndoxa, allora conclude Aristotele si sarà dimostrato in modo sufficiente (la prima tesi). Questa conclusione è confermata da un altro passo dello stesso libro VII dell’Etica Nicomachea, dove Aristotele trattando dello stesso oggetto afferma: “la risoluzione dell’aporia è scoperta” della verità48. A proposito del significato dell’espressione “la maggior parte” (τα πλειστα) degli endoxa non ci sono problemi, mentre a proposito del significato dell’espressione “i più importanti” (κυριωτατα) potrebbero essercene. Il termine in questione, infatti, significa letteralmente “i più dominanti” e può indicare sia i più dominanti dal punto di vista della diffusione, cioè i più endossali, sia i più dominanti dal punto di vista delle loro relazioni reciproche, cioè i più fondamentali, quelli dai quali gli altri dipendono49. Propendo per questa seconda interpretazione, perché gli èndoxa più diffusi potrebbero essere in conflitto con la maggior parte degli èndoxa, mentre i più fondamentali, essendo a causa del loro primato quelli da cui deriva la maggior parte degli altri, non possono essere in conflitto con questa. D’altronde nel suo testo Aristotele non contrappone tra loro la maggior parte e i più importanti tra gli èndoxa, ma sembra considerarli un unico insieme. Egli dice, infatti, “la maggior parte e i più importanti”, non “la maggior parte o i più importanti”. Ebbene, se l’accordo delle conseguenze di un’opinione e la maggior parte e i più importanti degli èndoxa, insieme con l’incompatibilità dell’opinione ad essa opposta col medesimo insieme di èndoxa, formano per Aristotele una condizione sufficiente perché si possa considerare dimostrata la prima opinione, ciò significa che la maggior parte e i più importanti degli èndoxa – dunque non tutti – riguardanti un determinato oggetto sono veri. Questo risultato è confermato da una serie di passi, presenti in diverse opere di Aristotele. Nella stessa Etica Nicomachea, libro I, ce n’è uno che dice: Dobbiamo discutere a proposito di questa [suppongo la felicità] non solo a partire dalla conclusione e dalle premesse dell’argomentazione, ma anche a partire dalle cose che se ne dicono (εκ των λεγομενων); perché col vero tutte le cose sussistenti (ταυπαρχοντα) si accordano, mentre col falso il vero è subito in disaccordo 50. Qui i legòmena coincidono con i phainòmena del passo precedente, mentre gli hypàrchonta coincidono con gli èndoxa del medesimo passo, o con gli èndoxa più importanti, o con gli endoxòtata, come risulta dal fatto che altrove Aristotele chiama i primi τα δοκουνταυ παρχειν 51 e i secondi τα μαλιστα δοκούντα υπαρ χεινοταυπαρχοντα ως ενδοξοτατα 52. D’altra parte qualche linea più avanti Aristotele aggiunge: Tra queste cose [cioè i legòmena o i phainòmena] alcune le dicono molti uomini e antichi, altre pochi e stimati (ενδοξο14); ora è ragionevole che né gli uni né gli altri si sbaglino interamente, ma che almeno su una cosa o anche sulla maggior parte siano nel giusto 53. Qui Aristotele distingue di nuovo, all’interno dei phainòmena, gli èndoxa ed afferma che questi, nella maggior parte dei casi, sono veri. Nelle linee precedenti egli aveva detto che l’accordo degli èndoxa, se è generale, è una garanzia di verità, mentre il disaccordo di uno tra essi con tutti gli altri è segno della sua falsità. Nell’Etica Eudemea ci sono due passi che, a mio avviso, sono paralleli rispettivamente a quello del libro VII e a quello del libro I dell’Etica Nicomachea e si trovano anch’essi esattamente nel libro VII e nel libro I. Vediamo anzitutto quest’ultimo: Su tutti questi problemi – dice Aristotele – bisogna sforzarsi di cercare la persuasione per mezzo di argomenti, usando come testimonianze ed esempi i pareri (τοις φαινομενοις). Infatti l’argomento più forte è che tutti gli uomini paiano essere d’accordo con le cose che saranno dette, e se non è possibile, che tutti lo facciano in qualche modo, cioè una volta persuasi a mutare opinione (μετα βιβαζομενοι); poiché ciascuno ha qualche familiarità (οικειοντι4) con la verità, a partire da cui è necessario dimostrare in qualche modo a proposito di questi problemi. A partire infatti dalle cose dette con verità ma senza chiarezza, a coloro che procedono verrà anche la chiarezza, se essi prendono sempre le cose più note tra quelle che sogliono essere dette in modo confuso54.
Qui l’accordo tra tutti gli uomini non solo è considerato una garanzia della verità, ma è esplicitamente fondato su un’attitudine che ciascuno avrebbe a cogliere la verità, all’inizio in modo oscuro e confuso ed in seguito in modo più chiaro. Gli èndoxa probabilmente sono, tra i phainòmena, le affermazioni sulle quali c’è accordo generale e che sono come delle verità oscure e confuse, dalle quali tuttavia è necessario partire per giungere alle verità più chiare e riconosciute come tali, evidentemente anche attraverso l’eliminazione di alcune tra esse, al fine di rendere l’insieme perfettamente coerente. Ciò che è interessante in questo passo è la possibilità, ammessa da Aristotele, che l’accordo con la maggior parte degli èndoxa sia ottenuto per mezzo di una modifica (μετα βιβαζειν), cioè di una correzione, dei modi di pensare più diffusi, prodotta evidentemente per mezzo di argomentazioni. Egli aveva alluso a questa possibilità anche parlando delle “utilità” della dialettica nei Topici, là dove aveva detto che la dialettica è utile per gli incontri occasionali, perché essa ci permette di persuadere gli altri a modificare (μετα βιβαζοντες) delle affermazioni che ci sembrino inaccettabili 55. Ciò dimostra che il metodo dialettico per Aristotele non consiste nell’accettare l’opinione della maggior parte degli uomini, in nome di un piatto conformismo, ma nel ricercare un vero consenso per mezzo della discussione 56. Il passo parallelo a quello notissimo di Eth. Nic. VII 1 si trova in Eth. Eud. VII, dove Aristotele scrive: Dobbiamo trovare una definizione la quale contemporaneamente ci restituisca il più possibile le opinioni (τα δοκούντα ) su questi oggetti e risolva le aporie e le opposizioni. Ciò accadrà se le opinioni opposte [alle opposizioni] appariranno ragionevoli (ευλόγως φαίνηται), poiché tale definizione sarà il più possibile in accordo con i pareri (τοις φαινομενοις ). Accade infatti che le opposizioni rimangano se ciò che è detto in un senso è vero e in un altro non lo è57. Qui, come nel libro VII dell’Etica Nicomachea, Aristotele cerca l’accordo con la maggior parte delle opinioni (τα δοκουντα, cioè τα φαινομενα) in cui sono evidentemente compresi gli èndoxa, per mezzo della risoluzione delle aporie, cioè della confutazione delle opinioni opposte. Ciò significa che non sono salvate tutte le opinioni, ma solo quelle che non sono in conflitto tra di loro, cioè che sono reciprocamente coerenti. Finché rimangono i contrasti, non si ha ancora la verità assoluta, perché la definizione cercata è vera dal punto di vista di alcune opinioni, ma falsa dal punto di vista di altre. Del resto la verità del consensus hominum è affermata da Aristotele anche altrove, per esempio nel noto passo della Metafisica dove si dice che la ricerca della verità è in un certo senso difficile e in un altro facile; ne è segno il fatto che nessuno è capace di coglierla adeguatamente né è possibile che tutti la manchino, ma ciascuno è in grado di dire qualcosa sulla natura, e preso da solo vi contribuisce in nessuna o in piccola parte, ma da tutti i contributi presi insieme (εκ παντων δεσυναθροι ζομενων) nasce una certa grandezza58. Insomma il singolo può ingannarsi, ma la maggior parte degli uomini, almeno nella maggior parte dei casi, non si inganna. Dunque la maggior parte degli èndoxa sono veri. Un altro passo molto noto è quello della Retorica, che dice: Scorgere il vero e il verosimile (το ομοιοντω αληθει) è proprio della stessa facoltà, e gli uomini contemporaneamente non solo sono per natura sufficientemente dotati in rapporto al vero, ma anche nella maggior parte dei casi (τα πλειω) colgono la verità; perciò la buona attitudine (στοχαστικωςεχειν) verso gli èndoxa è propria di chi ha una simile attitudine anche verso la verità59. In questo passo gli èndoxa sono indicati anche come “il verosimile”, espressione che non significa ciò che sembra vero ma non lo è, ma indica ciò che si avvicina molto al vero, ossia un’opinione che nella maggior parte dei casi è vera. Poiché la natura ha dotato gli uomini di una buona attitudine a cogliere la verità, nella maggior parte dei casi essi la colgono, e l’espressione di questa attitudine sono appunto gli èndoxa, condivisi dalla maggior parte degli uomini e veri nella maggior parte dei casi. Nell’Etica Nicomachea c’è infine un passo in cui, a proposito della definizione del bene come ciò a cui tutti aspirano, risalente a Eudosso e più volte lodata dallo stesso Aristotele, si afferma esplicitamente: “le cose che sembrano a tutti, queste diciamo che sono [cioè che sono vere], mentre colui che distrugge questa credenza non dirà affatto cose più degne di fede”60. Qui il consenso di tutti è ritenuto garanzia, se non di verità assoluta, almeno di verità maggiore rispetto all’opinione contraria.
4. Soluzione delle difficoltà
C’è d’altra parte nella Retorica qualche passo che sembra contraddire questa dottrina, in particolare Rhet. II 25, dove Aristotele afferma: È manifesto dunque che la controdeduzione (το αντι-συλλογίζεσθαι) si può fare a partire dagli stessi luoghi [che la deduzione], poiché le deduzioni si fanno a partire dagli èndoxa, ma molte opinioni (δοκουντα δεπολλα) sono tra loro opposte 61. Questo passo è stato interpretato come se Aristotele dicesse che vi sono molti èndoxa tra loro opposti e che, pertanto, vi sono molti èndoxa falsi 62. Ma bisogna ricordarsi che le opinioni ( τα δοκούντα) non coincidono con gli èndoxa, bensì, allo stesso modo dei phainòmena, le comprendono 63. Di conseguenza il fatto che molte opinioni siano tra loro opposte non significa che lo siano anche molti èndoxa, ma che, quando si vuole opporre una controdeduzione a una tesi dedotta da certi èndoxa, si può trovare, tra le opinioni che comprendono questi èndoxa, qualche altra opinione che sia opposta agli èndoxa da cui è stata dedotta la tesi in questione e che sia, a sua volta, un èndoxon. Tuttavia resta vero che, se si vuole stabilire, per ragioni non dialettiche o retoriche, ma epistemologiche, quali sono gli èndoxa veri tra quelli reciprocamente opposti, si dovrà vedere, secondo Aristotele, quali tra essi si accordano con “la maggior parte e i più importanti”. La stessa osservazione vale per gli altri passi, tutti contenuti non a caso – nella Retorica, in cui Aristotele consiglia di argomentare a partire da premesse diverse, e persino opposte, al fine di persuadere degli uditori, o dei giudici, affetti da passioni diverse od opposte 64. È chiaro infatti che in tutti questi casi le premesse a partire dalle quali si deve argomentare non sono èndoxa, ma sono semplicemente opinioni professate dagli stessi uditori, come risulta da Rhet. II 18, 1391 b 21-24, dove esse sono esplicitamente chiamate “opinioni e premesse” (δοξαι και προτασεις), e da Rhet. II 22, 1395 b 31-1396 a 2, dove esse sono indicate come “le opinioni (τα δοκούντα) […] di coloro che giudicano o di coloro dei quali essi accettano l’autorità”. In conclusione la base epistemologica della dialettica aristotelica è costituita dal fatto che gli èndoxa nella loro maggior parte sono anche veri e per questa ragione permettono di vedere, tra due tesi opposte da cui si siano dedotte le conseguenze, quale è vera e quale è falsa, l’una essendo quella le cui conseguenze si accordano con la maggior parte degli èndoxa, l’altra quella le cui conseguenze vi contraddicono. Lo stesso procedimento può, o deve, essere applicato nella ricerca dei principi delle scienze, per vedere, tra due tesi opposte ed ugualmente candidate al titolo di principi, cioè di premesse vere, quale è vera e quale è falsa. Questa base epistemologica non si oppone mi sembra – a tutti i passi ben noti in cui Aristotele distingue la dialettica, in quanto fondata sull’opinione, dalla scienza, in quanto fondata sulla verità, né si oppone in particolare al famoso passo di Metaph. I 2, in cui Aristotele distingue la dialettica in quanto peirastikè dalla filosofia in quanto gnoristikè 65. Mi limito a osservare che in questo passo, il quale dovrebbe essere oggetto di uno studio a parte, Aristotele non confronta soltanto la dialettica e la filosofia (prima), ma confronta la dialettica, la filosofia e la sofistica. Egli afferma, infatti, che i dialettici e i sofisti assumono lo stesso aspetto del filosofo, perché la sofistica è una filosofia apparente mentre i dialettici discutono di tutto, e ciò che è comune a tutto è l’essere, cioè l’oggetto della filosofia (prima). Ma la filosofia – prosegue Aristotele – differisce dalla dialettica per la natura della facoltà impiegata e dalla sofistica per la scelta di vita che propone: d’altra parte la dialettica è peirastica (πειραστικη) a proposito delle stesse cose di cui la filosofia è cognitiva (γνωριστικη) e di cui la sofistica sembra esserlo, ma non lo è66. Probabilmente questo passo ha di mira soprattutto la dialettica platonica, come risulta dal contesto che lo precede, dove Aristotele non accusa i dialettici di non fare filosofia, ma solo di non dire nulla della sostanza67. Ora i dialettici in questione sono soprattutto Platone, cioè l’autore del Sofista, che smaschera la falsa pretesa di sapere propria dei sofisti 68. Ma, a parte questo, quando si interpreta il termine peirastikè, per mezzo del quale Aristotele qualifica in questo passo la dialettica, ci si deve ricordare ciò che lo stesso Aristotele ha detto sulla peirastica negli Elenchi sofistici, dove egli caratterizza questa parte, o quest’uso, della dialettica come consistente nell’esaminare, e nel confutare per mezzo di deduzioni dialettiche, coloro che pretendono di sapere ma non sanno69. Questi ultimi non possono essere che i sofisti, i quali pretendono di sapere ciò che è oggetto della filosofia (prima), cioè l’ente in quanto ente e le proprietà che gli appartengono per se stesso (vale a dire i principi ad esso coestensivi). Dunque la dialettica è peirastica rispetto alla sofistica, nel senso che esamina la pretesa dei sofisti di conoscere le proprietà dell’ente e, confutandola, ne dimostra la falsità. Ma, poiché la confutazione di una tesi equivale alla dimostrazione della tesi ad essa opposta, la dialettica dimostra a sua volta certe tesi, specialmente dove non vi sono principi da cui partire, per esempio a proposito dei principi stessi della filosofia prima, che sono quelli coestensivi all’ente in quanto ente, cioè il principio di non-contraddizione e quello del terzo escluso, come risulta dal medesimo libro I della Metafisica 70. Aristotele approva sicuramente la confutazione della sofistica fatta da Platone per mezzo della dialettica, ma la giudica insufficiente per conoscere le vere proprietà dell’ente in quanto ente, a causa della sua negligenza della polisemia di quest’ultimo e del primato che, tra i suoi diversi significati, appartiene alla sostanza. Lui stesso invece, grazie all’analisi dei diversi significati del termine, che è d’altronde uno strumento della dialettica71, ha potuto giungere a quella vera conoscenza dell’ente in quanto ente che è la filosofia, ma ha potuto farlo per mezzo della dialettica, la quale in tal modo si rivela ancora una volta “utile” alla conoscenza scientifica. Note (*) Questo articolo è stato pubblicato in “Giornale di metafisica”, nuova serie, n. XVII, 1995. L’edizione di questo testo è provvisoria: va rivista la grafia dei termini greci (per problemi tecnici). 1 G.E.L. Owen, Τι θεν αιτα φαινομενα, in Aristote et les problèmes de méthode, Louvain 1961, pp.83-103. 2 J.D.G. Evans, Aristotle’s Concept of Dialectic, Cambridge 1977, p. 23. 3 T.H. Irwin, Aristotle’s First Principles, Oxford 1988, pp. 66-67, 167-168. 4 R. Bolton, “The Epistemological Basis of Aristotelian Dialectic”, in D. Devereux et P. Pellegrin (édd.), Biologie, logique et métaphysique chez Aristote, Paris 1990, pp. 185-236, spec. 213; Id., “The Problem of Dialectical Reasoning (Sullogismos) in Aristotle”, Ancient Philosophy 14 (1994), pp. 99-132. 5 È questa l’opinione di J. Brunschwig, Introduction a Aristote, Topiques (livres I-IV), Paris 1967, p. XII (v. anche la nota 4 a p. 116); Id., “Aristotle on Arguments without Winners or Losers”, Wissenschaftskolleg Jahrbuch 1984-1985, Berlin 1986, p. 33; Id., “Remarques sur la communication de Robert Bolton”, in D. Devereux et P. Pellegrin (édd.), op. cit., pp. 237-262, spec. 262. 6 E la tesi di D. Devereux, “Comments on Robert Bolton’s The Epistemological Basis of Aristotelian Dialectic”, ivi, pp. 246-286, spec. 284-285. R. Smith, “Aristotle on the Uses of Dialectic”, Synphics 96 (1993), pp. 335-357, spec. 351-354. 8. Αετιτος. Τόρ. 12, 101 a 25-28 9 E la tesi, mi sembra, dell’ultimo intervento di Brunschwig (1990, p. 262) 10 Quests distinzione è stata fatta da Brunschwig nel voo primo intervento (1967, p. 116), ma non è stata da lui ripresa in quelli succes 12 Metaph. VI 1, 1026 a 16. Cfr. anche Bolton, 1990, p. 195. 13 Cfr. anche Eth. Eud. I 8, 1217 b 22-23, dove i λογοι κατα φιλοσοφιαν sono tutti i trattati non essoterici. 14 Eth. Eud. I 3, 1214 b 28-1215 a 6. 15 Ciò è stato notato sia da J. Barnes, “Aristotle and the Methods of Ethics”, Revue Internationale de Philosophie 133-134 (1980), pp. 490-511, che da C. Rossitto, “Sull’uso dialettico e retorico del termine ‘exètasis’ nella tradizione platonico-aristotelica”, in E. Berti e L.M. Napolitano Valditara (a cura), Etica, Politica, Retorica. Studi su Aristotele e la sua presenza nell’età moderna, L’Aquila 1989, pp. 163-200, spec. 183-184. 16 Top.I 11, 105 a 3-7. 18 Cfr. An. pr. II 20, 66 b 11; Soph. el. 9, 170 b 1; 10, 171 a 2, 4. 19 È la tesi di Bolton, 1990, pp. 199-200. 20 È la tesi di Devereux, 1990, p. 284, n. 49, che non vede in Metaph. B alcun impiego degli ενδοξα. 21 A questo proposito concordo interamente con Brunschwig, 1990. 22 La prima interpretazione è difesa da Brunschwig (Topiques, p. 117), che peraltro pensa ai diversi accessi alla conoscenza dei principi. E’ lui che ha attirato la mia attenzione sulla differenza tra l’impiego della dialettica a proposito dei principi ed il suo impiego a proposito delle altre opinioni. 21 Si vedano per esempio Phys. IV 4, 211 a 7-11; De caelo I 10, 279 b 4-12. Ho analizzato tutti questi passi nel mio libro Le ragioni di Aristotele, Roma-Bari 1989. 24 Come ha sostenuto Barnes, art. cit. 25 Metaph. III 2, 996 a 20-21. 26 Тор. 110, 103 b 15-16. 27 Метаря. III 2, 996 6 10-13 28 Metaph. 12, 982 a 16-19 29 Тор 1 1, 100 b 21-23 30 Una delle analisi miglion a questo proposito è stata fatta da W Cavini, “Modalità dialettiche nei Tapiri di Aristotele”, in Le teorie della modalità Atti del Convegno internazionale di Storia della logica, Bologna 1989, pp. 15-46 31 Top. VIII 12, 162 b 27. A questo proposito Bolton osserva (art. cit., 1994) che la dialettica argomenta a partire da premesse false perché sviluppa le aporie in entrambi i sensi, e che essa lo fa proprio allo scopo di confutare tali premesse 32 Top 11, 100 6 23-101 a 1. R. Wardy: “Transcendental Dialectic”, Pkroneri: 36 (1991), pp. 56-106, ha sostenuto che, poiché gli endaca apparenti sono sicuramente falsi, gli endoxa autentici devono essere pro facto vern 33 Brunschwig ha perfettamente ragione di tradurla come “la nature exacte du subterfuge” 34 Sopk el. 33, 182 637-38. 35 E questa l’interpretazione di Pacius, riportata da 7. Tricot (Aristote, Orgason, Paris 1950, vol. VI, ad loc.) 36 Cfr. Cavini, art. cit., pp. 26-29. 37 Cioè stato giustamente notato da P. Fait, “Argomentazioni e comparazioni endossali sulla strumura del metodo dialettico aristotelico”, Annali del Dipartamento di Filozofia, Univerità di Firenze, (1991), pp. 3-40, spec. 13-14. 38 La suddetta distinzione è proposta da Fait, art. cit, pp. 7-14, che dal canto suo adotta l’interpretazione coerentiatica, ma non sottolinea la funzione della “maggior parte degli endoxa. In questo articolo Tinterpretazione che ho dato della dialettica aristotelica nel libro citato è collocata tra quelle fondazionalistiche, a causa della mia affermazione secondo cui Aristotele certamente credeva che gli endoxa fossero veri (p. 25). Ora devo correggere questa affermazione aggiungendov: “nella maggior parte dei casi, ma posso confermare nel suo insieme l’interpretazione proposta in questo libro. 39 Eph. Mie. VII 1, 1145 62-7. 40 G.E.L. Owen, art. cit. Penso tuttavia che non vi sia un’opposizione molto netta ta fra questo significato, che è il più conforme alle scienze pratiche, e il significato di “fenomeni sensibili”, che il termine e ha a proposito delle scienze fisiche. Al nguardo concordo percio con JJ. Cleary, “Phasesmena in Aristotle’s Methodology”, International Journal of Philosophical Studies 2 (1994), pp. 61-97 41 M. Craven Nussbaum, “Saving Aristotle’s Appearances”, in M. Schofield and M. Nussbaum (eds.), Language and Logor, Cambridge 1982, pp. 267-293. 42 Ct. Top 1 11, 104 b 19-28, dove alcune opinioni di filosofi (chiamate “test”) sono dette paradossali 43 Top 1 11, 104 6 1-2, 45 Questa interpretazione, proposta da Brunschwig contro Bolton nel 1990, era stata proposta anche da me nel libro citato, p. 127. 46 Sono debitore di questa preziosa osservazione a M. Mignucci, che qui ringrazio. 44 Top 110, 104 a 5-11 48 Eth. Nic. VII 4, 1146 b 7-8. 49 Questa interpretazione mi è stata suggerita da Devereux e Irwin. 50 Eth. Nic. 18, 1098 b 9-12. 51 Cfr. Phys. IV 4, 211 a 9. Ciò è stato notato anche da Barnes, art. cit., p. 506, n. 35, e Fait, art. cit., p. 31, n.57. 52 De an. 12, 403 b 25; Soph el. 34, 183 a 38. E possibile anche che gli hyparchonta siano i fatti osservati, ma in questo caso essi hanno la stessa funzione degli endoxa, come osserva Cleary nell’art. cit 53 Enk. Mir. 18, 1098 6 27-29 54 Ech Eud 16, 12166 26-35. 55 Top 1 2,101a 30-34. 56 Sono d’accordo, a questo proposito, con ciò che scrivono Bames, art. cit., C. Natali, “Fino a che punto rispettare le opinioni in etica: Aristotele e gli endoxa”, in N. Di Domenico, A. Excher Di Stefano e G. Puglisi, Ermeneutica e fliocofia pratica, Venezia 1990, pp. 191-202. 57 Ech. Elud. VII 2, 1235 6 12-18. 58 Мегарі. 11 1, 993 a 30-b 4. 59 Rher. 1 1, 1355 a 14-18, 60 Eok. Mie. X 2, 1172 6 366-1173 a 2. 61 Rher II 25. 1402 32-34 62 Ciò è stato sostenuto da M. Bumyest in occasione del seminario da me tenuto a Cambridge 1’8 marzo 1993 sul tema “How many dialectics are there in Aristotle?” 63 Top 1 1, 100 a 21-23. che ha spinto TH. Irwin a scrivere, come lui stesso ammette, il suo libro il suo libro Aristotle’s First Principles (cfr. p. VII) ea sostenere l’esistenza in Aristotele di due dialettiche, l’una debole e l’altra forte. Per una valutazione di questa tesi devo rinviare alla mia recensione di tale libro, pubblicata in Elσηςλος 12 (1991), pp. 116-125, e alla mia relazione “Is there a Development in Aristotle’s Conception of Dialectic?”, presentata in occasione del 64 Cfi, per esempio, Riet 11 4, 1382 a 16-19, 6, 1385 a 14-15. 65 E proprio questo passo colloquio di Boston su New Stubes in Aristotele’s Philosophical Development (18-20 gennaio 1992), in corso di stampa 66 Mecap IV 2, 1004 b 17-26 67 decap IV 2, 1004 6 8-10. 68 Ciò è stato dimostrato in modo, a mio avviso, convincente da C. Rossumo, “La possibilità di un’indagine scientifica sugli oggetti della dialettica nella fraqizica di Aristotele, Am dell’Istituto Veneto di Science. Lettere ed arti 136 (1977-78), pp. 363-359, e “La dialettica e il suo ruolo nella Mergfizica di Aristotele”, Rivista de filosofia neoscolastica $5 (1993), pp. 370-424. opt el 11, 171 6 4-6. Ciò è stato giustamente osservato da R. Bolton. Bolton, “Aristotle’s Conception of Metaphysics as a Science in D. Charles, ML. Gill, T Scaltsas (edd.), Cluny Admin and Explanation in Aristotle’s Metaphysics, Oxford 1994, pp. 321-354 69 Cit. Sopik el 71 Top. I 13, 105 a 21-24.
70 Evidentemente la dimostrazione del principio di non-contraddizione per via di confutazione, realizzata da Aristotele nel libro I della Metafisica, è una confutazione del tutto particolare, perché non può consistere semplicemente nella riduzione della tesi dell’avversario a contraddizione, dato che la contraddizione prova la falsità di una tesi solo in base allo stesso principio di non-contraddizione. Ciò non è stato visto, mi sembra, da Bolton nell’articolo citato alla nota precedente.
47 Cfr. Soph. el. 9, 170 a 39-b 5, in cui la “risoluzione” (λυσις) è esplicitamente collegata con la confutazione (ελεγχος); Soph. el. 18, 176 b 29, e 24, 179 b 23, in cui la risoluzione è definita come la manifestazione della falsità di una deduzione; Rhet. II 25, 1402 a 31-32, in cui la risoluzione è identificata con la “controdeduzione” (αντισυλλογίζεσθαι), cioè con la deduzione a partire da premesse opposte, e Rhet. II 26, 1403 a 24-26, dove essa è identificata con la “controdimostrazione” (ανταποδεικνυσθαι), cioè con la dimostrazione della tesi opposta. 17 Bolton, 1990, p. 213, afferma che i due aggettivi εξεταστικη ε πειραστικη derivano da radici i cui significati in greco si sovrappongono e che essi sono interscambiabili sia in Aristotele che in Platone (egli cita Rhet. I 1, 1354 a 5; Top. VIII 5, 159 a 25, 33; e Platone, Apol. 22 E-23 C; Prot. 348 A). 11 Cfr. Metaph. VI 1, 1026 a 18-19, dove Aristotele chiama “filosofie” tutte e tre le scienze teoretiche, cioè la matematica, la fisica e la teologia; e in generale si veda la voce φιλοσοφια nell’Index di Bonitz (Graz 1955).
Il metodo della filosofia pratica secondo Aristotele
A cura di Enrico Berti
1. L’intento tipologico
La fisica e la metafisica sono le due “scienze teoretiche” coltivate da Aristotele, quelle che si contendono il primato ed il titolo di “sapienza” (spettante, come si potrebbe mostrare in altra sede, inizialmente alla fisica e conclusivamente alla metafisica): la terza scienza teoretica da lui riconosciuta, cioè la matematica, non fu infatti da lui coltivata direttamente, anche se fu oggetto della sua considerazione come modello del metodo rigorosamente apodittico. Dal punto di vista del metodo, la fisica e la metafisica non differiscono sostanzialmente tra di loro, in quanto praticano procedimenti di tipo prevalentemente dialettico, cioè dialogico, raggiungendo livelli più o meno alti di dimostratività, mentre si distinguono abbastanza nettamente dalla matematica, la quale invece, secondo Aristotele, segue procedimenti dimostrativi di tipo esclusivamente monologico. Un’attenta considerazione merita, dal punto di vista metodologico, la cosiddetta filosofia pratica, perché essa è stata recentemente individuata, proprio nella sua formulazione aristotelica, come espressione di una forma di razionalità diversa rispetto a quella scientifica (2).
La dizione “filosofia pratica” è stata adottata per la prima volta proprio da Aristotele, il quale, nel II libro della Metafisica—il famoso ” alfa minuscolo”, che qualcuno considera non autentico, ma che in realtà è solo estraneo alla serie originaria—, dichiara:
“è giusto anche chiamare la filosofia scienza della verità. Infatti della filosofia teoretica è fine la verità, di quella pratica l’opera, poiché i [filosofi] pratici, anche se indagano il modo in cui stanno le cose, non studiano la causa di per se stessa, ma in relazione a qualcosa ed ora” (1, 993b 19-23).
La filosofia pratica, dunque, ha in comune con quella teoretica il fatto di cercare la verità, ossia la conoscenza di come stanno effettivamente le cose, e di cercare anche la causa di come esse stanno, ossia di essere scienza. La sua differenza rispetto alla filosofia teoretica è che per quest’ultima la verità è fine a se stessa, mentre per la filosofia pratica la verità non è il fine, ma è solo un mezzo in vista di altro, ossia dell’azione, la quale è sempre situata nel tempo presente, cioè non è qualcosa di già esistente, ma qualcosa che deve esser fatto ora. Mentre, insomma, la filosofia teoretica lascia, per così dire, le cose come stanno, aspirando solo a conoscere perché stanno in un certo modo, la filosofia pratica, al contrario, cerca di instaurare un nuovo stato di cose, e cerca di conoscere il perché del loro modo di essere solo al fine di cambiarlo.
Questo rapporto è ulteriormente illustrato nella famosa classificazione delle scienze contenuta nel libro VI, sempre della Metafisica. Qui Aristotele, dopo aver detto che la fisica, avendo per oggetto la natura, la quale ha in se stessa il principio del moto e della quiete, non è una scienza né pratica né poietica, aggiunge:
“infatti delle cose producibili il principio è in colui che produce, cioè è l’intelligenza o l’arte o una qualche altra capacità, mentre delle cose praticabili esso è in colui che agisce, ossia è la scelta, poiché ciò che è oggetto di azione coincide con ciò che è oggetto di scelta. Sicché, se ogni razionalità è o pratica o poietica o teoretica, la fisica sarà una [razionalità] teoretica, ma teoretica intorno ad un ente tale che è capace di muoversi, ed intorno alla sostanza che è secondo la forma per lo più, non quella che è solo separata” (1, 1026 a 22-27).
La denominazione di “pratica” deriva dunque dall’oggetto di questa scienza, che è costituito dalle cose “praticabili”, cioè dalle azioni, dalla “prassi”, le quali hanno il loro principio nella scelta, cioè nella iniziativa dell’uomo, perciò non sono indipendenti come le sostanze naturali, oggetto della fisica, anche se queste ultime sono anch’esse secondo la forma, cioè conformi alla regola, soltanto “per lo più” (cioè non “sempre”, come le realtà separate, ovvero immateriali, oggetto della matematica), esattamente come vedremo essere l’oggetto della filosofia pratica. L’azione, insomma, caratterizza la filosofia pratica sia come scopo che come oggetto, nel senso che l’unico settore della realtà in cui sia possibile, secondo Aristotele, cambiare lo stato delle cose, è quello costituito dalle azioni umane.
Questo intento pratico è ciò che contraddistingue la filosofia pratica, nel senso aristotelico del termine, non solo dalla filosofia teoretica, che in Aristotele abbraccia tanto ciò che noi chiamiamo filosofia quanto ciò che noi chiamiamo scienza, ma anche dalla scienza nel senso moderno del termine, che abbraccia tanto le scienze naturali quanto le cosiddette scienze umane, o sociali, o politiche. In virtù di esso, infatti, la filosofia pratica è tutt’altro che ” neutrale”, ” avalutativa”, nei confronti della realtà (umana), ma al contrario essa ne giudica il valore, cioè valuta che cosa in essa è bene e che cosa è male, al fine di migliorarla. Nel fare questo, tuttavia, essa non rinuncia a conoscere la verità, cioè ad essere scienza, ad accertare non solo come stanno le cose, ma anche quali ne sono le cause.
Vediamo allora qual è il metodo di questa scienza, cioè in quale misura la peculiarità del suo scopo e del suo oggetto influisce sul suo modo di procedere. Per chiarire questo, è necessario andare alle opere in cui tale filosofia è sistematicamente esposta, cioè le Etiche e la Politica. All’inizio dell’Etica Nicomachea Aristotele non esita a dichiarare che l’oggetto della “scienza politica” – questo, infatti, è il nuovo nome della filosofia pratica, per le ragioni che subito vedremo – è il bene supremo dell’uomo, cioè il suo fine ultimo, quello in vista del quale vengono ricercati tutti gli altri. Parlare del “bene”, inteso come fine dell’uomo, significa parlare di qualcosa che non è ancora realizzato, ma che proprio per questo si vuole realizzare e deve poter essere realizzato, cioè è “praticabile” e “da praticarsi”. Esso, per Aristotele, non è soltanto il bene del singolo individuo, bensì è il bene dell’intera città (polis), perché il singolo è parte della città; perciò la scienza che se ne occupa è la scienza della città, ovvero la scienza “politica”. Questa è anche detta da Aristotele “scienza architettonica” rispetto a tutte le altre arti o scienze pratiche (arte delle costruzioni navali, strategia, economia), perché svolge una funzione direttiva nei confronti di tutte, in quanto si occupa del fine ultimo (I 2).
La scienza politica non ha soltanto lo scopo di conoscere che cos’è il bene supremo, bensì si propone anche di realizzarlo; anzi, dice Aristotele, la conoscenza di esso ha una grande importanza proprio perché, guardando ad esso come ad un bersaglio, come fanno gli arcieri, “riusciremo meglio a realizzare ciò che deve essere”: dunque il bene non è soltanto un essere da conoscere, ma anche un “dover essere” da realizzare. La scienza politica, infatti, è “legislatrice”, cioè prescrive “che cosa si deve fare e da quali azioni ci si deve astenere”. Proprio per questo, a proposito del bene supremo dell’uomo, essa si accontenta di “delineare almeno in generale che cosa esso è mai” (1094 a 25), cioè si accontenta di conoscerlo, per così dire, nel “tipo”, vale a dire nello schema generale, nelle linee fondamentali, senza considerare le sue applicazioni particolari nei minimi dettagli.
Quest’ultima espressione, la quale ricorre numerose volte sia nell’Etica Nicomachea (1101 a 27, 1104 a 1, 1107 b 14, 1113 a 13, 1114 b 27, 1117 b 21, 1129 a 11, 1176 a 31, 1179 a 34) che nella Politica (1276 b 19, 1302 a 19, 1323 a 10, 1335 b 5, 1341 b 31), compare per la prima volta in Aristotele nei Topici a proposito della classificazione delle diverse specie di sillogismo (apodittico, dialettico, eristico), per dire che essa è sommaria, cioè non è un discorso “accurato” (akribes), ovvero dettagliato, preciso, esauriente – come quello che, ad esempio, viene fatto negli Analitici a proposito delle diverse figure di sillogismo -, ma tuttavia è “sufficiente alla trattazione proposta” (I 1, 101 a 19-24). Ciò significa che il risultato in questione non è il più accurato che si possa desiderare, pur senza essere errato o falso: esso ha il grado di accuratezza che si richiede ad una trattazione, la quale non ha come scopo esclusivo una conoscenza perfetta di un certo oggetto, ma vuole servirsi della conoscenza di esso in vista di un fine ulteriore. Insomma il carattere “generale”, o “tipologico”, della scienza politica è strettamente connesso al suo intento pratico(3).
Si deve riconoscere, tuttavia, che non solo la filosofia pratica si propone un intento tipologico, ma questo è comune, in certi momenti, anche alle scienze teoretiche, per esempio alla psicologia (De anima, II 1, 413 a 9; II 4, 416 b 30) ed alla zoologia (de part. an. I 1, 487 a 12; hist. an. I 6, 491 a 8), cioè alla fisica, e persino alla metafisica (cfr. metaph. VII 3, 1029 a 7), cioè si presenta ogni qualvolta non è necessario esaurire l’argomento sin nei dettagli, perché la trattazione non è fine a se stessa, ma è in vista di altro.
La proclamazione esplicita del carattere tipologico della scienza politica è contenuta nel capitolo del I libro delI’Etica Nicomachea, interamente dedicato all’illustrazione del metodo, dove Aristotele, a proposito appunto della “trattazione politica (methodos… politike)” dichiara:
“si parlerà in modo sufficiente, se si raggiungerà la chiarezza adeguata alla materia che sta sotto; il rigore (to akribes) infatti non deve essere cercato nella stessa misura in tutti i discorsi, come neppure in tutti i manufatti. Le azioni belle e giuste, di cui si occupa la scienza politica, hanno molte differenze e variazioni, al punto che sembrano essere solo per legge, non per natura. Ed un qualche margine di variazione di questo genere hanno anche i beni, per il fatto che a molti derivano danni da essi; alcuni infatti sono periti proprio a causa della ricchezza, altri a causa del coraggio” (I 3, 1094 b 11-19).
Qui Aristotele descrive con molta chiarezza quello che abbiamo chiamato l’intento tipologico proprio della scienza politica: essa si occupa delle azioni belle, cioè nobili, e giuste, come pure dei beni, che sono oggetti alquanto diversi e variabili, nel senso che ciò che è giusto in determinate circostanze può non esserlo in altre, e ciò che è bene per alcuni, può non esserlo per altri. La scienza politica non può, però, scendere nei dettagli, cioè determinare con assoluta precisione, o accuratezza, o rigore (akribes), ciò che è bello, giusto o buono in ciascuna circostanza o in ciascun caso particolare, ma deve limitarsi a indicare ciò che è bello, giusto e buono in generale. Anche qui dunque, come nei Topici, l’intento tipologico viene contrapposto all’accuratezza, al rigore. Si noti che, nel libro II della Metafisica, Aristotele dice la stessa cosa anche a proposito della fisica, quando afferma che non si deve pretendere l’esattezza della matematica anche nelle scienze di realtà materiali (3, 995 a 14-17).
Ma il parallelismo, dal punto di vista metodologico, tra la scienza politica e la fisica viene da lui ulteriormente sviluppato:
“si deve dunque desiderare che coloro i quali parlano intorno a cose siffatte ed a partire da premesse siffatte mostrino il vero sommariamente e nelle linee fondamentali, e che coloro i quali parlano intorno a cose che sono per lo più ed a partire da premesse di questo genere giungano anche a conclusioni di questo genere” (1094 b 19-22).
Qui da un lato viene ribadito l’intento tipologico, proprio della scienza politica, mentre dall’altro viene applicata anche ad essa la figura della dimostrazione valida non “sempre”, ma “per lo più”, cioè nella maggior parte dei casi, di regola (con qualche eccezione), che è propria della fisica (cfr. metaph. VI 1, 1025 b 26-28) e che, stando agli Analitici posteriori, non toglie il carattere di vera e propria scienza al discorso in questione (cfr. an. post. I 30, 87 b 19-22). Si deve supporre che “per lo più” siano i beni: per esempio la ricchezza per lo più è un bene, anche se in qualche caso produce danni. Le “molte differenze e variazioni” che caratterizzano i beni, menzionate in precedenza, non eccedono dunque il margine di indeterminatezza che è proprio del “per lo più” e comunque non impediscono di ” mostrare il vero ” e di concludere, sia pure ” per lo più”, a partire da premesse, cioè di fare dei veri e propri sillogismi.
Il parallelo con la fisica diventa poi un vero e proprio parallelismo col capitolo di metaph. II in cui il metodo di questa viene esposto. Prosegue infatti Aristotele:
“allo stesso modo è necessario anche che sia accolta ciascuna delle cose dette; è proprio infatti di colui che è istruito cercare il rigore in ciascun genere tanto quanto la natura della cosa lo ammette, poiché fa la stessa impressione sia accettare che un matematico faccia discorsi persuasivi sia pretendere che un retorico faccia dimostrazioni. Ciascuno giudica bene le cose che conosce, e di queste è buon giudice. In ciascun genere allora [giudica bene] colui che è istruito [in quel genere], mentre [giudica bene] in generale colui che è istruito intorno a tutto ” (1904 b 22 – 1095 a 2).
L’idea che bisogna essere istruiti sul metodo di ciascuna scienza prima di cominciare ad ascoltarne l’esposizione è già affermata in metaph. II (995 a 13), come pure la contrapposizione tra la matematica, concepita come dotata del massimo rigore, in quanto strutturata di vere e proprie dimostrazioni, e la retorica, concepita come mancante di rigore e dotata invece di persuasività, in quanto basata su esempi e testimonianze di poeti: come la fisica, in quel libro, si colloca ad un livello intermedio tra le due, così si deve pensare che si collochi la filosofia pratica, che è dunque più ” debole “, o ” duttile “, della prima e più ” forte”, o “rigorosa”, della seconda.
C’è infine un altro motivo di affinità tra la filosofia pratica, o scienza politica, e la fisica: entrambe abbisognano dell’esperienza. Continua infatti Aristotele:
“perciò della politica non è uditore appropriato il giovane; questi infatti è inesperto [apeiros, cioè senza esperienza] delle azioni che si compiono lungo l’intera vita, mentre i discorsi [della politica] partono da queste e vertono su queste” (1095 a 2-4).
È chiaro tuttavia che qui per esperienza non si intende semplicemente la conoscenza sensibile, cioè le “sensazioni”, ma l’esperienza della vita, cioè la conoscenza ripetuta di certe situazioni dovuta al fatto di averle vissute. La necessità di questa esperienza conferisce al cultore di filosofia pratica un certo carattere, che vedremo ricorrere anche nel ” saggio”, cioè in colui che, pur non essendo filosofo, sa come ci si deve comportare nei singoli casi.
Tipico della filosofia pratica, non di quella teoretica – pur essendo, ancora una volta, comune anche alla ” saggezza ” -, è invece l’ultimo carattere indicato da Aristotele, cioè:
“inoltre [il giovane] essendo seguace delle passioni, ascolterà vanamente ed inutilmente, poiché il fine non è la conoscenza, ma l’azione. Non fa nessuna differenza se uno è giovane di età o immaturo di carattere; il difetto non deriva infatti dal tempo, ma dal vivere secondo la passione e dal seguire ogni impulso. Per coloro che sono cosiffatti la conoscenza diventa inutile, come per gli incontinenti. A coloro invece che rendono i loro desideri conformi alla ragione ed agiscono di conseguenza, sarà molto utile il sapere intorno a queste cose” (1095 a 4-11).
Il requisito qui indicato per seguire con profitto un corso di filosofia pratica è una certa capacità di dominare le passioni, che in genere è assente nei giovani o negli immaturi di carattere. Esso è reso necessario dall’intento pratico di questa scienza, che non è solo di far conoscere il bene, ma di aiutare a praticarlo, cioè di rendere migliori. A nulla servirebbe, infatti, conoscere il bene, se poi non si avesse anche la forza di metterlo in pratica. Si noti come Aristotele si mostri qui perfettamente consapevole dell’insufficienza del solo conoscere in vista dell’agire, probabilmente con un sottinteso polemico nei confronti di Socrate, per il quale la sola conoscenza del bene era invece del tutto sufficiente a farlo praticare.
Ulteriori indicazioni metodologiche sulla scienza politica, che in fondo rientrano nell’approccio tipologico, sono contenute in altri passi del I libro dell’Etica Nicomachea.
“Non ci sfugga – dice Aristotele – la differenza tra i discorsi che derivano dai princìpi e quelli che vanno verso i princìpi. Giustamente infatti Platone si poneva questo problema e cercava se la via (hodos) venga dai principi o vada verso i principi, come nello stadio se vada dai giudici di gara alla meta o viceversa. Si deve infatti cominciare dalle cose note, ma queste lo sono in due sensi, cioè alcune per noi ed altre in assoluto. Certamente noi dobbiamo partire da quelle note a noi. Perciò è necessario che l’ascoltatore adeguato intorno a cose belle e giuste e in generale a questioni politiche sia stato educato bene per mezzo delle abitudini: principio infatti è il che, e se questo appare sufficientemente chiaro, non ci sarà più bisogno del perché, poiché chi è tale possiede o apprende facilmente i principi, mentre chi non è nessuno di questi tali, ascolti le parole di Esiodo, ecc.” (I 4, 1095 a 30-b 9).
L’analogia qui stabilita è ancora una volta tra la filosofia pratica e la fisica, perché è proprio della fisica partire dalle cose più note a noi, cioè dal “che”, dal dato di fatto, per risalire verso quelle più note in assoluto, cioè più intelligibili, che sono i principi, o il “perché” (cfr. phys. I 1, 184 a 15-21). Ma ben diverso è il significato che, nella filosofia pratica, hanno il “che” ed il “perché”. Il primo, infatti, sembra consistere nella norma, ovvero nell’indicazione “che” una certa cosa è buona, o “che” una certa cosa si deve fare, mentre il secondo sembra essere la giustificazione della norma, ossia la sua fondazione razionale.
Il primo, dunque, è principio per noi, o cosa più nota a noi, mentre il secondo è principio per sé, o cosa più nota in assoluto. Aristotele, col suo solito realismo, cioè con la consapevolezza già manifestata circa l’insufficienza del solo conoscere ai fini dell’agire bene, ritiene più necessaria, a questo fine, una buona educazione, attuata per mezzo di buone abitudini, che una accurata conoscenza del perché.
Anzi, anche sotto il profilo della conoscenza, secondo Aristotele, è più facile risalire al perché, cioè ai principi più noti in assoluto, alla giustificazione razionale della norma, una volta che si possiedano, per via di una buona educazione, i principi più noti a noi, cioè il che, la norma. Il metodo, dunque, è sempre quello di procedere dalle cose più note a noi, cioè dall’esperienza, a quelle più note in sé, cioè ai princìpi, ma ancora una volta per esperienza si intende un abito morale acquisito, non una mera conoscenza esteriore. Fatte salve queste differenze, la filosofia pratica si presenta, sotto l’aspetto metodologico, non dissimile dalla fisica, nel senso che va anch’essa alla ricerca di una fondazione razionale dell’esperienza, e quindi sale dal caso particolare alla legge generale, anche se si accontenta di determinare quest’ultima in maniera sommaria e generica, perché ciò che le interessa non è tanto la sua formulazione rigorosa, quanto la sua applicazione pratica.
Infine, dopo avere fornito una prima definizione dell’oggetto della scienza politica, cioè del bene supremo, ovvero della felicità, come esercizio della funzione propria (oikeion ergon) dell’uomo – che è una dottrina importante e famosa, caratterizzante l’intera sua etica – , Aristotele presenta il risultato in tal modo acquisito come esempio di approccio tipologico, nei termini seguenti:
“resti dunque in questo modo delineato nei suoi contorni il bene, poiché bisogna anzitutto disegnare lo schema, indi precisare ulteriormente. Si ritiene che sia alla portata di tutti proseguire e completare ciò che è stato delineato bene nei suoi contorni, e che il tempo sia buono scopritore o collaboratore nella scoperta di cose siffatte; dal che sono derivati anche i progressi nelle arti, poiché è alla portata di tutti aggiungere ciò che manca. Bisogna poi ricordarsi anche di quanto detto prima e non cercare l’accuratezza (akribeian) allo stesso modo in tutte le cose, ma in ciascuna secondo la materia che sta sotto e tanto quanto è proprio della trattazione” (I 7, 1098 a 20-29).
Di nuovo qui Aristotele oppone l’intento tipologico all’accuratezza, cioè al rigore, pur riferendosi ad una dottrina importante come quella della funzione propria dell’uomo, il che dimostra che la relativa mancanza di rigore o, meglio, di definitività, non comporta alcuna rinuncia alla fondazione razionale, cioè al discorso propriamente filosofico. Ai suoi occhi, probabilmente, le matematiche fornivano l’esempio di un sapere compiuto, e perciò non più suscettibile di alcun progresso, mentre la filosofia, cioè la fisica, la metafisica e la filosofia pratica, erano piuttosto simili alle arti, cioè alle tecniche (intese nel senso antico del termine), nelle quali è possibile un continuo progresso, non però nel senso del cambiamento radicale, bensì in quello del perfezionamento, della rifinitura di un abbozzo già disegnato nelle sue grandi linee.
Il discorso prosegue con l’esempio dei due modi diversi in cui l’angolo retto viene studiato dal costruttore e dallo studioso di geometria – esempio che ricorda molto da vicino quello della differenza tra la forma del camuso, oggetto della fisica, e quella del curvo, oggetto della matematica (cfr. metaph. VI 1, 1025 b 30 -1026 a 6) -, e si conclude così:
“neppure la causa deve essere cercata in tutte le cose allo stesso modo, ma in alcune è sufficiente che sia mostrato bene il che: per esempio, anche riguardo ai principi, il che è primo e principio. Tra i principi, poi, alcuni sono appresi per mezzo dell’induzione, altri per mezzo della sensazione, altri per mezzo di una specie di abitudine, altri in altri modi ancora. Bisogna cercare di intendere ciascuno di essi nel modo che gli è connaturato e bisogna impegnarsi affinché siano definiti bene, poiché essi hanno una grande importanza per ciò che segue. Si ritiene infatti che il principio sia più della metà dell’intero, e che molte delle cose indagate diventino chiare per mezzo di esso” (1098 a 33-b 9).
Qui Aristotele distingue chiaramente tre tipi di principi: quelli appresi per mezzo dell’induzione, quelli appresi per mezzo della sensazione e quelli appresi per mezzo dell’abitudine. I primi non possono che essere quelli della matematica, perché i secondi sono quelli della fisica. Mentre questa, infatti, perviene ai principi partendo dalla sensazione (cfr. metaph. VI 1, 1025 b 11), cioè dalla conoscenza sensibile, quella vi perviene per mezzo dell’induzione (cfr. an. post. II 19), cioè per mezzo della guida di un insegnante – il termine “induzione” letteralmente significa “guidare verso” ed equivale a “introduzione” -, il quale si serve di esempi particolari (per es. di figure disegnate) per far capire le assunzioni di esistenza e le definizioni universali (delle figure immateriali).
Il terzo tipo di principi, quelli che si apprendono per mezzo dell’abitudine, sono i principi della filosofia pratica. Solo per essi vale l’affermazione che il principio ed il primo è il “che”: essi infatti, come già abbiamo visto, consistono nella posizione di una norma, cioè nell’indicazione che una certa azione è buona (o cattiva) e pertanto deve essere fatta (o evitata). In questo caso, dunque, il “che” non significa una mera situazione di fatto, ma indica in generale una proposizione, un giudizio, una valutazione, presentata senza un “perché”, cioè senza una fondazione razionale. Ma è chiaro che il compito della filosofia pratica è di fondare questo tipo di principi, cioè di cercarne il perché, la causa, la ragione, sia pure in modo sommario e generale, cioè attraverso l’approccio tipologico, perché il suo interesse fondamentale non è conoscitivo, cioè teoretico, ma pratico. Con la filosofia pratica, dunque, siamo in presenza di una forma di razionalità originale, specifica, nettamente diversa dalla matematica come struttura e grado di rigore, più affine alla fisica sotto quest’ultimo aspetto, ma diversa anche dalla fisica per il suo intento.
2. Il procedimento diaporetico
Se quello che abbiamo chiamato intento tipologico indica il tipo di conoscenza a cui la scienza politica aspira, dato il suo carattere fondamentalmente pratico, il modo per ottenere tale conoscenza, cioè il vero e proprio percorso da seguire, viene descritto da Aristotele nei termini di un procedimento caratteristico della sua dialettica, che potremmo chiamare procedimento aporetico. Già all’inizio dell’Etica Nicomachea, infatti, cioè subito dopo avere enunciato l’intento tipologico, Aristotele si accinge a determinare che cosa sia il bene supremo dell’uomo, quello che tutti chiamano felicità, rilevando che esso viene inteso in modo diverso dai “molti” e dai “sapienti”. Per mezzo della prima espressione egli allude a concezioni che identificano la felicità col piacere, o con la ricchezza, o con il potere, mentre per mezzo della seconda allude fondamentalmente alla concezione di Platone, che identifica il bene supremo con la stessa Idea del bene. Ed ecco il primo accenno di tipo metodologico:
” esaminare (exetazein) tutte le opinioni è certamente alquanto vano, mentre è sufficiente farlo con quelle più diffuse o che sono ritenute possedere qualche ragione” (I 4, 1095 a 28-30).
L”‘esaminare” (exetazein) è l’attività propria della dialettica, la quale – come è detto nei Topici a proposito del suo terzo “uso”, cioè della sua utilità per le scienze filosofiche -, proprio per il fatto di essere “esaminatrice”, possiede la via che conduce ai principi di tutte le discipline (top. I 2, 101 b 3-4). Esaminare significa vagliare, saggiare il valore, sottoporre a prova (exetasis è infatti sinonimo di peira): tutte operazioni che, nel corso della discussione dialettica, vengono compiute da colui che interroga. Ciò che viene esaminato sono le opinioni, cioè, nel caso specifico, le diverse concezioni del bene, o della felicità, delle quali si vuole appunto accertare il valore, la tenuta, la consistenza. Ma non vale la pena – questa è la tesi proposta qui da Aristotele – esaminare tutte le opinioni che siano mai state espresse sul bene, cioè anche le opinioni qualsiasi, che non hanno mai avuto alcun credito e che dunque sono quasi sicuramente sprovviste di valore. Bisogna esaminare solo le più diffuse o quelle professate dai più sapienti, perché queste hanno più probabilità di possedere qualche ragione.
Non si confondano, tuttavia, queste opinioni, le quali devono essere esaminate, con gli éndoxa, i quali sono ciò alla luce di cui le opinioni vengono esaminate. Gli endoxa, infatti, sono le premesse da cui muovono i sillogismi dialettici (cfr. top. I 1, 100 a 29-b 23), non ciò che si cerca di confutare per mezzo di questi ultimi. Aristotele in genere non mette in discussione gli éndoxa, ma si serve di questi per mettere in discussione le opinioni. Anche quando, come nel caso della filosofia pratica, egli reputa degne di essere esaminate soltanto alcune opinioni, cioè le opinioni importanti, condivise, autorevoli, non per questo egli intende mettere in questione gli endoxa. È infatti a partire da questi, cioè da premesse che non possono non essere concesse, che si discuterà il valore dell’opinione dei molti o di quella di Platone.
Né si deve credere che il metodo qui esposto contrasti con quello proposto per la fisica o per la metafisica, dove si raccomanda di prospettare “tutte” le opinioni relative ad un certo problema (cfr. phys. I 1, 184 b 15-25; metaph. III 1, 995 a 24-27): l’importante, infatti, non è di accumulare quantitativamente il maggior numero possibile di opinioni, perché ciò non ha alcuna influenza sulla validità dell’esame, bensì di abbracciare tutte le possibili soluzioni di un problema, al fine di individuare quella giusta per mezzo di una progressiva eliminazione di tutte le altre. Ora, per prospettare tutte le soluzioni, bisogna creare delle alternative tra proposizioni reciprocamente contraddittorie, nelle quali possano rientrare tutte le opinioni possibili, senza che sia necessario esaminare queste ultime una ad una. Per non dire, poi, che nella filosofia pratica la completezza dell’esame è meno necessaria che nella fisica e nella metafisica, dato l’approccio tipologico che contraddistingue la prima, cioè il suo intento fondamentalmente pratico. In sostanza, dunque, Aristotele viene a proporre anche per la filosofia pratica lo stesso metodo dialettico che ha già proposto per la fisica e la metafisica.
Egli illustra questo metodo ulteriormente, sempre nell’Etica Nicomachea, subito dopo avere osservato che la definizione di felicità come esercizio della funzione propria dell’uomo rappresenta un primo abbozzo, il quale richiede di essere ulteriormente precisato, ed avere ricordato i diversi modi (induzione, sensazione, abitudine) attraverso cui si perviene al principio.
“Intorno a questo [cioè al principio] – egli prosegue – si deve indagare non solo a partire dalla conclusione e dalle premesse da cui derivano i discorsi, ma anche a partire dalle cose che vengono dette a proposito di esso, poiché rispetto al vero tutte le cose esistenti concordano, mentre rispetto al falso il vero subito discorda” (I 8, 1098 b 9-12).
Qui Aristotele anzitutto allude ai due modi fondamentali in cui un principio (con questa espressione, nel caso specifico, egli intende la definizione della felicità), può venire in genere scoperto, cioè il procedimento dal basso verso l’alto e quello dall’alto verso il basso, praticati rispettivamente dalla fisica e dalla matematica (il primo è quello che parte dalle conclusioni, cioè dagli effetti, il secondo quello che parte da premesse anteriori, cioè da cause ancora più universali o originarie). Ma a questi due modi egli ne aggiunge un terzo, che è quello qui più interessante, il quale consiste nel partire dalle “cose dette”, cioè dalle sentenze, vale a dire dalle opinioni. Si tratta dunque, ancora una volta, del metodo dialettico precedentemente accennato.
Tuttavia nell’ultimo passo riportato è contenuta un’importante osservazione circa il valore di tale metodo, quella per cui le opinioni vere sono tutte concordi, o compatibili, tra di loro, mentre tra le opinioni vere e quelle false c’è inevitabilmente discordia, cioè incompatibilità. In altri termini, quando c’è discordia tra due opinioni, è impossibile che siano entrambe vere, ma una di esse sarà vera e l’altra falsa, mentre quando c’è perfetta concordia tra più opinioni, esse possono benissimo essere tutte vere. La discordia, dunque, è segno – non necessario ma sufficiente – del falso, mentre la concordia è segno – necessario anche se non sufficiente – del vero. L’osservazione si basa, come si vede, niente meno che sul principio di non contraddizione, per cui la realtà è sicuramente incontraddittoria, e su quello del terzo escluso, per cui uno dei due corni della contraddizione è vero, mentre l’altro è falso.
Ma essa non è altro che un’allusione al metodo dialettico della confutazione: come risulta dai Topici, infatti, nella discussione dialettica colui che domanda, cioè che sottopone ad esame un’opinione, cerca di dedurne una contraddizione con qualche endoxon o comunque con qualche premessa concessa dall’avversario, poiché la contraddizione, cioè l’incoerenza interna ad un discorso, è considerata il segno più sicuro della sua falsità, mentre colui che risponde cerca di evitare in tutti i modi la contraddizione, perché l’incontraddittorietà, cioè la coerenza interna al discorso, è indispensabile alla sua verità. Questo stesso metodo, del resto, viene praticato ancora oggi nei dibattiti giudiziari, dove un testimone che si contraddice è considerato inattendibile, mentre una serie di testimonianze tra loro coerenti sono ritenute attendibili.
Aristotele applica questo metodo a proposito della sua definizione della felicità e trova conferma alla verità di essa nel fatto che le opinioni più diffuse o più autorevoli circa la felicità, per esempio quelle che la identificano con i beni dell’anima, o con la virtù, o con la saggezza, sono sostanzialmente concordi con essa. Anche opinioni come quella che identifica la felicità col piacere o quella che la identifica coi beni esteriori, secondo Aristotele, non sono incompatibili con la sua definizione, perché l’esercizio della funzione propria dell’uomo implica sicuramente il piacere e perché i beni esteriori sono pur sempre condizione necessaria per tale esercizio.
Ma il passo forse più famoso circa il metodo della filosofia pratica è quello contenuto all’inizio del libro VII, in cui Aristotele spiega come si deve procedere a proposito dell’incontinenza.
“Bisogna come negli altri casi, dopo aver posto i fenomeni (phainomena) ed avere anzitutto sviluppato le aporie (diaporesantas), mostrare in tal modo per quanto è possibile tutti gli endoxa intorno a queste passioni, e se ciò non è possibile, almeno la maggior parte ed i più importanti; qualora infatti si risolvano le difficoltà e si lascino in piedi gli endoxa, si sarà mostrato in modo sufficiente” (VII 1, 1145 b 2-7).
Tutti gli interpreti ormai concordano nel riconoscere che i “fenomeni” qui menzionati non sono i dati dell’osservazione sensibile, significato che pure il termine altrove possiede, bensì “ciò che pare alla gente”, e quindi i pareri, le opinioni (4). La prima cosa da fare, dunque, secondo Aristotele, è prendere in considerazione le opinioni espresse dagli altri a proposito dell’argomento trattato, nella fattispecie, le opinioni concernenti l’incontinenza. Queste opinioni, tuttavia, devono essere sottoposte ad esame, cioè indagate, messe alla prova. Ciò viene fatto per mezzo del procedimento chiamato diaporesai, il quale consiste, come è detto in top. I 2, 101 a 34-35, ed esemplificato in metaph. III, nello sviluppare le aporie in due direzioni opposte. A proposito di ciascuna opinione, dunque, si deve prospettare di fronte ad essa quella opposta, oppure si devono disporre tutte le opinioni concernenti un certo problema in coppie, o alternative, tra loro opposte; indi da ciascuna delle due opinioni tra loro opposte si devono dedurre tutte le conseguenze che ne derivano. A questo punto si devono confrontare tali conseguenze con gli endoxa relativi al problema in questione, cercando di vedere se esse si accordino o meno con tutti gli endoxa, o almeno con la maggior parte, o con i più importanti. Gli endoxa, si badi bene, non vengono messi in discussione, ma vengono presentati solo come termini di confronto, cioè come premesse fuori discussione, alla luce delle quali valutare le opinioni in questione, e le loro conseguenze.
Se si riesce a mostrare che le conseguenze di un’opinione si accordano con gli endoxa presentati, allora si saranno ” risolte le difficoltà ” (scartando, evidentemente, l’opinione opposta), e questa dovrà essere considerata una dimostrazione sufficiente della validità di un’ipotesi. Oppure, se non si riesce a fare questo, perché le conseguenze di un’opinione non si accordano con gli endoxa presentati, allora le difficoltà non saranno state risolte e l’opinione non sarà stata dimostrata, anzi sarà stata dimostrata in modo sufficiente la sua falsità. In ogni caso ciò che deve restare in piedi sono gli endoxa.
Questo non è altro, come si vede, che il procedimento diaporetico più volte teorizzato da Aristotele, anche a proposito della fisica (cfr. phys. IV 4, 211 a 6-11) e della metafisica (cfr. metaph. III 1, 995 a 27-30). Esso non è per nulla, dunque, specifico della filosofia pratica e non consiste, come qualcuno ha creduto, nel cercare di salvare gli endoxa, bensì consiste nel mettere alla prova i phainomena, cioè le opinioni, alla luce degli endoxa. Quando, infatti, Aristotele prescrive, come condizione del dimostrare in modo sufficiente, che siano lasciati in piedi gli endoxa, non intende dire che lo scopo della dimostrazione sia di mostrare la validità degli endoxa, ma che, per risolvere le difficoltà concernenti un’opinione, cioè per confutare l’opinione ad essa opposta, è necessario mostrare che la prima non contrasta con gli endoxa e che quella opposta invece vi contrasta. In tal modo, se si lasciano in piedi, cioè se non si mettono in discussione, gli endoxa, si sarà mostrata a sufficienza la validità di un’opinione e la falsità di quella ad essa opposta. Lo scopo della dimostrazione, insomma, non è di salvare, o di dimostrare, gli endoxa, ma di dimostrare, cioè di salvare, o di confutare, una certa opinione (5).
Infine c’è un ultimo passo dell’Etica Nicomachea, relativo al procedimento diaporetico, che merita di essere segnalato. Sempre a proposito dell’incontinenza, Aristotele dichiara:
“tali sono dunque le aporie che si presentano: di queste alcune cose si devono distruggere, altre conservare, poiché la soluzione (lysis) dell’aporia è una scoperta (euresis)” (1146 b ó-8).
Qui è chiaro che ciascuna aporia è costituita da due opinioni tra loro opposte, di cui alla fine una viene eliminata, perché confutata, e l’altra conservata, perché dimostrata vera. La soluzione dell’aporia equivale dunque alla scoperta di quale sia, tra le due opinioni opposte, quella vera.
Ulteriori precisazioni e conferme circa l’impiego del procedimento diaporetico da parte della filosofia pratica si trovano nei passi dell’Etica Eudemea paralleli a quelli già considerati della Nicomachea. In questa opera minore non si trova tutto quello che c’è nella maggiore, per esempio non si trovano accenni all’intento tipologico, mentre vi è chiaramente espresso il carattere pratico della trattazione, che si propone non solo di esaminare in che consista la felicità, ma anche come la si possa acquistare. Per quanto riguarda il metodo da seguire, il cap. 3 del libro I fornisce indicazioni perfettamente parallele e quelle che abbiamo incontrato nel cap. 4 del I libro della Nicomachea:
“è superfluo indagare tutte le opinioni che alcuni hanno intorno ad essa [cioè alla felicità]. Molte cose infatti paiono anche ai bambini, agli ammalati ed a coloro che hanno una mentalità perversa ed intorno ad esse nessuno che sia dotato di intelligenza svilupperebbe le aporie (diaporeseien). Costoro infatti non hanno bisogno di discorsi, ma alcuni di un’età in cui maturare, altri di una correzione medica o politica, poiché la terapia delle punizioni corporali non è una correzione di poco conto. Allo stesso modo di queste, neppure si devono indagare le opinioni dei molti, poiché essi parlano con leggerezza di quasi tutto, e soprattutto di questo argomento; infatti è assurdo addurre una ragione a coloro che non hanno nessun bisogno di ragione, ma di passione” (eth. eud. I 3, 1214 b 28-1215 a 3)
Si noti, in questo passo, non solo l’affermazione che bisogna contenere il numero delle opinioni da sottoporre ad indagine, ma anche l’indicazione del modo in cui tale indagine deve essere svolta, l’ormai famoso sviluppo delle aporie, cioè la deduzione delle conseguenze derivanti da opinioni opposte.
Proprio quest’ultima indicazione viene ripresa nel seguito del passo:
“poiché vi sono aporie proprie di ciascuna trattazione, è chiaro che ve ne sono anche a proposito del genere di vita superiore e della vita migliore. Queste opinioni, dunque, è bene esaminare (exetazein), poiché le confutazioni (elenchoi) dei contestatori sono dimostrazioni (apodeixeis) dei discorsi ad essi opposti” (1215 a 3-7).
Tre osservazioni meritano di essere fatte a proposito di questo passo, che è di importanza fondamentale dal punto di vista metodologico: 1) anzitutto l’aporia concernente un certo argomento è costituita dalle opinioni opposte esistenti intorno ad esso; 2) in secondo luogo lo sviluppo dell’aporia, cioè la deduzione delle conseguenze delle opinioni opposte, coincide con l’esame (exetazein), ovvero con la messa alla prova, delle singole opinioni; 3) infine la confutazione di un’opinione, cioè la deduzione da essa di conseguenze contrastanti con qualche endoxon, o con qualche premessa concessa da colui che la sostiene, equivale alla dimostrazione dell’opinione ad essa opposta (sempre che, ovviamente, si tratti di un’opposizione tra opinioni reciprocamente contraddittorie, non semplicemente contrarie).
I primi due momenti coincidono con quelli illustrati nel libro III della Metafisica rispettivamente come “aporia” e “sviluppo dell’aporia” (diaporesai); il terzo, che coincide con l”‘euporia”, è qui presentato come una vera e propria dimostrazione di una tesi, ottenuta attraverso la confutazione della tesi opposta, esattamente come viene detto in De caelo, I 10, 279 b 4 76. Qui dunque la soluzione dell’aporia non è solo una “scoperta”, come si diceva nell’Etica Nicomachea, ma è una vera e propria dimostrazione, cioè una conclusione dotata di necessità, di valore scientifico. Anche nella filosofia pratica, dunque, come nella fisica e nella metafisica, il procedimento diaporetico può portare in alcuni casi, cioè in presenza di alternative tra opinioni reciprocamente contraddittorie, a delle dimostrazioni “scientifiche”, cioè al massimo grado di forza dimostrativa.
Ma anche gli accenni ai “fenomeni”, alla concordanza o meno tra le opinioni ed alla differenza tra il “che” ed il “perché”, già incontrati nell’Etica Nicomachea, trovano un preciso riscontro nell’Eudemea. C’è un intero capitolo di questa, il cap. 6 del libro I, che è dedicato al metodo della trattazione e dice:
“bisogna che ci impegniamo, intorno a tutte queste cose, a cercare l’adesione (pistin) attraverso i ragionamenti, usando i fenomeni come testimoni ed esempi. Il massimo, infatti, è che tutti gli uomini risultino concordare con le cose dette; altrimenti, che [concordino] tutti almeno in qualche modo, ossia che lo facciano essendovi stati trascinati; poiché ciascuno possiede qualcosa di appropriato rispetto alla verità, a partire da cui è necessario mostrare in qualche modo a proposito di esse. A coloro infatti che procedono da cose dette con verità, ma non con chiarezza, sarà possibile ottenere anche la chiarezza, mettendo sempre le cose più note al posto di quelle che sogliono essere dette in modo confuso” (1216 b 26-35).
Anche qui, come in eth. nic. VII 1, i “fenomeni” sono evidentemente i pareri, cioè le opinioni degli altri, ed anche qui la concordia è considerata condizione della verità. Anzi Aristotele aggiunge che ciascun uomo ha una specie di disposizione naturale alla verità (tesi da lui sostenuta anche altrove, per esempio in metaph. II 1, 993 a 30-b 8), per cui la concordia è non solo una condizione necessaria, ma anche un indizio quasi sufficiente della verità. Proprio questa disposizione di ciascuno alla verità permette di scoprire progressivamente “le cose più note”, cioè i principi, partendo da quelle abitualmente confuse, che sono le più vicine a noi (osservazione fatta anche in phys I 1, 184 a 21-22).
Il contenuto, del tutto simile all’inizio della Fisica ed all’analogo libro II della Metafisica, induce Aristotele a introdurre anche la distinzione tra il “che” ed il “perché”, conformemente a quanto già fatto nell’Etica Nicomachea. Egli prosegue infatti:
“nei discorsi concernenti ciascuna trattazione c’è differenza tra quelli svolti in modo scientifico e quelli svolti in modo non scientifico. Perciò anche nel trattare di cose politiche non si deve credere che sia superflua una ricerca fatta in modo tale, per cui non solo risulti chiaro il che, ma anche il perché: di questo tipo infatti è il modo scientifico di procedere in ciascuna trattazione. […] Ed è bene anche giudicare separatamente il discorso che indica la causa e quello che viene dimostrato, sia per quanto detto poco fa, cioè che non bisogna occuparsi di tutto sulla base dei ragionamenti, ma spesso piuttosto sulla base dei fenomeni (ora invece [coloro che discutono], qualora non siano in grado di risolverli, sono costretti a credere ai discorsi fatti [dai loro avversari]), sia perché ciò che si ritiene essere stato dimostrato dal ragionamento è vero, ma non lo è tuttavia in virtù di questa causa per la quale lo dice il ragionamento. È possibile infatti dimostrare il vero attraverso il falso, come risulta chiaro dagli Analitici” (1216 b 35 – 1217 a 17).
Qui Aristotele da un lato afferma la necessità, anche nella scienza politica, di cercare il “perché”, cioè le cause, i principi, perché si tratta pur sempre di una scienza, e la scienza deve cercare le cause; dall’altro lato egli ricorda l’importanza dei fenomeni, cioè delle opinioni esprimenti il “che”, sia perché l’accordo tra queste, in mancanza di una confutazione, è sufficiente a garantire la verità di una tesi, sia perché non sempre la causa, attraverso cui si dimostra una tesi vera, è vera essa stessa (cfr. an. pr. II 2, 53 b 7 sgg.; an. post. I 32, 88 a 20). È importante, insomma, non solo la dimostrazione, cioè l’indicazione del “perché”, ma anche la verità effettiva di ciò che si dimostra, cioè del “che”, la quale può essere accertabile indipendentemente dalla dimostrazione, cioè per mezzo del procedimento diaporetico.
Infine un ultimo passo che illustra il metodo diaporetico della filosofia pratica è presentato da Aristotele a proposito della definizione dell’amicizia:
“bisogna adottare un discorso [o un modo di dire, o una definizione, secondo le diverse lezioni del testo], il quale ci restituisca il più possibile le opinioni intorno a queste cose ed al tempo stesso risolva le aporie e le opposizioni Ciò accadrà, se appariranno ragionevoli le opinioni opposte [a queste ultime], poiché un discorso di questo genere sarà il più possibile concordante con i fenomeni. Succede invece che rimangano le opposizioni, se ciò che si è detto in un senso è vero ed in un altro no” (VII 2, 1235 b 1318).
Ancora una volta la situazione ideale a cui aspirare è presentata come quella in cui si può ottenere la concordia della maggior parte delle opinioni (condizione necessaria, ma da sola non sufficiente ad assicurare la verità) ed insieme si riesce a confutare le obiezioni ad esse (condizione che viene a rafforzare la precedente). Ancora una volta, inoltre, il termine “fenomeni” è usato per indicare ciò
che pare a qualcuno, ossia le opinioni. Infine Aristotele presenta come accettabile, in via subordinata, anche l’eventualità che si debba adottare una posizione intermedia, o mista, o comunque tale da rispettare anche opinioni tra loro opposte, purché queste ultime non vengano intese nello stesso senso – il che darebbe luogo ad un’inaccettabile contraddizione -, ma in sensi diversi, che le rendano compatibili tra di loro. Come si vede, egli cerca sempre di fare tutto il possibile per andare d’accordo con tutti, talmente grande è la sua fiducia nella discussione, cioè talmente “dialogico” – come si direbbe oggi – è il suo atteggiamento.
I1 carattere fondamentalmente dialettico della filosofia pratica di Aristotele è stato sottolineato da molto tempo: dei “liberali” inglesi come Alexander Grant e John Burnet l’avevano già fatto tra la fine del secolo XIX e l’inizio di questo, interpretando tuttavia questa dialetticità come mancanza di scientificità, il che – come abbiamo visto – non è vero. Più recentemente alcuni esponenti della “riabilitazione della filosofia pratica” avvenuta in Germania, considerati dei “neoaristotelici” di indirizzo conservatore, cioè Wilhelm Hennis e Günther Bien, hanno interpretato la dialetticità della filosofia pratica come espressione di un grado di scientificità inferiore a quello delle scienze teoretiche, il che ugualmente non è vero. Un filosofo di orientamento cattolico tradizionale come Helmut Kuhn ha attribuito invece alla dialettica, sia nella filosofia pratica che nelle altre scienze, una funzione soltanto propedeutica, relegandola sul piano del “verosimile” inteso nel senso soggettivo del termine (“ciò che sembra vero a qualcuno”) ed ammettendo che invece la filosofia pratica, a causa della contingenza del suo oggetto, sia una vera scienza del “probabile” nel senso oggettivo del termine (ossia ciò che si avvicina al vero, che ha un’alta probabilità di essere vero).
Una valutazione più positiva della dialettica è stata data da uno specialista di Hegel come Otto Pöggeler, il quale tuttavia, pur negando che essa resti sul piano della semplice verosimiglianza soggettiva, continua a considerarla soltanto introduttiva alla scienza propriamente detta. Invece un “kantiano” come Otfried Höffe ha mostrato che il procedimento dialettico non resta esteriore alla scienza propriamente detta, ma ne costituisce precisamente il momento euristico, cioè inventivo, tanto nel caso della filosofia pratica quanto nel caso della fisica e della metafisica, mentre il procedimento apodittico ne costituisce il momento espositivo e didattico. Come si vede, dunque, quasi tutte le principali correnti del pensiero contemporaneo hanno riconosciuto la presenza di una razionalità di tipo dialettico – nel senso classico del termine – nella filosofia pratica di Aristotele, pur valutandola in modi diversi (7).
A me sembra che l’interpretazione di Hoffe sia la più conforme ai testi di Aristotele, e che di conseguenza la filosofia pratica possa essere considerata come una vera e propria scienza, dello stesso tipo della fisica e della metafisica, pur restando diversa, quanto al metodo, dalla matematica e pur conservando il suo carattere propriamente pratico, cioè orientato verso l’azione, e quindi la sua capacità di guidare quest’ultima, dando delle direttive, delle indicazioni su come ci si deve comportare. Ciò che caratterizza la filosofia pratica, o scienza politica, in fondo, non è né il metodo dialettico come tale, e nemmeno l’intento tipologico, che abbiamo esaminato in precedenza, bensì precisamente l’unione dei due, la quale fa sì che il metodo dialettico nella filosofia pratica sia ancor più adeguato allo scopo di quanto lo sia nelle scienze teoretiche, proprio perché tale scopo non è costituito da una conoscenza esaustiva e dettagliata, ma da quel tanto di conoscenza che può servire per orientare la prassi.
3. La phronesis ed il sillogismo pratico
Oltre alla filosofia pratica, o scienza politica, Aristotele ha descritto un’altra forma di razionalità, ugualmente pratica, ma non filosofica, o scientifica (nel senso antico): si tratta della phronesis, termine traducibile in italiano con ” saggezza” o ” prudenza”, ma che ormai, per la notorietà che ha raggiunto nella cultura contemporanea nella sua forma originale, è forse bene conservare immutato. Proprio nel dibattito odierno sulle forme di razionalità non scientifica la phronesis è stata spesso indicata come la principale, e talvolta l’unica, forma di razionalità pratica ammessa da Aristotele, e quindi come il modello di filosofia non scientifica che alcuni autori oggi contrappongono alle scienze. Di questo avviso si è dichiarato per primo Hans Georg Gadamer, seguito dal suo discepolo Rüdiger Bubner (8). In realtà per Aristotele tra filosofia pratica e phronesis c’è una precisa differenza, anche se le due forme di razionalità presentano innegabilmente qualche affinità; anzi questa distinzione è proprio una conquista di Aristotele nei confronti dell’indistinzione tra esse ancora presente in Platone.
Il luogo classico in cui Aristotele descrive la phronesis è il VI libro dell’Etica Nicomachea (uno dei tre libri comuni anche all’Eudemea), dedicato alla famosa illustrazione delle “virtù dianoetiche” ed oggetto di innumerevoli commenti da parte dei filosofi moderni e contemporanei. Qui Aristotele ricorda anzitutto che la parte razionale dell’anima, o “ragione” (dianoia), comprende a sua volta due parti, l’una avente per oggetto le realtà “i cui principi non possono stare diversamente”, cioè sono necessari, l’altra avente per oggetto quelle i cui principi possono stare diversamente, cioè sono contingenti. La prima parte è detta “scientifica” (epistemonikon), mentre la seconda è detta ” calcolatrice ” (logistikon) . È evidente che nella prima rientrano tutte le scienze teoretiche, cioè sia le matematiche, i cui oggetti sono necessari, sia la fisica e la metafisica, i cui oggetti hanno almeno principi necessari; ma in essa rientrano anche le scienze pratiche, i cui oggetti, cioè i beni, hanno principi che, come abbiamo visto, sono almeno “per lo più” e dunque, dal punto di vista epistemologico, sono equiparabili a quelli che hanno principi necessari. Nella seconda rientrano invece tutte le attività che hanno per oggetto realtà dipendenti dalla “deliberazione” umana, perché – dice Aristotele – deliberare e calcolare sono la stessa cosa e nessuno delibera sulle cose che non possono stare diversamente (cap. 1).
Entrambe le parti dell’anima razionale, ovvero della ragione, prosegue Aristotele, hanno come ” opera” la verità: quella scientifica ha come opera la verità pura e semplice, cioè la semplice conoscenza di come stanno le cose, mentre quella calcolatrice ha come opera la “verità pratica”, cioè “la verità in accordo col desiderio retto”. A proposito di quest’ultima Aristotele spiega che l’azione (praxis) ha come principio la “scelta” (proairesis), la quale è il risultato dell’incontro tra il desiderio di raggiungere un certo fine ed il calcolo dei mezzi necessari a raggiungerlo, o “deliberazione”. Quando il desiderio è retto, cioè è rivolto ad un fine buono, ed il calcolo è vero, cioè indica i mezzi realmente necessari, si ha la “verità pratica”. Mentre la prima parte della ragione, quella scientifica, si può chiamare anche teoretica, la seconda, quella calcolatrice, si può chiamare anche pratica, ma entrambe – insiste Aristotele – hanno come opera la verità (cap. 2). Si noti l’originalità del concetto di “verità pratica”, del tutto estraneo sia alla scienza che all’etica moderne e contemporanee.
L’intento del libro è, come abbiamo detto, di illustrare le “virtù dianoetiche”, cioè le capacità più alte, le prestazioni più eccellenti, di entrambe le suddette parti della ragione. Le virtù della parte scientifica, enumerate da Aristotele attraverso una specie di induzione completa, sono tre, cioè la “scienza” (episteme), definita come abito dimostrativo, cioè capacità di dimostrare, l’”intelligenza” (nous), definita come abito dei principi, cioè capacità di conoscere i principi della scienza, e la “sapienza” (sophia), definita come unità di scienza ed intelligenza, cioè capacità sia di conoscere i principi che di dimostrare a partire da essi: quest’ultima, ovviamente, è la virtù più alta della ragione scientifica, o teoretica, ed ha per oggetto le realtà più alte, cioè le realtà divine (capp. 3, ó, 7). Non c’è dubbio che la ” sapienza” coincide con la ” filosofia prima” o metafisica, mentre nella ” scienza ” rientrano tutte le altre scienze, sia teoretiche (matematica e fisica) che pratiche (filosofia pratica o scienza politica), e nell”‘intelligenza” rientrano le conoscenze dei principi di tutte queste altre scienze. Perciò, alla luce della classificazione del libro VI, si può affermare, per quanto ciò possa sembrare paradossale, che la filosofia pratica, o scienza politica, nonostante il suo intento pratico, è una virtù della ragione teoretica, per il fatto che essa è pur sempre una scienza.
Ben diversa è la collocazione della phronesis, la quale per Aristotele è una virtù, anzi è la più alta virtù, della parte calcolatrice dell’anima razionale, cioè della ragione pratica. Essa, infatti, è da lui concepita come la capacità di deliberare bene, cioè di calcolare esattamente i mezzi necessari per raggiungere un fine buono. Ora, poiché nessuno delibera sulle cose che non possono stare diversamente, la phronesis apparterrà a quella parte della ragione che ha per oggetto le realtà che possono stare diversamente, cioè che non sono né “sempre”, né “per lo più”: per questo motivo essa non è certamente una scienza e dunque differisce profondamente dalla filosofia pratica, che invece è una scienza ed ha per oggetto realtà i cui principi sono almeno per lo più. C’è una notevole differenza, infatti, tra la contingenza che caratterizza l’oggetto della phronesis, costituito, come vedremo, dai mezzi, che sono sempre particolari e mutevoli, e la relativa variabilità che caratterizza l’oggetto della filosofia pratica, costituito, come abbiamo visto, dai beni, cioè dai fini, i quali sono universali e, se non proprio immutabili, almeno validi ” per lo più”. Ciò non toglie che anche la phronesis possieda una sua verità, la verità – appunto – pratica, perciò Aristotele la definisce come “abito vero, fornito di ragione e pratico, concernente ciò che è bene e male per l’uomo” (5, 1140 b 5-6).
Come modello di phronimos (possessore della phronesis), cioè di ” saggio”, o “prudente”, Aristotele indica Pericle (1140 b 8), il grande leader politico che aveva governato Atene, il quale non era certamente un filosofo di professione, mentre come filosofo pratico, col quale discutere da pari a pari, magari per dissentire, Aristotele indica Socrate (13, 1144 b 18, 28), il quale non era certamente un leader politico, né aveva mai governato la sua città: anche da ciò risulta la differenza da lui stabilita tra la phronesis e la filosofia pratica.
A maggior ragione la phronesis differisce dalla sapienza: la prima, infatti, si occupa dell’uomo, cioè delle realtà umane, mentre la seconda, come abbiamo visto, si occupa di realtà più alte dell’uomo, cioè le realtà divine. Se modello della phronesis, come abbiamo visto, è Pericle, i modelli di sapienza indicati da Aristotele sono Talete ed Anassagora, altrove considerati dei fisici, ma qui presentati come indagatori di realtà divine (i principi supremi) (cap. 7).
Anche la phronesis, tuttavia, è politica (come già suggerisce l’esempio di Pericle), per lo stesso motivo per cui lo è la filosofia pratica, cioè perché il vero bene dell’uomo, secondo Aristotele, non è il bene del singolo individuo, ma quello della polis: anzi, a seconda che si consideri il bene dell’individuo, quello della famiglia, di cui l’individuo è parte, o quello della città, di cui la famiglia è parte, si avrà una phronesis pura e semplice (così è inteso, infatti, comunemente il termine), una phronesis “economica” ed una phronesis “politica”: quest’ultima, secondo Aristotele, è la più ” architettonica”, cioè è quella che presiede a tutte (come la scienza politica era la più architettonica delle scienze pratiche), e si distingue a sua volta in legislativa, amministrativa e giudiziaria (cap. 8). In nessun caso, tuttavia, essa va confusa con la scienza politica.
Oltre alle suddette differenze, Aristotele indica anche delle precise affinità tra la phronesis e la filosofia pratica: come quest’ultima, secondo quanto abbiamo visto, esige, per essere appresa con profitto, un certo dominio delle passioni, anche la phronesis suppone, per poter sussistere, la temperanza, la quale viene chiamata – osserva Aristotele – sophrosyne, perché “salva” (in greco sozei) la phronesis. Infatti, se è vero che il piacere e il dolore non influiscono su ogni tipo di giudizio – e quindi non è necessario dominarli per poter pronunciare dei giudizi corretti, per esempio, in fatto di matematica -, è vero che il piacere può corrompere i giudizi che riguardano le azioni, perché può indurre a scegliere le azioni che portano ad esso (5, 1140 b 11-16).
Per questo motivo, essendo non solo abito razionale, come ad esempio la scienza o l’arte, ma anche virtù morale, la phronesis non ammette che vi sia una virtù di essa (cioè una sua perfezione, in quanto è già perfezione essa stessa); né tra coloro che la possiedono è preferibile colui che sbaglia volontariamente, come invece lo è tra coloro che possiedono la scienza o l’arte (dove il saper sbagliare può essere segno di bravura, mentre lo sbagliare inconsapevolmente è segno di ignoranza); né infine, una volta acquisita, essa può venire dimenticata, come può avvenire nel caso della scienza o dell’arte (1140 b 21-30). Tutto ciò mostra, come si vede, che nella phronesis il momento conoscitivo e quello pratico sono intimamente compenetrati.
Un’altra affinità tra la phronesis e la filosofia pratica sta nel fatto che entrambe richiedono una certa esperienza della vita, perciò è difficile che possano essere possedute dai giovani. Il passo relativo a questo concetto è denso di significato, perciò merita di essere riportato integralmente.
“La phronesis – dice Aristotele – non è solo conoscenza dell’universale, ma deve conoscere anche i casi individuali, poiché è pratica e l’azione concerne i casi individuali. Perciò anche alcuni che non sanno sono più pratici di altri che sanno, ed anche in altri campi lo sono gli esperti (empeiroi). Se infatti uno sapesse che le carni leggere sono digeribili e sane, ma ignorasse quali carni sono leggere, non produrrebbe la salute, mentre chi sa che le carni di uccelli sono sane, piuttosto la produrrà. Ora la phronesis è pratica, sicché deve possedere entrambe le conoscenze, o piuttosto quest’ultima. Ma anche in questo campo vi sarà una [capacità] architettonica” (7, 1141 b 14-23).
Il carattere pratico, cioè concernente l’azione, proprio della phronesis, esige dunque che essa possieda la conoscenza dei casi individuali, perché l’azione si svolge sempre in situazioni individuali: perciò la phronesis richiede una certa esperienza, la quale è appunto conoscenza dei particolari. La phronesis, tuttavia, include in qualche misura anche la conoscenza dell’universale, nel senso che deve saper applicare al caso individuale una caratteristica generale, come mostra l’esempio fatto da Aristotele. Non basta, per produrre la salute (azione), sapere che le carni leggere sono sane (caratteristica universale), se non si sa che le carni di uccello sono leggere (caso individuale, o particolare) e quindi che le carni di uccello sono sane (applicazione dell’universale al particolare).
D’altra parte, anche se la phronesis include la conoscenza dell’universale, la sua peculiarità non è questa, bensì la conoscenza dell’individuale. La prima, cioè la conoscenza dell’universale, è invece la peculiarità di un’altra capacità, detta perciò architettonica, cioè atta a fornire le direttive più generali, la quale non può che essere la filosofia pratica, ovvero la scienza politica, di cui abbiamo parlato in precedenza. Qui dunque Aristotele chiarisce bene il rapporto tra filosofia pratica e phronesis: la prima conosce l’universale, dunque dà le direttive più generali, mentre la seconda conosce il particolare, dunque applica le direttive generali al caso particolare, o addirittura individuale.
Ma il possesso dell’esperienza accomuna la phronesis non solo alla filosofia pratica, bensì anche alla fisica ed alla “sapienza”, cioè alla metafisica: già avevamo rilevato, infatti, che questo carattere è comune alla filosofia pratica ed alla fisica. Dice infatti Aristotele:
“è segno di quanto detto anche il fatto che i giovani diventano competenti di geometria e di matematica, mentre si ammette che un giovane non possa diventare saggio (phronimos). La ragione è che la phronesis è anche conoscenza dei casi individuali, i quali diventano noti a partire dall’esperienza, mentre il giovane non è esperto, poiché per fare esperienza ci vuole molto tempo. Inoltre uno potrebbe indagare anche questo, cioè perché mai il fanciullo può diventare matematico, ma non sapiente o fisico. Non è forse perché gli oggetti della metafisica si ottengono per astrazione, mentre i principi della fisica e della sapienza si ricavano dall’esperienza? E su questi ultimi i giovani non hanno convinzioni, ma solo parlano, mentre su quelli hanno chiaro il che cos’è” (8, 1142 a 1 1-20) .
Come si vede, la phronesis, al pari della filosofia pratica, si differenzia soprattutto dalla matematica, molto meno, invece, dalla fisica e dalla metafisica. In ogni caso, prosegue Aristotele, essa non è scienza, perché riguarda l’ultimo termine della deliberazione, ossia ciò che può essere pratico, che è sempre qualcosa di particolare. Per la stessa ragione essa non è neppure intelligenza, perché l’intelligenza ha per oggetto le definizioni universali, non i casi individuali. Semmai essa somiglia alla sensazione, non però alla sensazione dei sensibili propri, cioè alla vista, all’udito, ecc., ma a quella sensazione con cui in matematica si percepisce che un singolo oggetto è un triangolo (1142 a 23-39). Si tratta dunque, come abbiamo già detto, della capacità di applicare la regola generale al caso particolare. Per questo motivo alcuni filosofi odierni hanno paragonato la phronesis di cui parla Aristotele alla “facoltà del giudizio estetico e teleologico (Urteilskraft) di cui parla Kant: anche quest’ultima, infatti, è la capacità di ricondurre un particolare già dato ad un universale soltanto cercato (9).
Ed anche a questo proposito Aristotele ricorre ad un esempio, il quale mostra come la phronesis abbracci tanto l’universale quanto il particolare.
“Inoltre l’errore – egli afferma infatti – nella deliberazione [cioè nell’operazione di cui la phronesis è la virtù] può riguardare o l’universale o l’individuale: ci si può sbagliare infatti o nel pensare che tutte le acque pesanti sono nocive, o nel pensare che questa determinata acqua è pesante” (1142 a 20-23).
Sia in questo esempio che in quello precedente, concernente le carni di uccello, Aristotele presenta il ragionamento compiuto dalla phronesis come una specie di sillogismo, quello che poi è stato chiamato il “sillogismo pratico”. In esso si può scorgere, infatti, una premessa universale, o maggiore (“tutte le carni leggere sono sane”, o “tutte le acque pesanti sono nocive”), una premessa particolare, o minore (“le carni di uccello sono leggere”, o “questa determinata acqua è pesante”), ed una conclusione, costituita dalla “scelta”, o dall’azione stessa (mangiare carni di uccello, o evitare questa determinata acqua).
Che si tratti di un sillogismo, del resto, risulta dal fatto che la forma errata di esso è presentata da Aristotele come un “sillogismo falso” (9, 1142 b 22-23) e dal fatto che lo stesso Aristotele parla di “sillogismi delle cose praticabili” (12, 1144 a 31-32). Anche la phronesis, dunque, sillogizza, sia pure a suo modo, nel senso che argomenta, fa dei ragionamenti con più momenti concatenati tra di loro, ed è perciò anch’essa una forma di razionalità, ben diversa, tuttavia, da quella della scienza, sia teoretica che pratica. Il suo sillogizzare è stato detto “pratico” in quanto approda ad un’azione ed è stato riconosciuto come una forma del tutto peculiare di razionalità soprattutto nella scuola dell’ultimo Wittgenstein (10).
L’analisi del sillogismo pratico consente di chiarire ulteriormente il rapporto tra la phronesis e la filosofia pratica. Aristotele presenta infatti il sillogismo pratico come esprimente nella premessa maggiore il fine a cui si tende e nella minore il mezzo necessario a realizzarlo. A proposito di esso egli afferma infatti:
“i sillogismi delle cose praticabili sono forniti del principio, poiché tale è il fine e l’ottimo, qualunque esso sia (ammettiamo infatti, tanto per discutere, che esso sia uno qualsiasi). Ma questo non è manifesto se non a chi è buono, perché la malvagità fa deviare e induce all’errore a proposito dei principi pratici. Sicché è chiaramente impossibile che uno sia saggio (phronimon) senza essere buono” (12, 1144 a 31-b 1).
Qui risulta non solo che la premessa maggiore indica il fine, cioè il bene supremo, e per questo costituisce il “principio” pratico, ma anche che essa richiede la bontà, cioè la virtù morale, e che quest’ultima è presupposta dalla phronesis. Sembra, dunque, che la phronesis, dando per presupposta l’indicazione del fine, fornita dalla virtù, abbia come sua prestazione peculiare l’indicazione del mezzo, cioè la premessa minore. Ciò è confermato anche da altri passi, dove Aristotele dice: “la virtù rende retto lo scopo, la phronesis ciò che è in relazione a questo [ossia i mezzi]” (1144 a 7-9); oppure: “non si avrà una scelta corretta senza la phronesis né senza la virtù, poiché questa indica il fine e quella fa compiere le azioni che sono in relazione al fine” (13, 114a 3-6).
A questo proposito si è avuta una celebre discussione tra chi ha sostenuto che la phronesis, in Aristotele, comprende la conoscenza del fine, e chi invece ha sostenuto che essa è essenzialmente conoscenza dei mezzi. Tale discussione è stata complicata dall’ambiguità di un passo, in cui Aristotele dice:
“se è proprio dei saggi il deliberare bene, la buona deliberazione sarà la rettitudine conforme a ciò che giova in relazione al fine, di cui la phronesis è la assunzione vera” (9, 1142 b 31-33).
Qui l’espressione “di cui” può essere riferita tanto al “fine”, quanto a “ciò che giova in relazione al fine”, ossia al mezzo, perciò non è chiaro se la phronesis sia assunzione vera del fine o del mezzo (11). A mio modo di vedere, tuttavia, la phronesis è essenzialmente conoscenza dei mezzi, perché Aristotele la definisce precisamente come “capacità di deliberare bene intorno a ciò che è buono e giovevole per se stessi, non da un punto di vista particolare, per esempio su quali cose lo sono in relazione alla salute, o alla forza, ma su quali lo sono in vista del vivere bene in senso globale” (5, 1140 a 26-28). Ora, il bene in senso globale non può essere oggetto di deliberazione, perché non è una realtà particolare e contingente, ma è valido sempre o almeno per lo più; solo i mezzi possono essere oggetto di deliberazione, perché sono particolari e contingenti. Su questi, dunque, verte propriamente la phronesis.
Del resto lo stesso Aristotele subito dopo aggiunge: “ne è segno il fatto che chiamiamo saggi anche quelli che si occupano di qualcosa di particolare, quando calcolino bene in vista di un fine valido” (1140 a 28-30). Altrove Aristotele afferma esplicitamente: “non deliberiamo sui fini, ma sulle cose che sono in relazione ai fini” (III 3, 1112 b 1112), cioè sui mezzi, e paragona il calcolo in cui consiste la deliberazione addirittura all’analisi geometrica (1112 b 20-24).
D’altra parte, è pur vero che la phronesis include, come abbiamo visto, anche la conoscenza dell’universale, e quindi del fine, per poter ricondurre ad esso il caso particolare, cioè il mezzo: il rapporto tra queste due conoscenze è di essere entrambe premesse, rispettivamente maggiore e minore, del sillogismo pratico. La conoscenza del fine che la phronesis include, tuttavia, non è una conoscenza scientifica, la quale può essere data solo dalla filosofia pratica ed anzi costituisce il compito specifico di questa, bensì è l’orientamento ad esso dato dalla virtù, cioè da un buon carattere, o da una buona educazione. Infatti, per avere la phronesis, cioè per essere saggi, non c’è bisogno di essere filosofi, nemmeno filosofi pratici, mentre è necessario, come abbiamo visto, essere temperanti, cioè buoni di carattere. Bisogna, infatti, che la capacità di deliberare rettamente circa i mezzi sia orientata ad un fine buono, altrimenti non è phronesis, ma semplice abilità, o astuzia (così del resto, sia pure erroneamente, è stata intesa la “prudenza” da Kant, il quale perciò le ha negato valore morale) .
Questa dottrina potrebbe dare l’impressione di un circolo vizioso: da un lato, infatti, la phronesis è necessaria per deliberare bene, quindi per agire bene, cioè per essere virtuosi, e dall’altro essa presuppone, per l’orientamento al fine buono, il possesso della virtù. Aristotele evita il circolo distinguendo due specie di virtù: una virtù “naturale”, cioè innata, di cui non si ha merito, perché proviene da una buona nascita o da una buona educazione, ed una ” virtù propriamente detta “, di cui si ha merito, perché la si acquisisce attraverso l’abitudine ad agire bene. La prima è presupposta dalla phronesis, mentre la seconda è prodotta da essa (12, 1144 b 14-17).
Infine Aristotele chiarisce che anche la phronesis è “prescrittiva (epitaktike)” (10, 1143 a 8), come lo è la filosofia pratica, anzi a maggior ragione della filosofia pratica, perché appunto, è ancor più “pratica” di quella, in quanto direttamente rivolta all’azione. Anche in questo caso, dunque, ci troviamo di fronte ad una forma di razionalità che può essere “vera” ed insieme “prescrittiva”, cioè pratica, cosa del tutto anomala dal punto di vista dell’etica moderna di orientamento analitico (l2). E’ interessante vedere di che cosa la phronesis sia prescrittiva, perché in tal modo si chiarisce definitivamente il suo rapporto con la sapienza (sophia). A questo proposito, proprio a conclusione del VI libro dell’Etica Nicomachea, Aristotele afferma:
“[la phronesis] non è signora della sophia né della parte migliore [dell’anima, cioè della ragione teoretica], come neppure la medicina lo è della salute, poiché non si serve di essa, ma guarda a come generarla; essa [la phronesis] comanda dunque in vista di quella [cioè della sophia], ma non comanda a quella. Inoltre è lo stesso che se qualcuno dicesse che la politica comanda agli dèi, per il fatto che dà disposizioni intorno a tutto ciò che sta nella città” (cap. 13, 1145 a 611).
Il fine ultimo della phronesis, dunque, è costituito dalla sapienza, come il fine ultimo della medicina, è costituito dalla salute, e chi comanda non è il signore supremo, ma è qualcuno che serve al fine.
Lo stesso concetto si trova al termine dell’Etica Eudemea, dove Aristotele dice:
“allo stesso modo le cose stanno a proposito della facoltà teoretica. Dio infatti non è signore al modo di chi comanda, ma è colui in vista del quale la phronesis comanda […], poiché egli non ha bisogno di nulla. Quella scelta ed acquisizione, pertanto, di beni naturali che produrrà nella misura massima possibile la contemplazione di Dio – sia essa di beni del corpo, o di ricchezze, o di amici, o di altri beni – questa sarà la migliore e questo criterio sarà il più bello. Se invece una scelta, o per difetto o per eccesso, impedisce di servire e di contemplare Dio, questa sarà cattiva” (VIII 3, 1249 b 13-21).
La conclusione della filosofia pratica si ricongiunge, così, alla conclusione “teologica” – nel senso aristotelico del termine – della filosofia teoretica, perché la “contemplazione di Dio” a cui si allude in questo passo non è altro che la “sapienza”, cioè la scienza delle cause prime, la metafisica. Le diverse forme di razionalità, pur restando chiaramente distinte, vengono così organicamente connesse (13).
Note
(*) Pubbicato in Studi sull’etica di Aristotele, a cura di A. Alberti, Bibliopolis
1) Questo scritto contiene la sintesi di una serie di lezioni tenute nel maggio 1988, presso l’Ecole Normale Supérieure di Parigi e l’Università di Paris IV (Sorbonne), nell’ambito del Programma Erasmus.
2) Mi riferisco, naturalmente, al dibattito verificatosi in Germania negli anni Sessanta e Settanta di questo secolo, per il quale si veda la raccolta curata da M. RIEDEL, Rehabilitierung der praktischen Philosophie, 2 voll., Freiburg i.B. 1972-1974.
3) L’espressione “metodo tipologico”, a proposito della filosofia pratica di Aristotele, è stata usata nell’ambito del dibattito contemporaneo in Germania da O. HOFFE, Praktische Philosophie. Das Modell des Aristoteles, München und Salzburg 1971, pp. 187-92.
4) Ciò è stato dimostrato, come è noto, da G.E.L. Owen, Tithenai ta phainomena, in Aristote et les problèmes de méthode, Louvain 1961, pp. 83-103.
5) Pertanto il metodo dialettico non può essere invocato per fare di Aristotele un filosofo del senso comune, come ha mostrato bene J. BARNES, Aristotle and the methods of ethicss, “Revue Internationale de Philosophie”, XXXIV (1980) pp. 490-551, anche se non sempre ha distinto adeguatamente, a mio avviso, gli endoxa, che fungono sempre da premesse, dalle opinioni, sia pure autorevoli, che sono messe in questione.
6) Nel passo dell’Etica Eudemea, anzi, Aristotele è ancora più chiaro che in quello del De caelo, perché mentre quest’ultimo può essere letto anche nel senso inverso (cioè: “tra due tesi opposte, le dimostrazioni dell’una sono aporie dell’altra”), il primo dice inequivocabilmente che le confutazioni si convertono in dimostrazioni. Il passo dell’Etica Eudemea pertanto, a mio avviso, può servire come indicazione del senso da dare a quello del De caelo.
7 Cfr. A. GRANT, The Ethics of Aristotle, London 1885, vol. 1, p. 425, e vol. II, pp. 144-5, 391-6; J. BURNET, The Ethics of Aristotle, London 1900, pp. XXXI-XLVI; W. HENNIS, Politik und praktische Philosophie, 1a ed. Neuwied, 2a ed. Stuttgart 1977; G. BIEN, Die Grundlegung der politischen Philosophie bei Aristoteles, Freiburg-Munchen 1973; H. KUHN, Aristoteles und die Methode der politischen Wissenschaft, “Zeitschrift fur Politik”, XII (1965) pp. 101-20 (ristampato in RIEDEL, Rehabilitierung cit., vol. II, pp. 261-90); O. POGGELER, Dialektik und Topik, in R. BUBNER- K. CRAMER – R. WIEHL (edd.), Hermeneutik und Dialektik, Tubingen 1970, vol. Il, pp. 273-310; O. HÖFFE, Praktische Philosophie, cit., pp. 28-9, e Ethik und Politik. Grundmodelle und Probleme der praktischen Philosophie, Frankfurt 1979, p. 64. Naturalmente non mancano anche i negatori della dialetticità della filosofia pratica aristotelica, tra cui vanno annoverati J.A. Stewart, F. Susemihl, H. H. Joachim, O. Gigon e E. F. R. Hardie (si vedano le rispettive citazioni in HÖFFE, Praktische Philosophie, cit., pp. 11-31).
8) Cfr. H.G. GADAMER, Verità e metodo (1a ed. orig. 1960), a cura di G. VATTIMO, Milano 1972, pp. 363-75, e R. BUBNER, Azione, linguaggio e ragione (1a ed. orig. 1976), trad. it. Bologna 1985, pp. 240-2. Successivamente Gadamer ha attenuato la sua posizione ammettendo una distinzione tra filosofia pratica e phronesis: cfr. H. G. GADAMER, L’ermeneutica come filosofia pratica (1a ed. orig. 1972, in RIEDEL, Rehabilitierung, cit.), in ID., La ragione nell’età della scienza, a cura di G. VATTIMO, Genova 1982, pp. 69-90.
9) Questo accostamento è stato fatto da H. ARENDT, La vita della mente, trad. it., Bologna 1988 e da E. VOLLRATH, Die Rekonstruktion der politischen Urteilskraft, Stuttgart 1977.
10) Mi riferisco ai volumi di G.E.M. ANSCOMBE, Intention, Oxford 1957, e G. H. VON WRIGHT, Spiegazione e comprensione, trad. it. a cura di G. Di Bernardo, Bologna 1977.
11) Le opposte interpretazioni sono state sostenute rispettivamente da R.-A. GAUTHIER nel commento ad Aristotele, Ethique à Nicomaque, Louvain-Paris 1958-1959, e La morale d’Aristote, Paris 1958, pp. 82-96, e da P. AUBENQUE, La prudence aristotélicienne porte-t-elle sur la fin ou sur les moyens?, “Revue des études grecques”, LXXVII (1965) pp. 40-51.
12) Mi riferisco, ovviamente, ai sostenitori della cosiddetta “legge di Hume”, da G.E. MOORE, Principia ethica, trad. it. di G. Vattimo, Milano 1964, a R. HARE, Il linguaggio della morale, trad. it., Roma 1961, i quali tuttavia a differenza dei già citati Anscombe e von Wright, non hanno tenuto conto della posizione aristotelica.
13) Un’ottima trattazione di molti temi toccati in questo scritto è stata, nel frattempo, pubblicata da C. NATALI, La saggezza di Aristotele, Napoli 1989.
SENOCRATE
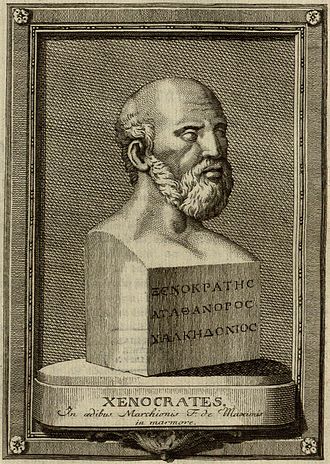 A cura di Daniele Lo Giudice
A cura di Daniele Lo Giudice
LA VITA
Senocrate succedette a Speusippo nella conduzione dell’Accademia, si dice a seguito di un’elezione. Ma fu votato da una maggioranza risicata, dopo un probabile scontro politico-ideologico di cui possiamo immaginare i contorni, ma del quale non abbiamo versioni realmente attendibili. C’entrava anche la politica, ovviamente, e l’oggetto del contendere era l’atteggiamento degli ateniesi nei confronti dell’espansione macedone.
Come Speusippo era stato compagno di Aristotele, e lo aveva seguito anche nella permanenza ad Asso. Con lo stagirita, quindi, condivise molte vicessitudini, studi, ricerche ed infinite discussioni. I due si separarono quando Aristotele venne chiamato alla corte di Filippo per educare l’allora tredicenne Alessandro Magno.
Tornato ad Atene, Senocrate diresse l’istituzione per 25 anni, dal 339 al 314 a.C.. Fu stimato dagli ateniesi, a differenza di Aristotele filomacedone, per avere resistito alla tentazione di accettare un cospicuo finanziamento da parte di Alessandro Magno. La fonte della notizia è in Cicerone (Tusc. 5. 32).
«Senocrate, dopo che i legati gli avevano portato, da parte di Alessandro, cinquanta talenti, che costituivano una cospicua somma di denaro per quei tempi, soprattutto ad Atene, condusse i legati a cena nell’Accademia. » Ed accettò solo una piccola parte della donazione, più per probità che per orgoglio personale o nazionale. Non riteneva che l’Accademia necessitasse di tanto denaro e non credeva che i regali fossero realmente a fondo perduto. Senocrate, insomma, sospettava che dietro alla generosità di Alessandro si nascondesse qualche disegno politico di strumentalizzazione dell’Accademia.
Basta questo per accreditare l’immagine di uno Senocrate onestissimo e tutto d’un pezzo? Forse no, ma la saggezza del comportamento è fuori questione. Non rifiutando del tutto, non si fece nemici astiosi. Non accettando del tutto, evitò di avere grossi debiti di riconoscenza, salvando quindi l’autonomia dell’istituzione.
IL PENSIERO
Senocrate aveva una teoria della conoscenza che in qualche modo rispecchiava quella platonica, distinguendo tra vero sapere, opinione e sensazione. Il primo aveva per oggetto l’intelligibilità della sostanza nella sua vera essenza. L’opinione era mescolanza di sapere e sensibilità inferiori, mentre la sensazione aveva tanto di verità quanto di falsità. Pertanto sia l’opinione che la sensazione non andavano respinte, ma attentamente vagliate.
Riteneva che la filosofia si potesse organizzare attorno a tre fondamentali campi di ricerca: dialettica, fisica ed etica.
Un’illuminante testimonianza di Cicerone restituisce profondità alla capacità speculativa di Senocrate, spesso trattato dagli storici della filosofia come un’onestuomo privo di grandi doti intellettuali:
«Quin etiam Xenocraten ferunt, nobilem in primis philosophum, cum quaereretur ex eo quid adsequerentur eius discipuli, respondisse ut id sua sponte facerent quod cogerentur facere legibus.» (Cicerone, De republica 1. 2)
Tradotto in maniera approssimativa: “asseriva Senocrate, filosofo assai nobile, che i suoi allievi imparavano a fare spontaneamente tutto ciò che gli altri facevano perchè costretti dalle leggi”. In altre parole, aveva ben chiara la distinzione tra quello che si fa solo per timore di una punizione e quello che si fa per amore della verità e della giustizia.
L’Abbagnano, senza purtroppo citare la fonte, riporta in chiusura del paragrafo un detto riferito a Senocrate che sembra anticipare lo stesso insegnamento cristiano: « il semplice desiderio equivale già al compimento del’azione cattiva.» Il che, tradotto in un linguaggio più comprensibile a noi, significa: si possono provare desideri momentanei, ma guai a struggersi in essi, e non realizzarli solo per timore o per incapacità. Bisogna condannarli severamente se essi portano a danneggiare qualcuno.
Bisogna trovare la forza per realizzarli, se essi producono buone cose.
Nel campo etico, quindi, Senocrate rimase ben fedele a Platone e a Socrate: il possesso della virtù e dei mezzi per conseguirla è l’unica via per essere felici.
Sul piano della ricerca fisica Senocrate accentuò il rapporto tra il platonismo, il pitagorismo ed altre dottrine non propriamente filosofiche, a mezza via tra le teorie mediche e pretesi insegnamenti religiosi.
Convinto come Speusippo della verità dei numeri come principi delle cose, asserì che il principio dell’unità è la divinità primordiale maschile, mentre quello della dualità risponde alla divinità primordiale femminile. Riprendendo alcuni concetti mitologici, non tutti di schietta origine greca, riconobbe l’esistenza dei demoni quali intermediari tra l’umano ed il divino.
Non sappiamo fino a che punto il nome della dea Ecate rispondesse al principio primordiale della dualità, o non fosse da considerarsi un demone, tuttavia il suo nome ricorreva in associazione alla Luna ed alla funzione di mediazione che l’astro notturno avrebbe tra il mondo sensibile ed il mondo intellegibile.
Questa teoria trovava certamente ripondenza negli antichi insegnamenti ippocratici sulla corrispondenza tra la Luna ed il diaframma, una linea fisica di separazione nella parte mediana del corpo tra il superiore e l’inferiore.
Sempre seguendo il principio delle idee-numeri, Senocrate definì l’anima come “un numero che si muove da sé”. I numeri erano dunque l’essenza del mondo. Ma essi andavano distinti in numeri “ideali” e numeri reali, quelli con cui si fanno le operazioni. I numeri ideali, elementi primordiali di ogni cosa esistente erano solo dieci. E tra questi l’uno ed il due rivestivano un’importanza capitale in quanto espressione dei principi dell’indivisibilità e della divisibilità.
Dall’unione dell’uno con il due scaturiva il numero propriamente dettoe quindi tutta la sequenza dei numeri ideali.
Trasponendo questa dottrina alla sfera della conoscenza, Senocrate asseriva una sostanziale coincidenza tra l’unità, da intendersi come un punto geometrico, ed il logos. La conoscenza vera e propria coincideva con la linea, mentre l’opinione era derivata dalla somma di punto e linea nella figura della triade, dove gli estremi sono i punti che segnano il limite. Analagomente, la percezione sensibile era coincidente con la tetrade.
SPEUSIPPO
 A cura di Roberta Musolesi
A cura di Roberta Musolesi
La vita e le opere
Le notizie che si hanno della vita di Speusippo derivano da molteplici fonti.
Una delle testimonianze più ricche e precise è quella di Filodemo, con la sua Vita Speusippi Herculanensis; quest’opera, ripresa anche da Diogene Laerzio, è costruita sui dati di Filocoro, attidografo del III secolo, e integrata con le memorie di Diodoro.
Nella testimonianza di Filodemo si parla di Speusippo che, in qualità di erede di Platone, ricevette la scuola quando era già malato; si precisa che “egli ricevette la scuola per successione”, aspetto questo che sembra avvalorare l’ipotesi di un passaggio delle consegne senza alcun procedimento elettivo.
Nella testimonianza poi si fa riferimento al fatto che Speusippo avrebbe edificato le immagini delle Grazie quando già era a capo dell’istituzione e su queste immagini vi sarebbe stata impressa la seguente dicitura: “Queste immagini delle dee Cariti Speusippo dedicò alle dee Muse, offrendole in contraccambio delle loro rivelazioni”.
Questa informazione consente di aprire una piccola parentesi circa la natura e le caratteristiche dell’Accademia platonica. L’Accademia, fondata da Platone presumibilmente dopo il suo primo ritorno dalla Sicilia, intorno al 380, è, fra tutte le scuole antiche, l’istituzione su cui si è più discusso e dibattuto: in quanto prima e vera scuola dell’Ellade, è stata un modello per altre scuole che si sono susseguite, in primo luogo del Liceo, sua diretta emanazione, poi di altre scuole ellenistiche. Molte fonti hanno parlato dell’Accademia nei termini di associazione di culto o tiaso delle Muse, ma in tempi recenti questa valutazione è stata messa in discussione. Secondo alcuni critici infatti è probabile che si sia equivocato circa le condizioni giuridiche del periodo: la situazione dal punto di vista normativo ad Atene era abbastanza fluida e tale da consentire ad una associazione filosofica di sussistere ed operare senza dover necessariamente assumere il carattere di una corporazione religiosa; relativamente alla presenza in un tempio dedicato alle Muse, il cui culto è collegato alla musica e all’istruzione primaria di cui la musica stessa faceva parte, questa si ricollega alla precedente funzione di ginnasio che la scuola aveva assunto. Rispetto poi alle Grazie, o Cariti, il culto di queste era già stato rilevato al tempo di Socrate: una testimonianza raccolta da Diogene Laerzio, Pausania e Plinio attribuisce appunto a Socrate, nella sua attività giovanile di scultore accanto al padre Sofronisco, l’immagine delle Cariti presente sull’Acropoli in Atene. Relativamente alla possibilità che l’istituzione avesse assunto principalmente la connotazione dell’associazione di culto, questa prospettiva potrebbe essersi realizzata non tanto con Speusippo, quanto piuttosto con l’avvento e la nomina di Senocrate, il quale, in quanto straniero, difficilmente avrebbe potuto porsi a capo di una proprietà comprendente anche una porzione di territorio pubblico e potrebbe essergli stato possibile guidarla solo nella forma dell’associazione di culto. E’ quindi verosimile che l’Accademia abbia assunto connotazione di associazione di culto solo a partire dall’elezione di Senocrate e che sia stata trasmessa, conservando inalterate le sue caratteristiche, a Speusippo in forma naturale per la sua stretta relazione di parentela con Platone, anche se la questione presenta comunque delle difficoltà, in quanto lo stesso Speusippo era discendente di Platone in linea femminile, poiché figlio di una sorella, mentre il testamento avrebbe avuto come beneficiario un altro nipote, Adimanto il giovane, figlio di un fratello.
Filodemo, nel precisare che Speusippo, nel momento in cui prese la guida dell’Accademia, che guidò per otto anni, aveva già le gambe paralizzate, fa riferimento ad un procedimento elettivo che sarebbe avvenuto all’interno dell’Accademia stessa e dal quale sarebbe risultato che la scelta degli allievi più giovani sarebbe caduta su Senocrate, anche perché Aristotele era già partito per la Macedonia per ricoprire l’incarico di precettore di Alessandro e altri due possibili candidati, Menedemo di Pirra ed Eraclide del Ponto, sarebbero stati superati per pochi voti; si fa riferimento inoltre al fatto che Menedemo avrebbe colto l’occasione per abbandonare la scuola e il suo nome si ritroverà più tardi fra gli allievi di Aristotele. Filodemo, rispetto alla presunta elezione di Senocrate, prosegue riferendo che gli Accademici avrebbero scelto quest’ultimo anche perché affascinati dalla sua saggezza; Speusippo invece sarebbe stato piuttosto incline all’ira ed incapace di dominarsi, oltre al fatto di essere debole nei confronti dei piaceri, cosa che sarebbe stata la causa della paralisi alle gambe. Nella testimonianza di Filodemo compare infine il nome di Diodoro, un discepolo di Speusippo di cui non si conosce nulla, ma che avrebbe scritto di lui, della sua natura acre e tagliente, della sua grande memoria e del fatto che si sarebbe occupato di ogni questione in modo esauriente.
La seconda testimonianza che permette di raccogliere informazioni circa la vita, l’opera e la personalità di Speusippo è quella riportata nelle Vitae philosophorum di Diogene Laerzio. Anche in questo caso si fa riferimento alla successione alla guida dell’Accademia in qualità di erede diretto, in quanto figlio di un non ben noto Eurimedonte, ateniese del demo di Mirrinunte, e di Potone, sorella di Platone. La narrazione di Diogene Laerzio fornisce indicazioni precise circa il periodo di scolarcato di Speusippo, che avrebbe assunto la guida dell’Accademia a cominciare dall’Olimpiade 108, che va dal 348 al 344 a.C., ed avrebbe quindi iniziato a dirigere la scuola intorno al 348-347, data della morte di Platone. Viene confermata anche da Diogene Laerzio la notizia riportata nella testimonianza di Filodemo, relativa alla edificazione delle immagini delle Grazie, con la precisazione che il tempio delle Muse sarebbe stato costruito nell’Accademia per opera di Platone e Speusippo vi avrebbe aggiunto le immagini delle Grazie, tesi questa che sarebbe avvalorata dalla presenza del già citato epigramma aggiunto alle immagini stesse. Diogene Laerzio prosegue nella sua narrazione sottolineando come Speusippo si sarebbe tenuto fedele, forse anche in un modo un po’ dogmatico, al pensiero di Platone, ma non ne avrebbe in nessun modo imitato lo stile di vita, in quanto manifestava una forte propensione all’ira e una notevole debolezza nei confronti del piacere. Sarebbe stato proprio Platone, così come è riportato da Plutarco e confermato anche nel De ira di Seneca, senza assumere atteggiamenti improntati alla severità o alla durezza, ma, al contrario, mostrando tranquillità e benevolenza, a distogliere Speusippo dalla sfrenatezza che gli era propria e di ispirargli il desiderio di imitarlo e di dedicarsi alla filosofia.
Nel testo di Diogene Laerzio si fa inoltre riferimento a due discepole, Lastinea di Mantinea ed Assiotea di Fliunte, che sarebbero accolte nell’Accademia e che vengono ricordate, anche da Filodemo, come le ultime due allieve di Platone; nella testimonianza si fa riferimento al fatto che Speusippo, diversamente da Platone che tendeva ad esentare dai tributi coloro che entravano nella sua scuola, avrebbe preteso invece pesanti tributi dai suoi allievi e una delle due allieve, Lastenia, viene presentata come sua amante.
Diogene Laerzio prosegue poi sottolineando le capacità intellettuali e i meriti teoretici di Speusippo, che sarebbe stato in grado di intuire l’interdisciplinarietà fra le varie scienze e che tentò di porre in rapporto le une con le altre. Viene riferito anche, riportando la testimonianza di un certo Ceneo, che Speusippo avrebbe rivelato i “segreti” di Senocrate; dietro questo Ceneo, secondo alcuni interpreti, in particolare secondo F. Jacoby, si celerebbe l’epicureo Idomeneo di Lampsaco, autore dell’opera Dei socratici, ma, in effetti, è più probabile che Ceneo non sia altro che una frettolosa trascrizione di Aphareus, figlio adottivo di Isocrate. Relativamente poi ai suddetti “segreti” rivelati, non si tratterebbe di dottrine politiche, quanto piuttosto di detti o di parole d’ordine; la notizia tuttavia fa pensare ad una certa vicinanza, se non appartenenza, di Speusippo ad ambienti isocratei. Diogene Laerzio parla anche dell’invenzione, da parte di Speusippo, della tecnica di intrecciare canestri a partire da fuscelli, “techne” che è stata attribuita da Diogene anche a Protagora.
La testimonianza di Diogene Laerzio prosegue con il riferimento a due fatti: il primo, non veritiero, fa riferimento al possibile trasferimento, da parte di uno Speusippo ormai immobilizzato dalla paralisi, della guida dell’Accademia a Senocrate, e il secondo, dedotto sicuramente da una fonte ostile all’Accademia, parla invece di un possibile incontro fra Speusippo e Diogene il cinico, durante il quale quest’ultimo, nel rispondere ad un saluto dello stesso Speusippo, gli avrebbe suggerito di porre fine alla sua vita, ormai solo colma di sofferenze e tribolazioni. Diogene Laerzio, nella sua testimonianza, sembra voler avvalorare l’ipotesi del suicidio di Speusippo, ipotesi che tuttavia non risulterebbe sostenuta da nessuna testimonianza; alcuni critici accettano il fatto che, ad un certo punto, vinto dagli stenti, Speusippo si sarebbe lasciato morire. Relativamente alle cause della morte, Diogene Laerzio riporta una notizia ricavata dalla Vita di Lisandro e Silla di Plutarco, secondo la quale la morte di Spesippo sarebbe stata provocata dalla pediculosi; in effetti non esiste alcuna prova a sostegno di questa informazione, che è derivata da Timoteo, un autore particolarmente ostile ai filosofi, di cui voleva porre in rilievo la morte indecorosa a contrasto con le belle parole. Il racconto di Diogene Laerzio si conclude con l’elencazione delle opere di Speusippo, presentate in modo nel complesso piuttosto disordinato, a causa presumibilmente di un difetto di interpretazione. In ogni caso le opere comprenderebbero:
a) dialoghi: Della ricchezza, Del piacere, Della giustizia, Della filosofia, Dell’amicizia, Sugli dei, Il filosofo, A Cefalo, Cefalo (Cefalo sarebbe il padre dell’oratore Lisia), Clinomaco e Lisia, Il cittadino, Dell’anima, A Grillo (Grillo sarebbe il figlio di Senofonte, morto nel 362 nella battaglia di Mantinea), Aristippo, Confutazione delle arti
b) commentarii: Dialoghi ipomnematici, Dell’arte, Dialoghi sulla scienza e simili, Divisioni e ipotesi sui simili, Esempi di generi e specie, Contro l’orazione “Senza testimoni” di Isocrate (che sarebbe stata viziata dal dato tecnico di essere stata condotta in assenza di testimonia da ambo le parti), Encomio di Platone (un elogio solenne a Platone, pronunciato in occasione del banchetto funebre), Lettere a Dione, Dioniso, Filippo, Della legislazione, Lo scienziato, Mandrobulo, Lisia, Definizioni, Commentarii distribuiti in ordine. Alcuni di questi titoli farebbero riferimento ad opere di carattere dialogico secondo lo stile platonico.
Il catalogo delle opere di Speusippo non è completo, in quanto mancano, ad esempio, gli epigrammi e sono state collocate insieme le lettere a Dione, Dioniso e Filippo, che sarebbero, a parte forse solo una, delle pseudoepigrafi. Di enorme importanza sono invece gli Оμοια, I simili, che vengono presentati in due parti, Dialoghi e Divisioni, anche se probabilmente si tratta di una stessa opera divisa in due parti, la seconda delle quali presentata come giustificazione delle premesse della prima. Nello scritto, che avrebbe lo scopo di determinare e delimitare gli enti singolari, Speusippo porta avanti il tentativo di classificare l’intera realtà secondo relazioni di specie e di genere e, secondo questa prospettiva, la definizione di un ente presuppone la conoscenza di tutte le differenze rispetto a tutti gli altri enti e quindi una conoscenza onnicomprensiva dell’essere. L’assunzione di una tale possibilità, che verrà, come si vedrà in seguito, duramente negata da Aristotele, implica una rigorosa articolazione degli universali, che Speusippo riprese, con alcune modifiche, dalle “dottrine non scritte” di Platone: dal suo punto di vista unità e molteplicità erano elementi e non generi dell’essere, che si ritrovano in forma analoga e specifica in ciascun ambito, in quello dei numeri matematici, delle grandezze matematiche, dell’anima del mondo e dei corpi sensibili.
La narrazione di Diogene Laerzio si conclude con la notizia, attribuita a Favorino di Arles, ma priva di consistenza storica, dell’acquisto da parte di Aristotele dell’intera biblioteca di Spesippo per tre talenti, acquisto che non si sarebbe mai realizzato vista la non vendibilità dei testi.
Rispetto al temperamento e alla personalità di Speusippo, è possibile ricavare alcune informazioni anche da Filostrato. Egli, per descrivere l’avidità di ricchezze propria del successore di Platone, narra di un suo viaggio in Macedonia per partecipare al banchetto di nozze di Cassandro, in occasione del quale avrebbe composto dei poemi di scarsissimo valore, che poi avrebbe recitato per guadagnare del denaro. A proposito della condizione economica di Speusippo, Chio di Eraclea riferisce che avrebbe ricevuto in moglie la più grande delle nipoti di Platone, con una dote di trenta mine inviata da Dioniso, e che sarebbe stato nel complesso piuttosto povero di risorse.
Relativamente alla fedeltà di Speusippo al pensiero di Platone, Cicerone, nel citarne a più riprese tutti i successori, parla non solo di Speusippo e di Senocrate, ma anche di Polmone, Cratere e Cantore, che avrebbero tenuto fede con scrupolo al pensiero del maestro. Questa notizia è confermata da Numenio, che cita Speusippo, Senocrate e Polmone come facenti parte di un tutt’uno nella loro fedeltà a Platone, fedeltà comunque relativa perché in effetti non si mantennero completamente in linea con la dottrina del maestro. Eusebio, al contrario, mostra invece come i tre successori avessero dissolto la dottrina platonica, introducendovi principi ad essa estranei e determinando la fine del pensiero platonico.
IL PENSIERO: I FRAMMENTI TRATTI DA OPERE CERTE
Le diverse interpretazioni dei frammenti
Dell’opera di Speusippo si possiedono concretamente solo pochi frammenti, limitati ad espressioni tipiche, semplici termini e brani isolati e forse una lettera; il resto delle testimonianze proviene da citazioni di altri filosofi e uomini di cultura. La principale fonte è il contemporaneo Aristotele, che tuttavia è conosciuto solo nell’edizione curata da Becker, quindi già dopo l’intervento di revisione e correzione di Andronico di Rodi. Aristotele, nella Metafisica, non cita quasi mai direttamente Speusippo fra i seguaci di Platone cui intende contrapporsi, quindi sono stati i commentatori, in particolare Alessandro d’Afrodisia, Aspasio, Simplicio, che hanno aiutato a scoprire tracce del spensiero speusippeo nei passi aristotelici che parlano di questioni affrontate da Platone.
Fra le altre testimonianze, se ne può individuare una sola di un contemporaneo di Speusippo, Teofrasto, il quale può fornire quindi informazioni dirette. Tali informazioni sono tratte presumibilmente da un’opera, intolata anch’essa Metafisica, scritta come chiarimento della Metafisica di Aristotele
Altra fonte è Giambico che, parlando di Speusippo, della perfezione del numero e del suo culminare nei numeri che rappresentano la piramide, si ha l’impressione che si stia riferendo ad un testo che sta citando in originale.
Anche Proclo sembra citare direttamente Speusippo, presentandolo, in una sua opera, come un io narrante che riporta la sapienza degli antichi, ma esistono dubbi circa l’attendibilità della citazione, in quanto viene attribuita a Speusippo la dottrina dell’uno incapace di generare qualcosa d’altro senza una dimensione di dualità, dottrina che in effetti è di Senocrate.
Dei filosofi
Diogene Laerzio, nelle sue Vite dei filosofi, cita, a proposito di Parmenide, l’opera speusippea Dei filosofi; questo titolo non compare effettivamente nel catalogo delle opere di Speusippo, mentre compare un Filosofi, che quasi sicuramente è il titolo più esatto. Speusippo non era un autore di biografie e il suo reale interesse era rappresentato dall’analisi di un certo modello teorico di vita filosofica, quindi è abbastanza improbabile che al successore di Platone possa venir attribuita una raccolta sistematica di vite dei filosofi.
Molto interessante è comunque il riferimento alla personalità di Parmenide. Speusippo fa infatti riferimento ad un Parmenide politico e legislatore e indica nella nomotetica, cioè nell’arte di produrre le leggi, l’attività più elevata nell’ambito di quella che è la vita politica nel suo complesso. Si tratta di un motivo questo tipicamente speusippeo, che tuttavia ritornerà anche in Aristotele, per il quale l’attività legislativa è annoverata come “architettonica”, quindi direttiva rispetto al resto dell’attività politica in generale.
A Cleofonte
Clemente Alessandrino cita, attribuendola a Speusippo, l’opera A Cleofonte, nella quale, riferendosi ad un ragionamento di Platone, si parla del valore nobile della legge in quanto prodotto dell’attività del re, il solo vero sapiente. Il discorso attribuito a Speusippo procede infatti dalla constatazione della superiore bontà del potere monarchico, dalla quale discende la bontà della legge. E’ necessario tenere conto del fatto che il concetto di legge cui fa riferimento Speusippo non è tanto la legge della città, ma piuttosto la legge propria del re, cioè la legge tradizionale di cui il buon re, il re saggio che vede come modello Minosse, non potrà mai fare a meno, valendosene come norma e regola nell’agire.
Tale idea del potere monarchico è stata tipica del programma politico perseguito da Platone a Siracusa ed appare perfettamente in conformità con l’ideale di legalità che l’Accademia in generale, e Speusippo in particolare, vedevano incarnato nella monarchia legittima e tradizionale di Filippo in Macedonia.
Dei numeri pitagorici
Anche questa opera manca nell’indice delle opere di Speusippo riportato da Diogene Laerzio, anche se è probabile che almeno una parte di essa fosse indicata nelle Vite dei filosofi con il titolo di Mathematicos. La prima parte dell’opera trattava probabilmente di cinque corpi cosmici e delle varie figure geometriche, piane e solide, mentre nella seconda parte il discorso verteva intorno alla decade, o tetractide, di modello pitagorico, come modello di perfezione dell’essere e modello cosmico. Il trattato di Speusippo doveva presentarsi come una sorta di rifacimento del Timeo platonico, privato della presenza del demiurgo, razionalizzato con l’eliminazione della connotazione mitologica e ridotto in termini più concretamente pitagorici.
Relativamente alla decade, oggetto, come già detto, della seconda parte del testo speusippeo, essa viene presentata come ciò che rappresenta il culmine della perfezione stessa. La decade è quindi il concetto principale che Speusippo desume dalla tradizione pitagorica a lui anteriore e che assume la funzione che nel Timeo, e nella concezione platonica generale, avevano le idee. Per Speusippo il numero in generale è modello della realtà cosmica, ma è anche, nel contempo, struttura del reale; il numero viene quindi in un certo qual modo calato nella realtà concreta, differentemente da quanto accadeva per le idee platoniche, che non sono mai state concepite da Platone stesso come collegate in un qualche modo al piano dell’immanenza.
La tetrade, come numero perfetto, vede la sua perfezione affidata al suo equilibrio interno e i fattori che le assicurano questo equilibrio vengono così elencati da Speusippo stesso:
1) la decade inizia con il numero 1, dispari, e culmina nel 10, che è pari. Speusippo in questo frangente si esprime per il carattere dispari dell’uno-numero, accogliendo la teoria pitagorica più antica. Speusippo inoltre, oltre a separare l’uno e il due come i primi fra i numeri, distingue l’uno come numero dall’uno come principio, indicato come adiaforico, cioè indifferente. L’uno in quanto principio ha una adiaforicità di partenza che non ne fa nemmeno un essere vero e proprio, ma solo la condizione prima dell’essere; l’uno invece in quanto numero è un principio unicamente nel senso di inizio e ha la stessa natura dei numeri della serie;
2) nella decade si trovano i logoi, cioè le ragioni del più e del meno, oltre che dell’uguale, il che conferisce alla decade stessa la sua completezza;
3) la decade contiene in sé la totalità dei rapporti spaziali, perché è costituita da 1, il punto, 2, la linea, 3, il triangolo, quindi la superficie, 4 , la piramide, quindi i solidi.
Appare evidente come Speusippo abbia tratto molto dal pitagorismo più antico, ma ha arricchito i concetti pitagorici attribuendovi, nel momento in cui ne parla come modelli organici dell’universo, caratteri marcatamente platonici.
La parte finale dell’opera di Speusippo è dedicata alla teoria del secondo principio, la forma materiale, la cui introduzione appare come un tentativo di correzione del Timeo platonico, in quanto, secondo la prospettiva speusippea, la tetrade, materializzata in una piramide, si sostituisce al triangolo quale base della realtà. In base alla tetradicità che domina il tutto, Speusippo formula la teoria delle quattro piramidi che sussistono ciascuna per ogni elemento della realtà; dal suo punto di vista, qualora si pongano dei triangoli alla base della realtà, non si procede oltre il numero tre, mentre solo la progressione fino al quattro ci fornisce la pienezza della perfetta tetradicità, cosa che si ottiene solo ponendo quattro forme piramidali alla base del tutto. La prima è il tetraedro regolare, che Platone aveva già posto all’origine dell’elemento fuoco, la seconda invece, e qui si osserva una novità introdotta da Speusippo, è la piramide a base quadrata. Questo solido non è né un tetraedro né una figura regolare, ma è stata suggerita a Speusippo dalla figura della piramide egizia e per questo può perfettamente riferirsi alla terra. La terza piramide ha infine per base un semitriangolo isoscele e la quarta un semitriangolo scaleno.
I simili
Homoia (I simili), opera organizzata in dieci libri, appare molto interessante perché consente di chiarire molti aspetti del pensiero di Speusippo, in particolare l’aspetto della priorità ontologica che egli, differentemente da Platone, attribuisce al particolare, cioè agli enti singolari e alle realtà sensibili, piuttosto che all’universale e all’eterno. In quest’opera il criterio della sovratemporalità delle idee, fondamentale in Platone, viene mantenuto, ma appare secondario rispetto alla priorità attribuita alle entità e ai rapporti matematici, come è testimoniato dall’uso del termine omoion, che assume il significato matematico di proporzionale.
La ricerca di Speusippo non si limita all’ambito dei rapporti matematici, ma si pone in una prospettiva molto più generale: la ricerca delle similitudini fra esseri viventi nel mondo empirico, che cadono sotto la conoscenza sensibile e che sono legati a tutta la approssimazione indefinita che è tipica del sensibile, non è concepita unicamente all’insegna del quantitativismo di carattere matematico, ma tiene conto anche dell’aspetto qualitativo, che appare da questo punto di vista determinante. La stessa approssimatività che appare nell’uso della terminologia sembrerebbe riflettere la consapevolezza di Speusippo del fatto che, abbandonato il terreno di quelle realtà che sono sottoposte al puro metodo quantitativo-matematico e inoltrandosi nella ricerca intorno alla struttura generale della specie, anche il criterio della similitudine perde necessariamente il carattere rigorosamente analogico-proporzionale e accede a quel livello di approssimazione che è proprio dell’ambito sensibile. In questa ottica anche il procedimento diairetico, per come viene interpretato da Speusippo, assume una connotazione maggiormente orientata verso la dimensione empirica e si trasforma da metodo di ordine logico a strumento di classificazione sistematica e scientifica. Attraverso questo metodo quindi risulta possibile estendere la ricerca fino ad abbracciare la quasi totalità delle specie esistenti, con un processo che tuttavia non può procedere indefinitamente e che trova il suo punto di interruzione di fronte alla cosiddetta “specie infima”, oltre la quale si pone unicamente la dispersa e infinita molteplicità degli individui. L’organo conoscitivo adibito alla “raccolta” delle informazioni è per Speusippo la sensazione scientifica: guidata dal logos, di cui essa partecipa, offre la base per una conoscenza sistematica della qualità del sensibile e permette di raccogliere i singoli casi in modo da evitare la dispersione, aspetto questo che rappresenta, secondo il punto di vista speusippeo, il male radicale.
Appare chiaro quindi che l’iniziale rigoroso matematismo di Speusippo viene mitigato attraverso il confronto con l’elemento qualitativo e con la molteplicità, ambito in cui emerge una tendenza alla ricerca di unità per mezzo dell’individuazione delle analogie e delle differenze che caratterizzano il reale. Tale tendenza all’unità può essere, nell’ambito della molteplicità, semplicemente parziale: non solo ad ogni somiglianza si oppone una differenza che distingue fra loro i singoli oggetti, ma la stessa somiglianza non appare dotata di una proporzionalità assoluta e rigorosa e deve tenere conto delle condizioni cui è sottoposto ciò che è oggetto della conoscenza empirica.
Il banchetto funebre di Platone
L’opera viene citata da Diogene Laerzio, che ne parla a proposito del fatto che in essa sarebbe stato riportato un episodio riguardante la nascita di Platone: Aristone, il padre di Platone, avrebbe cercato di far sua Perittione, madre di Platone e giovane molto avvenente, ma poi, ripresosi dall’impeto, avrebbe avuto la visione di Apollo e si sarebbe quindi astenuto da ogni contatto con la ragazza fino a che questa non ebbe partorito. Il discorso speusippeo, scritto per il banchetto funebre organizzato in occasione della morte di Platone, testimonierebbe due aspetti importanti:
a) la pratica diffusa del culto di Apollo, che in seno all’Accademia si univa al culto delle Muse;
b) l’orgine divina di Platone in quanto ritenuto figlio di Apollo, questione che permette di sviluppare alcune considerazioni circa il tipo di culto che, presso l’Accademia, sarebbe stato attribuito al maestro. Il capo dell’Accademia sarebbe stato infatti oggetto di una vera e propria divinizzazione, come è testimoniato dal racconto dello stesso Speusippo, che ci presenta per Platone come figlio di un dio e di una mortale; a sostegno di questa interpretazione vi sarebbe inoltre la testimonianza relativa all’erezione di un altare in suo onore. La divinizzazione di Platone è stata tuttavia messa in discussione da altri critici che ritengono il racconto di Speusippo inattendibile e infarcito di informazioni non corrette (egli era infatti troppo vicino alla famiglia di Platone per non sapere che non era il primo, bensì il terzo figlio di Perittione); lo scopo di Speusippo tuttavia non era certo quello di fornire una versione storica della nascita di Platone, ma forse quello di dare inizio al culto di Platone nell’Accademia e al processo di eorizzazione, con tutti i caratteri mitologici che gli sono propri. Queste valutazioni quindi permettono a ragione di ritenere che Speusippo possa essere ritenuto l’iniziatore di quella tradizione che caratterizzerà l’immagine di Platone prevalente nella tarda antichità.
Epigrammi, epistole e pseudoepigrafi
Nelle Epistole Socratiche vengono presentate numerose lettere che Speusippo avrebbe scritto a vari personaggi suoi contemporanei.
La prima lettera da prendere in considerazione è l’epistola socratica XXVIII, non da tutti considerata autentica, indirizzata a Filippo di Macedonia. Questa sarebbe stata scritta nell’inverno del 343-342, prima che l’intervento ateniese costringesse Filippo a astenersi dalla conquista di Ambracia.
Fin dalle prime righe della missiva ha inizio una polemica anti-isocratea che si protrarrà per tutto il resto della lettera. Speusippo vuole denunciare uno scritto dei suoi avversari, l’Anti-Filippo, e ciò spiega anche perché la lettera possa essersi conservata, trattandosi in effetti di una lettera aperta, cioè di un vero e proprio libello polemico scritto in forma epistolare, genere letterario non ignoto presso la scuola di Platone (la famosa VII Epistola mostra lo stesso carattere). Non è escluso infine che lo scopo della lettera fosse quello di evitare la scelta, per il giovane Alessandro, di un precettore vicino ad Isocrate e far quindi cadere la scelta su uno degli allievi di Platone.
Altra lettera oggetto di interesse è l’epistola socratica XXX, rivolta da Speusippo a Senocrate e contenente invece la richiesta da parte di Speusippo allo stesso Senocrate di prendere la guida dell’Accademia. In realtà, come già prevalentemente rilevato, l’Index Academicorum, ripreso anche da Diogene Laerzio, parla di una regolare elezione di Senocrate da parte dei discepoli, ma ciò non appare in netta contraddizione con l’ipotesi di una chiamata diretta da parte di Speusippo. Il tono generale della missiva appare in questo caso conciliatorio, teso cioè a creare accordo e a stabilire un legame fra i due primi grandi scolarchi dell’Accademia. La lettera inoltre è costruita in modo da porre in risalto la figura di Senocrate, cui viene riconosciuta legittimità sulla base delle stesse volontà di Platone, che avrebbe addirittura predisposto la sua tomba accanto a quella del discepolo prediletto; la scelta del successore, pertanto, alla luce delle considerazioni sviluppate nella missiva, non sarebbe quindi stata realizzata dai condiscepoli dell’Accademia, ma sarebbe stata invece indicata dallo stesso Platone.
Nel testo della lettera emerge anche una sorta di velato rimprovero di Speusippo nei confronti di Senocrate: Platone non avrebbe mai immaginato che Senocrate potesse allontanarsi dalla scuola ed è quindi a suo nome che Speusippo lo richiama, ricordandogli il dovere degli onori nei confronti del maestro e il rispetto della funzione di continuatore della sua opera, funzione che lo stesso Platone gli avrebbe attribuito.
IL PENSIERO: LE TESTIMONIANZE
Logica e gnoseologia
Una delle testimonianze più interessanti, per ciò che concerne l’analisi del pensiero di Speusippo dal punto di vista logico e gnoseologico, è contenuta nell’ Adversos mathematicos di Sesto Empirico, in cui l’autore attribuisce a Speusippo stesso un elemento di forte novità, la distinzione fra pensiero scientifico e sensazione scientifica. Secondo Speusippo, che ricollega quindi la sensazione non all’ambito della doxa, così come accadeva in Platone, ma a quello dell’episteme, essa può assumere carattere scientifico in quanto, così come accade al tocco del flautista che è una capacità tecnica, ma illuminata dal coesercizio della ragione, partecipa della verità intelligibile.
Speusippo opera anche delle integrazioni alla distinzione platonica fra conoscenza intuitiva, in virtù della quale si coglie la realtà giungendo ad essa in modo immediato, e conoscenza discorsiva, che procede dalle premesse e giunge a forme di conoscenza secondaria, e utilizza a questo proposito costantemente il termine di “caccia”, di uso platonico: delle cose di cui il pensiero va appunto a “caccia”, alcune, di cui esso ha una conoscenza per contatto, quindi molto chiara, le predispone come base per le ulteriori ricerche, altre, che non possono essere afferrate direttamente, vengono ricercate secondo il loro ordine conseguente. La conclusione di Speusippo è che la conoscenza sensibile si sposta dall’uno all’altro dei suoi oggetti con un movimento rettilineo e non è quindi previsto alcun movimento di discesa dai presupposti all’oggetto specifico della conoscenza, come invece ammetteva Platone per le realtà matematiche.
Altro aspetto importante affrontato da Speusippo è la distinzione, piuttosto netta e decisa, fra problemi e teoremi, distinzione con cui cioè differenzia un ragionamento che enuncia una proprietà dell’oggetto da un altro che, data una certa proprietà, costruisce in base a questa un oggetto. Speusippo individua, nella definizione di problema, qualcosa di inadeguato al carattere di assoluta uguaglianza a sé e di assoluta immobilità che contraddistingue il procedere matematico e tale dizione va pertanto eliminata, a favore invece di quella di theoremata, che indica una procedura per mezzo della quale attingiamo la conoscenza da qualcosa che sia di per sé eterno. Per Speusippo, di eterno e costantemente uguale a se stesso non ci sono altro che numero e figura e l’espressione “scienza teoretica” si riferisce quindi ai procedimenti della scienza matematica, mentre le altre scienze si pongono come subordinate a questa.
Molte testimonianze, in ordine alle questioni logiche e gnoseologiche, si possono ricavare anche dalla lettura delle opere di Aristotele, che a più riprese polemizza e prende posizione nei confronti delle dottrine speusippee. Negli Analitici posteriori, ad esempio, Aristotele si oppone, riferendosi molto chiaramente a Speusippo, contro coloro che tendono ad un panorama estensivo ed esaustivo di tutte le realtà esistenti, distinte fra loro per mezzo del criterio della differenza; Speusippo utilizzava ampiamente questo criterio, insieme a quello dell’analogia, nello studio dei simili e riteneva comunque il procedimento diairetico di Platone uno strumento fondamentale del conoscere, anche se da applicare con opportuni adattamenti. Dal punto di vista di Aristotele, invece, che in questo caso denota una scarsa conoscenza del pensiero di Speusippo, il successore di Platone era estensore di una metodologia che in realtà presupponeva la conoscenza di tutte le singole cose, che ovviamente non può essere raggiunta né con il procedimento diairetico né con quello induttivo. Il procedimento diairetico, che in Platone si configurava come un metodo di indagine applicabile certamente nell’ambito degli oggetti sensibili, ma avente come obiettivo il raggiungimento di un’idea, un eidos, ritenuto ultimativo nella ricerca, viene impiegato da Speusippo per padroneggiare l’ambito delle realtà sensibili e inserire tutti i singoli esseri in una trama ordinata e razionale di relazioni. La conoscenza dei sensibili è quindi per Speusippo non una sorta di impossibile conoscenza di tutte le singole realtà, bensì il punto di arrivo di una processo conoscitivo che, partendo dall’ordine astratto dei numeri, giunge a prospettare, grazie all’intervento della sensazione scientifica, un ordine dei singoli aspetti del reale.
Interessante è una testimonianza di Simplicio che fa riferimento al procedimento speusippeo della divisione dei nomi. Speusippo infatti distingueva fra nomi tautonimi ed eteronomi; fra i nomi tautonimi distingueva nomi sinonimi ed omonimi e fra quelli eteronomi quelli che sono tali in senso proprio, quelli polionimi e quelli paronimi. Malgrado la fonte diretta di Simplicio fosse Porfirio e non Speusippo, in effetti questa distinzione fu creata da Speusippo stesso sulla base del criterio analogia-differenza. Rispetto ad Aristotele, che utilizzava una tale divisione riferendosi ad enti concreti, Speusippo opera unicamente una divisione dei nomi e, rispetto al procedimento aristotelico, quello speusippeo procede in una direzione diversa: dalle cose ai nomi quello aristotelico, dai nomi alle cose quello di Speusippo.
Nel contesto dell’apparato dottrinale di Speusippo, la teoria dei nomi risulta essere fondamentale. Speusippo infatti aveva rifiutato la dottrina platonica delle idee, ma non l’insegnamento dell’ultimo Platone, per il quale il nome si poneva come una prima forma di conoscenza dell’oggetto, e dal suo punto di vista il nome rappresenta una realtà alla quale è possibile applicare i criteri di medesimo e di altro. In questo modo anche per Speusippo i nomi possono essere considerati alla stessa stregua delle cose.
Metafisica
La fonte principale per l’analisi di questo aspetto del pensiero di Speusippo è sempre Aristotele, in particolare la sua Metafisica, in cui vengono mossi a Speusippo diversi rilievi:
1) in diversi passi, si afferma che Speusippo avrebbe posto più essenze a partire dall’uno e principi diversi per ciascuna di esse, in particolare un principio per i numeri, uno diverso per le grandezze e uno ancora differente per l’anima, con conseguente allargamento del numero delle essenze e ammettendo una pluralità, ritenuta da Aristotele dispersiva, dei principi stessi. E’ fondamentale tuttavia non prendere troppo alla lettera la critica di Aristotele, il cui modo di concepire il pensiero di Speusippo è all’origine di interpretazioni di impostazione neoplatonica, in cui cioè si propone uno sviluppo della realtà in senso derivativo, o di stampo cosmologico pitagorizzante, in base al quale si prospetterebbe uno sviluppo che procede dall’assoluta unità e che si conclude con il Bene. In realtà Speusippo avrebbe concepito la realtà come un sistema sviluppantesi non in senso derivativo, ma secondo una prospettiva costruttivistica; l’uno da cui egli prende il suo inizio non è semplicemente il primo numero come inizio della serie numerica, ma, cosa che Aristotele non aveva compreso, il principio unico da cui il numero dipende e che ha il suo corrispettivo nel molteplice da cui il numero è formato;
2) secondo Speusippo, accomunato in questo agli antichi cosmologi, il bene non sarebbe nel principio, ma comparirebbe, insieme al bello, solo nel procedere ulteriore della realtà. Aristotele quindi afferma che per Speusippo il bene deriverebbe da un processo naturale e non da numeri e grandezze che sono in realtà immobili. Le affermazioni di Aristotele sembrano far pensare ad un’interpretazione del sistema di Speusippo in senso progressivistico: il bene, che non sarebbe comunque escluso dall’ambito dei principi e degli enti matematici, con cui condividerebbe il carattere dell’immobilità, troverebbe però la sua pienezza solo nella realtà ad un grado ulteriore del suo sviluppo;
3) relativamente alla contrapposizione fra uno e molteplice, secondo Aristotele, il secondo principio speusippeo, inteso come molteplicità, come ineguale o come piccolo contrapposto al grande, diverrebbe male di per sé, motivo per cui Speusippo non ha voluto rapportare l’uno al bene, per evitare cioè che per opposizione il secondo principio potesse essere identificato con il male. Speusippo in effetti, proprio per evitare la situazione che Aristotele ha rilevato, ha presentato il secondo principio in una forma molto generale: il bene, nel sistema speusippeo, si riscontra solo in un momento determinato, quando cioè la natura del tutto abbia raggiunto un certo sviluppo, e il secondo principio non viene identificato con il male, ma potrà ingenerarlo solo nei suoi effetti ulteriori di divisione e di dispersione, anche se la divisibilità di per sé non rappresenta il male. Questo particolare aspetto della dottrina di Speusippo deve essere ricollegato al Parmenide di Platone, dove si presenta l’opposizione uno-molteplice come un’opposizione fondamentale, primitiva e reale e come il confronto di due termini che si pongono ai poli opposti della realtà;
4) se il male consiste nella divisibilità e se ogni termine che ha un contrario è definibile per mezzo di esso, allora, dal momento che il bene è il contrario del male, allora il bene consisterà nell’essere indivisibile. Secondo Aristotele, questo tipo di ragionamento non può essere considerato valido in quanto il procedimento viene compiuto avendo assunto come scopo la dimostrazione di una determinata essenza, ma poi, nell’intento di dimostrarla, la si assume nello stesso tempo in via preliminare. Il bene in ogni caso è inteso come indivisibile dallo stesso Speusippo, tesi questa che sarebbe comprovata dall’opera Sui numeri pitagorici, ma tale tesi non è del solo Speusippo, per il quale fra l’altro l’uno si pone solo nella serie del bene;
5) Aristotele, nel distinguere coloro che considerano idee e numeri come una sola natura da chi invece li considera come vere sostanze, vuole analizzare, in senso critico, la teoria dei numeri che trascendono il reale, questione che in parte si era già comunque presentata con le idee platoniche, in quanto essenze separate dal sensibile. Queste, così come i numeri per Speusippo, sono vere in quanto reali e la loro verità razionale dipende dalla loro posizione metafisico-ontologica, che ne fa la realtà essenziale e quindi privilegiata sul piano gnoseologico. Aristotele mette a confronto le posizioni di Speusippo, Platone e anche Senocrate, che rappresenta per Aristotele una sorta di terza via nell’ambito della problematica. Platone ha parlato di idee e di entità matematiche, alcuni, come Speusippo, hanno parlato solo di entità matematiche come prime realtà dell’essere ed altri ancora di entità matematiche intese però in senso non strettamente matematico, posizione questa assunta da Senocrate, che unifica idee e oggetti matematici e viene a far cadere fra questi distinzioni precise. Speusippo, pur non accogliendo l’ipotesi di un’identità piena fra idee e numeri, non identifica però i numeri che egli definisce come “primi fra tutti gli esseri” con i numeri matematici di uso comune: per Speusippo, la matematica è il modello razionale del reale, le cui proporzioni sono evidenti nel numero matematico e soprattutto nella decade, e i numeri sono entità reali, ma aventi una loro superiorità metafisico-ontologica.
In un altro passo della Metafisica Aristotele ritorna sul problema di come sia possibile, per Speusippo, ammettere gnoseologicamente l’esistenza di un numero separato, numero che peraltro per il successore di Platone non è causa di nulla, ma che si configura come natura sussistente di per sé. Questo passaggio è importante perché Aristotele ci permette di comprendere come nel sistema del successore di Platone la trascendenza degli enti matematici fosse fondata anche su una ragione di ordine gnoseologico; il loro carattere razionale puro deriva dalla loro esistenza separata dal sensibile, anche se Speusippo si è servito di questa loro caratteristica per rendere tali entità unicamente una sorta di nature esistenti di per sé, quindi isolate nell’ambito del reale, e non cause. Questa puntualizzazione richiama il rimprovero aristotelico già rivolto a Platone nella Metafisica, dove le idee vengono criticate per essere svuotate di ogni funzione rispetto al sensibile. Aristotele si spinge oltre nella critica a Speusippo rimproverandogli l’affermazione secondo cui delle cose sensibili non si darebbe scienza; Aristotele si sforza si dimostrare che la dottrina dei numeri trascendenti crea, rispetto a tali entità, tutti gli inconvenienti già denunciati per le idee e finisce per applicare anche a Speusippo l’assioma platonico secondo cui si dà scienza solo di ciò che ha natura puramente razionale. In realtà per Speusippo, oltre al fatto che i numeri, pur essendo trascendenti, erano comunque modello del reale, è attestata l’esistenza di una scienza della sensazione, o meglio, come già precedentemente illustrato, di una sensazione di carattere tecnico-scientifico; egli attribuiva inoltre enorme importanza al procedimento diairetico come metodo per identificare gli enti sensibili in base alla loro reciproca analogia e/o differenza. In base a queste considerazioni si deve ritenere la testimonianza di Aristotele distorta e non corretta;
6) Aristotele si riferisce in generale ai Pitagorici e in particolare a Speusippo per ciò che concerne la diatriba fra la teoria dinamica e la teoria statica delle dimensioni. Aristotele parla diffusamente della teoria statica delle dimensioni, ma mostra di conoscere anche quella dinamica e ciò mostra che ai suoi tempi tale dottrina era già nota. Secondo alcuni critici la teoria dinamica delle dimensioni sarebbe da attribuirsi ad Archita, come è attestato anche da Diogene Laerzio, ma altri la attribuiscono invece a Speusippo, cosa che tuttavia non appare sostenibile per vari ordini di motivi. Speusippo ha tenuto in scarsa considerazione la kinesis nella fissazione dei diversi stati dell’essere: di kinesis si parla infatti soltanto a proposito del tempo e da ciò è possibile comprendere come, dal suo punto di vista, il movimento fosse accidentale e legato alla pura realtà dei fenomeni e che non fosse pertanto opportuno considerarlo nell’ambito dei principi matematici dell’essere. Speusippo avrebbe quindi accolto e sviluppato, analogamente per certi versi a quanto era riscontrabile in Platone, una teoria statica delle dimensioni, escludendo ogni possibile contaminazione con i processi dinamici di formazione delle figure; la teoria dinamica è quindi estranea sia a Platone che a Speusippo ed appare invece compatibile con il dinamismo tipico di Archita pitagorico, un autore in cui lo studio delle forme geometriche si univa strettamente all’analisi dei processi fisici e che portava a risultati radicalmente diversi da quelli di Platone;
7) Aristotele, parlando della molteplicità, delinea molto più chiaramente la portata della teoria speusippea dei principi, nella quale uno e molteplice non sono più i principi generali del tutto, ma solo principi dei numeri, prime realtà. I loro primi analoghi, riguardanti le figure, sono il punto, come equivalente dell’uno, e la proiezione spaziale della molteplicità, intesa platonicamente da Speusippo come topos o luogo. Questo “luogo” è proprio degli enti matematici diversi dal numero, cioè delle grandezze e delle figure, che hanno una loro propria e specifica dimensione nello spazio. Aristotele entra però immediatamente in polemica con Speusippo per quanto concerne l’esistenza di principi da cui deriverebbero tutte le diverse realtà. Secondo lo Starigita, se non si ammette che tutte le realtà derivino da determinati principi, realtà altrimenti impensabili se non ponendo i principi stessi come loro condizioni, le realtà risultano slegate fra loro.
Oltre ad Aristotele, altri autori hanno analizzato e commentato il pensiero di Speusippo.
Teofrasto, ad esempio, nella sua Metafisica, parla di Speusippo inserendolo fra coloro che vedono nel cosmo scarso e raro il bene e che lo vedono posto essenzialmente nella parte centrale. Questo particolare aspetto del pensiero speusippeo, al quale si è voluta dare erroneamente un’interpretazione cosmologica, vuole combinare la concezione del bene con la dottrina pitagorica del fuoco centrale: il sistema di Speusippo si sviluppa infatti dai principi ai numeri, alle grandezze, all’anima del tutto e comprende come termine ultimo le specie infime e le forme del sensibile, un sistema pertanto che prevede il bene al suo centro e che ha per estremi i principi da un lato e dall’altro la forma ultima cui lo sviluppo del reale mette a capo, il sensibile nella sua indefinita molteplicità. La teoria del bene come momento intermedio fra due estremi trova la sua corrispondenza nel sistema etico di Speusippo, in cui, analogamente, il bene si pone come momento intermedio fra un eccesso e un difetto che rappresentano estremità negative. Il modello del centro come momento medio fra due estremi, appare quindi per Speusippo uno schema di equilibrio genericamente riferibile al reale non solo sotto l’aspetto metafisico, ma anche sotto l’aspetto della stessa prassi.
Interessante è inoltre un altro brano della Metafisica di Teofrasto, in cui si fa riferimento al rapporto uno/diade infinita e alla possibilità che dall’uno derivino principi come il vuoto, il luogo, l’indefinito, l’anima e il tempo, ma che siano poi trascurate realtà importanti come il cielo. Teofrasto, in questo passaggio, afferma in definitiva che, una volta fissati i principi e le serie di realtà che da questi derivano, gli Accademici si disinteressano dell’estensione di tali serie fino all’osservazione particolareggiata delle realtà di ordine cosmologico. Speusippo in questo non rappresenta un’eccezione, mentre Senocrate si distaccherebbe dalla prospettiva accademica per la rilevanza attribuita alla cosmologia; in ogni caso, entrambi i filosofi si ricollegano alla tendenza di fissare due principi contrapposti del reale e a considerare le varie forme della realtà come riconducibili all’uno o all’altro dei due principi. Le realtà indicate come appartenenti alla serie dominata dal principio irrazionale sono il luogo, il vuoto e l’infinito, mentre quelle contrassegnate dalla razionalità, e quindi recanti in sé il contrassegno dell’ordine, dell’uguaglianza e della ragione, sono l’anima, il tempo e il cielo col suo movimento ordinato.
Teofrasto, in definitiva, con le sue considerazioni, vuole dimostrare che Speusippo, pur accogliendo l’idea pitagorica secondo cui i diversi aspetti della realtà derivano da due principi opposti, non fa poi alcuno sforzo per individuarli nella realtà stessa del cosmo, preferendo risolvere la questione con l’introduzione del criterio dell’analogia, in virtù del quale i principi stessi si ripetono nei diversi aspetti del reale.
Giamblico invece, nella rielaborazione di un brano speusippeo, individua come presupposti dei numeri matematici due principi, assolutamente primi e superiori a tutti, l’uno, che per il fatto di essere assolutamente semplice non può essere nemmeno ritenuto come qualcosa che è, e la molteplicità, o principio della divisione, che appare simile in tutto e per tutto ad una materia umida e ben plasmabile. Giamblico prosegue poi affermando che, sempre secondo Speusippo, da questi principi, l’uno e il molteplice, nasce il primo genere, quello dei numeri, che sono composti da ambedue i principi; solo quando la realtà ha compiuto un certo processo allontanamento dai principi, si manifesta prima il bello e, realizzatasi ancora una maggiore distanza dagli elementi primi, il bene. In conclusione, gli elementi primi, da cui derivano i numeri, non possono in nessun modo essere considerati né belli né buoni, ma è dall’unione dell’uno e della materia, causa della molteplicità, che si genera il numero e in esso per la prima volta si rivelano l’essere e il bello.
L’interpretazione di Giamblico appare in questo caso viziata da una spiccata nota di neoplatonismo in quanto l’uno viene collocato al di sopra di tutto l’essere e da esso deriva il bello, che si rivela prima negli enti matematici e poi, quando maggiore sia divenuta la distanza dai principi, nel bene. Il passo di Giamblico è interessante tuttavia per la precisazione relativa all’origine del male: esso si manifesterebbe non di per sé e al primo passaggio, ma al quarto o quinto passaggio, cioè come evento secondario del reale e quindi come una sorta di prodotto accidentale di esso. Questa interpretazione infine risulta essere contaminata anche da teorie stoicheggianti che ammettono lo sconfinamento della matematica nella fisica e che appare riferibile ad un’età molto più tarda e all’introduzione di temi non speusippei.
Teologia, cosmologia, psicologia
Teologia
La testimonianza più precisa che si ha della concezione del divino in Speusippo è presente nell’opera Placita di Ezio, in cui si afferma che per Speusippo la divinità è intelletto, non è simile né all’uno né al bene ed è dotato di natura propria.
A tale testimonianza sono state date diverse interpretazioni, così schematizzabili:
a) Speusippo, come Platone, avrebbe identificato dio con il nous, posizione che del resto nemmeno lo stesso Speusippo nega, anche se differenzia la divinità dal bene in sé e dall’uno;
b) al nous speusippeo potrebbe essere assegnato un determinato posto nella sclala dell’essere, che corrisponderebbe non a quello dell’anima universale, ma a quello degli enti matematici trascendenti;
c) il nous di Speusippo sarebbe semplicemente una parte dell’anima, così da negare nel suo pensiero la presenza di una concezione propria ed originale dell’intelletto, che finirebbe così per svolgere un ruolo assai modesto.
L’interpretazione più attendibile, che conferma, per questo aspetto, la vicinanza di Speusippo al pensiero del maestro, è quella che vede il nous come la parte più alta dell’anima del mondo, o meglio, come l’intelletto sovrano che la guida. A tale entità devono inoltre essere applicati predicati di bontà ed unità, anche se la sua natura specifica è diversa dall’essere buono o bello o dall’essere uno.
Cosmologia
Relativamente ai concetti di spazio e tempo, importanti sono le testimonianze contenute nella Metafisica di Aristotele e nelle Questioni platoniche di Plutarco.
Relativamente allo spazio, Aristotele critica Speusippo poiché, a suo avviso, collega il concetto di luogo agli enti matematici, concetto dal suo punto di vista è proprio invece degli esseri individuali, che sono separati proprio in virtù di questo. Probabilmente Speusippo, con tale concetto, voleva invece indicare una prima forma fisica di estensione delle forme matematiche, a cui attribuiva talvolta il nome di topos: per Speusippo il punto e il luogo, o spazio, che permette l’estensione geometrica, sono i principi della realtà spaziale, mentre per Aristotele non sarebbe corretto parlare di luogo senza dire esattamente anche “dove” questo luogo sia.
Relativamente invece al tempo, nella definizione propria di Speusippo manca il riferimento al concetto di numero, mentre è presente quello di quantità indeterminata; egli aggiunge un riferimento al movimento per chiarire la differenza che separa la grandezza temporale da quella spaziale, che è immobile. Questa definizione tuttavia non appare sostenuta da un sufficiente numero di testimonianze per poter provare in che termini di relazione si ponessero nel suo sistema il tempo, considerato come realtà a sé stante, e gli altri aspetti della realtà espressi in termini quantitativi.
Relativamente alle altre questioni cosmologiche, l’opera di riferimento è il De caelo di Aristotele, in cui viene presentata la posizione cosmologica di Speusippo. Egli propone, secondo Aristotele, un cosmo incorruttibile ed ingenerato, idea che può trovare la sua ragione teorica nella concezione matematica dell’universo sensibile data dallo stesso Speusippo, secondo il quale il mondo si costruisce in virtù di operazioni matematiche e geometriche, con l’esclusione di qualsiasi processo di genesi.
Psicologia
Per quanto concerne la concezione dell’anima, importante è la testimonianza di Giamblico, in cui si prende in esame il pensiero di coloro che estendono all’essenza dell’anima l’essenza matematica, fra i quali egli annovera Speusippo, che l’avrebbe definita come “forma di ciò che è generalmente esteso”. Questa definizione, che pure ha generato molti dubbi interpretativi, in effetti potrebbe essere accolta: se per Speusippo vale in primo luogo il principio dell’analogia, non appare per nulla strano che al numero, come indivisibile unità, e al punto, come principio della grandezza spaziale, potesse corrispondere una forma, o idea, geometrica ulteriormente perfezionata, ma unitaria ed organica, collocata ai livelli superiori delle facoltà psichiche. Tale interpretazione dell’anima si colloca peraltro a pieno titolo nell’ambito del matematismo accademico ed è confermata anche da Senocrate, con la sua interpretazione dell’anima come numero movente se stesso.
Nel De anima di Aristotele emergerebbe inoltre un parallelismo, sempre per analogia, fra la tetractide speusippea e le varie facoltà conoscitive e funzioni psichiche; da questo punto di vista, quindi, l’intelletto corrisponderebbe all’uno, la scienza al due, poiché si procede univocamente verso un oggetto, il tre all’opinione e il quattro alla sensazione. Per quanto concerne i due primi aspetti, l’intellezione come uno e la scienza come facoltà che procede in senso univoco verso l’uno, quindi come due, il riferimento potrebbe essere ritrovato anche in Platone, ma i passaggi successivi, che identificano il tre con l’opinione e separano questa dal quattro, cioè la sensazione, non possono essere ricondotti a Platone poiché egli procedeva ad un’identificazione e non ad una distinzione fra questi due momenti. Lo schema interpretativo delle facoltà psichiche deve essere quindi interamente ricondotto alla tetractide di Speusippo, che assume nel suo pensiero il valore di modello perfetto dell’universo e di eidos dell’anima cosmica.
Altra testimonianza interessante è infine quella di Olimpiodoro, che, nel suo In Platonis Phaedonem, cita Speusippo, insieme a Senocrate, Giamblico e Plutarco, come sostenitori della distinzione dell’anima in una parte razionale, immortale, ed un irrazionale, soggetta a morte. Il termine utilizzato è quello di άλογία, con il quale si vuole intendere probabilmente la parte arazionale dell’anima, intesa come anima individuale e che conosce moti estesi anche oltre e al di fuori dell’ambito della razionalità. Rispetto a questo aspetto, la dottrina di Speusippo potrebbe essere ricondotta alla teoria prima pitagorica, poi passata al medio a al neoplatonismo, della metensmatosi, secondo cui sarebbe necessario ammettere la conservazione di forme psichiche puramente vitali anche oltre la morte del corpo; questa dottrina sarebbe stata presa in grande considerazione soprattutto da Senocrate, la cui religiosità era orientata in senso spiccatamente pitagorico. Con l’espressione άλογία si deve quindi intendere come ciò che si caratterizza per il fatto di essere arazionale o per il fatto di uscire dai limiti della razionalità, quindi come ciò che si distacca dalla componente logica.
Etica
Per quanto concerne il pensiero etico di Speusippo, una delle fonti più importanti è rappresentata dall’Etica Nicomachea di Aristotele. Qui lo Stagirita, partendo dal presupposto che ciò che è opposto a qualcosa che deve essere fuggito in quanto male deve necessariamente essere un bene e che quindi il piacere deve essere un bene, critica Speusippo che afferma invece che il più è opposto al meno così come all’uguale, argomentazione con la quale Speusippo nega al piacere lo statuto di bene.
La posizione etica di Speusippo è così riassumibile:
– il piacere è pura genesis o processo, e un processo non può mai essere un bene;
– il saggio deve evitare e fuggire i piaceri;
– il bene è prodotto della techne e pertanto il piacere non può essere un bene;
– al piacere aspirano anche gli esseri inferiori, come gli animali e i bambini, cosa che nuovamente prova che il piacere non è un bene;
– il piacere è uno stato fluido, una sorta di apeiron, comunque di carattere negativo.
In Speusippo inoltre lo schema dell’etica è su base tripartita, con due diversi mali opposti fra loro ed entrambi contrapposti a quello che è il vero bene, che coincide per Speusipo con l’assenza di dolore; in questo caso il piacere non è una vera situazione reale, ma un passaggio da una condizione all’altra. E’ possibile leggere la dottrina etica di Speusippo, malgrado la sua considerazione del piacere come di un qualcosa lontano dal bene, come saldamente fondata sull’ontologia platonica, in particolare quella del Filebo, dove viene presentata la teoria del medio che equilibra gli opposti più e meno, la dottrina cioè che individua un valore intermedio fra due non valori rappresentati da eccesso e difetto, in particolare piacere e dolore, e che si inquadrerebbe quindi senza difficoltà nell’ambito delle posizioni etiche platonico-accademiche.
Considerazioni conclusive
Rispetto al rapporto con Aristotele, Speusippo, che pure aveva mostrato di condividere con lo Stagirita una certa passione per le scienze naturali, restava da questo distante e in eterna polemica a causa della dottrina delle idee-numeri; molte delle pagine più vigorosamente polemiche della Metafisica di Aristotele hanno come bersaglio proprio le posizioni di Speusippo. Eppure, al di là di questo aspetto sicuramente significativo, il pensiero dei due filosofi non è così distante da giustificare una polemica così accorata. Speusippo si era significativamente allontanato dall’opposizione evidente in Platone fra la conoscenza sensibile e conoscenza razionale ed attribuiva fondata importanza alla conoscenza scientifica da intendersi come esperienza guidata dalla ragione; non mostrava pertanto opposizione nei confronti di tutto ciò che proviene dai sensi, ritenuti fonte di errore e causa di inganno, ma optava per una continua dialettica tra il momento della percezione sensibile e quello della riflessione razionale.
Tra Speusippo ed Aristotele vi era quindi una certa comunanza di vedute e l’Abbagnano suggerisce addirittura che la critica alla dottrina delle idee formulata da Aristotele sia da accreditarsi a Speusippo e lo Stagirita si sarebbe limitato a riprenderla e rinvigorirla con nuovi argomenti.
Speusippo aveva dunque, malgrado le accuse di scarsa originalità filosofica, una propria personalità e non era un semplice riproduttore di dottrine platoniche e un ostinato custode del pensiero del maestro. Di questo accettò solo l’ultima svolta, quella centrata sull’uno e la diade, ed era convinto che il vero ordine divino, rintracciabile oltre le apparenze contraddittorie dei fenomeni, stesse in effetti nei numeri: la vera lingua della natura, dal suo punto di vista, era rappresentata dalla matematica e dalla geometria ed il cosmo appariva ai suoi occhi come un insieme ordinato da principi matematici, in cui le cose stavano in rapporto tra di loro secondo misura e proporzione.
Anche rispetto alla dottrina del Bene come principio del processo cosmico, Speusippo prese le distanze dall’illustre zio: tutti gli esseri viventi, dal suo punto di vista, manifestano una tendenza a passare da uno stato di imperfezione ad uno di perfezione ed il Bene rappresenta il punto conclusivo di un processo di continua crescita e non l’inizio. Il vero Bene è quindi, secondo Speusippo, una meta che l’uomo cerca lentamente e progressivamente di raggiungere e che forse, così come ammetteva Platone, può venire dal ricordo e dalla rammemorazione, ma che in effetti si manifesta come rifiuto e negazione di tutto ciò che è malvagio sia agli occhi dei sensi che della ragione.
Speusippo, come abbiamo visto, accolse di Platone anche il principio dell’anima del mondo, anche se con un’interpretazione meno accorata e partecipata, e più semplicemente si rivolse allo studio del regno animale e vegetale con intenti classificatori. Sicuramente, con il suo atteggiamento che senza esitazione possiamo definire scientifico, finì con lo stimolare gli studi di Aristotele e del suo allievo Teofrasto.
Bibliografia
Diogene Laerzio, Vite e dottrine dei piu celebri filosofi, Bompiani, Milano 2005, a cura di G. Girgenti e I. Ramelli.
M. Isnardi Parente, Speusippo. Testimonianze e frammenti. http://rmcisadu.let.uniroma1.it/isnardi/fronte.htm
D. Massaro, La comunicazione filosofica, vol. 1, Paravia.
F. Restaino, Storia della filosofia, vol. 1, UTET.
F. Volpi, Dizionario delle opere filosofiche, B. Mondadori, 2000.

