LA FILOSOFIA DEL 1800
“E dove dunque vogliamo arrivare? Al di là del mare? Dove ci trascina questa possente avidità, che è più forte di qualsiasi altro desiderio? Perché proprio in quella direzione, laggiù dove sono fino ad oggi tramontati tutti i soli dell’umanità? Un giorno si dirà forse di noi che, volgendo la prua a occidente, anche noi speravamo di raggiungere l’India, ma che fu il nostro destino a naufragare nell’infinito? Oppure, fratelli miei? Oppure?” (F. Nietzsche, Aurora)
INTRODUZIONE GENERALE
Con la morte di Hegel, avvenuta nel 1831, si apre una questione di gran rilievo per la storia del pensiero: il sistema hegeliano, organico ed estremamente compatto, trova nel fatto stesso di essere un sistema un punto di forza ma anche di debolezza. Infatti, non appena ne “crolla” una parte, anche il resto entra inevitabilmente in crisi. Ed è proprio quel che avviene negli anni Trenta dell’Ottocento; sorge dunque, presso il “popolo degli intellettuali”, l’assillante quesito: “come comportarsi nei confronti del sistema hegeliano?”. L’Hegelismo si manifesta pertanto, dopo la scomparsa del filosofo che l’aveva elaborato, in differenti forme e correnti, di cui se ne possono individuare essenzialmente tre. La prima corrente è quella che si muove, sia pur criticamente, nell’ambito dell’hegelismo, rimanendo fedele ad esso. Questa corrente seguace del sistema hegeliano si dividerà, a sua volta, in Destra e Sinistra hegeliana. Il motivo di tale scissione tra i sostenitori del sistema hegeliano sarà essenzialmente dato dal fatto che in Hegel convivono tranquillamente la sfera rivoluzionaria ( ciò che è razionale è reale ), secondo la quale tutto ciò che è giusto deve essere realizzato, e la sfera conservatrice ( ciò che è reale è razionale ), secondo la quale le cose così come sono vanno bene, in quanto manifestazioni di una razionalità profonda. La Sinistra coglierà nella filosofia di Hegel il continuo cambiamento dialettico della realtà, leggendo in chiave progressista e spesso rivoluzionaria il motto ‘tutto ciò che è razionale è reale’. La Destra, invece, guarderà con maggior simpatia al motto ‘tutto ciò che è reale è razionale’, dandone una lettura fortemente stagnante e conservatrice, ostile a cambiamenti di ogni sorta. E’ però opportuno ricordare che la scissione tra Destra e Sinistra nacque, ancor prima che sul versante politico, su quello religioso: la Destra, legata ai valori della religione e della Chiesa, tenterà di fondare una scolastica hegeliana, ovvero un tentativo di apologizzare la religione cristiana attraverso i concetti dell’hegelismo. Hegel aveva, infatti, insistito sul fatto che i contenuti della sua filosofia e quelli della religione cristiana coincidessero; e, tuttavia, aveva anche sottolineato la superiorità della filosofia sulla religione, sostenendo che la filosofia esprime gli stessi contenuti della religione cristiana, ma ad un livello incommensurabilmente superiore. Ed è su questo che si basa la Sinistra hegeliana, convinta che ormai la religione fosse stata definitivamente superata dalla filosofia. Abbracceranno la causa della Sinistra hegeliana pensatori del calibro di Feuerbach, Engels e Marx, sicchè non è sbagliato affermare che il marxismo è una sorta di “eresia” dell’hegelismo. Ma, accanto a questa corrente (divisa in Destra e Sinistra) che segue criticamente gli insegnamenti di Hegel, vi è anche un nutrito gruppo di pensatori che si ribella al panlogismo hegeliano, alla sua esasperata ricerca della razionalità, rivendicando la natura irrazionale della realtà: aderiranno a questa corrente di pensiero Schopenhauer, Kierkegaard e Nietzsche. Sul versante opposto, vi è poi un anti-hegelismo di stampo razionalistico: in sostanza, questa terza corrente di pensatori rinfaccia ad Hegel di aver elaborato una filosofia razionale in cui però la ragione in questione non è quella della scienza di tipo illuministico, ma è quella dialettica, in grado di dimostrare solo e soltanto che ” il vero è l’intero ” o che ” il negativo è insieme anche positivo “. Questo terzo filone costituirà quella corrente di pensiero passata alla storia con il nome di Positivismo: tesi portante di questa corrente è l’identificazione totale della ragione e, in generale, di ogni conoscenza, con la scienza (a cui Hegel non aveva dato molto peso), come se ciò che esula dalla scienza non potesse costituire in alcun modo la conoscenza. Ricapitolando, le tre correnti che si affacciano sulla scena filosofica successiva ad Hegel possono essere così riassunte:
- prosecutori dell’hegelismo, seppur criticamente: Destra e Sinistra.
- anti-hegeliani sostenitori della superiorità della scienza in ogni ambito: Positivismo.
- anti-hegeliani avversi ad ogni forma di razionalità: Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche.DESTRA E SINISTRA HEGELIANE
Come abbiamo accennato poc’anzi, la Destra e la Sinistra hegeliane nascono all’indomani della scomparsa del filosofo: un esponente dell’hegelismo, Strauss, definirà le due correnti opposte nate nell’ambito dell’hegelismo come “Destra” e “Sinistra” richiamandosi esplicitamente al parlamento francese. La Destra hegeliana, detta anche dei “vecchi” per il carattere marcatamente conservatore che la contraddistinse, si opponeva alla “Sinistra”, detta anche dei “giovani” hegeliani in virtù del fatto che a comporla erano per lo più giovani progressisti: il primo motivo che portò le due “fazioni” a scontrarsi fu di materia religiosa. Hegel aveva, infatti, sostenuto che la filosofia e la religione esprimessero gli stessi concetti, ma aveva anche aggiunto che la filosofia li esprime in maniera decisamente migliore. Dall’ambiguità del discorso hegeliano, nasce la spaccatura tra Destra e Sinistra: la prima, tende a sottolineare l’identità di contenuti della filosofia e della religione, avvalorando in questo modo la religione; la Sinistra, dal canto suo, sottolinea come la filosofia sia per natura superiore alla religione, poichè quest’ultima, come aveva detto Hegel, può solo esprimersi attraverso narrazioni mitologiche. In altri termini, la Destra approva la religione poichè ne sottolinea l’identità di contenuti con la filosofia; la Sinistra, invece, è contraria alla religione poichè ne sottolinea l’inferiorità della forma rispetto alla filosofia. Ne consegue inevitabilmente che i seguaci della Sinistra si dedicheranno assiduamente all’indagine filosofica, mentre invece gli esponenti della Destra arriveranno ad anteporre la religione alla filosofia, cosicchè i loro contributi alla storia del pensiero sono pressochè irrilevanti. Ma la questione religiosa non è la sola a creare disaccordi tra gli hegeliani: se in Hegel convivevano ambiguamente la superiorità della filosofia rispetto alla religione in ambito formale e l’uguaglianza tra le due in ambito contenutistico, è anche vero che nel filosofo trovavano il loro spazio anche due concezioni della realtà contrapposte; da una parte, infatti, egli diceva che tutto ciò che è giusto perchè razionale deve essere realizzato, dando così una veste progressista al suo pensiero; dall’altra parte, invece, sosteneva che la realtà, così come è, è razionale e, in ultima istanza, giusta, dando così una colorazione conservatrice alla sua filosofia. Ora, come per quel che riguarda la religione, anche qui si crea una spaccatura: la Destra sostiene che tutto ciò che esiste è razionale e, pertanto, non deve essere cambiato; la Sinistra, invece, è del parere che tutto ciò che è razionale debba essere fatto diventare anche reale, in una prospettiva progressista e, talvolta, rivoluzionaria. Ricapitolando, i due punti di “disaccordo” tra Destra e Sinistra sono:
- il rapporto religione-filosofia
- il rapporto tra razionale e reale
Sul versante religioso, merita di essere ricordato DAVID FRIEDRICH STRAUSS (1808-1874), convinto sostenitore della Sinistra, il quale dà del cristianesimo e della figura di Gesù un’interpretazione molto particolare: nell’opera Vita di Gesù (1835), recante lo stesso titolo di quella pubblicata a suo tempo da Hegel, egli sostiene, in netto contrasto con la tradizione, che la figura di Gesù sia il frutto dell’elaborazione mitologica dei cristiani. Strauss non mette in dubbio l’esistenza di Gesù, ma ciononostante è convinto che, paradossalmente, sia Gesù come elaborazione mitologica a derivare dal cristianesimo e non viceversa, come invece aveva sempre sostenuto concordemente la tradizione. Con queste riflessioni, Strauss può a pieno titolo rientrare nella sfera della Sinistra hegeliana, rivelando, tra l’altro, una certa tendenza (che sarà meglio espressa da Feuerbach) a naturalizzare il concetto di spirito, a riportarlo ad una dimensione immediata e calata concretamente nell’umanità. Altro grande esponente della Sinistra, fu BRUNO BAUER (1809-1882), curiosamente partito da posizioni proprie della Destra: nonostante le posizioni iniziali, egli si “converte” alla Sinistra ed espone la sua concezione della religione in La tromba del giudizio universale contro Hegel ateo e anticristo (1841). Con quest’opera, pubblicata anonimamente, egli attua una finzione letteraria, presentandosi come pensatore iper-conservatore e religioso e polemizzando aspramente con Hegel, accusato di essere ateo e anticristo. Con questo gioco intellettuale, Bauer vuole mettere in luce le tesi della Sinistra, facendo notare come se si vuole essere hegeliani non si può essere religiosi, poichè ciò che dice Hegel è inaccettabile per la religione: è dunque impossibile essere al contempo hegeliani e religiosi, come invece fanno gli uomini della Destra, ed è per questo che Bauer si dichiara apertamente ateo. Del problema politico si occupano soprattutto Ruge e Heine, i quali sottolineano (riprendendo concezioni illuministiche) come la Sinistra privilegi l’idea di una razionalità che deve a tutti i costi diventare reale: in quest’ottica, viene anche recuperato Fichte (molto più rivoluzionario di Hegel) e la sua concezione dinamica della realtà come tensione costante. Il succo del discorso di Ruge e di Heine è che se la Germania ha già fatto una rivoluzione sul piano intellettuale con il percorso che da Kant giunge fino ad Hegel, ora non resta che fare la rivoluzione sul piano politico ed è per questo che i pensatori della Sinistra guardano con particolare simpatia al liberalismo e alla democrazia, in un periodo particolarmente oppressivo e conservatore (siamo all’incirca nei foschi anni che di poco precedono il rivoluzionario 1848). Ed è curioso ricordare che, quasi sempre, gli esponenti della Sinistra furono emarginati dalle università, poichè il mondo accademico tedesco restava saldamente nelle mani degli hegeliani di Destra: non potendo esporre il loro pensiero nelle università, i filosofi della Sinistra si scatenarono (Ruge in prima persona) nella pubblicazione di riviste e giornali, per coinvolgere in modo democratico la società; ed è in questo contesto che muove i suoi primi passi il giovane Marx. La più serrata critica alla religione e uno dei più sentiti inviti ad abbracciare la causa democratico-rivoluzionaria in questi anni provengono da FEUERBACH (1804-1872), convinto sostenitore della Sinistra. Il punto da cui egli muove è la filosofia hegeliana e, soprattutto, il momento della “coscienza infelice” (Fenomenologia), dell’uomo medioevale che si sente radicalmente contrapposto a Dio e ne soffre. Feuerbach estende quest’infelicità all’intera religione (e non solo a quella medioevale), criticandola aspramente. Verso Hegel stesso egli è critico, poichè non può in alcun modo accettare che con Hegel termini la storia della filosofia: si propone pertanto di presentare una “filosofia dell’avvenire”, ponendosi come superamento dialettico di Hegel stesso. Con queste considerazioni sullo sfondo, Feuerbach scrive la sua opera più importante, L’essenza del cristianesimo (1841): Schleiermacher aveva ragione, egli dice, a considerare la religione come sentimento di dipendenza dell’uomo nei confronti dell’Assoluto; ma tale Assoluto altro non è se non l’umanità stessa alienata. Infatti, non è vero (come invece afferma il cristianesimo) che Dio crea l’uomo a propria immagine e somiglianza; al contrario, è l’uomo che crea Dio a propria immagine e somiglianza, il che vuol dire (essendo Dio una “produzione” dell’uomo) che la teologia, cioè la scienza di Dio, è un’antropologia, ovvero una scienza dell’uomo. E perchè l’uomo “produce” un Dio a propria immagine e somiglianza? Feuerbach dice espressamente che l’uomo è dotato di qualità quali la potenza (il poter amare, agire, conoscere) e sente l’esigenza di prenderne coscienza; ma l’uomo di cui parla Feuerbach non è il singolo, ma è, molto hegelianamente, l’umanità, poichè l’uomo è davvero tale solamente in rapporto con gli altri, quasi come se, restando solo, egli non fosse davvero “uomo”. Quelle facoltà che riferite ad un uomo erano finite, se estese all’intera umanità si moltiplicano all’infinito, cosicchè l’umanità, volendo prendere coscienza di sè e delle proprie infinite facoltà, si deve oggettivare, deve cioè proiettare fuori di sè le proprie caratteristiche per poterle così osservare come oggetto. Ed è con questo processo di oggettivazione (per molti versi simile al confronto tra autocoscienze tratteggiato da Hegel) che l’uomo crea Dio. Dunque, Agostino sbagliava a dire che nell’uomo si possono trovare tre nature poichè in Dio vi sono tre nature; al contrario, è corretto affermare che in Dio ci sono tre nature poichè nell’uomo vi sono tre nature: in altri termini, la somiglianza tra Dio e uomo si spiega nel fatto che l’uomo crea Dio. Ma la religione, nota Feuerbach, è stato un momento necessario nella storia dell’uomo e, proprio in quanto necessario, è stato giusto, anche perchè ha permesso all’uomo di prendere coscienza di sè. Tuttavia, il lato negativo di tutto ciò risiede nel fatto che l’oggettivazione è anche alienazione, vale a dire che l’uomo, creando Dio, è come se si fosse privato delle proprie facoltà, poichè ciò che viene dato a Dio viene inevitabilmente tolto all’uomo. Il problema che il pensiero moderno deve dunque affrontare consiste nel recupero della dimensione antropologica della religione, partendo dall’alienazione originaria con cui si è creato Dio. Una tendenza in questo senso, Feuerbach la scorge a partire dalla Riforma Protestante: con Lutero, infatti, Dio cessa di essere importante in sè, e diviene importante per ciò che è per l’uomo. La storia di riappropriazione della dimensione antropologica, avviatasi con Lutero, prosegue e culmina in Hegel, che però non è stato in grado di riconoscere l’autentica natura dell’umanità, bensì si è limitato a parlare di spirito o, tutt’al più, di umanità in termini troppo astratti. Feuerbach, invece, è ostile ad ogni astrattismo e quando parla di umanità, si riferisce non all’umanità spiritualizzata di Hegel, bensì a quella caratterizzata dall’esistere concretamente, quella cioè da cui siamo circondati e con cui abbiamo a che fare nella nostra vita quotidiana. Ed è per questo che Feuerbach può affermare in modo provocatorio che ” l’uomo è ciò che mangia “, come recita il titolo di un suo scritto: bisogna recuperare l’uomo materiale e sensibile, non alienato in Dio, e la sensibilità stessa assume un valore gnoseologico profondo, poichè attraverso il corpo e il contatto con esso, dice Feuerbach, si penetra nell’essenza delle cose e delle persone. Il bisogno di rapportarsi materialmente con gli altri è naturale a tal punto che la dimensione sensibile diventa sensoriale, come se coi sensi si potesse conoscere profondamente la realtà, cosicchè nel rapporto “io-tu” che si instaura materialmente per recuperare l’umanità smarrita in Dio, il contatto fisico gioca un ruolo fondamentale e l’amore fisico diventa anch’esso una forma di conoscenza. Si potrebbe obiettare a Feuerbach il fatto che egli si sforzi di cercare la concretezza per poi fermarsi all’umanità, senza pervenire ai singoli individui (come faranno Kierkegaard o Stirner); la risposta a questa possibile obiezione è molto semplice: se Feuerbach avesse concentrato la sua attenzione sui singoli e non sull’umanità (che comunque egli intende nel più concreto dei modi possibili), non avrebbe potuto spiegare l’oggettivazione dell’uomo in Dio. Infatti, perchè vi sia un’oggettivazione in qualcosa di infinito (Dio), è necessario che ad oggettivarsi sia qualcosa di infinito, come è appunto la somma infinita delle facoltà dell’umanità, facoltà che se considerate finitamente nel singolo non potranno mai oggettivarsi in qualcosa di infinito. Non c’è poi da stupirsi se un acceso rivale della religione come è Feuerbach, finirà per dare una veste religiosa alle proprie idee: infatti, l’oggetto della sua religiosità resta sempre e comunque l’umanità concreta (mai Dio), immanente nella realtà, quasi come se l’oggetto della teologia diventasse l’umanità nel suo complesso. Le considerazioni religiose di Feuerbach si intrecciano con quelle politiche: egli sottolinea, infatti, il carattere pericolosamente conservatore della religione; in essa, l’uomo tende a diventare schiavo, a sentirsi dipendente da un’entità superiore, e uno schiavo incatenato nel “mondo delle idee” diventa inevitabilmente anche schiavo nella realtà materiale, quasi come se oltre ad essere schiavo di Dio diventasse anche schiavo di un padrone materiale. Ne consegue che la liberazione politica dell’uomo dovrà passare per l’eliminazione della religione: infatti, solo dopo la scomparsa della religione l’uomo cesserà di essere schiavo di Dio e, successivamente, dei padroni materiali. Diametralmente opposta sarà la concezione di Marx, secondo la quale ” la religione è l’oppio del popolo ” : secondo Marx, infatti, l’uomo ricorre alla religione perchè materialmente insoddisfatto e trova in essa, quasi come in una droga (“oppio”), una condizione artificiale per poter meglio sopportare la situazione materiale in cui vive. Per Marx, dunque, non è la religione che fa sì che si attui lo sfruttamento sul piano materiale (come invece crede Feuerbach), ma, al contrario, è lo sfruttamento capitalistico sul piano materiale che fa sì che l’uomo si crei, nella religione, una dimensione materiale migliore, nella quale poter continuare a vivere e a sperare. Ne consegue che se per Feuerbach per far sì che cessi l’oppressione materiale occorre abolire la religione, per Marx, invece, una volta eliminata l’oppressione, crollerà anche la religione, poichè l’uomo non avrà più bisogno di “drogarsi” per far fronte ad una situazione materiale invivibile. Si può anche fare un cenno al rapporto che intercorre tra Hegel, la Sinistra hegeliana e Marx: se Hegel vedeva i processi meramente a livello ideale, con la Sinistra hegeliana si afferma la convinzione che le idee servono per trasformare la realtà, nella convinzione che il razionale debba diventare reale; in altri termini, con la Sinistra la rivoluzione ideale diventa premessa per la rivoluzione materiale. Marx, invece, sostiene che si debba dialetticamente cambiare non il mondo delle idee (poichè, cambiate le idee, le condizioni materiali non cambiano), bensì bisogna cambiare il mondo materiale e, cambiandolo, cambieranno anche le idee. Marx non è d’accordo con quella che definisce “ideologia tedesca” (cioè con quel mondo che parte da Hegel e giunge fino alla Sinistra), poichè secondo lui le idee, di per sè, non sono in grado di cambiare le cose: al contrario, bisogna prima cambiare le cose, e poi cambieranno pure le idee; e il primo atto filosofico per costruire una “filosofia dell’avvenire” consiste nel mutare il mondo con la rivoluzione a mano armata, grazie alla quale spariranno le vecchie idee (tra cui la religione) e ne nasceranno di nuove. Ecco perchè Marx può dire che ” fino ad oggi i filosofi si sono limitati ad interpretare il mondo, si tratta ora di cambiarlo ” e che ” bisogna sostituire alle armi della critica la critica delle armi “, nella convinzione che l’unica vera critica la si fa con le armi sulle piazze. Al di là delle posizioni appena tratteggiate, troviamo anche chi scorge nell’individuo la massima espressione della concretezza ed arriva a sostenere posizioni anarchiche: in questa prospettiva, troviamo le figure di MAX STIRNER (1806-1856) e MICHAIL BAKUNIN (1814-1876), accomunati dal concetto di “individualismo”; entrambi respingono tanto l’astratto spiritualismo hegeliano, quanto l’umanità di Feuerbach e la classe di Marx, ritenute anch’esse troppo astratte. Nelle filosofie di Bakunin e Stirner aleggia la convinzione che, in fin dei conti, a contare e ad aver diritti sia solo il singolo, per cui non ha senso parlare di “Stato etico” superiore ai singoli (come aveva fatto Hegel) o di “umanità” (come fa Feuerbach). Al contrario, solo il singolo individuo ha diritti ed è degno di essere indagato filosoficamente: se Bakunin si qualificò sempre come anarchico e partecipò perfino alla Prima Internazionale, Stirner, invece, non si è mai occupato di politica in senso stretto, anche se la sua filosofia ha ispirato maggiormente le ali di estrema destra per via delle posizioni accesamente individualistiche da lui propugnate. L’anarchia può infatti essere appannaggio tanto delle sinistre quanto delle destre ed è per questo che se la Sinistra, ispirandosi a Bakunin, mira all’individualismo come estrema libertà, la Destra, invece, (ispirandosi a Stirner) tende all’individualismo come superiorità del singolo sulle masse. In L’unico e la sua proprietà (1844), Stirner arriva a sostenere che ad esistere è solo l’individuo e ciò che per lui conta è, paradossalmente, solo lui stesso; tutto il resto (le cose, gli animali e perfino gli altri uomini) è solo uno strumento per l’affermazione di sè. Il mondo stesso viene concepito come strumento volto ad attuare la realizzazione del singolo. Sull’altro versante, Bakunin elabora anch’egli un anarchismo individualista, ma rimane nell’alveo dell’anarchismo di ispirazione socialista (proponendo, ad esempio, l’autorganizzazione), ma rispetto a Marx nutre molti sospetti verso la dittatura del proletariato, temendo che essa possa trasformarsi in stato autoritario. Infatti, Bakunin sostiene che bisogna abolire, anche violentemente, lo Stato, in quanto sinonimo di dominio coercitivo e di disuguaglianza; tutto ciò, portava Bakunin a privilegiare il sotto-proletariato, del tutto disorganizzato e per ciò in grado di agire spontaneamente in chiave rivoluzionaria e di rovesciare lo Stato. Marx, che nutriva profonda antipatia per Bakunin (peraltro cordialmente ricambiata), non esitò a definire utopistico tale progetto, contrapponendo ad esso il proprio, incentrato sulla dittatura del proletariato. Ma Bakunin ebbe ragione a temere una degenerazione autoritaria della dittatura del proletariato: la dittatura staliniana ne fu la conferma.
IL POSITIVISMO
Affermatosi già nella prima metà dell’Ottocento, ma sviluppatosi irresistibilmente soprattutto nella seconda, il Positivismo è un movimento culturale che, nato presso un gruppo elitario di intellettuali, tende sempre più a prendere piede presso la borghesia, a tal punto da caratterizzarsi come corrente di pensiero “di massa”; ma proprio quando comincerà a diventare un modo di pensare comune presso gli strati sociali più bassi, il popolo degli intellettuali l’avrà già abbandonato, preferendogli l’irrazionalismo e il decadentismo. Il paradosso di questa ambiguità culturale per cui le masse pensano in modo positivistico e gli intellettuali prediligono l’irrazionalismo verrà a galla nel concetto di razza, affermatosi prepotentemente nella seconda metà dell’Ottocento: si tenterà infatti di spiegare in modo assolutamente razionale (ricorrendo alla biologia) un qualcosa come la “razza” che, in realtà, sfugge ad ogni sorta di razionalità, e anzi si oppone ad essa. I tre eroi del pensiero positivistico sono il francese Auguste Comte (1798-1857) e gli inglesi John Stuart Mill (1806-1873) e Herbert Spencer (1820-1903): i Paesi d’origine sono particolarmente significativi se teniamo conto che l’uno è all’avanguardia sul piano industriale (l’Inghilterra) e l’altro sul piano dello sviluppo scientifico (la Francia) e il Positivismo altro non è se non la filosofia della rivoluzione industriale e della scienza. In particolare, nella Francia napoleonica era fiorita la scuola politecnica, caratterizzata da un orientamento spiccatamente tecnico-scientifico: in sostituzione alla Sorbona, che aveva il suo asse portante nell’insegnamento di teologia, era stata fondata l’Ecole normale e, in un secondo tempo, fu istituita l’Ecole politechnique, concernente le discipline fisiche. A testimonianza dei grandi successi ottenuti dalle scienze, si possono addurre parecchi esempi: il piemontese Joseph-Louis Lagrange (1736-1818) si era servito (in Meccanica analitica , del 1811) del calcolo infinitesimale per attuare una compiuta matematizzazione della meccanica, riformulando i concetti di velocità, accelerazione, forza e via discorrendo nei termini di derivate e integrali di funzioni; grandi conquiste furono anche realizzate da Joseph Fourier (1768-1830), il quale diede una formulazione matematica, attraverso equazioni e funzioni di coordinate spaziali e temporali, della propagazione del calore attraverso i corpi e il vuoto. La termodinamica, come calcolo della quantità di lavoro ottenibile da determinate quantità di calore, ricevette una sua prima formulazione da parte di Sadi Carnot (1796-1832), il quale individuò il presupposto del cosiddetto “primo principio della termodinamica”, ovvero il fatto che la trasformazione del calore in energia meccanica comporta una dispersione termica. Sul concetto di corrente elettrica come quantità misurabile, André-Marie Ampère (1775-1836) pose i fondamenti dell’elettrodinamica con la sua Teoria dei fenomeni elettrodinamici (1828). Particolarmente interessante e significativa, poi, è la figura di Pierre Simon de Laplace (1749-1827), il quale (in Esposizione del sistema del mondo , del 1796) elaborò, parallelamente a Kant, l’ipotesi dell’origine del sistema solare a partire da una nebulosa primitiva; alla base della sua cosmologia, basata sulla non-necessità di ricorrere all’ipotesi di un Dio che intervenga nel mondo, vi è una concezione rigidamente meccanicistica, secondo la quale ogni stato o evento dell’universo è conseguenza di stati ed eventi precedenti e, a sua volta, causa di quelli successivi; sicchè se si conoscesse lo stato di materia nell’universo in un dato momento, si potrebbero ricostruire meccanicamente tutti i momenti successivi e precedenti della materia. Ma Laplace è anche stato il fondatore moderno del calcolo probabilistico, il che sembrerebbe una contraddizione: come è possibile che, dopo aver sostenuto che tutto procede secondo il più rigido meccanicismo, egli ripieghi (in Teoria analitica delle probabilità , del 1812) su un calcolo basato non sulla certezza ma sulla probabilità? Tutto si spiega se teniamo presente che il meccanicismo e la conoscenza impeccabile che ne dovrebbe derivare funzionerebbe solo se fossimo dotati di una mente super-potente in grado di raccogliere e contenere tutti i dati possibili sullo stato della materia; ed è in assenza di questo strumento che bisogna accontentarsi non di verità inconfutabili, ma di probabilità. In altri termini, la necessità di formulare previsioni probabili dipende esclusivamente dall’ignoranza dei dati necessari per una previsione certa. Molto diverso sarà l’atteggiamento che assumerà su queste questioni il fisico novecentesco Heisenberg, il quale elaborò il “principio di indeterminazione”: esso prescrive che non si può calcolare contemporaneamente con precisione sia la posizione sia lo stato di movimento di una data particella. Ne consegue che se per Laplace tutto avviene in maniera rigorosamente meccanicistica ma si deve ricorrere al calcolo probabilistico perché non si hanno a disposizione strumenti adatti, per Heisenberg, invece, è assolutamente impossibile determinare insieme i due stati (posizione e movimento), indipendentemente dalle nostre facoltà. E Laplace, con la sua esasperata fiducia nel determinismo e nella scienza, rappresenta il modello positivistico e la formulazione più compiuta del meccanicismo come forma di conoscenza certa; è da queste considerazioni di carattere scientifico che muove i suoi passi il Positivismo, così battezzato da Comte (anche se il termine fu per la prima volta impiegato da Saint-Simon nel Catechismo degli industriali , del 1822). Il termine “Positivismo” viene con Comte a rivestire diversi significati, il che però non esclude la loro sostanziale convergenza: la polisemia del termine “positivo” non esprime altro che le differenti valenze, miranti tuttavia ad un unico scopo, del pensiero positivistico. In Discorso sullo spirito positivo (1844) Comte scrive che, nella sua accezione più antica e comune, “ la parola positivo designa il reale, in opposizione al chimerico ” , con la certezza (e per molti versi quasi l’illusione) che vi siano dati immediati assolutamente certi forniti dall’esperienza. Non a caso, il termine “positivo” deriva dal latino “ positum ”, participio passato del verbo porre e pertanto fa riferimento ai dati sensibili immediati, quelli contro i quali, nella Fenomenologia dello spirito , Hegel ci aveva messo in guardia, facendo notare come la certezza sensibile, ovvero il dato di fatto, se scavato un po’ più in profondità, è tutt’altro che una certezza. Quando percepisco una cosa, la mente non ha ancora cominciato a lavorarci sopra (e quindi non mi ha ancora potuto ingannare) e dunque parrebbe essere una vera e propria certezza. Tuttavia, fa notare Hegel, quando percepisco qualcosa, non posso ancora dire che percepisco una penna o una matita, ad esempio, ma devo limitarmi a dire che percepisco “un questo”, ovvero una singola cosa non meglio identificata: dire che percepisco una penna significa fare un passo avanti, significa inquadrare con l’intelletto quel qualcosa in una categoria. Potrò dire, per restare nella certezza sensibile, che percepisco “un questo” e nulla più: se ne evince che la conoscenza che in apparenza era la più solida ricca, si rivela invece, se meglio analizzata, esattamente il contrario, una vuota percezione. Ma i positivisti non sono affatto d’accordo con Hegel, e anzi vogliono porsi come recupero della scienza intellettuale illuministica, e non accettano la “banale” razionalità hegeliana. Nell’ambiente positivistico aleggia la convinzione che l’unico sapere valido sia quello scientifico e la scienza in questione è quella di matrice galileiana e newtoniana. Galileo stesso, del resto, aveva sottolineato come ci si dovesse occupare degli oggetti indagabili con certezza, rinunciando all’indagine di quegli aspetti della realtà non investigabili con altrettanto rigore: e i Positivisti, seguendo alla lettera l’insegnamento galileiano, dirigono le loro indagini sull’unico sapere certo possibile: la scienza, basata sui dati di fatto. Pertanto nel Positivismo è costante la fede (respinta da Hegel) nel dato di fatto, e proprio in virtù di questa fede si caratterizza per essere, in qualche misura, una filosofia un po’ ingenua e pronta ad accettare acriticamente il sapere scientifico. Ma il termine “positivo”, precisa Comte, designa anche il contrasto tra utile ed inutile: la filosofia positivistica, egli dice, deve essere volta “ al miglioramento continuo della nostra vera condizione, individuale o collettiva, invece che alla vana soddisfazione di una sterile curiosità ” . Con queste considerazioni, Comte riprende l’idea baconiana secondo cui “sapere è potere”, ovvero è del parere che un sapere, per essere degno di tale nome, debba dare certezze e che le uniche certezze conquistabili siano quelle della scienza (in questo, Comte rivela una certa adesione alle tesi cartesiane). Positivo, dunque, sarà anche ciò che è preciso e non vago: si dovranno pertanto rifiutare in modo sistematico tutti i concetti vaghi, che significano tutto e il contrario di tutto; ed era stato proprio Bacone stesso a mettere in luce come uno dei maggiori rischi per la conoscenza umana sia la vaghezza di certi termini del linguaggio comune. Infine, in una quinta accezione, il termine “positivo” viene da Comte contrapposto a quello “negativo”, facendo riferimento ad una forte valenza sociale: il compito fondamentale della filosofia, secondo il filosofo francese, è quello di organizzare la società e non di distruggerla, come credono altre correnti filosofiche. Anche in questo si può scorgere una netta antitesi rispetto all’hegelismo dilagante in quegli anni: se alcuni pensatori (Marx ed Engels) avevano reagito alle eccessive astrazioni di Hegel riducendo la dialettica ad un ambito meramente materiale, e altri (Schopenhauer in primo luogo) si erano opposti al panlogismo arrivando paradossalmente a negare ogni valore conoscitivo alla scienza, i Positivisti, dal canto loro, rivendicano il primato della scienza; il loro atteggiamento tende addirittura a sfumare nello “ scientismo ”, ossia nella convinzione che la scienza sia l’unico sapere valido. Naturalmente, non si tratta dell’atteggiamento scientifico di chi riconosce la fondamentale importanza della scienza, pur ammettendo altre forme di sapere: per i Positivisti l’unica forma di sapere è inequivocabilmente la scienza. Proprio in questo risiede l’opposizione positivistica a tutte le filosofie romantiche maturate in quegli anni e la forte simpatia per l’Illuminismo e per il suo interessamento per le conoscenze utili e precise. Tuttavia, vi è una differenza nettissima: sia l’Illuminismo sia il Positivismo sono espressioni filosofiche di quella borghesia tutta affaccendata nella produzione industriale e scientifica ( L’Enciclopedia degli illuministi si configurava, per molti aspetti, come una raccolta di dati tecini), tuttavia dal 5° significato (Positivo = organizzazione della società) del termine “Positivo” scaturisce l’inconciliabilità dei due movimenti. L’Illuminismo, infatti, era una filosofia radicalmente critica e rivoluzionaria, sempre pronta a mettere in discussione la società presente (e la Rivoluzione Francese ne è l’esempio lampante); viceversa, il Positivismo è funzionale alla società cui è contemporaneo, non vuole criticarla per guardare al futuro. Ecco perché Comte è, contemporaneamente, conservatore in politica e progressista sul piano scientifico: egli è il portavoce della borghesia del suo tempo, che dopo aver realizzato la sua rivoluzione, si era cristallizzata nel conservatorismo e nulla desiderava più del mantenimento delle forme politiche in vigore. In altri termini, tutte e due sono filosofie della borghesia, ma la borghesia del Settecento è, marxianamente, rivoluzionaria e interessata a spodestare l’aristocrazia, mentre la borghesia dell’Ottocento, realizzata quella rivoluzione tanto agognata e salita al potere, ha perso ogni spinta rivoluzionaria. E la condizione materiale della borghesia si riflette sulle filosofie che ne esprimono i valori: l’Illuminismo è rivoluzionario, il Positivismo è un illuminismo conservatore, che accetta acriticamente la società esistente (questo vale soprattutto per Comte). Merita di essere meglio analizzato il rapporto con le filosofie romantiche: quando Comte asserisce che il Positivismo è affermazione del reale in opposizione al chimerico, il chimerico in questione è proprio quello delle filosofie romantiche; tuttavia, nonostante l’accesa intenzione di distaccarserne, il Positivismo è pur sempre un figlio dell’era romantica e lo si può evincere dalla fede costante nell’Assoluto, inteso non come l’avevano inteso (in modo metafisico) Fichte, Schelling e Hegel; al contrario, l’Assoluto a cui aspirano i Positivisti è la scienza, che, non a caso, viene da loro assolutizzata e tende a scivolare nello scientismo che, come la religione, finisce per essere una fede. Resta da chiedersi quale posto occupi per i Positivisti la filosofia: avendo vivamente sostenuto che all’infuori della scienza non vi è vera conoscenza, pare che essi siano costretti dal loro stesso pensiero a sancire il rifiuto della filosofia in quanto sapere non scientifico. Il Positivismo in generale, sotto questo profilo, è una filosofia, per così dire, suicida, giacchè, nel proclamare la scienza unica forma di sapere, non fa altro che delegittimare il sapere filosofico. In realtà, quasi tutti i Positivisti, chi più e chi meno, riconoscono qualche campo di indagine alla disciplina filosofica (campo che varia da pensatore a pensatore), anche se, generalmente, si tratta di un margine piuttosto ristretto e subordinato alla scienza, di cui finisce per essere un completamento. Gli atteggiamenti adottati in merito dai Positivisti, sebbene piuttosto variegati, possono essere considerati tre. Il primo è quello proposto da Comte, secondo cui la filosofia altro non è se non una classificazione e una storia della scienza (ed è proprio ciò che egli fa nei suoi scritti), con l’inevitabile conseguenza che la filosofia si riduce ad epistemologia (studio della scienza e riflessione su di essa). E’ una concezione piuttosto riduttiva della filosofia, ma tuttavia si mantiene nell’alveo della tradizione platonico-aristotelica: ad esempio, se la matematica lavora coi numeri, spetta alla filosofia indagare sulla loro essenza. Del secondo atteggiamento è vessillifero John Stuart Mill: si tratta di un atteggiamento abbastanza simile a quello di Comte, ma comunque caratterizzato da una maggiore attenzione per i problemi logico-metodologici: la filosofia viene cioè ridotta a pura logica e metodologia, ovvero è tenuta a riflettere sui metodi e sulla logica dell’opera scientifica (e non è un caso che la principale opera di Mill si intitoli Logica ). Il terzo ed ultimo atteggiamento, proposto da Spencer, è quello che più di tutti dà peso alla filosofia, ma che tende anche di più a ridurla a scienza: in definitiva, per Spencer e per gli altri Positivisti che la pensano come lui, la filosofia è una specie di super-scienza; ciascuno di noi, infatti, ha le sue esperienze quotidiane e tende a generalizzarle per trarne delle regole di comportamento (e la scienza fa la stessa cosa, in maniera sistematica, per quel che riguarda la natura), ma poi, al di là delle leggi relativamente generali, è possibile individuare leggi generalissime che non valgono per un campo della realtà piuttosto che per un altro, ma, viceversa, valgono per tutta quanta la realtà. Proprio di queste leggi generalissime, valide per l’intera realtà, si occupa la filosofia. E proprio in virtù di questa concezione, Spencer e quelli del suo seguito tendono ad essere riduzionisti, ovvero a nutrire la convinzione che tutte le scienze siano riconducibile ad una sola scienza, la filosofia. Sono riduzionisti, in altre parole, perchè nutrono la convinzione che vi siano leggi generalissime valide per ogni realtà di cui le leggi studiate dalla scienza sono derivazioni particolari, come se, in ultima istanza, tutte le scienze fossero derivazioni particolari della super-scienza filosofia. La filosofia come la intendono questi pensatori , pertanto, svetta tra tutti i saperi, ma, qualitativamente, non è diversa dalle altre scienze. Con Spencer, poi, affiora l’elemento che forse più contraddistingue il Positivismo rispetto al razionalismo seicentesco e settecentesco: se è vero che in comune hanno il marcato interesse per le scienze (a tal punto da arrivare a considerarle spesso come unico sapere valido), tuttavia è diverso il tipo di scienza a cui fanno appello. Infatti, quando la filosofia prende come modello di indagine la scienza, tende sempre a scegliere quella più in voga al momento, cosicchè se ai suoi tempi Platone si era servito della scienza medica di matrice ippocratea, i filosofi del Seicento e del settecento, invece, avevano preferito la fisica matematizzata di stampo galileiano e newtoniano, e il “Discorso sul metodo” di Cartesio ne è una prova lampante, poichè il pensatore francese afferma esplicitamente di aver ravvisato nella matematica il vero modello conoscitivo. Spencer e i Positivisti, dal canto loro, vivono in un’epoca in cui sulla fisica newtoniana è prevalsa la biologia, maggiormente in sintonia con gli slanci vitalistici tipici dell’età romantica: ecco perchè, a differenza dell’Illuminismo e del razionalismo, il Positivismo sceglie la biologia e, in particolare, Spencer estende l’evoluzionismo biologico all’intera realtà. Finora abbiamo concentrato la nostra attenzione sul panorama positivistico francese; ma, come accennato, anche al di là della Manica la nuova corrente di pensiero andava sempre più affermandosi, tuttavia con un’enorme differenza: in Inghilterra il passaggio da Illuminismo a Positivismo è, più che da ogni altra parte, diretto. Certo, anche lì si era assistito al sorgere del movimento romantico, ma non in modo così radicale come sul continente: in tutta l’Europa continentale, infatti, il Romanticismo era nato come reazione all’illuminismo e al suo culto della ragione e, a sua volta, il Positivismo si era, hegelianamente, presentato come “negazione della negazione”, ossia come ripristino dell’Illuminismo ad un livello superiore (benchè, in realtà, l’Illuminismo fosse per molti aspetti, poc’anzi illustrati, superiore al Positivismo). Tutto ciò in Inghilterra è vero solo in parte, dove è come se dall’Illuminismo si saltasse direttamente al Positivismo, bruciando la tappa romantica. Questa continuità di pensiero che in Inghilterra lega le due età, quella dei lumi della ragione con quella dello scientismo, può anche essere scorta nelle vicende familiari di John Stuart Mill: suo padre, James Mill (1773-1836), vive a cavallo tra il Settecento e l’Ottoccento ed elabora una teoria della conoscenza come associazione di idee che inciderà in modo determinante sul pensiero del figlio. Un altro grande pensatore di quegli anni, Jeremy Bentham (1748-1832), dà una piena formulazione di quello che sarà uno dei capisaldi del Positivismo: l’ utilitarismo . Esso altro non è se non quella tesi etico-politica basata sull’idea che il fondamentale valore etico da perseguire sia la ricerca della felicità, intesa come somma dei piaceri; per raggiungerla, occorre effettuare, in una maniera che evoca l’antico epicureismo, un calcolo dei piaceri. Ma l’utilitarismo non implica puramente la ricerca del piacere immediato (ed è in questo che si distingue dall’edonismo), bensì sostiene la ricerca del piacere differito e, soprattutto, la felicità come somma di piaceri non viene intesa su un piano esclusivamente individuale, ma, al contrario, come felicità collettiva, destinata al maggior numero possibile di persone (quest’idea era vivissima anche nell’Illuminismo di Beccaria, ad esempio). In altre parole, si deve cercare di agire in maniera tale da promuovere la felicità massima per il maggior numero possibile di uomini ed è per questo che i sostenitori dell’utilitarismo si rifanno, oltrechè all’Illuminismo, al liberalismo. Si tratta però di un liberalismo concepito in maniera diversa da autore ad autore: il pastore anglicano Thomas Robert Malthus (1766-1834), dopo aver sostenuto, a seguito di una lucida analisi, il crescente divario in atto tra la crescita demografica e quella delle risorse per la sussistenza, si faceva portavoce di un liberalismo radicale e sfrenato, secondo cui ogni singolo individuo è e deve essere libero e privo di assistenza e solidarietà, in modo tale che a prevalere siano i più forti, a soccombere i più deboli. Negli stessi anni di Malthus, un altro celebre pensatore, David Ricardo (1772-1823), era in disaccordo con l’estremismo del pastore anglicano e metteva in forse le teorie eccessivamente liberiste di Adam Smith: “sarà poi vero che esiste quella mano invisibile (ipotizzata da Smith) che, anche se ciascuno persegue legittimamente i propri interessi personali, alla fine aiuta tutti?” sembra chiedersi Ricardo. Da ultimo, John Stuart Mill presenta il liberalismo sotto una luce più progressista (e più umana), pur senza accostarsi al socialismo (che anzi criticherà aspramente): Mill nutre, infatti, la convinzione che si debbano orientare il mercato e la società in una direzione che possa realizzare la maggiore felicità possibile per il maggior numero di uomini (e le tesi di Malthus non spingono certo in tale direzione). In altre parole, l’economia, secondo i dettami del liberismo più genuino, va lasciata al suo corso affinchè produca il più possibile; ma poi, in ambito politico, bisogna invece intervenire per realizzare una più equa distribuzione delle ricchezze.
L’EVOLUZIONISMO
Il grande impulso ricevuto dallo sviluppo delle scienze tra Sette e Ottocento non interessò soltanto le scienze esatte, come la matematica, la fisica, l’astronomia e la chimica, ma anche l’ambito delle scienze della vita: a questo sviluppo delle scienze naturali è strettamente connesso uno dei dibattiti scientifici che maggiormente influirono sulla cultura filosofica ottocentesca: la discussione sulla trasformazione della specie, ovvero il dibattito sull’evoluzionismo. E quando si parla di evoluzionismo, salta subito alla mente quello formulato da Darwin, ma in realtà si tratta di un qualcosa di più generale che investe anche la politica e la sociologia: infatti, l’idea dell’evoluzione delle cose nel tempo, per cui sopravvive solo ciò che è più adatto, ha molto influito sulle concezioni politiche del tempo, soprattutto in senso moderatore, poiché emerge la tesi secondo la quale anche nella società, così come nel mondo animale, vi sia una gradualità evolutiva che permette di giustificare il riformismo socialista. Ed è però anche vero che l’idea della selezione del più adatto ha molto inciso anche sulle concezioni politiche di colore opposto: soprattutto l’estrema Destra ha finito per cogliere nelle tesi evoluzionistiche una sorta di legge del diritto del più forte, per cui ha diritto a vivere solo chi si dimostra superiore agli altri. Dalla bislacca commistione delle tesi evoluzionistiche con quelle nietzscheane del superuomo, poi, nascerà un ibrido esplosivo che porterà molti pensatori schierati sull’estrema Destra a celebrare la guerra come strumento in grado di selezionare i “superuomini”. Sul versante comunista, invece, vi sarà chi vedrà evoluzionisticamente la classe operaia come la più adatta a sopravvivere e scorgerà nella rivoluzione il solo mezzo per realizzare la selezione. Ma che cosa si intende per “evoluzionismo”? Tale concetto si basa sulla convinzione che le specie viventi non siano immobili, ma in continua trasformazione nel tempo; opposta a questa teoria troviamo il “ fissismo ” , basato invece sulla convinzione che le specie siano sempre state così come oggi le vediamo. Sostenitore di questa tesi fu Aristotele, il quale concepì le specie animali come forme costitutive della realtà metafisica che, proprio perché strutture della realtà metafisica, non possono cambiare nel tempo. Oltre al fissismo, si contrappose all’evoluzionismo pure il “ creazionismo ”: esso si distingue dal fissismo poiché, a differenza di esso, non concepisce il mondo e le specie che lo animano come eterne; viceversa, i creazionisti credono, seguendo il verbo delle Sacre scritture, che Dio abbia creato il mondo (e che dunque esso non possa essere eterno) e le specie che lo abitano, le quali, diventando strutture della realtà, restano fisse. E nel corso della storia hanno nettamente dominato la tesi fissista (la tradizione aristotelica) e quella creazionista (il cristianesimo): solo in pochi hanno timidamente avanzato tesi evoluzionistiche e tra questi merita senz’altro di essere menzionato l’antico Anassimandro. Con la nuova temperie culturale, nell’Ottocento, il fissismo e il creazionismo entrano in crisi e si fa sempre più sentire l’ipotesi evoluzionistica: già Schelling aveva messo in luce l’esistenza di una sorta di gradualità della natura, la quale si articola secondo diversi livelli e gradini. In particolare, notava Schelling, vi è una sorta di scala per cui si procede dalle forme più semplici, meramente materiali, e ci si innalza sempre più verso forme gradualmente complesse e spirituali, fino ad arrivare all’uomo. Tuttavia, questo processo restava per Schelling puramente logico e atemporale. Un altro padre del tutto involontario dell’evoluzionismo è Linneo (1707-1778), che nel Settecento ha inventato la “tassonomia” ossia la tecnica di classificazione delle classi viventi, prospettando una parentela fra le specie. Pur essendo rigorosamente fissista, egli riteneva che le specie fossero in qualche modo imparentate fra loro, a tal punto da poter ipotizzare un gigantesco clan familiare delle specie: comincia ad affiorare, seppur implicitamente, l’idea che ci debba essere un antenato comune a tutte le specie. Fu poi il francese Buffon a prospettare apertamente l’evoluzionismo. E’ poi bene ricordare l’accesa disputa sull’embriologia divampata tra coloro che sostenevano la preformazione e coloro che invece difendevano l’epigenesi: i primi erano del parere che l’embrione fosse già, in sostanza, come l’animale sviluppato, anche se infinitamente più piccolo; a loro avviso, l’embrione del cavallo altro non era se non un cavallo minuscolo che si sarebbe poi ingrandito. Secondo i sostenitori dell’epigenesi, invece, nel corso dello sviluppo embrionale si passa da un tipo di forma ad un altro, cosicchè è scorretto affermare che l’embrione del cavallo è un cavallo minuscolo; viceversa, esso non è ancora un cavallo, è un’altra forma. La tesi epigenetica, risultata vera, non è di per sé evoluzionistica, ma tuttavia innesta nello studio della biologia un’idea di trasformazione, anche se all’interno dell’individuo singolo e non delle specie. Negli anni a venire si scoprì che l’ontogenesi ricalca la filogenesi, ovvero che il processo di formazione embrionale (ontogenesi) riproduce, per sommi capi, la generazione della specie (filogenesi): il che significa esattamente che esistono fasi in cui ciascuno di noi, in embrione, è più vicino ad un pesce che non ad un uomo, quasi come se stesse ripercorrendo in sé le grandi tappe dell’evoluzione della specie. Sempre in quegli anni si sviluppò un vivace dibattito inerente alla geologia: se si ipotizza l’evoluzione delle specie, si è costretti ad ammettere che essa avvenga in tempi molto lunghi, poiché la storia umana (dal paleolitico fino ad oggi) non attesta esempi di evoluzione. Infatti, da 2500 anni, per quanto ci è testimoniato, non abbiamo notizia di cambiamento alcuno e pertanto si deve ammettere che l’evoluzione avvenga in tempi estremamente lunghi. Ciò, tuttavia, era in contrasto con i Testi Sacri, secondo cui il mondo sarebbe stato creato da Dio 4004 anni prima della nascita di Cristo: l’evoluzione sembrava dunque impossibile, a meno che non si fosse messa in dubbio la veridicità dei Testi Sacri. Anche di fronte alla scoperta dei fossili nascevano comportamenti e interpretazioni ambigue: c’era chi, sulle orme di Aristotele, concepiva le conchiglie fossilizzate come errore di riproduzione dei pesci e non come esseri viventi rimasti intrappolati; vi era poi anche chi, pur riconoscendo che si trattasse di forme animali, sosteneva che fossero animali non ancora scoperti e un’ancora di salvezza era rappresentata dal diluvio universale, che permetteva di dire che, nonostante Dio avesse creato tutte le specie animali, molte di esse non eran riuscite a salire sull’arca di Noè e per questo eran sparite. Relativamente alla questione dei fossili, è molto interessante il dibattito intrapreso tra i trasformisti e i catastrofisti nel tentativo di spiegare la conformazione geologica della terra: secondo la tesi catastrofica, le imponenti modifiche che hanno coinvolto il nostro pianeta sono dovute a catastrofi naturali avvenute in un lasso di tempo assai ristretto; il che permette di spiegare il verificarsi delle trasformazioni in piena sintonia con i tempi riconosciuti dai Testi Sacri. L’ipotesi trasformista, invece, sostiene che la terra si è trasformata gradualmente e non concepisce le montagne come frutto di una catastrofe momentanea (come fa invece l’ipotesi catastrofica), ma come il risultato di un lento processo avvenuto, in condizioni tranquille, nel corso di millenni. Sempre i trasformisti settecenteschi (tra cui ricordiamo Buffon, Maupertuis, La Mettrie, Holbach, Diderot) erano del parere che gli esseri viventi avessero subito un processo di progressiva modificazione. Le posizioni dei trasformisti offrirono un notevole supporto alle tesi evoluzionistiche, come del resto lo offrì pure la nascita dell’anatomia comparata. Essa cominciava a scoprire che anche animali diversissimi tra loro presentano analogie ragguardevoli: mettendo a confronto un uomo ed un uccello, si può notare come, pur essendo radicalmente differente la struttura anatomica, esistano strutture di fondo analoghe come, per esempio, le braccia e le ali. Si intuisce facilmente come l’anatomia comparata abbia aperto spiragli verso l’evoluzionismo: in particolare, essa è una riproposizione della teoria di Goethe secondo la quale esisterebbe un essere comune di cui tutti gli altri sono derivati. Con tutte queste considerazioni sulle spalle, il primo a dare una formulazione organica dell’evoluzionismo fu Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829), autore di una “Filosofia zoologica” (1809). Ciò che distingue l’evoluzionismo lamarckiano da quello darwiniano sono, essenzialmente, i diversi meccanismi secondo cui esso avverrebbe secondo i due pensatori: in particolare, Lamarck basa la propria teoria sui concetti di uso e non-uso. A suo avviso, le giraffe si sarebbero evolute da animali a loro simili ma aventi il collo normale; in altri termini, un tempo le giraffe non avrebbero avuto il collo lungo, ma poi, in virtù di una modificazione ambientale, gli alberi sarebbero diventati più alti e per potersi cibare delle foglie le giraffe dovevano sforzarsi allungando il collo: esso sarebbe stato sottoposto ad un graduale allungamento dovuto all’uso e tale trasformazione si sarebbe trasferita, per via ereditaria, di generazione in generazione. Secondo la teoria lamarckiana, sono gli animali a doversi adattare all’ambiente compiendo sforzi immani: tuttavia il punto debole del ragionamento di Lamarck consiste nel fatto che l’esperienza insegna che i caratteri acquisiti (come l’allungamento del collo) non si possono trasmettere ereditariamente, per cui se la giraffa, a furia di sforzare il collo, lo allunga, ciononostante i suoi figli nasceranno col collo normale, proprio come un uomo che abbia acquisito una massa muscolare ingente non potrà trasmetterla ereditariamente al figlio. E’ curioso notare come nell’Unione Sovietica fu adottata una forma di neo-lamarckismo e venne respinto il darwinismo: l’idea dello sforzo per adattarsi all’ambiente suggeriva una maggiore dignità dell’individuo che si deve adattare all’ambiente senza viverlo passivamente. L’evoluzionismo di Charles Darwin (1809-1882) infatti, pur identico nella sostanza, si differenzia da quello lamarckiano nelle modalità in cui avviene: non vi è assolutamente lo sforzo (ipotizzato da Lamarck) per adattarsi all’ambiente. Darwin ebbe un’intensa esperienza di naturalista girando per il mondo e potè notare come certi uccelli molto simili fra loro avevano sviluppato caratteristiche molto diverse (ad esempio, il becco adatto per nutrirsi di determinati insetti presenti nell’ambiente in cui vivevano) a seconda dei contesti ambientali in cui vivevano. Sul piano teorico, poi, egli sapeva che molti allevatori riescono ad ottenere, attraverso un processo di selezione, delle razze nuove; inoltre, aveva sotto gli occhi le teorie elaborate da Malthus secondo cui le risorse ambientali sono limitate e per ciò nasce una lotta per la sopravvivenza che dà la meglio ai più adatti. E grazie a queste tre considerazioni (selezione, lotta, uccelli con modificazioni funzionali al loro modo di vivere) diede la sua celebre formulazione dell’evoluzionismo, sostenendo che le specie evolvono non per adattamento all’ambiente (non è cioè l’ambiente che le stimola ad adattarsi, come credeva Lamarck), ma per selezione: l’ambiente seleziona gli individui più adatti ed elimina quelli inadatti; così la giraffa col collo corto, inadatta a cibarsi delle foglie poste in alto, e la gazzella lenta, facile preda del leone, non ce la fanno a sopravvivere e hanno la meglio le giraffe col collo lungo e le gazzelle veloci. Non è che, in virtù dell’uso, il collo della giraffa si allunga o le gambe della gazzella diventano veloci e nasceranno gazzelle più veloci e giraffe col collo più lungo; viceversa, per errori casuali di copiatura del DNA nascono giraffe con il collo più lungo delle altre e si rivelano più adatte per la sopravvivenza, per cui si riproducono e nascono nuove giraffe col collo lungo, mentre quelle dal collo corto tendono ad essere spazzate via dalla selezione. Naturalmente Darwin non aveva ancora queste nozioni di genetica e si limitava perciò a parlare “errori” per via dei quali gli individui non nascono del tutto identici ai genitori: questi “errori”, che, nella stragrande maggioranza dei casi, sono dannosi, talvolta possono anche rivelarsi utili, come nel caso del collo lungo delle giraffe. Se lo slancio ipotizzato da Lamarck per adattarsi all’ambiente era di forte sapore romantico, il discorso di Darwin si inserisce pienamente nel quadro positivistico e materialista: infatti, nell’evoluzione darwiniana non vi è nulla di finalistico e, a rigore, non si dovrebbe nemmeno parlare di “evoluzionismo”, giacchè tale nozione presuppone che gli individui cambino in meglio, come se dovessero realizzare un fine. Al contrario, secondo Darwin, si tratta di una forma di selezione assolutamente necessaria e meccanica, indipendente da ogni forma di intelligenza della natura: se nel caso degli allevatori, la selezione avveniva in base alla volontà degli allevatori stessi, nel caso della natura, invece, non si muove verso fini prestabiliti ma secondo una meccanicità rigorosa. Darwin riprende le tesi di Malthus, ma non si sbilancia sul terreno sociale: si limita a parlare di evoluzione biologica, di animali e dell’uomo come animale, tant’è che fu messo alla berlina dalla Chiesa perché faceva derivare l’uomo dalla scimmia (“ nella sua arroganza l’uomo attribuisce la propria origine a un piano divino;io credo più umile e verosimile vederci creati dagli animali ” egli disse). Quando poi il darwinismo sarà impiegato come chiave di lettura della società darà vita al darwinismo sociale, anche grazie alla mediazione di Spencer, il quale arriverà ad estendere il discorso di Darwin all’intera realtà. A cavallo tra Ottocento e Novecento un cattolico, Teilhard de Chardin, interpretò la prospettiva evoluzionistica come processo governato da Dio, dando vita ad una specie di “evoluzionismo finalistico” che però non fu accettato dalla Chiesa (che anzi lo condannò severamente). Sarà invece Bergson ad accettare (con il concetto di “evoluzione creatrice”) l’evoluzionismo e a depurarlo dagli elementi di meccanicismo e anche da quelli finalistici. Una domanda curiosa che sorge spontanea è se l’evoluzionismo sia una dottrina scientifica: nel Novecento c’è stato chi ha detto che una teoria, per essere scientifica, deve essere verificabile e chi, come Popper, ha invece sostenuto che deve essere falsificabile; ma la cosa curiosa è che l’evoluzionismo non è così facilmente verificabile o falsificabile (ed è su questo che fanno ancora oggi leva i suoi oppositori) come possono esserlo le leggi individuate da Galileo. La paleontologia dovrebbe gettar luce in merito, ma nella maggior parte dei casi non ci riesce per via dell’incredibile difficoltà che implica la ricostruzione dell’albero genealogico. E poi vi è un aspetto teorico imprescindibile: oltre all’evoluzione per cui la giraffa si trova oggi ad avere il collo lungo, vi è anche un evoluzionismo più complesso, detto “macroevoluzionismo”, con il quale un organo che aveva una determinata funzione è passato, nel tempo, a svolgere mansioni di tutt’altro genere. Classico esempio di macroevoluzionismo è il passaggio da pesci ad esseri dotati di polmoni: i polmoni non derivano dalle branchie e perchè mai, del resto, una mutazione di tal genere dovrebbe essere selezionata? E’ forse utile? Le possibili risposte sono due: o si riconosce che le mutazioni non avvengono così gradualmente come sempre si è pensato, ma, viceversa, sono piuttosto rapide; oppure si ammette il finalismo e si riconosce che le fasi intermedie dell’evoluzionismo possano anche essere dannose, ma comunque in vista del risultato finale a cui si mira.
E’ curioso che, proprio quando Hegel riteneva di aver chiuso definitivamente la storia del pensiero ( la nottola di Minerva inizia il suo volo soltanto sul far del crepuscolo ) sostenendo che con l’autotrasparenza della realtà attuata nella sua filosofia terminasse la filosofia stessa e cominciasse la sofia, fioriscano ben tre correnti diverse che riaprono da capo il discorso che Hegel riteneva chiuso. Karl Löwith, nell’opera ” Da Hegel a Nietzsche. La frattura rivoluzionaria nel pensiero del XIX secolo ” ha scorto nella filosofia che da Hegel giunge fino a Nietzsche e alla fine dell’Ottocento un processo rivoluzionario e di “rottura”; tuttavia, dice Löwith, se è vero che dalla filosofia di Hegel muoveranno i loro passi filosofi che prenderanno le distanze dal “maestro” ed elaboreranno pensieri tra loro opposti, è anche vero che in questo processo di frattura rivoluzionaria vi è un filone unitario, che accomuna i vari pensatori. Il fatto stesso che per tutti questi filosofi Hegel resti il punto di riferimento avvalora la tesi di Löwith: infatti, per i Positivisti e per gli “irrazionalisti” Hegel costituisce (per motivi opposti) un bersaglio contro cui scoccare i propri dardi velenosi, mentre per gli hegeliani alla Marx, il filosofo del Sistema resta un maestro a cui ispirarsi, un maestro di cui si può magari anche compiere il parricidio, come aveva fatto Platone con Parmenide, ma non è questo ciò che conta. Affiora bene, in sostanza, come Hegel resti al centro della riflessione filosofica a lui successiva: anche per chi lo rifiuta e lo disprezza cordialmente, egli resta pur sempre l’idolo negativo combattendo il quale si costruisce la propria filosofia. Si può poi ravvisare un elemento di unitarietà, oltre che nel fatto che Hegel resti il punto costante di riferimento, anche nel senso della concretezza che pervade le filosofie tra loro opposte di questi pensatori. Se nella terminologia hegeliana, per “concretezza” si doveva intendere il privilegiamento per il saper cogliere le cose nelle loro relazioni reciproche, cosicchè il pensiero era più concreto della materia, la ragione più dell’intelletto, ora tale termine si colora di un nuovo significato, al quale anche noi siamo abituati: e così, paradossalmente, tutti i pensatori successivi ad Hegel possono accusarlo di “astrattezza”, quasi come se leggendo Hegel si avesse l’impressione che egli non stesse parlando di cose reali. Il termine “astratto” passa cioè a designare ciò che è sganciato dalla realtà, ciò che non è “concreto”. E’ quasi come se si attuasse un capovolgimento dialettico dei termini, per cui l’accusa infamante di “astrattismo” che Hegel muoveva all’Illuminismo, ora si ritorce contro di lui, seppur in una nuova accezione. Per citare degli esempi, in Marx “concretezza” vorrà dire che, pur accettando egli la dialettica hegeliana, la criticherà per il fatti di poggiare ” sulla testa “, cioè sulle idee: si tratta pertanto, dice Marx, di mantenerla valida così come è, rigirandola però in modo tale che poggi non sulla testa, ma sui piedi, ovvero sulle condizioni materiali ed economiche; ne scaturirà un processo dialettico che non si realizzerà astrattamente sulle pagine dei libri, come l’aveva inteso Hegel, ma, al contrario, si svolgerà concretamente e in modo rivoluzionario sulle piazze. Discorso simile sul versante positivistico, dove si esalta la concretezza del sapere scientifico e del dato di fatto ( ecco perchè “Positivismo”: dal latino positum , “ciò che è posto”, ovvero il dato di fatto); si tratta di una contrapposizione netta al pensiero di Hegel, il quale, nella Fenomenologia dello spirito , aveva posto il dato di fatto ( da lui definito certezza sensibile ) al gradino più basso. Anche tra gli irrazionalisti serpeggia l’aspirazione alla concretezza e, per addurre un esempio, Schopenhauer insiste sul fatto che l’uomo non è ” una pura testa alata d’angelo “, cioè non è puro spirito disincarnato, ma è essenzialmente un corpo e la natura di tale corpo consiste, soprattutto, nella volontà, nei desideri, negli istinti e nelle passioni, quelle cose, cioè, che Freud avrebbe più tardi definito come “pulsioni”; da notare che la rivendicazione che Schopenhauer fa della concretezza è in antitesi all’astrattezza hegeliana, come pure alla ragione, tanto cara ai Positivisti. Anche Feuerbach rivendica la matrice materiale e “concreta” dell’uomo, arrivando a sostenere che ” l’uomo è ciò che mangia “, facendosi latore di un materialismo di rottura, per alcuni versi molto provocatorio. Nel caso di Kierkegaard (che rimprovera a se stesso la sua breve adesione iniziale alla filosofia di Hegel dicendo ” Io, stupido hegeliano! “), poi, la ricerca esasperata della concretezza tenderà a manifestarsi come rivendicazione dell’esistenza singola: in Hegel si ha sempre l’impressione che, anche quando parla dell’uomo, in realtà non stia parlando di noi, sostiene Kierkegaard; da qui emerge il suo interesse per l’io come singolo, ovvero per l’io concreto, sganciato dalla nebulosa astrattezza in cui l’aveva avvolto Hegel. Del resto, osserva Kierkegaard, checchè ne pensi Hegel, noi siamo nel mondo come singoli, ancor prima che come umanità e spirito. Ed è con queste riflessioni maturate in Kierkegaard che comincia ad affiorare, seppur timidamente, il netto contrasto tra la concretezza dell’esistenza (l’io singolo) e l’astrattezza dell’essenza (l’umanità, lo spirito), contrasto già prospettato da Pascal e destinato a diventare centrale nella filosofia del Novecento con l’Esistenzialismo. Si può poi fare un breve cenno a Nietzsche, il quale in gioventù aderì alle tesi di Schopenhauer e, anche quando se ne distaccò, mantenne con esse un forte legame: infatti, il perno della sua filosofia è la volontà (concetto tipicamente schopenhaueriano) abbinata alla vitalità, contrapposte duramente al pensiero e, più in generale, alla ragione. Sempre Nietzsche rivendica anche quell’individualità già sostenuta da Kierkegaard: ed è per questo che Nietzsche è l’ultimo anello della catena che sancisce la frattura col pensiero di Hegel e, al tempo stesso, la sintesi delle concezioni più disparate emerse nel periodo post-hegeliano. Egli, da un lato, critica l’astratto in favore del concreto, salutando con entusiasmo la vitalità e la volontà di Schopenhauer (da lui cambiata nell’essenza e ribattezzata “volontà di potenza”), dall’altro lato pone l’accento sul problema dell’individuo sollevato da Kierkegaard, portandolo alle estreme conseguenze ed elaborando il mito del superuomo (con una bislacca commistione di elementi darwiniani). Tutte le riflessioni dei pensatori a lui precedenti, convivono in Nietzsche (spesso dando ibridi esplosivi quali il superuomo o la volontà di potenza) sotto un unico denominatore: la vitalità, il ” ritorno alla terra” che egli caldeggia così spesso nei suoi scritti, contrapponendosi bruscamente all’astrattismo hegeliano. Tuttavia, oltre agli aspetti che in qualche modo legano tra loro questi pensatori post-hegeliani, bisogna saper anche cogliere le numerose differenze che li separano: per dirne una, se Kierkegaard rivendica la concretezza come individualità, Marx, invece, molto più hegelianamente, la rivendica come umanità, come classe sociale. Sarebbe pertanto sbagliato ritenere che questi pensatori abbiano concezioni del tutto uguali tra loro; come sarebbe anche sbagliato illudersi che le loro filosofie maturino tutte dopo la morte di Hegel. In realtà, alcuni di questi filosofi cominciano ad elaborare le loro filosofie mentre Hegel è ancora in vita. La prova lampante di ciò è data da Scopenhauer, il quale compone la sua opera più famosa ( Il mondo come volontà e rappresentazione ) nel 1819, in un clima di pieno trionfo dell’hegelismo: ed è sintomatico il fatto che le idee di Schopenhauer hanno fatto breccia presso il pubblico solo dopo la morte di Hegel, tant’è che la prima edizione de Il mondo (composta quando Hegel era ancora in vita) andò al macero. Si può, tra l’altro, ricordare come Schopenhauer desiderasse tenere le sue lezioni universitarie in contemporanea ad Hegel, ma tuttavia non potè farlo per il semplice motivo che non aveva studenti: tutti, infatti, andavano ad ascoltare con entusiasmo Hegel, non tenendo in alcuna considerazione Schopenhauer.
SAINT-SIMON

Claude-Henri de Rouvroy de Saint-Simon (1760-1825) é uno dei cosiddetti “socialisti utopistici”, come li definì Marx, per contrapporli al suo “socialismo scientifico”; i socialisti utopistici, infatti, non prevedevano il raggiungimento dei loro obiettivi sociali con la rivoluzione (come sosterrà invece il socialismo scientifico di Marx), bensì progettavano a tavolino delle società utopiche e le presentavano ai ceti dominanti, sperando che essi volessero metterle in atto: ovviamente si tratta solo di un’utopia, in quanto le classi dominanti non concederanno mai quanto richiesto da questi socialisti; tuttavia il motivo per cui questo socialisti non penseranno ad un’azione rivoluzionaria, come farà invece Marx, é piuttosto semplice: a quei tempi stava appena nascendo e non aveva ancora preso piena coscienza di sè l’attore principale della rivoluzione prevista da Marx: il proletariato. Saint-Simon nacque a Parigi da nobile famiglia e, dopo aver partecipato alla guerra d’indipendenza americana e alla rivoluzione del 1789, costituì una società d’affari con il conte di Redern, si arricchì, ma successivamente sperperò i suoi beni viaggiando per l’Europa. Ormai in povertà, iniziò a comporre scritti in cui formulò i suoi progetti di riorganizzazione della società. Nelle Lettere di un abitante di Ginevra ai suoi contemporanei , pubblicate nel 1803, enunciò la tesi che le rivoluzioni scientifiche sono la causa di quelle politiche e presentò un progetto di governo dell’umanità affidato a scienziati liberamente eletti. Successivamente, nell’ Abbozzo di una nuova enciclopedia (1810) sostenne che l’Enciclopedia di Diderot e d’Alembert aveva distrutto il sapere proprio dell’epoca teologico-feudale, mentre una nuova enciclopedia sarebbe stata alla base della nuova società fondata sull’industria . A delineare i tratti di questa nuova società dedicò le sue opere successive, tra le quali Il sistema industriale (1821-1822) e il Catechismo degli industriali (1823). Secondo Saint-Simon la Rivoluzione francese ha seppellito il vecchio mondo dato che ha rappresentato un’ epoca critica che ha comportato la dissoluzione della precedente epoca organica , fondata sul sapere teologico e organizzata su basi feudali. La crisi é foriera non di morte, ma di salute, ovvero prepara il terreno alla costituzione di una nuova epoca organica, fondata su un corpo sistematico di credenze, diverso da quello che reggeva l’antica società: infatti il suo nucleo non può più essere fornito dalla religione; per riorganizzare la società, al posto della fede, deve subentrare la scienza . La società del passato trovava la sua legittimazione in un sistema di credenze teologiche, di cui era portatrice la classe che deteneva il potere spirituale: il clero. La società moderna é invece caratterizzata da un nuovo elemento, l’industria, sorta dal progresso scientifico e dalle sue applicazioni tecniche. Nella nuova epoca industriale, il cui scopo sono le attività produttive, la posizione che nelle precedenti società aristocratiche, fondate sulla guerra, era occupata dalla nobiltà feudale, é ora assunta dalle nuove classi produttive. Saint-Simon a tal proposito conduce un’aspra critica contro le vecchie classi oziose e parassitarie (clero, nobiltà, esercito), paragonate ai fuchi dell’alveare contrapposti alle api operose. Inoltre, va notato che per industria Saint-Simon intende qualsiasi attività produttiva e, pertanto, non solamente la manifattura, ma anche il commercio e l’agricoltura. Nella nuova epoca il potere temporale é destinato a passare nelle mani della nuova classe degli industriali, i quali essendosi mostrati capaci di dirigere la produzione nei vari settori ed essendo i legittimi rappresentanti degli interessi di tutte le classi produttrici, devono anche assumere la direzione della vita pubblica, in virtù di un potere fondato non sulla costrizione, ma sul consenso. Infatti, tra i membri delle classi produttive, Saint-Simon colloca anche gli scienziati (riprendendo in parte le teorie di Francesco Bacone), costruttori e portatori del nuovo sistema di credenze fondato sui metodi e sui risultati delle scienze positive: nelle loro mani é ora il potere spirituale, detenuto in precedenza dal clero parassitario. Ma la scienza é, per sua stessa costituzione, universale e pacifica, cosicchè la nuova società industriale fondata su di essa avrà anch’essa i caratteri dell’universalità, ossia sarà propria dell’umanità intera e sarà contrassegnata dalla coesistenza di ordine e di progresso, ovvero da una forma di progresso pacifico , senza violente fratture rivoluzionarie. Saint-Simon negava dunque al conflitto una funzione positiva e permanente all’interno della società, considerandolo soltanto un aspetto transitorio dello sviluppo storico, e faceva proprio un modello organico di società, contemporaneamente teorizzato da Maistre e da Bonald. Anche per lui si trattava di restaurare l’ordine sociale frantumato dalla rivoluzione, tornando a una forma di solidarietà reciproca e, insieme, gerarchica fra tutti i membri del corpo sociale, legittimata da un sistema di credenze condivise da tutti. Ma mentre per Maistre e Bonald il modello era dato dalla società organica medioevale, caratterizzata da una comune fede religiosa e da un’unica autorità suprema, il papa, capo della Chiesa, per Saint-Simon la scienza e l’industria erano destinate ad essere le nuove depositarie del potere temporale e spirituale. Si trattava però di un processo non ancora giunto a compimento, cosicchè diventava necessaria la costituzione di un partito industriale che operasse in vista della definitiva affermazione della società industriale, organizzata sulla base del sapere scientifico, inarrestabile e inattaccabile da crisi o conflitti. Ma nel tratteggiare la sua società tecnocratica, Saint-Simon commette un grave errore: egli infatti si scaglia contro i ceti parassitari e sostiene che la società debba essere amministrata dagli “industriali”, ovvero dagli imprenditori e dai lavoratori, senza differenza: Saint-Simon non vede quello scontro di classe tra proletariato e borghesia che sta alla base della società moderna e che Marx vedrà benissimo. Nell’ultima fase della sua attività, specialmente con Il nuovo cristianesimo (1825), Saint-Simon darà un’accentuazione religiosa alle sue teorie, interpretate come un ritorno al vero cristianesimo, fondato sull’amore del prossimo e particolarmente attento alla sorte delle classi meno abbienti. Era in qualche modo necessario competere con i forti appelli alla religione che provenivano dai pensatori tradizionalisti. Su questa linea, prettamente religiosa, ispirata ad una religione dell’umanità più che del singolo, si sarebbero mossi alcuni seguaci di Saint-Simon, soprattutto Barthélémy-Prosper Enfantin (1796-1866), che avrebbe organizzato addirittura una sorta di chiesa sansimoniana, con i suoi riti e una propria gerarchia. Ma il sansimonismo penetrò profondamente in Francia anche nella mentalità dei nuovi ceti imprenditoriali e finanziari, influendo così sulla costruzione di banche e sui progetti di costruzione di ferrovie e dei canali di Suez e di Panama.
CHARLES FOURIER

Anche Charles Fourier (1772-1837), insieme a Saint Simon e a Owen, é uno dei cosiddetti “socialisti utopistici”, come li definì Marx, per contrapporli al suo “socialismo scientifico”; i socialisti utopistici, infatti, non prevedevano il raggiungimento dei loro obiettivi sociali con la rivoluzione (come sosterrà invece il socialismo scientifico di Marx), bensì progettavano a tavolino delle società utopiche e le presentavano ai ceti dominanti, sperando che essi volessero metterle in atto: ovviamente si tratta solo di un’utopia, in quanto le classi dominanti non concederanno mai quanto richiesto da questi socialisti; tuttavia il motivo per cui questo socialisti non penseranno ad un’azione rivoluzionaria, come farà invece Marx, é piuttosto semplice: a quei tempi stava appena nascendo e non aveva ancora preso piena coscienza di sè l’attore principale della rivoluzione prevista da Marx: il proletariato. L’obiettivo perseguito da Charles Fourier é la riorganizzazione della società su nuove basi; queste nuove basi però non devono essere date dalla scienza, come riteneva Saint-Simon, quanto nelle passioni umane. Nato a Besancon nel 1772, rimasto presto orfano, per sopravvivere fu costretto ad impiegarsi in banca e in seguito a fare il commesso viaggiatore, l’agente di borsa e il dipendente di una ditta americana. Nel 1808 pubblicò anonima la Teoria dei quattro movimenti , che passò pressochè inosservata, e solamente nel 1822 fece comparire un secondo scritto, il Trattato dell’associazione domestica agricola , che nel 1842 sarà riedito con altri scritti sotto il titolo complessivo Teoria dell’unità universale . Nel 1825 intorno a Fourier si costituì un primo nucleo di seguaci, il più noto dei quali é Victor Considérant; l’anno seguente Fourier si stabilì definitivamente a Parigi e nel 1829 pubblicò Il nuovo mondo industriale e socioetario, o invenzione del procedimento d’industria attraente e naturale distribuita in serie passionali . Nel 1832-1834 il movimento fourierista fece apparire la rivista “Il Falansterio o la riforma industriale” , poi continuata con “La Falange” (1836-1840) , il cui motto era ” riforma sociale senza rivoluzione “. I seguaci di Fourier tentarono l’esperimento di organizzare un falansterio , ma esso fallì anche per mancanza di mezzi e Fourier, sempre più in disaccordo con essi, lo sconfessò. Il ragionamento di Fourier parte dalla constatazione che la società del suo tempo é un mondo capovolto ; infatti in essa l’ordine naturale delle cose é rovesciato, visto che vi regnano la miseria e la frode. Fourier ne trova la conferma evidente nel fatto che in un ristorante a Parigi una mela vale cento volte più che in Normandia. Rispetto a questa degenerazione prodotta dalla civiltà, la natura rappresenta, come già era avvenuto in Rousseau, il polo positivo, ma per Fourier ciò significa che sono buone tutte le passioni e le inclinazioni proprie della natura umana: esse devono pertanto essere assecondate e soddisfatte, mentre finora sono state considerate cattive e quindi da reprimere. Ma se le passioni non possono essere mutate, perchè sono quelle che sono, può essere mutato il loro orientamento, in modo da farne nascere l’ armonia generale dell’umanità. Il meccanismo che consente di raggiungere questo obiettivo é ravvisato da Fourier nella legge dell’attrazione universale , scoperta nel secolo precedente da Newton: il problema é ora di estendere questa legge all’intero mondo umano. Le passioni fondamentali sono l’amore per la ricchezza e l’amore per i piaceri; non a caso sono esse le passioni finora regolarmente represse dalla società. Se si desidera raggiungere un’organizzazione armonica della società, bisogna allora far leva su queste due passioni, anzichè reprimerle. Si tratta quindi di modificare le sfere del lavoro e dei rapporti sessuali, pertinenti ad esse. A parere di Fourier infatti sarà possibile aumentare la produttività del lavoro tramite l’ attrazione passionale , ossia l’impulso naturale tendente al piacere dei sensi nonostante l’opposizione dei doveri e dei pregiudizi. Il lavoro dovrà dunque essere suddiviso in funzioni differenti esercitate da individui differenti secondo i loro gusti, ossia le loro attrazioni passionali, e si dovranno formare gruppi in cui le passioni individuali siano armonizzate tra loro, in modo da evitare ogni conflitto e favorire al tempo stesso l’emulazione e la cooperazione. Le serie passionali così armonizzate troveranno applicazione nelle funzioni industriali , cioè nel lavoro domestico, agricolo, manufatturiero, commerciale, nonchè nell’insegnamento e nello studio. La passione più importante é il bisogno di varietà : saranno quindi necessari turni brevi di lavoro, per evitare che si cada nella noia, frequenti passaggi all’esercizio di funzioni differenti e mobilità da un gruppo all’altro; in tal modo, diversamente da quanto avviene nell’industria attuale, dove la varietà é repressa e il lavoro é uniforme, potrà costituirsi un’ industria attraente , capace di garantire il massimo della produttività. Su questa base si formeranno le falangi , ovvero gruppi di circa 1800 persone di entrambi i sessi, le quali vivono in falansteri economicamente e socialmente autosufficienti, anche se collegati tra loro: questi falansteri sono contemporaneamente abitazioni collettive, luoghi di lavoro e divertimento, circondati da aree coltivabili e foreste. In tal modo, l’utopia di Fourier arriva ad immaginare nuove forme di architettura e di urbanistica. Inoltre nei falansteri potrà trovare finalmente compimento la liberazione sessuale , sinora repressa attraverso l’affermazione del predominio maschile sulla donna e l’istituzione della famiglia monogamica : anche sul piano sessuale la regola sarà offerta dalla legge dell’attrazione, e si dovranno seguire le passioni: saranno dunque ammessi rapporti omosessuali. Fourier diede un’esposizione articolata delle sue tesi su quest’ultima questione in un’opera, rimasta inedita fino al 1967, intitolata Il nuovo mondo amoroso . L’idea generale che serpeggia nel pensiero di Fourier e che ne fonda l’adesione al socialismo (utopistico) é quella secondo la quale l’uguaglianza giuridica (data dal liberalismo) e quella politica (data dalla democrazia) non sono garantite se non é garantita anche l’uguaglianza sociale. E accanto all’uguaglianza sociale auspicata da Fourier troviamo uno spiccato spirito libertario : Fourier é convinto che ognuno debba gestire più liberamente la propria vita. Per quel che riguarda il lavoro , Fourier lo considera non come una condanna, bensì come un valore: tuttavia eseguire per un’intera vita lo stesso lavoro sarebbe tedioso, e quindi il pensatore francese prospetta un’alternanza dei lavori tra gli uomini: il lavoro deve infatti sempre essere un piacere, mai un peso e cambiare di continuo lavoro può essere un modo divertente di lavorare. Questo atteggiamento fourieriano lo si può evincere quando egli propone di usare per fare gli scavi i bambini: essi infatti si divertono sempre a scavare e a sguazzare nel fango e svolgendo tale lavoro potrebbero divertirsi essendo utili.
ROBERT OWEN

Robert Owen (1771-1858) esordì come operaio in un cotonificio. A vent’anni era direttore di una filanda a Manchester. A trenta era comproprietario di una fabbrica tessile a New Lanark e la trasformò in un luogo di produzione modello. A cinquanta riuscì a far passare una legge per la limitazione del lavoro di donne e bambini. A sessanta presiedette il congresso di fondazione della prima unione sindacale generale del mondo. Per tutta la vita si dedicò allo sviluppo del movimento cooperativo operaio. Catalogare Owen tra gli utopisti è certamente una forzatura, ma è certo che egli fu l’ultimo ad inseguire un modello sociale basato sull’idea e sulla morale. Negli Stati Uniti fondò una comunità basata sulla produzione e sul consumo sociale (New Harmony, 1826). La caratteristica principale dell’utopismo di Owen fu la prassi. Prima organizzò gli uomini, poi ne trasse degli insegnamenti e volle dare al tutto una veste di teoria sociale. Egli immaginò che qualcosa si poteva e si doveva fare per superare i problemi della società capitalistica. Cercò di mettere insieme delle forze reali che potessero giungere a risultati pratici. Fornì la prova, evidentemente non da solo ma con l’aiuto di elementi presenti nella società inglese dell’epoca, che la società capitalistica poteva essere superata. La sua sconfitta fu infatti dovuta esclusivamente a tre elementi: all’immaturità della situazione; alla lotta che la società borghese condusse contro di lui; all’impossibilità di legare il movimento sindacale ad un movimento politico rivoluzionario. Owen fu sempre contrario allo scontro di classe pur essendone un prodotto. Quel che ci interessa di Owen è che egli non riesce più a costruire un modello esclusivamente mentale, mentre la critica alla società non gli permette di rimanere al livello della satira. L’Inghilterra della sua epoca esigeva l’azione, mentre nella Germania era in gestazione la teoria e in Francia la politica. Owen capisce benissimo che col plusvalore estorto agli operai si potrebbero superare i problemi dell’indigenza di tutta la popolazione. Sa che è possibile un aumento programmato della produzione agricola e industriale tramite l’utilizzo generalizzato delle macchine. Sa che produzione controllata significa abbondanza e lo sa perché lo ha provato dirigendo una fabbrica di 2.500 operai e offrendo per la prima volta alle loro famiglie un’assistenza sociale. La potenzialità liberatoria che Bacone vedeva nella scienza e nella produzione sociale ancora a venire, per Owen era cosa che si toccava con mano, già realizzata. Occorreva soltanto risolvere il problema della distribuzione dei prodotti e dell’anarchia produttiva. Non sarebbe potuta esistere New Lanark se non fosse stato già sviluppato il lavoro sociale. E la fondazione delle Trade Unions era una conseguenza. Da questo punto di vista la cosa più interessante non fu la realizzazione di New Lanark e di New Harmony ma il loro fallimento. Le prime espressioni della lotta di classe avevano mostrato che la realizzazione delle istanze socialistiche non poteva passare attraverso modelli. Per quanto essi fossero concreti invece che immaginari, erano pur sempre modelli e non potevano rappresentare isole di un nuovo ordine sociale in un mare capitalistico proprio mentre i movimenti proletari abbandonavano il luddismo e le primitive forme per diventare movimenti di massa, anche politici, come il cartismo. Era materialmente inevitabile, per un personaggio coerente come Owen, passare dal fallimento dell’esperienza produttiva e sociale alla lotta di classe e alla fondazione del sindacato generale. Non ci interessa in questo momento sindacare sulla concezione di Owen che vedeva il sindacato come elemento di trasformazione graduale della società. L’importante è annotare come in ogni rivoluzione venga sconfitto l’elemento costruttivo e prenda il sopravvento quello distruttivo. Così dev’essere, anche se agli uomini piacerebbe di più assumere atteggiamenti costruttivi e quindi conservatori. Ma come avviene la distruzione rivoluzionaria che è nello stesso tempo costruzione?
IL PENSIERO
Owen era convinto che “l’uomo è un prodotto dell’ambiente e che mutando l’ambiente si può mutare anche l’uomo”; assertore della possibilità di una più equa gestione dell’industria, egli partì come operaio in gioventù, poi divenne direttore di una filanda e, infine, fu imprenditore. Trasformò il suo cotonificio di New Lanarck in un’azienda modello, pagando – grazie alla maggiore efficienza tecnica – salari di gran lunga superiori alla media, risanando l’ambiente morale degradato della fabbrica e migliorando le condizioni generali di vita. Si trattava di un’utopia che diventava realtà. Tentò anche di fondare una comunità socialista negli Stati Uniti, New Harmony, ma essa fallì miseramente, anche perché – come è noto – negli Stati Uniti il socialismo e il comunismo non riuscirono mai ad attecchire, a scalzare il mito della possibilità di arricchirsi lavorando onestamente. Owen rientra nella schiera di quei socialisti che Marx etichetta come “utopisti”, ossia quei socialisti che a tavolino fanno progetti di società migliori (appunto utopiche) e poi le presentano ai governanti o agli industriali affinchè essi le realizzano; per Marx si tratta di utopia, di un qualcosa di inattuabile, poiché è impossibile convincere chi è al potere: secondo Marx, al contrario, non occorrono utopie da inseguire; bisogna, piuttosto, che la classe operaia imbracci i fucili e abbatta violentemente la classe nemica, che la sfrutta e la tiene schiava. Marx, però, guarda con simpatia ai socialisti utopisti e riconosce che se essi non sono arrivati a teorizzare la rivoluzione, ciò è accaduto perché ai loro tempi la classe operaia non era ancora “in sé e per sé”, ossia non si era ancora completamente formata e non aveva ancora piena coscienza di sé e dei suoi diritti. Il caso di Owen, però, è diverso, tende a sfuggire dall’utopia e a riversarsi sulla realtà, ad un miglioramento reale delle condizioni operaie: egli riesce a dimostrare che, in qualche modo, è possibile gestire il profitto eliminando gli aspetti più barbarici e duri nei confronti degli operai. Riguardo alla struttura della società Owen era contrario all’istituto del matrimonio e alla vita familiare, scostandosi nettamente anche su questo punto dalle idee di Fourier. A ogni coppia convivente, nelle sue comunità, era consentito di allevare un massimo di due figli, fino all’età di tre anni. Dopo tale età i bambini sarebbero stati trasferiti in dormitori comuni, assieme a coloro che, pur non avendo ancora questa età, erano nati in un nucleo familiare che già comprendeva due figli. A parte l’aspetto paradossale di questo progetto, in esso è da vedersi la superiorità che Owen attribuiva a una vita pienamente comunitaria. Sul piano pratico egli dovette subire delle profonde delusioni, che pero’ non incisero sul suo ottimismo circa la bontà intrinseca del sistema. Un primo fallimento di “villaggio della cooperazione” si registro’ negli Stati Uniti, a New Harmony, nell’Indiana, dove egli si era recato nel 1824 per realizzare i suoi progetti. Anche un secondo tentativo non ebbe sorte migliore. Gli scritti di Robert Owen contengono, sotto questo profilo, spunti interessanti che hanno attinenza, direttamente o indirettamente, con il problema della divisione del lavoro.
Natura umana e condizionamenti sociali
L’idea centrale di Owen è che
“è possibile plasmare una comunità, o anche il mondo intero, in mille modi diversi, dal migliore al peggiore, dal più ignorante al più illuminato, mediante l’uso di certi mezzi; questi mezzi in buona misura ricadono sotto il dominio, e il controllo di coloro che hanno una influenza sulle relazioni tra gli uomini”. [1813, Robert Owen]
Owen ritiene infatti che
“l’uomo è il prodotto delle circostanze, e che egli in realtà è, in ogni momento della sua esistenza, esattamente quale lo hanno reso le circostanze in cui si è venuto a trovare, combinate con le sue qualità naturali”. [1820, Robert Owen]
Nonostante questa possibilità di formare per il meglio il carattere degli individui e, attraverso ciò, promuovere il benessere di tutti, Owen ha davanti a sé lo spettacolo di abbrutimento della classe operaia, lo sfruttamento delle donne e dei bambini nelle fabbriche, in sostanza il disfacimento morale e fisico dei lavoratori.
“Nelle nostre fabbriche, che sono tutte più o meno nocive per la salute, si fanno lavorare bambini piccolissimi. Li si condanna a una routine di interminabile e invariabile lavoro al chiuso, in una età in cui il loro tempo dovrebbe essere diviso esclusivamente tra salubri esercizi all’aria aperta ed educazione scolastica. In tal modo … si blocca e si paralizza la loro forza intellettuale, come pure quella fisica, invece di permettere il corretto e naturale sviluppo, mentre ogni cosa intorno a loro cospira a rendere depravato e pericoloso il loro carattere morale”. [1818, Robert Owen]
L’educazione
Per risolvere questa situazione, apportatrice e perpetuatrice di guasti e malessere, Owen propone di estendere a tutti, attraverso un piano nazionale, le pratiche educative che egli, assieme ad altri, aveva promosso nella Contea di Lanark.
L’educazione è esplicitamente vista da Owen come mezzo per il superamento delle barriere di classe:
“con una giudiziosa educazione i bambini di qualsiasi classe possono divenire in breve tempo uomini appartenenti a qualsiasi altra classe”. [1813, Robert Owen]
Produttività dell’istruzione
Ma per fare accettare le sue proposte anche alla classe industriale a cui egli appartiene, Owen deve basarsi non su criteri umanitari, ma su parametri di profitto: e di produttività. Rivolgendosi ai sovrintendenti delle industrie e a tutti coloro che danno lavoro, egli fa vedere l’importanza, di tener conto anche delle macchine viventi che
“possono essere facilmente addestrate e dirette in modo da produrre un notevole aumento dei guadagni pecuniari”. [1813, Robert Owen]
Riferendosi all’esperienza di New Lanark, Owen dice:
“Ho investito molto tempo e capitale in miglioramenti del capitale vivente; e risulta che il tempo e il denaro cosi impiegati nell’industria di New Lanark, anche ora che questi miglioramenti sono ancora in fase di attuazione e che non si può ottenere che la meta dei loro effetti benefici, rendono più del 50% e in breve produrranno profitti pari al 100% del capitale originariamente investito”. [1813, Robert Owen]
Ecco allora che già incomincia a incrinarsi un mito consistente nel credere che vi sia una correlazione positiva tra spossessamento delle facoltà intellettuali e rendimento produttivo.
I rischi dell’istruzione per le classi dominanti
Ma che cosa é che cozza contro questo progetto socialmente vantaggioso per la generalità delle persone? Il motivo lo si può ricavare dallo stesso Owen, estendendo ad altri soggetti le critiche che egli rivolge alla chiesa:
“I dignitari della Chiesa e i loro fedeli hanno capito che, a meno che non sia posto sotto il controllo diretto e sotto l’amministrazione di persone appartenenti alla Chiesa, un sistema nazionale per l’educazione dei poveri minerebbe rapidamente alla radice non solo i loro errori ma anche quelli di ogni altra istituzione ecclesiastica”. [1813, Robert Owen]
E, si può aggiungere, svelerebbe anche gli errori delle attuali leggi che sono state
“poste dai potenti per accrescere la propria autorità, mantenendo gli inferiori in uno stato di soggezione al proprio potere”. [1836-1844, Robert Owen]
Ed e ancor più facile rendersi conto della giustificata presenza di questi timori nella classe dominante, esaminando più dettagliatamente lo schema di analisi e le proposte di Owen.
La divisione del lavoro
“Nel sistema attuale si ha tra le classi lavoratrici la divisione più minuta tra forza mentale e lavoro manuale; gli interessi privati sono sempre in contrasto con il bene pubblico, e in ogni nazione agli uomini si insegna di proposito fin dall’infanzia a credere che il loro benessere è incompatibile con il benessere e la prosperità di altre nazioni”. [1813, Robert Owen]
“Sarà ora chiaro comunque che questa minuta divisione del lavoro e divisione di interessi non rappresenta altro che termini diversi per indicare povertà, ignoranza, sprechi di ogni genere, un conflitto universale all’interno della società, crimine, miseria e una grande debolezza fisica e mentale”. [1813, Robert Owen]
Studio e lavoro
“Per evitare questi mali … ogni bambino riceverà fin dai suoi primi anni di vita una educazione generale che lo preparerà ad adempiere agli scopi propri della società”.
“Istruzione ed educazione vanno concepite come intimamente connesse con le occupazioni offerte dalla comunità”. [1813, Robert Owen]
L’elemento caratterizzante i criteri socio-pedagogici di Owen è appunto questa stretta. compenetrazione tra momento educativo e realtà esterna, tra studio e lavoro.
I bambini dai 5 ai l0 anni
“acquisteranno pratica secondo le loro forze e attitudini in qualcuna delle più facili operazioni degli affari della vita; operazioni che possano procurare loro molta più gioia e contentezza di quanta può derivare dagli inutili giocattoli del vecchio mondo”. [1836-1844, Robert Owen]
In seguito, crescendo, dovranno acquistare
“la conoscenza teorica e pratica delle arti più progredite e più utili alla vita”. [1836-1844, Robert Owen]
Attraverso le varie fasi dell’educazione corrispondenti alle differenti età della vita, si dovrà arrivare a far si che uomini e donne siano
“addestrati ed educati a sapere che cos’è la società, qual è il modo migliore per produrre, conservare e distribuire la ricchezza”. [1836-1844, Robert Owen]
Inoltre
“è necessario che sappiano anche come unire queste varie parti nelle dovute proporzioni in modo da formare un nucleo scientifico di società”.
“E tutti saranno perciò uguali per educazione e condizione e nessuna distinzione artificiale, tranne quella dell’età, sorgerà mai fra loro”. [1836-1844, Robert Owen]
La nuova società
È solo così che si può attuare il rovesciamento della vecchia società e far si che
“tutte le vecchie cose spariscano e tutto si rinnovi”. [1836-1844, Robert Owen]
Allora,
“al posto del malaticcio fabbricante di punte di spillo o di capocchie di chiodo, che come un ebete guarda il suolo o si guarda intorno, senza capire e senza riflettere razionalmente, sorgerebbe una classe lavoratrice piena di attività e di conoscenze utili, di abitudini, di informazioni, modi e tendenze che porrebbero anche chi è ultimo nella scala sociale molto al di sopra dei privilegiati di qualsiasi classe formatasi nelle circostanze offerte da società del passato e da quella attuale”. [1813, Robert Owen]
Secondo Owen, devono essere portati a conoscenza di tutti i principi
“resi semplici, adeguati a tutte le capacità mentali, di organizzazione dell’economia e della società, per cui la stessa categoria di persone che può essere istruita per mandare avanti una qualunque delle cose complicate della vita può facilmente acquisire quella competenza che gli permetta di prendere parte all’amministrazione e alla sovrintendenza di queste nuove aziende”. [1813, Robert Owen]
In questo modo tutti, secondo uno svolgimento che è rapportato unicamente all’età, saranno via via governati e governanti.
Owen dunque concepisce una società che supera fin dall’infanzia le barriere tra manualità e intellettualità, e si struttura in classi di età a cui corrispondono occupazioni differenti svolte via via da tutti gli individui nel corso della loro esistenza. Ma ciò che è importante cogliere, concludendo questa rapida analisi dello schema oweniano, e il posto centrale che egli assegna all’istruzione per la formazione di un “Nuovo Mondo”.
Istruzione che da una parte è ricchezza produttiva nel senso più lato nel termine (abilità materiale e intellettuale, scoperte scientifiche, ecc.); dall’altra è condizione indispensabile per il superamento dell’antitesi tra lavoro manuale e lavoro intellettuale in quanto universalizza le capacità di comprensione del processo direttivo.
PROUDHON

Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) elaborò una forma di socialismo antiborghese e anarchico; nato a Besancon, in un primo tempo lavorò in una tipografia, poi, nel 1840, pubblicò la prima memoria sulla proprietà ( Che cos’é la proprietà? ), dedicata all’Accademia di Besancon che la sconfessò, nel 1841 la seconda memoria, dedicata a Blanqui (che sarà esponente politico del movimento socialista nel governo provvisorio del 1848, sostenitore di una poletica in cui il giacobinismo era commisto al marxismo), e nel 1842 la terza, immediatamente sequestrata. Accusato di attentato alla proprietà privata e alla religione e di incitamento all’odio per i governi, fu assolto; nel 1844 a Parigi entrò in contatto con Bakunin e Marx, con il quale però tuttavia ruppe ben presto i rapporti. Nel 1846 pubblicò il Sistema delle contraddizioni economiche o filosofia della miseria , a cui Marx non tardò a rispondere con la Miseria della filosofia. Nel 1848 Proudhon prese parte alla rivoluzione, fu redattore del giornale “Le Représentant du Peuple” e venne eletto nell’Assemblea costituente, ma l’anno successivo, avendo attaccato Luigi Bonaparte (il futuro Napoleone III), fu condannato a tre lunghi anni di prigione. Nel 1851 pubblicò la Filosofia del progresso e, nel 1859, Sulla giustizia considerata nella rivoluzione e nella Chiesa . Anche quest’opera, forse la sua più importante, fu immediatamente sequestrata ed egli fu di nuovo condannato a tre anni di prigione. Per evitarla si rifugiò a Bruxelles e solo nel 1862 tornò in Francia. Tra i suoi ultimi scritti vanno ricordati La guerra e la pace (1861) e Sul principio federativo (1864). La summa del suo pensiero politico si trova nell’opera “Del Principio Federativo “, pubblicata pochissimi anni prima di morire. In essa definisce il federalismo come teoria dello stato basato sul contratto politico (o di federazione). Afferma che lo stato, per essere coerente con il suo principio, deve equilibrare nella legge l’autorità con la libertà e che questo si ottiene ponendo a perno del loro equilibrio il contratto politico o di federazione fra le persone responsabili. Potrebbe essere questa la “religione civile dell’umanità” per i prossimi secoli. È cosiderato il padre del federalismo integrale. Nella Célébration du Dimanche definì la proprietà privata come l’ultimo dei falsi dèi, in quanto è un ostacolo all’uguaglianza fra gli uomini, cioè alla giustizia. In “Che cos’é la proprietà?” scrive poi la sua famosa frase, apprezzata anche da Marx: “la proprietà privata è un furto!”. In realtà ciò che Proudhon vuole combattere è soltanto la proprietà come mezzo di sfruttamento di altri uomini: i mezzi di produzione e la casa da abitare devono appartenere a chi li adopera, finché li adopera (“la casa è di chi l’abita”, dirà più tardi un famosissimo canto anarchico). Nella sua forma di governo ideale, egli rifiuta la presenza di uno stato perché considerato un’istituzione assurda, finalizzata semplicemente allo sfruttamento del lavoro altrui da parte di alcuni uomini. Egli rifiuta ogni tipo di potere al di sopra dell’individuo, ivi compreso Dio che, in ambito religioso, è esattamente come lo stato in ambito politico e la proprietà in quello economico: istituzioni illegittime finalizzate al controllo degli altri uomini ed al loro sfruttamento.
« L’anarchia è una forma di governo o di costituzione nella quale la coscienza pubblica e privata, formata dallo sviluppo della scienza e del diritto, basta da sola a mantenere l’ordine ed a garantire tutte le libertà. » (Pierre-Joseph Proudhon)
Per altri aspetti fu conservatore, ad esempio si dichiarò favorevole alla sottomissione della donna all’uomo e si scagliò contro le cosiddette perversioni sessuali. Il suo pensiero fu considerato inapplicabile e per questo quello che ipotizzò fu definito “socialismo utopistico” (dal greco “ou + topos”, “che non esiste in alcun luogo”).
ALEXIS DE TOCQUEVILLE

“Non c’è al mondo filosofo tanto eccelso che non creda a una miriade di cose sulla fede di altri, e che non supponga più verità di quante non ne stabilisca. “(La democrazia in America, libro II, parte I, cap.2)
“Vedo chiaramente nell’eguaglianza due tendenze: una che porta la mente umana verso nuove conquiste e l’altra che la ridurrebbe volentieri a non pensare più. Se in luogo di tutte le varie potenze che impedirono o ritardarono lo slancio della ragione umana, i popoli democratici sostituissero il potere assoluto della maggioranza, il male non avrebbe fatto che cambiare carattere. Gli uomini non avrebbero solo scoperto, cosa invece difficile, un nuovo aspetto della servitù… Per me, quando sento la mano del potere appesantirsi sulla mia fronte, poco m’importa di sapere chi mi opprime, e non sono maggiormente disposto a infilare la testa sotto il giogo solo perché un milione di braccia me lo porge”. Sono parole di Alexis Clérel de Tocqueville (1805-1859), il saggista francese che conquistò la fama con due opere che, ciascuna nel suo genere, sono rimaste esemplari: “La democrazia in America” , scritta fra il 1832 e il 1840 e tuttora fondamentale per la comprensione dell’ideologia e della vita sociale degli Stati Uniti, e “L’antico regime e la Rivoluzione” , il volume pubblicato nel 1856, che trasformò radicalmente i criteri interpretativi della Rivoluzione francese. Diverse per il soggetto, le due opere principali di Tocqueville sono legate fra loro dalla visione politica dell’autore, che fu un liberale incline alla democrazia e, nello stesso tempo, un critico acuto e profondo dei mali di questa. Il problema dell’equilibrio fra la libertà individuale e il potere democratico (lo Stato di massa, si direbbe oggi), che egli studiò negli Stati Uniti e vide formarsi nell’Europa del suo tempo, è ora il problema di tutto il mondo occidentale. In Italia sono stati tradotti recentemente due libri che hanno acuito nuovamente l’interesse per questo genio della storiografia e della sociologia politica, seppure quest’ultima, ai suoi tempi, non esistesse ancora come scienza a se stante. Sono gli Scritti, note e discorsi politici 1839-1852 (Bollati Boringhieri, con un saggio di Umberto Coldagelli); e la biografia scritta da André Jardin, Alexis de Tocqueville (Jaca Book). Si è così riacceso il dibattito: quasi tutti ormai si dichiarano liberal-democratici e Tocqueville sembra essere il loro antesignano o, meglio, un liberale portato all’estensione dei principi liberali a tutti, quindi incline alla democrazia; ma, nello stesso tempo, Tocqueville è un critico acuto e preveggente dei mali democratici. Il brano riportato in principio d’articolo de La democrazia in America mette a fuoco la posizione di Tocqueville di fronte all’eguaglianza. Questo aristocratico era convinto, a differenza di tanti borghesi liberali, che la Rivoluzione avesse abbattuto il principio della libertà come privilegio di un’altra classe, ma per sancire il diritto di tutti alla stessa dignità umana. Lo Stato non era più concepibile senza libertà né la libertà senza l’eguaglianza. Ma Tocqueville era troppo intelligente per credere all’eguaglianza come realtà di fatto e non come ideale morale e come condizione giuridica; e se comprese che il garantismo oligarchico non esauriva le immense possibilità del liberismo, comprese pure che l’ideale democratico della sovranità conteneva il pericolo della dittatura della maggioranza o, peggio, di una tirannia in nome del popolo, purché questo delegasse il potere, o se lo lasciasse strappare. Andando in America nel 1831, Tocqueville ci vide qualcosa di più che l’America stessa, ci vide l’immagine della democrazia quale si stava formando anche in Europa. Negli Stati Uniti, insieme agli aspetti positivi della democrazia, notò anche, già operanti, i difetti dell’eguaglianza e della sovranità popolare. Il diritto della maggioranza a governare, egli scrive, le dà “un immenso potere di fatto e un potere d’opinione e nulla più, delle contee e degli Stati, dall’indipendenza della magistratura e dalla sua altrettanto grande mobilità” i cui effetti negativi sono l’instabilità governativa, l’onnipotenza dei governi, la scarsa garanzia contro gli abusi (perché l’opinione pubblica forma la maggioranza, il corpo legislativo la rappresenta e il potere esecutivo ne è lo strumento); e anche l’amore per il benessere, l’accentramento del potere, il conformismo: “Non conosco un paese dove regni meno l’indipendenza di spirito e meno autentica libertà di discussione che in America… Il padrone non vi dice più: “pensate come me o morrete”; ma dice: “siete libero di non pensare come me; la vostra vita, i vostri beni, tutto vi resterà, ma da questo istante siete uno straniero fra noi”. Dalla visione dell’America contemporanea dedusse un’agghiacciante ed esatta previsione del mondo futuro: “Se cerco di immaginare il dispotismo moderno, vedo una folla smisurata di esseri simili ed eguali che volteggiano su se stessi per procurarsi piccoli e meschini piaceri di cui si pasce la loro anima… Al di sopra di questa folla, vedo innalzarsi un immenso potere tutelare, che si occupa da solo di assicurare ai sudditi il benessere e di vegliare sulle loro sorti. È assoluto, minuzioso, metodico, previdente, e persino mite. Assomiglierebbe alla potestà paterna, se avesse per scopo, come quella, di preparare gli uomini alla virilità. Ma, al contrario, non cerca che di tenerli in un’infanzia perpetua. Lavora volentieri alla felicità dei cittadini ma vuole esserne l’unico agente, l’unico arbitro. Provvede alla loro sicurezza, ai loro bisogni, facilita i loro piaceri, dirige gli affari, le industrie, regola le successioni, divide le eredità: non toglierebbe forse loro anche la forza di vivere e di pensare?”. Triste e veritiera profezia: l’Europa del Novecento ha conosciuto e conosce queste tirannie, e anche i paesi che si credono liberi ogni giorno sprofondano sempre più nelle sabbie mobili, stranamente allettevoli, del paternalismo autoritario che nasce dalla stessa democrazia. Come non pensare, oggi, ai meschini piaceri della Tv e del fanatismo sportivo? Nell’America del suo tempo, Tocqueville vide che le garanzie contro la “tirannia della maggioranza” erano costituite da diversi fattori. Innanzi tutto, la tradizione protestante-puritana dava all’individuo la certezza del suo valore assoluto come persona, dotata di diritti inalienabili e fonte di ogni rapporto sociale. Questa consapevolezza individualistica era aiutata dal decentramento amministrativo dal moltiplicarsi delle autorità e delle associazioni locali, dall’autonomia dei municautorità sul potere politico: un’autorità costituita dal diritto di dichiarare incostituzionali le leggi, dalla diffusione dello spirito giuridico, dovuta anche all’istituto della giuria estesa agli affari penali, e della giuria estesa agli affari civili, e dalla libertà di stampa, giudicata “infinitamente preziosa”. Ma soprattutto l’esperienza americana l’aveva convinto, contro la tesi dell’Illuminismo, della stretta dipendenza del concetto di libertà dalla “rivoluzione cristiana”: “Dubito che l’uomo – scriveva Tocqueville – possa sopportare insieme una completa indipendenza religiosa e una libertà politica senza limiti; sono anzi portato a pensare che, se non ha fede, sia condannato a servire e, se è libero, non possa non credere”. Per queste ragioni, l’America presentò a Tocqueville un equilibrio fra la fonte democratica del potere e il suo esercizio liberale, un equilibrio che egli intuì mancante all’Europa, anche per effetto della Rivoluzione francese. Si rivolse quindi allo studio di questa, ed ebbe la conferma di ciò che aveva scritto nell'”Introduzione” e La democrazia in America: la tendenza all’eguaglianza delle condizioni si era manifestata in Europa, e specialmente in Francia, già nel Medio Evo ed era progredita in modo formidabile negli ultimi tempi della monarchia francese. Così, sviluppando ne L’antico regime e la Rivoluzione i concetti espressi in uno studio pubblicato su una rivista inglese nel 1836, Tocqueville, contro tutti gli storici del suo tempo, quali che fossero le loro tendenze, mise in luce per la prima volta che la Rivoluzione non era stata una “catastrofe” radicalmente innovatrice che, operando un capovolgimento del mondo, avesse creato una realtà totalmente nuova: la Rivoluzione fu il logico proseguimento di un’evoluzione in corso da secoli, che tendeva a sostituire uno Stato fondato sull’eguaglianza e amministrato con uniformità dal centro a uno Stato fondato sul privilegio e la cui amministrazione era frazionata fra i feudatari, l’anzianità, la forza, gli stessi successi che la tendenza egualitaria e accentratrice aveva conseguito prima dell’89 spiegano perché questa tendenza prevalesse, durante e dopo la Rivoluzione, sull’orientamento liberale, più recente e meno diffuso. Quindi, anche in Francia, anche in Europa, il problema della democrazia è lo stesso che in America: La sopravvivenza della sua forma liberale è connessa più con l’educazione alla libertà e con le garanzie per l’autonomia dell’individuo che con la difesa della mera eguaglianza. È facile essere eguali nella servitù, più difficile, ma necessario, essere liberi nell’eguaglianza. Sui due volumi sulla “Democrazia in America” gli studiosi del più grande pensatore politico dell’800 (il giudizio è di Aron) da tempo ritengono che si tratti di due opere sostanzialmente diverse: la prima dedicata alla felice congiunzione, oltre Atlantico, della democrazia con il liberalismo; la seconda ai pericoli che uno Stato sociale, caratterizzato dall’eguaglianza delle condizioni, comporta soprattutto sul piano culturale e antropologico. De Sanctis è tra i pochi studiosi italiani che si siano cimentati nel compito di decifrare il mistero Tocqueville. Dietro la limpida scrittura dell’aristocratico francese, infatti, emergono ripensamenti e contraddizioni insiti nell’oggetto stesso della sua ricerca: la democrazia nei suoi rapporti con la rivoluzione, con la tradizione, con le istituzioni, con i costumi. “Soltanto in un’epoca in cui tutto vacilla”, rileva De Sanctis, possiamo comprendere il pathos della democrazia del 1840, la sua prefigurazione di “una società democratica in cui prevale una condizione umana atomizzata dall'”individualismo” ed estraniata dalla politica”. Tocqueville nella Democrazia dei moderni non teme l’anarchia, le grandi passioni collettive, la tirannia della maggioranza ma, al contrario, l’apatia, l’irresponsabilità individuale, la rinuncia alla politica e l’affidamento della res publica a un potere “onnisciente e dirigista”. Di qui il drammatico appello a riscoprire l’arte difficile dell’associazione. Scrive de Tocqueville: “ gli Americani di tutte le età, condizioni e tendenze si associano di continuo. Non soltanto possiedono associazioni commerciali e industriali, di cui tutti fanno parte, ne hanno anche di mille altre specie: religiose, morali, gravi e futili, generali e specifiche, vastissime e ristrette. Gli Americani si associano per fare feste, fondare seminari, costruire alberghi, innalzare chiese, diffondere libri, inviare missionari agli antipodi; creano in questo modo ospedali, prigioni, scuole. Dappertutto, ove alla testa di una nuova istituzione vedete, in Francia, il governo (…), state sicuri di vedere negli Stati Uniti un’associazione “. Così de Tocqueville, ne “La democrazia in America”, descrive il funzionamento, nella vita sociale, di quel principio che in seguito verrà chiamato “principio di sussidiarietà”. De Tocqueville ripercorre il senso della nascita di una maggioranza: “ la maggioranza è come una giuria incaricata di rappresentare tutta la società e applicare la giustizia che è la società “. E’ molto significativo il richiamo costante al rapporto fra attività di governo con un principio generale di giustizia: “ esiste una legge generale che è stata fatta, o perlomeno adottata, non solo dalla maggioranza di questo o di quel periodo, ma dalla maggioranza di tutti gli uomini. Questa legge è la giustizia “. E l’appello a considerare ” un potere sociale superiore “, che è poi il potere sovrano del popolo. Il richiamo a questo principio fondamentale di ogni forma di governo si apre nella forma democratica a ” qualche ostacolo che possa… dare il tempo per moderare ” il potere della maggioranza. L’ostacolo o opposizione è quindi strumento di “moderazione”, ha uno scopo sociale pari a quello della stessa maggioranza, in sintesi deve specchiarsi anch’esso in quello spirito di giustizia che sovrasta e “governa” tutta la società. L’opposizione è quindi un momento costruttivo della democrazia, perché elimina ogni rischio di tirannide, ma proprio per questa funzione deve affiancare la maggioranza in una forma di garanzia, non di ostilità. Lo strapotere della maggioranza è sempre pericoloso, ma altrettanto è il non armonizzare elementi omogenei: ” quando una società giunge ad avere veramente un governo misto, vale a dire esattamente diviso fra principi contrari, essa entra in rivoluzione o si dissolve “. Il de Tocqueville non ci ha lasciato nessuna indicazione sull’eventualità che sia l’opposizione a essere rappresentativa di una congerie di princìpi contrari e se, così mista, possa svolgere questo ruolo di garanzia della democrazia. E’ certamente un tema su cui riflettere, soprattutto quando una società sta percorrendo una via di mutamenti molto significativi che si propongono in tempi rapidi. Saggezza imporrebbe che le preoccupazioni espresse da de Tocqueville fossero presenti per raggiungere quell’equilibrio così sintetizzato per un buon governo: “ un corpo legislativo composto in modo tale che esso rappresenti la maggioranza senza essere necessariamente schiavo delle sue passioni; un potere esecutivo che abbia una forza propria e un potere giudiziario, indipendente dagli altri due poteri; avrete allora un governo democratico, ma non vi sarà più pericolo di tirannide “.
PASQUALE GALLUPPI

Nato, come Hegel, nel 1770 da nobile famiglia a Tropea, in Calabria, Pasquale Galluppi visse una vita raccolta di studi, lontana dalle vicende politiche del paese. Tuttavia non esitò ad aderire alla causa liberale quando, durante i moti degli anni ’20, abbracciò la riforma costituzionale dello Stato e protestò vivamente, in seguito, contro l’intervento repressivo degli Austriaci. Riaccostatosi nel 1830 alla monarchia borbonica, per via delle speranze che allora accese negli animi l’avvento al trono del giovane Ferdinando II, fu dall’anno successivo titolare della cattedra di logica e di metafisica nell’Università di Napoli. Terminò la propria esistenza nel 1846. Tra i suoi scritti meritano di essere ricordati il “Saggio filosofico sulla critica della conoscenza” (1819-32), gli “Elementi di filosofia” (1820-1826), le “Lettere filosofiche sulle vicende della filosofia relativamente ai princìpi delle conoscenze umane da Cartesio sino a Kant” (1827) e “La filosofia della volontà” (1832-40). Il merito maggiore di Galluppi risiede nell’avere, con gli “Elementi di filosofia” ma, soprattutto, con le “Lettere filosofiche”, introdotto nel nostro paese lo studio e la conoscenza della nuova filosofia europea, soprattutto quella kantiana: le “Lettere filosofiche” furono a ragion veduta definite il primo saggio in Italia di una storia della filosofia moderna, mentre gli “Elementi di filosofia” ebbero una larghissima diffusione nelle scuole. Le sue meditazioni sulla filosofia kantiana, però, di cui larga traccia è nel “Saggio filosofico sulla critica della conoscenza”, non potevano non risolversi anche in influenza di tale filosofia sulla formazione stessa del suo pensiero. E infatti, Galluppi comincia con l’essere, secondo la tradizione culturale ancora dominante ai suoi tempi, in cui vigeva l’empirismo illuministico, in particolare il sensismo formulato da Condillac. Ma ben presto Galluppi se ne discosta, rimproverando al sensismo di approdare, con le sue ultime considerazioni, allo scetticismo: di essere, cioè, un vano gioco di elementi soggettivi, incapace per questo motivo di dare al sapere un fondamento di oggettività. Ecco perché egli oppone a quel sensismo un suo sensismo personale, che è, per così dire, profondamente rivoluzionato nella sua essenza dalla presenza di un’esigenza critica, senza che se ne accorga pienamente. Il processo conoscitivo, osserva Galluppi, non è o non consiste nella pura e semplice sensazione: bensì, bisogna distinguere in esso dalla sensazione una coscienza della sensazione, che è qualcosa di più, almeno in quanto può considerarsi come sensazione della sensazione, ovvero come un senso più potenziato e riflesso. Attraverso questa distinzione, Galluppi si innalza alla distinzione, di sapore kantiano, tra la materia del conoscere, data da mere sensazioni, e la forma del conoscere, propria del soggetto conoscente e consistente nel ricevere sensazioni e nell’ordinarle e rielaborarle secondo leggi sue. Sembra dunque che la riflessione galluppiana slitti verso il kantismo e la sua concezione della sintesi a priori. Senonchè è proprio il valore della sintesi a priori che sfugge a Galluppi: egli è convinto che anche Kant resti, come gli altri sensisti, chiuso nel soggettivismo delle forme del senso e dell’intelletto; e quindi, secondo Galluppi, pure Kant scivola nello scetticismo, alla pari di tutti gli altri sensisti. Per non aver colto il valore della sintesi a priori, Galluppi è, in un certo senso, risospinto su posizioni lockeane; proprio in virtù del suo avvicinamento alle tesi di Locke, egli è indotto a porre la coscienza della sensazione (che per Kant non è più sensazione, ma pensiero) sul piano stesso della pura sensazione, attribuendo questa al senso esterno e quella al senso interno. Gli pare di aver superato per questa via il soggettivismo sia dei sensisti sia di Kant: ma, come abbiamo accennato, la conoscenza che Galluppi ha del pensiero kantiano è ancora imperfetta e risente della limitazione dovuta al fatto che all’epoca l’opera kantiana era in Italia nota solo indirettamente (in esposizioni francesi e in una versione latina). La coscienza che ho di qualunque sensazione, dice Galluppi, è coscienza immediata, a un tempo, del me e dell’altro da me, del non-me. Attraverso le modificazioni che il non-me produce sul me ho, vale a dire, la certezza dell’esistenza di una realtà oggettiva distinta dal soggetto. Ne deriva che conoscere significa analizzare, distinguere dal me le modificazioni che il me ha subito in rapporto con non-me. E, insieme, significa comporre in sintesi, nell’unità del me, del soggetto, l’articolarsi stesso di tali modificazioni. Il conoscere consiste, allora, nel procedimento insieme analitico e sintetico della coscienza: nel senso che condizione di ogni analisi e radice, ad un tempo, di ogni sintesi è, appunto, la coscienza, il me. Ora, le idee fondamentali mediante le quali il soggetto sintetizza le sensazioni che riceve dal mondo esterno, con cui ordina cioè e compone i dati dell’esperienza, sono per Galluppi quattro: sono le idee di sostanza, di causa, di identità e di differenza. Esse, in realtà, adempiono alla medesima funzione cui adempiono, nel criticismo kantiano, le forme a priori (categorie) dell’intelletto, anche se con una rilevante differenza: che per Kant le categorie (anche quelle di sostanza e di causa) sono pure funzioni dell’Io, sono funzioni sintetizzatrici dell’esoerienza meramente ideali, per cui risulta problematico il loro rapporto con la realtà in sé, con la realtà oggettiva delle cose; o, addirittura, si corre il rischio di giungere a negare l’esistenza stessa di tale realtà in sé (come in effetti è avvenuto con gli idealisti). Per Galluppi, invece, sintesi puramente ideali (esclusive cioè del soggetto) sono quelle che la coscienza compie mediante le idee d’identità e di differenza, mentre sintesi reali (ovvero oggettive, tratte immediatamente dai dati stessi dell’esperienza e da essi condizionate) sono quelle che la coscienza compie mediante le idee di sostanza e di causa: e con l’aver riaffermato la validità oggettiva delle idee di causa e di sostanza, Galluppi trova anche agevole riaffermare, in polemica con Kant, le tradizionali prove dell’esistenza di Dio (tratte dalla nozione di causa prima); l’essere mutabile del me, dice Galluppi, non può non rinviare, come a sua causa, all’essere immutabile, che è Dio. ” vi prego di porre attenzione alle seguenti dottrine, da me altrove stabilite: 1) La coscienza è un motivo infallibile de’ nostri giudizj; 2) Questa coscienza ci mostra l’io come una sostanza, ed una sostanza semplice; 3) Il principio: non vi ha effetto senza una causa, ha un valore reale ed assoluto; 4) Da questo principio segue, che l’esistenza di un essere assolutamente necessario, immutabile, e creatore del me, e di tutto il finito, è incontrastabile “. Galluppi fonda la sua dottrina morale sulla coscienza del dovere e sulla consapevolezza della libertà del volere: e in questo non si distacca molto dal Kant della “Critica della ragion pratica”. Attraverso la distinzione tra sintesi reali e sintesi puramente ideali, sembra a Galluppi di aver evitato il soggettivismo in cui è invece, a suo avviso, caduto Kant e di avere, come conseguenza, conferito al sapere un saldo fondamento di oggettività. Ma, in realtà, egli stesso resta nell’ambito del deprecato soggettivismo, perchèle idee di sostanza e di causa non sono, in definitiva, che idee della mente, di cui la validità oggettiva è asserita ma non provata. Questo, almeno, è il rimprovero che gli muoverà ben presto Rosmini, assorbito dalla ricerca di un più saldo fondamento del sapere.
ANTONIO ROSMINI

Antonio Rosmini Serbati (1797-1855) fu secondogenito di Pier Modesto e di Giovanna dei Conti Formenti di Biacesa del Garda. Della sua nascita, avvenuta il 24 marzo, Rosmini renderà sempre grazie a Dio poiché «Egli la fece coincidere con la vigilia della Beata Maria Vergine Annunziata». Viveva con sua sorella maggiore Margherita, entrata nelle Suore di Canossa, e con suo fratello più piccolo, Giuseppe. Rosmini compì gli studi giuridici e teologici presso l'Università di Padova e ricevette a Chioggia, il 21 aprile 1821 l'ordinazione sacerdotale. Iniziò a mostrare una profonda inclinazione per gli studi filosofici, incoraggiato in tal senso da papa Pio VII. Dal 1826 si trasferì a Milano dove strinse un profondo rapporto d'amicizia con Alessandro Manzoni che di lui ebbe a dire: «è una delle sei o sette intelligenze che più onorano l'umanità». Manzoni assistette Rosmini sul letto di morte, da cui trasse il testamento spirituale "Adorare, Tacere, Gioire". Gli scritti di Antonio Rosmini destarono l'ammirazione, tra gli altri, anche di Giovanni Stefani, Niccolò Tommaseo e Vincenzo Gioberti dei quali pure divenne amico. Nel 1830 fondò al Sacro Monte di Domodossola la congregazione religiosa dell'Istituto della Carità, detta dei "rosminiani". Le Costituzioni della nuova famiglia religiosa, contenute in un libro che curò per tutta la vita, furono approvate da papa Gregorio XVI nel 1839. A Borgomanero svolge la sua attività di insegnamento e di guida spirituale un collegio rosminiano, il "Collegio Rosmini", regolato dalla Congregazione delle Suore della Provvidenza rosminiane. Rosmini portò avanti tesi filosofiche tese a contrastare sia l'illuminismo che il sensismo. Sottolineando l'inalienabilità dei diritti naturali della persona, fra i quali quello della proprietà privata, entrò in polemica con il socialismo ed il comunismo[1], postulando uno Stato il cui intervento fosse ridotto ai minimi termini. Nelle sue teorie il filosofo seguì le concezioni di Sant'Agostino, e di San Tommaso rifacendosi anche a Platone. Gli esordi filosofici di Antonio Rosmini si ricollegano a Pasquale Galluppi, sia pure polemicamente, in quanto Rosmini avverte con ogni chiarezza come risulti insostenibile una posizione di integrale sensismo gnoseologico. La necessità di concepire una funzione ordinatrice dell'esperienza, e a questa precedente, porta Rosmini a guardare con interesse la filosofia di Kant. Tuttavia non è soddisfatto di ciò che lui chiama l'innatismo kantiano, legato ad una pluralità imbarazzante e precaria di categorie. Le quali, d'altra parte, gli sembrano fallire lo scopo di far conoscere il reale quale esso è, per la necessaria introduzione di modifiche soggettive nell'atto stesso del conoscere. Il problema filosofico di Rosmini si configurava perciò come quello di garantire oggettività alla conoscenza. La soluzione non potrà essere trovata, stante il rifiuto della trascendentalità kantiana e dei connessi sviluppi, se non in una ricerca ontologica, in un principio oggettivo di verità, che riesca ad illuminare l'intelligenza in quanto le si proponga con immediata evidenza, universalità ed immutabilità. Questo principio è per Rosmini l'idea dell'essere possibile, che da indeterminato contenuto dell'intelligenza, quale originariamente è, si fa determinato allorché viene applicato ai dati forniti dal senso. Essa precede e informa di sé tutti i giudizi con cui affermiamo che qualche cosa particolare esiste. L'idea dell'essere, dunque, costituisce l'unico contenuto della mente che non abbia origine dai sensi, ed è perciò innata (Nuovo saggio sull'origine delle idee, del 1830). Ma qui i problemi del kantismo, che sembrano superati o almeno messi da parte, si riaffacciano con urgenza. Di fronte al mero ricevere dati, di cui parlava il sensismo, Rosmini ha chiarito che la mente umana nel suo uso conoscitivo formula giudizi, in cui l'idea dell'essere ha funzione di predicato, cioè di categoria, e la sensazione è il soggetto, di cui si predica qualche cosa. Nel giudizio, inoltre, il predicato si determina e la sensazione si certifica. Se questa è la funzione propria del giudicare, ogni concetto non può sussistere che come predicato di un giudizio. Né a questa necessità sembra potersi sottrarre il concetto di essere, che è dato solo nell'attività giudicante, come forma del giudizio. Ma il Rosmini non accetta tale riduzione, ed esclude proprio il predicato di esistenza della funzione del giudizio, continuando ad attribuirgli una natura oggettive e trascendente. È l'essere trascendente che si rivela all'uomo, lo illumina e gli permette di pensare. Accanto a questa ontologia l'etica di Rosmini si sviluppa come etica caritativa (Principio della scienza morale, del 1831). Breve ma intensa la parentesi di Rosmini politico. Seguì papa Pio IX riparato a Gaeta dopo la proclamazione della Repubblica romana, ma la sua formazione attestatasi su ferme posizioni di cattolicesimo liberale era tale per cui fu costretto a ritirarsi sul Lago Maggiore, a Stresa. Tuttavia, quando Pio IX volle istituire dopo il 1849 una Commissione incaricata della preparazione del testo per la definizione del famoso dogma dell'Immacolata Concezione, nonostante ben due sue opere (Le cinque piaghe della Chiesa e La costituzione secondo la giustizia sociale) fossero all'Indice, Rosmini fu chiamato a prendere parte a tale commissione. Continuò a vivere a Stresa, fecondo nel perseguire il perfezionamento del suo sistema di pensiero con opere come Logica 1853 e Psicologia 1855, sino alla morte, avvenuta a 58 anni il 1º luglio 1855. Giovanni Paolo II ha riabilitato la figura di Rosmini annoverandolo nella Lettera Enciclica Fides et ratio, «tra i pensatori più recenti nei quali si realizza un fecondo incontro tra sapere filosofico e Parola di Dio» e concedendo l'introduzione della causa di beatificazione, ormai conclusasi nella sua fase diocesana novarese il 21 marzo 1998. L'appoggio al Rosmini, oltre che da Giovanni Paolo II, non mancò anche dagli altri pontefici. Giovanni XXIII verso la fine della sua esistenza fece il ritiro spirituale sulle rosminiane "Massime di Perfezione Cristiana", assumendole come propria regola di condotta. Anche Paolo VI prestò interesse nel Rosmini: in occasione del 150º anniversario di fondazione dell'Istituto della Carità inviò un messaggio all'allora padre generale, in cui elogiava l'intuizione del Rosmini nel dare un grande peso all missione caritativa già nel nome del nativo istituto religioso, appunto l'Istituto della Carità. Inoltre, Paolo VI tolse il divieto di pubblicazione dell'opera Dalle Cinque Piaghe della Santa Chiesa. Alla morte di Paolo VI il collegio cardinalizio scelse il successore di Pietro nella persona di Albino Luciani, che si laureò in sacra teologia alla Pontificia Università Gregoriana di Roma con una tesi su «L'origine dell'anima umana secondo Antonio Rosmini». E' bene precisare che Luciani era fortemente critico nei riguardi del pensiero rosminiano, solo successivamente cambiò opinione, rivolgendo nei riguardi di Rosmini parole di ammirazione e stima. Il cardinale Joseph Ratzinger, il 18 Maggio 1985 (quando la questione rosminiana era ancora ben accesa), nell'ambito di una serata organizzata dal Centro Culturale di Lugano, disse: "Nel confronto con le parole classiche della fede che sembrano così lontane da noi, anche il presente diventa più ricco di quanto sarebbe se rimanesse chiuso solo in se stesso. Vi sono naturalmente anche tra i teologi ortodossi molti spiriti poco illuminati e molti ripetitori di ciò che è già stato detto. Ma ciò succede ovunque; del resto la letteratura dozzinale è cresciuta in modo particolarmente rapido proprio là dove si è inneggiato più forte alla cosiddetta creatività. Io stesso per lungo tempo avevo l'impressione che i cosiddetti eretici fossero per una lettura più interessante dei teologi della chiesa, almeno nell'epoca moderna. Ma se io ora guardo i grandi e fedeli maestri, da Mohler a Newman a Scheeben, da Rosmini a Guardini, o nel nostro tempo de Lubac, Congar, Balthasar -quanto più attuale è la loro parola rispetto a quella di coloro in cui è scomparso il soggetto comunitario della Chiesa. In loro diventa chiaro anche qualco'saltro: il pluralismo non nasce dal fatto che uno lo cerca, ma proprio dal fatto che uno, con le sue forze e nel suo tempo, non vuole nient'altro che la verità. Per volerla davvero, si esige tuttavia anche che uno non faccia di se stesso il criterio, ma accetti il giudizio più grande, che è dato nella fede della Chiesa, come voce e via della verità. Del resto io penso che vale la stessa regola anche per le nuove grandi correnti della teologia, che oggi sono ricercate: teologa africana, latinoamericana, asiatica, ecc. La grande teologia francese non è nata per il fatto che si voleva fare qualcosa di francese, ma perché non si presumeva di cercare nient'altro che la verità e di esprimerla più adeguatamente possibile. E così questa teologia è diventata anche tanto francese quanto universale. La stessa cosa vale per la grande teologia italiana, tedesca, spagnola. Ciò vale sempre. Solo l'assenza di questa intenzione esplicita è fruttuosa. E di fatto non abbiamo davvero raggiunto la cosa più importante se noi ci siamo convalidati da soli, ci siamo accreditati da soli e ci siamo costruiti un monumento per noi stessi. Abbiamo veramente raggiunto la meta più importante se siamo giunti più vicino alla verità. Essa non è mai noiosa, mai uniforme, perché il nostro spirito non la contempla che in rifrazioni parziali; tuttavia essa è nello stesso tempo la forza che ci unisce. E solo il pluralismo, che è rivolto all'unità, è veramente grande". Il 1º giugno 2007, papa Benedetto XVI ha autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi a promulgare il Decreto sul miracolo della guarigione di Suor Ludovica Noè, attribuito all'intercessione di Antonio Rosmini. Tra quelli portati dalla postulazione dei padri rosminiani, si è scelto di dare maggiore impluso a quello della Guarigione della suora sopracitata, poiché il medico che la curò, da non credente, passo ad vere fede. Si tratta quindi di un "miracolo nel miracolo". La cerimonia di beatificazione è avvenuta il 18 Novembre 2007 nella città di Novara. La celebrazione è stata officiata dal cardinale José Saraiva Martins, prefetto della congregazione per le Cause dei Santi e concelebrata da circa 400 sacerdoti, rosminiani (tra cui il preposito generale James Flynn e la madre generale Carla Catoretti) e non. Tra questi il cardinale prefetto della Sacra Congregazione per i vescovi Giovanni Battista Re, dal cardinale arcivescovo di Torino Severino Poletto, dal vescovo di Novara, mons. Renato Corti, dall'arcivescovo di Trento, mons. Luigi Bressan, dal vescovo rosminiano mons. Antonio Riboldi e fra gli altri anche da mons. Germano Zaccheo ( scomparso improvvisamente dopo due giorni), vescovo della Diocesi di Casale Monferrato, da mons. Luigi Bettazzi, vescovo emerito di Ivrea, dal segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana Giuseppe Betori, da mons. Giovanni Lajolo, presidente del Governatorato della Città del Vaticano, dal rettore della Pontificia Università Lateranense, mons. Rino Fisichella e dal preposito generale dei barnabiti, padre Giovanni Maria Villa. Tra i numerosissimi fedeli accorsi da diverse parti del mondo per presenziare alla celebrazione, hanno preso parte anche il senatore a vita, Oscar Luigi Scàlfaro, il presidente del Senato, Franco Marini, e il Ministro della Difesa Arturo Parisi. Rosmini è il primo beato della Provincia del Verbano Cusio Ossola. In occasione della beatificazione sono stati moltissimi i quotidiani e periodici italiani e esteri che hanno dedicato articoli, pagine e interi numeri alla figura di Rosmini.
VINCENZO GIOBERTI

La restaurazione non solo della religione in quanto tale, ma della religione cattolica come fulcro della civiltà e della filosofia ad essa connessa fu l'obiettivo perseguito da Vincenzo Gioberti (1801-1852), che a partire dal 1830 aderì con entusiasmo alle idee mazziniane. Nato a Torino, sacerdote e cappellano di corte dal 1826, nel 1833 fu arrestato e costretto ad andare in esilio prima a Parigi e poi a Bruxelles, dove visse insegnando filosofia e storia. Il fallimento dei moti mazziniani in Savoia e in Piemonte, nel 1833, lo indusse a maturare un diverso programma politico, il neoguelfismo, mirante alla costituzione di una confederazione degli stati italiani con a capo il papa. A Bruxelles Gioberti compose i suoi scritti filosofici più importanti: la Teorica del sovrannaturale (1838), l' Introduzione allo studio della filosofia (1840), le Considerazioni sopra le dottrine religiose di Vittorio Cousin (1840), Degli errori filosofici di Antonio Rosmini (1841 e, in edizione più ampia, 1843), la Lettera sulle dottrine filosofiche e politiche di M. de Lamennais (1841) in francese, Del bello (1841) e Del buono (1843). Nel 1843 pubblicò il suo scritto più celebre, Del primato morale e civile degli italiani, nel quale sono delineati i presupposti teorici del programma politico neoguelfo: Gioberti è convinto, come Mazzini, che l'Italia abbia una missione da portare a termine, ma, a differenza di quanto pensava Mazzini, Gioberti è convinto che questa missione sia di stampo religioso. Accusato dai gesuiti di subordinare la religione ai problemi politici del momento, Gioberti rispose con i Prolegomeni al Primato (1845) e il Gesuita moderno (1846-47). Scoppiati i moti del 1848, tornò in Piemonte, fu eletto deputato e per breve tempo fu a capo del governo piemontese, ma dopo la sconfitta di Novara, nel 1849, tornò a Parigi, dove sarebbe morto poco dopo, lasciando vari inediti, tra i quali la Protologia e la Filosofia della rivelazione . Gioberti fu educato dai padri dell'Oratorio alla prospettiva del sacerdozio e ordinato nel 1825. All'inizio condusse una vita ritirata, ma gradualmente acquisì sempre più interesse negli affari del suo paese e nelle nuove idee politiche come anche nella letteratura del giorno. Parzialmente influenzato da Mazzini, la libertà italiana divenne per lui lo scopo principale nella vita, la sua emancipazione, non solo dai signori stranieri, ma anche da concetti reputati alieni al suo genio e sprezzanti della sua autorità europea. Questa autorità era associata nella sua mente alla supremazia papale, anche se in un modo più romanzato che politico. Si deve ricordare tutto questo quando si considerano quasi tutti i suoi scritti e anche quando si critica la sua posizione, sia in relazione al partito clericale al governo – i gesuiti — che la politica di corte piemontese dopo l'incoronazione di Carlo Alberto nel 1831. Fu perciò notato dal re che lo nominò suo cappellano. La sua popolarità e l’influenza in campo privato, tuttavia, erano ragioni sufficienti per il partito della corona per costringerlo all’esilio; non era uno di loro e non poteva dipendervi. Sapendo questo, si ritirò dal suo incarico nel 1833, ma fu improvvisamente arrestato con l’accusa di complotto e, dopo quattro mesi di carcere, fu bandito senza processo. Gioberti andò prima a Parigi e, un anno dopo, a Bruxelles dove vi restò fino al 1845 per insegnare filosofia e assistere un amico nella direzione di una scuola privata. Nonostante ciò trovò il tempo di scrivere diverse opere di importanza filosofica con particolare riferimento al suo paese e alla sua posizione. Essendo stata dichiarata un'amnistia da Carlo Alberto nel 1846, Gioberti (che era di nuovo a Parigi) divenne libero di tornare in Italia, o meglio, nel Regno di Sardegna, ma si rifiutò di farlo fino alla fine del 1847. Al suo ritorno a Torino il 29 aprile 1848 fu ricevuto con il più grande entusiasmo. Rifiutò la dignità di senatore che Carlo Alberto gli aveva offerto, preferendo rappresentare la sua città natale nella Camera dei Deputati della quale fu presto eletto presidente. Entro la fine dello stesso anno fu formato un nuovo ministero capeggiato da Gioberti, ma con l’incoronazione di Vittorio Emanuele II nel Marzo del 1849 la sua vita attiva giunse alla fine. Per un breve periodo infatti ebbe un posto nel consiglio dei ministri, anche se senza portafoglio, ma un diverbio irriconciliabile non tardò a venire e il suo trasferimento da Torino fu completato da un suo incarico in missione a Parigi, da cui non fece più ritorno. Rifiutò la pensione che gli era stata offerta e ogni promozione ecclesiastica, visse in povertà e passò il resto dei suoi giorni a Bruxelles, dove si trasferì dedicandosi all’ozio letterario. Morì improvvisamente di un colpo apoplettico il 26 ottobre 1852. Gli scritti di Gioberti sono più importanti della sua carriera politica; come le speculazioni di Rosmini-Serbati, contro cui scrisse, sono state definite l’ultima propaggine del pensiero medievale; anche il sistema di Gioberti, conosciuto come ontologismo, più nello specifico nelle sue più importanti opere iniziali, non è connessa con le moderne scuole di pensiero. Mostra un’armonia con la fede cattolica che spinse Victor Cousin a sostenere che la filosofia italiana era ancora fra i lacci della teologia e che Gioberti non era un filosofo. Il metodo per lui è uno strumento sintetico, soggettivo e psicologico. Ricostruisce, come afferma, l’ontologia e comincia con la formula ideale, per cui l’ Ens crea l’esistente ex nihilo. Dio è l’unico ente Ens; tutto il resto sono pure esistenze. Dio è l’origine di tutte le conoscenze umane (chiamate idee), che è una e diciamo che si rispecchia in Dio stesso. È intuita direttamente dalla ragione, ma per essere utile vi si deve riflettere e questo tramite i mezzi del linguaggio. Una conoscenza dell’ente e delle esistenze (concrete, non astratte) e le loro relazioni reciproche, sono necessarie per l’inizio della filosofia. Gioberti è da un certo punto di vista un platonico. Identifica la religione con la civiltà e nel suo trattato Del primato morale e civile degli Italiani giunge alla conclusione che la chiesa è l’asse su cui il benessere della vita umana si fonda. In questo afferma che l’idea della supremazia dell’Italia, apportata dalla restaurazione del papato come dominio morale, è fondata sulla religione sull’opinione pubblica; tale opera sarà la base teorica del neoguelfismo. Nelle sue ultime opere, Rinnovamento e Protologia si dice che abbia spostato il suo campo sull’influenza degli eventi. La sua prima opera, scritta quando aveva 37 anni, aveva una ragione personale per la sua esistenza. Un giovane compagno d’esilio e amico Paolo Pallia, avendo molti dubbi e sfortune per la realtà della rivelazione e della vita futura, lo ispirò alla stesura de La teorica del sovrannaturale (1838). Dopo questa, sono passati in rapida successione dei trattati filosofici. La Teorica è stata seguita dall’Introduzione allo studio della filosofia in tre volumi (1839-1840), dove afferma le ragioni per richiedere un nuovo metodo e una nuova terminologia. Qui riporta la dottrina per cui la religione è la diretta espressione dell’idea in questa vita ed è un unicum con la vera civiltà nella storia. La Civiltà è una tendenza alla perfezione mediata e condizionata, alla quale la religione è il completamento finale se portato a termine. È la fine del secondo ciclo espresso dalla seconda formula, l’ente redime gli esistenti. I saggi (inediti fino al 1846) su materie più leggere e più famose, Del bello e Del buono hanno seguito l’introduzione. Del primato morale e civile degl’Italiani e Prolegomeni sulla stessa e a breve trionfante esposizione dei Gesuiti, Il Gesuita moderno, ha senza dubbio accelerato il trasferimento di ruolo dalle mani religiose a quelle civili. È stata la popolarità di queste opere semi-politiche, aumentata da altri articoli politici occasionali e dal suo Rinnovamento civile d’Italia, che ha portato Gioberti ad essere acclamato con entusiasmo al ritorno nel suo paese natio. Tutte queste opere sono state perfettamente ortodosse e hanno contribuito ad attirare l’attenzione del clero liberale nel movimento che è sfociato sin dai suoi tempi nell’Unificazione italiana. I Gesuiti, tuttavia, si sono radunati attorno al Papa più fermamente dopo il suo ritorno a Roma e alla fine gli scritti di Gioberti furono messi all’indice. I resti delle sue opere, specialmente La filosofia della rivelazione e la Prolologia danno i suoi punti di vista maturi in molti punti. Tutti gli scritti giobertiani, tra cui quelli lasciati nei manoscritti, sono stati pubblicati da Giuseppe Massari (Torino, 1856-1861). Il Ministero dei beni culturali ha affidato la redazione dell'Edizione nazionale all'Istituto di Studi Filosofici "Enrico Castelli", presso l'Università La Sapienza di Roma.
JOHANN FRIEDRICH HERBART

Johann Friedrich Herbart (Oldenburg, 4 maggio 1776 – Gottinga, 14 agosto 1841) è stato un filosofo tedesco. È il maggior filosofo anti-idealista della Germania dell'idealismo. Con Herbart la linea di continuità dei grandi sistemi speculativi appare spezzata, tanto da suscitare già presso i contemporanei l'impressione di poter finalmente respirare "un'altra aria". Herbart si era cimentato fin dagli esordi con l'idealismo di Fichte, per smascherare il carattere contraddittorio del concetto di "Io" che, ponendo se stesso, diviene nuovamente oggetto dell'Io e porta così all'infinito la scomposizione in serie, senza mai raggiungere uno degli estremi della serie stessa. Per Herbart, l'io fichtiano possiede i tipici connotati di tutti i problemi speculativi, che sono appunto destinati a mettere capo a contraddizioni insolubili. E questo non significa che le contraddizioni possano essere superate per mezzo di un artificio del pensiero qual è costituito dalla dialettica categoriale di Hegel, nei cui confronti Herbart non è meno aspro di quanto lo sia con Fichte. Senza dubbio la contraddizione costituisce il terreno sul quale si innesta la riflessione filosofica in quanto "elaborazione di concetti"; ma il punto dal quale occorre partire è l'analisi dell'esperienza data, muovendo dalla quale si potrà mostrare – in polemica con l'accusa hegeliana a Kant di aver avuto troppa "tenerezza per le cose del mondo" – come "le contraddizioni non possono essere nelle cose, ma soltanto nella nostra insufficiente comprensione di queste". Il continuo richiamo a Kant non significa un ritorno alla filosofia critica. Anche se nel libro "Metafisica Generale" del 1828 Herbart dichiara di essere un "kantiano", lo dice con evidente tono polemico per contestare gli sviluppi idealistici della filosofia romantica. In realtà la rivendicazione dell'autorità dell'esperienza e i meriti riconosciuti a Kant per aver impostato il problema delle 'condizioni di possibilità dell'esperienza' mostrando che la cosa in sé non è conoscibile si coniugano con una decisa messa in questione della teoria della conoscenza kantiana, rivolta a colpirla nel punto "debole" costituita dalle forme a priori dell'intuizione e dall'apparato dei concetti puri dell'intelletto. Herbart, come sfondo delle sue teorie, muove a Kant due critiche. La prima è l'assunzione di 'mitologiche' facoltà dell'anima (la sensibilità, l'intelletto, l'immaginazione, la ragione): a questa concezione kantiana, che fa un passo indietro rispetto a Locke e a Leibniz, occorre invece contrapporre sia l'unità e la semplicità dell'anima sul piano metafisico. In secondo luogo, Herbart ritiene che su un punto cruciale la posizione di Kant vada sostanzialmente corretta: si tratta, cioè, di superare la soggettività delle forme dell'esperienza che Kant fondava nella facoltà conoscitiva e di mettere per contro in luce il carattere dato anche delle forme dell'esperienza. Per Herbart il dato è sempre costituito da ciò che viene percepito e dalla sua forma. Anche ammesso che spazio, tempo, categorie, idee siano le condizioni dell'esperienza che si radicano nell'animo, restano pur sempre da spiegare la determinatezza e la specificità delle singole cose che si manifestano nell'esperienza: perché, ad esempio, percepiamo qui una figura rotonda e là una figura quadrata? E non è dunque legittimo pensare che certe condizioni siano in realtà incluse nel dato? Proprio perché rifiuta l'idea di un'attività spontanea del soggetto che unifica il molteplice, Herbart non vede alcuna giustificazione di qualcosa come una sintesi a priori: la certezza della conoscenza dipende piuttosto dal suo contenuto, da ciò che accade e si dà. Già la teoria kantiana dello spazio e del tempo come forme a priori della sensibilità costituisce pertanto "una dottrina assai falsa", che ne disconosce la natura di forme seriali prodotte sulla base del decorso delle rappresentazioni. Non meno reciso è il giudizio di Herbart sulla teoria kantiana delle categorie, a suo avviso costruita su un illegittimo "salto" dalle forme del giudizio della "vuota logica" ai "concetti metafisici" della conoscenza. Per Herbart, più in particolare, la classificazione kantiana delle categorie richiede di essere disposta in maniera diversa se vuole avanzare qualche pretesa di effettiva connessione; e da questo punto di vista Herbart è persuaso che il gusto architettonico kantiano sia gravido di molti errori, come ad esempio di subordinare la categoria della realtà alla qualità, dal momento che realtà e qualità vanno se mai "collegate" per mostrare nella loro connessione che cosa una cosa sia e che essa sia. Soggetto a critiche è anche il concetto di Io puro kantiano che palesa tutte le contraddizioni di ogni principio assoluto ed è a fondamento dell'artificiosa sistemazione "nelle scatole quadrangolari delle cosiddette categorie". Per Herbart, al contrario, si deve partire dalla determinazione della categoria come indicazione del "conformarsi dell'esperienza ad una regola in base alle leggi del meccanismo psicologico": detto altrimenti, le categorie designano la forma che l'esperienza possiede e pertanto non sono forme del pensiero, bensì oggetti del pensiero. E poiché l'analisi dei concetti metafisici che sono alla base dell'esperienza parte dal concetto generalissimo di cosa e delle proprietà della cosa ne svolge le contraddizioni, illumina i rapporti tra i 'reali' in sé inconoscibili e ai quali rinviano le loro manifestazioni fenomeniche, si ottiene una sistemazione quadripartita delle categorie – ma in realtà lontana da ogni tentazione simmetrica e non esauribile in un elenco fissato una volta per tutte – che è al "servizio" della categoria di cosa. In questa prospettiva Herbart si dichiara molto più vicino ad Aristotele che a Kant e sottolinea come la domanda relativa al sorgere delle categorie debba trovare risposta da parte dell'indagine psicologica sulla "forma seriale" della rappresentazione spaziale, di cui tutte le altre forme (categorie comprese) sono solo "analogie". Herbart inoltre pone l'analisi dei dati dell'esperienza al servizio di una struttura metafisica dell'esperienza, fondata sull'assunzione di enti reali che possiamo cogliere solo nella oro 'traduzione' nel linguaggio delle manifestazioni fenomeniche. Ma il carattere controverso di una simile impostazione metafisica, l'influenza di Herbart sulla discussione filosofica tedesca si farà sentire a lungo: da un lato sarà uno dei grandi ispiratori della psicologia scientifica che si svilupperà nella seconda metà dell'Ottocento e che si servirà largamente del lessico psicologico herbartiano; dall'altro lato la visione genetico-psicologica dell'apparato categoriale costituirà la struttura portante delle indagini sulla "psicologia dei popoli".
JAKOB FRIEDRICH FRIES

A cura di G. Cambiano e M. Mori, "Storia della filosofia contemporanea" (ed. Laterza)
Jakob Friedrich Fries (1773-1844) insegnò a Heidelberg e a Jena. Tra le sue opere più famose ed importanti meritano di essere menzionate: Sistema di filosofia come scienza evidente (1804), Nuova critica della ragione (1807), Sistema di Logica (1811), Manuale di antropologia psichica (1820), Politica, o dottrina filosofica dello Stato (1848, postuma). Fries si propone di opporsi all'idealismosviluppando il pensiero di Kant in direzione diversa e quasi antitetica da quella seguita da Fichte, Schelling ed Hegel, sebbene anche il suo tentativo anti-idealistico non sia del tutto fedele all'insegnamento kantiano. Kant aveva insistito a più riprese sul fatto che la filosofia trascendentale, in quanto analisi delle forme a priori della conoscenza, non aveva nulla a che vedere con una semplice descrizione empirica, e quindi a posteriori, dei meccanismi psicologici dell'uomo. Contraddicendo apertamente questa prescrizione, Fries risolve invece la sua indagine sulle forme della conoscenza in un empirismo psicologistico . La sua " scienza dell'esperienza psicologica " intende infatti fornire, attraverso lo strumento dell' auto-osservazione introspettiva, un'analisi completa dell'esperienza interiore del soggetto, mettendo in evidenza le forme mediante le quali la conoscenza si sviluppa a livello empirico. La filosofia si risolve così nella psicologia, che Fries definisce " antropologia psichica ". Il metodo psicologico è dunque fondato sul principio dell'evidenza , ovvero sul presupposto che tanto i meccanismi psicologici che presiedono alla conoscenza quanto i risultati dei processi conoscitivi siano immediatamente evidenti all'auto-osservazione. Il problema kantiano della validità oggettiva della conoscenza, fondata su strutture trascendentali irriducibili a meccanismi psicologici, è un problema irresolubile per l'uomo. L'unico criterio di verità della conoscenza è l' autofiducia della ragione , che per Fries non è soltanto un principio, ma un fatto: in base ad essa, la ragione è certa di rappresentare gli oggetti e la loro esistenza così come sono. L'ambito della conoscenza, però, si estende (come per Kant) solamente entro i limiti della rappresentazione fenomenica: le essenze ultime delle cose non sono logicamente conoscibili e cadono nel dominio della fede . Solamente con un atto di fede sono attingibili anche le verità eterne, ossia le idee dell'assoluto, della libertà e dell'eternità, che stanno alla base della vita religiosa degli uomini. Proprio a scusa di questo riferimento alla fede come mezzo per afferrare la realtà assoluta, Fries (accanto a Jacobi e a Schelling, che non vengono tuttavia espressamente nominati) è oggetto della sarcastica critica all'intuizionismo che Hegel conduce nella Prefazione alla Fenomenologia dello spirito (1807). Importante è anche il pensiero etico e politico elaborato da Fries: esso è fondato sul principio (pur esso di derivazione kantiana) del valore assoluto della dignità umana : ogni uomo deve sempre e comunque essere considerato come "fine", cioè come un valore in sé, mai solamente come "mezzo". Il principio del valore assoluto della dignità umana è alla base di tutti i doveri morali e politici: la stessa costituzione dello Stato deve essere finalizzata esclusivamente alla sua promozione. Fries raccomanda, come concreti strumenti politici per la realizzazione della dignità umana, l'uguaglianza e la libertà dei cittadini. In virtù di queste sue dottrine marcatamente liberali, Fries venne sospeso dall'insegnamento dalle autorità della Prussia.
TRENDELENBURG

Non è possibile formulare un giudizio di realtà che per soggetto non abbia qualcosa di reale.
Friedrich Adolf Trendelenburg, nato nel 1802, elaborò una filosofia fortemente influenzata dalla sua formazione universitaria. Studiò nelle Università di Kiel, Lipsia e Berlino; si occupò soprattutto della filosofia di Platone e Aristotele, cercando, nel suo Platonis de ideis et numeris doctrina e Aristotele illustrata (1826) di ottenere una più precisa conoscenza del platonismo attraverso la critica aristotelica. Rifiutata l'offerta di una cattedra a Kiel, accettò un impiego, dal 1826 al 1833, di precettore del figlio di un amico del ministro prussiano dell’Istruzione, Altenstein. Pubblicate nel 1833 il De Aristotelis catogoriis e un’edizione critica del De anima di Aristotele, quello stesso anno il ministro Altenstein lo nominò professore straordinario a Berlino, divenendo nel 1837 professore ordinario. Nel 1836 pubblicò gli Elementa logices aristotelicae e nel 1842 le Erläuterungen zu den Elementen der Aristotelischen Logik; nel 1847 divenne membro dell’Accademia prussiana delle scienze di cui fu segretario, nella classe delle scienze storiche, fino al 1871. Insegnò per quasi 40 anni, esaminando anche i candidati insegnanti di filosofia e pedagogia in Prussia. Nel 1865 fu coinvolto in un’acrimoniosa controversia sull’interpretazione kantiana dello spazio con Kuno Fischer, che attaccò nel suo Kuno Fischer e il suo Kant (1869), ottenendone una replica polemica nell'Anti-Trendelenburg (1870) del Fischer. Il figlio Friedrich fu un noto chirurgo. La filosofia del Trendelenburg è condizionata dal suo studio di Platone e Aristotele, nei quali vede i fondatori dell'idealismo; la sua posizione è quella di un moderno interprete aristotelico. Negando la possibilità di un metodo filosofico assoluto, come rivendicato da Hegel, l'opera del Trendelenburg è volta alla dimostrazione della presenza dell'idea nella realtà. Il processo del pensiero è analitico, dalle realtà particolari all'universale nel quale esse hanno la loro spiegazione; anche se si intuisce il sistema del tutto dalle parti conosciute, il processo di ricostruzione rimarrà tuttavia approssimato. Invece di una costante atteggiamento speculativo, sarà nostro dovere rimanere fermi a ciò che può essere considerato il risultato acquisito di uno sviluppo storico. Trendelenburg trovò l'espressione classica di tali risultati nel sistema platonico – aristotelico. Il problema filosofico viene così posto: come il pensiero e l'essere sono uniti nella conoscenza, come il pensiero giunge nell'essere e come l'essere entra nel pensiero? Procedendo secondo il principio secondo il quale il simile può essere solo conosciuto dal simile, Trendelenburg ottiene una dottrina personale, da lui definita organische Weltanschauung, concezione organica del mondo – per quanto basata su Aristotele. Introduce il concetto di movimento costruttivo che unifica essere e pensiero, nel senso che il mondo esterno è oggetto a ogni istante di percezione e pensiero: quest'ultimo produce a priori le forme – il tempo, lo spazio e le categorie delle scienze naturali – ma le produce in concordanza con la realtà e pertanto esse sono insieme soggettive e oggettive. In questo modo Trendelenburg tenta di risolvere il problema della conoscibilità della kantiana cosa in sé. È vero che la materia non può così essere completamente risolta nella conoscenza ma la parte irriducibile può essere tratta, seguendo Aristotele, come astrazione a cui avvicinarsi indefinitamente. I fatti dell'esistenza non sono però spiegati compiutamente in modo meccanicistico. L'interpretazione decisiva dell'universo può trovarsi soltanto nella superiore categoria del fine o causa finale. Qui Trendelenburg trova la linea divisoria tra i sistemi filosofici: da una parte quelli che non ammettono finalità ma cause efficienti, i quali entrano nel gruppo del democritismo; dall'altra la concezione organica o teleologica del mondo, che interpreta le parti con l'idea del tutto e vede nelle cause efficienti il veicolo dei fini ideali. Questa può essere definita in generale un platonismo; un sistema come lo spinozismo, che sembra appartenere a un terzo gruppo, rientra in realtà nel democritismo, ossia essenzialmente in una concezione materialistica. L'ultimo aspetto, derivato dalle vicende della vita umana, attiene al mondo etico, che consiste in sostanza nella realizzazione dei fini. Il diritto naturale di Trendelenburg è il completamento del suo sistema: poiché il compito dell'uomo è attuare l'idea della propria umanità, non astrattamente come Kant, ma nel contesto dello Stato e della storia, il suo pensiero deve tendere a fini che la realizzino. Il diritto è il mezzo col quale si realizza l'esigenza etica: condizione della vita morale, nasce dallo scopo etico. Lo Stato, l'organismo etico in cui l'individuo – uomo in potenza – diviene uomo in atto, è esso stesso l'uomo universale nella forma del popolo.
SCHOPENHAUER

Per non diventare molto infelici il mezzo più sicuro è di non pretendere di essere molto felici.
Arthur Schopenhauer rientra a pieno titolo nel filone di quei pensatori che si pongono in netta rottura con il sistema hegeliano e, insieme a tutti gli avversari del panlogismo di Hegel, tende a far prevalere l'irrazionalità della realtà: per Schopenhauer, come per Kierkegaard, Hegel è l'idolo polemico in antitesi col quale costruire la propria filosofia; diverso sarà, invece, il discorso di Nietzsche, il quale intraprenderà una lotta contro l'intera filosofia occidentale sviluppatasi da duemila anni a questa parte, e il bersaglio su cui si riverseranno le sferzate di Nietzsche sarà non Hegel, ma Platone, il fondatore del pensiero occidentale; ecco perchè, tra l'altro, quella nietzscheana può essere etichettata come "polemica inattuale". Tra i pensatori di questo periodo serpeggia l'aspirazione alla concretezza e, per addurre un esempio significativo, Schopenhauer insiste sul fatto che " l'uomo non è un angelo ", cioè non è puro spirito disincarnato, ma è essenzialmente un corpo e la natura di tale corpo consiste, soprattutto, nella volontà, nei desideri, negli istinti e nelle passioni, quelle cose, cioè, che Freud avrebbe più tardi definito come "pulsioni"; da notare che la rivendicazione che Schopenhauer fa della concretezza (e che trova conferma anche nella celebre espressione di Feuerbach: " l'uomo è ciò che mangia ") è in antitesi all'astrattezza hegeliana, come pure alla ragione, tanto cara ai Positivisti. Schopenhauer ha un periodo di produzione filosofica piuttosto lungo, che nel complesso dura una quarantina d'anni: la sua opera principale, Il mondo come volontà e rappresentazione , risale al 1819 e negli anni a venire continuerà a comporre opere che però non introdurranno notevoli modifiche al suo pensiero. La data di pubblicazione del Mondo è particolarmente significativa perchè si colloca nell'era del dominio del pensiero hegeliano: ed è sintomatico il fatto che le idee di Schopenhauer hanno fatto breccia presso il pubblico solo dopo la morte di Hegel, tant'è che la prima edizione de Il mondo (composta quando Hegel era ancora in vita) andò al macero e Schopenhauer potè fare un'amara constatazione: " Io non ho scritto per gli imbecilli. Per questo il mio pubblico è ristretto " . Si può, tra l'altro, ricordare come Schopenhauer desiderasse tenere le sue lezioni universitarie in contemporanea ad Hegel, ma tuttavia non potè farlo per il semplice motivo che non aveva studenti: tutti, infatti, andavano ad ascoltare con entusiasmo Hegel, non tenendo in alcuna considerazione Schopenhauer, che si ritrovava così perentoriamente a tenere lezione a nessuno. Solo con la morte di Hegel, avvenuta nel 1831, il pensiero di Schopenhauer cominciò a dilagare e Nietzsche stesso, nelle sue prime opere, si dichiarerà suo seguace; non solo, perfino Wagner rimase incantato dalla filosofia schopenhaueriana ed è importante ricordare l'interpretazione del De Sanctis in cui mette a confronto il pessimismo di Schopenhauer con quello di Leopardi. Sempre a dimostrazione del fatto che il successo di Schopenhauer arrivò solo dopo la morte di Hegel, si può anche ricordare come nel Novecento alcuni pensatori marxisti della "Scuola di Francoforte" opereranno una sintesi tra il pensiero marxista e quello schopenhaueriano; fatta questa carrellata di successi di Schopenhauer, si può in sostanza dire che Il mondo cominciò a riscuotere successo dalla seconda metà dell'Ottocento in poi, quando comincerà ad essere letto come una valida alternativa all'hegelismo. Infatti, la filosofia di Schopenhauer altro non è se non un tentativo di schierarsi contro Hegel e al fianco di Kant, dando di quest'ultimo un'interpretazione opposta a quella data dall'idealismo. Fino agli anni '50 dell'Ottocento, anche Kierkegaard contribuisce alla lotta contro Hegel, aprendo spiragli verso l'anti-hegelismo ma anche verso le filosofie esistenzialistiche che fioriranno nel Novecento; ma Kierkegaard, ancora più di Schopenhauer, non avrà tempo di assistere al proprio successo perchè lo coglierà una morte prematura. Entrando nel senso del discorso schopenhaueriano, egli si pone in contrapposizione all'interpretazione che di Kant ha dato l'idealismo (i cui tre eroi sono Fichte, Schelling e Hegel, tutti e tre cordialmente odiati da Schopenhauer): se l'interpretazione idealista, infatti, si è limitata ad eliminare quella "cosa in sè" ammessa da Kant ma da lui stesso riconosciuta inconoscibile (seppur ineliminabile), la posizione di Schopenhauer spinge in direzione opposta, in quanto si risolve nel recupero della "cosa in sè" , tanto odiata dagli idealisti. Essa per Schopenhauer non solo esiste (come era in fondo anche per Kant), ma è addirittura attingibile e, dunque, conoscibile; è però bene fare subito una precisazione: una volta conosciuta, la "cosa in sè" non si rivelerà essere il principio della realtà come lo intendevano Hegel e Fichte, ovvero come principio essenzialmente razionale. Al contrario, la "cosa in sè" sarà sì il principio che governa la realtà, ma esulerà da ogni forma di razionalità e, anzi, sarà addirittura una sorta di principio maligno. Ed è per questo che si può essere indotti a leggere il discorso schopenhaueriano come un capovolgimento parodistico del neoplatonismo: dall'Uno deriva la molteplicità delle cose, ma, essendo l'Uno radicalmente negativo, anche ciò che da esso deriva non potrà essere positivo. In maniera analoga, il pensiero di Schopenhauer può essere inteso come stravolgimento speculare di quello di Bruno e di Spinoza: tutto ciò che ci circonda è manifestazione di un'unica realtà, ma quest'ultima è totalmente negativa. Per questa marcata convinzione che la realtà sia governata da un principio negativo, si può parlare di pandemonismo schopenhaueriano, in antitesi con il panlogismo hegeliano. E' curioso il fatto che una volta un editore che doveva pubblicare la Critica della ragion pura di Kant chiese a Schopenhauer un parere su quale delle due edizioni fosse meglio adottare: e il filosofo non esitò minimamente a scegliere la prima versione, poichè in essa la "cosa in sè" ha ancora quello spessore che, con la seconda edizione, Kant aveva sempre più limato. Fatte queste precisazioni, può essere utile, per capire a fondo il pensiero di Schopenhauer, analizzare un'opera precedente al Mondo e, più precisamente, risalente al 1813: Quadruplice radice del principio di ragion sufficiente . Il principio di ragion sufficiente menzionato nel titolo è quello di matrice leibniziana: principio fondamentale della metafisica, esso prescrive, essenzialmente, che nulla avviene senza un motivo, cosicchè è lecito dire a priori che ogni avvenimento ha una sua motivazione. Schopenhauer riprende tale principio e coglie quelli che, a suo avviso, sono i quattro diversi modi ("quadruplice radice") in cui esso si manifesta: 1) la prima "radice" spiega la dimensione del divenire dei corpi naturali ( principium rationis sufficientis fiendi ) attraverso la connessione tra la causa e l' effetto fisici (necessità fisica); in altri termini, la prima manifestazione del principio di ragion sufficiente è la causalità, per cui, dato un evento, so con certezza che esso deve avere una causa e per questo è detto "del divenire". 2) La seconda spiega il conoscere razionale dell' uomo ( principium rationis sufficientis cognoscendi ) per mezzo della relazione tra antecedente e conseguente (necessità logica): se nella 1° radice si trattava della causalità fisica, ora la causalità in gioco è quella logica. Nel ragionamento concepiamo, cioè, il rapporto tra premessa e conseguenza come nel mondo fisico concepiamo quello tra causa ed effetto. 3) La terza giustifica l' essere ( principium rationis sufficientis essendi ) come definito dai rapporti dello spazio e del tempo, determinando così la concatenazione degli enti aritmetici e geometrici (necessità matematica). Con la terza radice, Schopenhauer interpreta kantianamente lo stesso principio di causa/effetto nella sfera matematica, poichè l'essere è ciò che si definisce nello spazio e nel tempo, i quali, a loro volta, sono i fondamenti della geometria. Tra l'espressione algebrica a sinistra dell'uguale e quella a destra (oppure tra il triangolo e i teoremi che da esso derivano), vige un rapporto analogo a quello causa/effetto del mondo fisico. 4) La quarta, infine, sta alla base dell' agire ( principium rationis sufficientis agendi ), in quanto stabilisce la connessione causale tra l' azione che si compie e i motivi per cui è compiuta (necessità morale). Il rapporto che si instaura tra il motivo di un'azione e la sua conseguenza è analogo a quello che intercorre tra la causa e l'effetto nel mondo fisico, sicchè non esistono azioni umane prive di motivi. Esaminate le 4 radici, si può notare come Schopenhauer dia un'interpretazione di forte sapore kantiano al principio di ragion sufficiente: tale principio, infatti, altro non è se non un nostro modo di conoscere (quasi una categoria kantiana), ossia siamo noi che in esso inquadriamo tutte le nostre conoscenze; il che comporta che, a livello di conoscenza intellettuale, tale principio aprioristico valga anche per la volontà umana (avendo ogni azione un suo motivo, ne consegue che non c'è spazio per il libero arbitrio, poichè ogni azione è rigidamente governata da cause deterministiche) e pertanto si è costretti a giungere alla conclusione che conosciamo tutta quanta la realtà (da quella fisica a quella matematica) in base ad un solo principio. Kant stesso era pervenuto a una concezione simile, ma per lui il livello noumenico delle cose in sè restava inconoscibile, o meglio, se ne poteva avere una sorta di conoscenza pratica (con l'esperienza morale, dove si sceglie liberamente seguendo l'imperativo categorico); ora, nel Mondo , Schopenhauer fa un discorso simile: con la quadruplice radice del principio di ragion sufficiente conosciamo il mondo così come esso ci appare (privo di libertà), ma nulla ci vieta di pensare che al di sotto di questa realtà ve ne sia un'altra in cui vige la libertà. Di questa realtà "nascosta" si può avere conoscenza in parte, come aveva detto Kant, attraverso l'esperienza morale, ma da sola essa non basta. La chiave per risolvere il problema è nel titolo stesso dell'opera: Il mondo come volontà e rappresentazione , diviso in quattro parti, di cui nella prima e nella terza si parla del mondo come rappresentazione, mentre nella seconda e nella quarta del mondo come volontà. Il titolo ci dice che il mondo, per un verso, è una nostra rappresentazione attraverso il principio di ragion sufficiente e, per un altro verso, è volontà; più precisamente, il mondo così come esso ci appare (il mondo come rappresentazione), ce lo rappresentiamo attraverso il principio di ragion sufficiente, mentre il mondo come è in sè è volontà. Certo, anche per Kant si entrava in un certo senso in contatto con il livello noumenico attraverso la "volontà buona", ma la nozione di volontà di Schopenhauer è nettamente diversa. E per comprenderla a fondo è opportuno addentrarsi nel Mondo come volontà e rappresentazione , il cui titolo, come abbiamo già detto, evoca in senso lato Kant: infatti il mondo fenomenico della rappresentazione viene contrapposto fin dalle prime pagine a quello noumenico, il mondo come volontà, il che vuol dire sia che esso viene attinto nell'atto di esprimere la volontà (come era in Kant) sia che la volontà, oltre ad essere strumento per attingere la "cosa in sè", è essa stessa la "cosa in sè". La partizione dell'opera, dicevamo, è in quattro libri: nel primo, viene delineato il mondo così come noi lo conosciamo attraverso le forme a priori della conoscenza (ovvero il principio di ragion sufficiente); nel secondo libro, invece, si vedrà come, al di sotto del mondo così come esso ci appare in prima analisi, esiste un altro mondo, cioè il mondo come effettivamente è e che, scoperto, si rivelerà come volontà. Nel terzo libro, poi, si ritornerà a tratteggiare il mondo come rappresentazione, ma non più come rappresentazione fenomenica, bensì artistica: verrà cioè delineato il mondo così come noi ce lo rappresentiamo esteticamente. Infine, nel quarto libro si torna a parlare della volontà, ma non come volontà affermativa (come era nel secondo libro): al contrario, se ne parlerà in termini negativi, la volontà cioè può volere il proprio annullamento o, in altre parole, può volere di non volere. L'argomento centrale del quarto libro sarà pertanto quella che Schopenhauer designa, con un neologismo, come "noluntas": così come esiste una "voluntas" (di cui si occupa il secondo libro), allo stesso modo c'è anche una "noluntas" (e ad essa è dedicato il quarto ed ultimo libro). Esaminiamo ora, singolarmente, le quattro parti che costituiscono il Mondo : il primo libro è quello che meno si allontana dal kantismo (di cui Schopenhauer si professò sempre seguace ortodosso); la frase che apre l'opera è " il mondo è una mia rappresentazione ", che suona kantiana all'ennesima potenza. Tuttavia si può notare come il significato profondo di tale frase presenti delle notevoli differenze rispetto al pensiero kantiano: infatti, Kant, dichiarando che percepiamo il mondo non come esso è ma come ci appare, non sottolinea l'aspetto di illusorietà del mondo così come ce lo rappresentiamo, ma, al contrario, attraverso la rivoluzione copernicana del pensiero ha fondato l'oggettività della conoscenza. Per Kant, infatti, è vero che percepiamo il mondo non come esso è in sè, ma come ci appare, però è anche vero che il fatto stesso di essere dotati tutti delle stesse categorie conoscitive fa sì che la conoscenza umana sia oggettiva (cioè universale) e dunque valida. In conclusione, quindi, anche per Kant il mondo è una nostra rappresentazione, ma non per questo tale rappresentazione è priva di valore conoscitivo, anzi è l'unica forma di conoscenza che possiamo avere del mondo, dal momento che per Kant la "cosa in sè", pur esistendo, resta inconoscibile. Ma, nel momento in cui Schopenhauer presuppone di poter conoscere la fantomatica "cosa in sè", allora è evidente che la conoscenza fenomenica venga proclamata illusoria, poichè impedisce di vedere il mondo come effettivamente è; parimenti, per Kant la conoscenza fenomenica non era un'illusione, ma anzi era l'unica conoscenza che si poteva avere, poichè con le categorie la "cosa in sè" restava inattingibile . Ed è bene notare come anche il Kant della Dissertazione del 1770 , ammettendo la possibilità della conoscenza della "cosa in sè", non aveva esitato a dichiarare illusoria la conoscenza fenomenica, proprio come, molti secoli prima, Platone aveva preferito, alla conoscenza del mondo sensibile, quella delle idee. Ed è nel secondo libro che Schopenhauer proclama la conoscibilità della "cosa in sè" attraverso la volontà ed è in virtù di questa considerazione che l'espressione " il mondo è una mia rappresentazione " si colorerà di negativo e finirà per suonare: " il mondo è una mia illusione". Schopenhauer cerca di avvalorare il proprio pensiero ripescando filosofi del passato: in particolare, egli si riaggancia a quella sfilza di pensatori che, nel mondo occidentale, rappresentano una specie di filo rosso minoritario e pessimistico. Infatti, se per lo più la filosofia occidentale è stata ottimistica ("l'essere e il bene sono interscambiabili" dicevano i filosofi medioevali), è anche vero che vi sono stati pensatori che si sono distinti per un marcato pessimismo e Schopenhauer ha soprattutto in mente, oltre al Platone della Diade, Anassimandro ("il venire alla luce è un peccato originale"), gli Orfici (il corpo tomba e prigione dell'anima), alcuni Neoplatonici (la decadenza dall'Uno verso il basso), e il misticismo cristiano (che trova in Jacopone da Todi il suo eroe) con il suo disprezzo per il mondo. Ma Schopenhauer si richiama anche alla letteratura ( " il peggior delitto dell'uomo è essere nato scrive in La vita è sogno , riprendendo la letteratura di Calderòn de la Barca) e, sull'onda dell'entusiasmo romantico per l'esoticismo, al mondo orientale, specialmente indiano; ma, nonostante il recupero del pensiero indiano, Schopenhauer è a tutti gli effetti un interprete dell'Occidente, poichè il suo pensiero matura nell'ambito della tradizione occidentale e i riferimenti alla cultura orientale gli servono solo per riscontrare analogie con il proprio pensiero. Ed è da queste civiltà tanto distanti dall'Occidente (e cordialmente detestate da Hegel) che Schopenhauer desume due concetti basilari nella sua filosofia: il Nirvana e il velo di Maya. Il velo di Maya è il velo dell'illusione: il pensiero orientale ha sostenuto che la nostra visione del mondo è ottenebrata da una sorta di velo che bisogna stracciare per poter così acquisire una prospettiva che non ci inganni. Ora, per Schopenhauer il mondo fenomenico altro non è se non un velo che deve a tutti i costi essere stracciato poichè impedisce di cogliere la realtà così come essa è effettivamente. Tale mondo fenomenico ha, kantianamente, le sue due forme sensibili a priori (spazio e tempo) e la sua forma a priori dell'intelletto (non più le 12 categorie, ma esclusivamente la causalità, come già si era prospettato nella Quadruplice radice): la ragione, però, non è più (com'era in Kant) la facoltà con cui si tendeva all'infinito, ma è semplicemente la facoltà di astrazione mediata dal linguaggio. Dunque, se la sensibilità e l'intellettività si giocano, rispettivamente, su spazio e tempo e sulla causalità, la ragione, dal canto suo, lavora sull'astratto attraverso il linguaggio; il che comporta un assottigliamento della distinzione tra uomo e animali. Infatti, per Schopenhauer, gli animali, oltre a percepire le cose nello spazio e nel tempo, sono anche in grado di cogliere i rapporti di causalità e dunque hanno un intelletto; ciò di cui sono sprovvisti è la ragione, in assenza della quale non possono pensare per concetti generali. Sul perchè gli animali non siano in grado di formulare astrazioni attraverso la ragione, Schopenhauer spiega che è il fatto stesso che essi siano privi di linguaggio che impedisce loro di ragionare per astrazioni; è proprio nel linguaggio, infatti, che si esprime l'universalità della ragione, e, non a caso, in esso troviamo per lo più nomi comuni, con i quali operiamo le astrazioni. Attraverso l'uso dei concetti elaborati con la ragione, l'uomo costruisce la scienza e la filosofia: ed è significativo il fatto che Schopenhauer non riconosca alcun valore conoscitivo alla scienza (accostandosi in questo modo alle future considerazioni epistemologiche del Novecento). Tuttavia, la scienza non è completamente inutile: infatti, pur non potendo essere d'aiuto nel processo conoscitivo, essa ha una grande importanza a livello pratico, dal momento che, essendo costruita sul mondo fenomenico (ed è per questo che non può aiutarmi a conoscere la "cosa in sè") mi permette di dominare tale mondo nella vita pratica. Nel secondo libro del Mondo , affiora il tema della volontà, di cui già abbiamo fatto alcune anticipazioni. Come nel primo libro, si parte da un discorso di forte sapore kantiano: il mondo, dice Schopenhauer, è una mia rappresentazione ma in essa rientra anche il soggetto conoscente; il che vale a dire che ciascuno di noi si percepisce fenomenicamente (e quindi illusoriamente), non come effettivamente è in sè. Tuttavia Schopenhauer prende subito le distanze da questo discorso (che troviamo quasi uguale in Kant) facendo notare che tra tutte le rappresentazioni possibili ve n'è una particolare e privilegiata ed è il nostro corpo, poichè, da un lato, lo percepiamo fenomenicamente in modo analogo a tutte le altre cose, ma dall'altro lato lo viviamo dall'interno in maniera assolutamente immediata, con una specie di autointuizione che ce lo fa conoscere noumenicamente. Infatti, percepiamo senza mediazione alcuna il piacere, il dolore e i desideri poichè li viviamo in maniera direttissima e ciò ci consente di scavalcare il mondo fenomenico e di entrare in contatto con la "cosa in sè", che ci si manifesta sotto forma di volontà. Il mondo, infatti, è, kantianamente, una rappresentazione ma attraverso il corpo ci è concesso di attingere la "cosa in sè" e la percepiamo come volontà, sicchè non è scorretto affermare che per noi la cosa in sè è volontà . E l'esperienza del volere è per Schopenhauer (come per il Kant della "volontà buona") il luogo in cui si entra in contatto con la cosa in sè, la quale, però, non è, com'era per Kant, un postulato della ragion pratica confinato all'esperienza morale (per Kant potevo dire di essere libero noumenicamente ma a livello fenomenico dovevo continuare a riconoscermi "servo"); Schopenhauer, invece, intorno alla "cosa in sè" costruisce la propria filosofia, che viene dunque a delinearsi come un tentativo di descrivere quella cosa in sè per Kant inconoscibile sul piano teoretico. Ed è per questo motivo che la filosofia di Schopenhauer si colloca a metà strada tra l'arte e la scienza: infatti, come l'arte, si fonda su un'intuizione profonda della realtà e ad essa dà quella veste razionale tipica della scienza; con questo, non si vuol dire che la filosofia è una sorta di scienza debole, poichè, al contrario, la scienza è per Schopenhauer addirittura inferiore all'arte, visto che quest'ultima, pur non essendo in grado di razionalizzare, sa comunque cogliere intuitivamente l'essenza profonda della realtà. La filosofia dunque è superiore alla scienza perchè, a differenza di essa, sa cogliere la "cosa in sè", ma è anche superiore all'arte perchè, oltre a cogliere la "cosa in sè", le dà una veste razionale. Ne consegue che per Schopenhauer, a differenza di Kant, si può costruire una metafisica (ed è ciò che egli fa nel Mondo ); ma non solo, emerge anche che, se per il pensatore di Königsberg la volontà era libera nella misura in cui era razionale (cioè in grado di obbedire alla legge morale) con la conseguenza che gli animali, in assenza della ragione, non erano liberi, per Schopenhauer invece la volontà esula da ogni forma di razionalità ed è sinonimo di desiderio e di impulso istintivo. Si tratta pertanto di una volontà irrazionale , che non consiste nel seguire la legge morale dettata dalla ragione, ma piuttosto nel desiderare cibo e bevande; e per questo è corretto affermare che il corpo, più che avere desideri ed impulsi, è lui stesso la somma degli impulsi e dei desideri, quasi come se esistesse in forma di concretizzazione dei medesimi. La volontà, in un certo senso, può essere letta come una sorta di desiderio mediato, poichè quando si vuole qualcosa è un modo mediato dall'intelletto per soddisfare i desideri irrazionali del corpo. Si può anche notare come il discorso di Schopenhauer rievochi fortemente quello di Cartesio: come il filosofo francese, dopo aver messo ogni cosa in dubbio, trovava una certezza (penso, dunque sono) nell'ambito della coscienza, in modo analogo Schopenhauer mette in forse il mondo intero e per agganciare la cosa in sè ricorre all'autointuizione dell'Io, anche se l'Io in questione non è più il mero pensiero Cartesiano (res cogitans), ma è piuttosto un "desidero, dunque sono", poichè capisco di esistere nel momento in cui entro in contatto con i miei desideri. E come Cartesio, del resto, Schopenhauer prova a fornire una chiave di lettura dell'intera realtà con questo ragionamento: io che mi sono colto metafisicamente diverso da come mi concepivo a livello fenomenico, posso tranquillamente pensare che tutti gli altri miei simili, che fenomenicamente mi sono uguali, lo siano anche sul piano noumenico, ovvero saranno anche loro (come me) volontà. Dopo di che, Schopenhauer (e qui sta il passaggio fondamentale) estende il discorso all'intero universo: dal momento che la mia essenza noumenica come volontà, nascosta da quella fenomenica, è uguale a quella di tutti gli altri uomini poichè sono a me simili, posso anche dire che gli animali, le piante e gli oggetti mi sono in qualche modo simili e che dunque, sotto il velo dell'apparenza, anche la loro essenza profonda è volontà, cosicchè tutto il mondo è volontà . Con questa considerazione Schopenhauer può riprendere le riflessioni ilozoistiche fatte dai Presocratici, dai Rinascimentali (Bruno in primis) e da Hegel stesso (la cui idea di "spirito del mondo" implica che l'intera realtà sia spirito nella sua essenza); però la grande novità è che, come vedremo meglio più avanti, questa volontà che permea il mondo dal suo interno è radicalmente negativa. Fatte queste puntualizzazioni, è bene ricordare come Schopenhauer cerchi di stroncare subito possibili fraintendimenti della sua filosofia: quando egli dice che la volontà che ognuno scopre in sè è uguale in tutto il mondo, non intende dire che gli oggetti inanimati hanno un qualcosa di analogo in tutto e per tutto alla mia volontà; il fatto è che, dice Schopenhauer, in assenza di una parola che possa designare questo principio che governa l'intera realtà, non resta che usare il nome della parte per nominare il tutto; vale a dire che quel principio, che nell'uomo si manifesta come volontà, lo chiameremo in generale "volontà" per indicarlo tanto negli animali quanto nelle cose, pur sapendo che non è la stessa cosa. Perciò anche gli animali, nel momento in cui tendono al cibo, hanno volontà e anche le piante quando si protendono per captare i raggi solari; perfino le cose quando, lasciate, cadono al suolo, rivelano una volontà. Il succo del discorso è che la volontà, principio negativo che permea la realtà, è una sola ed è la stessa e si estrinseca in modi diversi : ogni singolo fenomeno della realtà ne è una manifestazione particolare. Sorge spontaneo chiedersi come Schopenhauer possa affermare che la volontà è una sola: e il filosofo risponde introducendo quello che, nella filosofia aristotelica, è noto con il nome di "principio di individuazione". A far sì che una cosa sia se stessa e non le altre sono lo spazio, il tempo e i rapporti di causalità: posso infatti dire che il libro posato sul tavolo è se stesso poichè è in un tempo e in uno spazio diversi da quelli delle altre cose. Questo processo con cui l'intelletto inquadra nel tempo e nello spazio la realtà fenomenica non può valere per la realtà noumenica, in quanto essa è al di là dello spazio e del tempo, come già aveva fatto notare Platone (l'idea di cavallo, diceva, è una sola perchè il tempo e lo spazio non possono individuarla). Ne consegue che se la realtà fenomenica è molteplice, quella noumenica, invece, è unica e dunque, entrando in contatto dentro di me con la volontà, sono autorizzato a dire che essa (che costituisce la "cosa in sè") è una sola e si manifesta nell'illusoria molteplicità che caratterizza il mondo fenomenico. Ma tale volontà, oltre ad essere una, è anche irrazionale: e con quest'affermazione Schopenhauer capovolge l'atteggiamento tipico della filosofia occidentale, atteggiamento che trova la sua massima espressione in Hegel e nella sua convinzione che la ragione costituisca l'essenza profonda della realtà, per cui gli elementi irrazionali altro non sarebbero se non manifestazioni indirette e accidentali della razionalità stessa. Per Schopenhauer è l'esatto opposto: l'essenza profonda della realtà è irrazionale e gli elementi di razionalità che ci sembra di poter cogliere non sono null'altro che manifestazioni esteriori. La volontà sfugge ad ogni razionalità, poichè non vuole nulla che sia riconducibile alla ragione: vuole semplicemente vivere, esistere, e per far ciò cerca di utilizzare tutti gli strumenti possibili, tra cui l'intelletto e la ragione. In altri termini, gli istinti e gli organi di un animale sono espressione della volontà di vivere: le zanne e gli artigli delle tigri sono gli strumenti che la volontà usa nella tigre per esistere. E questa stessa volontà si manifesta diversamente a seconda dell'individuo in questione: nell'uomo, ad esempio, si manifesta nelle facoltà razionali, per cui ragione e intelletto sono gli strumenti da essa adottati per esistere. Il che significa che la natura profonda della realtà è una volontà priva di ragione e di scopi razionali ma che per poter sopravvivere, nell'uomo, si dota della razionalità. Da questa riflessione scaturisce un'altra importante considerazione: dal momento che solo razionalmente ci si possono porre degli obiettivi (ed è così appunto che la volontà si struttura nell'uomo), ne consegue che la volontà, irrazionale e quindi priva di obiettivi, non può mai essere soddisfatta , e si configura pertanto come un continuo tentativo di affermarsi, tentativo presente anche nell'uomo, il quale si pone degli obiettivi razionali ma, non appena li realizza, è preso dal desiderio di realizzarne di nuovi, quasi come se dietro questi obiettivi razionali si camuffasse la volontà irrazionale. E le riflessioni di Schopenhauer vengono a incrociarsi con quelle del suo contemporaneo Leopardi: per entrambi la vita umana (in Leopardi) e la vita universale (in Schopenhauer) è una continua altalena fra la noia e il dolore ; finchè non si è raggiunto l'obiettivo desiderato si soffre, quando lo si è raggiunto ci si annoia e ci si pone pertanto dei nuovi obiettivi. Occorre però fare una precisazione, poichè altrimenti non si spiega come la volontà sia una ma l'intelletto la veda molteplice: dobbiamo tener presente che l'intelletto stesso è, come ogni altra cosa, una manifestazione della volontà ed è, più precisamente, la volontà che grazie ad esso si illude, quasi come se vivesse uno sdoppiamento di personalità. In altri termini, il fatto che l'intelletto frammenti la volontà fa sì che, in un certo senso, la volontà sia per davvero frammentata e finisca per riconoscersi solo nelle sue manifestazioni, quasi come se si scordasse di essere un tutto; ne consegue che ciascuna manifestazione della volontà, non riuscendo a capire di essere solo una parte della volontà stessa, riconosce solo se stessa come volontà, mentre vede tutte le altre cose come strumenti per sopravvivere, non come altre manifestazioni della stessa volontà. La volontà, infatti, cerca di esistere in ogni singola manifestazione (dall'uomo alla pietra) e per vivere la volontà, ingannata dall'intelletto, lo fa a danno di tutte le altre manifestazioni, cosicchè ogni manifestazione danneggia le altre per il solo fatto di essere venuta al mondo; infatti, per affermarsi, ogni ente lotta e aggredisce tutti gli altri ( " gli amici si dicono sinceri, ma in realtà sinceri sono i nemici ") Da qui scaturisce il pessimismo schopenhaueriano, che affonda le sue radici nell'idea che la volontà è profondamente sofferente (e questo vuol dire che l'intero universo è sofferente) poichè non ha un obiettivo e si manifesta in tanti modi diversi che altro non sono se non illusioni. Si potrebbe uscire dalla condizione di dolore se si pensasse che la volontà è insita solo negli uomini e negli animali: basterebbe essere vegetariani; ma, poichè la volontà investe ogni realtà, anche chi mangia solo ortaggi è in lotta con la volontà. Ecco dunque che diventa drammaticamente cosmica quella guerra di tutti contro tutti prospettata da Hobbes: il mondo è una lotta di tutto contro tutto, e la vita stessa di un uomo è una specie di lotta per tenere insieme tutti i "pezzi". Si può dunque affermare che la volontà è cannibalica , poichè anche il leone che mangia la gazzella, in realtà, essendo una sola la volontà, sta mordendo se stesso. Nemmeno con il suicidio si può uscire da questa situazione di dolore: eliminare noi stessi come manifestazione della volontà altro non è se non ritornare alla volontà, sicchè il suicidio non è una rinuncia alla volontà, ma ne è anzi un'affermazione più potente. Chi si suicida, infatti, lo fa perchè è come se volesse qualcosa di diverso. In virtù di queste considerazioni, Schopenhauer può credere alla metempsicosi: ogni volta che si muore, subito si rinasce e la rinascita è una condanna, giacchè la cosa migliore sarebbe poter uscire dal circolo della volontà. La via d'uscita da questa situazione, dice Schopenhauer, consiste in un percorso di conoscenza che mi faccia capire che ciò che mi sembra altro rispetto a me in realtà non lo è; in fin dei conti, già quando tiro fuori di tasca una moneta per aiutare un bisognoso è come se provassi un senso di compassione, è come se capissi che chi soffre non è radicalmente diverso da me. Ecco perchè c'è stato chi ha sostenuto che il discorso di Schopenhauer è una "Gnosi moderna", poichè la salvezza deriva da una conoscenza dell'identità tra noi e tutto il resto. In altre parole, per Schopenhauer, se il mondo è un inferno in cui ciascuno è diavolo e dannato, ovvero soffre e fa soffrire, allora bisogna acquisire la convinzione dell'unità del tutto, presente nelle pratiche dei monaci buddhisti: essi, infatti, mettono gli uomini di fronte agli oggetti e li invitano a ripetere "questo sono io". Sempre mutuando riflessioni dal buddhismo, Schopenhauer dice che tre sono le cose da conoscere: 1) la sofferenza, 2) la causa della sofferenza, 3) le vie per uscirne. Egli afferma che l'umanità è esteticamente una serie di caricature, gnoseologicamente una banda di cretini e moralmente una banda di delinquenti. Dopo aver tratteggiato la sofferenza e le sue cause, resta ora da descrivere la via per uscirne: non può essere il suicidio, nè il vegetarianesimo e neanche la politica. Quest'ultima, infatti, non si occupa della condizione umana nello specifico, ma cerca solo di dare momentanei sollievi ed è per questo accostata da Schopenhauer alla Firenze di Dante, che, alla stregua di un malato sdraiato nel letto, cerca sollievo nel cambiar posizione: " … vedrai te somigliante a quella inferma / che non può trovar posa in sulle piume, / ma con dar volta suo dolore scherma " (Purgatorio, canto VI). Così si spiega perchè Schopenhauer non nutrì mai grandi interessi per la politica (collocandosi però su posizioni conservatrici) e guardò sempre con sospetto il movimento socialista che stava allora nascendo. A questo punto si entra nel terzo libro del Mondo , in cui si delinea una nuova forma di rappresentazione del mondo: l'estetica. Schopenhauer risulta, in quest'ambito, particolarmente influenzato dal pensiero di Platone e dalla sua dottrina delle idee. L'esperienza estetica, infatti, nasce, secondo Schopenhauer, da una contemplazione delle idee che ciascuno di noi può avere , sicchè l'artista come l'uomo comune possono ugualmente contemplare l'idea del bello, che (come aveva sottolineato Platone) tende a filtrare più di tutte nel mondo sensibile, con la differenza quantitativa, però, che l'artista riesce a restare in tale contemplazione per più tempo. L'esperienza artistica è, infatti, momentanea, si protrae per pochissimo tempo e l'abilità dell'artista sta proprio nel farla durare più a lungo, in modo tale da poter fissare in termini sensibili l'oggetto di tale breve contemplazione: l'artista, dunque, con l'opera d'arte rende tutti gli uomini partecipi della sua contemplazione extrasensibile e li facilita a provare anch'essi tale esperienza. Ci troviamo di fronte ad un apparente paradosso, dal momento che da un lato Platone condannava l'arte e dall'altro lato in molti (tra cui Schopenhauer) si sono artisticamente ispirati a lui: il problema si risolve facilmente se teniamo conto delle modifiche apportate alla dottrina platonica da Plotino e dai suoi successori. Il limite dell'arte, secondo Platone, risiedeva nel fatto che essa non è imitazione dell'idea, ma del mondo sensibile (che dell'idea è pallida copia), cosicchè l'opera d'arte è copia di una copia; ma in realtà, è stato obiettato (da Hegel in primis), nell'opera d'arte si cala sensibilmente l'idea e non il mondo sensibile, non si imita cioè ciò che empiricamente ci sta di fronte, ma l'idea stessa di ciò che ci sta di fronte, per cui si scavalca definitivamente la sensibilità: ecco perchè per Hegel l'arte era rappresentazione sensibile dello Spirito. In effetti, una sorta di paradosso era già insito nella filosofia di Platone: egli infatti condannava l'arte e poi, soprattutto nel Fedro e nel Simposio, sottolineava come l'esperienza del bello fosse una specie di scorciatoia per giungere al mondo delle idee. Schopenhauer, dal canto suo, concepisce l'opera d'arte come rappresentazione dell'idea e non del mondo sensibile, accostandosi in questo modo ad Hegel e distanziandosi da Platone: resta ora da capire che cosa si debba intendere per "idea". Come abbiamo appreso, la realtà profonda è volontà e ciò che ci circonda ne è una manifestazione illusoria; e questa concezione schopenhaueriana secondo la quale, accanto ad una realtà profonda tendenzialmente unitaria, vi sia una realtà molteplice ed illusoria sa molto di platonico, pur essendo negativo il principio posto al vertice. Tuttavia, se per Platone la realtà era una piramide al cui vertice stava l'idea del Bene e più si scendeva e più la realtà tendeva a frantumarsi, per Scopenhauer, invece, al vertice della realtà c'è la volontà unitaria, alla base c'è la moltiplicazione indefinita e illusoria della volontà e a metà strada c'è una moltiplicazione parziale costituita dal mondo delle idee : infatti, a distinguere l'unica idea di cavallo dalla miriade di cavalli sensibili è che solo questi ultimi sono concretamente calati nello spazio, nel tempo e nei rapporti di causalità: ovvero, detto un pò banalmente, i cavalli sensibili sono tanti (mentre l'idea di cavallo è una) perchè esistono in tempi diversi, in luoghi diversi e in rapporti causali diversi. In altri termini, la volontà si oggettiva su due livelli differenti: ad un primo livello si oggettiva nelle idee (che Schopenhauer definisce " oggettità "), nel secondo livello si oggettiva nel mondo sensibile. Il discorso schopenhaueriano è talmente affine a quello platonico da farci presagire che, in fin dei conti, la volontà non può essere così malvagia intrinsecamente; più nello specifico, poi, ci aiuta a capire perchè l'esperienza estetica sia un primo modo per sfuggire al dominio della volontà e della sua sofferenza. L'esperienza estetica, infatti, diceva Kant, è caratterizzata dal fatto di essere disinteressata, per cui se vediamo una rappresentazione estetica del cibo possiamo provarne un piacere disinteressato, ovvero non legato al fatto che il cibo esista effettivamente e io possa nutrirmene. Schopenhauer concorda con Kant sul fatto che sia disinteressato, ma reinterpreta il tutto con categorie platoniche: quando contemplo il cibo nella misura in cui posso nutrirmene, bado all'esistenza effettiva del cibo stesso, ovvero contemplo la cosa empirica; quando invece contemplo il cibo in sè, indipendentemente dal fatto che essa esista e possa soddisfare il mio appetito, contemplo platonicamente l'idea. Ne consegue che nel secondo caso per Schopenhauer il piacere estetico è disinteressato perchè contemplo la cosa non nella sua esistenza, ma nella sua idealità , fuori dal tempo, dallo spazio e dai legami di causalità. E il cibo "empirico", invece, posso mangiarlo proprio perchè è calato in essi e solo di esso posso avere un desiderio, una volontà, ovvero un piacere interessato. Con le idee, dunque, ci si limita a contemplare e a provare piacere in modo disinteressato: e, nota Schopenhauer, il rapporto interessato col mondo non fa altro che generare di continuo desiderio e volontà, calandoci in continuazione nel ciclo della sofferenza (volere di continuo e senza scopo) da cui non si può uscire orientando la volontà su una cosa anzichè su un'altra o suicidandosi. L'unica cosa da fare per uscirne è annullare la volontà, ovvero trasformarla in nolontà (volontà capovolta) e per far ciò occorre trasformare quelle cose che ci fanno muovere come oggetti di desiderio (i "motivi") in "quietivi": tali quietivi servono appunto ad annullare la volontà e uno di essi è l'esperienza artistica, che ci consente di guardare alle cose non come a oggetti di volontà, ma ci fa diventare un primo "occhio sul mondo", ci fa cioè assumere un atteggiamento puramente contemplativo e sganciato dalla volontà; l'arte, infatti, mi fa guardare la realtà nella sua dimensione ideale e dunque non usufruibile. Ecco perchè è un quietivo che mi fa uscire dal desiderio e dalla volontà. Il grande limite dell'esperienza estetica, però, è di durare per troppo poco tempo, poichè l'uomo è pur sempre immerso nel mondo della volontà: dopo aver visto per breve tempo le cose in modo ideale e disinteressato, si è costretti a ritornare a vederle in modo interessato ed empirico. E' curioso il fatto che l'opera d'arte preferita da Schopenhauer sia la tragedia: e non a caso la prima opera del giovane Nietzsche, seguace per un pò di Schopenhauer, sarà proprio L'origine della tragedia . La seconda via per uscire dal circolo di sofferenza della volontà è data dalla morale: di per sè, ogni singola manifestazione individuale della volontà tende a riconoscere se stessa come unica e legittima espressione della volontà, vedendo erroneamente tutto il resto come mero strumento di cui servirsi. Ma non tutta la realtà funziona così: l'uomo, infatti, si distingue per essere in grado di rendersi conto, più o meno consciamente, che al di là di lui stesso esiste qualcosa di simile a lui. In altri termini, nessun uomo si comporta come fa il leone con la gazzella, trattando cioè gli altri come semplici oggetti, ma, al contrario, se può aiutare gli altri con un piccolo gesto non esita a farlo. Ed è proprio con l'esperienza morale che comincia a manifestarsi embrionalmente il "questo sei tu" dei monaci buddhisti, ovvero la coscienza che gli altri non sono radicalmente altra cosa rispetto a noi (questo è il messaggio cristiano delle origini, sostiene Schopenhauer). Affiora dunque il discorso kantiano secondo cui non bisogna mai trattare il prossimo come semplice strumento, ma anche sempre come fine in se stesso, senza fare agli altri ciò che non vorremmo che fosse fatto a noi. L'esperienza morale può, in altri termini, essere letta come presentimento che siamo tutti la stessa cosa e da cui scaturisce un rispetto che si manifesta a vari livelli , primo dei quali è il diritto. Esso mi impone di non nuocere agli altri e pertanto si configura, agli occhi di Schopenhauer, come una morale passiva, che non dice cosa fare ma cosa non fare (nuocere agli altri); e dando ragione ad Hobbes, egli può affermare che la società civile è solamente una forma di "egoismo intelligente", privo di morale, in quanto non si dice che è un male uccidere agli altri, ma semplicemente ciascuno si accorge che non gli conviene vivere nel selvaggio stato di natura e così ci si raggruppa nella società civile. Se il diritto impone di non nuocere agli altri, la morale, invece, comanda di venire in aiuto agli altri: ma in Schopenhauer sulla morale prevale la compassione , ossia la sofferenza insieme agli altri. La cosa fondamentale, infatti, non è di aiutare gli altri, ma di soffrire insieme a loro, cosa che in apparenza risulta totalmente passiva e negativa. In realtà, nella compassione si capisce che colui con cui soffro insieme non è altra cosa rispetto a me; il cristianesimo stesso, dice Schopenhauer (in modo scorretto), è una forma di compassione che non prevede l'aiuto per il prossimo. Ecco dunque che per Schopenhauer la morale si configura come compassione poichè il limite della morale in quanto tale è che, anche aiutando gli altri, non si riesce ad annullare la volontà e la sofferenza che ne deriva; si tratta pertanto di rintracciare una terza e più efficace via per uscire dal dolore. L'arte è troppo breve, la morale, pur essendo più intensa e duratura, non riesce a superare il problema, anche se mi fa capire che gli altri sono come me e che dunque la loro sofferenza è anche la mia. In altri termini, con l'esperienza artistica pervengo alla radice del problema, con la morale comprendo che siam tutti la stessa cosa e che dunque il problema non è di aiutarci ma di annullare in tutti la volontà, cosa di cui però la morale si rivela incapace, pur essendo anch'essa un quietivo: l'annullamento della morale a cui porta l'arte è momentaneo, quello a cui porta la morale è parziale. E l'obiettivo a cui si deve pervenire è proprio l'annullamento della volontà, ovvero il suo capovolgimento in nolontà: ma come si può realizzare ciò? Schopenhauer ne dà un'approfondita spiegazione nel quarto libro del Mondo : solo nell'uomo si può attuare il capovolgimento della volontà in nolontà e questo per un motivo molto semplice, dice Schopenhauer. Infatti, solo l'uomo è provvisto della ragione, ma essa è solo un aspetto marginale della vita umana (tema che verrà approfondito da Freud), poichè è un puro e semplice strumento di cui la volontà si avvale per affermarsi. Tuttavia, la ragione, il cui obiettivo consiste appunto nel far sì che la volontà possa affermarsi, non può essere relegata ad un solo obiettivo e tende anzi ad investirne il maggior numero possibile, proprio alla stregua della radio, per esempio, che, nata per realizzare obiettivi militari, si è poi estesa al soddisfacimento di bisogni dell'intera società. E così la ragione, nata come strumento in mano alla volontà, si è allargata ad una più ampia sfera di obiettivi e realizzazioni, delle quali le più raffinate sono la scienza e, soprattutto, la filosofia, superiore perchè legata, in una certa misura, all'arte (e tra le forme artistiche spicca la musica, che, col suo carattere fluido, non coglie l'idea, ma la volontà stessa: e Schopenhauer ha soprattutto in mente il don Giovanni di Mozart, caro anche a Kierkegaard). Ne consegue che la ragione ci fa conoscere cose che vanno al di là dell'obiettivo per cui essa era nata in origine e, addirittura, può consentire alla volontà di capovolgersi in nolontà. Infatti quella volontà che tende sempre ad affermarsi aumentando in tal modo la propria sofferenza, con questo proposito si dà come strumento la ragione, la quale però, se ben impiegata, porta l'uomo a comprendere le tre cose fondamentali (1 sofferenza, 2 cause della sofferenza, 3 vie per uscirne) : in altre parole, la ragione fa capire alla volontà che l'unica via da intraprendere è di decidere di uscire dalla volontà, diventando un puro "occhio sul mondo" (che vede tutto in modo distaccato, senza essere coinvolto), e decidendo di non stare più al gioco ma uscirne (cessando così il circolo vizioso per cui continuava ad affermarsi in tutti i modi). Ma per annullarsi, essa non può ricorrere al suicidio (equivarrebbe ad abbandonarsi ad un'altra forma di volontà), alla politica (cambia le cose solo in modo provvisorio e superficiale) o al vegetarianesimo (mangiando gli ortaggi non si esce dal cannibalismo della volontà): l'unica via possibile è allora quella dell' ascesi , ovvero del progressivo annullamento in sè della volontà che nasce dalla convinzione di essere uno col tutto; e se annullo in me la volontà, la annullo anche in tutti gli altri, visto che è una sola. In questa prospettiva, Schopenhauer ha in mente il mondo orientale dell'ascetismo, che vince la volontà di bere e di mangiare, mortificando così la carne e producendo un progressivo annullamento della volontà (la quale si capovolge in nolontà); lo stesso impulso sessuale viene da Schopenhauer condannato come delitto in quanto mette al mondo nuovi individui destinati a soffrire. Ma distruggendo la volontà di bere e di mangiare, come fanno gli ascetici, si arriva ad una sorta di lento suicidio e Schopenhauer, come abbiamo visto, condanna questa pratica. Però bisogna tener presente che se il suicidio in senso classico non è una soluzione per uscire dal dolore (e quindi Schopenhauer lo condanna), il suicidio ascetico è diverso, in quanto altro non è se non il traguardo di quel processo di ascesi che annulla gradualmente la volontà e le stesse funzioni vitali (tale suicidio è dunque accettabile perchè riesce ad annullare e a far estinguere la volontà). Schopenhauer nota però amaramente che l'annullamento della volontà non è ancora stato raggiunto da nessun uomo (sebbene i mistici ci siano andati vicini), altrimenti il mondo non esisterebbe più: infatti, annullare la volontà significa annullare il mondo, che di essa è rappresentazione fenomenica (e senza la "cosa in sè" non può nemmeno esserci il fenomeno). Come meta dell'annullamento della volontà si può pervenire ad una sorta di Nirvana , ossia al raggiungimento del nulla: ma Schopenhauer critica aspramente il Nirvana prospettato dai Buddhisti, in quanto, regalando una specie di beatitudine paradisiaca, sembra essere eccessivamente positivo. Il nulla così come lo intende Schopenhauer non vuol essere un paradiso, ma piuttosto un puro e semplice annullamento di questo mondo, senza con questo voler dire che tale annullamento coincida con il "nulla" come generalmente lo si concepisce: non si può infatti dire (non essendo ancora stato raggiunto) che tipo di nulla sarà quello successivo all'annullamento della volontà. E così Schopenhauer conclude il Mondo : " lo riconosciamo francamente: per coloro che sono ancora animati dal volere, ciò che resta dopo la totale soppressione della volontà è il vero ed assoluto nulla. Ma viceversa, per coloro in cui la volontà si è convertita e soppressa, questo mondo così reale, con tutti i suoi soli e le sue vie lattee, questo, propriamente questo, è il nulla "; come a dire che per chi è ancora nel circolo della volontà, la nolontà è il nulla; per chi invece la capovolgerà in nolontà, il mondo è il nulla. E' ora bene spendere qualche parola sul pessimismo che informa la filosofia leopardiana: che la tesi pessimista sia difficile da sostenere se n'erano già accorti, ad esempio, Agostino e i Neoplatonici, che si erano visti costretti a concepire il male come una pura e semplice assenza di bene. E infatti quando si finisce per dire che tutto è male, in qualche modo lo si fa in riferimento ad un qualcosa di opposto che è il bene. Questo emerge benissimo nella chiusura del Mondo , in cui Schopenhauer, dopo aver sostanzialmente dichiarato che tutto è male, apre un tenue spiraglio asserendo che tutto è male dal punto di vista in cui ci troviamo noi, ma ciò che per noi è il nulla, non è detto che nella realtà sia il nulla in assoluto: forse potrebbe esserci una dimensione positiva. Tutto ciò può essere d'aiuto per impostare un paragone con l'altro grande pessimista di quegli anni, Leopardi: se Schopenhauer ha una concezione profondamente metafisica della realtà, il poeta e filosofo marchigiano, invece, ha una concezione radicalmente meccanicistica. Questa differenza fa sì che per Schopenhauer il mondo è male, per Leopardi è la nostra condizione ad essere malvagia, non il mondo : esso, di per sè, è del tutto indifferente all'uomo e alle sue sorti, come si evince benissimo, ad esempio, nel Bruto minore , dove Leopardi immagina che Bruto, unico sopravvissuto al massacro della battaglia di Filippi, volga gli occhi in cielo e scorga la luna, nè benigna nè avversa all'uomo e alle sue disgrazie. Dunque, per Schopenhauer esiste una volontà maligna, per Leopardi il male non esiste o, meglio, esiste solo la tragicità dell'esistenza, tesi con la quale anticipa l'esistenzialismo e la sua tesi centrale secondo cui l'uomo è gettato nel mondo. Si può notare come Leopardi sia molto più pessimista di Schopenhauer, in quanto, nella misura in cui si concepisce una volontà maligna imperante nel mondo, si ammette anche una possibilità di capovolgerla, poichè ponendo il male si pone anche concettualmente il bene; Leopardi, invece, ponendo non il male, ma il nulla (tipico anche di Kierkegaard) e l'indifferenza della natura non lascia spazio alcuno al bene. Tuttavia, al di là delle differenze, vi sono anche punti in comune tra i due pensatori: sia Schopenhauer sia Leopardi sono convinti che il dolore aumenti con la consapevolezza (per cui l'uomo soffre più degli animali perchè sa già che dovrà morire) e che la vita sia un ondeggiare continuo tra il dolore e la noia. Ma Leopardi non dà quelle speranze che invece prospetta Schopenhauer: per quest'ultimo la compassione è un primo passo verso la salvezza, per il poeta marchigiano è un puro e semplice aiuto per meglio sopportare la sofferenza.
Opere Principali
- Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde (Sulla quadruplice radice del principio di ragion sufficiente) 1813
- Die Welt als Wille und Vorstellung (Il Mondo come volontà e rappresentazione) 18191, 18442, 18593
Vita
La sua famiglia era di origine olandese, il padre ricco commerciante di Danzica (ove Arthur nacque il 22 febbraio 1788)
il giovane Arthur viaggiò molto, per imparare le lingue e poter proseguire il lavoro del padre: fu così in Francia (Le Havre 1797/9), a Karlsbad, Praga, Olanda, Inghilterra, Svizzera, Austria, Slesia e Prussia.
Morto il padre per suicidio (1805) ereditò una fortuna cospicua, che gli permise di vivere di rendita, studiando: prima al ginnasio (di Gotha, e poi di Weimar), poi all'università di Gottinga (1809/11), dove conobbe G.E.Schulze, che lo introdusse a Kante a Platone, e Berlino (1811/13), dove seguì Schleiermacher, Fichte e il filologo F.A.Wolf.
Per la guerra, raggiunse a Weimar la madre, che (romanziera) vi teneva un salotto letterario, cui veniva anche Goethe, e si laureò a Jena nello stesso 1813, con una tesi Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde, apprezzata da Goethe. Ivi conobbe anche l'orientalista Friedrich Mayer, estimatore delle Upanišhad.
Ruppe ben presto con la madre, Johanna Henriette, che aveva accolto in casa un amante, nel 1814.
Si trasferì così a Dresda e qui pubblicò Die Welt als Wille und Vorstellung, suo capolavoro, scritto nel 1818 e pubblicato nel 1819. Dopo un viaggio in Italia, ottenne la libera docenza a Berlino nel 1820, discutendo con Hegel, col quale venne a diverbio; e a Berlino rimase, frustrato per la concorrenza hegeliana, per cui le sue lezioni erano disertate, fino al 1831, quando vi si diffuse un'epidemia di colera.
Allora si trasferì a Francoforte, dove rimase fino alla morte, sopraggiunta nel 1860. Di tale periodo sono La volontà della natura (1836), I due problemi fondamentali dell’etica (1841) e il brillante e popolare Parerga et paralipomena (1851). Tali opere gli guadagnarono riconoscimenti pubblici e maggior successo delle opere precedenti.
Come scrive Abbagnano "nessun successo immediato arrise all'opera di Schopenhauer, che dovette aspettare più di vent'anni per pubblicare la seconda edizione del Mondo come volontà e rappresentazione, edizione che egli arricchì di un secondo volume di note e supplementi. (…) Soltanto dopo il 1848, in concomitanza con un'ondata di pessimismo che colpì l'Europa, cominciò la "fortuna" della sua filosofia". E in generale la fortuna della sua filosofia tende ricorrentemente a coincidere con periodi in cui l'umanità occidentale avverte il bisogno di una spiegazione della realtà che ne evidenzi la tragicità.
la critica all'idealismo
Schopenhauer critica in generale "i tre grandi ciarlatani" idealisti, e in particolare Hegel, "sicario della verità", la cui filosofia è mercenaria, al servizio dello Stato:
"Hegel, insediato dall'alto, dalle forze al potere, fu un ciarlatano di mente ottusa, insipido, nauseabondo, illetterato, che raggiunse il colmo dell'audacia scodellando i più pazzi e mistificanti non sensi"
il suo pensiero è "una buffonata filosofica".
i riferimenti del suo pensiero
Furono Kant, da cui prese la distinzione tra fenomeno e noumeno, interpretandola però in modo difforme dallo stesso Kant, attribuendo al fenomeno una valenza di illosorietà a quello sconosciuta (dato che al contrario per il filosofo di Koenigsberg proprio del fenomeno e anzi solo del fenomeno si piò dare conoscenza rigorosamente scientifica e valida), Platone (da cui trasse la concezione delle idee, anche qui però intese in modo originale, "forme eterne sottratte alla caducità dolorosa del nostro mondo" (Abbagnano) come strato ontologico intermedio tra il centro della realtà, che è cieca Volontà e l'apparenza fenomenica più superficiale), e la filosofia indiana, da cui appunto trae la decisiva convinzione del carattere ingannevole del mondo sensibile, che altri filosofi occidentali avevano sì in precedenza definito imperfetto, e al limite prossimo al nulla (Parmenide, Platone, Plotino), ma mai giudicato deformante inganno.
1a) il mondo come rappresentazione
Noi non conosciamo le cose in sé stesse ("vediamo non il sole né la terra"), ma in quanto sono rapportate al soggetto, dipendenti dal soggetto, "interne" ad esso (conosciamo "l'occhio che vede il sole, la mano che sente il contatto con la terra"), e il soggetto filtra la realtà con le tre categorie (una sorta di a-priori, che il soggetto pone mediante l'intelletto, analogamente a Kant, con la differenza che per Sch. le categorie hanno una matrice fisiologica, piuttosto che trascendentale)
|
la causalità a sua volta, in quanto principio di ragion sufficiente, assume quattro forme, ossia |
causa fiendi (cioè del divenire; regola i rapporti causali); causa cognoscendi (regola i rapporti tra i giudizi); causa essendi (regola i rapporti tra le parti del tempo e dello spazio); causa agendi (regola i rapporti tra le azioni); |
- (spazio e tempo (che rendono molteplice l'oggetto)
- la causalità (che lo rende un "cosmo conoscitivo"), poste come per Kant, dall'intelletto
Essa è perciò fenomeno, nel senso di apparenza, in parentela stretta col sogno, analogamente a Pindaro ("l'uomo è il sogno di un'ombra"), Sofocle, Shakespeare ("noi siamo di tale stoffa, come quella di cui son fatti i sogni, e la nostra breve vita è chiusa in un sonno"), Calderòn, o, con espressione di derivazione indiana, "velo di Maya".
- " è Maya, il velo ingannatore, che avvolge gli occhi dei mortali e fa loro vedere un mondo del quale non può dirsi nê che esista, nê che non esista; perchê ella rassomiglia al sogno, rassomiglia al riflesso del sole sulla sabbia, che il pellegrino da lontano scambia per acqua; o anche rassomiglia alla corda gettata a terra che egli prende per un serpente (Il mondo come volontà …, paragrafo 3)
ma c'è il modo per giungere alla realtà in sé stessa:
1b) e come volontà
esistenza della Volontà
Ne posso essere certo in quanto
a)ho accesso diretto alla mia volontà, che sperimento essere la mia più intima essenza, facente tutt'uno con il moto del mio corpo (che posso infatti conoscere o oggettivandolo, o dall'interno, come mosso dalla volontà).
Io sono volontà, Wille zum Leben, impulso prepotente;
b)per analogia estendo questo a tutto il reale:
osservando nei fenomeni naturali "l'impeto violento e irresistibile con cui le acque si precipitano negli abissi, … l'ansia con cui il ferro vola verso la calamita, la violenza con cui i poli elettrici tendono a riunirsi …[riconosciamo] quell'identica essenza che in noi persegue i suoi fini al lume della conoscenza, ma che qui non ha che impulsi ciechi, sordi, unilaterali e invariabili" (§ 23 Il mondo come volontà e rappresentzione)
sua essenza
La Volontà è inconscia…
Come ricorda Abbagnano: "essendo al di là del fenomeno, la Volontà presenta caratteri contrapposti a quelli del mondo della rappresentazione, in quanto si sottrae alle forme proprie di quest'ultimo: lo spazio, il tempo e la causalità. Innanzitutto la Volontà primordiale è inconscia, poichê la consapevolezza e l'intelletto costituiscono soltanto delle sue possibili manifestazioni secondarie. Di conseguenza, il termine Volontà, preso in senso metafisico-schopenhaueriano, non si identifica con quello di volontà cosciente, ma con il concetto più generale di energia o di impulso (e in questo senso si comprende perchè Schopenhauer attribuisca la volontà anche alla materia inorganica e ai vegetali)."
…unica…
In secondo luogo, la Volontà risulta unica, poichò esistendo al di fuori dello spazio e del tempo, che dividono gli enti, si sottrae costituzionalmente a ciò che egli chiama "principio di individuazione". Infatti la Volontà non è qui più di quanto non sia là, più oggi di quanto non sia stata ieri o sarà domani. Essa, dice Schopenhauer, "è in una quercia come in un milione di querce".
…eterna…
Essendo oltre la forma del tempo, la Volontà è anche eterna e indistruttibile, ossia un Principio senza inizio nè fine. Per questo, Schopenhauer scrive che "alla Volontà è assicurata la vita" e paragona il perdurare dell'universo nel tempo ad un "meriggio eterno senza tramonto refrigerante", oppure all'"arcobaleno sulla cascata", non toccato dal fluire delle acque (op.cit., paragrafo 54).
…assurda e cieca.
Essendo al di là della categoria di causa, e quindi di ciò che Schopenhauer denomina "principio di ragione", la Volontà si configura anche come una Forza libera e cieca, ossia come un'Energia incausata, senza un perchè e senza uno scopo. Infatti noi possiamo cercare la "ragione" di questa o quella manifestazione fenomenica della Volontà, ma non della Volontà in se stessa, esattamente come possiamo chiedere ad un uomo perchè voglia questo o quello, ma non perchè voglia in generale. Tant'è che a quest'ultima domanda l'individuo non potrebbe rispondere che "voglio perchè voglio", ossia, traducendo la frase in termini filosofici, " perchè c'è in me una volontà irresistibile che mi spinge a volere". Infatti, la Volontà primordiale non ha una mèta oltre se stessa: la vita vuole la vita, la volontà vuole la volontà, ed ogni motivazione o scopo cade entro l'orizzonte del vivere e del volere (op.cit., paragrafo 29).
consegnenze etiche
Vi è in Schopenhauer un rifiuto di ogni ottimismo:
"Ogni volere scaturisce da bisogno, ossia da mancanza, ossia da sofferenza. A questa dà fine l'appagamento; tuttavia per un desiderio che venga appagato, ne rimangono almeno dieci insoddisfatti; inoltre la brama dura a lungo, le esigenze vanno all'infinito; l'appagamento è breve e misurato con mano avara. Anzi, la stessa soddisfazione finale è solo apparente: il desiderio appagato dà tosto luogo a un desiderio nuovo: quello è un errore riconosciuto, questo un errore non ancora conosciuto. Nessun oggetto del volere, una volta conseguito, può dare appagamento durevole… bensì rassomiglia soltanto all'elemosina, la quale gettata al mendico prolunga oggi la sua vita per continuare domani il suo tormento" (op.cit., paragrafo 38).
La realtà è una '"arena di esseri tormentati e angosciati, i quali esistono solo a patto di divorarsi l'un laltro, dove perciò ogni animale carnivoro è il sepolcro vivente di mille altri e la propria autoconservazione è una catena di morti strazianti"
"Se si conducesse il più ostinato ottimista attraverso gli ospedali, i lazzaretti, le camere di martirio chirurgiche, attraverso le prigioni, le stanze di tortura, i recinti degli schiavi, i campi di battaglia e i tribunali, aprendogli poi tutti i sinistri covi della miseria, dove ci si appiatta per nascondersi agli sguardi della fredda curiosità, e da ultimo facendogli ficcar l'occhio nella torre della fame di Ugolino, certamente finirebbe anch'egli con l'intendere di qual sorte sia questo meilleur des mondes possibles. Donde ha preso Dante la materia del suo Inferno, se non da questo mondo reale? E nondimeno n'è venuto un inferno bell'e buono. Quando invece gli toccò di descrivere il cielo e le sue gioie, si trovò davanti a una difficoltà insuperabile: appunto perchê il nostro mondo non offre materiale per un'impresa siffatta" (op.cit., paragrafo 59)
"A diciassette anni, ancora privo di ogni cultura, fui colpito dalla miseria della vita così profondamente come Buddha nella sua gioventù, quando vide per la prima volta la malattia, la vecchiaia, il dolore e la morte. La verità che del mondo mi parlava chiaro e tondo, ebbe presto il sopravvento sui dogmi ebraici che mi erano stati inculcati; e la mia conclusione fu che questo mondo non poteva essere l'opera di un ente assolutamente buono… "
"Verrà un tempo in cui la dottrina di un Dio come creatore sarà considerata in metafisica, come ora, in astronomia, si considera la dottrina degli epicicli"
“Dei mali della vita ci si consola con al morte, e della morte con i mali della vita. Una gradevole situazione”
“Noi ci consoliamo delle sofferenze della vita pensando alla morte, e della morte pensando alle sofferenze della vita”
“…alla fine tutti quanti siamo e restiamo soli”
“Alla natura sta a cuore solo la nostra esistenza, non il nostro benessere”
“Ogni sera siamo più poveri di un giorno”
“Dal punto di vista della giovinezza la vita è infinita; dal punto di vista della vecchiaia è un brevissimo passato”
“Si può dire quello che si vuole! Il momento più felice di chi è felice è quando si addormenta, come il momento più infelice di chi è infelice è quando si risveglia”
“A parte poche eccezioni, al mondo tutti, uomini e animali, lavorano con tutte le forze, con ogni sforzo, dal mattino alla sera solo per continuare ad esistere: e non vale assolutamente la pena di continuare ad esistere; inoltre dopo un certo tempo tutti finiscono. È un affare che non copre le spese”
“Se è stato un Dio a creare questo mondo, non vorrei essere lui: la sofferenza nel mondo mi spezzerebbe il cuore”
“Chi ama la Verità odia gli dèi, al singolare come al plurale”
in realtà la storia ci inganna facendoci credere che le cose cambino sostanzialmente, mentre ha ragione l'Ecclesiaste: non vi è nulla di nuovo sotto il sole in ogni tempo fu, è e sarà sempre la stessa cosa (Il mondo come volontà e rappresentazione, II, 38)
"Mentre la storia ci insegna che in ogni tempo avviene qualcosa di diverso, la filosofia si sforza di innalzarci alla concezione che in ogni tempo fu, è, e sarà sempre la stessa cosa" (Supplementi, capitolo 38)
"Ogni giubilo eccessivo nasce sempre dall’illusione di aver trovato nella vita qualcosa che è impossibile trovarvi, e cioè la pacificazione definitiva del tormento"
"chi considera bene .. scorge il mondo come un inferno, che supera quello di Dante in questo, che ognuno è diavolo per l'altro."
"l'uomo è l'unico animale che faccia soffrire gli altri al solo scopo di far soffrire"
“Ciò che rende gli uomini socievoli è la loro incapacità di sopportare la solitudine e se stessi. […] Tutti i pezzenti sono socievoli, da far pietà”
"Vi è dunque, nel cuore di ogni uomo, una belva, che attende solo il momento propizio per scatenarsi ed infuriare contro gli altri" (Parerga, 2, 114)
"Come l'uomo si comporti con l'uomo, è mostrato, ad esempio, dalla schiavitù dei negri. Ma non v'è bisogno di andare così lontani: entrare nelle filande o in altre fabbriche all'età di cinque anni, e d'allora in poi sedervi prima per dieci, poi per dodici, infine per quattordici ore al giorno, ed eseguire lo stesso lavoro meccanico, significa pagar caro il piacere di respirare. Eppure questo è il destino di milioni, e molti altri milioni ne hanno uno analogo"
"la vita è un continuo oscillare tra dolore e noia"
- cosmico (quello delle religioni, con la loro idea di Provvidenza)
- storico (il progresso, come in Hegel, Comte, Marx e altri):
- sociale (secondo cui l'uomo è naturalmente buono verso gli altri):
2) la liberazione
|
/ Schopenhauer rifiuta il suicidio come via alla liberazione per due motivi : \ |
1) perchè "il suicidio, lungi dall'essere negazione della volontà, è invece un atto di forte affermazione della volontà stessa" in quanto il suicida "vuole la vita ed è solo malcontento delle condizioni che gli sono toccate" (ivi, paragrafo 69), per cui anzichê negare veramente la volontà egli nega piuttosto la vita; |
| 2) perchê il suicidio sopprime unicamente l'individuo, ossia una manifestazione fenomenica della Volontà di vivere, lasciando intatta la cosa in sé, che pur morendo in un individuo rinasce in mille altri, simile al sole che, appena tramontato da un lato, risorge dall'altro." (Abbagnano) |
Essa ha come momenti principali
a)l'arte: "mentre la conoscenza, e quindi la scienza, è continuamente irretita nelle forme dello spazio e del tempo, ed asservita ai bisogni della volontà, l'arte, secondo Schopenhauer, è conoscenza libera e disinteressata, che si rivolge alle idee, ossia alle forme pure o ai modelli eterni delle cose." (Abbagnano)
- "Mentre per l'uomo comune, il proprio patrimonio conoscitivo è la lanterna che illumina la strada, per l'uomo geniale è il sole che rivela il mondo".
b) la compassione, che rompe la catena di egoismi che mette ogni individuo contro l'altro, causando inutile e assurda sofferenza.
- “L’amore autentico è sempre compassione; e ogni amore che non sia compassione è egoismo”
c) l'ascesi
- essa nasce dall'"orrore" dell'uomo "per l'essere di cui è manifestazione il suo proprio fenomeno, per la volontà di vivere, per il nocciolo e l'essenza di un mondo riconosciuto pieno di dolore" (ivi, paragrafo 68), è l'esperienza per la quale l'individuo, cessando di volere la vita ed il volere stesso, si propone di estirpare il proprio desiderio di esistere, di godere e di volere: "Con la parola ascesi… io intendo, nel senso più stretto, il deliberato infrangimento della volontà, mediante l'astensione dal piacevole e la ricerca dello spiacevole, l'espiazione e la macerazione spontaneamente scelta, per la continuata mortificazione della volontà" (ivi).
comporta la perfetta castità, la rinuncia ai piaceri, l'umiltà, il digiuno, la povertà, il sacrificio e l'automacerazione
Fino ad arivare alla noluntas
"il deliberato infrangimento della volontà,… per la continuata mortificazione della volontà"
"Quel che rimane dopo la soppressione completa della volontà – dice Schopenhauer alla fine della sua opera – è certamente il nulla per tutti coloro che sono ancora pieni della volontà. Ma per gli altri, in cui la volontà si è distolta da se stessa e rinnegata, questo nostro universo tanto reale, con tutti i suoi soli e le sue vie lattee è, esso, il nulla" (ivi, paragrafo 71).
Note
- Nota 1
Secondo Abbagnano "dell'Illuminismo lo interessano il filone materialistica e quello dell'ideologia, da cui eredita la tendenza a considerare la vita psichica e sensoriale in termini di fisiologia del sistema nervoso. Inoltre da Voltaire desume lo spirito ironico e brillante e la tendenza demistificatrice nei confronti delle credenze tramandate. Dal Romanticismo Schopenhauer trae alcuni temi di fondo del suo pensiero, come ad esempio l'irrazionalismo, la grande importanza attribuita all'arte e alla musica, e, soprattutto, il tema dell'infinito, cioè la tesi della presenza, nel mondo, di un Principio assoluto di cui le varie realtà sono manifestazioni transeunti. Altro motivo indubbiamente romantico è quello del dolore. Tuttavia mentre il Romanticismo, sul piano filosofico, mostra una tendenza globalmente ottimistica, che si concretizza in un tentativo di dialettizzare o riscattare il negativo tramite il positivo (Dio, lo Spirito, la storia, il progresso eccetera) Schopenhauer appare decisamente orientato verso il pessimismo, di cui è uno dei maggiori teorici. Decisiva importanza, anche se indiretta, gioca pure l'idealismo, vera "bestia nera" e "idolo polemico" dello schopenhauerismo."
L'ARTE E LA MUSICA
" L'arte si deve necessariamente considerare come il grado più alto, come l'evoluzione più perfetta di quanto esiste; ci offre infatti essenzialmente la stessa cosa che il mondo visibile; ma più concentrata, più perfetta, con scelta e con riflessione: possiamo quindi, nel vero senso della parola, chiamarla il fiore della vita. Se il mondo come rappresentazione non è che volontà divenuta visibile, l'arte è precisamente tale visibilità resa più chiara; la camera oscura che abbraccia meglio e con una sola occhiata; è lo spettacolo nello spettacolo, la scena nella scena. "
L’arte ha per Schopenhauer un doppio valore. Valore teoretico . La ragione, la quale ci consente di raggiungere le alte vette ed astrazioni della matematica e della fisica, grazie alla quale abbracciamo gli infiniti spazi cosmici ed oltre, è tuttavia prigioniera del principium individuationis, non può squarciare il velo di Maya e fornirci una conoscenza concettuale di ciò che vi è al di là. Dunque il requisito per tale conoscenza è l’evasione, pur momentanea dalla volontà. Questa condizione è realizzata nella contemplazione, nel rapimento estetico visto che in questa particolare condizione ci liberiamo momentaneamente degli impulsi della volontà è ciò che l’arte rappresenta, il puro dato sensibile diventa simbolo, metafora della pura idea che vi soggiace. È evidente che, essendo la ragione esclusa da tale processo conoscitivo, ed essendo i concetti e le parole, i mezzi attraverso cui essa opera, non è possibile esprimere con i linguaggi tradizionali ciò che risiede oltre il mondo dominato dalla volontà. Il linguaggio dell’arte è invece un linguaggio allegorico, che si esprime per metafore, immagini delle idee. Tutte le arti sono rappresentazione dei diversi gradi di oggettivazione della volontà dai più bassi del mondo inorganico fino al più alto: l’uomo. Tuttavia come ribadisce lo stesso Schopenhauer negli ultimi periodi del §52 lo stesso mondo come rappresentazione visto dall’asceta che è riuscito a svincolarsi dalla volontà è una visione rasserenante di quest’ultima e delle sue oggettivazioni sensibili ed ideali. L’arte non fa che rendere ciò che nel mondo è già visibile (agli occhi dell’asceta) più chiaro ancora, concentrato nella purezza e perfezione dell’idea. Valore catartico . Partendo dall’assunto che il mondo mosso dalla volontà è dominato dalla guerra, dagli egoismi e dal dolore e che nessun essere (dal sasso, all’animale, all’uomo) ne è libero, bensì tutti sono ugualmente destinati alla sofferenza in modo proporzionale al grado di consapevolezza, la contemplazione estetica, in quanto consente all’uomo di liberarsi momentaneamente dalla volontà sottrae allo stesso tempo l’uomo alla sofferenza, al ciclo di dolore (desiderio), piacere (appagamento) e noia (assenza di desiderio) che contraddistingue la sua condizione. La musica occupa una posizione eccentrica rispetto alle altre arti. Infatti non è solo rappresentazione, immagine, allegoria di un’idea, ma è l’allegoria, l’immagine, la rappresentazione della volontà medesima di cui è oggettivazione al pari delle idee. Ad essa vengono dedicati il §52, ultimo del libro terzo “Il mondo come rappresentazione” nel capitolo “L’idea platonica: l’oggetto dell’arte” e nel capitolo 39 dei “Supplementi al libro terzo” intitolato “Sulla metafisica della musica”. Essendo l’immagine stessa della volontà ci consente di cogliere l’in sé di ogni fenomeno, la forma pura privata della materia (in abstracto). Ma cos’è la volontà se non impulso cieco e irrazionale, passione, sentimento? E proprio questo è il linguaggio della musica: il sentimento, contrapposto al concetto della ragione. Questo esprime la musica quando “parla”: ci racconta la vita più intima e segreta della volontà, attraverso i gradi della sua oggettivazione, dal mondo inorganico all’uomo, dalla forza bruta ai più delicati moti e sentimenti dell’animo umano. Schema che visualizza la concezione schopenhaueriana della musica come immediata oggettivazione della Volontà al pari delle idee rispetto alle quali si trova allo stesso livello. Così come poi le idee sono ordinate secondo una precisa gerarchia di consapevolezza che culmina nell’uomo (l’essere che, in quanto dotato di ragione è fra tutti il più consapevole) e si moltiplicano attraverso le dimensioni spazio-temporali e causali originando tutti i fenomeni esistenti, così la musica stessa è ordinata in una gerarchia di suoni di altezza crescente che sono in diretto parallelismo con le varie idee ed i fenomeni in cui esse si oggettivano e particolarizzano La musica nella sua struttura raccoglie perciò l’intero mondo. Di conseguenza Schopenhauer procede nella sua analisi metafisica della musica (che ripercorreremo nella pagine seguenti), instaurando una serie di parallelismi e analogie fra mondo e musica. Infatti al pari delle idee la musica è immediata oggettivazione e copia della medesima volontà e differisce perciò dalle idee solo nella forma. Al pari delle altre arti la musica è in grado di sottrarci momentaneamente alla sofferenza, ma non solo. Vista la sua natura è in grado di influire sulla volontà, riproducendo in noi gli infiniti moti di quest’ultima (ruolo che vedremo affidato alla melodia), il suo incessante ciclo di insoddisfazione e appagamento. Non è tuttavia da ritenere che per questo motivo perda il suo potere catartico. Infatti non è in grado di farci soffrire veramente essendo solo pura, distaccata, rappresentazione. Come tutte le arti anche la musica esige che “la volontà resti fuori dal gioco e che noi ci limitiamo ad essere puro soggetto conoscente” " Quando, invece, nella realtà con i suoi orrori, è la volontà stessa ad essere sollecitata ed angosciata, non abbiamo più a che fare con suoni e rapporti numerici, ma siamo noi in persona adesso la corda tesa, pizzicata e vibrante ".
IL COMICO
1. Le fonti. La teoria della comicità e dell'arguzia si trova nel § 13 dell'opera principale di Schopenhauer: Il mondo come volontà e rappresentazione (1818). Il Mondo, tuttavia, non ebbe il successo sperato, e Schopenhauer mette mano a una riedizione dell'opera solo nel '44. La mole del libro cresce sensibilmente: Schopenhauer l'arricchisce di molti supplementi. Tra questi vi è anche un approfondimento della teoria del ridicolo (Supplementi, cap. VIII), volto più a chiarire che a correggere le pagine del 1818. Nel corso delle nostre considerazioni ci rifaremo, senza ulteriori indicazioni, alle pagine del Mondo e dei Supplementi.
2. Una premessa necessaria: intelletto e ragione nella filosofia di Schopenhauer. Le riflessioni di Schopenhauer sul riso si collocano nel primo libro de Il mondo come volontà e rappresentazione, e costituiscono una breve digressione volta a far luce su uno dei nodi centrali della sua filosofia: il rapporto tra intelletto e ragione. Di qui la necessità di premettere alle nostre considerazioni una breve esposizione del senso che Schopenhauer attribuisce a queste due facoltà che, a partire almeno dalla Critica della ragion pura, diventano centro di interpretazioni contrastanti.
Per Schopenhauer come per Kant, l'intelletto ha una funzione trascendentale: permette di passare dall'ambito delle sensazioni alla sfera degli oggetti della nostra esperienza. Il rimando a Kant, tuttavia, non deve impedirci di cogliere una differenza sostanziale: per Schopenhauer, e non certo per Kant, l'intelletto fa tutt'uno con l'intuizione e non deve essere inteso alla luce della forma logica del giudizio. L'esperienza non assume validità obiettiva grazie alle categorie della logica trascendentale: se dalle sensazioni come modificazioni della nostra corporeità risaliamo agli oggetti non è perché i dati sensibili vengono connessi nell'unità di un giudizio, ma è solo in virtù dell'interpretazione tanto irriflessa, quanto istintiva che ci costringe a pensare alla causa dei nostri stati psicologici. L'intelletto non è allora, per Schopenhauer, la kantiana facoltà di pensare i fenomeni, ma è ciò che permette all'uomo e agli altri animali di orientarsi nel mondo e di intuirlo come una concatenazione di eventi causalisticamente connessi.
Diversamente stanno le cose per la ragione. La ragione è, per Schopenhauer, la facoltà che ci permette di risalire dalla rappresentazione al concetto e di cogliere le relazioni che tra i concetti sussistono. L'uomo non si limita a operare nell'esperienza, ma riflette anche sull'esperienza: la ragione ci permette di riflettere sulla realtà, di raccogliere nell'unità di una rappresentazione di secondo grado (di una rappresentazione di rappresentazioni) una molteplicità di rappresentazioni individuali tra loro per qualche aspetto simili.
E tuttavia, nella natura mediata del concetto, Schopenhauer non coglie soltanto la definizione logica del pensiero razionale, ma anche la sua più generale collocazione metafisica:
come dalla luce diretta del Sole si passa a quella riflessa della Luna, così ora passeremo dalla rappresentazione intuitiva che si afferma e garantisce da sé, alla riflessione, ai concetti astratti della ragione (Il mondo come volontà e rappresentazione, op. cit., p. 75)
– così scrive Schopenhauer, e di quest'immagine che apre le sue considerazioni sulla ragione non si può rendere conto solo richiamandosi alla tesi di sapore empiristico secondo la quale il piano concettuale non fa che rispecchiare in forma attenuata la ricchezza del mondo intuitivo. Dietro quell'immagine vi è altro: il Sole è calore, luce, vitalità, mentre la Luna è un valore notturno, e brilla di luce fredda nella sua lontananza dalle vicende umane.
Sono proprio questi valori immaginativi che Schopenhauer intende proiettare sulla nozione dio ragione. Finché si muove sul terreno dell'intuizione concreta, l'uomo è interamente immerso nel presente, ed è tutt'uno con la natura e con il mondo e quindi anche con la volontà che lo anima. La ragione strappa l'uomo da questo sicuro (e ingenuo) sentimento della vita e lo getta in una nuova dimensione dell'esistenza, più fredda e priva di colore e di vitalità. In altri termini, la ragione ci distacca dal flusso dell'esperienza, ci permette – per così dire – di contemplare dall'alto ciò che accade. I concetti, proprio perché ci permettono di avanzare previsioni raccordando il presente all'esperienza passata, ci strappano dal dominio che l'attimo esercita su di noi, disponendoci in una dimensione diacronica e quindi storica. La ragione è dunque ciò che allontana l’uomo dalla vita, che cancella la sua piena e spontanea adesione al mondo, separandolo dalla natura e dal suo continuo fluire.
Questa separazione ha il suo suggello nella paura della morte che è così tipica dell’uomo e che dipende dalla sua razionalità: solo perché la ragione strappa l’uomo dalla sua immediata e vitale adesione al mondo, solo perché lo toglie dall’attimo presente in cui è la vita, per disporlo nella prospettiva della storia, solo per questo può insinuare nel suo animo la paura per ciò che ancora non è, ma verrà – la morte.
3. Il riso come rivincita della vita: la teoria schopenhaueriana del ridicolo. Sullo sfondo metafisico che abbiamo delineato si colloca la dottrina schopenhaueriana del ridicolo. Si tratta di una teoria molto semplice che tuttavia pretende di avere validità universale:
Il riso – osserva Schopenhauer – proviene sempre da un’incongruenza subitamente constatata fra un concetto e l’oggetto reale cui quel concetto, in un modo o nell’altro, ci fa pensare; e non è appunto se non l’espressione di questa incongruenza (ivi, p. 109).
È facile suggerire degli esempi che mostrino concretamente il senso di questa definizione. Di un predicatore noiosi può dire "Bav è il buon pastore di cui la Bibbia parlava / quando il suo gregge dormiva lui solo vegliava" (ivi, p. 854), così come nell’epitaffio di un medico si può scrivere "egli giace qui, come un eroe circondato dalle sue vittime" (ivi), ed in entrambi i casi il riso nasce perché ciò che si adatta bene al concetto (il pastore che si preoccupa delle sorti di un’umanità ignara e il combattente caduto dopo aver fatto strage del nemico) si dimostra invece del tutto incongruente non appena ci poniamo sul terreno dell’oggetto concreto (ivi).
Da questa base semplicissima, Schopenhauer muove per caratterizzare ulteriormente il fenomeno che gli sta a cuore. Un’incongruenza tra conoscenza astratta e conoscenza intuitiva può avere luogo in due diverse forme:
o sono dati nella conoscenza due o più differenti oggetti reali, due o più rappresentazioni intuitive che identifichiamo arbitrariamente nell’unità di un concetto comune […]. Oppure, viceversa, c’è dapprima nella conoscenza il concetto, dal quale passiamo in seguito alla realtà, cioè alla pratica: oggetti radicalmente differenti sotto ogni altro aspetto, ma che il pensiero abbraccia sotto un solo concetto, vengono trattati e considerati tutti allo stesso modo; finché da ultimo la grande divergenza che li separa finisce per dare nell’occhio con grande sorpresa e meraviglia di chi opera (ivi, p. 109).
Schopenhauer propone di chiamare arguzia il primo genere del ridicolo, per riservare al secondo il nome di buffoneria. Questa classificazione del ridicolo può essere ulteriormente arricchita, e Schopenhauer si muove in questa direzione quando illustra brevemente la natura del calembour, dello scherzo, dell’ironia, dell’umorismo. Tuttavia, piuttosto che soffermarci su queste nozioni che possono essere desunte facilmente dalle pagine schopenhaueriane e che restano comunque in ombra nella sua teoria, vorremmo soffermarci un poco sulla distinzione principale che Schopenhauer propone: quella tra buffoneria e arguzia. L’arguzia, egli osserva, è sempre volontaria: sorge quando intendiamo mostrare l’incapacità di un concetto di dominare la ricchezza di senso del materiale intuitivo. Al contrario la buffoneria è sempre involontaria, e ha la sua origine nella convinzione, che si mostrerà poi erronea, di avere nella ragione una guida sicura per le nostre azioni. Così, seppure da prospettive diverse, buffoneria ed arguzia ci mostrano uno stesso stato di cose: ciò che l’uomo arguto ci fa comprendere e che traspare nel gesto del buffone è di fatto
l’incapacità della ragione con i suoi concetti astratti ascendere fino all’infinita molteplicità e alle infinite sfumature dell’intuizione (ivi, pp.860-1).
Del resto, è proprio in questo incrinarsi del dominio della ragione sulla vita che consiste la forma del piacere che proviamo ridendo:
è questa vittoria della conoscenza intuitiva sul pensiero che ci rallegra. Intuire è infatti il modo primitivo di conoscere, inseparabile dalla natura animale, un conoscere in cui si presenta tutto ciò che dà soddisfazione immediata alla volontà: è l’intermediario del presente, del godimento, della gioia […]. Con il pensiero accade sempre il contrario: pensare è il conoscere alla seconda potenza, che esige sempre qualche sforzo, spesso anche considerevole; suoi sono i concetti, che così spesso si oppongono alla soddisfazione dei nostri desideri immediati, giacché tali concetti, come intermediari del passato, del futuro e della serietà, fanno da veicoli ai nostri timori, ai nostri rimorsi e a tutte le nostre preoccupazioni. Dev’essere perciò un godimento scoprire una buona volta l’insufficienza della ragione, di questa governante severa, instancabile e opprimente. Per questo dunque l’espressione del riso e quella della gioia si assomigliano tanto (ivi, p. 861).
L’immagine della ragione come una governante opprimente e saccente indica del resto la via per comprendere quell’accostamento tra pedanteria e buffoneria che, a prima vista, può stupire, ma che è in realtà perfettamente coerente con l’approccio schopenhaueriano. Il pedante ha poca fiducia nelle sue capacità intuitive e teme l’urgenza e la complessità dei problemi che il presente gli pone: si arma per questo di un insieme di regole che gli permettono di cancellare la novità del presente, riconducendolo (e quindi riducendolo) a ciò che è già stato. Il pedante abbandona la vita in concreto per rifugiarsi nella vita in abstracto, in un’esistenza, dunque, nella per ogni problema quale vi è già una soluzione collaudata. Ma il corso della vita e dell’esperienza non sono proni ai dettati della pedanteria: il concetto – di cui il pedante fa la sua unica guida –
Non discende mai fino al particolare e […] la sua universalità e la rigidezza della sua determinazione non gli permettono di esprimere esattamente le sfumature, le svariate modificazioni della realtà (ivi, p. 110).
Per quanto fitta, la rete delle regole non aderisce mai perfettamente alla realtà, ed il pedante diviene così preda del ridicolo. E se le cose stanno così, il riso non è che il gesto liberatorio nel quale la vita si affranca dalle forme morte in cui la ragione la costringeva: sullo sfondo della dottrina schopenhaueriana della comicità si deve dunque leggere una rivendicazione esplicita dei diritti della vita e dell’immediatezza sulle forme astratte e rigide della ragione.
4. Lo spirito della storia e lo spirito della terra. Le nostre considerazioni sulla teoria schopenhaueriana del ridicolo potrebbero chiudersi già qui. e tuttavia è forse opportuna una breve digressione volta a far luce su un passo del Mondo in cui Schopenhauer tocca, seppure di sfuggita, l’argomento del riso. Si tratta di un passo molto impegnativo dal punto di vista metafisico: Schopenhauer intende infatti liberarsi con poche parole delle concezioni razionalistiche della storia, ed in particolare di quella hegeliana, tutta volta a cercare nella concatenazione degli eventi il dipanarsi necessario dello Spirito. Ora, la prima mossa in questa direzione consiste, per Schopenhauer, nel sottolineare come la storia non sia affatto il processo necessario in cui lo Spirito si rivela, ma sia piuttosto il regno del caso:
Se, per ipotesi, ci fosse dato di gettare uno sguardo luminoso nel regno della possibilità e sulla completa catena delle cause e degli effetti, lo Spirito della Terra sorgerebbe, e ci mostrerebbe in un quadro gli uomini più eminenti, i luminari del mondo e gli eroi che furono rapiti dal destino prima che l’ora delle rispettive missioni fosse suonata. Ci mostrerebbe quindi i grandi avvenimenti che avrebbero cambiato aspetto alla storia del mondo, e arrecato ere di luce e di suprema civiltà, se il caso più cieco e l’accidente più futile non li avessero soffocati sul nascere (ivi, p. 271).
Ora, di fronte a questo spettacolo, noi uomini abituati a comprenderci come frutto della storia non potremmo probabilmente sottrarci ad un senso di raccapriccio, e ci dispereremmo per le crudeli scelte operate dal caso. E tuttavia all’uomo che piange il mancato progresso dell’umanità e lamenta l’assenza di una Ragione nella storia, lo Spirito della terra potrebbe rispondere con un sorriso (ivi, p. 271), poiché a chi ha compreso che i fenomeni nel loro mutevole esserci altro non sono che manifestazioni di un’identica volontà, non può che apparire ridicola la pretesa razionalistica di scorgere nel fluire del tempo il progresso della storia degli uomini.
IL MONDO COME VOLONTA' E RAPPRESENTAZIONE
Primo libro del Mondo come volontà e rappresentazione
Gnoseologia. Schopenhauer aveva definito nella Quadruplice che le categorie kantiane potevano essere ridotte alla sola causalità, unita alle forme di spazio e tempo. La gnoseologia esposta nel Mondo riprende i concetti di fenomeno e noumeno. Ma per Kant il rapporto fra fenomeno e noumeno è adeguato, in quanto il fenomeno è il reale modo di conoscere il noumeno; al contrario, per Schopenhauer il rapporto è inadeguato, in quanto il fenomeno è pura apparenza. Infatti, La Volontà, che determina tutto il mondo, non vuole altro che realizzarsi, in qualsiasi forma essa possa farlo; un modo è anche attraverso l'uomo, entità superiore che permette forme di realizzazione superiori, più ardite; la capacità conoscitiva dell'uomo serve all'uomo per muoversi nel mondo, ma alla Volontà serve che l'uomo possa muoversi per realizzarsi di più. Alla Volontà non interessa il fatto che l'uomo conosca in sé e per sé, ma gli interessa perché essa si possa realizzare meglio. Dunque, i fenomeni non hanno un valore in sé, ma solo in rapporto all'uomo come mezzo della Volontà. Per Schopenhauer il fenomeno è apparenza, il velo di Maya, mentre il noumeno è la realtà vera sottostante e nascosta. Il mondo in quanto fenomeno lo conosciamo come rappresentazione, che è composta da un soggetto rappresentante ed un oggetto rappresentato. Il soggetto conosce con le forme a priori che però distorcono la sua visione, e dunque la vita è sogno.
Secondo libro del Mondo come volontà e rappresentazione
Mondo come volontà e come rappresentazione. Se il soggetto conoscente guarda all'esterno, non vede che il mondo come rappresentazione, e si ferma all'aspetto fenomenico; ma c'è un modo per raggiungere l'ambito noumenico dell'essere, ed è il guardare in sé stessi. Visto che non è possibile raggiungere il noumeno degli oggetti, ma lo stesso soggetto è un noumeno, guardando in sé lo si può trovare. L'analisi del proprio corpo è illuminante: il corpo può essere visto come fenomeno, ma anche come manifestazione di un'altra realtà: la volontà. Il corpo è oggettivazione della volontà, dunque il noumeno dell'uomo è la volontà. Guardando in sé, si scopre un'altra dimensione dell'uomo e del mondo: la volontà. Il mondo come rappresentazione ha come principio l'Io penso, come volontà l'Io voglio.
Caratteri, assolutezza ed oggettivazioni della volontà. La scienza non può arrivare a spiegare le forze naturali, e questo lo può fare la metafisica, che sarà empirica e procederà per analogia. La Volontà è presente in tutto il mondo, con gradi di coscienza diversi, fino all'uomo in cui è autocoscienza. la Volontà nel resto è inconscia, è un impulso di energia, è unica (non soggetta alle categorie di spazio e tempo, essendo un noumeno), eterna, incausata, senza scopo. La Volontà dapprima si oggettiva nelle idee, archetipi a cui si rifà per determinarsi nelle cose; fra idea e fenomeno sta la legge naturale (esplicazione necessaria della forza in relazione ad una situazione empirica). Dietro al fenomeno c'è la forza irrazionale che non vuole che affermarsi in qualsiasi modo.
Terzo libro del Mondo come volontà e rappresentazione
Caratteri di metafisica ed etica. Se la volontà è il principio del mondo, la metafisica si identifica con l'etica, il piano teoretico porta al piano pratico immediatamente. L'etica come la metafisica dev'essere descrittiva. Per capire il comportamento della volontà bisogna definire la libertà della volontà.
Rapporto di volontà ed intelletto. La volontà, che è in genere inconscia, nell'uomo produce il fenomeno coscienza, divisibile in intelletto (capacità di intuire il nesso causale) e ragione (capacità di pensare in modo astratto); quindi l'intelletto è al servizio della volontà, non viceversa, e il comportamento morale non sarà sottomesso all'intelletto ma alla volontà stessa.
Estetica. L'intelletto si pone allo stesso livello della volontà nell'esperienza estetica. L'arte è una forma di conoscenza: attraverso essa, visto che si guarda la bello disinteressato, cioè che non ha alcuna utilità nel mondo fenomenico, si attraversa il mondo fenomenico per mirare le idee della volontà, le oggettivazioni pure. Come l'oggetto della rappresentazione diventa l'idea, così il soggetto, da soggetto immerso in un ambiente fenomenico, si eleva ad universale e in un ambito noumenico. L'arte non è uno schermo alla volontà come gli altri fenomeni, ma uno specchio della volontà, che appare come idea, o nella musica, come sé stessa. Con l'arte ci si libera dal dominio della volontà.
Quarto libro del Mondo come volontà e rappresentazione
Libertà e liberazione. L'etica è possibile solo se esiste la libertà; per Schopenhauer la libertà è assenza di necessità, e questo lo si ha quando l'intelletto, l'uomo si eleva dal mondo fenomenico al mondo noumenico, in cui non vige il determinismo imposto dalla volontà. Quindi l'etica è il processo di liberazione dell'uomo dal dominio della volontà. Un primo momento di liberazione è durante l'esperienza estetica, in cui l'uomo, posto alla pari della volontà, è nel mondo noumenico. Ma solo l'etica permette una permanenza stabile in tale ambito.
Scelta di carattere intelligibile. L'azione è sicuramente determinata dal carattere empirico dell'individuo, in quanto si dà nel mondo fenomenico; ma l'uomo ha la possibilità di scegliere il proprio carattere intelligibile, di scegliere il proprio comportamento etico una volta per tutte. Per liberarsi dal dominio della volontà, o ci si pone al suo stesso livello, ci si identifica con essa, e si afferma la vita e la volontà, cosicché si posa stare nell'ambito noumenico dove non esiste la necessità, o si nega la volontà, poiché la volontà non è altro che dolore. L'uomo può quindi scegliere la direzione del proprio comportamento, alla quale adeguerà le sue proprie azioni.
Fonti dell'etica e sue caratteristiche. L'etica non nasce da un imperativo categorico dettato dalla ragione, ma da un sentimento di compassione, dal patire le sofferenze altrui come proprie; non appena si sente la sofferenza altrui (non basta sapere che c'è), si sente l'unità noumenica della realtà. La morale ha come virtù la giustizia che è un freno all'egoismo, ed è una virtù negativa ("non fare il male"), mentre la carità è positiva ("allevia il male"). Con la pietà si vince l'egoismo, ma non ci si libera totalmente della vita e dunque della volontà.
Ascesi. La morale della compassione porta all'ascetismo, un insieme di pratiche che mortificano la volontà, che fanno capire come la volontà sia causa di sofferenza e sia l'essenza del mondo, cosa che fa desiderare la mortificazione della volontà. La voluntas, quando si autoriconosce, ha coscienza di sé, tende a farsi noluntas, a negarsi, e l'asceta tende a quello che, per persone normali, parrebbe il nulla, ma in verità è il tutto, mentre nulla è il mondo fenomenico. l'asceta nega la volontà, non vuole il nulla, ma vuole trasformare la volontà in non-volontà.
Pessimismo
Dolore, piacere, noia. Volontà è desiderare, e si desidera quello che non si ha; quindi volere è soffrire, alla base della volontà c'è la sofferenza, e la volontà provoca la sofferenza; se si appaga un desiderio, altri rimangono inappagati, e inoltre la fine del desiderio appagandolo, non dà la felicità, ma la mancanza di dolore, cessazione del dolore. Quindi non esiste il piacere ma la cessazione del dolore, e il piacere esiste se c'è il dolore, mentre il dolore non presuppone il piacere per necessità. Quando non c'è più desiderio subentra la noia; la noia è l'assenza di tensione, e come assenza alla fine dà dolore.
Pessimismo cosmico. Il dolore nell'universo si dà per la mancanza e per la sopraffazione nei confronti degli altri; il dolore è di tutti, ma l'uomo soffre di più perché ne è più cosciente.
Eros. L'eros è tanto forte perché è uno strumento della volontà per giungere alla riproduzione; quindi l'uomo, credendo di fare una cosa umana che lo realizza, è strumento della volontà; l'amore è sentito come un peccato poiché produce altri individui destinati a soffrire.
Critiche
Alla filosofia di Stato. Chi è pagato non può pensare liberamente.
All'ottimismo cosmico. Il mondo non è un organismo perfetto governato dall'assoluto, ma un'esplosione di forze irrazionali.
All'ottimismo sociale. Naturalmente, i rapporti fra gli uomini sarebbero di sopraffazione; gli uomini vivono insieme per limitare il bellum omnium contra omnes .
All'ottimismo storico. La storia non è scienza, poiché cataloga gli individui, non usa concetti; studiando l'uomo, si capisce che questo non muta essenzialmente.
FRASI SIGNIFICATIVE
“Chiunque noi siamo, e qualunque cosa possediamo il dolore ch’è essenza della vita non si lascia rimuovere”
“L’infelicità è per il nostro animo il calore che lo mantiene tenero”
“La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere, sfogliarli a caso è sognare.”
“L’amore autentico è sempre compassione; e ogni amore che non sia compassione è egoismo”
L’uomo è l’unico animale che provoca sofferenza agli altri senza altro scopo che la sofferenza come tale”
“Il giudizio universale è il mondo stesso”
“La vita umana è un continuo oscillare fra il dolore e la noia”
Ogni giubilo eccessivo nasce sempre dall’illusione di aver trovato nella vita qualcosa che è impossibile trovarvi, e cioè la pacificazione definitiva del tormento”
“Nella monogamia l’uomo ha troppo sul momento e troppo poco nel tempo; per al donna è il contrario”
“Il perpetuarsi dell’esistenza dell’uomo non è che una prova della sua lussuria”
“Ogni innamoramento, per quanto etereo voglia apparire, affonda sempre le sue radici nell’istinto sessuale. […] Se la passione del Petrarca fosse stata appagata, il suo canto sarebbe ammutolito”
“La malinconia attira, il tedio respinge”
“La vera vita del pensiero dura soltanto fino al confine delle parole: oltre il pensiero muore”
“Ciò che ha valore non viene stimato, e ciò che è stimato non ha alcun valore”
“Dei mali della vita ci si consola con al morte, e della morte con i mali della vita. Una gradevole situazione”
“Si può essere saggio solo alla condizione di vivere in un mondo di stolti”
“…alla fine tutti quanti siamo e restiamo soli”
“Io non ho scritto per gli imbecilli. Per questo il mio pubblico è ristretto”
“È la cattiveria il collante che tiene insieme gli uomini. Chi non ne ha abbastanza si distacca”
“Il filosofo non deve mai dimenticare che la sua è un’arte e non una scienza”
“Gli uomini completamente privi di genio sono incapaci di sopportare la solitudine”
“Se noi potessimo mai non essere, già adesso non saremmo”
“Alla natura sta a cuore solo la nostra esistenza, non il nostro benessere”
“Più si invecchia, meno quel che si vede, si fa e si vive lascia traccia nello spirito: non fa più alcuna impressione, siamo ormai insensibili”
“Più ristretto è il nostro campo di azione, di visuale e di relazioni, e più siamo felici”
Veniamo adescati alla vita dall’illusorio istinto del piacere: e veniamo mantenuti in vita dall’altrettanto illusoria paura della morte”
“Ogni sera siamo più poveri di un giorno”
“Dal punto di vista della giovinezza la vita è infinita; dal punto di vista della vecchiaia è un brevissimo passato”
“Si può dire quello che si vuole! Il momento più felice di chi è felice è quando si addormenta, come il momento più infelice di chi è infelice è quando si risveglia”
“A parte poche eccezioni, al mondo tutti, uomini e animali, lavorano con tutte le forze, con ogni sforzo, dal mattino alla sera solo per continuare ad esistere: e non vale assolutamente la pena di continuare ad esistere; inoltre dopo un certo tempo tutti finiscono. È un affare che non copre le spese”
“Per non diventare molto infelici il mezzo più sicuro è di non pretendere di essere molto felici”
“Tutti gli uomini vogliono vivere, ma nessuno sa perché vive”
“L’amicizia, l’amore e l’affetto degli uomini li si ottiene solo dimostrando loro amicizia, amore e affetto. […] Per sapere quanta felicità può ricevere una persona nella sua vita, basta sapere quanta ne può dare”
“La solitudine rende oggettivi; la compagnia rende sempre soggettivi”
“Il giustificato sprezzo degli uomini ci porta a rifugiarci nella solitudine. Ma il deserto di questa a lungo andare dà angoscia al cuore. Per sfuggire al suo peso, dunque, bisogna portarsela in società. Bisogna cioè imparare ad essere soli anche in compagnia, a non comunicare agli altri tutto ciò che si pensa, (a non) prendere alla lettera quello che dicono, al contrario, ad aspettarsi molto poco da loro, sia moralmente che intellettualmente”
“La malvagità, si dice, la si sconta nell’altro mondo; ma la stupidità in questo”
“Ciò che rende gli uomini socievoli è la loro incapacità di sopportare la solitudine e se stessi. […] Tutti i pezzenti sono socievoli, da far pietà”
“Il denaro è la felicità umana in abstracto; perciò chi non è più capace di goderla in concreto si attacca al denaro con tutto il suo cuore”
“Dopo che ogni sofferenza fu bandita nell’Inferno, per il Paradiso non restò altro che la noia: ciò dimostra che la nostra vita non ha altre componenti che la sofferenza e la noia”
“Se ad un Dio si deve questo mondo, non ci terrei ad essere quel Dio: l'infelicità che vi regna mi strazierebbe il cuore ”
“Chi ama la Verità odia gli dèi, al singolare come al plurale”
“Il grande dolore che ci provoca la morte di un buon conoscente e amico deriva dalla consapevolezza che in ogni individuo c’è qualcosa che è solo suo, che va perduto per sempre”
“Chiunque ami un altro essere quasi come se stesso, sia il figlio, la moglie o un amico, se questo essere gli sopravvive muore solo a metà: chi invece non ha amato altri che se stesso vuota il calice della morte fino in fondo”
“Che cosa si può pretendere da un mondo in cui quasi tutti vivono soltanto perché non hanno il coraggio di suicidarsi!”
“Ciò che rende gli uomini socevoli è la loro incapacità di sopportare la solitudine e, in questa, se stessi. ”
“Il suicida è uno che, anziché cessar di vivere, sopprime solo la manifestazione di questa volontà: egli non ha rinunciato alla volontà di vita, ma solo alla vita. ”
“La salute non è tutto, ma senza salute tutto è niente ”
“Le religioni sono come le lucciole: per splendere hanno bisogno delle tenebre. ”
“L'intelligenza è invisibile per l'uomo che non ne possiede. ”
“Noi ci consoliamo delle sofferenze della vita pensando alla morte, e della morte pensando alle sofferenze della vita”
SØREN KIERKEGAARD

Se mi etichetti mi annulli.
L’opera di Kierkegaard si colloca negli anni immediatamente precedenti il 1850 e, benchè il filosofo sia morto prematuramente, ci ha lasciato un numero cospicuo di scritti. Importante nella sua formazione è il luogo di nascita, la Danimarca, che in quegli anni si configurava come una sorta di periferia del mondo intellettuale tedesco e, proprio per questo, risentiva molto del pensiero hegeliano. E non a caso Hegel sarà l’idolo polemico contro il quale Kierkegaard costruirà il proprio sistema filosofico, pur avendo in gioventù aderito all’hegelismo (cosa di cui si pentirà esclamando ” io, stupido hegeliano “). Nella sua formazione culturale ha molto peso la famiglia, in particolare il padre, che trasmette al figlio l’attaccamento alla religione luterana (in particolare il forte senso del peccato). Di Kierkegaard possediamo un diario, nel quale trovano spazio, e anzi vengono ingigantite, anche le situazioni più banali, quale ad esempio la rottura del fidanzamento. Ed è nel diario che troviamo narrato un episodio, riguardante il padre, che sconvolse indelebilmente il giovane Kierkegaard: racconta di aver visto il padre commettere uno di quei peccati che lui stesso sempre condannava e quest’esperienza rappresentò un vero trauma, poiché vide crollare una figura austera nella quale nutriva fiducia. Fin dalle pagine del diario, ci si può rendere conto di come in Kierkegaard sia costante l’idea che, al di sotto della superficie, anche quando tutto sembra andar bene, vi sia in realtà un tarlo profondo che corrode ogni cosa di nascosto: ed è proprio questo tarlo che Kierkegaard si propone di indagare con la sua filosofia. Tornando alla formazione del giovane filosofo, il padre lo spinse a seguire gli studi di teologia per poter diventare pastore protestante, ma tali studi si protrassero troppo a lungo per via di quell’incapacità di prendere decisioni che ben si evincerà dagli sviluppi della sua filosofia: è come se Kierkegaard volesse prolungare in eterno la propria adolescenza, senza mai diventar uomo. Questa fase corrisponderà ad uno dei tre “stadi della vita” (estetico, etico, religioso) che il filosofo delineerà nella sua riflessione: anzi, si potrebbe dire che in fin dei conti i tre stadi della vita umana altro non sono che i tre stadi della vita personale di Kierkegaard. Altro episodio centrale nella vita del pensatore danese è un lungo fidanzamento che, in prospettiva, avrebbe potuto rappresentare quella vita adulta, tanto temuta, che continuava a rinviare; e proprio per questo vi sarà la rottura del fidanzamento. Ma non per questo Kierkegaard dovrà fare il pastore protestante per guadagnarsi da vivere: infatti, egli, dopo la morte del padre, ereditò un patrimonio tale da potersi permettere di vivere di rendita; e così, senza inserirsi nella vita matrimoniale o in quella lavorativa, egli si dedicherà a quello “stadio” da lui definito come religioso, entrando in conflitto con la Chiesa luterana della Danimarca: ad essa rimproverava aspramente il fatto che andasse sempre più istituzionalizzandosi. La religione di Kierkegaard sarà, infatti, drammatica e sofferta e, in tale prospettiva, inconciliabile con quella della Chiesa danese, che con il suo eccessivo adattamento alla società (“teologia liberale”) ben poco aveva di drammatico. E, a tal proposito, Kierkegaard gioca la carta di Lutero contro il luteranesimo stesso: in Lutero, infatti, convivono due aspetti contrastanti, per cui, da un lato, troviamo una religiosità profonda e drammatica, caratterizzata da un disperato tentativo di rispettare la regola, e, dall’altro lato, un costante invito ad inserirsi nella società civile, nella convinzione che un vero cristiano debba inquadrarsi nella società attraverso il lavoro e la famiglia. Ecco perché Lutero appare nel contempo come uomo medioevale (per la sua religiosità disperata) e moderno (per la centralità della società e del lavoro). E proprio l’invito luterano ad inquadrarsi nella società sarà accettato da Kierkegaard nel secondo stadio della vita, quello etico (invito già peraltro accettato da Hegel nel momento dell’Eticità). Ed è però per colpa di Hegel e del suo abbandono della drammaticità religiosa che la Chiesa luterana è diventata quel che è diventata, dice Kierkegaard: adagiatasi sulle posizioni hegeliane, essa si è scordata dell’aspetto drammatico della religione in Lutero e si è concentrata solamente sull’inserimento nella società così come essa è (e proprio questo porterà la Chiesa luterana ad aderire al nazismo). Kierkegaard, a differenza delle tendenze hegelizzanti, fa prevalere di Lutero la sfera drammatica e disperata, occupandosi principalmente di problematiche esistenziali. Infatti, non gli interessa come sia fatto il mondo, ma il destino dell’uomo di fronte alle proprie scelte, ed è in virtù di questo interessamento che Kierkegaard può essere considerato un esistenzialista , collocandosi in quel filone di pensiero destinato a riscuotere così grande successo nel Novecento. E da vero esistenzialista, mira a comprendere l’uomo nella sua individualità, poiché gli uomini non sono nulla all’infuori che nella loro individualità; gli interessi di Kierkegaard vertono (a differenza di quelli di Hegel) sull’esistenza e non sull’essenza e l’esistenza in questione è quella del singolo. Ed è proprio su queste considerazioni che matura l’avversione di Kierkegaard nei confronti di Hegel, accusato di voler inquadrare ogni cosa (compreso l’uomo) in categorie troppo astratte e sganciate dalla realtà: e infatti Hegel non parla mai del singolo uomo, ma sempre del popolo o dell’umanità. E anche quando parla dell’uomo, in realtà sembra che non stia parlando di noi, sostiene Kierkegaard; da qui emerge il suo interesse per l’io come singolo, ovvero per l’io concreto, sganciato dalla nebulosa astrattezza in cui l’aveva avvolto Hegel. Del resto, osserva Kierkegaard, checchè ne pensi Hegel, noi siamo nel mondo come singoli, ancor prima che come umanità e spirito. Prima di addentrarci nel merito della sua filosofia, passiamo in rassegna gli illustri antecedenti di Kierkegaard: in primo luogo, come abbiam visto, troviamo Lutero, da cui mutua il concetto di fede e di angoscia (per Lutero la paura è paura di qualcosa, l’angoscia è paura del nulla); accanto all’eroe della Riforma protestante, troviamo Blaise Pascal e il suo disinteresse per i discorsi teologici su Dio; a Pascal interessava non tanto se Dio esistesse, quanto piuttosto che senso avesse per l’uomo credere in Dio. E’ curioso notare come sia Lutero sia Pascal non siano filosofi in senso stretto: in loro la filosofia è al confine con la religione e anche in Kierkegaard, in qualche misura, sarà così; il suo pensiero, non a caso, dopo una sepoltura durata mezzo secolo, verrà ripreso e fatto rinascere da un nutrito gruppo di teologi (tra cui Barth). E in effetti si può ben capire perché un pensiero interessato all’esistenza tenda a scivolare nella religione: Aristotele aveva fatto notare che la scienza è sempre scienza dell’universale e che l’individuale esula da essa. Infatti, posso dire che cosa è l’uomo o che cosa è il triangolo solo dopo che li ho definiti, ma il singolo uomo (Socrate, Gorgia, Platone, ecc.) non è definibile, ma sfugge ad ogni forma di inquadramento intellettuale (e dunque ad ogni forma di filosofia), cosicchè per indagare l’esistenza dei singoli è necessario percorrere strade alternative. E così l’esistenzialismo di Kierkegaard, di Lutero e di Pascal prova la via religiosa, mentre quello del Novecento prova quella del teatro e della letteratura (Sartre e Camus), poiché il teatro, la letteratura e la religione consentono di presentare situazioni concrete ed individuali. Ecco perché Kierkegaard è un pensatore religioso che cerca di incarnare in persone concrete le sue categorie generali (questo spiega anche perché scrivesse spesso sotto pseudonimo): troveremo pertanto personaggi desunti dal mito, dalla tradizione letteraria e religiosa, che rappresentano costantemente il singolo; Don Giovanni rappresenterà l’incarnazione estetica, Guglielmo e Agamennone quella etica, Adamo e Abramo quella religiosa. Entriamo ora nel merito della filosofia kierkegaardiana: esistenza, possibilità e singolarità sono le tre categorie con cui la filosofia esistenzialista del pensatore danese si oppone alle filosofie tradizionali, in particolare a quella di Hegel, vista come eccessivamente astratta e per questo incapace di cogliere la realtà. Queste stesse accuse venivano in quegli anni mosse all’hegelismo da pensatori come Marx, Feuerbach e Schopenhauer: ma Kierkegaard si differenzia da essi in quanto prova a recuperare la concretezza dell’esistenza dei singoli, nella convinzione che la realtà non sia l’essenza dell’uomo (lo Spirito hegeliano), ma l’esistenza effettiva. E Kierkegaard vuole proprio indagare il singolo, caratterizzato dall’essere irriducibile all’universalità. Ecco dunque che la categoria di esistenza viene contrapposta a quella hegeliana di essenza; e per far ciò, il pensatore danese si riaggancia alle riflessioni dello Schelling maturo che aveva rinfacciato ad Hegel di aver elaborato una filosofia “negativa”, cioè incapace di cogliere, al di là dell’essenza, l’esistenza dell’uomo. E infatti, l’errore imperdonabile di Hegel sta nell’aver fatto derivare in modo necessario l’esistenza dall’essenza (la Natura come derivazione necessaria dall’essenza dell’Idea), senza accorgersi dell’incapacità dell’essenza di spiegare l’esistenza. Tuttavia Kierkegaard, pur apprezzando Schelling per queste riflessioni, ne critica l’eccessiva nebulosità del discorso, come se dietro ad essa si nascondesse troppa astrattezza. Dunque, abbandonato Schelling, cerca conferme dell’irriducibilità dell’esistenza all’essenza in altri pensatori e le trova in Kant: quest’ultimo, infatti, aveva smontato la prova ontologica dell’esistenza di Dio elaborata da Anselmo di Aosta mettendo in evidenza come l’esistenza sia un qualcosa di sganciato ed indipendente dall’essenza, cosicchè (diceva Kant) dall’essenza del concetto di Dio non se ne può dedurre l’esistenza. In altri termini, per Kant l’esistenza era una “posizione” assoluta che esulava completamente dall’essenza. E Kierkegaard, riprendendo queste considerazioni, conduce un’analisi della categoria di esistenza che fonderà la riflessione degli esistenzialisti novecenteschi: essi faranno, infatti, notare che esistere (dal latino existo , “vengo fuori”) significa venir fuori dal concetto, ossia non essere riconducibili ad essenza, riconfermando la tesi kantiana secondo cui l’essenza e l’esistenza sono indipendenti. Sempre nel Novecento, si farà notare che l’esistenza è un venir fuori nel senso che, in fin dei conti, ciascuno di noi non è mai tutto in se stesso, ovvero non si è mai solamente ciò che si è, ma anche ciò che si sta decidendo progettualmente di essere, con la conseguenza che l’uomo non è tanto quel che è nel presente, quanto piuttosto ciò che verrà ad essere in seguito alle sue scelte. L’accezione di esistenza colta dall’esistenzialismo ,dunque, è duplice: implica il venir fuori dal concetto e da se stessi (e il venir fuori da se stessi in Kierkegaard è solo implicito). Centrale nel pensiero di Kierkegaard è, accanto alla categoria di esistenza, quella di futuro : Hegel individuava come dimensione temporale fondamentale il passato, facendo notare che “essenza” vuol dire “ciò che è stato” (come già aveva mostrato Aristotele), cosicchè il pensatore tedesco non si lasciava mai andare a descrizioni del futuro, ma restava saldamente ancorato al presente e, soprattutto, al passato. Ma, dice Kierkegaard, la nostra categoria è quella del presente che si proietta nel futuro, poichè ciascuno di noi esiste come singolo e progetta la propria vita affacciato sull’avvenire. E così il futuro viene contrapposto al pasato, come l’esistenza è contrapposta all’essenza; allo stesso modo Kierkegaard contrappone la singolarità indagata dalla sua filosofia all’universalità del pensiero hegeliano. Infine, alla necessità tipica del sistema hegeliano, egli contrappone la possibilità : se la scienza e la filosofia cercano di scoprire le leggi necessarie del funzionamento della realtà, l’esistenza, dal canto suo, sfugge alla necessità; ciascuno di noi, infatti, per quel che riguarda l’essenza è necessariamente uomo, ma per quel che riguarda l’esistenza è libero di effettuare le proprie scelte guardando al futuro e le scelte non possono che farsi nella possibilità. Dalla categoria della possibilità si passa così a quella della soggettività , ossia della verità soggettiva: infatti, l’analisi che Kierkegaard vuole fare della realtà non è oggettiva, ma dell’uomo singolo nella sua soggettività. Kierkegaard, da buon cristiano, è convinto che vi sia oggettivamente una religione vera (quella cristiana) e una miriade di religioni false; ma, da vero esistenzialista, più che occuparsi della verità universale di tali religioni, si occupa del modo in cui ciascuno si rapporta soggettivamente ad esse. Ciò equivale a dire che a Kierkegaard, pascalianamente, interessa non tanto se Dio esista, quanto piuttosto che importanza abbia per l’esistenza soggettiva credere o meno nell’esistenza di Dio. ” E’ più facile che sia salvato un persecutore di cristiani che non un insegnante di teologia ” egli afferma, a sottolineare che il persecutore ha vissuto autenticamente (anche se in modo sbagliato) le proprie convinzioni, mentre l’insegnante fa il proprio lavoro in maniera puramente oggettiva, senza partecipazione soggettiva; allo stesso modo, la verità scoperta da Galileo era oggettiva, mentre quella di Giordano Bruno era soggettiva e, pertanto, doveva essere vissuta fino alla morte. Ed è dentro queste categorie che Kierkegaard costruisce (in Aut-aut e Timore e tremore ) quelli che lui chiama ” stadi della vita ” (estetico, etico, religioso): Aut-aut segna il passaggio dal primo stadio (estetico) al secondo (etico), mentre Timore e tremore (espressione desunta da san Paolo) segna il passaggio dal secondo (etico) al terzo stadio (religioso). Gli stadi della vita sono tre modelli generali di vita che, tipicamente, l’individuo può scegliere nella sua esistenza e queste scelte sono, tendenzialmente, in sequenza, per cui si tenderà a partire dallo stadio estetico per poi passare gradualmente agli altri due. Ne consegue che lo stato etico nasce come superamento di quello estetico, e quello religioso come superamento di quello etico: tuttavia, non si tratta di un superamento di matrice hegeliana, cioè retto dalla necessità (altrimenti tutte le categorie esistenzialiste perderebbero di significato); al contrario, il passaggio da uno stadio all’altro è dettato da una libera scelta del singolo. Certo, il pieno sviluppo di uno stadio può creare condizioni favorevoli per il passaggio allo stadio successivo, ma, in ultima analisi, spetta sempre al singolo scegliere se compiere il ” salto mortale “, ossia uscire da quello stadio e passare al seguente o rimanervi. Un’evidente analogia con la dialettica hegeliana sta nel fatto che anche qui ci troviamo di fronte ad un procedimento triadico: tuttavia il procedimento kierkegaardiano si differenzia perchè, oltre ad avvenire liberamente e non secondo necessità, riguarda sempre e solo i singoli e non l’universale; inoltre, la logica hegeliana era quella dell’ “et-et”, dove cioè valeva tutto e il contrario di tutto, visto che l’intelletto coglieva le contraddizioni e la ragione le ricuciva mettendo in evidenza come esse si richiamassero a vicenda: in altri termini, Hegel coglieva le contraddizioni solo per negarle e superarle, cosicchè, detto banalmente, il nero era sempre anche bianco e pertanto si trattava di una logica dove valeva sia A sia B (“et-et”). E questo, nota Kierkegaard, è un procedimento corretto solo se riferito alla sfera dell’astratto: se passiamo all’esistenza, la logica dell’et-et perde di significato, in quanto quando il singolo sceglie una cosa, per questo stesso motivo ne esclude altre. Ne consegue che se per la logica vale l’et-et, per l’esistenza vale invece l’aut-aut (come recita il titolo dell’opera di Kierkegaard): si sceglie o questo o quello, e la scelta dell’uno implica l’esclusione dell’altro. Detto questo, Kierkegaard cala i tre stadi della vita in personaggi concreti: l’eroe del momento estetico è il Don Giovanni, personaggio desunto dall’omonima opera di Mozart (riconosciuta da Kierkegaard, come da Schopenhauer, capolavoro assoluto della musica). Don Giovanni è il seduttore che mira a conquistare tutte le donne che gli capitano sotto mano ed è per questo il simbolo della vita estetica, ovvero del vivere le sensazioni che il mondo fornisce; l’esperienza estetica è prevalentemente di tipo quantitativo (alla qualità delle donne Don Giovanni preferisce la quantità) e consiste, essenzialmente, nel vivere dell’istante, godendo in maniera puntiforme di ogni sensazione che la realtà offre. La prima caratteristica dell’esteta sarà pertanto di presentarsi come spirito assolutamente libero: ma in realtà egli è tutto fuorchè libero. E’ infatti il mondo che sceglie per lui: l’unica scelta che egli fa è di non scegliere, ossia di scegliere che sia il mondo a scegliere per lui. E infatti Don Giovanni, scegliendo tutte le donne, non ne sceglie nessuna: è il mondo che gliele offre; la libertà di cui l’esteta si vanta è allora una mancanza di libertà, la dominazione della realtà di cui si sente capace è solo apparente, e la sua soggettività è del tutto inesistente visto che non compie scelte. Accanto alla seduzione fisica incarnata dal don Giovanni, Kierkegaard propone, con la figura di Johannes (che compare in alcune lettere), il seduttore intellettuale, capace di sedurre attraverso le epistole. La vita dell’esteta, che sembrava traboccante di libertà, si rivela invece essere tutto l’opposto (capovolgimento più hegeliano del previsto): l’esito di questa rinuncia alla libertà di costruire la propria vita nel tempo è la disperazione . Infatti, in una situazione in cui il soggetto si smarrisce e si trova privo di libertà, non può non nascere la disperazione. E’ un esito necessario: ma non è necessaria (bensì è libera) la scelta di uscire da questa disperazione. La figura dell’esteta, nota Kierkegaard, è cosciente della disperazione, ma spesso sa metabolizzarla vivendola esteticamente: un pò come l’ape che si sposta di fiore in fiore e carpisce nell’istante ciò che le è offerto, quando perviene alla disperazione può viverla esteticamente (un pò come il protagonista de Il piacere di D’Annunzio), in modo aristocratico, dicendo di aver capito che la vita non ha un senso e, proprio in virtù di questa scoperta, rivendicando una presunta superiorità. Dunque, la disperazione è il risultato necessario della vita estetica: ma poi sta all’uomo scegliere se vivere esteticamente anche la disperazione o passare allo stadio successivo, quello della vita etica. Ecco dunque che è la disperazione a portare al superamento del momento estetico, un pò come in Lutero era la desperatio fiducialis a portare alla salvezza. Analogamente a come era in Hegel, anche in Kierkegaard lo stadio della vita etica si caratterizza come dimensione in cui l’uomo vive calato nei valori della collettività: la figura che meglio incarna tale stadio è quella del consigliere di stato Guglielmo, classico burocrate statale. Egli viene presentato come corrispondente epistolare che si rivolge tramite lettera ad un amico più giovane che si trova in difficoltà suilla strada da scegliere, indeciso tra vita estetica e vita etica. E Guglielmo, con forti richiami alla tradizione luterana, gli illustra i valori positivi della vita matrimoniale (che rientra nello stadio della vita etica), invitandolo a calarsi professionalmente e matrimonialmente nei valori della vita etica. Se la scelta della vita estetica è, paradossalmente, di non scegliere, quella della vita etica consiste invece nello scegliere di scegliere: si è consapevoli di scegliere e di portare fino in fondo tali scelte. Se poi la dimensione temporale della vita estetica era puntiforme, quella della vita etica si configura piuttosto come una linea retta, ovvero come scelta che avviene nel tempo del progetto: non avendo un progetto, la vita estetica viveva nell’istante; avendocelo, quella etica progetta nel tempo. L’uomo etico vuole infatti cambiare continuamente e per questo l’etica vive nella ripetizione, cioè nel desiderare di continuo la scelta fatta a suo tempo: la vita matrimoniale e quella lavorativa ne sono il simbolo. Tuttavia, anche l’atteggiamento etico entra in crisi: pur essendo superamento di quello estetico, ha il limite di mancare di valore assoluto, dal momento che la vita umana è finita e l’uomo etico è privo di un aggancio con l’Assoluto; da ciò scaturisce una crisi che travolge la finitezza dell’uomo etico ed è simboleggiata dal pentimento, ovvero dal rendersi conto della propria finitudine che rende insignificanti le scelte etiche. Scatta a questo punto la possibilità di una nuova dimensione, quella della vita religiosa, che trova in Abramo il suo eroe. Dio gli chiede di sacrificare suo figlio Isacco e, proprio quando sta per farlo, viene bloccato da un messo divino. L’accettazione totale della volontà divina simboleggia l’uomo religioso, che si caratterizza anche per il fatto di essere completamente solo nel suo agire e, anzi, in conflitto con la comunità che condannerebbe l’uccisione del figlio. Dunque Abramo è solo e va contro l’eticità: ecco perchè nella Bibbia l’uomo religioso è spesso solo nel deserto, dove può parlare a tu per tu con Dio stesso. Questo rappresenta quell’aggancio con l’Assoluto di cui la sfera etica manca: inoltre, il Dio di Abramo non è (come già aveva detto Pascal) quello dei filosofi, degli scienzati e dei teologi, ma è il Dio persona con cui si può dialogare abbandonando la civiltà. E Kierkegaard nota che, a differenza di quella di Abramo, la scelta di Agamennone, il quale, per poter salpare con la flotta, deve ingraziarsi gli dei sacrificando la propria figlia Ifigenia, è una scelta etica, che non viene compiuta in solitudine a tu per tu con Dio (infatti Agamennone è attorniato dal coro, emblema del popolo greco e quindi dell’eticità). Succede (un pò come nella scommessa di Pascal) che chi si è giocato tutto puntando su Dio ha fatto la scelta più libera che si potesse fare e, oltre a riavere tutto ciò che era disposto a perdere (Isacco), ci ha anche guadagnato (diventando capostipite del popolo eletto). L’uomo religioso vive nel “momento”, ovvero nella riproposizione dell’istante, ma è un istante dotato di senso assoluto, poichè, se l’estetica è mancanza di tempo e l’etica è tempo lineare, la religiosità è inserzione dell’eternità nel tempo , ovvero è l’eterno che si cala nel tempo (anche in Hegel l’idea atemporale si calava nello spazio della natura e nel tempo dello spirito). Qui però non c’è mediazione tra eternità e tempo, in quanto è l’eternità che irrompe nel tempo facendone saltare le regole, idea che ben si accosta a quella cristiana di Dio che si incarna in Cristo e nella storia. Se Hegel insisteva che tale calarsi di Dio è una metafora usata dalla religione per esprimere il calarsi dell’Idea nella natura, per Kierkegaard non è così ed egli infatti si riaggancia al cristianesimo radicale, caratterizzato dal fatto che non si concepisca come continuazione e completamento della tradizione classica, ma come opposizione ad essa (Tertulliano rientrava in quest’ambito): il comportamento di Abramo, dice Kierkegaard, è assurdo agli occhi della filosofia, è un paradosso; lo stesso san Paolo (che dapprima fu persecutore dei cristiani) definì la croce come “follia per i pagani”, a sottolineare l’assurdità dell’eternità che irrompe nel tempo. Ecco perchè per Kierkegaard il cristianesimo è la religione del paradosso che fa saltare le categorie della tradizione classica. E così la filosofia kierkegaardiana sfia kierkegaardiana si avvita sulla riflessione religiosa, la cui categoria principale è quella di angoscia : il concetto, che sarà ripreso dagli esistenzialisti del Novecento, fu esaminato dettagliatamente per la prima volta da Lutero, che definì l’angoscia come paura del nulla, ossia paura priva di un oggetto. Kierkegaard la riprende in quest’accezione e si può notare come essa e l’angoscia siano facce della stessa medaglia: la disperazione, infatti, è quel senso del nulla interiore che l’esteta prova nel rendersi conto che la vita estetica è nulla; si tratta di una sorta di tarlo interiore che mette in luce la nullità di fondo che caratterizza l’esistenza umana. L’angoscia, dal canto suo, è esteriore rispetto alla disperazione ed è legata alla categoria di possibilità: infatti, nota Kierkegaard, la categoria di possibilità è ambigua, poichè da un lato è positiva ( ” ciò che l’uomo desidera sempre e comunque è una possibilità “) perchè rende possibile la libertà e l’allontanamento dalla disperazione, ma, dall’altro lato, è negativa, in quanto possibilità vuol sempre anche dire possibilità di cadere nel nulla ed è per questo accostata al senso di vertigine che si prova a guardar giù dalle alture. Infatti, quando si sceglie si ha sempre l’impressione di poter essere risucchiati dal vuoto e di poter piombare nel baratro del nulla. Dunque, se l’essere in senso hegeliano è sempre necessario, l’esistenza, invece, è libera di scegliere bene o male e proprio per questo è strutturalmente legata al senso di angoscia, ovvero alla paura di precipitare nel nulla. Ed è dalle vicende di Adamo e del suo peccato originale che affiora la bivalenza della possibilità: ma se la paura è una condizione accidentale (che si verifica cioè solo in presenza dell’oggetto che incute timore), l’angoscia, invece, è costitutiva dell’esistenza umana proprio perchè l’esistenza è possibilità e la possibilità genera angoscia. L’unica paura necessaria, esulante da ogni accidentalità, è la morte: ma la paura della morte, nota Kierkegaard, è essa stessa angoscia, in quanto è timore del nulla. Alla categoria di angoscia è indisgiungibilmente connessa quella di fede : la fede è la sola cosa, aggrappandoci alla quale, possiamo compiere quel salto decisivo che ci consente di uscire dall’angoscia. Finchè restiamo nella nostra condizione umana, il timore del nulla non può essere debellato (nell’estetica per la sua non-libertà di scelta e nell’etica per la sua finitudine), ma non appena optiamo per la scelta religiosa (abbracciando la fede), ecco allora che sfuggiamo all’angoscia e alla disperazione e troviamo un riparo da essi nell’Assoluto. Nel Novecento, accanto agli esistenzialisti credenti e a quelli difficili da catalogare, come Heidegger (Vattimo dà di lui un’interpretazione non-religiosa), vi saranno anche esistenzialisti atei che riprenderanno le riflessioni di Kierkegaard, rimproverando però al filosofo danese e, in generale, all’esistenzialismo religioso di aver tradito l’istanza esistenzialistica originaria ricorrendo a Dio: infatti, l’esistenzialismo è tutto incentrato sulla possibilità ed essa, per essere tale, non può agganciarsi a Dio, perchè così facendo si approda al porto sicuro della fede e si tappa l’enorme falla del nulla, tipica della ricerca esistenzialista. Camus, ad esempio, insisterà vivamente sul concetto di assurdo e sull’accettazione da parte dell’uomo dell’assurdità dell’esistenza; l’uomo di Camus saprà dunque vivere fino in fondo la condizione di ineliminabile assurdità dell’esistenza. Tuttavia, contro la critica mossa dall’esistenzialismo ateo, si può spezzare una lancia in favore di Kierkegaard, facendo notare come per lui la fede non rinneghi la matrice esistenzialista: infatti, egli non la concepisce in modo tranquillo e sereno, come un porto in cui trovar riparo; al contrario, la vive in modo drammatico e problematico (l’immagine della fede è per lui Abramo), come l’avevano vissuta Tertulliano, san Paolo, Lutero e Pascal, non in modo tranquillo e sereno come Erasmo e Tommaso.
GRIGLIA RIASSUNTIVA
Esposizione sintetica
Vita
K. nacque a Copenaghen il 5 maggio 1813, ultimo di sette fratelli, dalle seconde nozze del padre (con la domestica). Quando Søren nasce il padre aveva 56 anni e la madre 44; cinque suoi fratelli morirono prima di lui. Di temperamento malinconico, introverso e riflessivo, K. ebbe dal suo ambiente familiare un senso di maledizione incombente, e non ebbe una giovinezza spensierata.
La sua fede, molto forte, si ispirò più alla drammaticità del Crocifisso che alla letizia dell'incontro cristiano. Come ricordano dei suoi studiosi gli furono da subito familiari concetti come il dolore, il peccato, il sangue. Traumatica poi fu per lui la scoperta di una colpa paterna, di cui egli non precisa gli esatti contorni.
Importante nella sua vita fu anche la rottura del fidanzamento con Regina Olsen (da lui descritta con toni angelicati): fu lui a non voler concludere il matrimonio, per motivi anche qui non del tutto precisati (vuoi la sua malinconia, vuoi una, variamente interpretata, "spina nella carne", vuoi per potersi dedicare interamente alla sua missione intellettuale, da lui vista con toni fortemente religiosi); ma il suo ricordo continuò potentemente ad agire in lui. K. decise di vivere da penitente, dedicandosi tutto al rapporto con Dio e alla sua vocazione di scrittore.
Nel 1841 ascoltò Schelling a Berlino, rimanendone dapprima entusiasta (era lo Schelling della filosofia positiva, con la sua sottolineatura dell'esistente), poi deluso.
opere
Pubblicò, spesso con pseudonimi, tra l'altro le seguenti opere:
| Sul concetto di ironia | 1841 |
| Aut-aut | 1843 |
| Timore e tremore | 1843 |
| Il concetto dell'angoscia | 1844 |
| Briciole filosofiche | 1844 |
| Stadi sul cammino della vita | 1845 |
| Postille conclusive non scientifiche alla Briciole filosofiche | 1846 |
| La malattia mortale | 1849 |
suoi bersagli polemici:
a) la Cristianità stabilita
- Kierkegaard critica il Cristianesimo intiepidito quale era vissuto dalla Chiesa luterana del suo tempo, che aveva dimenticato la portata radicale del Vangelo, il suo essere scandalo e paradosso e ne aveva fatto una comoda religione del buon senso comune, una moralità fatta di massime razionalmente condivisibili. In particolare nel 1846 va segnalata la sua polemica con Il Corsaro.
b) Hegel
la verità soggettiva
Da Hegel lo differenzia il concetto di soggettività della verità, da intendersi non nel senso di soggettivismo, ma come valenza esistenziale del vero: la filosofia non deve rimanere fredda e astratta sintesi sistematica, ma deve illuminare l'esistenza.
"la via della riflessione oggettiva trasforma il soggetto in qualcosa di accidentale, e quindi riduce l'esistenza in qualcosa di indifferente, di evanescente", "porta dunque al pensiero astratto". "Al suo culmine la soggettività è svanita" .
"la passione è precisamente il culmine dell'esistenza (..). Se ci si dimentica di essere un soggetto esistente, la passione se ne va (..), ma il soggetto (..) diviene un'entità fantastica." (Postilla)
"succede alla maggior parte dei filosofi sistematici, riguardo ai loro sistemi, come di chi si costruisse un castello, e poi se ne andasse a vivere in un fienile: per conto loro essi non vivono in quell'enorme costruzione sistematica." (Diario)
Invece la verità che interessa K. è quella che fa "comprendere se stesso nell'esistenza" (Postilla)
"se stesso": a) singolo irriducibile all'organismo storico-statale, irriducibile a momento dello sviluppo dialettico dello Spirito; e b) chiamato a scegliere (aut-aut), per il quale dunque la verità non è scindibile dal bene personalmente voluto e attuato (a differenza di Socrate);
K. interpreta anche la celebre definizione tomista di verità come adaequatio intellectus ad rem:
- l'intellectus, che si "adegua" alla realtà, non è nè la Ragione trascendentale, nè un Ragione astratta, ma il "pensiero soggettivo" del concreto esistente;
- a cui preme non l'essere-in-sé, un essere astratto, conosciuto sistematicamente, ma la propria esistenza (a cui è "infinitamente interessato", Postilla), fatta di eventi contingenti, non deducibili dalla necessità dell'Idea, dunque drammatica. In ciò polemizza tanto contro la tranquillità della coscienza hegeliana, per la quale tutto è necessario e razionale, quanto contro la Cristianità stabilita, che non coglie il carattere drammatico della vita).
Palando del Giudizio Universale K. immagina che su quattro che si presenteranno al Supremo Giudice, tre non cristiani, ma con sofferente ricerca, e uno cristiano, anzi professore universitario, ma animato dalla presuntuosa convinzione di aver spiegato il Cristianesimo, sarà proprio quest'ultimo ad essere nella situazione peggiore.
la dialettica
Hegel, con la sua dialettica dell'et-et, sintetizzava gli opposti: per lui non c'è antitesi che non possa essere riassorbita e riconciliata in una sintesi. Parallelamente tutto il cammino della vita umana, personale e collettiva, si snoda secondo una logica necessaria: senza che vi sia responsabilità della libertà personale.
Kierkegaard invece sottolinea con forza appunto una prospettiva incentrata sulla persona, che si caratterizza per la possibilità di scelta libera, e di scelta tra alternative inconciliabili. Non un et-et, che dispensa dalla scelta un singolo visto come trascinato dall'inesorabile flusso della collettività storica, ma un aut-aut, che impegna la persona nella sua indelegabile, indemandabile libertà personale, in un dramma assolutamente personale, in cui ne va del proprio destino eterno.
gli "stadi" dell'esistenza (in aut-aut)
La filosofia deve interessarsi essenzialmente dell'esistenza, e l'esistenza può, in ultima analisi, avere tre forme, o stadi: estetico, etico e religioso. La tripartizione kierkegaardiana può trovare delle analogie, oltre che con il ritmo ternario che Hegel aveva ripreso da una tradizione medioevale, con la teoria dei tre ordini di Pascal: la materia (estetica), lo spirito(etica), la carità (religiosità). Tra uno stadio e l'altro il passaggio non è necessario automatismo, ma salto, effettuabile solo dalla libertà del singolo.
1. estetico [tesi / pura particolarità /sensibilità ]
L'uomo che vive in questa forma, l'esteta, rifiuta tutto ciò che è impegnativo, ripetitivo, serio:
"chi vive esteticamente vive sempre solo nel momento"
L'esteta ricerca sensazioni sempre nuove, idolatrando l'istante fuggevole che non affondi radici nel passato e non costruisca impegnativamente il futuro. Per questo "la sua vita si disfa in una serie incoerente di episodi" senza senso ultimo; analogamente egli rifiuta ogni legame stabile, tanto a livello affettivo, quanto a livello sociale.
Figura-simbolo della vita estetica è il Don Giovanni, il seduttore, che non si lega mai ad una donna, ma passa senza sosta da una donna all'altra, nessuna amando mai veramente, senza vera storia e senza prospettiva.
L'esteta in tal modo fugge continuamente da sé stesso, distraendosi nell'esteriorità (in una esteriorità alienante, si potrebbe dire), ed è contrassegnato dalla noia (come dice Kierkegaard in Aut-aut), ed è in fondo, lo sappia o no, disperato.
2. etico [antitesi / pura universalità /ragione ]
È caratterizzato da stabilità, fedeltà, ripetitività: figura-simbolo ne è il matrimonio; in questo stadio l'uomo si sottopone a una forma, a una regola, a un impegno costante nel tempo, sceglie insomma l'universale. Ma non si tratta ancora dello stadio che vede la realizzazione piena dell'umano.
Un uomo che voglia essere davvero serio, e non rigoristicamente e farisaicamente serioso, deve infatti riconoscere che nella sua vita c'è il peccato e ci sono quella angosce e quella disperazione che la semplice razionalità e l'osservanza pur meticolosa di regole universali non bastano a sanare; anzi in questo stadio l'uomo non riesce a guardare in faccia davvero la Medusa terribile del suo proprio male. Per raggiungere la verità di sé e della propria vita bisogna andare oltre: solo se amato da un Altro, che sia Infinita Misericordia l'uomo può guardare davvero a sé come a un "io". Perciò il passo ultimo della vita etica è il pentimento , il porsi di fronte al Dio personale che si rivela in Cristo, ma questo lo spinge a trapassare nello stadio religioso.
c. religioso [sintesi / di universale e particolare/ fede ]
In questo stadio soltanto l'uomo affronta fino in fondo sé stesso, quell'io di cui finora aveva censurato quegli aspetti che non riusciva a capire e a risolvere, ossia l'angoscia e la disperazione.
Tali aspetti non sono, per Kierkegaard, stati d'animo eccezionali e propri di certi temperamenti al limite della patologia, ma sono intrinseci strutturalmente al modo con cui ogni soggetto umano guarda a sé e al mondo.
a. ex parte obiecti l'angoscia (trattato ne Il concetto dell'angoscia)
L'angoscia è strutturale in ogni essere umano, in quanto radicata nella sospensione della conoscenza umana (riferita essenzialmente al futuro) tra il sapere del puro immediato (tipicamente animale) e il sapere della totalità concreta (angelico-divino): non è angosciato chi del futuro sa tutto (Dio) o chi non ne sa nulla (l'animale, che vive esaurientemente nell'istante presente). Il suo oggetto è l'indeterminatezza del futuro, il futuro in quanto indeterminato, e in tal senso l'angoscia, il cui oggetto è appunto l'indeterminato, differisce dalla paura, che è sempre paura di un determinato.
b. ex parte subiecti la disperazione (trattato ne La malattia mortale)
Se l'angoscia è relativa a ciò che potrebbe accadere, e di cui sappiamo/non-sappiamo, nell'ambito della oggettività dei rapporti intersoggettivi, la disperazione è riferita alla nostra stessa soggettività. Essa significa che l'uomo non riesce ad accettare sé stesso: dispera di essere sé stesso. Essere sé stesso infatti non è automatico, dato che la nostra natura è complessa, è sintesi di fattori tra loro in dialettica, la finitezza e l'infinitezza, la necessità e la possibilità. Normalmente gli uomini soni disperati, perché rinunciano ad essere integralmente sé stessi, rinunciano al loro vero io, e puntano solo su quel fattore del proprio io che meglio riescono a controllare: chi punta sulla finitezza (/necessità) e chi sulla infinitezza (/possibilità), gli uni buttandosi nella sola materialità, gli altri in uno spiritualismo disincarnato e puramente intellettuale/sentimentale.
La sua vera soluzione è solo il Cristianesimo, che permette all'uomo di guardare alla verità, complessa, di sé. Esso ci si presenta come ineludibile problema: quell'Uomo, Cristo, pretende di essere la mia felicità, la risposta al mio bisogno più urgente e fondamentale: non posso ignorarlo, devo sapere se dice il vero o no.
Kierkegaard insiste nel presentare la fede come scandalo e paradosso: è un salto reale oltre la semplice razionalità.
Si cresce nella verità, e nella verifica della fede, rischiando per essa, non pretendendo di conservarla per così dire in freezer, come pensava l'intellettualismo socratico.
INTERPRETAZIONI E EREDITÀ
L'interesse per K., dapprima limitato all'area scandinava, si sviluppò subito dopo la Prima Guerra mondiale, ad esempio nella cultura filosofica di indirizzo esistenzialista (come Karl Jaspers), che a lui si ispirò, e nella "teologia dialettica".
Lucacs se ne interessò: dapprima valorizzandolo (ne L'anima e le forme, 1911), poi (ne La distruzione della ragione, 1954) criticando in lui un irrazionalismo di stampo borghese-reazionario.
Karl Löwith (Da Hegel a Nietzsche) vide in lui al contempo la crisi del mondo cristiano-borghese, e il ritorno al Cristianesimo primitivo.
Jean Wahl (Etudes kierkegaardiennes, Parigi 1938) può essere ricordato per il suo bilancio sull'influenza di K. nella cultura francese.
In Italia K. è stato studiato con attenzione, tra gli altri, da Enzo Paci e da Luigi Pareyson (Esistenza e persona, 1950; Studi sull'esistenzialismo, 1971); un confronto positivo col la tradizione tomista è stato sviluppato da Cornelio Fabro.
Segnaliamo, tra le altre, l'interpretazione di Abbagnano, insigne studioso, da cui dobbiamo in questo caso dissentire. Inaccettabile ci appare la sua lettura di Kierkegaard come di uno che per sondare tutte le possibilità avrebbe rinunciato a scegliere, optando per una "condizione eccezionale di indecisione e di instabilità", per cui "il centro del suo io è di non avere un io" (3°vol. Filosofi e Filosofie nella storia, Paravia, Torino 1986, 165); secondo Abbagnano la sua scelta di nascondersi dietro pseudonimi starebbe ad indicare il suo non impegno a scegliere tra le diverse possibilità.
Ma in Kierkegaard troviamo un continuo invito alla scelta, da lui vista come la cosa più fondamentale della vita. Che poi il suo temperamento fosse sensibile e malinconico, e in qualche modo poco portato ad adottare decisioni nette nella propria vita, è altra questione.
A cura di Giuseppe Modica
DON GIOVANNI
1.
Nel delineare la figura del Don Giovanni mozartiano Kierkegaard conferisce all'estetica una purezza che ne rivaluta lo statuto non solo nei riguardi dell'etica, ma anche nei riguardi della stessa estetica del seduttore psichico, il confronto con il quale è rivelativo delle ragioni d'una siffatta rivalutazione. Infatti è qui che viene smascherato il responsabile dell'inquinamento dell'estetica e individuato in quel pensiero riflesso che rompe l'immediatezza e la naturalezza dell'aisthesis, il suo fluire spontaneo e inarrestabile, capovolgendone la leggerezza nel pesante andamento della strategia e del calcolo, dell'interesse e del ripensamento.
Il seduttore psichico (1) mette infatti in atto una seduzione mediata poiché ha bisogno di «tempo» per predisporre i suoi piani, e anzi egli fa del tempo stesso uno strumento di seduzione. Il suo obiettivo non è tanto quello di possedere una donna fisicamente, quanto quello di possederla psichicamente. Il suo godimento è frutto d'un egoismo raffinato e sottile in quanto consiste non già nel far godere la donna ma, viceversa, nel condurla a uno stato di soggiogamento totale, senza essere a sua volta soggiogato in quest'opera di seduzione.
Per mettere in atto il proprio progetto egli si mostra alla sua preda ora distaccato e assente, ora interessatissimo e presente, ora furioso come un temporale d'autunno, ora dolcissimo come uno strumento musicale ricco di armoniche (2). Il suo obiettivo è infatti di rendere la relazione «interessante» (3), ed essa è tale quando, lungi dal rinchiudersi nel vincolo delle decisioni e delle scelte, rimane sospesa sull'indeterminato, sul regno dell'«infinita possibilità» (4). Perciò, quando una relazione è compiuta e determinata, essa smette d'essere interessante e allora bisogna trovare ogni mezzo per mollare la preda, giacché «introdursi in immagine nell'intimo d'una fanciulla è un'arte, uscirne fuori in immagine è un capolavoro» (5).
Tuttavia, lungi dal trovare libertà, in quest'opera di liberazione il seduttore psichico rimane schiavo e vittima dei suoi stessi intrighi e dei suoi conflitti. E infatti il gioco perverso cui egli mette capo rende la sua esistenza costantemente inquieta, preda d'una «consapevole follia». E però «la sua condanna ha un carattere puramente estetico» (6). Sicché Kierkegaard sottomette l'estetica del seduttore psichico al giudizio negativo pronunciato nei confronti del giovane estetico de L'equilibrio, con la differenza, tuttavia, che, seppure si sia in entrambi i casi in presenza d'una instabilità psicologica ed esistenziale, ne L'equilibrio tale instabilità rimanda ipso facto all'etica poiché è denunciata come perniciosa nei confronti dell'attuazione della «scelta di sé» e quindi della formazione della «personalità» come «unità dell'universale e del singolo» (7), laddove ne Il diario del seduttore essa resta come prigioniera della sua stessa dimensione estetizzante, quasi che l'estetica trovi già in se stessa la chiave per intendere il proprio fallimento, precisamente nell'indebito esercizio della riflessione ancor prima che questa assuma le sembianze e la consistenza della coscienza morale.
2.
La seduzione sensuale, emblematizzata da Don Giovanni, si presenta invece come la chiave di volta che indica la possibilità di sottrarre l'estetica tanto alla determinazione del pensiero quanto alla giurisdizione dell'etica per restituirle una dignità che solo allora essa può legittimamente ostentare.
Non a caso, a differenza del seduttore psichico, il seduttore sensuale è presentato da Kierkegaard come colui che «non ha bisogno d'alcun preparativo, d'alcun progetto, d'alcun tempo […]» (8). Egli infatti seduce con l'immediatezza del proprio desiderare, sicché vedere, desiderare e amare per lui non sono tre momenti distinti in successione logica e temporale, bensì le tre facce d'uno stesso atto – la seduzione – compiuto immediatamente (9).
Ora, soltanto la musica può, secondo Kierkegaard, esprimere adeguatamente l'erotismo immediato, la «genialità sensuale», in quanto essa – nota Kierkegaard con felice ossimoro – è il «medio dell'immediato» (10). La genialità sensuale è infatti «l'idea più astratta che si può immaginare» (11); e, dal momento che la musica è la meno storica fra tutte le arti, un'idea come quella della genialità sensuale non può essere espressa pienamente che attraverso la musica. Non a caso – come egli specifica più con la forza dell'intuizione che con i passaggi dell'argomentazione – la musica «ha […] in sé un momento di tempo, e tuttavia non scorre nel tempo se non in senso figurato» ,tant'è che essa non riesce ad esprimere la successione temporale degli accadimenti, ovvero «ciò che nel tempo è storico» (12).
Di qui l'irriducibilità della genialità sensuale a qualsiasi altra forma d'arte. Per un verso, essa non può essere rappresentata né dalla scultura – e ciò in quanto la genialità sensuale è «un tipo di determinazione in sé dell'interiorità», è cioè qualcosa di troppo intimo per poter essere espresso spazialmente o plasticamente -, né dalla pittura – «poiché [la genialità sensuale] non è fissabile in contorni determinati» (13) -. Quel che impedisce che la genialità sensuale possa essere scolpita o dipinta è, in altri termini, il fatto che essa non risiede in un momento, bensì in una successione frenetica di momenti che non possono essere fermati in un'immagine scultorea o pittorica. Non a caso Kierkegaard la descrive come qualcosa di assolutamente lirico: «una forza, un respiro, insofferenza, passione, ecc.» (14).
Che l'eros istintivo e immediato della genialità sensuale sia esprimibile pienamente soltanto dalla musica è ribadito da Kierkegaard attraverso il paradosso per cui «Don Giovanni non dev'essere visto, ma ascoltato!» (15). Vederlo presupporrebbe infatti una sua dimensione fisica e temporale. Ma ciò significherebbe tradire l'essenza di Don Giovanni, che non si lascia ridurre a nessuna determinazione spazio-temporale. E infatti Don Giovanni non seduce per la sua bellezza o in virtù di un qualsiasi altro suo attributo fisico (16).Egli seduce piuttosto in virtù del suo spirito, ossia in virtù del suo stesso desiderare. Perciò chiedersi che aspetto abbia Don Giovanni è come voler ridurre a un elemento esteriore una forza che è, invece, tutta interiore. E anzi, proprio perché è una forma dell'interiorità, «una determinazione verso l'interno […]» (17), Don Giovanni non può adeguatamente essere rappresentato nemmeno dalla danza, in cui, pure, le movenze del corpo si fondono con la musica, ché proprio quelle movenze esteriorizzerebbero e ridicolizzerebbero Don Giovanni (18).
Che la genialità sensuale sia qualcosa di assolutamente lirico non deve però indurre a credere che essa possa essere espressa dall'«epica» e dalla «poesia». Queste, infatti, si esprimono in parole, ossia ancora nella mediazione e nella riflessione, laddove – come s'è detto – la genialità sensuale si muove costantemente nell'immediatezza. E' per questo che né il Don Giovanni di Byron né quello di Molière possono adeguatamente rappresentare Don Giovanni: essi gli danno la parola e, dunque, gli conferiscono una «personalità riflessa» che lo nega come «idealità» (19). Sicché, nella misura in cui seduce con l'astuzia della mediazione razionale, il Don Giovanni «in prosa» è da rapportarsi piuttosto ai modi del seduttore psichico. Perciò soltanto il Don Giovanni musicale, di cui il Don Giovanni mozartiano rappresenta per Kierkegaard la più emblematica incarnazione, può esprimere adeguatamente l'essenza della genialità sensuale.
Se a questo punto si vuol formulare attraverso un'unica categoria la differenza di fondo tra il seduttore psichico e il seduttore sensuale, essa non può che essere ravvisata nella temporalità, nel senso che è pur sempre in riferimento al «tempo» che le due forme di seduzione vengono sbozzate. E però, se la prima è tutta calata nella temporalità del processo seduttivo, sicché l'intero dramma della seduzione psichica è gestito all'insegna della caducità, la seconda, viceversa, è un'autentica trasfigurazione della temporalità, propriamente una divenienza senza tempo, ché Don Giovanni «non ha […] una sua sussistenza, ma urge in un eterno sparire […]» (20), e perciò la dialettica della seduzione sensuale mette capo all'inesauribilità. Ne consegue che mentre su quella incombe la morte, in questa trionfa la vita. Non a caso Don Giovanni è definito da Kierkegaard come indefinibile e come incompibile: «un'immagine che […] non acquista mai contorni e consistenza, un individuo che è formato costantemente, ma non viene mai compiuto», e perciò non già un «individuo particolare, ma la potenza della natura, il demoniaco, che non […] smetterà di sedurre come il vento di soffiare impetuoso, il mare di dondolarsi o una cascata di precipitarsi giù dal suo vertice» (21), come quel 1003 «che dà l'impressione che la lista non sia affatto finita […]» (22).
Certo, l'epifenomeno dell'inesauribilità di Don Giovanni è costituito dall'inappagabilità e dall'insoddisfazione: nessuna donna soddisfa pienamente Don Giovanni, com'è mostrato appunto dallo stesso numero indeterminato delle sue conquiste. Ma sarebbe errato chiedersi se Kierkegaard faccia dipendere tale insoddisfazione da un limite di Don Giovanni o piuttosto da una sua esorbitanza d'essere, da una sua strisciante impotenza o piuttosto da una sua irrefrenabile potenza. Ciò infatti presupporrebbe ancora che Don Giovanni sia un individuo in carne ed ossa, laddove, in quanto espressione esemplare dell'erotico musicale, egli è «idealità»: non «persona o individuo, ma […] potenza» (23). Vero è che Kierkegaard avverte che Don Giovanni incarna la costante «oscillazione tra essere idea, vale a dire forza, vita, e essere individuo. Ma – come egli subito precisa – quest'oscillazione è la vibrazione musicale» (24), tant'è che appena Don Giovanni «diventa individuo, l'estetico avrà tutt'altre categorie» (25), ripiomberà cioè nel flusso di quell'esistenza estetica che inevitabilmente cade sotto il severo giudizio dell'etica.
3.
Don Giovanni incarna insomma quell'«amore sensuale» che, in quanto «somma dei momenti» che costituiscono un solo unico «momento» che «si ripeterà all'infinito» (26) e, dunque, in quanto è «sparizione nel tempo» e un calarsi interamente nella «concrezione dell'immediatezza» (27), è sicuro di sé e «assolutamente vincitore» (28). Di contro, l'«amore psichico» – proprio in quanto si nutre della mediazione razionale – vive nel dubbio e nell'inquietudine e anzi, poiché tale stato permane anche se «vedrà soddisfatto il suo desiderio e sarà amato», esso «ha in sé il dubbio e l'inquietudine […]» (29) non essendo che «sussistenza nel tempo» (30).
Di qui la differenza da Faust (31) e il possibile accostamento di Faust al seduttore psichico. Anzitutto «Faust […] è il dubbio personificato», e anzi dubbio che «crebbe a dismisura» essendosi Faust abbandonato «nelle braccia del diavolo» (32); «maestro del dubbio», e perciò «scettico» (33), Faust quindi «nel sensuale non tanto cerca il godimento quanto una distrazione […] dalla nullità del dubbio. La sua passione non ha perciò la Heiterkeit che distingue un Don Giovanni. Il suo volto non è sorridente, la sua fronte non è senza nubi, e la gioia non è sua compagna» (34). Per di più Faust coltiva un dubbio che conduce alla disperazione poiché non si tratta di un dubbio puramente intellettuale, ma d'un autentico «dubbio della personalità» (35). Egli infatti «sta agli antipodi di cotesti dubitanti scientifici che dubitano una volta al semestre sulla cattedra […]» (36) e che – dimentichi dell'«interiorità» – rendono il de omnibus dubitandum una mera «filastrocca» (37). Ne consegue che in Faust «l'erotico è già riflesso, qualcosa a cui egli s'abbandona spinto dalla disperazione» (38). Non a caso Faust – a dispetto della sua irrequietezza – è seduttore statico e cerebrale: non solo seduce una sola donna, ma compie la sua opera attraverso la sola forza del «discorso» e della «menzogna» (39). Di contro, Don Giovanni è seduttore dinamico e istintivo: non solo seduce tutte le donne, ma compie la sua opera attraverso la sola forza del «desiderio sensuale» (40).
Da queste premesse si comprende in che senso Kierkegaard consideri Faust espressione del demoniaco spirituale – che, come tale, è una sorta di variazione del seduttore psichico del quale anzi ribadisce la peculiarità -, laddove Don Giovanni è l'espressione del demoniaco sensuale, «del demoniaco determinato come il sensuale» (41). Il che è decisivo per introdurre il secondo essenziale elemento di discriminazione nei confronti del seduttore psichico e in favore della purezza dell'estetica: la coscienza morale.
4.
In proposito occorre soffermarsi sul paradosso cui ricorre Kierkegaard per suffragare e sviluppare la tesi del rapporto privilegiato tra eros e musica: la sensualità nel mondo è stata introdotta dal cristianesimo proprio perché ve l'ha esclusa. Infatti, in nome dell'assunto dialettico per il quale «ponendo una cosa, indirettamente si pone l'altra che si esclude» (42), il cristianesimo avrebbe introdotto la sensualità nell'atto stesso in cui l'ha negata e condannata attraverso lo spirito che esso ha direttamente introdotto nel mondo.
Ma in tal modo il cristianesimo ha fatto della sensualità una «forza» e un «principio» (43), e quindi una realtà positiva. Vero è che la sensualità esisteva anche prima del cristianesimo, ma essa non era – e non poteva essere – determinata spiritualmente, cioè per contrasto con lo spirito, e dunque non era «principio», ma semplice armonia: come in Grecia, dov'essa non era una «pericolosa nemica da soggiogare» (44), ma un elemento armonicamente presente ovunque, tra gli uomini come tra gli dei. E però, non esistendo come principio, non esisteva neppure una rappresentazione simbolica di essa. Vero è che Eros, dio dell'amore, potrebbe essere considerato un principio. Ma Eros, nel mondo pagano, è raffigurato non come innamorato a sua volta, bensì come un fanciullo ignaro dell'amore (45), il che «è più un'oggettivazione che una rappresentazione dell'amore» (46).
Soltanto col cristianesimo la sensualità può venire rappresentata in un «unico individuo» (47). E' da qui che nasce Don Giovanni. Il grembo dal quale egli viene alla luce è propriamente «il dissidio tra la carne e lo spirito», sicché egli è «l'incarnazione della carne» (48) attuata grazie allo spirito, per contrasto con esso. E però, dal momento che lo spirito è il regno della riflessione e del peccato, la carne, in quanto è il suo opposto – o, se si vuole, il principio che lo spirito pone nell'atto in cui lo nega -, non può che essere di qua da quel regno. Perciò Don Giovanni vive la seduzione nell'«indifferenza estetica»: egli è propriamente il «primogenito» del «regno» del «Monte di Venere», dove non hanno diritto di cittadinanza né la «ponderatezza del pensiero né il travagliato acquisire della riflessione» e, di conseguenza, neppure il peccato: vi abitano soltanto la «voce elementare della passione, il giuoco dei desideri […]» (49).
Perciò, se eros qui sta per genialità sensuale, musica sta per ludicità, ed entrambi – nella loro coessenzialità -stanno per trionfo del dionisiaco, del demoniaco sulla serietà dell'etica e sulla sistematicità della logica (50). E Kierkegaard ha talmente a cuore il concetto per cui Don Giovanni non «cade affatto sotto determinazioni etiche» che egli si spinge a dichiarare la difficoltà di chiamarlo «seduttore» o anche «impostore», epiteti che implicano l'esercizio della riflessione e, di nuovo, della coscienza morale. Don Giovanni andrebbe piuttosto qualificato come desideratore: a Don Giovanni manca il tempo per essere un vero seduttore: «gli manca il prima, in cui elaborare il suo piano, e il poi, in cui rendersi cosciente della propria azione» (51). Egli insomma non seduce toutcourt, ma anzitutto «desidera, ed è questo desiderio ad avere un effetto seducente». E d'altra parte egli, certo, inganna, ma senza premeditazione, «senza organizzare il suo inganno in precedenza» (52).
Ne discende coerentemente che neanche il pentimento in Don Giovanni ha diritto di cittadinanza. Pur «affaticato» dagli stessi intrighi che costituiscono l'ordito della sua vita erotica (53), Don Giovanni è tutt'altro che pentito del proprio operato. Lo stesso banchetto che precede l'entrata del Commendatore – entrata su cui Kierkegaard significativamente sorvola – suona come un atto di sfida contro quella «coscienza» (54) che il Commendatore incarna, la conferma che il credo di Don Giovanni non è mai la meditatio mortis – ciò che piuttosto si potrebbe dire di Faust -, ma, nonostante egli sia ora «stato spinto fino alla punta estrema della vita» (55), una «"gaiezza esuberante di vita"» (56) di cui sono altrettanti simboli «l'inebriante conforto dei cibi, il vino spumeggiante, le note festose della musica sullo sfondo […]» (57). A dispetto di Freud, in Don Giovanni il circolo eros-thanatos non si chiude: il thanatos è e resta evento esterno all'eros in quanto sopraggiunge come punizione d'una colpa di cui Don Giovanni non ha alcuna consapevolezza ed è lungi dall' essere l'ombra cupa e minacciosa che inesorabilmente incalzerebbe le imprese del seduttore immediato. Insomma, solo quando «interviene la riflessione» il regno di Don Giovanni «si presenta come il regno del peccato; ma allora Don Giovanni è stato ucciso, allora la musica tace […]» (58). In tal senso si può ben dire che Don Giovanni è non solo il discrimen tra l'immediatezza e la mediazione, ma anche l'estremo baluardo dell'innocenza della natura (59), il topos ideale in cui finisce la spontaneità dell'avventura sensuale e iniziano l'exacerbatio dell'erotismo intellettuale e le vessazioni della coscienza morale.
Don Giovanni è, sì, angosciato, ma quest'angoscia – precisa Kierkegaard – non è mai «disperazione», bensì, ancora, la sostanza stessa del «demoniaco desiderio di vivere» (60). Don Giovanni, insomma, è la stessa forza cosmica, perciò naturale, della sensualità: in lui c'è piuttosto l'immediatezza della natura che il peccato della coscienza e la coscienza del limite. Farne un simbolo della solitudine e della caducità del finito rispetto all'infinito, dell'uomo «crocifisso sulla contraddizione insopprimibile tra la sua natura finita e l'infinito delle sue aspirazioni», farne insomma un «eroe della privazione» e perciò negativo, piuttosto che un «eroe dell'incontinenza» e perciò positivo, significa sposare il mito romantico di Don Giovanni (61), farne l'incarnazione dello Streben e la controfigura di Faust, con ciò tradendo la lettura musicale di Kierkegaard che ne fa, invece, «l'incarnazione della carne» rappresentata come principio.
5.
In una prospettiva più ampia le considerazioni de Gli stadi erotici contribuiscono a chiarire il senso del giudizio limitativo sull'estetica formulato ne L'equilibrio. Tale giudizio non risulta più meramente fondabile sull'affermazione per la quale l'estetica rappresenta la dimensione per cui ciascuno «è immediatamente ciò che è», rispetto alla dimensione, propria dell'etica, in cui ciascuno «diventa ciò che diventa» (62). E infatti proprio questa naturalità dell'estetica è l'elemento vincente delle riflessioni su Don Giovanni. Quel giudizio è piuttosto fondato sul fatto che tale naturalità è in ultima analisi vista come fissità e cristallizzazione, e perciò assimilata alla «necessità» (63), laddove in Don Giovanni essa è intesa come divenire incessante e inesauribile, e perciò assimilata alla connotazione spontanea e istintiva della libertà: purché – beninteso – si tenga presente che Don Giovanni è un'idea musicale, un principio, un mito, e anzi, proprio per questo può realizzare compiutamente la purezza della sfera estetica che invece è destinata ad inquinarsi non appena si cala in un'esistenza temporale.
Questa osservazione può contribuire a sua volta a chiarire come sia possibile che Kierkegaard inneggi all'estetismo demoniaco e naturalistico di Don Giovanni e poi condanni – come fa ne L'equilibrio – l'intera dimensione estetica dell'esistenza come velleitaria ed astratta, capricciosa e discontinua, incoerente e dispersiva, volubile ed eccentrica. La risposta va possibilmente ricercata nella diversa prospettiva dalla quale viene pronunciato il giudizio rispettivamente su Don Giovanni e sul giovane esteta de L'equilibrio. Quest'ultimo giudizio è pronunciato da una prospettiva etica, che è quella in cui si trova il magistrato Wilhelm, incarnazione stessa del matrimonio e dell'amore coniugale, della responsabilità e del dovere, della continuità e della durata, della centricità e della coerenza, insomma, d'una coscienza morale che non può che condannare l'esistenza di chi, dei balli della vita, conosce soltanto il «valzer dell'istante» e anzi rifugge da quell'atto gravoso e decisivo che è la «scelta di sé» attraverso cui soltanto sarebbe possibile compiere il salto nella sfera etica. Il giudizio su Don Giovanni è invece pronunciato da una prospettiva a sua volta estetica e, dunque, nell'indifferenza etica. Lungi dall'essere quello del Commendatore, il punto di vista di Kierkegaard qui infatti è il medesimo di Don Giovanni, come dire del demoniaco, del dionisiaco, del ludico, di quella forza cosmica della natura che – come tale – è spontanea e immediata (64).
In tal senso si può ben dire che il Don Giovanni di Kierkegaard rappresenta una sorta di deontologia della sfera estetica, ossia la sfera estetica così come dovrebbe essere, vissuta pienamente e interamente sul piano dell'aisthesis senz'alcuna interferenza della riflessione, dello spirito, della coscienza, elementi che, mentre ne turbano la gioiosità e la schiettezza, ne compromettono l'immediatezza poiché vi insinuano l'angosciante senso del peccato.
Certo, Don Giovanni realizza compiutamente la purezza della sfera estetica in quanto egli è fondamentalmente un'idea musicale, un principio, un mito. E anzi, volerne fare «un'idea storica» significherebbe assimilarlo di nuovo e indebitamente a Faust (65). Ma, a ben vedere, è proprio il carattere mitico di Don Giovanni che, lungi dal rinchiudere l'estetica dentro un alveo incapace d'ogni crescita che non sia quella che passa attraverso il salto nella sfera etica, conferisce all'estetica una interna teleologia di cui Don Giovanni è il paradigma mai raggiungibile ma perciò stesso trainante, una sorta di idea regolativa in grado, unatantum, di far compiere all'estetica un'autentica ripresa, una Wiederholung laica e, perciò stesso, ancora una volta, paradossale.
Il che trova conferma proprio nell'evento che sembrerebbe compromettere quella natura di Don Giovanni che è «essenzialmente vita» (66), ossia nel fatto che Don Giovanni è sí un eroe positivo, ma è un eroe che, per vivere in eterno come un'idea musicale, deve morire. Ve ne è come un presentimento nel rilievo per il quale, che egli sia «assolutamente vincitore […], è un motivo d'indigenza» (67), dal momento che resta preda d'una ripetizione all'infinto di cui il «catalogo» delle conquiste è emblematica misura: se una donna vale l'altra, la seduzione è sostanzialmente lo specchio su cui Don Giovanni riflette narcisisticamente, e quindi in maniera sterile e inerte, la propria genialità (68). Don Giovanni muore infatti per mano dell'etica, ma non ne è – data la sua costitutiva immediatezza – consapevole, sicché – com'è stato prima evidenziato – l'etica e la morte che essa porta con sé gli restano sostanzialmente estranee: «perciò è […] stato saggiamente disposto» – osserva Kierkegaard – che il Commendatore «stia al di fuori» dell'opera, di cui egli costituisce «la premessa piena di forza e l'ardita conclusione tra le quali sta il termine medio di Don Giovanni […]» (69). Insomma, la stessa dialettica che pone in essere Don Giovanni nell'atto in cui l'esclude è, per cogenza interna, costretta a ucciderlo per farlo vivere in eterno, ossia per consacrarlo esemplarmente a quel piano mitico grazie a cui egli può operare appunto una ripresa della sfera estetica.
Note
(1) Cfr. S. KIERKEGAARD, Il diario del seduttore, in Enten-Eller, a cura di A. Cortese, III, Milano, Adelphi, 1978.
(2) Cfr. ivi, p. 22.
(3) Cfr. ivi, pp. 61 ss.
(4) Cfr. ivi, p. 89.
(5) Cfr. ivi, p. 84.
(6) Cfr. ivi, p. 21.
(7) Cfr. S. KIERKEGAARD, L'equilibrio tra l'estetico e l'etico nell'elaborazione della personalità, in Enten-Eller, cit., V, 1989, p. 159.
(8) S. KIERKEGAARD, Gli stadi erotici immediati, ovvero il musicale-erotico, in Enten-Eller, cit., I, 1976, p. 171.
(9) Cfr. ivi, pp. 163-64.
(10) Ivi, p. 135.
(11) Ivi, p. 118.
(12) Ivi, p. 119.
(13) Ivi, p. 118.
(14) Ibidem.
(15) Ivi, p. 173.
(16) Cfr. ivi, p. 172.
(17) Ivi, p. 178.
(18) Ivi, p. 177.
(19) Ivi, p. 178.
(20) Ivi, p. 172.
(21) Ivi, p. 161.
(22) Ivi, p. 162.
(23) Ivi, p. 178.
(24) Ivi, p. 161.
(25) Ivi, p. 166.
(26) Cfr. ivi, p. 164.
(27) Ibidem.
(28) Ivi, p. 163.
(29) Ibidem.
(30) Ivi, p. 164.
(31) Sul mito di Faust in Kierkegaard Cfr. S. SPERA, Il pensiero del giovane Kierkegaard, Padova, CEDAM, 1977, pp. 11-47.
(32) S. KIERKEGAARD, Diario, Brescia, Morcelliana, 1980(3) ss. [12 voll.], vol. II, IA 72, pp. 32, 33.
(33) S. KIERKEGAARD, Silhouettes, in Enten-Eller, cit., II, 1977, pp. 102, 103.
(34) Ivi, pp. 100-101.
(35) «Il dubbio è la disperazione del pensiero, la disperazione il dubbio della personalità» (L'equilibrio tra l'estetico e l'etico, cit., p. 90).
(36) S. KIERKEGAARD, Timore e tremore, in Opere, a cura di C.Fabro, Firenze, Sansoni, 1972, p. 94.
(37) S. KIERKEGAARD, Postilla conclusiva non scientifica alle «Briciole di filosofia», in Opere, cit., p. 403.
(38) Diario, cit., vol. II, IA 227, p. 71.
(39) Gli stadi erotici immediati, cit., p. 169.
(40) Ivi, p. 170.
(41) Ivi, p. 158.
(42) Ivi, p. 124.
(43) Ibidem.
(44) Ivi, p. 125.
(45) Cfr. ivi, p. 126.
(46) L. PAREYSON, L'etica di Kierkegaard nella prima fase del suo pensiero, Torino, Giappichelli, 1965, p. 5.
(47) Gli stadi erotici immediati, cit., p. 127.
(48) Ivi, p. 156.
(49) Ivi, p. 158.
(50) Il tema dell'inconsistenza logica ed etica dell'eros è d'altra parte motivo ricorrente di In vino veritas. Cfr. in proposito R.CANTONI, La vita estetica nel pensiero di Kierkegaard, Saggio introduttivo a S. KIERKEGAARD, Don Giovanni. La musica di Mozart e l'eros, Milano, Mondadori, 1976, p. 27.
(51) Cfr. Gli stadi erotici immediati, cit., pp. 168-69.
(52) Ivi, p. 168.
(53) Ivi, p. 211.
(54) Ivi, p. 201.
(55) Ivi, p. 211.
(56) Ivi, p. 172.
(57) Ivi, p. 210.
(58) Ivi, p. 158.
(59) Naturalmente si tratta d'una innocenza – come ha opportunamente precisato R.CANTONI (La coscienza inquieta. Sören Kierkegaard, Milano, Il Saggiatore, 1976, pp. 39-40) – «da intendersi in senso relativo e dialettico, ché l'uomo l'ha da tempo perduta».
(60) Gli stadi erotici immediati, cit., p. 206.
(61) M. Mila, Lettura del Don Giovanni di Mozart, Torino, Einaudi, 1988, p. 8.
(62) Cfr. L'equilibrio tra l'estetico e l'etico, cit., p. 46.
(63) Cfr. ivi, p. 108. Sostenere che l'estetico è «immediatamente quello che è» non significa – precisa Kierkegaard – che egli «non abbia uno sviluppo; ma egli si sviluppa con necessità, non con libertà, con lui non ha luogo nessuna metamorfosi, in lui non ha luogo nessun infinito movimento grazie a cui giungere al punto partendo dal quale egli diventa quel che diventa» (ibidem).
(64) Anche a voler condividere la lettura dialettica di E. PACI (Kierkegaard e Thomas Mann, Milano, Bompiani, 1991, p. 16) in base a cui Kierkegaard «ama l'estetico nel momento stesso nel quale vorrebbe superarlo e vincerlo», resta che qui Kierkegaard «è un innamorato, un innamorato del Don Giovanni di Mozart, ma, soprattutto, un innamorato dell'immediatezza erotica, dell'infinità della passione, della sconfinata ed irresistibile potenza dell'eros, del selvaggio ardore del desiderio» (ivi, p. 20).
(65) Gli stadi erotici immediati, cit., p. 119. In proposito Cfr. J. COLETTE, Kierkegaard et la non-philosophie, Paris, Gallimard, 1994, p. 179. Del medesimo autore si veda anche Musique et érotisme, in AA.VV., Kierkegaard et le Don Juan chrétien, Monaco, Edition du Rocher, 1989, pp. 117-133.
(66) Gli stadi erotici immediati, cit., p. 193.
(67) Ivi, p. 164.
(68) Non a caso, anche presso la critica più recente, è ricorrente il rilievo per cui, in proposito, si è in presenza d'una cattiva infinità
1. Le fonti. Kierkegaard affronta il problema dell’ironia nella sua tesi di laurea, pubblicata nel 1841 con il titolo Il concetto di ironia in costante riferimento a Socrate. Si tratta di un’opera ricca di riferimenti al dibattito letterario e filosofico, poiché l’ironia – a partire dall’età del romanticismo – era diventata un tema particolarmente vivo ed aveva attirato su di sé l’attenzione di autori come Tieck, Schlegel e Solger. È tuttavia Hegel l’autore cui il giovane Kierkegaard si sente più vicino: nelle pagine della sua tesi di laurea, il filosofo danese ha infatti ben chiara davanti agli occhi la riflessione hegeliana sulla valenza soggettiva e negatrice dell’ironia, ed una delle mete cui il suo lavoro approda può essere forse indicata proprio nell’acquisizione di una prima parziale autonomia del giovane filosofo dalla pagina hegeliana.
2. L’ironia: una caratterizzazione per contrasto. Il primo passo per venire a capo dell’ironia è, per Kierkegaard, di natura descrittiva: occorre infatti cercare di caratterizzare questa forma del comportamento, indicando quali sono le differenze strutturali che ci permettono di distinguerla da altri atteggiamenti della soggettività.
Osserveremo allora che, da un punto di vista descrittivo, l’ironia si rivela come quella forma del discorso “la cui caratteristica è di dire l’opposto di quello che si pensa” (ivi, p. 192). Parlare significa dare al pensiero un’apparenza sensibile, e ciò è quanto dire che “mentre parlo, il pensiero, l’opinione è l’essenza, la parola l’apparenza” (ivi). Nell’atteggiamento ironico, tuttavia, la parola cessa di essere manifestazione del pensiero: il fenomeno non ci conduce più alla sostanza che in esso dovrebbe farsi visibile, ma ci vincola apparentemente ad un pensiero che è per noi del tutto privo di verità e di sostanza. L’ironia è dunque una sorta di sovversione del rapporto tra fenomeno ed essenza, ed appartiene proprio per questo alla famiglia dei fenomeni “doppi”: nell’ironia il fenomeno diviene infatti un’apparenza ingannevole che allude ad una realtà che deve essere tuttavia negata. L’ironia sembra essere dunque una peculiare forma di ipocrisia: le cose, tuttavia, non stanno affatto così, perché – come nota Kierkegaard –
L’ipocrisia pertiene di fatto all’ambito della morale. L’ipocrita si sforza in continuazione di sembrare buono, pur essendo cattivo. L’ironia, per contro, si situa in un ambito metafisico, e per l’ironista si tratta sempre solo di sembrare diverso da come veramente è, sicché, come nasconde il suo scherzo nella serietà, e la sua serietà nello scherzo […] così può anche venirgli di passare per cattivo, pur essendo buono (ivi, p. 199).
Del resto, la differenza tra ironia e ipocrisia traspare già nel fatto che l’ipocrita non vuole che il suo pensiero sia colto e lo dissimula quindi interamente, mentre chi fa dell’ironia lascia trapelare nel riso la sua vera opinione. L’ipocrita, dunque, non dice ciò che pensa perché non vuole essere giudicato: l’ipocrita dunque nega se stesso perché non intende confrontarsi con la realtà che lo circonda, perché non se la sente di contrastare un’opinione che gode di credito nel mondo. L’ironia segue una strada diversa: chi nel sorriso ironico riconosce la distanza che lo separa da ciò che ha detto, non nega sé, ma la sua adesione ad una realtà che appare per qualche verso priva di valore (ivi, p. 102). L’ironia, dunque, permette al soggetto di prendere le distanze da ciò che ha detto, liberandosene, tagliando i ponti che lo vincolano ad una realtà che è riconosciuta priva di valore.
Ora, proprio in questo suo far “piazza pulita” della molteplicità dei legami che stringono l’uomo alla realtà che lo circonda, l’ironia sembra inaugurare un nuovo cominciamento per il soggetto. La battuta ironica, che fingendo di confermarla, nega l’adesione del soggetto ad un mondo dato, libera di fatto l’io da una realtà cui non crede, ed è proprio questo senso di liberazione che si esprime nel riso dell’ironia:
Ma quanto in tutti questi casi ed altri simili emerge dell’ironia è – nota Kierkegaard – la libertà soggettiva che tiene ad ogni istante in suo potere la possibilità di un cominciamento senza l’intralcio di legami anteriori. In ogni cominciamento c’è qualcosa di seducente, poiché il soggetto è ancora libero, e questo è il piacere desiderato dall’ironista (ivi, p. 196).
La funzione di cominciamento dell’ironia, il suo porsi come uno strumento per mettere tra parentesi una realtà ritenuta inessenziale, traccia una chiara linea di demarcazione tra l’ironia e l’ipocrisia, ma sembra riconnetterla al dubbio, poiché anche nel dubbio – come Cartesio insegna – il soggetto si libera dai vincoli di un sapere tradizionale per inaugurare un nuovo cominciamento.
Il rapporto tra ironia e dubbio ha del resto più di una ragione per essere istituito: anche il dubbio ci dispone in un atteggiamento di natura negativa rispetto alla realtà e ci libera dalle convinzioni cui eravamo precedentemente legati. Anche in questo caso, tuttavia, al momento della somiglianza si deve affiancare quello del contrasto: nel dubbio il soggetto vuole penetrare nell’oggetto, vuole appunto conoscerlo, ma l’oggetto gli sfugge, proprio perché il dubbio non permette mai alla soggettività di riposarsi e di stare ben salda sulle sue acquisizioni conoscitive. Nell’ironia invece il soggetto non vuole affatto cogliere l’oggetto, non intende penetrare nella sua intima essenza: intende piuttosto prenderne le distanze. In altri termini: chi dubita, crede di non conoscere la realtà, ma è certo che valga egualmente la pena di comprenderla, ed è per questo che cerca di farsi presso la natura intima delle cose; chi fa dell’ironia, invece, crede di conoscere la realtà, ma è certo che non valga la pena di soffermarvisi, e nel sorriso ironico prende commiato da un mondo che gli appare privo di valore.
L’ironia, infine, deve essere colta anche sullo sfondo della relazione che la lega al raccoglimento religioso. Come l’ironia, anche l’atteggiamento religioso del raccoglimento mette tra parentesi il mondo circostante, riconoscendone la vanità. Tale riconoscimento, tuttavia, si affianca alla negazione del sé: il gesto del religioso che allontana da sé il mondo colpisce in eguale misura la persona del fedele che riconosce se stesso come “cosa miserrima fra tutte” (ivi, p. 200).
Nell’ironia, invece – nota Kierkegaard – mentre tutto si fa vano, la soggettività diviene libera. Quanto più tutto si fa vano, più leggera vuota di contenuto e fugace si fa la soggettività. E mentre tutto diventa vanità, il soggetto ironico, invece di diventare vano a se stesso, salva la sua vanità (ivi, p. 200).
Dal naufragio del mondo che essa stessa provoca, l’ironia salva lo spettatore – l’io che si fa ironista.
3. L’ironia: una personcina invisibile. Sin qui ci siamo mossi all’interno di un’analisi prevalentemente descrittiva, volta a chiarire quali fossero i tratti distintivi che caratterizzano l’ironia come comportamento soggettivo. Il compito che dobbiamo ora svolgere è diverso: si tratta infatti di comprendere quale sia la funzione generale dell’ironia, quale sia – in altri termini – la funzione metafisica che all’ironia è affidata.
Questa funzione può essere colta se dall’ironia come gesto occasionale passiamo all’ironia come atteggiamento generale verso il mondo. Proprio come il dubbio da empirico si fa filosofico quando Cartesio lo estende al di là dei limiti cui la quotidianità lo vincola, così anche l’ironia guadagna una sua dimensione metafisica non appena si solleva al di sopra dei singoli casi empirici per diventare un atteggiamento generale della soggettività:
L’ironia sensu eminentiori non si rivolge contro questo o quel singolo esistente, bensì contro tutta la realtà data in un determinato tempo e sotto determinati rapporti (ivi, p. 197).
Ora, ciò è quanto dire che “a essere considerato sub specie ironiae non è questo o quel fenomeno, ma la totalità dell’esistenza” (ivi): l’ironia si pone così come lo stile di vita che colora emotivamente la forma dialettica hegeliana della negatività infinita e assoluta. Scrive Kierkegaard:
Per il soggetto ironico la realtà data ha perso completamente il suo valore, gli è diventata una forma imperfetta e intralciante ovunque. Per l’altro verso, però, possiede il nuovo. Sa una sola cosa, che il presente non corrisponde all’idea (ivi, p. 202).
Di fronte ad una realtà nella quale non si riconosce, il soggetto ironico non contrappone una protesta determinata, non contrappone al dato un dover essere che in qualche modo vincoli la sua volontà ad un progetto e la sua condotta futura ad un insieme di norme e di convinzioni; tutt’altro: l’atteggiamento ironico non si impegna nel mondo per un mondo nuovo ma – additandone la possibilità – libera il soggetto nel presente, permettendogli di negare in interiore homine quell’adesione al mondo che pure a parole tributa.
Il sorriso ironico ci permette così di estraniarci dal mondo, di non riconoscergli alcun valore. Da questa negazione tuttavia non derivano alla soggettività impegni di nessun genere: la negazione ironica del mondo scompare nell’atto stesso del negare e non si solidifica in un che di positivo. E ciò è quanto dire che nell’ironia il soggetto guadagna una libertà soltanto negativa:
L’ironia – scrive Kierkegaard – è una determinazione della soggettività. Nell’ironia il soggetto è libero in negativo; difatti la realtà suscettibile di dargli contenuto è assente, e il soggetto è libero dallo stato di costrizione in cui lo tiene la realtà data, ma è libero in negativo e come tale fluttuante, poiché nulla v’è che lo tenga. Ma proprio questa libertà, proprio questo fluttuare trasmette all’ironista un certo entusiasmo, nel senso che si ubriaca degli infiniti possibili […]. A questo entusiasmo tuttavia non si abbandona, ma nutre in sé e ravviva solo quello dell’annientare (ivi, p. 203).
La libertà dell’ironia è dunque sempre soltanto libertà da qualcosa, mai libertà di agire per qualcosa – è appunto una libertà vuota e soltanto negativa.
A partire di qui si può davvero comprendere non soltanto perché Socrate, il filosofo con cui si chiude la stagione della “felice immediatezza” del mondo greco, debba essere per Kierkegaard il vero campione dell’ironia, ma anche la ragione per la quale in un passo del suo libro si parla dell’ironia come di una personcina invisibile: nel sorriso ironico, l’io ritrova e guadagna se stesso proprio nel momento in cui si sottrae ad ogni sguardo che lo cerchi nel mondo. La soggettività che l’ironia ci consegna paga così il gesto di diniego che sancisce la sua superiorità sul mondo e sul reale con il suo divenire invisibile, con il suo perdersi in una vuota possibilità: il luogo da cui la soggettività ironizzante guarda il mondo è così lo spazio vuoto della pura possibilità.
4. L’ironia dominata. Prima di concludere le nostre analisi sull’ironia in Kierkegaard è opportuno dare almeno uno sguardo alle pagine conclusive della sua tesi di laurea. Qui Kierkegaard prende silenziosamente commiato dall’ironia come negatività infinita e assoluta e ne suggerisce una considerazione più positiva ed urbana. L’ironia può essere infatti dominata, e ciò significa che anche questo atteggiamento negativo della soggettività può essere preso con la giusta dose di ironia. Dalla smania ironica che tende a svuotare il reale di ogni valore si deve prendere un ironico distacco; e se l’ironia impedisce all’io di perdersi nel mondo, l’ironia sull’ironia gli impedirà di perdersi di là da esso. L’ironia smette così di essere la lama tagliente che rescinde una volta per tutte il nesso dell’io con il mondo e diviene la coscienza critica che ci impedisce di restare chiusi nei dati di fatto della vita, di idolatrare i fenomeni, cui occorre certo dare peso, ma solo alla luce della consapevolezza della loro insufficienza a racchiudere una volta per tutte la ricchezza di significato della soggettività.
L’ironia come stato d’animo sconfina così in una superiore forma di saggezza che ci insegna a vivere nel mondo senza tuttavia rimanervi impaniati. Ed in questo volto bonario che l’ironia sa assumere e che le permette di essere il viatico in nome del quale l’uomo può attraversare la vita senza disgustarsi della ripetitività delle sue forme e della vuotezza delle manifestazioni dello spirito oggettivo, traspare già un primo indizio di quel rifiuto della filosofia hegeliana che Kierkegaard pronuncerà nelle sue opere più tarde.
IL PECCATO
Per Kierkegaard come per il cattolicesimo, il peccato è il rifiuto dell’amicizia con Dio che si è offerto all’uomo. Tutte le leggi a cui il popolo di Israele deve obbedire hanno lo scopo di assicurare la comunione con Dio. Il peccatore è colui che non ascolta la voce del Salvatore, che agisce contro l’alleanza. In Il Concetto di Angoscia Kierkegaard parla del peccato originale e qui la sua visione non è “né cattolica né protestante. Il peccato originale viene distinto dalla concupiscenza luterana e riferito alla decisione della libertà come tale considerata però nella sfera dell’immanenza del soggetto”. Per i luterani l’immagine di Dio impressa nell’uomo e distrutta dal peccato rimane un tenue residuo, per noi cattolici nel peccatore c’è la perdita almeno parziale dei doni soprannaturali e la permanenza della natura, anche se ferita dal peccato. Per Lutero il peccato originale appartiene alla natura e comporta la perdita di tutte le forze e delle facoltà dell’uomo cioè la corruzione totale della natura, perché l’uomo cerca il fondamento in sé e non in Dio: così l’uomo corrotto dal peccato non è liberato né con il battesimo né con la fede. Per il filosofo l’individuo, come pensa San Tommaso, ha in sé il peccato originale (la pena del danno) e in potenziale la pena del senso (cioè i peccati personali). Ha così in effetti un rapporto soggettivo con la possibilità del peccato. Per Kierkegaard l’individuo è nello stato equivoco di un’innocenza colpevole (per generazione) e di una colpa innocente che si traduce nella malinconia dell’innocenza perduta e nella possibilità del peccato. Il peccato crea angoscia prima che la libertà dell’uomo possa o non compiere pene del senso. Per noi cattolici il peccato originale, come affronta il Concilio di Trento, porta alla perdita della santità e giustizia originale, ed è trasmesso per generazione (cioè da padre a figlio). Solo Cristo, ultimo Adamo, ci ha redento (Paolo Rm 5, 12-21) e tramite il battesimo ha permesso la nostra salvezza poiché la Grazia perdona il peccato originale. Per Kierkegaard invece, dal momento che non crede che il battesimo lavi il peccato originale, quest’ultimo è un residuo che di continuo vive dentro l’uomo, quasi divenendo una categoria ontologica della natura umana estranea alla volontà e alla libertà dell’individuo. La Malattia Mortale parla della disperazione e dell’angoscia per dimostrare che nascono dal peccato. “Nel cristianesimo il peccato è atto di libertà e il suo muoversi verso la propria perdizione: perché l’io si scandalizza perché non supera la possibilità dello scandalo”. Con la venuta di Cristo l’uomo non si trova solo davanti a Dio, ma a Gesù uomo come noi. L’uomo-Dio dà scandalo esistenziale, è il nuovo Adamo che si è incarnato per strapparci dalla disperazione del peccato. Kierkegaard distingue così fra peccato originale e primo peccato. Le due nozioni non possono essere confuse per la difficoltà inerente alla conciliazione di possibilità ed attualità del peccato perché “ciò escluderebbe Adamo dalla storia, non potendosi di fronte ad essa giustificare, non solo per il presente, ma neppure per il passato, l’esistenza di un tale presupposto”. Questa contraddizione si supera nella storia. Con la continuazione della specie, avviene poi la giustificazione individuale e insieme storica del peccato di Adamo; per Adamo, progenitore della stirpe umana, per generazione, il peccato vale per sé e per gli altri.
IL SINGOLO
Il Singolo per Kierkegaard ha una grandissima importanza poiché è creato ad immagine di Dio. Kierkegaard, in base a tale realtà, attacca la filosofia speculativa e il sistema hegeliano. L’esistenza per il filosofo corrisponde alla realtà singolare, cioè al singolo. La filosofia sembra essere interessata soltanto ai concetti: si preoccupa solo di quell’esistente concreto che possiamo essere io e tu, e non dell’irripetibilità e singolarità della persona. Il singolo in sostanza è il punto su cui egli converge la sua filosofia. Contro i concetti rivendica l’esistenza. Il singolo è la categoria attraverso cui devono passare il tempo, la storia e l’umanità. Ed è il singolo l’unica alternativa all’hegelismo poiché per Hegel ciò che conta è l’umanità. Per Kierkegaard il singolo è la contestazione e la confutazione del sistema, della forma di immanentismo e panteismo con cui si tenta di ridurre e di riassorbire l’individuale nell’universale. Il singolo diviene così baluardo della trascendenza. La persona si erge contro il cristianesimo universalmente diffuso e l’organizzazione sociale dell’umanità come folla. Il singolo si pone nel cammino di riconoscere il proprio io a poco a poco: ne segue la gradualità della vita e gli stadi che impongono nell’esistenza una crescita umana. Per Kierkegaard Cristo è il salvatore di tutti, però raggiunge singolarmente gli uomini e li salva ad uno ad uno invitandoli tutti ad andare da lui per ricevere la salvezza. Qui si manifesta il carattere del Suo amore che non è vago né generico, ma concreto. Cristo non forza nessuno, ma rispetta la libertà: è Singolo e ha agito come tale nella sua vita. Ne segue che il cristianesimo a differenza e in opposizione al giudaismo e al paganesimo che parlavano di razza, pone la persona nel rapporto con Cristo: anche nella disperazione ognuno è solo davanti a Lui. E questa disperazione si vive nella coscienza. Il cristianesimo per Kierkegaard, seguendo la concezione luterana, è individualismo. Diventare cristiano vuol dire accogliere lo spirito per essere salvati dal genere, diventare spirito è diventare singolo e l’isolamento è la condizione inevitabile perché Cristo è il vero Singolo. Nella Chiesa Cattolica si riconosce l’irripetibilità e unicità della persona umana che deve avere una fede singola e personale, ma si supera questo individualismo quasi nichilista del pensiero protestante, riconoscendo che Cristo è il Singolo, ma che la sua volontà è che noi, membra del suo corpo, diveniamo e siamo Chiesa cioè comunità di amore, suo Corpo Mistico. Il singolo perciò, nella teologia kierkegaardiana deve porsi a contatto personalmente con Dio. Ma data la distanza che c’è fra Dio e l’uomo, quest’ultimo trascende sé stesso e vive un rischio infinito affrontando così il coraggio della disperazione. Per il filosofo Dio ha cura del singolo e protegge il povero: accoglie chi è solo. La preferenza che Dio ha per il singolo deriva dalla sua maestà divina perché Dio è la Soggettività Assoluta. Il singolo deve quindi affidarsi a Dio per non rimanere sopraffatto come Mosè che non riusciva a superare la visione di Dio poiché la dicotomia fra Dio e l’uomo fa sì che l’uomo più si avvicini a Dio e più ne senta la distanza. L’uomo non deve chiudersi in sé stesso: il religioso deve porsi ed offrirsi agli altri perché il rapporto del singolo con Dio determina il suo rapporto con la comunità e non viceversa. La missione del singolo è di impedire che la comunità diventi folla. Kierkegaard infatti critica la folla perché è incapace di capire Cristo.
IL TRAGICO
Kierkegaard crea un’analogia tra la tragedia di Antigone e la sua personale tragedia di vita.
Come Antigone conosce i peccati di suo padre Edipo, già quando lui era ancora in vita, ma tace abbandonandosi alla tristezza. Ella sa che, se confidasse al suo amato tali segreti, lo perderebbe. Comunque solo nel momento della morte confesserà il suo amore, in modo tale che in quell’unico attimo si associano la confessione di appartenere all’amato, ma anche la non appartenenza, cioè la perdita dell’amato a causa dei segreti espressi.
Così Kierkegaard riguardo al peccato di suo padre, che lo perseguita in modo ossessivo per tutta la vita, si rende consapevole di un ostacolo che si frappone alla felicità sua con Regina Olsen. Egli ha dovuto rendere infelice Regina con lo scioglimento del fidanzamento, perché solo in questo modo l’avrebbe infine resa felice. Pertanto la chiave interpretativa di Kierkegaard consiste nel senso dialettico della situazione: ciò che libera dalla morte, in realtà porta verso di essa. Il concetto del tragico in Kierkegaard è dunque la chiave per accedere all’intimo problema della sua sofferenza. Lui scrive che la disperazione non conosce via d’uscita.
Nel cammino del pensiero e della vita Kierkegaard risolve il tragico nello humor, che è elemento di confine tra etico e religioso. Per parlare del tragico egli sceglie il termine contraddizione, col quale indica la precedente unità delle due forze in reciproca collisione, unità che fa sì che il loro conflitto sia tragico, in quanto le due forze in conflitto sono omogenee (Aut-Aut). Questa opposizione non è ricomponibile, ma la non ricomponibilità non è da attribuire alla realtà alla quale essa non appartiene, ma al modo di vedere dell’uomo, che così non raggiunge l’uscita, ma può superare la contraddizione in una prospettiva più elevata, alzando il tono della contraddizione (passaggio allo stadio religioso).
AUT-AUT
L’opera “Enten-Eller”, tradotta in italiano con “Aut-aut”, fu edita da Søren Kierkegaard nel 1843 sotto lo pseudonimo di Victor Eremita, che dice di se stesso di essere uno scrittore religioso. Il testo, che nell’edizione italiana consta di 5 volumi [S. Kierkegaard, “Enten-Eller”, a cura di A. Cortese, Adelphi, Milano 1976 – 1989, 5 voll], è composto di due parti: le Carte di A, del giovane esteta, e le Carte di B, di Guglielmo l’Assessore e fu scritto di getto in undici mesi, quasi interamente a Berlino, città nella quale Kierkegaard si era rifugiato dopo la rottura del fidanzamento con Regina. L’opera ci conduce nel mondo del pensiero di Kierkegaard. Un “aut – aut” ci impone una scelta, ed è proprio quello che Kierkegaard vuole: costringere il lettore a prendere una decisione. Egli deve decidere come vuole vivere la sua vita, invece di andare passivamente alla deriva lasciandosi semplicemente scivolare lungo il “fiume della vita”. Tutto il cammino della vita umana, personale e collettiva, si snoda secondo una logica necessaria: senza che vi sia responsabilità della libertà personale. Kierkegaard invece sottolinea con forza una prospettiva incentrata sulla persona, che si caratterizza per la possibilità di scelta libera, e di scelta tra alternative inconciliabili. Non un et-et, secondo la visione hegeliana che dispensa dalla scelta un singolo visto come trascinato dall’inesorabile flusso della collettività storica, ma un aut-aut, che impegna la persona nella sua indelegabile, indemandabile libertà personale, in un dramma assolutamente personale, in cui ne va del proprio destino eterno. Così in “Aut – aut” Kierkegaard confronta due ‘stili’ di vita che lui definisce: l’estetico e l’etico. Al termine estetico, comunque, lui dà un significato diverso da quello che solitamente gli diamo noi; egli intende l’immediato e il piacere illusorio dei sensi, che è il punto di partenza della vita di ogni uomo. Nella prima parte della sua opera Kierkegaard ci mostra una varietà di vite estetiche: dalla più bassa che vive in balia dei sensi, e in questi si disperde senza mai impegnarsi eticamente, come viene ben esemplificato nella figura del “Don Giovanni”, all’uomo che si è reso conto del vuoto e della nullità di una vita puramente estetica, ma che, ciononostante, si aggrappa ancora disperatamente ad essa pur sapendo bene che quest’ultima può condurre solo alla disperazione. Ma perché una vita puramente estetica ci porta alla disperazione? Perché, secondo Kierkegaard, l’uomo ha dentro di sé qualche cosa d’altro, che non potrà mai essere soddisfatto da una vita puramente ‘sensibile’. Questo qualche cosa d’altro è l’eterno. L’uomo è costituito dalla sintesi di due elementi opposti: corpo e spirito, temporale ed eterno, finito ed infinito, necessità e libertà. È caratteristica dell’estetico enfatizzare un elemento solo della sintesi: il corporale, il temporale, il finito e il necessario. La mancanza dell’altro elemento della sintesi causa nell’essere umano ansietà; Kierkegaard la definisce “una simpatica antipatia, un’antipatia simpatica”, che allarma e attira allo stesso tempo. Il termine che meglio descrive questa esigenza dello spirito nel mondo sensibile è angoscia; l’angoscia è il segno della presenza dell’eterno nell’uomo. Senza l’eterno non ci sarebbe nessuna angoscia. Ma l’uomo che ha sentito l’angoscia dentro di sé e che ancora ostinatamente persiste in un’esistenza estetica finirà col disperare. Su questi concetti gemelli di angoscia e disperazione Kierkegaard scrisse due delle sue opere più ispirate: “Il Concetto dell’angoscia” (“Begrebet Angest”; 1844) e “La malattia mortale” (“til di Sygdommen Døden”; 1849). Questi due libri sono “saggi psicologici”, come Kierkegaard stesso li definisce, ma in “Aut – aut” gli stessi temi sono trattati attraverso una sorta di letteratura immaginativa, dall’introduzione degli aforismi di “Diapsalmata”, in cui trovano espressione gli umori che attanagliano l’uomo estetico, agli esempi presi dalla letteratura, come Don Giovanni, Antigone, a caratteri desunti dai drammi di Scribe, a figure inventate come “il più infelice” e Giovanni il Seduttore. Insieme formano una galleria di caratteri che vanno dall’immediatamente sensibile, che in un certo senso è innocente a causa della sua immediatezza, perché, in altre parole, non riflette troppo su quello che fa, al seduttore consapevole che ha capito la situazione, ma ciononostante sfida la disperazione. Ma l’uomo che ha sentito dentro di sé l’angoscia della disperazione non può non cogliere l’inadeguatezza di una vita vissuta tutta nella sfera estetica, e chi, nell’angoscia e nella disperazione, non vuol più rimanere in essa, è ormai maturo per scegliere qualche cosa d’altro ed entrare così nella sfera etica. Questo è testimoniato dal fatto che l’eterno ha riposto le sue richieste sull’uomo che non solo le accetta, ma crede nella possibilità di essere consapevole delle richieste etiche nel temporale, nel mondo sensibile. Tale uomo, che scrive lunghe lettere ad un amico che è un “esteta” (nella seconda parte di “Aut-aut”), conduce una vita “etica”. Simbolo di tale vita è l’assessore Guglielmo, marito fedele, professionista laborioso ed onesto, combattente e ottimista che consapevolmente lotta per una buona causa e ha senza dubbio la forza di convincere i suoi amici e il mondo intero su quello che è il ‘buono’. Lui non si negherà sperperando la sua vita nella sfera estetica, ma crede che sia possibile unire i due punti di vista in una specie di sintesi. Non per niente uno dei capitoli della seconda parte di “Aut-aut” è intitolato fiduciosamente e non senza ragione: “Sull’equilibrio tra l’estetico e l’etico nello sviluppo di personalità”. Senza dubbio questo concetto è quello che Kierkegaard stesso pensava a quel tempo. Egli era stato attirato fortemente alla vita estetica nelle sue forme più raffinate, ma lui indubbiamente ancora sperava che sarebbe stato possibile trovare un qualche genere di sintesi tra i due mondi. È vero che lui aveva in un certo senso rinunciato all’etico quando aveva rotto il fidanzamento con Regine e così era sfumata la possibilità di sposarsi, ma in realtà non aveva mai abbandonato il suo collegamento col mondo, né la speranza che tutto, in uno modo o un altro, si sarebbe risolto nel migliore dei modi. Ebbe all’improvviso la conferma di questa speranza una domenica di primavera del 1843, quando, lasciando la ‘Chiesa di Nostra Signora’ di Copenhagen, incontrò casualmente Regine che usciva dalla chiesa. Lei gli fece un cenno con il capo. Quello fu tutto; ma l’animo di Kierkegaard fu nuovamente sconvolto. Così lei aveva capito; e lei non lo credeva, malgrado tutto, un impostore! Nella testa di Søren cominciò a farsi strada l’idea che forse loro potevano avere una sorta di rapporto ‘inusuale’, una specie di matrimonio spirituale, libero dalle concupiscenze della carne. Ma per non correre rischi evitò di incontrarla di nuovo rifugiandosi ancora una volta a Berlino per poter lavorare indisturbato. Là lui scrisse due opere: “Timore e tremore”(“og di Frygt Bæven”) e “La Ripetizione” (“Gentagelsen”). Ambedue sono scritti in una forma a lui molto congeniale: a metà strada tra la letteratura immaginativa e la filosofia. L’idea che domina le due opere è la fede anche se è vista in due modi profondamente diversi.
Le Carte di A racchiudono vari saggi quali:
Diapsalmata – una raccolta di aforismi a carattere poetico in cui emergono l’invincibile malinconia e infelicità dell’autore;
Gli stadi erotici immediati, ovvero il musicale-erotico – è il commento all’opera “Don Giovanni” di Mozart in cui viene illustrata la figura del ‘seduttorÈ: Don Giovanni rappresenta il “seduttore dell’immediatezza”;
Il riflesso del tragico antico nel tragico moderno – dal confronto tra queste due realtà emerge la profonda disperazione insita nella tragedia moderna;
Silhouettes – vengono messe a confronto tre figure di donne “sedotte” e i loro seduttori: Marie Beaumarchais (Clavigo), Elvira (Don Giovanni) e Margherita (Faust); Faust è visto come l’uomo del dubbio, un dubbio che ha annientato in lui la realtà, per questo motivo egli nell’amore non cerca più il piacere, ma la distrazione;
Il più infelice – chi vive nella “infelicità del ricordo” è più infelice rispetto a colui che vive nella “infelicità della speranza”;
Il primo amore;
La rotazione delle colture;
Il diario del Seduttore – A non è l’autore. Questa fu la parte più letta dell’opera e quella che fece più scalpore; in essa si parla soprattutto della seduzione della parola: al seduttore non interessa quante ragazze può sedurre, ma interessa solo come le seduce.
Anche le Carte di B racchiudono vari saggi come:
Lettere ad A;
Validità estetica del matrimonio;
L’equilibrio tra l’estetico e l’etico nell’elaborazione della personalità – viene posto l’accento sulla “scelta” come momento discriminante tra l’estetico e l’etico e quindi la possibilità dell’enten-eller; lo scegliere appartiene infatti al momento etico il quale non è ciò che è immediatamente, come l’estetico, ma ciò che diventa mediante appunto la scelta.
Ultimatum (predica di un pastore dello Jutland).
TIMORE E TREMORE
L’opera “Timore e Tremore” appare il 16 ottobre 1843. «Dopo la mia morte» scrive Kierkegaard nel Diario a proposito di Timore e Tremore, «si vedrà che basta quest’opera per rendere immortale un nome di scrittore, si inorridirà per il tremendo pathos che contiene». Firmata da Johannes de Silentio (uno dei molti pseudonimi che Kierkegaard ama enigmaticamente adottare), Timore e tremore fa parte delle opere scritte nel 1843, dopo la rottura del fidanzamento con Regine Olsen. Johannes de Silentio vi prospetta la possibilità della «sospensione dell’etica» di fronte all’esigenza religiosa: quel Dio che ha ordinato ad Abramo di sacrificare Isacco ha imposto a lui (Johannes, cioè Kierkegaard) di rinunciare a Regine. Pur attraverso i veli di una sapiente allegoria, questa singolare «lirica dialettica» ci rende partecipi delle tensioni di un’esperienza religiosa profondamente vissuta. Kierkegaard, in Timore e Tremore, si è servito del dramma di Abramo (di cui non ha capito l’intreccio tra colpa morale e interesse politico) per giustificare la sua rottura col mondo sociale e l’insegnamento. Abramo -secondo Kierkegaard- non può essere capito dalla massa perché vive un rapporto speciale con l’assoluto. Apparentemente sembra un assassino, invece egli compie soltanto un sacrificio che gli viene richiesto da Dio. Il dramma di Abramo è che non può comunicare a nessuno la sua angoscia. Kierkegaard si identifica in Abramo come nell’Angoscia lo farà con Adamo, ma in entrambi i casi stravolgendo completamente il senso delle cose. Nella prefazione dell’opera l’autore si dichiara poeta, non filosofo. “Il sottoscritto non è affatto un filosofo; egli non ha compreso il sistema, non sa se esso esiste, se è compiuto; […] egli è, ‘pöetice et eleganter’, uno scrittore”. La filosofia, alla quale si dichiara estraneo, e refrattario, è quella hegeliana, che viene criticata in due punti nodali: nella identificazione radicale dell’interno e dell’esterno (per cui la sfera dell’interiorità perde ogni sua determinante e specifica consistenza); nella risoluzione della fede come momento che va oltrepassato nel divenire dello Spirito. L’opera, poi, si svolge in due tempi:
Stati d’animo e Panegirico di Abramo in cui prevale l’andatura poetica;
Problemata e Problemi (I, II, III) in cui la ragione dialettica riprende i problemi della prima parte e li dispiega in una serrata riflessione.
Stato d’animo
Lo “Stato d’animo” è quello esistenziale, dove si aprono, nel “mistero” della libertà che è il “segreto” dell’esistenza, le varie possibilità, dentro le quali si staglia netta e decisa la fede di Abramo. Le quattro “visioni” che il solitario melanconico e contemplativo riferisce a Johannes de Silentio, sono le “possibilità” che si sarebbero potute verificare se Abramo non avesse creduto:
la possibilità della finzione di Abramo che si fa credere da Isacco un mostro piuttosto che egli perda la fede in Dio;
la possibilità della perdita della gioia, come conseguenza dell’assurdo vissuto;
la possibilità della tentazione del peccato imperdonabile: Abramo prega Dio di perdonarlo di aver voluto sacrificare suo figlio Isacco;
la possibilità della disperazione di Abramo e della conseguente perdita della fede da parte di Isacco, senza che il padre mai se ne accorga.
Invece Abramo credette.
Panegirico di Abramo
In questa parte dell’opera Kierkegaard mostra la figura di Abramo quale “eroe della fede”. Il “panegirico” può essere schematizzato nel modo seguente.
La funzione del “poeta” è quella di essere il “genio della rimembranza”.
Descrizione dell’eroe della fede
Il tempo della fede.
“Il tempo passava” (tempo cronologico);
“c’era la possibilità” (permanere del possibile);
“Abramo credette” (la forza della fede). La forza della fede è:
recupero del tempo come “presenza esistenziale”. “Abramo credette e mantenne la promessa”;
recupero del transeunte nell’adesione all’eterno. “È una cosa grande il rinunciare al proprio desiderio ma è più grande il mantenerlo dopo averlo abbandonato; è una cosa grande afferrare l’eternità, ma è più grande mantenere la realtà temporale dopo averla abbandonata”.
La fede è giovinezza spirituale: “Abramo credette, perciò egli è giovane; poiché colui che […] crede, conserva un’eterna giovinezza”. Proprio perché riscatta il tempo dalla precarietà del divenire nella sporgenza dell’eterno, la fede è giovinezza spirituale.
Il “combattimento” con Dio è la vera “passione” dell’uomo.
“Abramo tuttavia credette e credette per questa vita. […] Egli credette l’assurdo”.
Problemata
I “Problemata” si aprono, quasi per stabilire una sorta di continuità “ideale” tra il momento lirico e il momento dialettico, in cui si delinea la figura del “cavaliere della fede”. Abramo è il “cavaliere della fede” e non l’eroe tragico della rassegnazione infinita.
Il segreto del dramma di Abramo è l’angoscia di fronte alla determinazione religiosa, quella del sacrificio del figlio, che è qualitativamente diversa dalla determinazione morale e richiede la decisione della fede: insomma, bisogna “fare della fede un valore assoluto”. Il percorso indicato da Kierkegaard è il seguente.
Polemica contro la predicazione dei pastori
L’angoscia. “L’espressione etica per l’azione di Abramo è ch’egli voleva uccidere Isacco, l’espressione religiosa è ch’egli vuol sacrificare Isacco; ma in questa contraddizione si trova precisamente l’angoscia che può certamente rendere un uomo insonne – Abramo però non lo è, egli non ha quest’angoscia”.
La determinazione religiosa (il Sacrificio) non è quella morale. “Se infatti si sopprime la fede riducendola a zero o al nulla, non resta più che il fatto crudo, che Abramo voleva uccidere Isacco”.
La decisione di fede. “È solo con la fede che si ottiene la somiglianza con Abramo”.
Combattimenti dialettici della fede (polemica con Hegel):
Abramo è il “cavaliere della fede” e non l’eroe tragico.
Abramo non è neppure il calcolatore umano. “Egli credette in virtù dell’assurdo, poiché ogni calcolo umano era da tempo stato abbandonato”.
Abramo amò Dio con la fede.
Non bisogna andare oltre la fede.
Ricerca del “cavaliere della fede”. “si è rassegnato infinitamente a tutto ed ecco che ha riavuto tutto in virtù dell’assurdo.”.
Carattere del “cavaliere della rassegnazione infinita”.
Il “cavaliere della fede”. “Egli fa una rinuncia infinita all’amore, ch’è il contenuto della sua vita, è riconciliato nel dolore; ma allora si compie il prodigio, egli fa ancora un movimento più meraviglioso di tutti, poiché dice: io però credo che riuscirò ad averla in virtù cioè dell’assurdo, in virtù del principio che a Dio tutto è possibile. […] Egli [Abramo] conosce l’impossibilità e nello stesso tempo crede l’assurdo”.
Ecco dunque, riassumendo, i momenti dialettici della fede:
riconoscimento dell’impossibilità secondo i criteri umani;
simultaneamente si crede che ogni cosa è possibile a Dio. Si crede ciò che, secondo la pura razionalità, è l’assurdo.
La fede, perciò, non è un impulso di carattere estetico, né l’istinto immediato del cuore, ma è “paradosso” di vita, che con umile coraggio afferra “tutta la temporalità in virtù dell’Assurdo”. Per cui “ogni tempo può essere felice se possiede la fede”.
Problema I
Si dà una sospensione teleologica dell’etica?
La seconda parte dell’opera intende ricavare la dialettica della fede, la quale si configura come “inaudito paradosso”, che trasforma ciò che sul piano della norma morale generale è un delitto in un atto santo e gradito a Dio.
Esiste una sospensione teleologica della morale? Per rispondere affermativamente a tale domanda bisogna rilevare le connotazioni seguenti.
Connotazione della morale intesa come il Generale, che vale per tutti, dentro un orizzonte di immanenza, giacché la morale ha in sé il suo “telos”.
Connotazione dell’Individuo come essere immediato, sensibile, psichico. Ora il problema sta nel rapporto tra l’Individuo e il Generale come norma morale. La morale richiede che l’individualità si risolva nel Generale. Rivendicare infatti la propria individualità di fronte, cioè contro, il Generale è peccato e la riconciliazione può avvenire solo riconoscendo il Generale. La crisi morale sta proprio nel tentativo di rivendicare la individualità di fronte al Generale e la liberazione dalla crisi è il pentimento.
Nel rapporto tra Individuo e Generale si configura la connotazione della fede come paradosso. Per la fede, infatti, per cui l’Individuo si rapporta con l’Assoluto in un rapporto assoluto, l’Individuo si pone sì al di sopra del Generale, ma in maniera tale da essere, radicalmente, in regola con il Generale, in quanto proprio per la fede, l’Individuo come tale è in rapporto assoluto con l’Assoluto. La fede, perciò, non è integrabile con il sistema: è “scandalo” per la ragione del sistema.
A questo punto Kierkegaard fa seguire esempi di “eroi tragici” quali: Agamennone, Jefte e Bruto; ma di fronte alla vicenda di Abramo non si può piangere, come si può fare nei confronti dell’eroe tragico, si ha invece l’ “horror religiosus”: la fede è “timore e tremore”.
Problema II
Esiste un dovere assoluto verso Dio?
Come si è appena constatato, Abramo ha varcato tutti i confini della sfera etica: il suo “telos” è più in alto, al di sopra dell’etica. Quindi, dal punto di vista etico, sorge una “nuova categoria”: il dovere come espressione della volontà di Dio, a cui ci si rapporta in un rapporto assoluto. Ma esiste un dovere assoluto nei confronti di Dio? La risposta è affermativa. Passando attraverso la critica della filosofia hegeliana che pone il “das Aussere” (la manifestazione) superiore al “das Innere” (l’interiore), si giunge ad affermare che il “paradosso della fede” si basa sulla incommensurabilità dell’interiore all’esteriore, per cui è l’”interno” – il “divenire soggettivo” – ad essere superiore all’esterno.
Il rovesciamento della fede nei riguardi della morale è questo: che la morale non è abolita, ma riceve un’espressione diversa, quella del paradosso, che non si presta ad essere mediato.
È questa la “terribile responsabilità” che deve accollarsi il “cavaliere della fede”.
Il “cavaliere della fede” deve rinunciare al generale per diventare il Singolo e questo lo fa in forza dell’assurdo; non può chiedere aiuto a nessuna mediazione, neanche a quella della Chiesa; egli è completamente solo.
Problema III
Dal punto di vista etico si può scusare il silenzio di Abramo con Sara, Eliezer, Isacco sul suo progetto?
Il “pathos” è il protagonista delle ultime pagine dell’opera dove viene esaminato il “silenzio” di Abramo. Nel “silenzio” di Abramo, Johannes de Silentio vede configurato il silenzio emblematico della fede, lo “stupore assoluto” dell’uomo. Emerge ancora il caso di Abramo. Il suo “silenzio” non è “estetico” né “etico”, ma “religioso”.
Un silenzio fatto di sofferenza e di angoscia, che vive e si nutre nella “terribile responsabilità della solitudine”.
“Allora «aut – aut»: o esiste il paradosso che il Singolo come Singolo sta in un rapporto assoluto all’Assoluto, oppure Abramo è perduto”.
IL CONCETTO DELL’ANGOSCIA
La possibilità è la categoria fondamentale dell’esistenza. La condizione di insicurezza, di inquietudine e di travaglio connessa a questa categoria è l’oggetto dei due scritti che, accanto alle “Briciole” e alla “Postilla”, costituiscono il nucleo più prettamente filosofico del pensiero di Kierkegaard: “Il concetto dell’angoscia” (1844) e “La malattia mortale” (1849). L’angoscia è la “vertigine” che scaturisce dalla possibilità della libertà. L’uomo sa di poter scegliere, sa di avere di fronte a sé la possibilità assoluta: ma è proprio l’indeterminatezza di questa situazione che lo angoscia. Egli acquista la coscienza che tutto è possibile, ma quando tutto è possibile, è come se nulla fosse possibile. La possibilità non si riveste di positività, non è la possibilità della fortuna, della felicità, ecc.; è la possibilità dello scacco, la possibilità del nulla. L’angoscia è la condizione naturale dell’uomo. Essa non è presente nella bestia che, priva di spirito, è guidata dalla necessità dell’istinto, né nell’angelo che, essendo puro spirito, non è condizionato dalle situazioni oggettive. L’angoscia è propria di uno spirito incarnato, quale è l’uomo, cioè di un essere fornito di una libertà che non è né necessità, né astratto libero arbitrio, ma libertà condizionata dalla situazione, cioè appunto dalla possibilità di ciò che può accadere. E’ la possibilità di poter agire in un mondo in cui nessuno sa che cosa accadrà. E’ l’angoscia provata da Adamo posto di fronte al divieto di gustare i frutti dell’albero della conoscenza: egli non sa ancora in che cosa consista la conoscenza, non conosce la differenza tra il bene e il male, non comprende il senso del divieto stesso. Egli non sa che cosa accadrà, eppure è chiamato a scegliere tra l’obbedienza e la disobbedienza. Strettamente connessa alla categoria della possibilità è anche quella della disperazione, che è la “malattia mortale” di cui Kierkegaard tratta nel libro omonimo. Tuttavia, se l’angoscia è incentrata soprattutto sui rapporti tra il singolo e il mondo, la disperazione riguarda piuttosto quel rapporto del singolo con se stesso. L’angoscia è determinata dalla coscienza che tutto è possibile, e quindi dall’ignoranza di ciò che accadrà. Invece la disperazione è motivata dalla constatazione che la possibilità dell’io si traduce necessariamente in una impossibilità. Infatti, l’io è posto di fronte a un’alternativa: o volere o non volere se stesso. Se l’io sceglie di volere se stesso, cioè di realizzare se stesso fino in fondo, viene necessariamente messo a confronto con la propria limitatezza e con l’impossibilità di compiere il proprio volere. Se,viceversa, rifiuta se stesso, e cerca di essere altro da sé, si imbatte in un ‘impossibilità ancora maggiore. Nell’uno come nell’altro caso, l’io è posto di fronte al fallimento, è condannato a una malattia mortale, che è appunto quella di vivere la morte di se stesso. Tanto l’angoscia,quanto la disperazione possono avere un solo esito positivo:la fede. Sia l’esperienza della possibilità del nulla propria dell’angoscia, sia quella della malattia mortale che rivela l’impossibilità dell’io, si risolvono soltanto quando l’uomo compie un salto qualitativo, aggrappandosi all’unica possibilità infinitamente positiva, che è Dio. Il credente non ha più l’angoscia del possibile, poiché il possibile è nelle mani di Dio; né il suo io si perde nella disperazione della propria impossibilità, poiché sa di dipendere da Dio e di trovare in Dio un sicuro ancoraggio. Il passaggio alla fede, tuttavia,è un salto senza mediazioni. La fede non può essere dimostrata per mezzo di analisi storiche e filologiche, né può essere fondata su una filosofia speculativa che la riconduca, come aveva fatto Hegel, a una determinazione della ragione umana. La fede è, piuttosto, il risultato di un atto esistenziale con cui l’uomo va al di là di ogni tentativo di comprensione razionale, accettando anche ciò che al vaglio della ragione o della critica storica appare assurdo. L’essenza intima della fede non è una verità oggettiva, determinabile con gli stessi strumenti di indagine con cui si analizza un fenomeno naturale o un problema logico-matematico. Al contrario, essa è soggettiva non nel senso di essere relativa e variabile, ma nel senso di essere fondata esclusivamente sul rapporto soggetto con la rivelazione divina. Nella fede ogni uomo è solo con Dio. La fede è data dalla fusione di quella manifestazione di temporalità, di finitezza,di possibilità, in una parola di esistenza, che è l’uomo, con l’elemento dell’eternità e dell’infinito. Con la nozione di momento Kierkegaard indica proprio l’irrompere dell’eternità nel tempo con cui Dio si rivela all’uomo. Nel momento l’infinito si manifesta al finito; cosicché nella verità che ciascun credente porta soggettivamente nel suo cuore è contenuta la stessa verità divina. Il Cristianesimo è quindi l’unica vera religione, poiché esso soltanto riesce ad esprimere questa verità per mezzo della dottrina dell’incarnazione di Dio.
BRICIOLE DI FILOSOFIA
La tensione drammatica dei testi precedenti qui è notevolmente ridimensionata. Ora Kierkegaard traduce sul piano filosofico le riflessioni maturate su quello psico-religioso. Egli inoltre cerca di dare un fondamento filosofico alla propria concezione religiosa dell’esistenza. I concetti che va elaborando, oltre a quello di “singolo”, sono: “paradosso” (in antitesi alla mediazione hegeliana dei contrari: la mediazione è concettuale, l’esistenza è paradossale perché unica, irriducibile alla comprensione adeguata del pensiero), “scandalo” (che è -secondo Kierkegaard- il vero volto del dubbio cartesiano e di tutta la filosofia moderna, che ha voluto staccarsi dalla religione), “contemporaneità” (in antitesi al concetto hegeliano di “divenire storico”: per il singolo la storia si riduce a un nulla, in quanto il problema di realizzare una “beatitudine eterna” nella storia gli si presenta nella sua assoluta radicalità e la storia non gli è di nessuno aiuto ai fini della realizzazione). Il singolo di Kierkegaard deve essere consapevole di vivere un’esistenza unica, paradossale e, in quanto “discepolo di Cristo” (perché il singolo si definisce “cristiano” o almeno intenzionato a diventarlo) deve anche sentirsi “contemporaneo” a lui, aldilà dello sviluppo storico, anzi contro questo stesso sviluppo, che ha ridotto l’esperienza cristiana a una banalità, a una ovvietà (si è cristiani in massa, solo perché si viene battezzati, solo perché si vive in un certo Stato ecc. -dice Kierkegaard). In questa “contemporaneità” la fede del singolo non può che destare “scandalo” nell’interlocutore, che si sente già cristiano e che non dubita della propria fede. Lo scandalo mette in crisi le certezze acquisite, le conquiste del passato. Kierkegaard rifiuta il concetto di “divenire storico” in quanto la storia ha tradito Cristo. Con questo saggio prosegue la critica, iniziata con Timore e tremore, dell’ufficialità protestantica della Chiesa danese, anche se questa polemica, per il momento, passa attraverso la critica dell’hegelismo. Da notare comunque che Kierkegaard non ha mai accettato di definirsi “filosofo”: anche quando scriveva di filosofia egli preferiva definirsi col termine di “scrittore religioso” o “edificante” (la sua, semmai, è una filosofia della religione).
GLI STADI DEL CAMMINO DELLA VITA
Negli Stadi del cammino della vita, Kierkegaard distingue tre condizioni o possibilità esistenziali fondamentali, alle quali egli dà il nome di “stadi”, poiché possono essere considerati come momenti successivi dello sviluppo individuale. Contrariamente alle affermazioni hegeliane, nel passaggio dialettico tra l’uno e l’altro non vi è nessuna forma di automatismo, bensì un “salto”che può essere colmato soltanto con la libera scelta del singolo. Queste determinazioni sono lo stadio estetico, lo stadio etico e lo stadio religioso. Nella prima opera pubblicata dopo la tesi di laurea, Aut-aut, Kierkegaard delinea la distinzione tra i primi due stadi. Lo stadio estetico è incarnato dalla figura del seduttore, che dedica la sua intera esistenza alla conquista dell’animo femminile per il puro piacere della conquista stessa. La vita estetica, infatti, è incentrata sul desiderio e sul godimento. L’esteta non esce dalla sfera della sensualità:per questo il personaggio che meglio lo rappresenta è il Don Giovanni di Mozart. La musica è infatti la più sensuale delle arti, poiché in essa l’espressione è totalmente immediata, senza far ricorso alla parola, che invece comporta una dimensione concettuale e riflessiva. Analogamente il seduttore vive nell’elemento dell’immediatezza: egli non compie mai una scelta definitiva, non si impegna mai in nulla, la sua filosofia è il motto graziano del “carpe diem”. La vita dell’esteta è una successione ininterrotta di istanti indipendenti gli uni dagli altri:egli passa da un’esperienza all’altra senza che quella precedente lasci una traccia di sé su quella successiva, senza che la sua esistenza abbia una storia. L’unico elemento costante nella sua vita è la ricerca del nuovo e del rifiuto della ripetizione, considerata come fatale principio di noia. Il suo unico compito è la ricerca dell’eccezionalità, nell’ esasperata volontà di diversificarsi da tutti gli altri individui, così come da tutte le proprie esperienza passate. Proprio a causa dell’assenza di un punto unificatore dell’esistenza, l’esito finale dello stadio estetico è la disperazione, la presa di coscienza della assoluta vanità di ogni cosa. Anche la disperazione, tuttavia, può essere vissuta in due maniere diverse. Essa può venire considerata una forma estremamente raffinata di divertimento, che consiste appunto nel non prendere mai sul serio nulla e godere anzi della mancanza di senso di ogni cosa:in questo caso non si esce dalla sfera estetica. Oppure l’esteta può pervenire alla disperazione vera che, mostrandogli la vanità delle sue esperienze, lo induce a compiere il salto verso un genere di vita superiore, retto da principi completamente estranei alle regole dell’estetica. In questa situazione il singolo perviene allo stadio etico. Tra i due stadi, comunque, non c’è alcuna forma di mediazione. Il passaggio dalla disperazione finita (estetica) alla disperazione infinita (etica) è un salto che può essere compiuto solo in base alla libera scelta del singolo. Lo stadio etico trova la sua migliore rappresentazione nella figura del marito o, più in generale, nel personaggio del Consigliere di Stato Guglielmo, la cui esistenza è circoscritta dalle sfere del matrimonio, della famiglia, della professione, della fedeltà allo Stato. Se l’esteta trapassa di istante in istante senza impegnarsi mai in nulla, la vita dell’uomo etico è invece contrassegnata dalla scelta. In primo luogo, egli compie la scelta fondamentale tra bene e male; in secondo luogo, una volta scelto un determinato bene, una certa sposa, una certa professione, ecc. egli conferma in ogni momento la sua scelta, tornando a scegliere in ogni istante ciò che ha già scelto per sempre. L’uomo etico, a differenza dell’esteta, non teme dunque la ripetizione, anzi la ama, vedendo in essa una continua riconferma della sua decisione iniziale. Se la vita dell’esteta si frantuma in una miriade di istanti privi di storia, quella dell’etico si sviluppa nella continuità del tempo. All’ esasperata ricerca dell’eccezionalità da parte dell’esteta egli contrappone la tranquilla universalità del dovere, di cui l’esistenza etica è una continua realizzazione. Ma per l’uomo etico il dovere non è un’imposizione esteriore (come sarebbe per l’esteta), bensì un concreto dovere coniugale, professionale o civile che egli spontaneamente riconosce come la propria condizione. Il dovere morale non è altro che “il compito che si è a se stessi”,ciò che ciascuno ha deciso di diventare in virtù della sua libera scelta. Anche la vita etica, tuttavia, appare limitata. Se sceglie se stesso fino in fondo, l’individuo raggiunge la propria origine, cioè Dio. Ma poiché di fronte alla maestà di Dio l’unico sentimento che l’uomo può provare è quello della propria inadeguatezza morale, cioè della propria colpevolezza, l’esito finale della vita etica è il pentimento. L’uomo etico viene così messo di fronte al peccato, il quale però non è più una categoria etica, bensì una determinazione religiosa. Con il pentimento, dunque, si esce dalla sfera dell’etica per entrare in quella della religione, sebbene,anche in questo caso, il passaggio non sia automatico, ma comporti un salto ancora più radicale di quello che divideva l’ambito etico da quello estetico. Lo stadio religioso è descritto in Timore e tremore,opera che già nel titolo esprime la natura dell’atteggiamento che l’uomo religioso deve avere nei confronti del divino. Nella sfera etica l’individuo vive nell’ambito dell’universale: ciò che è bene e ciò che è male, ciò che è dovere e ciò che è colpa, sono noti a tutti. Nella sfera della religione invece, il “cavaliere della fede” è assolutamente solo:il suo unico rapporto è quello con Dio. La dimensione religiosa comporta una sospensione dell’etica, poiché essa si impernia esclusivamente sulla volontà di Dio, che può anche divergere dalle leggi dell’etica. La figura emblematica di questa condizione è Abramo, che per obbedire a Dio non esita a sacrificare l’unico figlio Isacco. Dal punto di vista morale egli ha soltanto un dovere, quello di essere un buon padre: l’etica, dunque, lo condanna irrimediabilmente come un assassino. La giustificazione della sua intenzione di uccidere Isacco risiede tutta nella volontà di Dio, la quale si esprime esclusivamente nel rapporto interiore tra il singolo Abramo e la divinità. Nessuno lo può capire in base alle regole dell’etica, ed egli stesso non può essere certo di non sbagliare: la fede è rischio. Isolato da tutti gli altri, egli è un’eccezione assoluta, come l’esteta, con la sola ma importante differenza che l’eccezionalità dell’esteta è tale perché non si è ancora elevata all’universalità dell’etica, mentre quella religiosa è tale perché ha già superato questa universalità. La fede consiste proprio nel paradosso per cui esiste un’interiorità incommensurabile con l’esteriorità: in virtù della fede il singolo, che per l’etica è subordinato all’universalità della legge, afferma la propria superiorità rispetto all’universale in nome del suo rapporto individuale con l’assoluto.
POSTILLE NON SCIENTIFICHE
Alle Briciole seguirà nel ’46 la monumentale Postilla conclusiva non scientifica. A partire da questo volume (che secondo Kierkegaard doveva essere un’antitesi alla Logica di Hegel), Kierkegaard si lamenta di non avere più un interlocutore. Nelle Briciole, infatti, il “re senza terra”, lo “scrittore senza pretese” -come si autodefinisce nel Concetto dell’angoscia) crede ancora nel valore di un pubblico riconoscimento della sua produzione letteraria. Ma nella Prefazione della Postilla -visto il pessimo risultato editoriale delle Briciole- cambia completamente parere, chiarendo anzi che la celebrità è un grave impedimento alla realizzazione del suo ideale religioso. Così pure afferma nel discorso edificante Vangelo delle sofferenze, edito sempre nel ’46, ove esalta la figura di Giobbe. Tuttavia, i fatti successivi al ’48 dimostreranno che Kierkegaard non era affatto alieno dal desiderare una pubblica notorietà. Con la Postilla -di cui riuscirà a vendere solo 50 copie- l’intenzione di Kierkegaard era quella di concludere la sua attività di scrittore: lo attesta il fatto che con essa egli fa un bilancio di tutta la sua precedente produzione letteraria, rivelando al pubblico, che peraltro già lo sapeva, chi si celava dietro i diversi pseudonimi usati per i suoi libri. A chiudere tale attività l’aveva indotto anche la polemica con la rivista satirica Il corsaro, che lo prese in giro per diversi mesi, facendo colpo sul pubblico. Il giornale venne chiuso dal governo e il direttore espulso dal paese per “indegnità morale”, ma Kierkegaard se ne risentì profondamente, anche perché pochissimi avevano preso le sue difese. Egli aveva sopportato gli scherni perché così gli sembrava di adempiere al compito di testimoniare una verità religiosa, ma ciò non era avvenuto senza profondi drammi personali. Nella vita di Kierkegaard gli avvenimenti esteriori sono molto pochi ma, a causa del suo autoisolamento, essi venivano ad acquistare un’importanza eccezionale per la sua coscienza. Kierkegaard voleva essere uno scrittore per il popolo, o meglio per i molti singoli della società: Il corsaro invece aveva capito ch’egli altro non era che uno “scrittore per scrittori”, cioè un’individualità astratta, isolata, con pretese sproporzionate rispetto alle sue forze. Nella Postilla comunque il disprezzo per la socialità raggiunge forme di particolare conservatorismo filo-monarchico. Kierkegaard teme chiaramente le idee liberali, democratiche e socialiste. Tuttavia, nella Postilla la rottura col pubblico non è così esacerbata come lo sarà nella Malattia mortale e nell’Esercizio del cristianesimo. Forse perché la sua posizione esistenziale restava, in ultima istanza, ancora troppo poco determinata: lui stesso la definisce “umoristica”. “Climacus” (lo pseudonimo scelto per i due volumi di filosofia) è un “umorista privatista”, cioè un intellettuale indifferente alle vicende della vita, è un “poeta”, “senza autorità”, senza essere seguace di alcun partito, ha solo il senso del “comico” (che è tipico delle nature malinconiche) e scrive per il gusto di scrivere, senza sentirsi coinvolto sino in fondo in quello che dice. La sua preoccupazione è quella di porre il problema di come vivere il cristianesimo, non è quella di dimostrare come vada vissuto concretamente. “Climacus” non è cristiano ma è impegnato a diventarlo. La Postilla vuole anzitutto essere un testo anti-hegeliano. Essa rappresenta il tentativo di fare del cristianesimo un’esigenza personale, non solo l’oggetto di una speculazione intellettuale. In questo senso la filosofia di Kierkegaard è sempre una filosofia religiosa o della religione. Ciò che più gli interessa non è il problema “oggettivo” della verità, cioè non gli interessa discutere sulla verità oggettiva del cristianesimo, poiché questa verità egli la dà per scontata. Il problema per lui è dimostrare soggettivamente il valore di questa verità. La speculazione, le prove ontologiche dell’esistenza di Dio, la tradizione, la Bibbia, la considerazione storica…: tutto ciò o è tautologico (in quanto non dimostra soggettivamente ciò in cui dice di credere oggettivamente) o è ipocrisia (in quanto dice il contrario di quello che vive, di quello che è la realtà). L’oggettività o è falsa o non serve, in quanto non può provare nulla. Per Kierkegaard è definitivamente tramontato il tempo in cui il cristiano può considerarsi tale solo perché dice di credere nelle verità di fede della chiesa. La sua propria religiosità deve dimostrarla nei fatti, coll’atteggiamento personale. Tuttavia nella Postilla Kierkegaard arriva a tale consapevolezza solo a livello teoretico, con l’affermazione principale che “la verità è la soggettività”, che vuol dire: solo nel modo come il soggetto vive la verità si può comprendere se questa verità è per lui autentica, genuina, profonda. Il criterio della verità è la pratica della verità stessa. Questa pratica per Kierkegaard è eminentemente religiosa. La fede è quella forma di interiorità (destinata a esplicitarsi in un giudizio di condanna della cristianità stabilita) che non si lascia oggettivare da alcunché. La soggettività infatti è la sola realtà che Kierkegaard sia disposto ad ammettere. Nel Vangelo delle sofferenze (1846) Kierkegaard fa coincidere espressamente “interiorità” con “sofferenza”. Cioè la sofferenza è il criterio della verità: senza pathos una qualunque verità è astratta, non edificante. In particolare nel Vangelo delle sofferenze il singolo-Giobbe soffre da innocente davanti a Dio, pur pensando, umilmente, d’essere colpevole, poiché davanti a Dio l’uomo ha sempre torto. Kierkegaard dunque sa di non aver nulla da rimproverarsi davanti agli uomini, in quanto l’esteriorità della Chiesa trionfante è chiaramente per lui una falsità.
LA MALATTIA MORTALE
A. CHE LA DISPERAZIONE SIA LA MALATTIA MORTALE – B. LA DISPERAZIONE È UNA MALATTIA NELLO SPIRITO NELL’IO, E COSÌ PUÒ ESSERE TRIPLICE: DISPERATAMENTE NON ESSERE CONSAPEVOLE DI AVERE UN IO (DISPERAZIONE IN SENSO IMPROPRIO); DISPERATAMENTE NON VOLER ESSERE SE STESSO; DISPERATAMENTE VOLER ESSERE SE STESSO. L’ uomo è spirito. Ma che cos’è lo spirito? Lo spirito è l’io Ma che cos’è l’io? È un rapporto Che si mette in rapporto con se stesso oppure è, nel rapporto, il fatto che il rapporto si metta in rapporto con se stesso; l’io non è il rapporto, ma il fatto che il rapporto si mette in rapporto con se stesso. L’uomo è una sintesi dell’infinito e del finito, del temporale e dell’eterno, di possibilità e necessità, insomma, una sintesi. Una sintesi è un rapporto fra due elementi. Visto così l’uomo non è ancora un io. (S. Kierkegaard, La malattia mortale, Roma, Newton Compton)
Nell’opera La malattia mortale Kierkegaard riprende ed approfondisce il tema della disperazione. Abbiamo già visto ch’egli presenta la disperazione sia come l’elemento che caratterizza la vita dell’esteta, sia come la condizione che permette il salto dalla vita etica a quella religiosa. Si tratta di due aspetti, spiega il filosofo, di due facce dello stesso fenomeno. La disperazione, cioè, è sempre una negazione di sé, del proprio io; ma nel primo caso essa ha luogo in quanto l’uomo è sempre alla ricerca di se stesso, di un io che non coincide mai con quello che di volta in volta egli è, e che però egli non trova mai; nel secondo caso essa è rifiuto totale di sé, è quella rinuncia a sé che si traduce, sul piano della fede, nella assoluta autodonazione a Dio. Anche la disperazione dunque, come l’angoscia, caratterizza un rapporto: la seconda, quella del singolo con il mondo, la prima quella del singolo con se stesso. Infatti l’angoscia insorge al cospetto di quegli «infiniti possibili», e dell’«infinità del possibile» che il mondo rappresenta per l’uomo; la disperazione nasce invece di fronte a quella radicale incognita che è il proprio io. Due sono i possibili modi di relazionarsi a se stesso; uno è quello di accettare di essere se stesso, l’altro è quello di rifiutare di essere se stesso; ma la disperazione si verifica in entrambi i casi, sia quando l’uomo vuole essere se stesso, sia quando non vuole assolutamente essere se stesso, cioè quando egli rinnega totalmente se stesso, quello che è e quello che potrebbe essere. Nel primo caso il singolo si dispera perché vuole ma non riesce a trovare se stesso nei vari possibili, in quanto tutte le possibilità di essere se stesso si rivelano insufficienti e inadeguate. Nel secondo caso egli si dispera quando percepisce che non c’è piú alcuna possibilità di trovare il vero se stesso, e vi rinuncia; e vorrebbe semplicemente distruggere se stesso senza potervi riuscire. Questa seconda è dunque la forma piena, totale, della disperazione; è quella che Kierkegaard chiama malattia mortale.
Cadere nella malattia mortale è non poter morire; ma non come se ci fosse la speranza della vita; l’assenza di ogni speranza significa qui che non c’è nemmeno l’ultima speranza, quella della morte. Quando il maggior pericolo è la morte, si spera nella vita; ma quando si conosce un pericolo ancora piú terribile, si spera nella morte. Quando il pericolo è cosí grande che la morte è divenuta la speranza, allora la disperazione nasce venendo a mancare la speranza di poter morire. In quest’ultimo significato la disperazione è chiamata la malattia mortale: quella contraddizione penosa … di morire eternamente, di morire e tuttavia di non morire, di morire la morte. Perché morire significa che tutto è passato, ma morire la morte significa vivere, sperimentare il morire. (La malattia mortale)
Questa disperazione è la porta della fede.
L’ESERCIZIO DEL CRISTIANESIMO
Nell’Esercizio del cristianesimo egli afferma che Dio si serve del singolo per far uscire l’ordine stabilito dal suo autocompiacimento. L’ambizione del singolo è quella di essere direttamente contemporaneo a Cristo, tanto da dover apparire, agli occhi dei suoi contemporanei, come lui, cioè come un singolo che lotta contro il sistema sacrificandosi fino al martirio. Kierkegaard ha bisogno di porre in atto la possibilità dello scandalo, da cui può sorgere la fede, al fine di dimostrare al sistema che la sua alternativa è l’unica praticabile, recuperando così la profondità del cristianesimo. Nell’Esercizio Kierkegaard torna a parlare della collisione del pietismo coll’ordine stabilito, ma egli pensa di aver fatto molto di più. Egli avrebbe rifiutato l’esperienza pietistica perché come singolo la possibilità dello scandalo gli era parsa superiore. La comunità -dice Kierkegaard- è “un’anticipazione impaziente dell’eternità”, mentre essere singoli significa lottare contro tutti, poiché la storia è il tempo della lotta, mentre l’eternità è la felicità della vittoria. La chiesa militante deve essere una chiesa di singoli. La possibilità dello scandalo è qui superiore perché nell’ambito del singolo la “comunicazione diretta” con l’interlocutore è impossibile, cioè è impossibile essere capiti, almeno finché si è vivi. Ciò è per il singolo fonte di sofferenza, ma per l’interlocutore è una prova della sua fede, la quale è scelta esistenziale e non conclusione logica di un ragionamento. L’interlocutore deve credere nel singolo non per quello che fa ma per quello che dice. Infatti per quello che fa egli resta insignificante, ambiguo: il che però, rapportato a quello che dice, desta profondo scandalo. Questa “duplicità dialettica” deve far riflettere l’interlocutore e portarlo alla fede. Per indicare l’impossibilità della “comunicazione diretta” (che se ci fosse porterebbe l’interlocutore ad avere fede non in Dio ma nel singolo), Kierkegaard usa il termine “raddoppiamento maieutico” o “reduplicazione”. L’Esercizio del cristianesimo, che appare nel ’50, toccherà Mynster -dice Kierkegaard- “in misura estremamente dolorosa”, tanto che il vescovo reagirà bollandolo con l’apostrofe “un gioco empio con le cose sacre”. Con questo libro Kierkegaard in pratica rinunciava a una qualunque intesa colla cristianità: egli aveva messo in chiaro il suo punto di vista, ora poteva finalmente smettere di scrivere. Tuttavia nel ’51 pubblica, senza pseudonimo, Per l’esame di se stessi raccomandato ai contemporanei, ove esalta la figura dell’apostolo Giacomo (per la valorizzazione del concetto di “opere”) e la figura di Lutero per l’approfondimento del concetto che senza la fede le opere non servono a niente; alla fine condanna la cristianità per aver abolito fede ed opere. Naturalmente l’opera più importante è per Kierkegaard “l’imitazione di Cristo”, che è il contrario della superficiale ammirazione. Sempre nel ’51, per un tracollo finanziario, Kierkegaard perde molti suoi beni.
IL DIARIO DI UN SEDUTTORE
Tre sono i possibili modi fondamentali di vivere e di concepire la vita, secondo Kierkegaard: quello estetico, simboleggiato da don Giovanni, che il filosofo presenta come protagonista del Diario di un seduttore, quello etico, simboleggiato dal «marito fedele», e quello religioso, simboleggiato da Abramo, il personaggio biblico. I primi due «ideali» sono descritti in Aut-Aut, il terzo in Timore e tremore. Questi tre «modelli» sono in irriducibile alternativa tra di loro; si escludono vicendevolmente; sicché il terzo non costituisce un superamento in senso hegeliano dei due precedenti. Il passaggio, possibile ma non necessario, dall’uno all’altro implica, per Kierkegaard, sempre una radicale rottura, un salto, una metànoia, cioè un capovolgimento di mentalità. Nello stadio estetico l’uomo conforma la sua esistenza secondo il principio di godersi la vita; il che comporta un vivere permanentemente nel presente, nell’attimo. Il grado di godimento varia a seconda del livello di spiritualità ch’egli ha conquistato. In senso pieno, però, l’esteta è colui che, guidato da una sensibilità raffinata e da una vivacissima immaginazione, ricerca sempre qualcosa che possa interessarlo e in cui possa coinvolgersi, spinto da un desiderio continuo di rinnovarsi nelle sempre nuove esperienze di piacere. Egli rifiuta pertanto il godimento grossolano, l’esperienza banale, i pensieri meschini; anzi sa valutare i diversi possibili piaceri e sa scegliere quelli che «valgono la pena», cioè quelli eccezionali e quelli che producono più intenso godimento. È evidente, osserva Kierkegaard, che per esser davvero esteta bisogna aver «talento», un appropriato dono naturale; ma è pur vero che vivere da vero esteta implica «educazione» alla raffinatezza. Se poi si aggiunge che le circostanze della vita spesso ne impediscono il godimento, allora, non solo questo «ideale» non è alla portata di tutti, ma addirittura pochi possono avere la «fortuna» di incarnarlo stabilmente nella propria esistenza.
Dobbiamo godere la vita; ma la condizione di questo godimento la troviamo nell’individuo stesso, però in modo da non esser posta da lui. Qui in generale la personalità è determinata come talento… Forse non si rimarrà fermi al talento nella sua spontaneità, lo si educherà in tutti i modi, ma la condizione per la soddisfazione nella vita è il talento stesso … Nel desiderio l’individuo è immediato, e, per quanto il piacere sia raffinato, ricercato, studiato, l’individuo è pur sempre in esso come immediato. Chi gode è nel momento, e per quanto molteplice sia questo godimento, egli è sempre immediato, perché è nel momento. Pertanto vivere per soddisfare i propri desideri è una posizione molto raffinata nella vita, e, grazie a Dio, è raro vederla realizzata completamente a causa delle difficoltà della vita terrena che danno altro da pensare all’uomo. (Aut-Aut)
Ma vivendo momento per momento l’uomo non trova mai in sé una sua propria identità, sicché s’insinua il sentimento dell’inadeguatezza del suo modo di vivere; ossia, s’insinua la noia che apre la porta alla disperazione; meglio, alla consapevolezza della sua disperazione (infatti il suo legarsi all’attimo, il suo incessante passaggio da piacere a piacere, non è che inconsapevole disperazione); e questa consapevolezza costituisce la condizione primaria per l’insorgenza del bisogno di «cambiar vita», di una vita diversa, anzi di segno opposto, e dell’effettivo salto nello stadio etico.
ABRAMO
Tre sono i possibili modi fondamentali di vivere e di concepire la vita, secondo Kierkegaard: quello estetico, simboleggiato da don Giovanni, che il filosofo presenta come protagonista del Diario di un seduttore, quello etico, simboleggiato dal «marito fedele», e quello religioso, simboleggiato da Abramo, il personaggio biblico. I primi due «ideali» sono descritti in Aut-Aut, il terzo in Timore e tremore. Questi tre «modelli» sono in irriducibile alternativa tra di loro; si escludono vicendevolmente; sicché il terzo non costituisce un superamento in senso hegeliano dei due precedenti. Il passaggio, possibile ma non necessario, dall’uno all’altro implica, per Kierkegaard, sempre una radicale rottura, un salto, una metànoia, cioè un capovolgimento di mentalità. Anche la vita religiosa non nasce come continuazione, incarnazione della vita etica, ma, al contrario, proprio religioso dal naufragio di questa; come – di nuovo – «rottura», come «conversione», come «abbandono» anche degli stessi criteri e valori etici. Lo strumento che permette la vita etica è la ragione, quello che guida la vita religiosa è la fede. Di questa fede Kierkegaard ha portato come esempio Abramo. A lui, già settantacinquenne, e senza figli per la sterilità della moglie Sara, Dio disse: «Parti dal tuo paese, dai tuo parentado, dalla casa di tuo padre, e va nella terra che io ti mostrerò. Io farò di te un popolo grande, ti benedirò e renderò grande il tuo nome». Spinto dalla fiducia nella Parola del suo Signore, Abramo eseguì il comando. Diventò molto ricco di bestiame, di oro e di argento, ma non ebbe quel figlio dal quale doveva nascere il popolo di Israele. E quando cominciava ad emergere il dubbio sulla promessa di Dio, questi lo rassicurò: avrebbe avuto un erede «uscito dalle sue viscere», partoritogli da sua moglie ormai novantenne. E nacque infatti Isacco. Sembrava ormai compiuto il compito di Abramo; ma Dio lo mise alla prova: «Orsù, prendi il tuo figlio, l’unico che hai e che tanto ami, e offrilo in olocausto sopra quel monte che io ti mostrerò». Sembrava quindi che Dio ritirasse la promessa, ma, ciò nonostante, il vecchio eseguí l’ordine. Ma allorché già aveva deposto sulla legna per la pira il corpo di Isacco e aveva messo mano al coltello per sgozzarlo, intervenne il Signore e gli disse: «Non mettere la mano addosso al fanciullo, e non fargli alcun male, perché ora conosco che tu temi Iddio, e non mi hai negato tuo figlio, il tuo unico figlio». In questo racconto biblico Kierkegaard individua gli elementi della fede autentica:
Ci furono uomini grandi per la loro energia, per la saggezza, la speranza o l’amore. Ma Abramo fu il piú grande di tutti: grande per l’energia la cui forza è debolezza, grande per la saggezza il cui segreto è follia, grande per la speranza la cui forma è demenza, grande per l’amore ch’è odio di se stesso. Fu per fede che Abramo lasciò il paese dei suoi padri e fu straniero in terra promessa. Lasciò una cosa, la sua ragione terrestre, e un’altra ne prese: la fede. Altrimenti, pensando all’assurdità del suo viaggio, non sarebbe partito. Fu per fede uno straniero in terra promessa ove nulla gli ricordava quel che egli amava, mentre la novità di tutte le cose gli poneva in cuore la tentazione d’un doloroso rimpianto … Fu per fede che Abramo ricevette la promessa che tutte le nazioni della terra sarebbero state benedette nella sua posterità. Il tempo passava, la possibilità rimaneva Abramo credeva. Il tempo passò, la speranza diventò assurda, Abramo credette. È pure esistito nel mondo colui che ebbe una speranza. Il tempo passò, la sera fu al suo declino, e quell’uomo non ebbe la viltà di rinnegare la sua speranza… Poi conobbe la tristezza; e il dolore, invece di deluderlo come la vita, fece per lui tutto quel che poté e, nella sua dolcezza, gli dette il possesso della sua speranza ingannata. È umano conoscere la tristezza umano condividere la pena di chi è afflitto, ma è cosa piú grande credere, e piú confortevole e benefica cosa contemplare chi crede. Abramo non ci ha lasciato lamentazioni. Non ha contato tristemente i giorni man mano che trascorrevano; non ha guardato Sara con occhio inquieto per vedere se gli anni incidevano rughe sul suo volto; non ha fermata la corsa del sole per impedire a Sara di invecchiare, e Sara fu schernita nel paese. Eppure era l’eletto di Dio e l’erede della promessa… Non sarebbe forse stato meglio che egli non fosse stato l’eletto di Dio? Che cosa significa dunque essere l’eletto di Dio? Significa vedersi rifiutare nella primavera della vita quello che è il desiderio della giovinezza, per essere esaudito in vecchiaia dopo grandi difficoltà. Ma Abramo credette e serbò fermamente la promessa, cui avrebbe rinunciato se avesse dubitato. Avrebbe detto a Dio, allora: «Forse non è nella tua volontà che questo mio desiderio si realizzi. Rinuncio dunque al mio desiderio, all’unico mio desiderio, nel quale riponevo la mia felicità. La mia anima è onesta, e non nasconde nessun astio segreto per il tuo rifiuto». Non sarebbe stato dimenticato. Avrebbe salvato molti col suo esempio ma non sarebbe diventato il padre della fede, perché è grande cosa rinunciare al proprio desiderio piú caro, ma è cosa piú grande serbarlo dopo averlo abbandonato. Grande è cogliere l’eterno, ma è piú grande cosa riavere il transeunte, dopo averne fatto rinuncia. (Timore e tremore)
Di fronte al personaggio di Abramo, che non si trattiene finanche dal voler sacrificare il figlio, Kierkegaard nota:
Ma, quando mi metto a riflettere su Abramo, sono come annientato. Ad ogni istante i miei occhi cadono sull’inaudito paradosso che è la sostanza della sua vita…; il mio pensiero non può penetrare quel paradosso neppure per un capello. (Timore e tremore)
Per lui dunque la fede è esperienza propria del singolo, vissuta in piena solitudine. Non è mai un possesso stabile, ma una ricerca continua, un rapporto con Dio che deve rinnovarsi momento per momento. Tale rapporto è paradossale, perché implica lo scontro con la propria ragione, coi propri affetti e sentimenti, e perché è aperto sull’ignoto: perciò è anche angoscioso. Esso sorge da una chiamata di Dio – in ciò la fede è dono di Dio – non dal potere dell’uomo, e, tuttavia, all’uomo manca la certezza di questo rapporto, mancano le possibilità di verifica. All’uomo non resta altro che rinunciare a sé per trovare il vero se stesso.
HEGEL
La verità soggettiva
Da Hegel lo differenzia il concetto di soggettività della verità, da intendersi non nel senso di soggettivismo, ma come valenza esistenziale del vero: la filosofia non deve rimanere fredda e astratta sintesi sistematica, ma deve illuminare l’esistenza.
“la via della riflessione oggettiva trasforma il soggetto in qualcosa di accidentale, e quindi riduce l’esistenza in qualcosa di indifferente, di evanescente”, “porta dunque al pensiero astratto”. “Al suo culmine la soggettività è svanita” .
“la passione è precisamente il culmine dell’esistenza (..). Se ci si dimentica di essere un soggetto esistente, la passione se ne va (..), ma il soggetto (..) diviene un’entità fantastica.” (Postilla )
“succede alla maggior parte dei filosofi sistematici, riguardo ai loro sistemi, come di chi si costruisse un castello, e poi se ne andasse a vivere in un fienile: per conto loro essi non vivono in quell’enorme costruzione sistematica.” (Diario )
Invece la verità che interessa K. è quella che fa “comprendere se stesso nell’esistenza” (Postilla )
“se stesso”: a) singolo irriducibile all’organismo storico-statale, irriducibile a momento dello sviluppo dialettico dello Spirito; e b) chiamato a scegliere (aut-aut), per il quale dunque la verità non è scindibile dal bene personalmente voluto e attuato (a differenza di Socrate);
K. interpreta anche la celebre definizione tomista di verità come adaequatio intellectus ad rem:
l’intellectus, che si “adegua” alla realtà, non è nè la Ragione trascendentale, nè un Ragione astratta, ma il “pensiero soggettivo” del concreto esistente; a cui preme non l’essere-in-sé, un essere astratto, conosciuto sistematicamente, ma la propria esistenza (a cui è “infinitamente interessato”, Postilla), fatta di eventi contingenti, non deducibili dalla necessità dell’Idea, dunque drammatica. In ciò polemizza tanto contro la tranquillità della coscienza hegeliana, per la quale tutto è necessario e razionale, quanto contro la Cristianità stabilita, che non coglie il carattere drammatico della vita). Palando del Giudizio Universale K. immagina che su quattro che si presenteranno al Supremo Giudice, tre non cristiani, ma con sofferente ricerca, e uno cristiano, anzi professore universitario, ma animato dalla presuntuosa convinzione di aver spiegato il Cristianesimo, sarà proprio quest’ultimo ad essere nella situazione peggiore.
La dialettica
Hegel, con la sua dialettica dell’et-et, sintetizzava gli opposti: per lui non c’è antitesi che non possa essere riassorbita e riconciliata in una sintesi. Parallelamente tutto il cammino della vita umana, personale e collettiva, si snoda secondo una logica necessaria: senza che vi sia responsabilità della libertà personale.
Kierkegaard invece sottolinea con forza appunto una prospettiva incentrata sulla persona, che si caratterizza per la possibilità di scelta libera, e di scelta tra alternative inconciliabili. Non un et-et, che dispensa dalla scelta un singolo visto come trascinato dall’inesorabile flusso della collettività storica, ma un aut-aut, che impegna la persona nella sua indelegabile, indemandabile libertà personale, in un dramma assolutamente personale, in cui ne va del proprio destino eterno.
Gli “stadi” dell’esistenza (in aut-aut)
La filosofia deve interessarsi essenzialmente dell’esistenza, e l’esistenza può, in ultima analisi, avere tre forme, o stadi: estetico, etico e religioso. La tripartizione kierkegaardiana può trovare delle analogie, oltre che con il ritmo ternario che Hegel aveva ripreso da una tradizione medioevale, con la teoria dei tre ordini di Pascal: la materia (estetica), lo spirito(etica), la carità (religiosità). Tra uno stadio e l’altro il passaggio non è necessario automatismo, ma salto, effettuabile solo dalla libertà del singolo.
1. estetico [tesi / pura particolarità /sensibilità ] L’uomo che vive in questa forma, l’esteta, rifiuta tutto ciò che è impegnativo, ripetitivo, serio:
“chi vive esteticamente vive sempre solo nel momento” L’esteta ricerca sensazioni sempre nuove, idolatrando l’istante fuggevole che non affondi radici nel passato e non costruisca impegnativamente il futuro. Per questo “la sua vita si disfa in una serie incoerente di episodi” senza senso ultimo; analogamente egli rifiuta ogni legame stabile, tanto a livello affettivo, quanto a livello sociale.
Figura-simbolo della vita estetica è il Don Giovanni, il seduttore, che non si lega mai ad una donna, ma passa senza sosta da una donna all’altra, nessuna amando mai veramente, senza vera storia e senza prospettiva.
L’esteta in tal modo fugge continuamente da sé stesso, distraendosi nell’esteriorità (in una esteriorità alienante, si potrebbe dire), ed è contrassegnato dalla noia (come dice Kierkegaard in Aut-aut), ed è in fondo, lo sappia o no, disperato.
2. etico [antitesi / pura universalità /ragione ] È caratterizzato da stabilità, fedeltà, ripetitività: figura-simbolo ne è il matrimonio; in questo stadio l’uomo si sottopone a una forma, a una regola, a un impegno costante nel tempo, sceglie insomma l’universale. Ma non si tratta ancora dello stadio che vede la realizzazione piena dell’umano. Un uomo che voglia essere davvero serio, e non rigoristicamente e farisaicamente serioso, deve infatti riconoscere che nella sua vita c’è il peccato e ci sono quella angosce e quella disperazione che la semplice razionalità e l’osservanza pur meticolosa di regole universali non bastano a sanare; anzi in questo stadio l’uomo non riesce a guardare in faccia davvero la Medusa terribile del suo proprio male. Per raggiungere la verità di sé e della propria vita bisogna andare oltre: solo se amato da un Altro, che sia Infinita Misericordia l’uomo può guardare davvero a sé come a un “io”. Perciò il passo ultimo della vita etica è il pentimento , il porsi di fronte al Dio personale che si rivela in Cristo, ma questo lo spinge a trapassare nello stadio religioso.
c. religioso [sintesi / di universale e particolare/ fede ] In questo stadio soltanto l’uomo affronta fino in fondo sé stesso, quell’io di cui finora aveva censurato quegli aspetti che non riusciva a capire e a risolvere, ossia l’angoscia e la disperazione. Tali aspetti non sono, per Kierkegaard, stati d’animo eccezionali e propri di certi temperamenti al limite della patologia, ma sono intrinseci strutturalmente al modo con cui ogni soggetto umano guarda a sé e al mondo.
a. ex parte obiecti l’angoscia (trattato ne Il concetto dell’angoscia) L’angoscia è strutturale in ogni essere umano, in quanto radicata nella sospensione della conoscenza umana (riferita essenzialmente al futuro) tra il sapere del puro immediato (tipicamente animale) e il sapere della totalità concreta (angelico-divino): non è angosciato chi del futuro sa tutto (Dio) o chi non ne sa nulla (l’animale, che vive esaurientemente nell’istante presente). Il suo oggetto è l’indeterminatezza del futuro, il futuro in quanto indeterminato, e in tal senso l’angoscia, il cui oggetto è appunto l’indeterminato, differisce dalla paura, che è sempre paura di un determinato.
b. ex parte subiecti la disperazione (trattato ne La malattia mortale) Se l’angoscia è relativa a ciò che potrebbe accadere, e di cui sappiamo/non-sappiamo, nell’ambito della oggettività dei rapporti intersoggettivi, la disperazione è riferita alla nostra stessa soggettività. Essa significa che l’uomo non riesce ad accettare sé stesso: dispera di essere sé stesso. Essere sé stesso infatti non è automatico, dato che la nostra natura è complessa, è sintesi di fattori tra loro in dialettica, la finitezza e l’infinitezza, la necessità e la possibilità. Normalmente gli uomini soni disperati, perché rinunciano ad essere integralmente sé stessi, rinunciano al loro vero io, e puntano solo su quel fattore del proprio io che meglio riescono a controllare: chi punta sulla finitezza (/necessità) e chi sulla infinitezza (/possibilità), gli uni buttandosi nella sola materialità, gli altri in uno spiritualismo disincarnato e puramente intellettuale/sentimentale.
La sua vera soluzione è solo il Cristianesimo, che permette all’uomo di guardare alla verità, complessa, di sé. Esso ci si presenta come ineludibile problema: quell’Uomo, Cristo, pretende di essere la mia felicità, la risposta al mio bisogno più urgente e fondamentale: non posso ignorarlo, devo sapere se dice il vero o no. Kierkegaard insiste nel presentare la fede come scandalo e paradosso: è un salto reale oltre la semplice razionalità. Si cresce nella verità, e nella verifica della fede, rischiando per essa, non pretendendo di conservarla per così dire in freezer, come pensava l’intellettualismo socratico.
“Nella specie animale – dice Kierkegaard – vale sempre il principio : il singolo è inferiore al genere. Il genere umano ha la caratteristica, appunto perché ogni singolo è creato ad immagine di Dio, che il Singolo è più alto del genere”. Hegel ha invece fatto dell’uomo un genere animale, giacché solo negli animali il genere è superiore al Singolo. L’esistenza – sostiene Kierkegaard – corrisponde alla realtà singolare, al Singolo; e non coincide mai con il concetto : un uomo singolo, concreto, determinato non ha certo un’esistenza puramente concettuale. Invece la filosofia hegeliana pare solo interessata ai concetti : essa non si preoccupa di quell’esistente concreto che siamo io o tu. Il sistema hegeliano ha inoltre la pretesa di spiegare tutto e di dimostrare la necessità di ogni evento. Ma l’esistenza non può essere ingabbiata in un sistema. Ed è sempre la singola esistenza che tiene in scacco tutte le forme di immanentismo e di panteismo, con cui si tenta di ridurre, annullare o riassorbire l’individuo singolo nell’universale.
Ad Hegel che sosteneva l’identità di interno ed esterno, esprimendo così il principio dell’appartenenza inseparabile che i contrari hanno nel concetto, e grazie a cui è possibile la dialettica, il movimento, il progresso, Kierkegaard afferma l’opposto : quanto minore sarà l’esteriorità, tanto maggiore sarà l’interiorità (si pensi alle figure di Socrate e di Cristo: esteriormente erano persone comuni, Socrate era anche piuttosto bruttino; ma interiormente …). Di qui anche la contestazione del passaggio hegeliano dalla quantità alla qualità, che è per Kierkegaard una “superstizione”, in quanto si crede che, con l’aumentare delle determinazioni quantitative, venga fuori una qualità nuova, mentre la quantità è strutturalmente diversa dalla qualità. Infine, all’identità hegeliana di soggetto e oggetto, essere e pensiero ecc., Kierkegaard risponde che la vita intera è basata sulla contraddizione, sul paradosso e non vi è superamento di contrari bensì alternative impegnative che si escludono a vicenda : non vi è nessun et et ma solo un aut aut : o questo o quello, la vita è una scelta continua.
FRASI CELEBRI
Io ho un solo amico, è l’eco: e perché è mio amico? Perché io amo il mio dolore e l’eco non me lo toglie. Io ho un solo confidente, è il silenzio della notte. E perché è il mio confidente? Perché il silenzio tace.
Ma la passione suprema dell’uomo è la fede. Nessuna generazione comincia qui da un punto diverso dalla precedente e ogni generazione comincia da capo; la generazione seguente non va più in là della precedente se questa è rimasta fedele al suo compito. […] Forse in ogni generazione molti non ci arrivano neppure, ma nessuno va oltre.
La mia malinconia è l’amante più fedele ch’io abbia conosciuto: che meraviglia allora ch’io torni ad amarla?
La vita può essere capita solo all’indietro, ma va vissuta in avanti.
Gli uomini come sono incoerenti! Non approfittano mai delle libertà che hanno, ma reclamano quelle che non hanno: hanno la libertà di pensare, chiedono la libertà di parlare.
Ciò che nella sua ricchezza è essenzialmente inesauribile, è anche nel suo minimo atto essenzialmente indescrivibile, proprio perché‚ ciò ch’è essenzialmente presente, e in modo totale, dappertutto, non si può essenzialmente descrivere.
Il primo periodo dell’innamoramento è sempre il più bello, poiché a ogni incontro ogni sguardo si porta a casa qualcosa di nuovo per rallegrarsi.
Io ho il coraggio, credo, di dubitare di tutto; ho il coraggio, credo, di lottare contro tutto; ma non ho il coraggio di conoscere qualcosa, né il coraggio di avere, né di possedere qualcosa.
La mia concezione della vita è completamente senza senso. Io penso che uno spirito maligno mi ha messo sul naso un paio di occhiali di cui una lente ingrandisce a dismisura mentre l’altra rimpicciolisce anch’essa a dismisura.
La mia vita è diventata per me una pozione amara e tuttavia essa va presa come le gocce, lentamente, contando.
Quindi non sono io il padrone della mia vita: io sono un filo che dev’essere intessuto nella trama della vita! Bene, se non so tessere sono almeno capace di tagliare questo filo.
Cos’è la giovinezza? Un sogno. Cos’è l’amore? Il contenuto del sogno.
JEREMY BENTHAM
 LA VITA E IL PENSIERO
LA VITA E IL PENSIEROFilosofo e giurista, nato a Londra il 15 febbraio 1748, mortovi il 6 giugno 1832. Fu d’ingegno assai precoce, tanto da poter leggere a tre anni, parte della History of England di P. De Rapin, e iniziare l’anno seguente l’apprendimento del latino. Studiò a Westminster, quindi all’università di Oxford dove conseguì il grado di baccelliere (1763) e di “maestro in arti” (1766). Indirizzato dal padre all’avvocatura, cui non intendeva dedicarsi, la esercitò per breve tempo, e si volse quindi agli studi filosofici, avvicinandosi particolarmente alle dottrine di Locke, Hume, Beccaria, Montesquieu, Helvétius. Pubblicò, anonimo, nel 1776, il suo primo lavoro, “A Fragment of Government”, in cui attaccava violentemente la costituzione inglese e indicava nel principio utilitaristico il fondamento delle dottrine etico-giuridiche. Compì, nel 1785, passando per l’Italia e per Costantinopoli, un viaggio in Russia (per visitare il fratello, ingegnere navale di Caterina II) e là scrisse la “Defence of usury” (1787). Tornato in Inghilterra, pubblicò la sua opera principale cui attendeva da molti anni: “Introduction to the principles of Moral and Legislation” (1789) intesa alla ricerca di solidi princìpi, dal punto di vista dell’utilitarismo, per una sana legislazione. L’opera gli diede larga fama in Europa e in America. Essa è anche la sola, fra le maggiori, scritta interamente di suo pugno. Nel resto delle sue opere Bentham ebbe a collaboratori discepoli e seguaci, primo fra essi il ginevrino Dumont conosciuto a Londra, il quale, oltre alle traduzioni, ne redasse e pubblicò in francese i “Traités de législation civile et pénale” (3 voll. Contenenti varie opere di Bentham: Principes généraux de législation; Principes du code civil; Principes du code pénal; Mémoire sur la panoptique; De la promulgation des lois, ecc., Parigi 1802); e inoltre la “Théorie des peines et des récompenses” (1811); il “Traité des preuves judiciaires” (1823), e altri scritti. Uscì postumo “Deontology or the Science of Morality” per cura di J. Bowring (Edimburgo 1834). Bentham, per oltre 20 anni, si interessò anche a progetti filantropici, e principalmente alla riforma dei penitenziari (pensava ad un tipo di carcere in cui, da un punto centrale ogni parte fosse visibile, denominato dal greco “panopticon”). Nonostante i suoi progetti fossero stati presi in considerazione dal Parlamento inglese, non approdò ad alcun risultato, pur avendone largo compenso in danaro. Le opere di Bentham, che restano una ricca sorgente di idee legislative, studiate da politici e giuristi, influirono, nel periodo della restaurazione, su varie legislazioni d’Europa e d’America. In Inghilterra le idee del filosofo ebbero larga diffusione, grazie soprattutto alla Westminster Review, da lui fondata, in collaborazione con James Mill, nel 1823, come organo radicale in opposizione alla conservatrice Edimburg Review. La rivista attrasse attorno a sé un gruppo di fervidi collaboratori, primo fra tutti Stuart Mill. La riforma della legislazione inglese, del diritto processuale, civile e penale, in gran parte fu dovuta a Bentham. Bentham occupa un posto importante, oltre che nella storia della legislazione, anche nella storia del pensiero etico per la sua originale espressione, sistemazione e difesa dell’ utilitarismo . Educato dapprima al conservatorismo inglese, tradizionale e ortodosso, Bentham ebbe dalla lettura di Hume la prima rivelazione del principio utilitaristico che divenne il centro di tutta la sua concezione etico-giuridica. Non c’è, egli osserva, a fondamento della condotta umana, quand’essa non si lasci influenzare da pregiudizi, particolarmente d’ordine religioso, altro movente che quello della felicità. Il piacere e il dolore inerente o connesso con le nostre azioni è, in fondo, il vero e unico motivo che le determina. Anche quella che si chiama ed è sentita come “obbligazione” morale non si concepisce né si spiega altrimenti che come necessità di porre o tralasciare un’azione perché ciò serve o è indispensabile al bene dell’individuo e della società. Essa trova parimenti la sua sanzione principale nelle dannose conseguenze che un’azione contraria all’utilità naturalmente comporta. Il principio utilitaristico diventa così insieme la base della morale e del diritto, e di conseguenza della legislazione, la quale dev’essere sottratta alle norme teoretiche del cosiddetto diritto naturale, e guidata unicamente dall’intento di realizzare ” la maggior felicità possibile per il più gran numero possibile di individui “. Tale la formula sintetica del principio e della norma etico-giuridica, enunciata già da Beccaria, cui Bentham si ispira. Identificato così il bene etico con l’utile e il male con tutto ciò che nuoce alla felicità, la morale viene concepita come un calcolo sapiente (che rievoca il “calcolo dei piaceri” di Epicuro) del più reale e fruttuoso interesse di tutti. Infatti l’interesse dei singoli, se bene inteso, si accorda in definitiva con l’interesse generale: e i limiti che questo impone all’egoismo del momento sono compensati dal risultato finale ch’è una somma maggiore di felicità. Bentham si addentra quindi in una sottile descrizione dei motivi delle azioni, di cui costruisce estesissime tavole, e in un’analisi minuziosa delle varie classi di piaceri, tentando di determinare il loro rispettivo apporto, immediato e mediato, alla somma finale della felicità. In generale il piacere va considerato: 1) da parte dell’oggetto, nella sua intensità, durata, certezza, accessibilità, fecondità, purezza da mescolanza di dolore, estensione a una maggiore o minore moltitudine di individui. 2) Riguardo al soggetto. Il piacere infatti è relativo, per cui, nel computo dei piaceri entrano come fattori di decisione e scelta tutte le varianti ambientali e individuali. 3) Nel suo aspetto sociale, poiché appunto l’interesse privato è intimamente connesso con quello generale. Un delitto, ad esempio, va visto non solo in quello che di bene o male reca a chi lo compie, ma in tutte le risonanze che determina nella società, di danno, incertezza, paura, ecc. In rapporto a questo calcolo del valore quantitativo dei piaceri, che, per la maggior parte delle azioni umane, è già stato fatto dall’esperienza dei secoli, Bentham, enuncia la norma concreta e universale dell’azione: se prevale la somma dell’utile, e soltanto allora, l’azione va compiuta. L’etica benthamiana, equivalente, come si vede, a una tecnica e a un’aritmetica del piacere e dell’utile, si discosta, per questo carattere, dall’edonismo cirenaico – vòlto unicamente al piacere attuale e presente – con cui pure sostanzialmente concorda nella riduzione della felicità a bene e godimento empirico. In ciò è anche il suo errore e la sua intrinseca insufficenza. Indubbiamente Bentham, valorizzando il principio dell’utilità, ch’è pure parte integrante in un sistema generale di etica, seppe portare un valido contributo al diritto e alla sua codificazione (la parola è di Bentham). In ciò va considerato il suo apporto positivo. Inoltre molte delle sue conclusioni stanno e si reggono indipendentemente dai princìpi dell’utilitarismo. Bentham (1748-1832) diede la formulazione più compiuta dell’utilitarismo. Nel suo “Frammento sul governo” pubblicato a soli ventotto anni, nel 1776, riprendendo l’idea illuministica che nell’attività politica bisogna promuovere “il massimo bene per il massimo numero di persone”, propone la dimostrazione che questo scopo è conseguibile solo con una riforma politica in senso democratico. La sua opera maggiore, tuttavia, è “Introduzione ai princìpi della morale e della legislazione” (1798), in cui egli si prefigge di dare alla moralità e alla politica il carattere di scienza rigorosa. Esse, a suo avviso, devono quindi esser fondate sull’analisi dei fatti. Tra questi, quello fondamentale è che ” la natura ha posto l’umanità sotto il governo di due sovrani, la pena e il piacere “. Dunque l’uomo agisce “naturalmente” in vista del piacere, e tende ad eliminare il dolore, a tutti i livelli del suo comportamento, sia a quello privato che a quello sociale, economico, politico. Pertanto egli fa coincidere la sua felicità col godimento del piacere. Bisogna fondare, allora, un sistema etico ed una dottrina politica che s’incentrino sul principio della “ricerca del piacere”, in modo che il comportamento etico dell’individuo e l’azione politica del legislatore abbiano un fondamento “naturale”, oggettivo. Ma perché morale e politica possano massimizzare il piacere, è necessario che esse abbiano un carattere scientifico, anzi, i caratteri della scienza matematica. Il che è possibile: si può infatti, induttivamente, ricavare una tavola in cui siano indicati i princìpi della misura dei piaceri e dei dolori, la loro classificazione per specie, e la catalogazione delle diverse sensibilità individuali rispetto ad essi. Relativamente alla misura, Bentham specifica che il valore di un piacere è in rapporto ai seguenti elementi: intensità, durata, certezza, prossimità, fecondità (capacità di produrre altri piaceri) e purezza (assenza di connessi dolori). Sulla base di questa tavola, è possibile procedere al calcolo aritmetico del rapporto piacere-dolore in relazione ad una determinata azione da compiere. Per quanto attiene all’aspetto etico di questo discorso, Bentham dà per equivalenti il bene e il piacere; la virtù, perciò, coincide con la naturale ricerca della felicità, ma in quanto guidata dal calcolo razionale con il quale l’uomo “regolarizza” l’egoismo ed orienta l’azione al conseguimento dei piaceri piú pieni; essa si risolve nella capacità di misurare e classificare piaceri e dolori in relazione alla sensibilità individuale e alle condizioni concrete in cui si agisce, e di scegliere in conseguenza. La moralità di un comportamento non è determinata o qualificata dalle intenzioni o dagli ideali, ma dalle sue conseguenze: cattiva è l’azione che inibisce o limita l’acquisizione di un massimo piacere; perciò non ha senso, per Bentham, parlare di “coscienza” o “senso morale”, né di “obbligo etico”: questi, per lui, non sono che “nomi vani”. Quanto poi all’attività del legislatore, essa sarà legittima se promuove la massima felicità per il maggior numero possibile di persone, sulla base della tavola sopra indicata. A questo scopo devono ispirarsi i suoi poteri di promozione o di limitazione dell’attività individuale, non a valori astratti. I “diritti naturali” affermati dalla Rivoluzione Francese, dice Bentham, sono concetti vuoti; che cos’è infatti lo stesso diritto alla libertà? Se fosse un diritto assoluto esso, a rigore, annullerebbe per sé il valore della norma di diritto, perché questa comporta sempre una limitazione della libertà stessa. Lo scopo dell azione politica, dunque, non è la libertà, ma l’utilità individuale e collettiva, che sola può costituire anche il criterio con cui il legislatore può armonizzare libertà e coercizione. L’attività di governo deve quindi favorire, anche sul piano economico, l’ egocentrismo , che non solo è naturale ed ineliminabile, ma anche razionale e desiderabile, perché la ricerca dell’utile individuale è la condizione primaria dell’utilità sociale, e quindi della felicità collettiva. A differenza di Malthus e di Ricardo, Bentham non è però favorevole al “laisser-faire” dei liberisti più sfrenati: il potere del governo, egli sostiene, deve intervenire con sanzioni legislative per regolamentare la libertà individuale in economia; esso, mirando a far coincidere l’interesse privato con quello pubblico, deve promuovere e compensare le iniziative economiche che producono il maggior beneficio per tutti, e limitare o penalizzare le attività che, nate o condotte in vista del puro egoismo, diminuiscono il benessere collettivo. Va però detto che la sistematica concezione di Bentham morale ristretta entro gli angusti limiti dell’empirismo, non è in grado di salvare la norma etica dal relativismo, e quindi, semplicemente, di conservarla in quanto tale. Identificando il bene morale con l’utile si cessa di riconoscere, accanto al puro interesse, egoistico o sociale che sia, un valore superiore universale di bene che valga per se stesso e si imponga all’uomo in quanto essere spirituale. La stessa incomprensione il Bentham dimostra nei confronti della religione cristiana e poi della religione in genere, discussa in base al principio utilitaristico e giudicata più dannosa che utile all’umanità. Le sue idee in proposito furono svolte principalmente nell’ “Analysis of Religion”, pubblicata da Grote con lo pseudonimo di Ph. Beauchamp, nel 1822. Di Bentham furono messe all’Indice: “Traités de Législation civile et pénale” (22 marzo 1819), “Traité des preuves judiciaires” (4 marzo 1828), “Deontology” (20 gennaio 1835). Manzoni scrisse in confutazione di Bentham l’operetta “Del sistema che fonda la morale sull’utilità” , pubblicata come appendice al capitolo III delle “Osservazioni sulla morale cattolica”.
LA FELICITA’ UMANA
Per Bentham la filosofia non era una questione di ragionamento astratto, e se egli è mai arrivato a formulare una complessa e rivoluzionaria dottrina filosofica, è stato anzitutto sotto lo stimolo di problemi extrafilosofici, pratici e concreti, quelli connessi alla riforma della legislazione in Inghilterra. Egli lo affermava esplicitamente, ad esempio quando, parlando della sua filosofia, diceva che le sue definizioni e distinzioni ” sono lungi dall’essere mera materia di speculazione “. Esse anzi “sono suscettibili dell’applicazione più estesa e costante sia al discorso morale che alla pratica legislativa”. Il problema che sopra a tutti egli cerca di risolvere appartiene più alla giurisprudenza che alla filosofia, ed è quello di adeguare il ferraginoso sistema di leggi dell’Inghilterra del suo tempo ai nuovi rapporti sociali che si stavano delineando in seguito alla rivoluzione industriale. Solo che il modo in cui risolse questo problema ha una grande rilevanza filosofica, e fa largo uso di una reinterpretazione della psicologia edonistica di derivazione empiristica (che traeva soprattutto da Locke e Hume), della nuova consapevolezza metodica delle scienze esatte del suo tempo, e dell’applicazione della matematica alla scienza sociale ed alla morale, in base all’idea della calcolabilità del bene, resa possibile appunto dalla sua identificazione con l’utile del maggior numero. L’etica di Bentham pone al suo centro il problema della felicità umana, nel solco di una tradizione che risale all’etica classica. L’etica è anzi da lui definita come ” l’arte di dirigere le azioni degli uomini verso la produzione della maggior quantità possibile di felicità per coloro il cui interesse ha di mira “. La felicità è identificata col piacere, senza differenze qualitative tra piaceri “nobili” e “bassi”: la differenza può essere solo quantitativa, tra piaceri più forti e duraturi ed altri precari e passeggeri (che sono i fugaci piaceri connessi ai comportamenti viziosi). Ognuno è libero di perseguire ciò che più gli dà piacere: l’etica lo orienta peraltro verso un piacere che possa essere puro (non mischiato a dolori) e duraturo. L’omogeneità qualitativa dei piaceri tra loro rende possibile indicare con scientifica precisione, attraverso il calcolo morale, i comportamenti che consentono di creare la maggior quantità totale di piacere, quel “maggior bene per il maggior numero” che era il criterio ultimo della morale di Bentham. Tutta questa produzione di piacere e felicità ha di mira anzitutto la propria felicità, in quanto nell’etica benthamiana ha un ruolo centrale la virtù della prudenza, che consiste nella capacità di fare il proprio dovere verso se stessi, in vista del proprio bene e del proprio interesse. Ora, per quanto secondo Bentham i propri interessi siano gli unici che un uomo ha adeguati motivi per seguire – in accordo alla psicologia edonistica, secondo la quale il piacere è appunto la guida dell’uomo in tutte le sue scelte consapevoli – la morale gli dice che egli è tenuto a tener conto anche di interessi diversi dai suoi, per moventi certo meno forti del proprio interesse immediato, come la naturale tendenza alla benevolenza, e il desiderio di ottenere amicizia e reputazione. Così universale è questo comandamento dell’etica, volto alla massimizzazione del piacere, da includere in esso anche gli animali.
SUSSURRI DELLA MORALITA’ E TUONI DELLA LEGGE
Naturalmente Bentham non si nasconde che il peso che gli interessi altrui hanno sulle decisioni umane è molto debole, se questi interessi confliggono con i propri. Ed ecco perché ” i sussurri della moralità ” vanno rinforzati con ” i tuoni della legge “, in modo da creare dei moventi dissuasivi precisi a qualunque azione che (avendo di mira il proprio interesse egoistico) diminuisca la quantità generale di felicità. Se questa regola sarà rispettata, non è neanche necessario che le pene siano particolarmente rilevanti (Bentham ad esempio è contrario alla pena di morte): l’importante è che siano certe, e proporzionate al reato. Si respira in queste pagine di Bentham una grande fiducia nei mezzi della ragione umana, se essa viene messa in grado di dare ordine alla vita degli uomini. Anche qui, come in Locke e Paley, ci si vale delle pene e delle punizioni, ma non si ricorre ad un essere sovrumano ed onnipotente per questo: visto che ciò che conta sono le azioni, e non le intenzioni, non è necessario uno ” scrutatore dei cuori “. Bentham si accontenta di un sistema razionale di leggi, e – certo – di un efficiente apparato di polizia, in grado di scovare i trasgressori, e di non far pesare la speranza dell’impunità nel calcolo razionale di chi è tentato – per i propri moventi egoistici – dal commettere un reato. Egli dunque oggi potrebbe essere annoverato, rispetto a questa parte della sua concezione, tra i sostenitori di quelle teorie morali che sono state definite recentemente ” utilitarismo delle regole “, teorie che si sono affermate soprattutto negli Stati Uniti, e che (tenendo conto della preferenza degli individui per il proprio interesse personale) rinforzano le motivazioni al comportamento etico con un sistema di “regole” (le leggi), connesso ad una serie di sanzioni per la sua violazione. A parte questo, per l’utilitarismo delle regole l’individuo è considerato libero di fare quello che vuole per massimizzare il suo interesse, senza che nessun suo comportamento, anche il più egoistico, sia nemmeno criticato dalla morale, fin quando non lo porta a violare la legge. Naturalmente c’è qui un problema, che viene dal fatto che ogni utilitarismo delle regole “puro”, che lasci l’individuo determinato in ultima analisi solo dal proprio interesse egoistico, si espone all’antica domanda che nella “Repubblica” platonica Glaucone poneva a Socrate: ‘se sono certo di non essere scoperto quando commetto un reato che massimizza il mio piacere individuale, a discapito di quello altrui o di quello della collettività, perché mai non dovrei commetterlo?’ La risposta che Bentham dava a questa domanda si discosta dall’utilitarismo puro delle regole, ed è basata su un postulato indimostrato: non devo commettere il reato perché in ultima analisi l’interesse del singolo, correttamente inteso, coincide con quello della società. Il paradosso storico sta qui nel fatto che se si legge la “Repubblica” platonica fino in fondo, col suo complesso repertorio lussurreggiante di miti poetici ed immagini fantasiose, refrattarie certo a qualunque moderno calcolo utilitarista, si ottiene la stessa risposta. Il risultato dell’antica tradizione filosofico-religiosa coincide dunque con quello della più scaltrita riflessione etica moderna, armata dei nuovi strumenti della psicologia, dell’economia politica e della matematica.
IL METODO CLASSIFICATORIO
Se dovessimo fermare qui la nostra analisi, è evidente che dovremmo concludere che tutta la decisiva “rivoluzione” di Bentham e dei “benthamiti” non è approdata a nessun risultato sostanzialmente nuovo per il pensiero etico. Ciò può sorprendere, ed indurre anche una certa perplessità, se si guarda alla solennità di alcuni proclami benthamiani, e al modo derisorio e caricaturale con cui parla di gran parte della tradizione precedente. Ma in verità la sua originalità filosofica sta, molto più che nei risultati, nel metodo con cui egli conduce la sua analisi, il cosiddetto ” metodo naturale “. La convinzione che Bentham ha nella giustezza del suo modo di procedere, e la radicalità con cui critica le posizioni tradizionali, deriva in effetti dall’idea che il calcolo razionale etico sia il modo di procedere cui naturalmente si ispirano tutte le creature viventi, nelle loro scelte individuali e nel giudizio su quelle altrui, come si vede dal brano riportato in esergo. La funzione della sua filosofia è dunque duplice: da un lato una funzione critica nei confronti delle altre dottrine, che confondono il retto e naturale giudizio degli uomini, dall’altra ha una funzione orientativa per la condotta individuale e per l’elaborazione delle regole che devono guidarla: egli vuole fornire gli strumenti adeguati, all’altezza delle scoperte scientifiche a lui contemporanee, per aiutare gli uomini a scegliere secondo la loro natura (che è ben altra cosa dallo scegliere in base all'”oscuro fantasma” della legge di natura). Per questo egli suddivide ed analizza l’agire umano, distinguendo puntigliosamente i vari tipi di piacere e dolore, le diverse circostanze che influenzano la sensibilità degli uomini, le intenzioni che li muovono, le categorie delle loro azioni, i gradi di consapevolezza che hanno quando agiscono, etc. Al di là di questo enorme apparato tecnico, ciò che conta è appunto il metodo con cui tutta questa attività classificatoria viene compiuta. Il grande modello è qui uno scienziato, Linneo, che nella sua “Philosophia botanica” (1751) aveva analizzato e suddiviso i campi rispettivi della botanica e della biologia in base ai principi della fruttificazione ed a quello generale della procreazione. Aveva cioè riportato la complessità del suo campo d’indagine ad un unico principio, scelto non arbitrariamente, ma in base alla natura dell’oggetto indagato. Ciò che è essenziale nell’attività classificatoria secondo Bentham, che segue appunto nel campo della morale l’esempio di Linneo, è la naturalità del principio ordinatore che viene scelto, che deve sempre essere quello che, in base alla natura dell’argomento, è il più adeguato per ordinare quella materia. E Bentham era certo di essere in possesso di un principio adeguato, in campo morale, a svolgere la stessa funzione unificante e razionalizzante che il principio trovato da Linneo aveva per la biologia: per l’appunto, il principio di utilità, in grado di discriminare tra azioni giuste e sbagliate, e tra i vari gradi quantitativi per i quali un’azione può essere giusta o sbagliata, ovvero utile o inutile o dannosa. Lo sforzo gigantesco di analizzare, ordinare e spiegare tutta la vita umana alla luce di questo unico principio costituisce per Bentham la scientificità della sua opera, e sarà per lui al tempo stesso un formidabile strumento critico ed un limite oggettivo, che porterà il suo autore a forzature ed inevitabili unilateralità nell’analisi dell’animo umano, come si sforzerà di mostrare il suo allievo più brillante, John Stuart Mill, nel suo impietoso saggio sul suo vecchio maestro.
FRANCIS HERBERT BRADLEY

Nella seconda metà dell’ottocento anche in Inghilterra si produsse una reazione idealistica al positivismo, in particolare al pensiero di Spencer e Stuart Mill. In questa rinascita di interesse per le posizioni idealistiche, sulla scia di quel platonismo inglese che già si era affacciato sulla scena in pieno ‘600 ( i platonici di Cambridge) , si delinea l’importante contributo di Francis Herbert Bradley , nato nel 1846 e vissuto ad Oxford anche se non insegnò nel College. L’opera principale di Bradley, “Appearence and Reality”, si svolse a partire dal vecchio, ma mai pienamente superato, tema platonico dell’esperienza individuale della realtà piena di contraddizioni e nella riaffermazione di una vera realtà costituita dalla coscienza assoluta, cioè unità di soggetto ed oggetto derivata da Hegel. Bradley nacque il 30 gennaio 1846 a Clapham nella contea del Surrey. Era il quarto figlio di Charles Bradley, predicatore Evangelico, e della sua seconda moglie Emma Linton. La sua famiglia, costituita da molti fratelli, dimostrò d’essere una straordinaria fucina di talenti intellettuali. George Granville Bradley, nato da un precedente matrimonio, fu successivamente Head Master al Marlborough College, Master of University College, Oxford, and Dean of Westminster Abbey; A.C. Bradley, il figlio più giovane del secondo matrimonio, studiò filosofia a Oxford fino al 1881, e, dopo una decisa virata verso studi di tipo letterario, insegnò a Liverpool e Glasgow, rifiutò una cattedra a Cambridge, e divenne il più importante critico di Shakespeare del suo tempo. Nel 1856 Bradley cominciò a frequentare il Cheltenham College; nel 1861 si trasferì al Marlborough College, che era diretto da suo fratello. Mentre era a Cheltenham aveva cominciato a studiare il tedesco. E riuscì a leggere molte parti della “Critica della Ragion Pura” di Kant, sebbene molti aspetti della lingua tedesca non gli fossero ancora del tutto chiari. Durante l’inverno del 1862-63 si ammalò gravemente e corse il rischio di morire. Nel 1865 entrò entrò all’University College di Oxford, come scolaro, ottenendo una buona votazione nel 1867, ma un inaspettato insuccesso in litterae humaniores nel 1869. Alfred Edward Taylor, assai noto per i suoi studi su Platone in un’opera che ebbe fortuna in Inghilterra (“Elementi di metafisica” del 1903) giustificò questo insuccesso di Bradley nella completa incapacità degli esaminatori di comprendere la profondità del nuovo approccio di Bradley agli studi filosofici in Gran Bretagna. Nel giugno del 1871 Bradley cominciò a soffrire una grave infiammazione renale. Ciò aggravò il suo già precario stato di salute e lo portò a condurre una vita ancora più isolata e riservata, tra ansietà e varie forme di esaurimento nervoso. Collingwood nella sua autobiografia descrive in parte la riservatezza di Bradley: ” Sebbene abbia vissuto a meno di cento yards da lui per ben sedici anni, mai riuscii a posare il mio sguardo su di lui “. Questa reclusione aggiunge un elemento di mistero alla sua reputazione filosofica, mistero incrementato dal fatto che alcuni suoi libri risultano dedicati ad una persona identificata solo dalle iniziali E.R. Sebbene Bradley fosse votato agli studi filosofici, la sua non fu solo un’esistenza trascorsa tra i libri. Per proteggere la sua salute dai tremendi inverni inglesi, egli trascorse diversi periodi al mare, sia nel sud dell’Inghilterra che sulle coste mediterranee. Molti dei suoi libri, specialmente il postumo “Aforismi”, non possono essere solo l’opera di un uomo confinato nei suoi studi. Politicamente fu un conservatore, ma non di tipo dottrinario. Sebbene i suoi scritti rivelino un temperamento religioso, egli confessò in una lettera del 1922, di aver trovato la religiosità evangelica di suo padre esageratamente oppressiva. Ottenne in vita diversi riconoscimenti ufficiali e nel 1924 re Giorgio V lo insignì dell’ Order of Merit: così Bradley fu il primo filosofo ad essere scelto per questo rara ed ambita onorificenza. Tre mesi più tardi, dopo, pochi giorni di malattia, morì il 18 settembre del 1924 e fu sepolto all’Holywell Cemetery di Oxford. Il primo sostanziale contributo di Bradley alla filosofia fu la pubblicazione del suo pamphlet “The Presuppositions of Critical History”, esprimente un sostanziale scetticismo intorno all’interpretazione dei fatti storici. Ispirato dalla lettura di certa critica biblica tedesca – critica ai miracoli che violano la legge di natura -Bradley tenta di estendere questa riluttanza alla storia in generale senza tuttavia riuscire ad essere molto convincente. Il lavoro non fu mai letto e valutato per il suo significato storico, ma come una introduzione al pensiero filosofico di Bradley. Alcun temi caratteristici delle opere successive compaiono già qui, come quello della fallibilità dei giudizi individuali di persone che non hanno una coscienza sufficientemente ampia e che dunque confondono l’apparenza con la realtà. Nei “Principi di logica” del 1893, lo stesso anno della pubblicazione di “Apparenza e realtà”, Bradley cercò di dimostrare che anche il mondo della logica pura, se astratto dalla coscienza assoluta, è solo l’espressione di una coscienza finita e limitata, pertanto contiene le stesse contraddizioni e le stesse limitazioni del finito e dell’apparenza. Per Bradley il senso della logica sta nel giudizio, il quale va inteso come “qualificazione” della realtà stessa. In altre parole ogni idea contenente un giudizio, per Bradley non è solo un’idea, ma una qualità del reale. Posto dunque che qualsiasi qualificazione non sia davvero transitoria e accidentale, per cui ad esempio sono stanco adesso, ma ieri sera ero in forma, per Bradley appare evidente che l’essere stanco in generale definisce, per esempio, una persona “stanca” di natura sotto un profilo, ma attiva e dinamica sotto un altro, e ciò implica contraddizione. Tutto il reale qualificato, pertanto risulta contraddittorio, illusorio e la logica stessa vacilla nell’impossibile impresa di qualificare in modo stabile e determinato la realtà. Pertanto la molteplicità dei giudizi, pur considerando che essi vengono espressi sotto determinate condizioni e circostanze limitate, porta comunque a contrapposizioni inconciliabili. Di notevole interesse, a questo proposito, è la seguente riflessione: anche le condizioni e le limitazioni qualificano la realtà a loro volta. Pertanto la contraddizione non è superata, diciamo, dall’ambientazione, ma semplicemente moltiplicata. Tale impostazione potrebbe essere facilmente contestabile dalla semplice introduzione del concetto di “funzione”, per cui, per esempio, un uomo è un “padre”, un “marito”, un “cittadino” del Regno Unito e un “professore di filosofia” ed ogni giudizio logico deriva la sua stessa fondazione certa, muovendo dal “fatto” della funzione e da quale sia l’aspettativa legata a questo fatto, ovvero cosa ci aspetta da un “padre”, da un “marito” e così via. Ma in realtà, posto che in partenza vi sia una generale intuizione idealistica che trova comunque contraddittorie due affermazioni diverse sullo stesso argomento, emesse, per così dire, prima in veste di “professore” che, seguendo l’etica di Russell, è contrario al matrimonio, e poi in veste di “marito” che , essendosi sposato, è favorevole (ma non troppo) al matrimonio, o di “padre” che spinge sua figlia a cercarsi un fidanzato di qualità, affidabile, e non il primo bellimbusto che le capita a tiro, è inevitabile che Bradley finisca con l’avere ragione. Ovvero il mondo dell’esperienza individuale è contraddittorio e Guglielmo di Ockham ebbe torto a scrivere che ” l’obbedienza non implica peccato “. Ovvero, svolgendo una funzione, si deve, a volte commettere “peccato” obbedendo alla logica della funzione perché non si può fare altrimenti. Ad esempio “correggere” un figlio che non apprezza in modo particolare né la matematica né le brave persone. Oppure rifilare un brutto voto allo studente che non sa dir nulla nemmeno sulla concezione del tempo in Agostino. Questo rigetto radicale del fantastico mondo della vita e della contraddizione tra funzioni porta Bradley comunque alla definizione di un criterio assoluto di verità, cioè, al riconoscimento che vi è una realtà assolutamente priva di contraddizioni, quindi realmente consistente. Per Bradley questa realtà non può essere altro che “coscienza” assoluta, perfettamente coerente, e non determinabile da nessuna delle tante facce della coscienza contraddittoria e finita, quindi nemmeno dal pensiero, dalla sensazione, dalla volontà, proprio perché anche tali qualità, o facoltà, sono in sè contraddittori. Vi possono essere, per esempio, volontà contrastanti in una stessa persona, e possono darsi sia pensieri contrastanti, che sensazioni contrastanti, come vedere la bellezza di una donna brutta o viceversa l’odio che si annida latente in ogni amore fatale e possessivo respinto o tradito. Neppure la moralità, scrive ancora Bradley, può essere attribuita all’assoluto. Per Bradley in generale le relazioni sono inconcepibili e questo mette in crisi il modo realistico di concepire il mondo come una rete di relazioni tra cose e tra le cose e le proprie qualificazioni. Esamina ad esempio il rapporto tra qualità primarie e secondarie introdotto da Locke e vi scorge diverse contraddizioni, tutte in qualche modo da riportare alla difficoltà fondamentale della ricerca filosofica sulla relazione, ovvero l’identificazione di ciò che è diverso. Non c’è identificazione che non sia poi contraddittoria, anche perchè ogni relazione comporta una modificazione dei suoi termini relativi, esattamente come un uomo ed una donna sposati non sono più come erano prima di sposarsi. Ma data questa modificazione – osserva acutamente Bradley – ” ogni termine della relazione si scinde ” in due parti, rimanendo quello che era e insieme diventando il nuovo. Queste due parti divise, non possono riunirsi che attraverso una nuova relazione, la quale darà vita ad una nuova scissione, e dunque ad una nuova relazione unificante, e ciò all’infinito. Perciò la relazione è intrinsecamente contraddittoria e lo stesso “io” non può sfuggire a questa logica inesorabile della scissione, pur essendo al di là di ogni dubbio che esso esista nel mondo quotidiano delle apparenze. La riflessione razionale infatti lo scalza e lo rende persino inconcepibile di fronte alla contraddizione del chi e del cosa “sono io” realmente. Direi che in questo aspetto viene ad essere ingigantito più il problema della qualificazione che quello della vera e propria identità dell’io. Ma forse in Bradley, questa distinzione che pure è posta, non sempre viene mantenuta lucidamente. In altre parole se l’identità pura necessita di una qualificazione per ritrovarsi sicura della propria identità, è evidente che la serie di relazioni necessarie alla ricostruzione porta a contraddizioni insanabili. E questo anche tornando al concetto di contraddizione che aveva Aristotele perchè io, posto un concetto di tempo superiore all’attimo, anche se inferiore al quarto d’ora, posso essere sia impegnato a scrivere questo articolo che a pensarne un altro, sia qui a digitare che con la mente a pescare sulle ridenti rive di un ruscello. Ciò per il semplice fatto che l’individuo non è solo determinato dalla sue relazioni, e anche perchè le sue relazioni con le proprie qualità sono di natura diversa dalle relazioni con gli altri esseri umani, ma perchè un individuo è soprattutto quello che fa e non credo si possa dire che il rapporto tra io e la mia attività sia catalogabile solo come “relazione”. Inoltre il fatto di appartenere ad un sindacato non cambia in modo determinante tutte le altre attività del mio io, e non pone di fatto alcun dubbio sulla mia identità e sulla relazione con altre mie qualificazioni, intelligenza, carattere espansivo e comunicativo, apertura mentale, un fisico da Maciste e così via. In sostanza Bradley esagera i problemi e finisce con l’occultare questioni ovvie e risolte, tuttavia non si può liquidare con poche battute perchè sotto un profilo veramente razionale il problema della “relazione logica” esiste ed in quanto tale è stato evidenziato da Bertrand Russell.
THOMAS HILL GREEN

Allievo di Coleridge, Thomas Hill Green (1836-1882) è una delle massime espressioni dell’idealismo inglese. Se in Francia la reazione al dilagante positivismo si attua con lo spiritualismo, in Inghilterra (dove la corrente dominante era da sempre l’empirismo stesso, stante alla base tanto dell’Illuminismo quanto del positivismo) la reazione si compie volgendo lo sguardo alla Germania. Come Coleridge e Carlyle avevano reagito all’Illuminismo e all’utilitarismo guardando al Romanticismo tedesco, così ora la cultura inglese si oppone al positivismo recuperando l’idealismo di Hegel, in particolare restaurando quei valori dello spirito azzerati dalla cultura positivistica. In particolare, questo «ritorno a Hegel» si configura come un ritorno allo spiritualismo e alla dialettica hegeliani. In questa prospettiva si muove Green. Attento studioso di David Hume, Green fu – insieme a Thomas Grose – il curatore dell’edizione delle opere del filosofo scozzese (oltreché autore delle Introduzioni alle due sezioni dello humeano Trattato della natura umana). Ciò non di meno, egli riscontra un’irrisolvibile contraddizione nella teoria empiristica della conoscenza. Tale teoria, infatti, risolve la coscienza nella molteplicità delle impressioni che via via si susseguono, le quali sono considerate come atti percettivi isolati e intrinsecamente privi di connessione (l’io humeanamente inteso come fascio di percezioni). Ma la stessa specificità di ciascuna impressione non sarebbe possibile – rileva Green – se non esistesse una coscienza indipendente dalla percezione stessa e, per ciò stesso, in grado di distinguerla da tutte le altre. Tanto più necessario appare il riferimento alla coscienza quando si voglia spiegare – cosa che nell’empirismo risulta assai ardua – la connessione tra una percezione (o un’idea) e l’altra: quest’operazione appare possibile solo quando, ancora una volta, esiste una coscienza che, essendo indipendente dalle percezioni stesse, può operare dall’esterno la loro unificazione. Di coscienza esistono però due diversi livelli, nota Green: al grado più basso, v’è la coscienza individuale, la quale apprende i propri contenuti in maniera progressiva, giacché è condizionata dai processi biologici che scandiscono la conoscenza dell’organismo animale. Al grado più alto sta invece una coscienza assoluta e infinita, la quale già contine in se stessa il sapere come una totalità perfetta e immota, ancorché concettualmente articolata al suo interno. Al di là della sua base naturale, la quale è stata descritta dalla filosofia empiristica e positivistica, la conoscenza appare dunque come un processo di graduale partecipazione della coscienza individuale a quella assoluta. L’Assoluto, del resto, non soltanto una determinazione gnoseologica, ma anche assiologia e morale: esso non è soltanto laVerità, ma anche il Bene. La progressiva partecipazione della coscienza assoluta si configura pertanto come un progressivo innalzamento morale del soggetto: ciò implica un riflesso politico nella creazione di una società nella quale tutti gli individui collaborano spontaneamente e armonicamente. L’idealismo gnoseologico funge così da base per la difesa di una concezione organicistica e spiritualistica della morale e della politica: ciò spiega la ragione per la quale l’analisi di Green sulla percezione e sulla coscienza siano illustrate in un’opera il cui titolo recita significativamente Prolegomeni all’etica (1883). Nella prospettiva di Green, è erronea la totale riduzione humiana della coscienza ai suoi fenomeni; questa è «fuori» sia dalle idee sia da ogni successione, proprio per poter cogliere idee e successioni. E contro ogni interpretazione naturalistica della coscienza egli afferma che il mondo è una serie di fatti; un fatto non ha capacità di comprendere né se stesso né gli altri fatti né il loro mutamento; pertanto la coscienza non è un fatto naturale; essa sta oltre i fatti. Di qui Green ricava che l’individuo è espressione di un Soggetto unico, eterno, assoluto, universale, infinito, estraneo al tempo e alla materia. Soggetto che però è il fondamento di tutte le relazioni tra i fatti. Tale Soggetto, o Coscienza assoluta, attraverso gli individui assume dimensione temporale e storica; esso «diventa» coscienza umana sul piano mondano quando l’organismo animale diventa «veicolo» della sua manifestazione. Sicché la coscienza umana, in quanto funzione dell’organismo animale che veicola la coscienza eterna, cambia, è successione di fatti interni dipendente dalla successione dei fatti esterni ad essa; ma in quanto coscienza assoluta che si veicola nell’organismo, essa è indipendente dal tempo e dalle mutazioni dei fatti, è atemporale ed eterna. Perciò della coscienza umana si può dire ugualmente che è divina, in relazione al secondo senso, e che è naturale, cioè dipendente dalle funzioni vitali dell’organismo, secondo il primo senso. Proprio perché la coscienza umana è l’una e l’altra cosa, l’uomo ha il «compito» etico di realizzare in sé, compiutamente, la Coscienza assoluta. Questa, che altro non è che Dio, «è» infatti tutto ciò che l’uomo «può» diventare. Certo, Dio è l’Essere che ci ha originati, ma è anche l’Essere «in cui» noi esistiamo Però il nostro essere in Lui non significa che noi abbiamo «attualmente» le sue proprietà. Ecco perché all’uomo si pone come compito morale quello di diventare «identico» a Lui, perfezionando la propria condizione mondana. Tale perfezionamento non è da concepirsi però come un impresa che riguardi solo l’individuo singolo. Poiché Infatti nella Coscienza assoluta sono installati allo stesso titolo tutti gli uomini, bisogna concepire questo perfezionamento in senso anche sociale: il bene, insomma, consiste in una vita sociale in cui tutti gli individui cooperino armonizzando le loro volontà libere.
PIERRE DUHEM

La Vita
Pierre Maurice Marie Duhem nasce a Parigi il 9 giugno 1861, primo di quattro figli, da Joseph, commerciante originario delle Fiandre, e da Marie Alexandrine. L’ambiente domestico trasmette al giovane Pierre una precisa impronta cristiana e un profondo senso del dovere, che ne segneranno radicalmente sia la vita privata sia quella professionale. Ancora fanciullo, è testimone della “Comune di Parigi” (1871), che lo impressionerà indelebilmente – più che per i suoi tentativi di stabilire un ordine più umano rispetto a quello reale – soprattutto per la violenza che da essa derivò. Nei primi anni 1870, s’iscrive al “Collegio Stanislas”, prestigioso istituto cattolico parigino che prepara all’ingresso nelle grandi “École”. Qui Duhem matura la sua vocazione per la fisica teorica. Nel 1882 – primo della sua classe – è ammesso all’École Normale Supérieure di Parigi, dove avrà come compagno il futuro matematico Jacques Hadamard (1865-1963). Ben presto la sua attenzione si rivolge alla termodinamica e alle sue applicazioni, un settore al quale rimarrà sempre legato. Nel 1887, quando diviene lettore alla facoltà di Scienze dell’università di Lille, dove insegnerà per alcuni anni idrodinamica, elasticità e acustica, Duhem è già noto nei circoli scientifici per le sue originali ricerche sul potenziale termodinamico. Nel 1890 sposa Marie-Adèle Chayet, che perderà nel 1892, dopo la nascita della figlia Hélène, con la quale passerà il resto della sua vita. A trentadue anni è nominato professore nella facoltà di Scienze dell’università di Bordeaux, in attesa di una cattedra in un grande istituto superiore a Parigi, naturale esito della sua brillante carriera scientifica, che però non gli verrà mai concessa; anche se sarà lui stesso a rifiutare la nomina a insegnante di storia della Scienza al Collège de France, dichiarando di sentirsi un fisico e non uno storico. Tre anni prima della morte, avvenuta a Cabrespine, nel dipartimento dell’Aude, il 14 settembre 1916, sarà chiamato come membro non residente all’Accademia delle Scienze di Parigi. “Mente essenzialmente sistematica — ha detto di lui il premio Nobel per la fisica Louis de Broglie (1892-1987) —, era attratto dai metodi dell’assiomatica che formulano postulati con l’obiettivo di derivare mediante ragionamenti rigorosi conclusioni inattaccabili”. Per questa sua propensione all’astrazione, Duhem respinge ogni tentativo di “visualizzazione” dei concetti della fisica, proposta dalla nascente teoria atomica. E tuttavia è attento ai problemi applicativi, in particolare nel campo della chimica fisica, dov’è fra i primi, in Francia, a esaminare e a presentare in dettaglio le idee di Willard Gibbs (1839-1903) sulla regola delle fasi. Autore prolifico, lascia qualche centinaio di lavori, fra i quali spicca il Traité d’ènergétique générale, del 1911, compendio dei suoi studi.
L’epoca del positivismo
La figura di Duhem non è rilevante solo dal punto di vista strettamente scientifico. La vasta erudizione, ma soprattutto la preoccupazione di chiarire e di rendere sempre più coerente il quadro concettuale nel quale si svolge il lavoro del ricercatore, lo portano a occuparsi anche del significato dell’impresa scientifica, a riflettere sul valore e sui limiti delle teorie fisiche e a cercare nella storia le origini e, se possibile, il percorso di quell’avventura intellettuale che è, appunto, l’impresa scientifica. Benché si sia sempre professato “fisico teorico”, Duhem ha svolto, parallelamente all’attività accademica, una poderosa indagine epistemologica e storica. L’opera nella quale ha esposto la sua idea di scienza è certamente La teoria fisica: il suo oggetto e la sua struttura, del 1906, ma preparata con una lunga serie di articoli fin dal tempo dell’insegnamento a Lille, fra il 1887 e il 1893. Alla seconda edizione, del 1914, aggiunge in appendice La fisica del credente, lunga e articolata risposta alle critiche mosse alla sua “filosofia scientifica”, giudicata appunto espressione della “fisica di un credente”. Gli attacchi allo “spiritualismo” e al “dogma”, che caratterizzano il dibattito epistemologico negli anni in cui Duhem è attivo sulla scena accademica, sono il frutto di quella “filosofia positiva” elaborata proprio in Francia, intorno alla metà del secolo XIX, da Auguste Comte (1798-1857) e presto accolta nel resto dell’Europa con il nome di positivismo, in cui l’esaltazione del “fatto empirico” s’accompagna a un forte risentimento anti-metafisico, un vigoroso ripudio del “chimerico” in favore del reale (e dell’utile). A fare del positivismo anche una mentalità, verso la fine del secolo XIX, concorrono le suggestioni del metodo scientifico e le strabilianti applicazioni nel campo della tecnica: è il tempo della teoria evolutiva di Charles Darwin (1809-1882), del canale di Suez, nel 1869, e della torre Eiffel, nel 1889. E il clima di generale entusiasmo intorno alla scienza, talora “ingenuo”, anticipa e prefigura un’era in cui “la scienza organizzerà Dio stesso”, secondo il celebre motto del positivista Ernest Renan (1823-1892).
Il filosofo della scienza e la Teoria fisica
A questa tendenza, che prepara lo scientismo contemporaneo, Duhem oppone una concezione della teoria fisica nella quale sono precisati i limiti del metodo scientifico e ne sono messi in evidenza i profondi legami storici e concettuali con il pensiero realista. Come i positivisti, egli condivide l’attenzione per il “fatto” e per la legge, o “teoria fisica”, che lo descrive in un dato contesto, precisando però che “la teoria fisica non è né una spiegazione metafisica, né un insieme di leggi generali di cui esperienza e induzione hanno stabilito la verità. Si tratta di una costruzione artificiale costruita con grandezze matematiche; la relazione delle grandezze con le nozioni astratte scaturite dall’esperienza è soltanto quella che hanno i segni con i significanti”. Per questa visione “utilitaristica” della relazione fra il fenomeno e la sua descrizione Duhem, insieme al matematico Henri Poincaré (1854-1912), viene considerato il fondatore del convenzionalismo e, in qualche modo, avvicinato all’empirismo critico di Ernst Mach (1838-1916). Ma, mentre l’empirismo critico evolve secondo un ambizioso — e mai concluso — programma di ricostruzione del discorso scientifico in termini esclusivamente logici, in modo da evitare ambiguità e problemi di tipo metafisico, per Duhem (che in ciò rivela la sua matrice cattolica) la distinzione fra fenomeno e teoria fisica non costituisce né una contraddizione né un’imbarazzante scelta di campo: essa è semplicemente l’espressione di due diversi livelli di realtà, entrambi veri nel loro ordine. Anzi, il formalismo matematico, se pure non coincide – kantianamente – con la realtà in sé, ne rispecchia comunque le relazioni fondamentali. Certo, una grandezza fisica e la realtà che rappresenta non sono la stessa cosa, e su questa distinzione si fonda l’osservazione che “in sé e per essenza ogni principio di fisica teorica è inutilizzabile nelle discussioni metafisiche o teologiche”. Dunque, domande come “il principio di conservazione dell’energia è compatibile con il libero arbitrio?” sono prive di senso perché quel principio “non è in alcun modo un’affermazione certa e generale relativa agli oggetti concreti”. Ma l’ordine ontologico soggiacente ai fenomeni, che per il metafisico è oggetto di ricerca e punto di partenza, per il fisico deve costituire il criterio d’orientamento e il punto d’arrivo. Il fisico, infatti, è come portato naturalmente ad affermare “che sotto i dati sensibili, i soli accessibili ai suoi procedimenti di studio, si nascondono realtà la cui essenza è inafferrabile da questi stessi procedimenti, che le realtà si dispongono secondo un certo ordine di cui la scienza fisica non potrebbe avere una osservazione diretta. Egli afferma che la teoria fisica, attraverso i suoi successivi perfezionamenti, tende tuttavia a disporre le leggi sperimentali secondo un ordine sempre più simile a quello trascendente, con il quale si classificano le realtà, che con ciò la teoria fisica si incammina gradualmente verso la sua forma limite che è quella di una classificazione naturale”. Lontano dagli esiti difformi del positivismo, dai circoli viziosi indotti dalla ricerca di un’improbabile ed ardita autofondazione, Duhem giunge al nucleo profondo della sua epistemologia: se “nessun metodo scientifico porta in sé la piena e completa giustificazione, né potrebbe, con i suoi soli princìpi, rendere conto di tutti questi principi”, se “la fisica teorica si fonda su postulati che non si possono autorizzare se non con ragioni estranee alla fisica”, il fisico deve rivolgersi altrove per trovare quella certezza della conoscenza senza cui tutto il suo discorso logico sarebbe privato della capacità di trasmettere anche solo un barlume di verità. Il presupposto indimostrabile, immediato ed evidente su cui si fonda il potere logico della ragione e che garantisce ogni riflessione razionale è, per Duhem, il senso comune. Interrogandosi se questa nozione non sia “equivalente a qualche credenza filosofica o religiosa”, egli risponde chiaramente che “la stessa cosa si potrebbe dire circa le scienze, incluse quelle che sono considerate fra le più rigorose […]. Questi concetti, questi princìpi, sono formati dal senso comune. Senza questa base formata dal senso comune, una base niente affatto scientifica, nessuna scienza può giustificare sé stessa; tutto della sua solidità proviene di là”.
Lo storico della scienza e il Système du monde
Duhem ritiene di riconoscere quella faticosa ricerca d’ordine e d’unità, che caratterizza, quasi come “un desiderio irresistibile”, il lavoro scientifico, nella storia delle dottrine fisiche. Animato dalla sola intenzione di svolgere un’indagine storica, senza finalità direttamente apologetiche, egli intraprende, agli inizi del secolo XX, una ricerca archivistica di proporzioni che, ancor oggi, lasciano esterrefatti. Senza assistenti, senza nessuno degli odierni ausili della ricerca, afflitto da un tremore progressivo alla mano destra, compila in breve tempo centoventi quaderni di duecento pagine ciascuno, con brani estratti da un centinaio di manoscritti medievali, rintracciati nelle più svariate biblioteche e librerie francesi, specialmente parigine, individuate con estrema difficoltà per l’assenza di cataloghi e di repertori generali. Da questo materiale vedrà la luce il monumentale Le Système du monde. Histoire des doctrines cosmologiques de Platon à Copernic, pensato in dieci volumi, lasciato incompiuto all’ottavo per la morte dell’autore, pubblicato dal 1913 al 1954 con lunghi intervalli. La documentazione storica duhemiana veniva a smentire uno dei cliché più consolidati della storiografia progressista, quello secondo cui il cristiano “distacco dal mondo” avrebbe congelato l’interesse per l’indagine naturale che fu proprio del mondo greco. Duhem avverte, invece, che la scienza greca aveva già perduto molto della sua vivacità al tempo in cui il cristianesimo era diventato un fattore socio-culturale importante e che, in genere, il mancato sviluppo della scienza presso tutte le culture antiche, quella greca inclusa, doveva avere una causa estranea al cristianesimo. E il tratto comune a quelle civiltà era la concezione circolare del tempo, che rinchiudeva il cosmo e l’esistenza umana in un perpetuo ciclo di nascita-morte-rinascita, senza inizio né fine e sostanzialmente privo di senso, ovvero l’esatto opposto di quanto può suscitare curiosità scientifica: “per condannarlo e gettarlo a mare come una mostruosa superstizione, doveva venire il cristianesimo”, scrive Duhem. Ne segue, dunque, che il cristianesimo non ha inibito la ricerca scientifica, ma anzi – paradossalmente – l’ha animata, conferendole una vivacità che col tempo era andata perduta. Nel 1913, quando pubblica il terzo volume degli Études sur Léonard de Vinci, ceux qu’il a lus et ceux qui l’ont lu, è ormai consapevole che la sua indagine storica gli ha fornito la prova documentale delle radici medievali della scienza di Isaac Newton (1642-1727), radici ritrovate nella dottrina non aristotelica dell’impetus professata alla Sorbona dai doctores parisienses e riportata dal più eminente fra loro, Giovanni Buridano (1300 ca.-1358 ca.), nei commentari al De Caelo e alla Fisica di Aristotele (384-322 a. C.). In essa Duhem riconosce chiaramente un’anticipazione della prima legge di Newton, o legge del moto inerziale, e nella meccanica parigina del secolo XIV il segno della fecondità del tradizionale atteggiamento cristiano verso il cosmo, che, dall’Antico Testamento fino ai Padri e alla Scolastica, ha posto le condizioni del sapere scientifico dei secoli successivi: “come potrebbe un cristiano non essere grato a Dio per tutto questo?”, egli si interroga stupito. Il cristianesimo – e, nella fattispecie, il ricorso a Dio – serve a Duhem per trovare una risposta che, da sola, la scienza non è in grado di fornire all’uomo, a dispetto di quel che invece riteneva Comte e, sulla sua scia, il nutrito stuolo dei positivisti che, in nome del progresso e del dato di fatto, avevano bandito ogni realtà metafisica (Dio compreso). Metafisica e scienza sono invece da Duhem tenute separate, in modo che non si inquinino a vicenda: solo così ciascuna di esse può saldamente rimanere valida, cosa che, evidentemente, non può avvenire se le si mischiano indebitamente o se si proclama dogmaticamente la superiorità della scienza sulla metafisica (come fanno i positivisti).
JAMES MILL

Discepolo di Jeremy Bentham, James Mill (1773-1836) – che fu padre del celebre John Stuart Mill – rimase saldamente fedele al maestro sia per quel che concerne le tesi politiche sia per quel che riguarda l’utilitarismo. Nella voce “Governo”, redatta nel 1820 per l’Enciclopedia Britannica, teorizzò la necessità e l’opportunità del «governo rappresentativo» espressione della volontà popolare. Nell’opera maggiore, Analisi dei fenomeni dello spirito umano (1829), riprese i temi dell’empirismo humiano, dando però al suo discorso un metodo positivistico; soprattutto da Hume riprese il principio dell’associazione con il quale spiegò, oltre che il procedimento logico del pensiero, anche la stessa vita morale. Il fatto fondamentale su cui si articola tutta la vita dello spirito è la sensazione; da essa derivano tutti i contenuti del pensiero; pertanto le idee non sono altro che copie delle sensazioni. E poiché le sensazioni vengono connesse secondo la legge dell’associazione, questa è anche la legge del pensiero razionale, cioè della connessione delle idee. Sicché come le sensazioni sono connesse per contiguità, cioè secondo lo spazio, e per continuità, cioè secondo la loro successione nel tempo, cosí, sul piano razionale, noi associamo le idee o per contemporaneità, in quanto le pensiamo legate insieme in uno stesso contenuto mentale, o per successione temporale, come nel caso di idee connesse nel rapporto causa-effetto. Come sul piano delle sensazioni, cosí anche su quello delle idee quando una determinata associazione si ripete con regolarità essa si stabilizza, al punto che, per abitudine, pensando la prima vi pensiamo collegata anche la seconda. Tuttavia per James Mill l’associazione tra le idee è pur sempre un fatto assolutamente mentale, che non implica di necessità la sua corrispondenza ad un’associazione reale tra le cose o tra le proprietà delle cose, cosicchè l’intera vita mentale dell’uomo è data dall’associazione delle idee, le quali altro non sono se non immagini delle sensazioni, secondo la legge della continuità nel tempo e della contiguità nello spazio. In questo senso, l’associazionismo – avviato da Hume e radicalizzato da David Hartley – giunge con Mill all’apice. Sul principio dell’associazione è fondata anche la vita morale. Il desiderio di un piacere non è altro che l’idea di un determinato piacere; questa idea si accompagna a quella dell’azione adatta a procurarlo, secondo un’associazione che si è venuta stabilizzando sulla base dell’esperienza; sicché l’azione concreta non è che la traduzione sul piano del comportamento di questa seconda idea. Pertanto, dice Mill, non esiste il libero volere; ogni azione ha il suo movente necessario nell’idea del piacere ch’essa può procurare. Ciò, tuttavia, non significa che l’uomo si muove esclusivamente nella dimensione dell’egoismo. Infatti anche l’altruismo ha una sua spiegazione sulla base del principio d’associazione. Certo esso nasce pur sempre dall’egoismo; ma spesso constatiamo che il nostro piacere individuale è vincolato a quello di altre persone, e quindi che la ricerca del primo implica di fatto la ricerca del secondo; l’associazione costante tra i due piaceri a può indurre a ricercare quello degli altri come se fosse il nostro: ecco allora il comportamento altruista. E quando poi il nostro piacere perde valore in relazione a quello di altri, cioè quando si verifica l’assoluta prevalenza del fine secondario (piacere altrui) rispetto a quello primario e originario (piacere proprio), allora si è giunti al sacrificio. Gli esiti morali a cui perviene Mill sono affini a quelli cui era pervenuto Bentham: se correttamente intesa, la soddisfazione di impulsi egoistici si traduce in un’azione a carattere altruistico. In questo senso, ben si capisce come Mill potesse affermare che l’azione educatrice dell’uomo consista nel promuovere quelle associazioni di idee che mettano capo a un’azione utile e, viceversa, reprimere quelle determinanti azioni dannose. In quest’accezione, l’utilitarismo di Bentham e l’associazionismo di Mill vanno a nozze: occorre soprattutto diffondere l’associazione che spontaneamente s’instaura nella mente umana tra il piacere proprio e quello degli altri (in primis quello delle persone a noi più care).
DAVID RICARDO

Introduzione
Celeberrimo economista inglese (Londra 1772 – Gatcomb Park, Gloucestershire, 1823), David Ricardo è – con Adam Smith – il massimo esponente della scuola classica dell’economia. Figlio di un banchiere ebreo, accumulò una considerevole fortuna prima come agente di cambio, poi come banchiere e, nel 1819, venne eletto alla camera dei comuni. Dopo alcuni saggi di teoria monetaria, nel 1817 pubblicò la sua opera fondamentale, Princìpi dell’economia politica e dell’imposta, nella cui prefazione affermava che il problema principale dell’economia politica era determinare le leggi che regolano la distribuzione del prodotto nazionale tra proprietari terrieri, capitalisti e lavoratori. Rifacendosi alla teoria smithiana del valore, Ricardo pose a fondamento del valore di scambio di un bene la quantità di lavoro necessaria per ottenerlo e, in opposizione a Smith, sostenne che tale principio era valido non solo per le società precapitalistiche ma anche per quelle capitalistiche. Inoltre nel lavoro necessario alla produzione di un bene considerò incluso anche il lavoro impiegato per la fabbricazione degli utensili, macchine ed edifici utilizzati nella produzione stessa. Nella teoria della distribuzione dei redditi Ricardo ricercò le leggi che regolano la rendita, il salario e il profitto. Considerò la rendita come determinata dalla differenza fra costi di produzione su terre a fertilità diversa, il salario naturale (distinto da quello corrente determinato dalla domanda e dall’offerta, ma che forze insite nel sistema riconducono a quello naturale) come determinato da quanto è necessario al mantenimento e alla riproduzione del complesso della manodopera esistente senza aumenti e diminuzioni (livello minimo di sussistenza fisiologico, ma legato alle abitudini e ai costumi di ogni popolo) e infine il profitto come determinato da ciò che rimane ai capitalisti una volta pagati i salari e le rendite. L’analisi della distribuzione dei redditi servì a Ricardo per formulare una teoria “pessimistica” dello sviluppo economico capitalistico. Posta come condizione allo sviluppo stesso l’esistenza di un saggio di profitto sufficientemente elevato da permettere un’adeguata accumulazione di capitale e quindi un aumento della produzione, l’economista inglese rilevò che la tendenza del saggio di profitto a diminuire (in quanto la necessità di coltivare terre sempre meno fertili in seguito allo sviluppo demografico avrebbe determinato da una parte un aumento della rendita e dall’altra un aumento del prezzo delle derrate alimentari e quindi dei salari correnti) avrebbe frenato lo sviluppo economico. Di notevole importanza sono anche i contributi di Ricardo alla teoria del commercio internazionale (alla cui base egli pose il principio dei costi comparati) e alla teoria monetaria (a lui si deve una delle prime formulazioni della teoria quantitativa della moneta). In sostanza, Ricardo, pur condividendo i princìpi liberistici di Adam Smith, non ritiene che la legge della domanda e dell’offerta possa condurre ad un’equa redistribuzione della ricchezza: a tal proposito, Ricardo individua due fattori di sperequazione. Il primo è dato dal rapporto tra la rendita fondiaria, cioè il reddito prodotto dalla proprietà della terra, e la crescita demografica. Per sfamare la popolazione sarà necessario coltivare anche i terreni meno fertili, con maggiori costi di lavoro e una minore rendita. Giacchè la popolazione crescerà sempre di più, sarà sempre più vasto il ricorso a terreni sempre meno fertili con rendite sempre più basse. Per questa via la “rendita differenziale”, ovvero la differenza tra la rendita dei terreni più fertili e quella dei terreni meno fertili diverrà sempre più grande. Il secondo fattore di sperequazione economico/sociale è dato dalla cosiddetta legge ferrea dei salari, secondo la quale, in base alla legge della domanda e dell’offerta, i salari tendono ad abbassarsi sempre più, per attestarsi al mero limite di sopravvivenza del lavoratore. La consapevolezza di tali squilibri socio/economici indusse molti intellettuali – che pure si definivano “liberali” e “liberisti” – a formulare un’analisi della società e un progetto operativo che prevedessero una più equa redistribuzione della ricchezza e una politica di emancipazione sociale e culturale delle classi subalterne; ma tali risoluzioni furono tutto fuorchè soddisfacenti. Dalla presa di coscienza del loro fallimento, muoverà Marx, il quale – alla strada del riformismo dall'”alto” – opporrà quella della rivoluzione dal “basso”.
Brani dalle opere
Del celebre economista inglese David Ricardo riportiamo questo brano, tratto dall’opera Princípi dell’economia politica (1817) in cui sono presenti la distinzione fra valore d’uso e valore di scambio e il rapporto fra lavoro e valore, che saranno poi ripresi da Marx.
[D. Ricardo, Principi dell’economia politica]
È stato osservato da Adam Smith che “la parola valore ha due significati diversi, e talvolta esprime l’utilità di una cosa, talvolta il potere che questa cosa conferisce al suo possessore di comperare altre cose. Il primo può chiamarsi valore d’uso; il secondo valore di scambio. Le cose, egli continua, che abbiano il piú grande valore d’uso, spesso non hanno che poco o nessun valore di scambio; ed all’opposto quelle che abbiano il piú grande valore di scambio, non hanno che poco o nessun valore d’uso”. L’acqua e l’aria sono utilissime; eppure, nelle circostanze ordinarie, non si può ottenere nulla in cambio di esse. Viceversa l’oro, quantunque in paragone all’acqua e all’aria sia poco utile, si permuta con una gran copia di altri beni. Dunque l’utilità non è la misura del valore di scambio, benché ne formi un elemento essenziale. Se una merce non fosse utile in nessun modo – in altri termini, se non potesse contribuire in nessun modo ai nostri bisogni – essa sarebbe priva di valore di scambio, per scarsa che fosse, o quale che fosse la quantità di lavoro occorrente per procurarsela. Possedendo dell’utilità, le merci derivano il loro valore di scambio da due fonti: dalla loro scarsità e dalla quantità di lavoro richiesto per ottenerle. Vi sono alcune merci, il cui valore è determinato soltanto dalla loro scarsità. Nessun lavoro può aumentare la quantità di simili oggetti, e perciò il loro valore non può diminuire in seguito ad un aumento dell’offerta. Alcune statue e pitture rare, vini di qualità speciale, che possono esser fatti soltanto con uve raccolte in un determinato terreno, la cui estensione sia assai limitata, sono tutti di questo tipo. Il loro valore è del tutto indipendente dalla quantità di lavoro originariamente necessario a produrli, e varia col variare delle ricchezze e dei gusti di coloro che sono desiderosi di possederli. Tuttavia, queste merci formano una piccolissima parte della massa delle merci giornalmente cambiate sul mercato. La massima parte degli oggetti desiderati si procura con il lavoro; e possono moltiplicarsi senza alcun limite – non soltanto in un paese, ma in molti – se noi siamo disposti ad impiegare il lavoro necessario per ottenerli. Parlando dunque di merci, del valore di scambio e delle leggi che regolano i loro rispettivi prezzi, intendiamo sempre soltanto quelle merci, la cui quantità può essere aumentata con l’esercizio dell’industria umana, e sulla cui produzione la concorrenza opera senza freni. Nei primi periodi della società il valore di scambio di queste merci, o la regola che determina quanto di una di esse sarà dato in cambio di un’altra, dipende quasi esclusivamente dal confronto fra le quantità di lavoro impiegate per ciascuna di esse. “Il prezzo reale di ogni cosa, dice Adam Smith, ciò che ogni cosa costa realmente all’uomo che ha bisogno d’acquistarla, è la pena e la fatica di acquistarla. Ciò che ogni cosa vale realmente per l’uomo che l’ha acquistata, e che vuol disporne o cambiarla con un’altra, è la pena e la fatica che essa può risparmiare a lui ed imporre ad altri”. Il lavoro fu il primo prezzo, la primitiva moneta con cui si pagarono tutte le cose. Ancora, “in quel primitivo e rozzo stato della società che precede e l’accumulazione del capitale e l’appropriazione della terra, la proporzione fra le quantità di lavoro necessario ad acquistare differenti oggetti sembra essere il solo dato su cui si regola lo scambio di uno con un altro. Se per esempio in un popolo di cacciatori uccidere un castoro richiede ordinariamente un lavoro doppio che uccidere un cervo, un castoro si cambierà naturalmente con due cervi, o ne varrà due. È naturale che ciò che è ordinariamente il prodotto del lavoro di due giorni o di due ore valga il doppio di ciò che è ordinariamente il prodotto del lavoro di un giorno o di un’ora”. Che questo sia realmente il fondamento del valore di scambio di tutte le cose, eccettuate quelle che non possono essere aumentate dall’industria umana, è in economia politica una dottrina di somma importanza; in quanto da nessuna fonte si originano, in questa scienza, tanti errori e tanta differenza d’opinioni, quanto dai significati vaghi che si attribuiscono alla parola valore. Se la quantità di lavoro incorporato nelle merci determina il loro valore di scambio, ogni accrescimento della quantità di lavoro deve aumentare il valore di quella merce su cui viene esercitato, come ogni diminuzione deve abbassarlo.
T.R. MALTHUS

Figlio cadetto di un gentiluomo amico di Hume e di Rousseau, Thomas Robert Malthus compì gli studi a Cambridge e divenne pastore anglicano ad Albury (Surrey). Nel 1798 pubblicò anonimo il Saggio sul principio di popolazione di cui diede la versione definitiva nel 1803. Nel 1805 fu nominato professore di economia politica nel collegio di Haileybury. Le altre sue opere fra cui Ricerca sulla natura e sul progresso della rendita (1815), Principi di economia politica considerati dal punto di vista della loro applicazione pratica (1820), La misura del valore(1823) e Definizioni di economia politica (1827) sono meno famose del Saggio, ma non meno importanti. Infatti Malthus ha legato il suo nome oltre che alla controversa teoria della popolazione anche all’analisi monetaria, allo studio della rendita fondiaria e alla cosiddetta teoria degli “ingorghi generali” (in base alla quale le depressioni economiche sarebbero dovute, da una parte, all’eccessivo aumento del risparmio e degli investimenti e, quindi, dell’offerta di prodotti; dall’altra, all’insufficiente aumento della domanda di beni di consumo). Malthus identifica la causa principale della miseria nel fatto che la popolazione tende ad aumentare più rapidamente dei mezzi di sussistenza. In particolare, mentre la popolazione tende ad aumentare in progressione geometrica, i mezzi di sussistenza tendono ad aumentare in progressione aritmetica. L’incremento demografico può tuttavia essere ritardato da freni repressivi come guerre, epidemie, carestie o da freni preventivi come la restrizione morale. Quest’ultima, a cui Malthus esorta tutti gli uomini e soprattutto i poveri, consiste in una limitazione volontaria delle nascite attraverso l’astensione dal matrimonio. Malthus propone quindi di adottare ogni misura atta a scoraggiare la natalità e di abolire la “legge sui poveri”, poiché la carità è un incentivo all’incremento di popolazione. Malthus mette in luce il crescente divario tra la crescita demografica e quella delle risorse per la sussistenza. La popolazione – egli asserisce – cresce secondo una proporzione geometrica (1-2-4-8, ecc), per cui ogni singolo aumento è principio di moltiplicazione degli aumenti successivi. Al contrario, le risorse per la sussistenza aumentano solamente in proporzione aritmetica (1-2-3-4, ecc): ne segue che l’aumento delle risorse non riesce a tenere il passo con la crescita della popolazione; vi saranno sempre più esseri umani e, proporzionalmente, sempre meno risorse sufficienti a sfamarli. Come soluzione, Malthus propone un rigoroso controllo delle nascite, ossia un ritegno morale consistente nell’astenersi dal matrimonio e dalle pratiche sessuali. In questa maniera, dopo aver sostenuto il crescente divario in atto tra la crescita demografica e quella delle risorse per la sussistenza, Malthus si fa portavoce di un liberalismo radicale e sfrenato, secondo cui ogni singolo individuo è e deve essere libero e privo di assistenza sociale e solidarietà, in modo tale che a prevalere siano i più forti, a soccombere i più deboli.
PASSI DALLE OPERE [Th. R. Malthus, Saggio sul principio della popolazione]
In una indagine sui futuri progressi della società, il modo naturale di condursi sarebbe quello d’investigare:
1° – le cause che hanno finora impedito i progressi del genere umano verso il suo benessere;
2° – le probabilità di rimuovere, in tutto o in parte, queste cause.
Entrare pienamente in questo esame, ed enumerare tutte le cause che hanno finora ostacolato i progressi umani, sarebbe cosa superiore alle forze di un solo uomo. Lo scopo principale del presente saggio è di esaminare gli effetti di una sola gran causa, intimamente legata alla natura dell’uomo, la quale, quantunque abbia costantemente ed energicamente operato fin dalle origini sociali, pure ha attirato poco l’attenzione degli autori che si sono occupati di questa materia […] La causa a cui alludo è la costante tendenza, che hanno tutti gli esseri viventi a moltiplicarsi piú di quanto permettano i mezzi di sussistenza di cui possano disporre […] Nel regno animale e vegetale, la natura ha profuso i germi della vita, ma è stata comparativamente avara dello spazio e degli alimenti necessari al loro moltiplicarsi. I germi esistenti in un piccolo angolo di terra, se avessero con loro abbondanza di cibo e di spazio, nel corso di poche migliaia d’anni avrebbero occupato milioni di mondi. La necessità, legge universale e prepotente in natura, li reprime entro i limiti prescritti. Le piante e gli animali son costretti a piegare sotto l’impero di questa legge; e la razza umana, qualunque sforzo facesse, sarebbe sempre, come ogni altra, costretta ad ubbidirle. Per le piante e per gli animali, la cosa procede in modo ben semplice. Sono tutti portati da un poderoso istinto a moltiplicare la loro specie; istinto che non viene frenato da alcun ragionamento o dubbio sul modo di provvedere all’esistenza delle loro generazioni. Perciò spiegano la loro forza di procreazione dovunque possono, e tutto il sovrappiú viene eliminato in un secondo momento per mancanza di spazio e di viveri; e fra gli animali, inoltre, per la voracità che li fa preda gli uni degli altri. Nell’uomo, gli effetti di questa legge sono molto piú complicati. Mosso dal medesimo istinto di procreazione, la ragione lo arresta, e gli propone il quesito se gli sia lecito far sorgere esseri nuovi nel mondo, per i quali egli non possa provvedere sufficienti mezzi di sussistenza. Se egli cede a questo ragionevole dubbio, il suo astenersi si converte spesso in causa di vizi. Se non vi bada, la razza umana si vedrà di continuo tendente ad accrescersi al di là dei suoi mezzi di sussistenza. Ma siccome, per quella legge della nostra natura che fa dipendere la vita dal cibo, la popolazione non può moltiplicarsi piú di quanto permetta il piú limitato nutrimento capace di sostenerla, cosí s’incontra sempre un forte ostacolo al suo incremento nella difficoltà di nutrirsi; difficoltà che di tanto in tanto deve necessariamente apparire, e deve risentirsi nella maggior parte del genere umano, sotto l’una o l’altra fra le varie forme della miseria, o della paura della miseria […] Si può con tutta franchezza asserire che la popolazione, quando non è arrestata da alcun ostacolo, si raddoppia ad ogni periodo di 25 anni, crescendo cosí in progressione geometrica. La ragione secondo cui si possa credere che aumentino le produzioni della terra non è altrettanto agevole a determinarsi. D’una cosa, tuttavia, siamo ben certi, che questa ragione dev’essere affatto diversa da quella secondo cui procede l’aumento della popolazione […] L’Europa non è di certo popolata quanto potrebbe. È in Europa che esistono le migliori speranze di vedere ben diretta l’industria. La scienza agraria si è molto studiata nell’Inghilterra e nella Scozia; e nondimeno vi sono ancora molte terre incolte. Esaminiamo con quale progressione il prodotto di quest’isola potrebbe accrescersi sotto le piú propizie circostanze. Se supponiamo che, con il miglior governo e i migliori incoraggiamenti all’agricoltura, il prodotto medio dell’isola si raddoppi nei primi 25 anni, faremo la piú generosa ipotesi che si possa. Nel periodo seguente, è impossibile immaginare che il prodotto si troverà quadruplicato. Ciò sarebbe in opposizione con quanto conosciamo sulle attitudini produttive del suolo. Il miglioramento delle terre sterili è opera che richiede tempo e lavoro; ed è evidente per chiunque abbia le minime nozioni agricole che, quanto piú la coltivazione si estende, tanto piú diminuisce l’aumento possibile del prodotto […] Immaginiamo che l’incremento annuo di prodotto, invece di decrescere, come certo fa, rimanga sempre costante; e la produzione dell’isola si accresca, ad ogni periodo di 25 anni, di una quantità eguale a quella del prodotto attuale: il piú esagerato speculatore non potrebbe immaginare di piú. In pochi secoli, ogni palmo di terreno in questo paese sarebbe divenuto un giardino. Se la medesima ipotesi si applicasse a tutta la terra, e se si ammettesse che la sussistenza agli uomini fornita dalla terra si potesse aumentare ad ogni 25 anni di tanto quanto se ne produce oggi, ciò sarebbe un supporre una progressione molto superiore a quanto sia dato sperare da qualsiasi sforzo dell’industria umana. Perciò possiamo dire che, considerando lo stato presente della terra, i mezzi di sussistenza, nelle circostanze piú favorevoli all’industria umana, non potrebbero crescere che in proporzione aritmetica. La conseguenza inevitabile di codeste differenti progressioni è palpabile […] Posto che la popolazione attuale ascenda a 1000 milioni, la razza umana crescerebbe secondo i numeri 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, e i viveri secondo i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. In due secoli la popolazione si troverebbe, rispetto ai viveri, come 256 a 9; in tre secoli, come 4096 a 13; in duemila anni la differenza sarebbe quasi impossibile a calcolarsi. In questa ipotesi non si suppone alcun ostacolo all’incremento dei prodotti della terra. Possono sempre aumentarsi indefinitamente; e, tuttavia, la forza generativa supera talmente la produzione dei viveri che, per mantenerla ad uno stesso livello in modo che la popolazione esistente trovi sempre gli alimenti indispensabili, è necessario che ad ogni momento una legge superiore formi ostacolo ai suoi progressi; che la dura necessità la soggioghi; in una parola, che quello, fra i due princípi contrari, la cui azione è preponderante, sia contenuto entro certi confini.
ELIA BENAMOZEGH

A cura di Ilaria Orsini
Elia Benamozegh è una tra le maggiori figure dell’ebraismo italiano dell’Ottocento. Nacque a Livorno il 24 aprile 1823 da una famiglia originaria di Fez, in Marocco, rimasto orfano ben presto, fu allevato dalla madre e dallo zio di lei Yehudah Coriat, rabbino e cabalista. Proprio dallo zio fu iniziato allo studio del Talmud e della qabbalah. Esercitò l’ufficio rabbinico nella città natale, Livorno e qui vi rimase tutta la vita e vi morì il 6 febbraio 1900. Benamozegh fu scrittore prolifico e spesso non soddisfatto del suo lavoro, come testimoniano le opere inedite; scrisse in ebraico, italiano e francese. Oltre che rabbino, fu filosofo e cabalista: si interessò alla filosofia, alla teologia, al diritto, alla critica biblica e alla filologia. Le sue opere ancora adesso sono ritenute fonte indispensabile per la comprensione di una serie di testi antichi. Attraverso i suoi testi, il lettore riconosce di trovarsi di fronte ad un pensatore colto e geniale, ma anche non rigoroso, a volte confuso come dimostrano le numerosissime note e aggiunte ai suoi testi. Questo aspetto particolare deve però essere ricondotto alla situazione culturale in cui Benamozegh scrive. Egli vive in un periodo in cui l’ebraismo europeo attraversa una forte crisi di identità: è l’epoca dell’ebraismo riformato. In questo periodo si sviluppa in ambito culturale la Wissenschaft des Judentums, la Scienza dell’ebraismo: la ricerca scientifica, i metodi di analisi del pensiero europeo, operano molte volte dei processi di assorbimento della cultura ebraica in quella occidentale, e non sempre la tradizione, l’ortodossia, a contatto con le nuove metodologie riesce a mantenere la propria stabilità. Benamozegh, a differenza di altri pensatori ebrei contemporanei, non troverà contrasto tra la scienza moderna e l’ebraismo: fu lettore di molte opere della tradizione filosofica occidentale, egli cita Hegel, che conobbe tramite le opere di Gioberti, Hartmann e, nelle scienze, Darwin; lesse la maggior parte delle opere di questi autori nella traduzione francese che si faceva inviare. La peculiarità di Benamozegh è di presentarsi sulla scena europea con una preparazione da autodidatta nella formazione filosofica, ma anche con un’eredità propria difficile da proporre. Egli è rabbino e, come professa egli stesso: “Il mio credo religioso è quello dell’ebraismo ortodosso”, il suo retaggio culturale è quello di un ebreo proveniente dall’ambiente sefardita nord-africano, quindi notoriamente più tradizionalista: l’eredità esoterica della qabbalah ha un ruolo importante nel suo panorama culturale. Malgrado ciò, Benamozegh fu uno dei pochi pensatori ebrei che, in epoca moderna, riuscì ad associare l’erudizione occidentale con il proprio patrimonio culturale, visse in un contesto occidentale con il quale seppe intrecciare la propria cultura orientale. La tradizione, per Benamozegh, non è qualcosa di esaurito, di morto, è una dimensione antropologica e rappresenta l’elemento vitale dell’ebraismo, la sua anima. E’ bene comunque ricordare che, proprio per la posizione che Benamozegh assume nei confronti della tradizione esoterica, egli fu al centro di molte discussioni, soprattutto nell’ambiente rabbinico; nota è la polemica che intrecciò con un’altra importante figura dell’ebraismo italiano ottocentesco: Samuel David Luzzatto. Il punto di contrasto verteva sull’importanza della tradizione cabalistica, essenziale per Benamozegh, inutile e dannosa per Luzzatto. Egli si poneva come interlocutore attivo nel dibattito culturale e religioso europeo dell’epoca, il suo contributo al pensiero occidentale è ricco di spunti e fervidi apporti non solo nutriti dall’interesse per la qabbalah. Nell’opera più famosa dell’illustre rabbino, Israele e l’umanità, Benamozegh si propone di trovare la religione che possa offrire una soluzione per risolvere il problema della crisi religiosa e morale contemporanea. Secondo Benamozegh all’interno dell’ebraismo coesistono due elementi che lo caratterizzano: quello universale e quello particolare. Israele ha una religione universale, ossia la religione che Dio ha dato a Noè e la soluzione alla crisi di valori viene proprio da questo antico ebraismo, da quelle radici che accomunano il popolo di Israele all’umanità intera: la religione noachide. Con questo termine, colto dalla tradizione, Benamozegh fa riferimento ai sette precetti che Dio diede a Noè dopo il diluvio, si tratta di norme giuridiche che regolano la convivenza tra i popoli. I precetti “noachici” prevedono: l’obbligo di istituire tribunali, il divieto di blasfemia, il divieto di idolatria, il divieto di fornicazione, il divieto di omicidio, il divieto di furto, il divieto di mangiare le membra di un animale vivo. Per dimostrare l’universalismo della religione ebraica Benamozegh fa riferimento alla concezione di un Dio universale, la cui provvidenza abbraccia l’intero universo, e all’unità d’origine e quindi all’uguaglianza tra gli uomini. Le leggi noachidi investono tutti gli ambiti della vita individuale e sociale dell’uomo. Benamozegh sostiene che il noachismo è una legge razionale, ma in accordo con la tradizione afferma il carattere religioso delle leggi di Noè. Comunque, per il suo carattere razionale, il noachismo può essere considerato una base per costruire un intero sistema etico e giuridico valido per l’intera umanità. Benamozegh individua, nelle leggi di Noè, una radice etica e antropologica. L’uomo è libero e questa libertà risiede nella capacità dell’uomo di perfezionarsi; l’avanzamento verso uno stato di perfezione morale, sociale, intellettuale è possibile attraverso l’esercizio della libertà umana, ma anche per la vocazione dell’uomo all’imitazione di Dio. La concezione dell’uomo come “essere progressivo” e di una società in via di perfezionamento, si spiega attraverso l’esigenza di fondare una società giusta. La giustizia è un’idea fondante l’etica del noachismo: Noè è nello stesso tempo l’uomo giusto e l’uomo etico. Ma l’ebraismo è anche una religione particolare che ha, all’interno del progetto teorico di Benamozegh, un ruolo fondamentale; infatti nella storia religiosa dell’umanità il popolo ebraico con la propria legge particolare è strumento della provvidenza divina: ha il compito di custodire attraverso tale legge la legge noachide che porta dentro di sè e di mostrarla all’umanità. La legislazione mosaica ha quindi un carattere “sacerdotale”: essa, così restrittiva, ha la funzione di preservare l’integrità di Israele e di prepararlo al suo compito universale. Benamozegh si rivolge anche al cristianesimo che assume una posizione importante; egli elabora la teoria di un cristianesimo incompleto e deviato e riconduce la dogmatica cristiana alla matrice ebraica attraverso l’esame della lingua viva della qabbalah, che abbiamo detto rappresenta una parte importantissima dell’indagine di Benamozegh. Il cristianesimo, come anche l’islamismo, hanno bisogno di essere restaurati per tornare alla loro religione madre. Benamozegh, nei confronti del cristianesimo, assume posizioni ambivalenti: da una parte sembra che, dopo la restaurazione, la religione cristiana possa ambire a diventare religione universale, dall’altra sembra che debba essere sorpassata o ridotta a semplice noachismo. Credo che il cristianesimo, in questo progetto, abbia un ruolo di mediatore tra Israele e l’umanità laica in vista dell’attuazione dell’era messianica affinché, un giorno, l’umanità intera, riconosca e rispetti la legge noachide. Benamozegh invita, quindi, le chiese a collaborare all’avvenire religioso dell’umanità; ma è necessario ripristinare la duplice struttura di Israele e l’umanità: altrimenti, ogni pretesa di universalità etica dovrebbe essere considerata vana.
FÉLIX RAVAISSON-MOLLIEN

VITA E OPERE
Jean Gaspard Felix Ravaisson-Mollien (23 ottobre 1813 – 18 maggio 1900) nacque a Namur e, dopo un corso di studi pieno di successo al College Rollin, continuò a Monaco, dove frequentò le lezioni di Schelling e si laureò in filosofia nel 1836. Nell’anno seguente pubblicò il primo volume della sua famosa opera Essai sur la métaphysique d’Aristote, al quale, nel 1846, aggiunse un volume supplementario. In questo suo lavoro non solo critica e commenta le teorie di Aristotele e la filosofia peripatetica, ma da esse trae un sistema filosofico moderno. Nel 1838 riceve il titolo di dottore e diviene professore di filosofia a Rennes. Dal 1840 fu ispettore generale nelle biblioteche e nel 1860 divenne ispettore generale del dipartimento dell’istruzione superiore. Era anche membro dell’Accademia e dell’Accademia di Scienze Politiche e Morali oltrechè sovrintendente del Dipartimento di Antichità al Louvre (dal 1870). Morì a Parigi il 18 maggio 1900. Nel campo della filosofia, egli faceva parte della scuola di Cousin, col quale era sempre in questione su molti punti importanti. L’atto di coscienza, secondo lui, è alla base di tutto il sapere. Questi atti di coscienza sono manifestazioni della volontà, vale a dire la ragione e il potere creativo della vita intellettuale. L’idea di Dio è un’intuizione aggiuntiva data da tutte le diverse facoltà della mente, nella sua osservazione dell’armonia nella natura e nell’uomo. Questa teoria ebbe un’influenza considerevole sulla filosofia speculativa in Francia durante gli ultimi anni del XIX secolo. I principali lavori filosofici di Ravaisson sono: Les Fragments philosophique de Hamilton (1840); Rapport sur Iestoicisme (1851) ; La Philosophie en France au dix-neuvième siecle (1868, terza edizione, 1889) ; Morale et métaphysique (1893). Eminente filosofo, Ravaisson fu anche archeologo e contribuì con articoli sulla scultura antica al Revue Archiologique, e al Mémoires de l’Académie des Inscriptions. Nel 1871 pubblicò una monografia sulla Venere di Milo.
IL PENSIERO
Ravaisson fa risalire le radici dello spiritualismo allo stesso Aristotele, il quale, a suo giudizio, ha mostrato come l’intelligenza dell’uomo “per esperienza immediata colga in se stessa la realtà assoluta dalla quale ogni altra dipende”. Dunque la percezione intima della coscienza è rivelativa del senso dell’essere dell’uomo, e dev’essere il fondamento della riflessione filosofica. In questa esperienza interiore, l’uomo si scopre spirito, cioè libertà, o meglio libera attività creatrice sul piano del pensiero e su quello dell’azione. Ma si tratta di uno spirito non separato dalla materia, bensí in continuità con essa. Infatti è vero che la libertà caratterizza lo spirito e la necessità contrassegna la materia, ma c’è un’area della vita psichica umana – quella dell’abitudine – che ci mostra quella continuità; nell’abitudine infatti la volontà cosciente diventa inconscia, la libertà diventa semplicemente spontaneità; in essa l’attività non si pone fuori del campo dello spirito, perché è pur sempre in funzione di un fine, e quindi implica l’esercizio dell’intelligenza; ma il fine è incorporato nell’attività stessa, reso inconsapevole, per cui l’azione sembra assumere caratteri “meccanici”. Dunque non c’è opposizione tra spirito e materia; e pertanto va riveduto lo stesso concetto di “meccanicismo naturale”. La vita della natura “appare” meccanica, ma una riflessione piú profonda rivela che tutta la realtà è in movimento verso l’intelligenza, e non solo nel senso che tende al suo compimento nella vita intellettiva dell’uomo, ma anche e soprattutto nel senso che essa tende all’Intelligenza divina. Ciò ha mostrato anche Aristotele quando ha indicato nel passaggio dalla potenza all’atto la legge che muove gli enti finiti verso il Pensiero puro. L’uomo è il punto di congiunzione tra la materia, cosiddetta meccanica, e Dio, spirito puro, perché nell’uomo lo spirito, imbrigliato nella natura, diventa consapevole e si apre alla perfezione divina in un rapporto di “amore scambievole” con Dio. Tale apertura ha luogo nello slancio della volontà verso la realizzazione del bene, e nell’amore per la bellezza della natura e dell’arte. Ravaisson si esprime in favore di Maine de Biran, il cui merito è ravvisato nell’aver sottratto la filosofia all’influenza della tradizione illuministica, riconfermando il primato dello spirito sulla natura. La coscienza è la fonte di ogni verità (già per Aristotele, secondo Ravaisson) e il mondo naturale, che cade sotto le determinazioni empiriche del tempo e dello spazio, è mera parvenza, riconducibile all’attività dello spirito. Per giustificare l’apparenza della materialità alla luce di quest’attività spirituale da cui tutto promana, Ravaisson ricorre al concetto fondamentale di abitudine, concetto che sta al centro della sua importante tesi di dottorato su L’abitudine (1838) appunto. L’abitudine è un ponte di passaggio dall’attività spirituale all’inerzia materiale. Infatti, benchè nasca dallo spirito, attraverso la ripetizione meccanica degli atti, l’abitudine implica una graduale perdita della consapevolezza e della libertà che contrassegnano ogni attività meramente spirituale. Ne segue che si viene a creare una realtà che, pur mantenendo la sua radice spirituale, è ormai del tutto inerte e inconscia: tale è la materia. Tra i due estremi dati dal puro spirito e dalla materia si distribuiscono gradualità diverse di coscienza e libertà, corrispondenti ai diversi livelli della realtà (inorganica, vegetale, animale, umana).
LÉON OLLÉ-LAPRUNE

Breve introduzione
Tra i tanti studenti di Léon Ollé-Laprune presso l’Ecole Normal Supérieure ci furono i primi leader Socialisti, il sociologo Jean Jaurés, Emil Durkheim, per non parlare di Henri Bergson e Maurice Blondel, due dei più grandi filosofi francesi del XX secolo. Cattolico convinto, inspirato dall’impegno sociale di Frédéric Ozanam e dei democratici cattolici del 1848, Ollé-Laprune difese una filosofia rinnovata che cercava di andare oltre l’approvata scolastica del tempo. Per questa ragione, e anche perché egli scelse di insegnare nel sistema universitario statale di cui l’Ecole Normale Supérieure faceva parte, Ollé-Laprune a volte si trovò emarginato da alcuni gruppi cattolici conservatori. D’altro canto, la sua fede proclamata pubblicamente ha fatto sì che la sua filosofia ne risentisse a causa delle forze anticlericali che guadagnavano un’ascendenza nella vita francese del tardo XIX secolo. Ollé-Laprune non ha mai cercato di fornire conforto a nessuna delle sue teorie e ciò, assieme alla sua morte prematura nel 1898 avvenuta all’apice della sua carriera, può spiegare l’oscurità nella quale la filosofia di Ollé-Laprune è ingiustamente caduta. Insieme alla sua ispirazione filosofica, Alphonse Graty, Léon Ollé-Laprune cercava di porre le fondamenta di una nuova filosofia capace di rispondere alle sfide del mondo moderno, il quale è emerso come risultato delle rivoluzioni democratica e industriale del XVII e XIX secolo. E’ una sfida che sta ancora di fronte a noi all’alba del XXI secolo.
Biografia
Alcune date nella vita di Léon Ollé-Laprune
25/02/1839 Nasce a Parigi
1858: Entra a l’Ecole Normale Supérieure al primo posto
1861: Diplomato in Arte al primo posto
1862: Professore di filosofia a Nizza
1862: Inizia un piano di studi privato di scienza e teologia propostogli dal professor Graty
1864: Professore a Douai
1868: Professore al liceo Henri IV di Parigi
1869: Si sposa con Mademoiselle Saint-René Taillandier
1875 : Lettore presso l’Ecole Normale Supérieure
1880 : Proteste contro l’espulsione di congregazioni religiose da parte del governo francese, seguite da un anno di sospensione dal suo posto di insegnamento ; lettere di solidarietà da parte degli studenti, firmate in cima da Jean Jaurés fondatore del Partito Socialista.
1893-97: Presiede la cerimonia della premiazioni al Collegio Stanislas
13/02/1898: Muore a Parigi
Il pensiero
Ollé-Laprune, Léon, filosofo cattolico francese, nato a Parigi nel 1839 e colà morto nel 1898, sotto l’influenza del filosofo Caro e del libro di Padre Graty “Les Sources” [“Le Fonti”], Ollé-Laprune, dopo studi eccezionalmente brillanti presso l’Ecole Normale Supérieure (dal 1858 al 1861), si è consacrato alla filosofia. Trascorse la sua vita insegnando una filosofia illuminata dalla luce della fede cattolica, prima nei licei e poi presso l’Ecole Normale Supérieure a partire dal 1875. Come Ozanam è stato un professore cattolico di storia e letteratura straniera nell’università, lo scopo di Ollé-Laprune era di essere un professore cattolico di filosofia là. Père de Règnon, il teologo Gesuita, gli scrisse: “Sono lieto di pensare che Dio voglia nel nostro tempo riportare in auge l’apostolato laico, come ai tempi di Giustino e Atenagoras; sei tu che specialmente mi fai venire questi pensieri.” Il Governo della Terza Repubblica era adesso pressato da parte di alcune sezioni della stampa di punire il “clericalismo” di Ollé-Laprune, ma la reputazione del suo insegnamento filosofico lo protesse. Solo per un anno (1881-82), dopo aver organizzato una manifestazione in favore delle congregazioni espulse, fu sospeso dal suo posto da Jules Ferry, e la prima firma della protesta indirizzata al ministro in favore del loro professore fu del futuro deputato socialista Jean Jaurés, allora studente all’Ecole Normale Supérieure.
La prima opera importante di Ollé-Laprune fu “La filosofia di Malebranche” (1870), che già ben rivelava le sue tendenze in sede filosofica. Dieci anni dopo, per ottenere il dottorato, difese davanti la Sorbonne una tesi sulla certezza morale. Come oppositore alle esagerazioni del razionalismo cartesiano e del determinismo positivista studiò il ruolo della volontà e del cuore nel fenomeno della convinzione. Quest’opera riassume sotto molti aspetti la “Grammatica dell’assenso” di Newman; ma Ollè-Laprune non deve, più che cardinale Inglese, essere considerato responsabile della successiva tendenza che ha cercato di diminuire il margine di intelligenza nell’atto di fede e di separare completamente il campo della credenza da quello della conoscenza. Nel suo “Saggio sulla morale di Aristotele” (1881) Ollé-Laprune ha difeso l’”edonismo” del filosofo greco contro le teorie kantiane; e ne “La filosofia e il tempo presente” (1890) ha rivendicato, contro lo spiritualismo deista, il diritto del pensatore cristiano di andare oltre il dato della “religione naturale” e illuminare la filosofia con i dati della religione rivelata. Una delle sue più influenti opere è stato il “Premio della vita” (1894), in cui mostra perché vale la pena di vivere la vita. Il parere dato da Leone XII ai Cattolici di Francia ha trovato in Ollé-Laprune un attivo difensore. Il suo opuscolo “Ciò che si va a cercare a Roma” (1895) fu uno dei migliori commentari sulla politica papale. L’Accademia delle Scienze Politiche e Morali lo elesse membro della sezione filosofica nel 1879 per succedere a Vacherot. I suoi articoli e conferenze attestano la sua crescente influenza nei circoli cattolici. Egli divenne leader dell’attività cristiana, consultato e ascoltato da tutti fino alla sua morte prematura quando era sul punto di terminare il suo libro su Jouffroy (Parigi, 1899). Molti dei suoi articoli sono stati raccolti da Goyau sotto il titolo “La vitalità cristiana” (1901). Qui sono anche state trovate una serie di inedite meditazioni, che da una notevole coincidenza nacque il futuro motto di Pio X, “Omnia instaurare in Cristo”. Il professore Delbos dell’Università di Parigi pubblicava nel 1907 il corso che Ollé-Laprune ha dato sulla ragione e il razionalismo (la ragione e il razionalismo). Alcuni mesi dopo la sua morte Mr. Willim P. Coyne lo ha chiamato con giustizia “il più grande cattolico laico che sia apparso in Francia da Ozanam” (“Nuova Rivista Irlandese”, Giugno, 1899, p. 195). John Henry Newman (1801-1890) aveva distinto – nel suo “Saggio sulla grammatica dell’assenso” (1870) – tra l’assenso nozionale (che è di tipo intellettuale e si configura come adesione teoretica ad una proposizione assertiva) e l’assenso reale (dato invece dalla volontà e tale da investire la sfera pratica dell’agire), riconoscendo la netta superiorità del secondo: ora, Ollé-Laprune riprende questa concezione, e la espone in diversi suoi scritti (“La certezza morale”, 1880; “Il valore della vita”, 1894). In “La certezza morale”, egli distingue infatti tra la certezza astratta (o scientifica) e la certezza reale (o pratica): la prima concerne esclusivamente proposizioni teoriche senza riferimento alla loro realtà (la matematica ne segna il vertice), mentre la seconda riguarda le cose concrete. Solamente la certezza reale può originare l’atteggiamento del credere, che è indispensabile per la vita pratica. Dal credere scaturisce anche la fede, che per sua stessa natura non può risolversi in una mera conoscenza teorica, bensì deve svilupparsi in una concreta volontà d’azione.
GIUSEPPE MAZZINI

BIOGRAFIA
Nessuno dei protagonisti della Storia patria aveva un’idea così alta e così completa di cosa dovesse essere l’Italia come Giuseppe Mazzini. Non il Cavour che, pur essendo stato definito da Spadolini “l’unico uomo di Stato, per uno Stato che ancora non c’era” , si opponeva tenacemente all’idea unitaria intendendola, dopo i fatti del 1860/61, come il semplice ampliamento del Vecchio Regno di Sardegna e come l’avverarsi di ciò che pochi secoli prima aveva detto
Emanuele Filiberto di Savoia
(“L’Italia? Un carciofo di cui i Savoia mangeranno una foglia alla volta” );
non il Cattaneo che, chiamando il proprio giornale pubblicato nel 1848 “Il Cisalpino” e non “L’Italiano”, restringeva l’orizzonte del proprio progetto politico federalista al solo Nord sviluppato; non il Gioberti che, ne “Il Primato”, si faceva promotore di un anacronistico legame tra Stato e Chiesa che sembrava potersi avverare soltanto se analizzato alla luce delle riforme concesse da Papa Pio IX nello Stato della Chiesa nel 1848 dopo l’elezione al soglio pontificio.
Ma tutte queste speranze si riveleranno, dopo la svolta autoritaria del Pontefice nel 1848, pure illusioni. Tanto meno erano innovative le posizioni di quei liberali di scuola classica guidati in Piemonte dal D’Azeglio ed in Toscano dal Ricasoli che sognavano semplicemente di modificare in senso costituzionale il rapporto Corona-Parlamento senza stravolgere le condizioni sociali ed economiche esistenti.
Giuseppe Mazzini affronta il problema italiano…
…in un’ottica nuova: parla di una forma di Stato di tipo unitario e, per la forma di governo, dichiara le proprie idee repubblicane.
Interessante, per capirne il pensiero politico, è la biografia politica del pensatore ligure. Nasce a Genova nel 1805 da un’agiata famiglia piccolo-borghese e compie i primi passi nella lotta politica guidando, col Ruffini , i primi moti rivoluzionari nel Nord-Ovest dalle colonne dell’”Indicatore”. Falliti questi tentativi insurrezionali si assiste alla fondazione di una nuova società segreta “La Giovine Italia”. All’origine di essa vi è una critica incisiva della Carboneria a cui si imputa di essere troppo elitaria e totalmente disorganizzata al proprio interno degenerando, quindi, in organizzazione di stampo verticistico in cui i singoli adepti non sono a conoscenza dell’intero programma politico per la cui realizzazione lottano. La “Giovine Italia” propone un nuovo modello di lotta politica che, innanzi tutto, vuole coinvolgere le masse per giungere ad un moto insurrezionale popolare e nazionale. Vi è, inoltre, un forte interesse per i giovani che sono visti come elementi nuovi da invitare alla lotta politica.
Si è di fronte ad un’organizzazione non più di stampo liberale (quindi oligarchico), ma democratica il cui messaggio politico è indirizzato a tutte le classi sociali, anche le meno abbienti, affinché siano esse, e non le oligarchie monarchiche, le vere protagoniste del processo di unificazione tendente a fare dell’Italia uno Stato unito, indipendente e repubblicano che si possa inserire in una più vasta nuova Europa unitaria basata su valori democratici e di reciproco rispetto. È infatti, sempre negli anni ’30, che il Mazzini fonda “La Giovine Europa” che ha lo scopo di promuovere un processo di integrazione europea.
Benché definisse il Mediterraneo Mare Nostrum non si può considerare Mazzini nazionalista. Infatti il pensatore politico ligure sosteneva la pari dignità tra tutti i popoli europei e riteneva che la massima conquista civile della società fosse stata l’abolizione della schiavitù.
Come si può leggere a pagina 92 del volume 17 del “Westminster Review” (1852) Mazzini si faceva sostenitore di una graduale emancipazione delle colonie britanniche. Tanto W. T. Wilson e George Lloyd George , quanto molti leaders post-coloniali, tra i quali Gandhi , Golda Meir , David Ben Gurion , Nehru e Sun Yat-sen , consideravano Mazzini il proprio Maestro e “I doveri dell’uomo” la propria Bibbia morale, etica e politica. Mazzini, teorizzando l’integrazione fra le nazioni europee in un’ottica democratica e riformista giunge con quasi un secolo d’anticipo ad affermare ciò che grandi europeisti, quali Altiero Spinelli , Ugo La Malfa , Umberto Terracini e Giorgio Amendola , sosterranno nel “Manifesto di Ventotene” alla fine del II conflitto mondiale che aveva sconvolto le coscienze di milioni di europei che negli anni ’50 si interrogheranno se la nuova Europa dovesse divenire finalmente quel luogo politico e culturale in cui svelenire gli odi nazionalisti nell’ottica dell’interesse comune di pace e di prosperità oppure se dovesse essere il baluardo avanzato della guerra fredda.
Mazzini subordinava il concetto di Patria a quello più ampio di Umanità, auspicando che il concetto di nazione sarebbe stato superato a favore di una federazione fra i popoli europei che, da un lato, avrebbe permesso la rimozione delle tensioni internazionali sanando le ferite nazionaliste e, dall’altro, avrebbe permesso lo sviluppo anche dei popoli più poveri. La nazioni sarebbero dovute giungere a questo nuovo assetto geopolitico spinte dalla comprensione della “legge morale” a cui tutte sono soggette. Il pensatore democratico intravedeva già negli anni ’30 come la vecchia idea d’Europa, nata a Vienna nel 1914, non potesse reggere al progredire impetuoso della Storia. In tale considerazione vi è una consonanza con il filosofo tedesco Hegel che, nel 1831, affermava che in breve tempo l’Europa avrebbe ceduto il primato agli Stati Uniti. Contrariamente ad Hegel, che intendeva le nazioni in una naturale e reciproca competizione, Mazzini le considerava necessariamente cooperanti in nome dell’Umanità di cui ogni singola nazione è parzialmente manifestazione.
Contrariamente a Machiavelli , Mazzini si interessa alle nazioni in quanto popoli e non stima i “principi” che le guidano poiché, come ha detto Fançois Mitterand , “Sono le nazioni, qualora ne siano in grado a fare grandi i propri governanti”. Alla luce di quanto detto è assolutamente errato il tentativo di Giovanni Gentile di parlare di un “Mazzini fascista”. Quindi l’idea dell’Italia fascista figlia di Mussolini non trova legittimazione nell’ideologia politica democratica mazziniana. Inoltre non si può giustificare, ricorrendo al pensiero politico mazziniano, né l’esperienza coloniale patrocinata dal Crispi , né l’occupazione della Libia attuata nel 1912 dal IV gabinetto Giolitti . Questi atti coloniali trovano un riferimento culturale in Alfredo Oriani che teorizzava che le disfatte di Custoza, di Lissa e di Adua avevano creato al Regno d’Italia un complesso di inferiorità che poteva essere sanato soltanto se l’Italia fosse vissuta al di sopra delle proprie possibilità giungendo ad una “grandezza della Patria” in grado di risolvere le contraddizioni fra le quali il nuovo stato era nato e cresciuto. Ma questo è il pensiero del romagnolo Alfredo Oriani, l’autore de “La lotta politica in Italia”, definito da Antonio Gramsci “il rappresentante più onesto e più appassionato per la grandezza nazional-popolare fra gli intellettuali italiani della vecchia generazione” , non il ligure Giuseppe Mazzini, ritenuto da Francesco de Sanctis “il Mosè dell’Unità “.
I moti ispirati da “La Giovine Italia” danno tutti risultati negativi e ciò causa una forte crisi morale al Mazzini che, durante gli anni ’30, vive la “tempesta del dubbio”. In questi anni cerca una pace interiore dedicandosi a studi filosofici soprattutto in campo musicale.
È infatti pubblicata nel 1836 l’opera…
“Filosofia della Musica”
…dedicata ad un “Ignoto Numin i” che, per stessa confessione dell’autore, ha il compito di “trarre la musica dal fango o dall’isolamento in che giace per ricollocarla dove glia antichi grandi, non di sapienza, ma di sublimi presentimenti l’avevano posta accanto al legislatore ed alla religione “. Secondo Mazzini gli antichi avevano, dell’arte musicale, soltanto il germe (la melodia), non riuscivano a oltrepassare l’accompagnamento. Ma in quei popoli vi era una fede alla base alla base dell’”Istinto all’Unità “, fondamento di tutte le grandi cose. In Italia, continua Mazzini, la musica nasce nel XVI secolo con Palestrina che “tradusse il Cristianesimo in note”. Secondo Mazzini elementi generatori della musica sono la melodia, simbolo dell’individualità il cui massimo esperto fu il bolognese G. M. Martini (vissuto nel periodo classico e maestro anche di Mozart ), e l’armonia, simbolo del pensiero sociale, magistralmente rappresentata da Rossini , “Titano di potenza e di audacia. Il napoleone d’un epoca musicale”. Mazzini vedeva in Rossini quell’”Ignoto Numini” che doveva “spiritualizzare ” la musica “riconsacrandola con una missione “. Probabilmente quell’”Ignoto Numini” era già nato e, come ha scritto Massimo Mila : “Mazzini steso gli aveva aperto il cammino, additando agli artisti italiani un altro dei valori attraverso i quali era possibile placare la struggente ansia individualistica del Romanticismo: ‘Dio e Popolo’. ” Infatti l’individuo è naturalmente portato a tendere verso l’infinito, definito da Mazzini stesso “l’anelito delle anime nostre”, inserendo l’elemento divino e se stesso in quell’entità collettiva rappresentata dal popolo.
Queste novità filosofiche sono la piattaforma da cui parte il melodramma di Giuseppe Verdi che, dopo i successi del “Nabucco” (1842) e dei “Lombardi” (1843), abbandona il modello rossiniano per giungere ad opere con personaggi aventi caratteri individuali quali l’”Ernani” (1844) che è di tipo donizattiano. Nella già citata “Filosofia delle Musica” è presente un aspetto profondamente religioso (anche se l’autore non riconosceva valore alla gerarchia ecclesiastica) e di tensione verso il divino che ha portato Gaetano Salvemini ad affermare che “Mazzini non fu né un uomo di Stato, né un filosofo. Fu un mistico. Chiunque vive non per se stesso, ma per gli altri, è un mistico anche se è ateo”.
L’azione politica riprende vigore nel 1848, l’anno della I Guerra d’Indipendenza, e delle forti tensioni internazionali che porteranno a Vienna alla caduta del Metternich ed, a Parigi, alla fuga degli Orlèans ed alla proclamazione della II Repubblica che ben presto cadrà nelle mani dell’ambizioso Napoleone Bonaparte . Mazzini, nel 1848, guida con Armellini e Saffi , la Repubblica romana che è il momento maggiormente rappresentativo delle sue capacità amministrative e la cui Costituzione assume, nell’interpretazione di Giovanni Spadolini , il ruolo di anticipatrice delle moderne Costituzioni democratiche europee. Fu ispirata dalle tradizioni giacobine e dalle idee socialistiche esprimendo, così, non solo aspirazioni locali, ma gli ideali maturati da grandi uomini in molti anni di forzato esilio.
Molti sono i punti in comune tra la Costituzione della Repubblica romana e la Costituzione italiana del 1948. Per entrambe la “sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione” (art. 1), evitando così di contrapporre il popolo sovrano alle legittime assemblee da esso elette. Il parallelo continua per quanto riguarda gli artt. 3, 6, 7, 8 della Costituzione mazziniana e gli artt. 13, 14, 8, 21 della Costituzione italiana. Infatti in tutti questi articoli si affermano, negli stessi termini, i diritti inviolabili della libertà d’insegnamento, dell’inviolabilità del domicilio e dell’abolizione della pena di morte. Importante è l’art. 28 della Costituzione della Repubblica romana in cui si prevede un indennizzo per tutti i rappresentanti del popolo eletti, conquista raggiunta, nel Regno d’Italia, soltanto in epoca giolittiana dal movimento socialista. Fu d’ispirazione mazziniana, nell’interpretazione data da Piero Calamandrei nel suo “Discorso sulla Costituzione”, pronunciato a Milano nel 1955, l’art. 2 della Costituzione del 1948 in cui si afferma: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa della libertà di offesa degli altri popoli”.
Sempre di Calamandrei è un nobile e virtuoso parallelismo tra l’Assemblea Costituente romana del 1847 e quella italiana del 1948. Ciò non fu affatto un azzardo, ma la consapevolezza che l’Assemblea mazziniana doveva essere il compimento del Primo Risorgimento, ma così non fu e che l’Assemblea Costituente era il simbolo della Resistenza che, come disse a Milano il 25 aprile 1968 l’allora Presidente della Camera dei Deputasti Sandro Pertini , era stata “Un secondo Risorgimento i cui protagonisti furono le masse popolari”.
Caduta la Repubblica romana e giunto, nel 1852, al potere il Cavour si assiste alla fase calante della politica mazziniana. È la monarchia sabauda a guidare, nonostante che ciò non fosse nei progetti del Cavour, il processo di unificazione nazionale e numerosi mazziniani (Garibaldi , Crispi, Visconti-Venosta , Giuseppe Verdi ) passano alle file monarchiche aderendo alla “Società Nazionale” istituita da Cavour e dal Vittorio Emanuele II .
Mazzini si reca esule, per l’ennesima volta, in Inghilterra dove intrattiene buoni rapporti con i liberali inglesi amici di Gladstone e godendo, come testimoniato dagli scritti di Denis Mack Smith , di vasta popolarità.
Nel 1848 Marx e Engels pubblicano il “Manifesto del Partito Comunista” e nel 1864 si assiste alla nascita della Prima Internazionale alla quale partecipano fra gli altri Marx, Mazzini e Bakunin .Nel corso di questi anni la polemica tra Marx e Mazzini raggiunge livelli molto alti tanto che il filosofo tedesco accusa Mazzini di “leccare il culo ai borghesi liberali” e Mazzini replica affermando che, pur accettando le istanze di giustizia sociale che sono alla base del socialismo marxiano, rifiuta la lotta di classe e la violenza come mezzo di lotta politica. Critica fortemente i socialisti francesi che, con il loro radicalismo, hanno facilitato il colpo di Stato di Luigi Bonaparte. Condanna, con buona pace del capo del sindacalismo rivoluzionario George Sorel (che sosteneva che “La violenza è la levatrice della Storia”) la violenza ponendosi in posizione critica nei confronti della Comune parigina del 1870.
Ma nonostante tali polemiche non è improprio parlare di “socialismo mazziniano” intendendo il termine Socialismo nel senso più profondo ed originario della parola. Si rivolge alle classi medie e, tramite le “Società operaie”, al proletariato del cui appoggio ritiene di avere bisogno.
Il Partito d’Azione da lui fondato è il primo movimento veramente democratico poiché, oltre che a sostenere il suffragio elettorale universale maschile, prevede che il governo debba essere responsabile del proprio operato di fronte al popolo affinché il potere non sia detenuto da una ristretta elités. Mazzini col tempo diviene il punto di riferimento, con Piero Gobetti , Giovanni Amendola, i fratelli Carlo e Nello Rosselli, di quell’Italia di minoranza che Norberto Bobbio ha chiamato “Italia civile della ragione”.
Buona parte del pensiero della sinistra democratica affonda le proprie origini nel pensiero mazziniano. Come amava ricordare Giovanni Spadolini si tratta di un pensiero “carsico” che, a partire dal Partito d’Azione risorgimentale giunge alle più recenti formazioni politiche laiche e democratiche passando attraverso l’Unione Democratica Nazionale di Giovanni Amendola, la Pentarchia del 1925, il Partito d’Azione di Ferruccio Parri , Emilio Lussu e Leo Valiani e per il Partito Repubblicano Italiano di Ugo La Malfa, è riconducibile al pensiero filosofico e politico di Mazzini. Il pensatore ligure condannava la censura e la negazione della libertà sapendo che le grandi idee della Storia erano, in molti casi, state promosse da uomini perseguitati. Valgono sempre le parole di Socrate: “Mi avete ucciso perché volete sottrarvi all’accusatore e non rendere conto delle vostre viltà! Se credete che, uccidendo uomini, possiate impedire a qualcuno di consumare le vostre vite malvagie, siete in errore”.
I modi e le forme con cui l’Italia viene unificata nel biennio 1860-61 non sono certamente quelli auspicati da Mazzini, ma come ha osservato Gaetano Salvemini in una delle sue ultime lezioni: “L’intera penisola è stata unificata sotto una sola dinastia, la casa Savoia. Tutte le altre dinastie sono state spezzate “. In tale Italia Mazzini non si può riconoscere e muore, sotto falso nome, a Pisa nel marzo 1872.
Ci piace pensare che in quell’ora suprema, Giuseppe Mazzini avesse ancora in cuore le parole, scritte nel lontano 1831 al sovrano Carlo Alberto , piene di appassionata fede e simbolo di indomito animo: “Non v’è carriera più santa al mondo di quella del cospiratore che si costituisce giudice dell’umanità, interprete delle leggi eterne della natura.”
SINTESI DEL PENSIERO
Come molto acutamente è stato osservato, «le concezioni di Rosmini e Gioberti sono dominate dall’idea di tradizione; il pensiero di Mazzini è dominato dall’idea di progresso. Ma l’apparente antitesi delle due concezioni, e l’aspra polemica che su di essa s’impernia, non riescono a celare la loro identità d’ispirazione: il progresso stesso è la tradizione ininterrotta del genere umano, come la tradizione non è che il suo progresso incessante. Tuttavia accentuare, come fa Mazzini, il concetto di progresso implica una differenza importante dal punto di vista pratico-politico; giacché significa far servire l’idea della tradizione al fine della trasformazione della società e delle istituzioni anzicché al fine della loro conservazione» (N. Abbagnano). Giuseppe Mazzini (1805-1872) è stato definito appunto «apostolo di una nuova era», nuova sia dal punto di vista storico-politico che da quello religioso. Su quali presupposti filosofici egli fonda il suo ideale? «Dio è Dio e l’umanità è il suo profeta». Tra Dio e l’umanità non c’è abisso: l’umanità è l’«incarnazione» di Dio, incarnazione continua, incessante. Essa, nel suo sviluppo, manifesta e compie la legge di Dio, la legge divina del progresso storico, al di là degli obiettivi immediati delle volontà individuali. Essa, insomma, è la vera «testimone» di Dio e «la sola interprete della legge di Dio sulla terra». La Storia, pertanto, non è solo storia umana, ma anche, e soprattutto, storia divina: è il progressivo compimento del regno di Dio sulla terra attraverso l’opera dell’uomo. Il compito dell’uomo, pertanto, è di secondare consapevolmente l’azione che attraverso di lui la Divina Provvidenza attua nel corso degli eventi. Come può l’uomo attingere la verità, cioè conoscere la direzione, individuare gli obiettivi della sua azione? Ricorrendo alla «coscienza» e alla «tradizione». Infatti nella coscienza si può cogliere la volontà divina e nella tradizione si può riscontrare già il suo parziale compimento. Esse sono quindi i soli criteri per la verità, purché usati in modo coordinato: infatti la coscienza individuale, isolata in se stessa, porta all’anarchia, mentre la tradizione, da sola, induce all’immobilismo e al dispotismo. E che cosa indicano coscienza e tradizione? La Rivoluzione Francese ha concluso quel moto storico verso l’affermazione dei «diritti dell’uomo» in quanto individuo. L’epoca post-rivoluzionaria apre ora il discorso, secondo il Mazzini; dei «doveri dell’uomo» cioè quelli connessi al fatto che l’individuo, reso ormai sovrano, per progredire ulteriormente deve «aprire» la sua esistenza, allargare il suo essere fino ad identificarsi con la realtà mistica dell’umanità. Se dunque finora egli ha conquistato la sua libertà, ora deve lottare per la «libertà» e per il «progresso» dell’Umanità. Ciò egli può fare agendo all’interno delle «sfere» della «famiglia» e della «nazione», entro cui solo l’individuo può perseguire «il perfezionamento morale di se stesso e d’altrui», o, per dirla in modo diverso, «il perfezionamento di se stesso attraverso gli altri e per gli altri» Chi concepisca la vita in tal modo, sentirà evidentemente d’avere una missione da svolgere. «La vita è una missione»; essa dev’essere guidata da una sola legge, quella del «dovere», che indica, quale scopo degli individui come dei popoli, l’impegno costante al loro riscatto da ogni schiavitú, alla realizzazione cioè della libertà, con la quale si compie il progresso dell’umanità verso una nuova società umana che realizzi in sé il Regno di Dio. La costituzione dell’unità politica dell’Italia è per Mazzini, dunque, un dovere «religioso», un obiettivo prossimo perché gli italiani vivano come nazione, superando ogni oppressione e divisione e realizzando la loro libertà; ossia è una tappa imprescindibile nel cammino verso la realizzazione dell’Umanità. Bisogna che gli individui rinuncino alla loro sovranità per riconoscersi in quella della Nazione, realtà super-individuale che sola può dare senso e direzione «superiore» all’azione individuale. Il vero sovrano dunque deve essere il Popolo, che, in quanto realtà collettiva, è il luogo d’azione della forza della Provvidenza con cui Dio guida e regola il corso del mondo. Solo identificandosi col Popolo l’individuo acquista coscienza del Fine religioso della storia, e del compito che egli, insieme agli altri, ha da realizzare concretamente, in un dato momento storico, per l’attuazione di quel Fine. In quanto caratterizzato da un compito «religioso» il Popolo è realtà religiosa. E lo Stato, ossia la sua organizzazione politica, non può non avere una funzione religiosa. Una politica senza una religione è un assurdo. Sicché assurdo è il concetto di Stato laico, o addirittura di Stato ateo. Lo Stato deve infatti assumersi l’onere di unificare il Popolo intorno alla sua missione e di promuovere cosí l’educazione progressiva verso la perfezione individuale e collettiva. In tal senso esso deve essere una Chiesa. Dati questi presupposti, era inevitabile che Mazzini si opponesse alla visione materialistica della storia quale delineata da Marx e da Engels, e contestasse l’azione della Prima Internazionale. Quella visione, a suo giudizio, negava proprio i tre elementi fondamentali della sua concezione: Dio, patria e proprietà. Senza Dio, l’umanità, a suo giudizio, procederebbe senza una legge, e pertanto non potrebbe attuare alcun progresso; i popoli non avrebbero un disegno complessivo in cui inscrivere la loro opera, e gli individui sarebbero abbandonati ai loro impulsi sensibili, che sono variabili e incoerenti, preda del loro arbitrio, fiduciosi solo nella loro forza, e senza timore per alcuna sanzione. Negare la patria, poi, significherebbe privarsi di un imprescindibile «punto d’appoggio» per il compimento del progresso, per il perfezionamento dell’uomo. Senza patria non v’è modo di rendere concreto il progresso, di assumerlo come fine individuale e collettivo. Sopprimere infine la proprietà individuale implicherebbe estinguere ogni incentivo alla produzione. L’uomo tenderebbe solo alla sua sopravvivenza, e non mirerebbe al suo benessere, né a quello della collettività in cui vive. La proprietà, sostiene Mazzini, è legittimata dal lavoro che la produce; essa è «il segno visibile della nostra parte nella trasformazione del mondo materiale, come le nostre idee, i nostri diritti di libertà e di inviolabilità della coscienza, sono il segno della nostra parte nella trasformazione del mondo morale». Se la società capitalistica, fondata sulla proprietà, ha prodotto e produce danni all’umanità, non per questo la proprietà perde il carattere di elemento stimolatore del progresso. La stortura delle società capitalistiche sta nel fatto che la proprietà è privilegio di pochi; camminare sulla via del progresso, allora, significa renderla sempre piú accessibile a un numero sempre maggiore di uomini attraverso il lavoro che essi compiono. Anche con Mazzini dunque si compie il recupero della tradizione spiritualistica italiana; anche per lui esso diventa il fondamento ideale per una visione complessiva della storia in cui si inscriva l’impegno politico dell’uomo dei suoi tempi per la soluzione, in senso «rivoluzionario», dei problemi da cui erano afflitte l’Italia e l’intera Europa. Per lui, quindi, la tradizione religiosa offre la base salda per l’unificazione e il progresso della società, delle nazioni e dell’umanità intera. L’uomo nuovo sarà, allora, l’uomo cosciente del suo destino e del suo compito; cioè sarà un uomo che si fa strumento consapevole – ma nel segno del progresso, non della conservazione – del disegno provvidenziale di Dio, trascendente-immanente.
I DOVERI DELL’UOMO
E’ inutile avvertire che in molte parti, i “DOVERI DELL’UOMO” sono stati superati dai tempi; tuttavia molte cose che al tempo in cui Mazzini scriveva sembravano arditi sogni, coloriti di generosa utopia, si sono poi verificati e sono state le maggiori conquiste non solo per l’Italia ma per tutto il genere umano. Ma il problema dell’educazione del popolo resta ancora intatto. La scuola materialista contro la quale insorse Mazzini, seguita a tentare la conquista delle masse premendo sull’instaurazione d’una società con una gioia fittizia, una bellezza superficiale, un’ amore epidermico, un individualismo senza freni; è per questo che i DOVERI DELL’UOMO sono ancora opera viva. E politicamente, direi ancora attuale, se siamo rimasti attenti alle ultime vicende geopolitiche. Opera a molti sconosciuta, rintracciandone una rarissima copia, credo di fare cosa gradita pubblicandola integralmente. E’ un’opera sconosciuta a molti, ma non ignorata da grandi statisti. Tanto W. T. Wilson e George Lloyd George, quanto molti leaders post-coloniali, tra i quali Gandhi , Golda Meir , David Ben Gurion , Nehru e Sun Yat-sen , hanno considerato Giuseppe Mazzini il proprio Maestro e “I DOVERI DELL’UOMO” la propria Bibbia morale, etica e politica. Mazzini, teorizzando l’integrazione fra le nazioni europee in un’ottica democratica e riformista giunge con quasi un secolo d’anticipo ad affermare ciò che grandi europeisti, quali Altiero Spinelli , Ugo La Malfa , Umberto Terracini e Giorgio Amendola, alla fine del II conflitto mondiale che aveva sconvolto le coscienze di milioni di europei che negli anni ’50 si interrogheranno se la nuova Europa dovesse divenire finalmente quel luogo politico e culturale in cui svelenire gli odi nazionalisti nell’ottica dell’interesse comune di pace e di prosperità, oppure se dovesse essere il baluardo avanzato della guerra fredda. (“contro chi?” – “ancora contro se stessa?”- La risposta la lasciamo all’attento lettore).
Mazzini subordinava il concetto di Patria a quello più ampio di Umanità, auspicando che il concetto di “NAZIONE” sarebbe stato superato a favore di una “FEDERAZIONE” fra i popoli europei che, da un lato, avrebbe permesso la rimozione delle tensioni internazionali sanando le ferite nazionaliste e, dall’altro, avrebbe permesso lo sviluppo anche dei popoli più poveri. La nazioni sarebbero dovute giungere a questo nuovo assetto geopolitico spinte dalla comprensione della “LEGGE MORALE” a cui tutte sono soggette. Il pensatore democratico intravedeva già negli anni 1830 come la vecchia idea d’Europa, nata a Vienna nel 1914, non potesse reggere al progredire impetuoso della Storia. In tale considerazione vi è una consonanza con il filosofo tedesco Hegel che, nel 1831, affermava che in breve tempo l’Europa avrebbe ceduto il primato agli Stati Uniti. (e non era presente nella I e nella II guerra mondiale). Ma contrariamente ad Hegel, che intendeva le nazioni in una naturale e reciproca competizione, Mazzini le considerava necessariamente cooperanti in nome dell’Umanità di cui ogni singola nazione è parzialmente manifestazione. Le tensioni internazionali non hanno per nulla sanato le ferite; e la federazione sta fallendo proprio davanti a quel primato paventato da Hegel. Fu d’ispirazione mazziniana, nell’interpretazione data da Piero Calamandrei nel suo “Discorso sulla Costituzione Italiana”, pronunciato a Milano nel 1955, l’ARTICOLO 2 della medesima Costituzione del 1948 in cui si afferma: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa della libertà di offesa degli altri popoli”. E sempre di Calamandrei è un nobile e virtuoso parallelismo tra l’Assemblea Costituente romana del 1848 e quella italiana del 1948. Mazzini, esattamente cento anni prima, nel 1848, guidò la Repubblica Romana che è il momento maggiormente rappresentativo delle sue capacità amministrative e la cui Costituzione assume, anche nell’interpretazione di Giovanni Spadolini, il ruolo di anticipatrice delle moderne Costituzioni democratiche europee oltre che di quella Italiana. Infatti, molti sono i punti in comune tra la Costituzione della Repubblica romana del 1848 e la Costituzione italiana del 1948. Per entrambe la “sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione” (art. 1), evitando così di contrapporre il popolo sovrano alle legittime assemblee da esso elette. Il parallelo continua per quanto riguarda gli artt. 3, 6, 7, 8 della Costituzione mazziniana e gli artt. 13, 14, 8, 21 della Costituzione italiana. Infatti, in tutti questi articoli si affermano, negli stessi termini, i diritti inviolabili della libertà d’insegnamento, dell’inviolabilità del domicilio e dell’abolizione della pena di morte.
CARLO CATTANEO

BIOGRAFIA
Nacque il 15 giugno 1801 in Milano e morì il 6 febbraio 1869 in Castagnola, presso Lugano. Studioso di problemi economici, sociali, discepolo di Gian Domenico Romagnosi, ispirò la sua attività al proposito di promuovere gradualmente, attraverso il progresso scientifico, l’evoluzione politica dell’Italia. Così egli si adoperò assiduamente per realizzare un miglioramento delle condizioni economiche e sociali del Lombardo-Veneto al fine di assicurarne l’autonomia in seno all’Impero asburgico. Un analogo processo di sviluppo politico nelle altre parti d’Italia avrebbe dovuto condurre, infine, alla formazione di una federazione italiana indipendente. Di formazione e di cultura positivista, nutrì un’assoluta fiducia nel progresso tecnico-scientifico come mezzo di elevazione materiale e morale dei popoli. Lasciò numerosi scritti, spesso frammentari. Le opere più famose sono Notizie naturali e civili su la Lombardia (1844) e Dell’insurrezione di Milano nel 1848 e della successiva guerra (1849). La vicenda pubblica di Cattaneo comincia nel 1820 quando fu nominato professore di grammatica latina e poi di umanità nel ginnasio comunale Santa Marta. Seguiva ogni tanto la scuola privata di Gian Domenico Romagnosi e si laureò in diritto presso l’Università di Pavia nel 1824. Nel 1835 lasciò l’insegnamento (e si sposò); da quel momento svolse l’attività di scrittore, occupandosi di ferrovie, di bonifiche, di dazi, di commerci, di agricoltura, di finanze, di opere pubbliche, di beneficenza, di questioni penitenziarie, di geografia, ecc., insinuando tra questi argomenti anche qualcuno di quelli che “hanno viscere”, com’egli diceva, di letteratura ed arte, di linguistica e di storia, di filosofia. Richiesto nel 1837 dal governo britannico, scrisse sulla politica inglese in India e sui sistemi di irrigazione applicabili all’Irlanda. La sua attività di pubblicista cominciò ben presto a procurargli dei problemi con il governo austriaco di Milano. Lui che s’era tenuto estraneo a sette e congiure e che aveva cercato con la sua opera di accrescere il prestigio e il decoro e di elevare nell’animo dei cittadini la coscienza dei loro diritti, si trovò, in breve, a causa della sua idea di conquista graduale di riforme politiche e civili che ridessero al Lombardo-Veneto l’indipendenza, ad essere bersaglio della diffidenza dell’Austria. In verità Cattaneo, oltre ad aver serratamente criticato il programma di Gioberti, non fu contrario a lasciare l’Austria nel Lombardo-Veneto, a patto che concedesse riforme liberali. L’obbiettivo principale del suo programma – che precisò meglio solo dopo il 1848 – era la fondazione di tante repubbliche da unire in una Federazione. Non era favorevole, a differenza di Mazzini, ad una Repubblica unitaria; temeva che l’accentramento avrebbe sacrificato l’autonomia dei Comuni, delle regioni e delle zone più povere, soprattutto il Mezzogiorno. Il raggiungimento di una vera libertà e di una reale indipendenza era possibile, secondo lo storico ed economista milanese, solo attraverso l’educazione delle masse lavoratrici e l’eliminazione delle grandi ingiustizie sociali, delle troppo marcate differenze tra ricchi e poveri. Al problema politico Cattaneo abbinava cioè anche la questione sociale.
Il dibattito si allargava coinvolgendo nuovi gruppi, più vasti settori di opinione pubblica: solo nel 1848, tuttavia, fu possibile fare il primo decisivo passo avanti sulla via dell’unità e dell’indipendenza. Le Cinque Giornate trovarono in lui un leader naturale: nei tre giorni dal 19 al 21, Cattaneo fu Capo del Consiglio di guerra, non mercanteggiando con nessuno ma teso solamente alla vittoria. Il suo motto era “A guerra vinta”. Prevalsi però gli avversari politici, angosciato per gli eventi, lasciò Milano nell’agosto di quell’anno e si recò a Parigi.
Nel 1859, pur lieto della guerra, non volle, tenacemente fermo nelle sue idee federali, partecipare al nuovo ordine economico delle cose e tornò a Milano il 25 agosto esclusivamente per parlare di filosofia. Sul finire di quell’anno fece risorgere il Politecnico, un importante strumento utilizzato come “difensore” d’ogni progresso materiale e morale del paese; lo lascerà nel 1864.
Nel 1860 fu a Napoli con Garibaldi, ma se ne allontanò quando vide la impossibilità di imporre la soluzione federalista. Eletto più volte deputato, non andò in Parlamento per non prestare giuramento alla corona. Eletto deputato a Sarnico, Cremona, e nel V collegio di Milano, optò per questo ma non entrò mai in Parlamento, non volendo prestare giuramento contro la sua fede repubblicana. Abbandonò anche, nel 1865, con atto di fiera onestà, la cattedra di filosofia al liceo di Lugano, unica sua risorsa economica. Nel marzo del 1867 fu rieletto deputato a Massafra e al I collegio di Milano: optò per la città natale, fu più volte al Parlamento di Firenze, ma non seppe mai piegarsi ad un giuramento formale.
IL PENSIERO
Carlo Cattaneo (1801-1869), milanese, presente nel movimento risorgimentale col suo programma democratico repubblicano e federalista, fondatore e direttore del “Politecnico”, fu autore di alcuni scritti filosofici di notevole interesse, tra i quali ricordiamo Considerazioni sul principio della filosofia (1844) e Psicologia delle menti associate (1859-1866).
Quest’ultima opera era del tutto nuova e originale nel contesto storico-culturale italiano, in quanto prima teorizzazione di una psicologia sociale che, a suo avviso, poteva spiegare il passato – illuminando come i rapporti tra le menti degli uomini avevano prodotto quel progressivo incivilimento che contrassegna lo sviluppo storico – e poteva costituire uno strumento scientifico per la futura organizzazione delle società umane.
Studioso attento di molte scienze (ad esempio di quella economica, di quella storica, di quella giuridica); fu – contro l’arroganza di una filosofia, quella spiritualistica, che si alimenta di problemi praticamente insolubili, che procede con scorrette dimostrazioni, e soprattutto è grande “sprezzatrice delle scienze” – un difensore accanito del metodo e dei risultati scientifici, invitando inequivocabilmente i giovani, in pieno clima di restaurazione spiritualistica, a dedicarsi ai “faticosi studi positivi”, in quanto – affermava – solo “le discipline sperimentali” costituiscono “la potenza e la gloria delle moderne nazioni”.
È convinzione generale, dice Cattaneo, che il progresso storico è determinato dal progresso della conoscenza dell’uomo, che l’incivilimento è prodotto dal pensiero umano. Ma quando s’indaga sul pensiero, sull’attività della mente, si cade comunemente nei discorsi astratti sulla Coscienza, sull’Io, sulle facoltà dello Spirito.
Se s’inverte il procedimento di studio, cioè se si abbandona il passaggio dal pensiero ai suoi prodotti, e si muove dai prodotti a ciò che ne è l’origine, allora si scoprono cose interessanti. Ad esempio il ruolo dell’istinto nella generazione delle idee.
Vi sono entro di noi certe forze alle quali noi non abbiamo assegnato parte veruna nell’origine delle nostre idee, e le quali anzi si considerano come estranie all’intelletto; e tuttavia se scrutiamo i fatti, troviamo essere state coefficienti potentissimi d’ogni nostro lavoro scientifico.
Considerate l’istinto. L’istinto è la facultà di compiere certi atti senza previa cognizione. L’istinto è l’azione senza l’idea. È una facultà che perciò appunto può dirsi estranea all’intelletto. Eppure molti delli istinti nostri non possono dirsi superflui ed indifferenti alla complessiva elaborazione del nostro sapere.
(Psicologia delle menti associate)
Allora, la scienza non è il frutto anche dell’istinto sociale, con cui un uomo si lega all’altro, anche ad un altro vissuto in tempi passati?
All’elaborazione della scienza non basterebbero, dunque, tutte le facultà dell’intelletto, se l’uomo non fosse già per istinto di natura un essere socievole. Ecco, dunque, l’istinto entrare nell’opera scientifica come un necessario coefficiente. E v’entrano altri istinti. V’entra quel bisogno di comunicare altrui i propri sentimenti e pensieri… Quindi lo spontaneo sforzo d’imparar la parola e di formarla: lavoro che noi andiamo proseguendo coll’imporre un nuovo vocabolo ad ogni nuova scoperta.
V’entra quello dell’imitazione… che è di supremo momento, non solo alla formazione della parola, ma in tutte le arti. E questo medesimo istinto imitativo, combinato ad altri, ci spiega il fatto della tradizione domestica e della tradizione scientifica, onde proviene l’associazione delli avi ai posteri, dei maestri alli allievi, e la perpetua successione nell’immortale opera del sapere. E vi sono altri istinti che possono svolgersi solamente in seno alla società. E son quelli che la scôla scozzese chiama istinti morali e che altre scôle preferiscono chiamare piuttosto col nome di sentimenti. Tale è la credulità, l’adesione all’amicizia e all’autorità, l’amor della lode, il terror dell’infamia.
(Psicologia delle menti associate)
Dunque, se ad esempio c’è stato un progresso nella considerazione dell’acqua da Talete a Lavoisier, è perché nei ventiquattro secoli trascorsi il lavoro di analisi degli antichi Greci è passato agli Arabi e da questi ai moderni, che, piú attrezzati sul piano dell’indagine analitica, hanno scoperto una verità di livello piú profondo.
La scoperta dei componenti dell’acqua era un ultimo gradino in una lunga scala dei pensieri, a edificar la quale avevano collaborato molte generazioni. Essa non era l’opera delle facultà solitarie di un uomo, bensí quella delle facultà associate di piú individui e di piú nazioni.
(Psicologia delle menti associate)
Pertanto lo studio dell’uomo, del pensiero dell’uomo, come quello della civiltà, dev’essere concepito come studio delle analisi delle menti associate.
Per analisi delle menti associate, intendo dire quelle grandi analisi le quali si vennero continuando per collaborazione, talora mutuamente ignote, di piú pensatori in diversi luoghi e tempi e modi, e con diversi fini e diverse condizioni e preparazioni.
(Psicologia delle menti associate)
Si consideri quest’esempio. L’uomo comune, come l’uomo primitivo, contempla la luna e ne segue le variazioni nel tempo. Ma quando la si osserva col telescopio, si compie un atto di analisi, cioè “un atto con cui la mente distingue le parti di un tutto”. Ma – è qui il punto –
l’occhio non poteva trovarsi armato (del telescopio) e guidato, se non in virtú di una lenta preparazione della vita sociale. Quell’atto è l’ultima risultanza del lavoro delli avi e dei posteri: essa è l’opera di piú generazioni associate.
(Psicologia delle menti associate)
Tuttavia capita che in uno stesso tempo una nazione vede analiticamente piú cose, un’altra compie meno progressi, o addirittura conserva un modo primitivo di vedere. Ciò avviene proprio perché la conoscenza analitica è sempre un prodotto sociale. Là dove la società è meno progredita, anche l’analisi, che come funzione primitiva è propria e tutta intera di ogni individuo, in quanto modo d’osservazione scientifica è meno progredita, e dà risultati meno perfetti e meno compiuti che altrove. Infatti son le condizioni sociali che sollecitano oppure inibiscono l’attenzione analitica su certi fenomeni.
Il livello culturale di una nazione non dipende tanto dalla qualità delle scoperte, quanto dalla qualità e quantità delle ricerche. E queste, in certe società, non sono “libere”, come non lo erano in certe antiche nazioni, in cui “molte cose erano inaccessibili, molte parvero funeste ed empie”.
Questo discorso sulle componenti sociali che determinano la ricerca scientifica apre poi un’altra serie di problemi su cui indagare. Infatti, posto che “l’atto piú sociale delli uomini è il pensiero”, poiché congiunge “sovente in un’idea molte genti fra loro ignote e molte generazioni”, bisognerebbe studiare “come e donde in seno a quell’istintiva e spontanea associazione delle menti possa l’analisi attingere una piú eccelsa iniziativa” e “come ora espanda, ora costringa, la sua libera attività”.
Ma soprattutto,
dacché questa facultà deve considerarsi come essenziale all’intelletto, giova studiare come, ciò non ostante, la libera analisi non abbia potuto attuarsi in tutto il genere umano. Giova studiare come, presso molti popoli, le forze analitiche, dopo una rapida emancipazione, abbiano potuto ricadere in lunga servitú; come nessuna nazione abbia saputo finora serbare continuamente vivo e libero il corso dei suoi pensieri; come molte nazioni siano spante, quasi meteore, senza lasciare eredità di un’idea; come ogni società, senza avvedersi, prefigga a se stessa i limiti della sua sfera d’analisi; come noi medesimi, che qui ci aduniamo in nome della scienza viva, non tutti ancora possiamo, sciolti da ogni precedente nostro od altrui, stendere egualmente la mano a tutti i rami dell’arbore scientifico. La libera analisi è uno dei piú grandi interessi morali e materiali del genere umano. La filosofia deve proporsi uno studio fondamentale: l’analisi della libera analisi.
(Psicologia delle menti associate)
Si consideri dunque “l’analisi per sé, com’essa proceda tanto nell’individuo quanto nelle menti associate”. Essa è un andare in profondità, un cogliere evidenze piú nascoste; ma non separandole dal tutto; anzi queste conoscenze piú profonde servono per chiarire il tutto.
Andare in profondità significa pure riuscire a scoprire la legge che unifica fatti apparentemente sconnessi e incomponibili, come appare manifesto
quando l’analisi ha quella veste astratta e universale che le danno le formule algebriche. Poiché quella veste commune rende comparabili fra loro anche concetti che a prima vista potevano apparir privi d’ogni intima relazione. E cosí nella confusione del superficiale e del vario, la mente può discernere l’identico, il costante, l’essenziale, il certo.
(Psicologia delle menti associate)
Analisi significa insomma superare l’incanto dell’evidenza immediata, “procedere dalle cose piú ovvie ed evidenti alle piú astruse”; significa cioè scoprire, dietro e al di là di ciò che ci è immediatamente noto, qualcosa d’ignoto.
Il suo metodo specifico è quello dell’astrazione. Il che significa anche che “ogni piú sottile astrazione è sempre opera d’analisi”.
Sicché, in sintesi:
Un’analisi può dirsi intera, quando con certa equabile profondità si estende a tutto un certo campo di osservazione; cioè a un dato essere o fenomeno, o complesso di esseri o fenomeni, e a tutte le loro parti, qualità e relazioni, entro quella misura e secondo quel fine che l’osservatore si prefigge.
(Psicologia delle menti associate)
Ma qui è il problema, per cui è insufficiente il discorso dell’analisi “in sé”. Su quale base l’osservatore stabilisce la misura, il limite, l’oggetto dell’analisi? È egli libero, incondizionato, nel determinare queste cose? No. Egli è limitato e guidato dalle condizioni naturali e da quelle sociali, come l’esame delle condizioni umane primitive dimostra.
Cosí è. Alle evoluzioni della potenza analitica hanno parte la natura e la società. E come sono esse le cause che la destano, cosí sono parimenti le cause che possono renderla perpetuamente inerte.
(Psicologia delle menti associate)
La natura anzitutto:
La natura aveva già stabilito fra una gente e l’altra una disparità di condizioni, secondo la disparità delle cose utili o nocive e dei luoghi e dei climi. Le singole genti nelle loro singole patrie non potevano avvedersi se non di ciò che ella vi avesse posto. La presenza di certi frutti ovviamente alimentari e di certi animali o piú mansueti o piú feroci, il complesso d’una terra o d’un clima, d’una flora e d’una fauna, dettavano adunque agli aborigeni una serie di atti di attenzione coordinata alla serie delle piú immediate necessità; e tanto quivi inevitabile quanto impossibile altrove. E cosí gli aborigeni dovevano costituire nelle singole regioni native le singole parti d’una superficiale analisi dispersa a frammenti su tutta la terra abitata. La rimanente natura giacque inosservata e indistinta. Era pel genere umano come s’ella non fosse.
(Psicologia delle menti associate)
Quindi la società.
Quanto alla società, comunque isolata e misera, questi singoli frammenti d’osservazione dovevano nel suo seno sopravvivere all’individuo. Ciò che l’infante, per necessità di convivenza e per cieca imitazione apprendeva, doveva apparire come l’ordine necessario, ed unico possibile della vita. Cosí nasceva la tradizione, involontaria, spontanea, irriflessiva ma imperiosa già fin da allora com’essa è tuttavia per noi L’analisi non era libera. Ogni individuo non era piú costretto a cominciare da sé tutta la serie di quelle scoperte. Ma ogni mente entrava nella carriera del pensiero già impronta del pensiero altrui. L’analisi, nata serva della natura, crebbe serva della società
(Psicologia delle menti associate)
E sempre natura e società condizionano l’analisi, anche quando un individuo, un “genio”, spesso “per caso”, scopre un'”idea madre” che diventa l’origine di una nuova scienza, e l’analisi diventa “libera”, va “oltre la tradizione e contro la tradizione”, come nel caso di colui che cadendo in un fiume, si salvò appoggiandosi per istinto ad un tronco galleggiante e percepí l’idea madre dell’arte nautica, “vedendo nelle cose ciò che li altri non videro”. Cosí il genio individuale e il caso spiegano “come le nazioni abbiano potuto raggiungere un’idea forse piú astrusa, senza averne potuto percepire un’altra forse piú ovvia”, e come l’analisi in certe nazioni si diversifichi per qualità e risultati da quella di altre nazioni; ma sempre nel contesto dei condizionamenti specifici di natura e società di un certo popolo. Il pensiero dunque dev’essere studiato come fenomeno sociale. Assurdo è parlare, come fa Cartesio, di un puro e nudo spirito, fuori della tradizione e della società. Locke “dimostrò come la riflessione ne’ suoi piú alti sforzi ricevesse sussidio dal linguaggio. Or voi mi concederete, signori, che il linguaggio è la società”. “Ma la società coopera al pensiero dell’individuo in molti altri modi oltre il linguaggio”. Ad esempio: il pensiero s’alimenta col rapporto dialettico di opposizione degli spiriti che solo gli uomini viventi in relazione sociale possono realizzare. Tutte le piú alte prove della scienza e della virtú si svolgono negli accordi e disaccordi degli uomini posti fra loro in intima relazione. Ciò hanno mostrato Vico ed Hegel. È nelle famiglie, nelle classi, nei popoli che si attua quella “antitesi delle menti associate” che è “quell’atto col quale uno o piú individui, nello sforzarsi a negare un’idea, vengono a percepire una nuova idea, ovvero quell’atto col quale uno o piú individui, nel percepire una nuova idea, vengono, anche inconsciamente, a negare un’altra idea”. È nel rapporto sociale che nascono quelle passioni che originano i ragionamenti (“Nei conflitti della vita, il ragionamento è l’arte reciproca di tutte le passioni”); è in questo rapporto che i “ragionatori”, “al cospetto della passione”, diventano “combattenti” in una lotta che “trascina ambe parti nel vortice della verità”, in una lotta che non è altro che un processo comune di analisi, un'”analisi delle menti associate”.
Ma tale dialettica delle menti deve esser tenuta sempre viva anche nei confronti del pensiero degli uomini del passato; bisogna verificarsi con essi perché solo cosí si evita la “chiusura nel proprio sistema”, e si genera il processo di arricchimento della verità. L’uomo, infatti, tende al “sistema” per necessità, cioè “perché vive in presenza di un unico universo, per la limitata natura del suo intelletto, e per l’unità della sua coscienza, e per l’identità delli universali, e per complessivo effetto di tutte le operazioni riflessive”. Ma non deve assolutizzare il suo sistema, come non deve assolutizzare quello ricevuto dagli antenati: “miseri i figli che temono d’essere migliori dei loro padri; le dottrine piú audaci sono ridutte dal tempo ad aride regole, a formule viete, a consuetudini stupide e servili”. “I sistemi – dice Cattaneo – devono tenersi sempre aperti, un sistema compiuto e chiuso diviene sepolcro dell’intelligenza e della virtú che lo ha tessuto”. Bisogna dunque “agitare e rinnovare i sistemi”, “scuotere ogni giogo d’autorità”, “seguendo risolutamente e impavidamente l’unico lume dell’esperienza e della ragione”. Solo cosí si attua il progresso della civiltà: “Il progresso, nella proporzione medesima con cui fornisce nuove idee, fornisce anche nuova occupazione all’intelletto, tiene in esercizio forzoso le nostre facultà morali e le spinge a continuo perfezionamento”.
GIUSEPPE FERRARI

LA VITA
Giuseppe Ferrari nacque a Milano il 7 marzo 1811 e si spense a Roma nella notte tra l’1 e il 2 luglio 1876. Prima avvocato, passò poi completamente agli studi filosofici, considerando come proprio maestro Romagnosi. Per alcuni anni studiò Vico, delle cui opere fu anche editore; spirito irrequieto, proteso verso l’azione, le lotte e i contrasti ideali, Ferrari trovò in Francia, ove si recò nel 1838, un ambiente consono al suo spirito. Il pensiero e l’atteggiamento politico di Ferrari ruotavano attorno al principio di libertà ed uguaglianza sociale e all’idea di federalismo repubblicano e democratico come unica forma di soluzione del problema italiano del Risorgimento. Il federalismo per Ferrari si doveva manifestare nell’assetto da dare all’Italia libera, ma per raggiungere questo era necessario che vi fosse un’unione rivoluzionaria. Egli fu però contrario al principio dell'”Italia farà da sè”, perché ritenne necessario l’intervento francese in Italia: le delusioni del 1848 esasperarono le sue idee federaliste, repubblicane e radicali e dal 1852 al 1859 si raccolse negli studi. Nel problema dei rapporti tra Stato e Chiesa, come non partecipò dell’entusiasmo per Pio IX, così non approvò né la formula di Cavour, né il pensiero di Mazzini, e auspicava una completa indipendenza del moderno stato italiano da ogni legame religioso. Non fu nemmeno un uomo di governo; ebbe però un grande interesse per la vita politica, così che rientrato in Italia nel 1859 ed eletto deputato per il collegio di Luino, partecipò per molti anni ai dibattiti parlamentari. Sedeva sui banchi della sinistra, in realtà fu un isolato della tenace idea del federalismo. Cavour, Minghetti, Crispi, riconoscendone il valore e l’onesta sincerità lo stimavano, ma in fondo vedevano in lui il superstite di una corrente politica sconfitta. Fu però favorevole a una Roma capitale e, nonostante il suo federalismo, votò per la convenzione di Settembre; nel maggio del 1873 propose che la soppressione delle corporazioni non si restringesse entro i confini della legge. Prese parte soprattutto alle discussioni economiche, sociali ed amministrative e i meriti scientifici di Ferrari ottennero ampi riconoscimenti ufficiali: ebbe una cattedra universitaria a Milano e tenne corsi liberi a Torino e a Pisa.
IL PENSIERO
Echi non irrilevanti ebbero le tematiche dei positivisti francesi nel pensiero di Giuseppe Ferrari (1811-1876), filosofo e pensatore politico, costretto ad un ventennale esilio appunto in Francia, e divenuto, dopo il rientro in Italia in seguito alla proclamazione del Regno, deputato e docente all’Università di Milano. Della sua ricca produzione culturale sono da ricordare gli scritti Filosofia della rivoluzione (1851), Corso sugli scrittori politici italiani (1862), Prolusione al corso di filosofia della storia (1862), Teoria dei periodi politici (1874), Saggio sul principio e sui limiti della filosofia della storia (1843). L’umanità – egli sostiene in tono positivistico – passata attraverso l’età della religione e quella della metafisica, ha compiuto, con la Rivoluzione Francese, il passo decisivo verso l’«età della rivoluzione». La filosofia ha il compito dunque di spazzar via il rigurgito di spiritualismo, verificatosi dopo gli eventi rivoluzionari francesi, e le nostalgie dell’astrattismo logico, per affermare l’insostituibilità del «fatto positivo» nella formazione della conoscenza e nell’organizzazione sociale. Deve sostituire la «rivelazione naturale», cioè l’osservazione empirica dei fatti, alla «rivelazione religiosa», aprendo cosí la strada al definitivo predominio della scienza in una società fondata sull’uguaglianza, sul socialismo e sulla democrazia; in una società in cui non vi siano piú chiese né religione, e in cui non sussista piú la sovranità della proprietà privata, difesa con vigore dai borghesi e produttrice di squilibri e disuguaglianze sociali. Da questi elementi si evince come, accanto a quella esercitata dal positivismo, fu decisiva su Ferrari l’influenza del socialismo utopistico, in particolare quello di Proudhon (col quale fu in rapporti). Primo editore delle opere di Giambattista Vico, Ferrari fu il primo pensatore a considerare sensu stricto la storia come scienza. La Rivoluzione francese – nota Ferrari – è rimasta incompiuta: per farla proseguire, occorre tener saldo, contro ogni forma di spiritualismo, il presupposto del sensismo illuministico, secondo il quale la base della certezza sta nei fatti, ovvero in ciò che si vede e si sente. Sicché un pensiero che si proponga di travalicare il dominio dei fatti, è per ciò stesso illegittimo, giacché si trasforma in una “logica” astratta, disancorata dall’esperienza e dunque tale da produrre errori e da indurre a credere che ciò che appare ai sensi sia solo parvenza. Proprio in ciò è racchiusa la genesi delle erronee costruzioni metafisiche. Il puro pensiero genera contraddizioni, ma ciò è semplicemente il segno della sua incapacità di cogliere la realtà e la vita, che è movimento e individualità. Se ne deve allora trarre la conseguenza che “poiché la ragione non afferra la vita, tanto peggio per la ragione”. Il programma di Ferrari si risolve allora in un tentativo di “riconquistare il fatto”, subordinando il pensiero all’esperienza. Alla rivelazione divina, egli contrappone la rivelazione naturale, la quale consiste nell’intuizione diretta dei fatti: essa ci rivela la nostra vita e, insieme, quella degli altri. La verità sta nell’istinto che ci guida e ci governa, noi non siamo mai del tutto consapevoli del nostro operare: si tratta allora di vivere come se ci fosse un fine. Ferrari è convinto che l’umanità cammini lungo la strada di un progresso inarrestabile orientato verso l’epoca della rivoluzione, che sarà caratterizzata dall’instaurazione del dominio della scienza e dell’uguaglianza. Essa procederà oltre le conquiste della rivoluzione francese, eliminando le chiese, riequilibrando le ricchezze e stabilendo una democrazia egualitaria. Mediante la scienza, sarà possibile sopperire ai bisogni del proletariato, liberandolo dalla fame e dalle malattie e provvedendo alla sua educazione. Il governo stesso si dovrà ridurre all’amministrazione di un popolo, che si organizzerà attraverso libere associazioni. In queste conclusioni, il pensiero elaborato da Ferrari è assai vicino a quello di Proudhon.
FERDINAND TÖNNIES
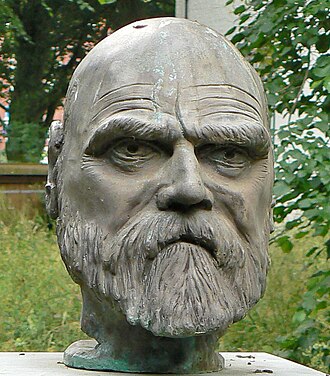
Se nella cultura francese e inglese il modello positivistico di marca comteana e spenceriana aveva diffusamente influenzato lo sviluppo della sociologia e delle altre "scienze sociali", in Germania queste erano state in buona parte ricomprese nell’ambito delle scienze storiche e per lo più ritenute come discipline ausiliarie in vista di una spiegazione su basi storiche. Un fulgido esempio della situazione culturale tedesca è, in questo senso, quello di Ferdinand Tönnies (1855-1936), che nella sua celeberrima opera del 1887, Comunità e società (Gemeinschaft und Gesellschaft), delinea due tipi alternativi di associazione, incentrati l’uno su un rapporto immediato, l’altro su un rapporto artificiale. Il primo è definito in termini organicistici, il secondo sulla base di un modello meccanicistico. Questi due diversi modelli, che rispondono ad un’esigenza analitica, si presentano anche come termini di un’alternativa storiografica alla quale deve essere ricondotta la molteplicità storica delle formazioni sociali nelle successive fasi del loro svilupparsi. Anche quando la sociologia – nel primo Novecento – si avvierà a diventare una scienza formale, ossia che studia i rapporti sociali dal punto di vista delle forme di coesistenza fra gli uomini, la relazione tra scienze sociali e storiografia rimarrà un rapporto tra termini complementari, come nelle opere di Georg Simmel. Per Tönnies, organica è la comunità (Gemeinschaft), le cui forme embrionali emergono in seno alla famiglia nei rapporti tra madre e figlio, tra moglie e marito, tra fratelli, per estendersi poi ai rapporti di vicinato e di amicizia. Tali rapporti sono improntati a intimità, riconoscenza, condivisione di linguaggi, significati, abitudini, spazi,. Ricordi ed esperienze comuni. I vincoli di sangue (famiglia e parentela), di luogo (vicinato) e di spirito (amicizia) costituiscono delle totalità organiche – le comunità appunto – in cui gli uomini si sentono uniti in modo permanente da fattori che li rendono simili gli uni agli altri e al cui interno le disuguaglianze – ancorchè non siano appianate – possono svilupparsi solo entro certi limiti oltre i quali i rapporti diventano così rari e insignificanti da far scomparire gli elementi di comunanza e condivisione. All’interno della comunità, infatti, i rapporti non sono segmentati in termini di ruoli specializzati, ma comportano che i membri siano presenti con la totalità del loro essere. Nulla di tutto ciò avviene nell’ambito della società. Scrive a tal proposito Tönnies:
"La teoria della società riguarda una costruzione artificiale, un aggregato di esseri umani che solo superficialmente assomiglia alla comunità, nella misura in cui anche in essa gli individui vivono pacificamente gli uni accanto agli altri. Però, mentre nella comunità essi restano essenzialmente uniti nonostante i fattori che li separano, nella società restano essenzialmente separati nonostante i fattori che li uniscono".
Nella società, gli individui vivono per conto loro, separati, in un rapporto di tensione con gli altri e ogni tentativo di entrare nella loro sfera privata viene percepito come un atto ostile di intrusione. Il rapporto societario tipico è il rapporto di scambio: nello scambio i contraenti non sono mai disposti a dare qualcosa di più rispetto a quel che ricevono; anzi, lo scambio avviene proprio perché ognuno ritiene di ricevere qualcosa che ha un valore maggiore di quello che cede, altrimenti non entrerebbe neppure nel rapporto. Venditori e compratori sono in rapporto di reciproca competizione, giacché i primi cercano di vendere al prezzo più alto possibile, mentre i secondi cercano di acquistare al prezzo più basso possibile. Il guadagno dell’uno è la perdita dell’altro. Il rapporto di scambio, poi, non mette in relazione individui nella loro totalità, ma soltanto le loro prestazioni; chi vende non è interessato al compratore come individuo, né all’impiego che questi farà del bene scambiato, ma solo alla sua capacità di pagare il prezzo stabilito. La società è dunque una costruzione artificiale e convenzionale, composta da individui separati, ognuno dei quali persegue il proprio interesse individuale, ed essa entra in gioco solamente come garante del fatto che le obbligazioni che i contraenti si sono assunte vengano onorate. Nella società, infine, tutti i rapporti tendono ad improntarsi al modello dei rapporti di scambio di mercato: nulla viene fatto senza attendersi una contropartita, sia nei rapporti interpersonali, sia nei rapporti tra individui e istituzioni. Fin troppo evidente appare la posizione ideologica di Tönnies: l’avvento della modernità, ovvero della Gesellschaft, è un processo inarrestabile e, tuttavia, rappresenta una perdita rispetto ai valori autentici di solidarietà che trovano una realizzazione compiuta soltanto nell’ambito della comunità. Questa vernice ideologica è però secondaria rispetto alla dicotomia instaurata da Tönnies fra comunità e società. Nel 1897 uscì un’importante studio di Tönnies su Nietzsche (Il culto di Nietzsche), in cui il sociologo tedesco metteva abilmente in luce il quadro culturale di fine Ottocento, dominato dalla figura di Nietzsche e dall’irrazionalismo da lui propugnato: il confronto con Nietzsche fu di importanza capitale per mettere a fuoco il contesto problematico al cui interno doveva operare la nuova disciplina sociologica. La scoperta dell'abisso su cui veniva dipanandosi la trama della razionalizzazione e della modernizzazione, del loro impatto potenzialmente disgregatore e nichilistico non soltanto sulla "tradizione" ma sulla stessa forma di civiltà da esse disegnata, fu la cifra comune dell'opera degli autori richiamati. Dei tre grandi padri fondatori della sociologia tedesca, Tönnies è certo colui che con maggior rigore e impegno tentò di definire il carattere progettuale della sociologia in una sostanziale aderenza con le ragioni e lo sviluppo dello stesso movimento operaio, in cui vedeva l'unico soggetto storico in grado di dare continuità ai caratteri progressivi della modernità. Si trattava evidentemente, per Tönnies, di un movimento operaio cui andavano sottratti i caratteri più inquietanti e turbolenti, che lo configuravano come portatore di guerra all'interno della società, e che andava ricondotto a quell'ideale della pace sociale in cui egli, hobbesianamente, vedeva il motore dello sviluppo moderno. Proprio la fedeltà di Tönnies alla lezione di Hobbes (cui dedicò studi fondamentali) rende ragione dell'impossibilità di una sua ascrizione al campo delle teorie sociologiche organicistiche. L'uguaglianza e l'"urto" delle individualità come tratti destinali del moderno costituiscono piuttosto la norma critica che la sociologia di Tönnies oppone a ogni rapporto fondato sull'ineguaglianza e sul dominio, anche e soprattutto di classe. Il libro dedicato al culto di Nietzsche, la prima interpretazione sociologica non tanto della sua filosofia quanto della straordinaria fortuna che essa conobbe in Germania sul finire dell'800, deve essere letto proprio su questo sfondo. Esso rappresenta infatti la resa dei conti con ogni immagine dell'individualità – quale è per Tönnies quella sottesa alla nietzscheana "morale dei signori" – che, nel recuperarne un'aura "aristocratica", ne giochi il mito contro la determinazione ugualitaria che dell'individualità stessa costituisce l'ineludibile condizione di pensabilità. E che non si arresta sulle soglie domestiche, se è vero che Tönnies delle dottrine etiche dell'ultimo Nietzsche non contesta solo il carattere "aristocratico" ma anche quello "androcratico".
RECENSIONE DI COMUNITA’ E SOCIETA’
La comunita' e' un rapporto reciproco sentito dai partecipanti, fondato su di una convivenza durevole, intima ed esclusiva.
La vita comunitaria e' sentita (implica comprensione, consensus), durevole, intima (confidenziale), esclusiva; al contrario, la vita societaria e' razionale, passeggera, apparente (come tipo di legame), pubblica.
Sono forme primitive di comunita':
– il rapporto madre-bambino;
– il rapporto uomo-donna;
– il rapporto tra fratelli.
Delle tre forme primitive di comunita', le prime due sono piu' istintive, la terza piu' umana.
|
COMUNITA' |
SOCIETA' |
|
antica |
recente |
|
convivenza durevole |
convivenza passeggera |
|
convivenza genuina |
convivenza apparente |
I rapporti di affermazione reciproca, se positivi, danno origine ad associazioni: la comunita' e' un'associazione organica (sentita dai partecipanti), la societa' e' un'associazione meccanica, artificiale e recente (pag.45). L'Autore distingue comunita' di lingua, di costume, di fede; societa' di profitto, di viaggi, di scienze (pag.46).
La societa' e' il pubblico, il mondo: "in una comunita' con i suoi una persona si trova dalla nascita, legata ad essi nel bene e nel male, mentre si va in societa' come in terra straniera" (pag.45). La societa' implica delimitazione dei campi di attivita' e prestazioni reciproche di pari entita' (concetti di scambio e valore).
La comunita' e' caratterizzata dal diritto familiare, la societa' dal diritto delle obbligazioni (pag.229). In societa' gli individui rimangono "separati nonostante tutti i legami" (pag.83).
Il potere nella societa' e' a vantaggio di chi lo detiene, nella comunita' e' finalizzato all'educazione ed all'insegnamento (pag.62).
|
rapporto materno |
istinto |
comunita' di sangue |
parentela |
casa |
padre |
giustizia |
dignita' dell'eta' |
|
rapporto coniugale |
abitudine |
comunita' di luogo |
vicinato |
villaggio |
principe |
forza |
dignita' ducale |
|
rapporto fraterno |
ricordo |
comunita' di spirito |
amicizia |
citta' |
maestro |
saggezza |
dignita' sacerdotale |
La volonta' comunitaria implica comprensione (consensus, che ha natura singola) e concordia (unita' di cuore, che ha natura complessiva). La comprensione deriva dalla conoscenza reciproca che a sua volta richiede partecipazione e quindi vita comune, e richiede anche somiglianza (linguaggio).
Sono leggi fondamentali della comunita':
– l'assuefazione (parenti, coniugi, vicini, amici);
– la comprensione;
– la vita comune (concordia).
La comprensione e' tacita, "la concordia non puo' venire costruita" (pag.65).
La comunita' e' unita' nel differente (pag.61), in essa le diseguaglianze reali non possono pero' essere troppo accentuate.
L'amicizia si fonda su un modo di pensare concorde e dalla comunanza di arti e professioni; i compagni d'arte sono compagni di fede e cooperano ad una stessa opera (pag.58). I rapporti di amicizia sono i meno istintivi e i meno condizionati dall'abitudine.
L'uomo si lega con le proprie opere, con il territorio, con la casa (pag.67): possesso e godimento reciproco di beni comuni caratterizzano la vita comunitaria (pag.66).
LOUIS DE BONALD

Dopo aver salutato con entusiasmo gli esordi della rivoluzione dell’89, il visconte Louis de Bonald (1754-1840) fu eletto nel 1790 membro dell’Assemblea nazionale. Tuttavia, in seguito alla vendita dei beni ecclesiastici (1791) e alla Costituzione civile del clero, egli si trasferì in Germania – ad Heidelberg – e solamente nel 1797 rientrò a Parigi in virtù della mutata situazione politica. Bonald fu gradito al regime napoleonico, ma nel 1815 venne eletto deputato della destra ultra, cominciò a scrivere su giornali conservatori e – nel 1823 – fu nominato Pari di Francia. In seguito alla Rivoluzione di luglio del 1830 e l’instaurazione della monarchia di Luigi Filippo, Bonald abbandonò le cariche e si ritirò in provincia: qui morì nel 1840. Le sue opere più importanti, degne di essere menzionate, sono la Teoria del potere politico e religioso (1795) – la cui diffusione venne arrestata a Parigi su ordine del Direttorio -, il Saggio analitico sulle leggi naturali dell’ordine sociale (1800), la Legislazione primitiva (1802) e la Dimostrazione filosofica del principio costitutivo della società (1830). A partire dalla Teoria del potere politico e religioso, Bonald critica aspramente la pretesa tipica dell’uomo di ergersi a legislatore della società, giacché è la società (politica e religiosa) a costituire l’uomo, e non viceversa (Marx ribalterà questa posizione). In opposizione all’esaltazione illuministica dell’individuo e dei diritti che gli spettano, Bonald mette l’accento su come l’uomo esista solo per la società, il cui obiettivo è quello di conservare quel che è stato prodotto. Ma tale scopo di conservazione può essere garantito solamente dalla monarchia, nella quale il potere è concentrato e non suddiviso: solo in forza di questo potere unitario è garantita la sussistenza della società. Sotto questo profilo, la rivoluzione, con le sue conseguenze democratiche che frantumano il potere unitario attribuendolo ad una miriade di individui ritenuti uguali, è una grave malattia, che però Bonald legge come punto di partenza per una migliore salute. Infatti la rivoluzione stessa è una specie di prova dell’esistenza di Dio, poiché mette in luce come l’eliminazione della religione conduca alla distruzione della società. L’ambito religioso e quello politico sono, agli occhi di Bonald, indisgiungibili. Al binomio meramente negativo rappresentato dalla democrazia e dall’ateismo, si contrappone il binomio positivo incentrato su monarchia e religione. Nell’opera sulla Legislazione primitiva, Bonald mette in chiaro come ogni società non sia il risultato di un contratto – come invece pretendeva Rousseau -, ma piuttosto costituisca una sorta di trinità, composta di tre persone sociali: potere, ministro, soggetto. Nella società domestica, ovvero nella famiglia, queste tre persone sono il padre, la madre e i figli. Nella società religiosa, le tre persone sono Dio, i sacerdoti e i fedeli. Nella società politica, esse sono il sovrano, i nobili (o i funzionari pubblici) e i sudditi (o i popoli). Ma in senso originario il potere risiede unicamente in Dio: l’unità è pertanto il contrassegno costitutivo del potere, mentre molteplici sono i ministri che ne eseguono la volontà. Il linguaggio di cui l’uomo dispone non fa altro che provare l’esistenza di Dio: l’uomo, infatti, trova il linguaggio già costituito ancor prima di formulare il proprio pensiero, cosicché i segni del linguaggio non possono essere stati inventati dall’uomo. Per inventarli, infatti, occorrerebbe pensare, ma non si può pensare facendo a meno di essi: ne segue che l’uomo ha potuto e può pensare poiché si è trovato dinanzi ad un linguaggio già costituito. Cade qui la tesi convenzionalista, secondo cui il linguaggio è una mera invenzione umana: viceversa, l’essere sociale dell’uomo presuppone il linguaggio, che, per essere spiegato, richiede il riferimento ad un essere diverso dall’uomo: tale è Dio, che ha creato l’uomo parlante. Nel pensiero di tutti gli uomini (articolantesi nel linguaggio) è in origine presente l’idea dell’essere, che coincide con l’idea stessa di Dio e che sta alla base di tutte le altre idee, specialmente di quelle morali, sociali e politiche. E’ però assolutamente impossibile che l’uomo abbia inventato l’idea di Dio o di tutto ciò che esiste. Sfruttando al meglio la tematica del linguaggio, Bonald chiarisce il rapporto intercorrente tra sudditi e sovrano: tale rapporto si fonda sulla relazione tra parola e ascolto, dove ascolto equivale a obbedienza (il sovrano detta legge e i sudditi obbediscono). La legge non è se non la volontà di Dio enunciata in linguaggio umano affinché sia intesa da altri uomini: ma alla base di ogni legislazione vi è la Sacra Scrittura, valida per tutti gli uomini. E’ Dio a comunicare agli uomini la verità attraverso la parola, la quale risveglia nella mente umana le idee innate che Dio stesso vi ha posto. Poiché non è la ragione individuale degli uomini ad inventare le idee, risulta a dir poco assurda la pretesa avanzata dagli Illuministi di fare dell’uomo il legislatore in grado di modificare in maniera radicale la società. Dopo il panorama caotico generato dalla rivoluzione, la società tenderà necessariamente a tornare al suo stato naturale, ossia ad applicare le leggi trasmesse da Dio mediante la società stessa, la quale sta al di sopra dell’individuo. In quest’ottica, il cattolicesimo assurge a religione richiesta dalla società stessa: la sua necessità è provata anche dalla storia, la quale è orientata a ristabilire – dopo i danni provocati dalla rivoluzione – l’unione della monarchia con la religione cattolica.
JOSEPH DE MAISTRE

INTRODUZIONE AL PENSIERO
Joseph-Marie de Maistre nacque a Chambery nel 1753 e ben presto entrò nella massoneria e fu al servizio della monarchia sabauda, che nel 1802 lo mandò in veste di plenipotenziario a Pietroburgo al cospetto dello zar Alessandro. Vi rimase fino al 1817, allorché – per via di forti dissensi con lo zar – venne richiamato a Torino, città in cui, l’anno seguente, fu nominato reggente della Grande Cancelleria del Regno. Le sue opere più importanti sono Sulla sovranità del popolo (1794) – rimasta incompiuta -, le Considerazioni sulla Francia (pubblicate anonime nel 1796), il Saggio sul principio generatore delle costituzioni politiche e delle altre costituzioni (pubblicato senza che de Maistre lo sapesse nel 1814, a Parigi, da Louis de Bonald), Sul papa (1819), le Serate di San Pietroburgo (uscite nel 1821, poco dopo la morte dell’autore). Le travolgenti vicende della Rivoluzione francese paiono a Maistre come la più evidente conferma dell’agire della Provvidenza: da un lato, esse sembrano il meritato castigo per una nobiltà e un clero corrotti e, dall’altro lato, paiono la dimostrazione più lampante che la Provvidenza si serve degli uomini (anche dei giacobini) come strumenti per realizzare i propri fini imperscrutabili. La convinzione di fondo che percorre l’intera riflessione di Maistre è infatti che gli uomini non siano padroni delle proprie vicende e dei propri accadimenti: ciò pare del resto incontrovertibilmente provato dal fatto che, quando al Rivoluzione raggiunse l’apice della tirannide, ci volle poco per rovesciarla; il XVIII secolo si è presentato come rivolta contro Dio, il quale ha punito questo efferato delitto ritirandosi dalla storia, lasciando fare agli uomini. Proprio in virtù di ciò “il mondo andò in frantumi”, dice Maistre. L’imperdonabile errore commesso dalla filosofia moderna sta nel ritenere che tutto sia bene, mentre in realtà l’uomo è profondamente segnato dalla colpa del peccato originale e, in forza di ciò, nel mondo, dove ogni cosa è stravolta, v’è soltanto violenza, crudeltà, efferatezza, cosicché anche gli innocenti finiscono col pagare per i colpevoli. Nelle Serate di San Pietroburgo Maistre torna con rinnovato interesse sul problema del male e del dolore, asserendo che il vero male – quello di natura morale – è imputabile esclusivamente all’uomo, il quale impiega in maniera distorta la propria libertà, mentre il male fisico non è che la conseguenza di tale colpa. E’ soltanto il sacrificio a poter espiare le colpe di cui l’umanità si è macchiata, in primis il sacrificio di Cristo, ma poi anche quello degli innocenti che si fanno carico delle colpe e soffrono anche per i colpevoli. L’agire di Dio (che è l’unico e autentico padrone della storia) può apparire dispotico e crudele, ma ciò dipende solamente dalle colpe degli uomini, che rivendicano per se stessi una libertà assoluta. Maistre, in perfetta sintonia con Bonald, attacca duramente le teorie contrattualistiche e le vane pretese di creare una società nuova, tutte pretese chimeriche della dilagante mentalità illuministica e dei rivoluzionari, che confidavano esclusivamente nella ragion umana. La conclusione cui Maistre addiviene è che “il più grande flagello dell’universo è sempre stato in tutti i secoli ciò che chiamiamo filosofia”, ovvero l’umana ragione che agisce autonomamente e – presa da orgoglio – senza accompagnarsi alla fede, giungendo per tale via ad esiti esclusivamente distruttivi. Ne segue, allora, che la costituzione politica non può né deve essere opera dell’uomo e assumere artificiosamente una codificazione scritta, giacché l’uomo non può creare nulla e ciò vale non solo sul piano naturale, ma anche su quello morale e politico. La costituzione è, al contrario, il modo di esistere che un potere superiore (cioè divino) assegna a ciascuna nazione, cosicché il potere non può essere del popolo e l’unico modo di ricostruire la vera sovranità dipende da un potere unico e assoluto. La legge, infatti, è realmente tale se e solo se emana da una volontà superiore, non dalla volontà di tutti o dei più. Sicché la forma naturale di governo (quella che rispecchia il volere divino) è la monarchia, ove al potere del monarca non si possono porre limiti di alcun tipo. In antitesi con quel che credevano i rivoluzionari, il re può essere ucciso ma non legittimamente giudicato. Conseguentemente, la monarchia ereditaria, finalizzata a perpetuare il potere unico e assoluto, è la forma di governo avente la massima stabilità e il massimo vigore. Nell’opera Sul papa, Maistre accentua esponenzialmente la dimensione teocratica del suo pensiero, arrivando a sostenere l’urgente necessità di ripristinare il primato e la funzione universale che il papato aveva avuto nel Medioevo, in quanto unico potere superiore e infallibile, in grado di impedire alle monarchie stesse di degenerare in tirannidi e di ricostruire l’unità che è bene (di contro alla divisione, che è sempre male). Allo scritto Sul papa (pubblicato nel 1819, in pieno clima di restaurazione) arrise grande successo, a tal punto da avere cinquanta edizioni nel corso del XIX secolo: di fronte allo spettacolo della carneficina prodotta dalla Rivoluzione francese e, più in generale, dalla storia, paragonata a un immenso “mattatoio” (Hegel stesso ricorre a questo paragone), quand’è affidata alla sola ragione umana, Maistre presenta come unico salvifico rimedio il ripristino di un’autentica autorità indivisa, al di sopra dei monarchi stessi: il papa. Senza il papa, il cristianesimo stesso si riduce ad una credenza fra le tante, priva di potenza: il papa serve per mantenere l’unità della cristianità, anche nelle zone più periferiche. Non a caso Maistre lo paragona al Sole nel sistema dei pianeti, che tutto illumina e tutto alimenta: è “il grande demiurgo della civiltà universale”, in cui l’autorità spirituale infallibile e la sovranità temporale fanno tutt’uno. Una pari importanza alla figura del papa in sede politica sarà ammessa anche da Vincenzo Gioberti (anch’egli operante a Torino), che – nel 1842 – con lo scritto sul Primato civile e morale degli italiani prospetta come soluzione della questione italiana una confederazione di Stati, governati ciascuno dal proprio principe, sotto la guida morale del papa (il neoguelfismo): “l’opera del risorgimento é opera di educazione, bisogna promuovere un’altissima aspirazione idealistica, un ritorno alle tradizioni e ai valori, che in Italia sono quelli del cattolicesimo, ristabilire il dominio di quell’Idea, che in Italia sede del papato, ha la sua naturale dimora”.
BRANI ANTOLOGICI
Il potere dev’essere assoluto
Contro la concezione democratica del potere fondato sulla volontà del popolo, Joseph de Maistre ripropone la teoria del potere che viene da Dio, e in quanto tale assoluto e infallibile. Si noti la vicinanza con la dottrina di Hobbes: il potere deve essere assoluto o non può esistere.
[J. de Maistre, Del papa]
“Che non si è mai detto dell’infallibilità considerata sotto l’aspetto teologico!
Sarebbe difficile aggiunger nuovi argomenti a quelli che i difensori di quest’alta prerogativa hanno accumulato per appoggiarla sopra autorità incrollabili, e levarle d’attorno i fantasmi di cui l’han cinta i nemici del cristianesimo e dell’unità, nella speranza di renderla, se non altro, per lo meno odiosa.
Ma io non so se per questa grande questione, come per tante altre, sia stato abbastanza notato che le verità teologiche sono semplicemente delle verità generali, manifestate e divinizzate sul piano religioso, di modo che non si potrebbe assalirne una senza assalire anche una legge mondiale.
L’infallibilità nell’ordine spirituale, e la sovranità nell’ordine temporale, sono due parole perfettamente sinonime. L’una e l’altra esprimono quell’alto potere che ad ogni altro impera, da cui ogni altro deriva, che governa e non è governato, giudica e non è giudicato.
Quando noi diciamo che la Chiesa è infallibile, non chiediamo per essa – è essenzialissimo osservarlo – nessun privilegio particolare; chiediamo soltanto ch’ella goda del diritto comune a tutte le sovranità possibili, le quali agiscono tutte necessariamente come infallibili; perché tutti i governi sono assoluti; e non esisterebbero piú, quando si potesse loro resistere sotto pretesto d’errore o d’ingiustizia. […]
Lo stesso è per la Chiesa; in un modo o in un altro bisogna che sia governata, come qualunque altra associazione; altrimenti non vi sarebbe piú aggregazione, non insieme, non unità. Questo governo è dunque di sua natura infallibile, ossia assoluto, senza di che non governerebbe piú.
Nell’ordine giudiziario, che è una delle parti del governo, non è fuor di dubbio che bisogna assolutamente giungere a un potere che giudica e non è giudicato, precisamente perché sentenzia in nome del potere supremo di cui è ritenuto organo e voce?”
Le origini divine delle costituzioni
Joseph de Maistre paragona la critica di Cicerone alla dottrina atomistica di Epicuro con la sua critica all’idea, propria dei rivoluzionari, che le costituzioni possano essere scritte a priori, astrattamente.
[J. de Maistre, Saggio sul principio generatore delle costituzioni politiche]
“Notissimo è il paragone di Cicerone a proposito del sistema di Epicuro per il quale il mondo si costruisce con gli atomi che precipitano a caso nel vuoto. Sarebbe piú facile farmi credere, diceva il grande oratore, che lettere gettate in aria possano, cadendo, disporsi in modo da formare un poema. Migliaia di volte si è ripetuto e celebrato questo pensiero; ma nessuno ha pensato di completarlo come esso esige. Supponiamo che caratteri di stampa gettati a piene mani dall’alto di una torre formino in terra l’Athalie di Racine; che cosa ne deriverà? Che una intelligenza ha presieduto alla caduta ed alla disposizione dei caratteri. Il buon senso non concluderà mai diversamente […]
La costituzione è opera delle circostanze, ed il numero delle circostanze è infinito. Le leggi romane, le leggi ecclesiastiche, le leggi feudali, i costumi sassoni, normanni e danesi; i privilegi, i pregiudizi e le pretese di ogni genere, le guerre, le rivoluzioni, le conquiste, le crociate; tutte le virtú, tutti i vizi, tutte le conoscenze, tutti gli errori, tutte le passioni: tutti questi elementi, dunque confluendo insieme a formare con la loro mescolanza e reciproca unione combinazioni moltiplicate indefinitamente, hanno prodotto, dopo molti secoli, l’unità piú complessa ed il piú bell’equilibrio di forze politiche che si sia visto nel mondo […]
Ora, poiché questi elementi proiettati nello spazio si sono disposti in cosí bell’ordine, senza che tra l’innumerevole folla di uomini che hanno agito in questo vasto campo, uno soltanto abbia mai saputo ciò che faceva in rapporto al tutto, o previsto ciò che ne doveva conseguire, ne deriva che questi elementi erano guidati nella loro caduta da una mano infallibile, superiore all’uomo. La piú grande follia del secolo delle follie fu forse il credere che le leggi fondamentali potessero essere scritte a priori; mentre evidentemente sono opera di una forza superiore all’umana, e la stessa scrittura, molto posteriore, è, al paragone. il segno piú evidente della nostra negatività”.
La dignità del latino
Secondo Joseph de Maistre la grandezza della lingua latina è data dalla sua storia. I Romani le hanno impresso il senso della maestà. Essa poi è stata usata per civilizzare i barbari. Infine i grandi scienziati l’hanno usata per scrivere le loro opere.
[J. de Maistre, Saggio sul principio generatore delle costituzioni politiche]
“Niente uguaglia la dignità della lingua latina. Fu parlata dal popolo-re, il quale le impresse quel marchio di grandezza unico nella storia del linguaggio umano, che nessuna lingua, neppure la piú perfetta, è mai riuscita a conquistare. Il termine di maestà appartiene al latino. La Grecia l’ignora; ed è soltanto per la maestà che essa rimase inferiore a Roma, nelle lettere come sui campi di battaglia. Nata per comandare, questa lingua comanda ancora nei libri di coloro che la parlarono. È la lingua dei conquistatori romani e dei missionari della Chiesa romana: uomini che differiscono soltanto per lo scopo ed il risultato della loro azione. Per i primi si trattava di asservire, umiliare, sconvolgere il genere umano; i secondi venivano ad illuminarlo, risanarlo, salvarlo; ma si trattava sempre di vincere e di conquistare e, da una parte e dall’altra, si trova la stessa potenza. […]
È la lingua della civiltà. Mescolata a quella dei nostri padri, i Barbari, ha saputo affinare, ingentilire e, per cosí dire, spiritualizzare quei rozzi idiomi che soltanto cosí sono diventati quel che vediamo. Forti di questa lingua, gli inviati del Pontefice romano andarono incontro a quei popoli che piú non li avvicinavano. Dal giorno del loro battesimo, costoro non l’hanno piú dimenticata. Si dia uno sguardo a un mappamondo; la linea d’arresto di questa lingua universale segna i confini della civiltà e della fraternità europea; al di là troverete soltanto quella parentela umana che si trova fortunatamente dovunque. Il segno distintivo dello spirito europeo è la lingua latina. […]
Dopo essere stato lo strumento della civiltà, mancava al latino un solo genere di gloria, e lo conquistò, quando maturò il momento, divenendo la lingua della scienza. I geni creatori l’adottarono per comunicare al mondo i loro grandi pensieri. Copernico, Keplero, Descartes, Newton e cento altri ancora, importantissimi anche se meno celebri, hanno scritto in latino. Una enorme quantità di storici, pubblicisti, teologi, medici, antiquari, ecc., inondarono l’Europa di opere latine di ogni genere. Piacevoli poeti, letterati di prim’ordine restituirono alla lingua di Roma le antiche forme e la riportarono ad un grado di perfezione che non cessa di stupire gli uomini che paragonano i nuovi scrittori ai loro modelli. Tutte le altre lingue, per quanto studiate ed intese, tacciono tuttavia nei monumenti antichi, probabilmente per sempre.
Sola tra tutte le lingue morte, quella di Roma è veramente risuscitata; e, simile a colui che celebra dopo venti secoli, una volta risuscitata, non morirà piú”.
DAVID FRIEDRICH STRAUSS

Nell’ambito della Sinistra hegeliana, occupa un posto a sé la figura di David Friedrich Strauss (1808-1874), il quale prese parte in prima persona, per un certo periodo, alle lezioni di Hegel tenute a Berlino. Strauss si formò a Tubinga, studiando teologia con l’hegeliano Ferdinand Christian Baur, fondatore della scuola storico/critica di teologia. Proprio presso l’università di Tubinga, Strauss apprese ad applicare i metodi dell’analisi storica e filologica anche alle Sacre Scritture: in questo modo, egli preparò il terreno a quella che sarebbe stata la sua opera più famosa, la Vita di Gesù (1835). In quest’opera, destinata a fare epoca, egli sostiene l’ardita tesi secondo cui i Vangeli non sono un resoconto storico attendibile, ma piuttosto un mito, ossia un racconto liberamente creato sulla base delle impressioni prodotte da Gesù sui primi cristiani e sulle loro credenze e attese. In tale contesto, Gesù fu considerato il figlio di Dio, ovvero Dio stesso fattosi uomo; ma questa – nota Strauss – non è che una costruzione mitologica, che ciò non di meno esprime l’idea dell’unità del divino e dell’umano, dell’infinito e del finito (Cristo è infatti uomo e, insieme, Dio). Solo nell’umanità – argomenta Strauss – queste due dimensioni si congiungono. Se il contenuto del cristianesimo – che è la religione suprema – è mitico e ha la sua origine nell’immaginazione, allora la religione in quanto tale, in ogni sua forma, non può essere innalzata alla sfera del concetto mediante la filosofia, come aveva preteso Hegel. Affiora in questa maniera la scissione insanabile tra religione e filosofia, scissione che, secondo i sostenitori della Destra hegeliana, Hegel aveva voluto conciliare e sanare. Per questa via, Strauss avrebbe dunque finito con l’abbandonare sia il cristianesimo sia l’hegelismo, addivenendo a sostenere, in uno dei suoi ultimi scritti – L’antica e la nuova fede (1872) – una sorta di religione panteistica, in cui l’universo intero diventa oggetto di venerazione. Su queste basi, egli edificò una dottrina morale tale da identificare il dovere col rendersi conformi all’idea di umanità, stabilendo legami di solidarietà e amore fra gli uomini, legami fondati sullo Stato e sulla famiglia. Nella Vita di Gesù (opera significativamente recante lo stesso titolo di quella pubblicata a suo tempo da Hegel), Strauss sostiene, in netto contrasto con la tradizione, che la figura di Gesù sia il frutto dell’elaborazione mitologica dei cristiani; egli non mette in dubbio l’esistenza storica di Gesù, ma ciononostante è convinto che, paradossalmente, sia Gesù come elaborazione mitologica a derivare dal cristianesimo e non viceversa, come invece aveva sempre sostenuto concordemente la tradizione. Sulla scia di Hegel, Strauss sostiene la sostanziale identità dei messaggi veicolati dal cristianesimo e dalla filosofia; ciò che li distingue è però la forma, in quanto ciò che la religione sostiene nella forma immaginifica del mito, è dalla filosofia sostenuto tramite la superiore forma del concetto. Hegel stesso aveva dato di Cristo un’interpretazione alquanto filosofica, concependo l’incarnazione come momento della negazione (Dio, nel farsi uomo, si nega come Dio) volto a riscattare la finitudine umana; di conseguenza, Cristo non era se non il simbolo, in forma mitica, della conciliazione di finito e infinito. Similmente, Strauss sostiene che la filosofia è verità compiuta e dispiegata, designando invece la religione come rappresentazione mitica e immaginifica. Proprio sulla base di tale distinzione, Strauss ritiene opportuno distinguere tra il Cristo della fede e quello della storia: quello della storia è un uomo eccezionale; quello della fede è miticamente inteso come Dio fattosi uomo. Il problema che si para dinanzi a Strauss, quand’era vicario pastorale, è il seguente: predicando ai fedeli, quale linguaggio – quello storico o quello mitico? – occorre impiegare? Egli risponde che, di fronte ai fedeli, impiegherà quello mitico della religione (ossia quello che ricorre a miti quali la moltiplicazione dei pani), giacché il popolo non è sufficientemente preparato per recepire messaggi filosofici. La filosofia hegeliana si riverbera nella struttura stessa della Vita di Gesù di Strauss: questa, infatti, è suddivisa in tre parti, secondo una scansione che ricorda quella hegeliana della tesi, dell’antitesi e della sintesi. In particolare, nella prima parte dell’opera Strauss parla di Cristo in maniera mitica; nella seconda, invece, dimostra – sulla scia di Spinoza – l’inattendibilità storica delle vicende del Cristo narrate nelle Scritture, smascherando tanto gli errori più grossolani (come la trasformazione dell’acqua in vino) quanto gli scarti cronologici (ad esempio, il censimento di Augusto non corrisponde affatto con quanto si dice nelle Scritture). La rappresentazione mitica – asserisce Strauss – dev’essere ricondotta alla mentalità del tempo in cui fu prodotta, tenendo conto dell’impatto che la figura del Cristo ebbe sulla società di allora. Tenendo conto di ciò, quest’uomo eccezionale potrà essere definito come “il più divino degli uomini”, ancorché si tratti pur sempre di un uomo. Cristo allora non è che il campione morale della virtù:
“Questo ideale della perfezione morale, quale il comporta un essere cosmico dipendente da bisogni e da tendenze, non può essere concepito da noi che sotto le forme di un uomo; anzi, siccome noi non possiamo farci alcuna idea della potenza di una forza e quindi neanche della disposizione morale, se non a condizione di figurarcela lottante contro ostacoli e trionfante benché assalita d’ogni lato, questo ideale si presenterà a noi sotto la forma di un uomo pronto non solo a compiere egli stesso ogni dovere umano e a propagare il piú possibile con la sua dottrina e col maggior vantaggio del genere umano, e malgrado le seduzioni piú attive, ogni sorta di patimenti, fino alla morte piú ignominiosa”.
Scrive ancora Strauss, nella seconda parte della sua opera:
“La storia del Vangelo è, in sostanza, la storia della natura umana ridotta ad un concetto ideale; essa ci mostra nella vita di un individuo, ciò che l’uomo dev’essere, ciò ch’egli può realmente divenire unendosi a quell’individuo e seguendone la dottrina e l’ esempio”.
In questo senso, il mito di cui si avvale la religione per esprimersi non è mera impostura oscurantista (quale invece era per certo Illuminismo), ma è piuttosto la rappresentazione che la società del tempo aveva di se stessa e delle proprie vicende. Nell’ultima parte dell’opera, infine, Strauss presenta una conciliazione tra il Cristo della religione e quello della storia; ma, nonostante questo estremo tentativo compromissorio, egli fu espulso dalla facoltà. Dopo tale accadimento, egli non si preoccupò più della censura e, pertanto, acuì le proprie posizioni, negando ogni possibile conciliazione tra religione e filosofia e, inoltre, opponendosi tanto al potere politico vigente quanto a quello religioso. In questa nuova fase della sua produzione, Strauss sostiene che la filosofia è verità dispiegata e compiuta solamente qualora mantenga un atteggiamento critico nei confronti della realtà, senza cercare conciliazioni col reale. In questo modo, Hegel diventa bersaglio di critiche durissime, in forza del fatto che egli aveva presentato la filosofia come un qualcosa che nasce e che spicca il suo volo solo quando la realtà s’è già formata, cosicché il suo compito è soltanto quello di render conto del reale, senza mutarlo. Si tratta invece – dice Strauss (e con lui concorda tutta la Sinistra hegeliana) – di cambiare un reale che, così com’è, è tutto fuorché razionale; si tratta, per l’appunto, di far diventare razionale ciò che, di per sé, non è ancora tale.
MELCHIORRE GIOIA

Melchiorre Gioia era nato a Piacenza nel 1767 e morì a Milano nel 1829. Dopo studi in filosofia e teologia e diverse attività in ambito politico e pubblicistico, fu nominato nel 1801 storiografo della Repubblica Cisalpina e si dedicò a studi di economia e statistica. Mente enciclopedica e poliedrica, Gioia trattò tutti i problemi sociali del suo tempo. Dopo la restaurazione del governo austriaco a Milano, nel 1820, egli fu arrestato con Silvio Pellico e con Maroncelli, per poi essere liberato l’anno seguente: ciò non di meno, rimase sospetto al governo austriaco fino alla morte, avvenuta nel 1829. Fu autore di svariate opere, delle quali meritano sicuramente di essere ricordate il Nuovo Galateo (1802), il Trattato del merito e delle ricompense (1808-1809), l’Ideologia (1822) e la Filosofia della statistica (1826). Nella medicina legale è rimasto famoso per la nota regola del calzolaio: in un trattato di statistica essa anticipava il concetto della riduzione della capacità lavorativa specifica:
” … un calzolaio, per esempio, eseguisce due scarpe e un quarto al giorno; voi avete indebolito la sua mano che non riesce più che a fare una scarpa; voi gli dovete dare il valore di una fattura di una scarpa e un quarto moltiplicato per il numero dei giorni che gli restano di vita, meno i giorni festivi …”.
Gioia ritiene che l’ideologia – non nel senso (marxiano) di coscienza capovolta, bensì in quello, propri degli ideologues, di scienza dell’origine e dello sviluppo delle idee – debba fondarsi su un metodo puramente descrittivo delle operazioni psichiche, senza alcun riferimento all’anima come causa produttrice di esse. In perfetta sintonia con il sensismo e in particolare con Condillac, Gioia rintraccia la base di tali operazioni nelle sensazioni reali, ma riconosce poi una funzione nel costituirsi delle idee anche a quelle immaginarie. Il privilegiamento del metodo descrittivo, connesso ai suoi spiccati interessi per la matematica, portano il filosofo piacentino a considerare la statistica come uno strumento imprescindibile per la raccolta e per la classificazione dei fatti, quantificati sulla base delle loro ricorrenze. In questa prospettiva, si capisce anche la marcata propensione di Gioia per l’aritmetica morale di Bentham, intesa come calcolo delle utilità in base ai piaceri e ai dolori prodotti dalle azioni, anche se egli è poi costretto a lamentare il fatto che, in sede morale, non è possibile effettuare calcoli e misure precise come avviene nelle scienze fisiche. Poco persuaso dalla “rivoluzione Copernicana” compiuta da Kant, Gioia lo liquidò con un motto di spirito: “l’Italia non s’inkanta”.
LANGE

A cura di Matteo Casu
Friedrich Albert Lange (1828-1875), filosofo e sociologo tedesco, nasce il 28 settembre 1828, a Wald, presso Solingen, figlio del teologo J. P. Lange. Studia a Duisburg, Zurigo e Bonn, dove si distingue sia negli studi sia nella ginnastica. Nel 1852 diviene rettore a Duisburg, ma si dimette quando il governo proibisce ai rettori di prendere posizione in agitazioni politiche. In seguito, Lange inizia la carriera di giornalista militante per la causa della riforma politica e sociale. Influente nelle questioni della sua città, trova svago nello scrivere molti dei suoi libri più celebri, Die Leibesitbungen (f 863), Die Arbeiterfrage (1865, 5th ed. 1894), Geschiichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart (1866; 7th ed. con cenni biografici di H. Cohen, 1902; Eng. trans., E. C. Thomas, 1877), e J. S. Mills Ansichten uber die sociale Frage (1866). Nel 1866, scoraggiato dagli eventi in Germania, si trasferisce a Winterthur, presso Zurigo, diventa collaboratore del giornale democratico Wintert/zurer Landbote. Nel 1869 è Privat Dozent a Zurigo, e professore l’anno dopo. Le forti simpatie francesi della Svizzera nella guerra franco-tedesca porta alle sue pronte dimissioni. Tempo dopo abbandona la politica. Nel 1872 accetta la docenza a Marburgo. Sfortunatamente, il suo vigore fisico viene già minato da un’epidemia, e, dopo una lenta agonia, muore a Marburgo, il 23 novembre 1875, ligio fino alla fine. Il suo Logische Studien è pubblicato da H.Cohen nel 1877 (II ed., 1894). Lange si occupa inizialmente di psicologia, partendo da posizioni herbartiane, dalle quali però si allontana presto, criticando in Herbart soprattutto l’uso della matematica nella filosofia. Il suo lavoro principale, la Storia del materialismo (Geschichte des Materialismus), scritto brillantemente e con ampia conoscenza scientifica, è più vicino al pensiero inglese di quanto sia solito in Germania, ed è più un’esposizione didattica di principi che una storia nel vero senso del termine. Adottando il punto di vista kantiano secondo cui possiamo conoscere solo i fenomeni, Lange sostiene che né il materialismo né altri sistemi metafisici abbiano un valido accesso alla verità ultima. Tuttavia, per la conoscenza empirica fenomenica, che è tutto ciò che l’uomo può cercare, il materialismo con i suoi precisi metodi scientifici ha dato il servizio più utile. La metafisica ideale, anche se non coglie la natura profonda delle cose, ha un valore come incarnazione delle alte aspirazioni, allo stesso modo della poesia e della religione. Lange si affermò come uno dei primi rappresentanti maggiori del neocritiscmo.
Secondo Lange, nella storia del pensiero prekantiano il materialismo è l’unica concezione fondata e coerente, è la condizione stessa che rende possibile una concezione scientifica della realtà. Ma dopo Kant il materialismo è diventato un principio metafisico, e come tale deve essere rifiutato al pari dell’idealismo. I fenomeni studiati dalla scienza sono relativi alla nostra percezione, la quale è a sua volta condizionata dalla nostra organizzazione mentale innata. Ne deriva la necessità, rispetto alla questione del materialismo, di rifarsi alla posizione di Kant, riconoscendo il suo aspetto positivo, cioè il determinismo dei fenomeni, e opponendosi alla pretesa speculativa di determinare la cosa in sé. Nello scritto Logische Studien di Lange, che tenta una ricostruzione della logica formale, l’idea portante è che il ragionare ha validità nella misura in cui può essere rappresentato in termini di spazio. Il suo Arbeiterf difende accesamente un’indefinita forma di socialismo, e protesta contro l’egoismo industriale contemporaneo, e contro l’organizzazione dell’industria sul principio darwiniano della lotta per la sopravvivenza.
La Germania ha prodotto pochi filosofi della stessa lucidità, giudizio e sincerità di Lange, della cui Storia del materialismo mantiene il suo valore di lavoro classico e di esempio di storiografia filosofica nonostante il cambiamento dei tempi e l’incremento di conoscenza. Lange, leader del neo-Kantismo, ha espresso il materialismo ma, d’altra parte, ci ha insegnato ad apprezzare i filosofi materialisti la cui indipendenza dalla tradizione idealista ha spesso ottenuto apprezzabili risultati ed è stata diretta da intuizione critica. Dopotutto, Lange distrusse il diffuso pregiudizio che l’adozione di visioni idealistiche in sede metafisica avrebbe garantito standard morali più alti di quelli raggiunti dalla condotta di vita di coloro che professavano il materialismo.
Prima che Lange pubblicasse la sua storia del materialismo, il suo libro Ansichten uber die sociale Frage creò agitazione nelle politiche sociali. Lange difendeva energicamente gli interessi dei lavoratori e le loro richieste politiche ed economiche, ed era desideroso di accrescere le loro condizioni culturali. Egli spesso discuteva con i primi leaders del socialismo tedesco, e molto spesso li sosteneva, parlando ai congressi da loro indetti. In particolare, interessato al pensiero e all’azione politica, si rese fautore di un socialismo etico, le cui matrici filosofiche erano essenzialmente in Kant e Schiller.
Egli cercò con onestà di unire democratici e socialisti tedeschi. La sua morte prematura fu pianta allo stesso modo da intellettuali e lavoratori.
Nella Storia del materialismo, Lange dimostra la necessità di rigettare e superare il materialismo grossolano perché esso pretende di derivare la conoscenza dal moto materiale. Dirigendosi verso uno spinoziano parallelismo psico-fisico, Lange afferma che l’esperienza immediata mostra il parallelismo tra ambito psichico e ambito fisico, distinti l’uno dall’altro ma uniti in una realtà assoluta. Questa realtà tuttavia sfugge alla nostra comprensione. Nessuno dei due ambiti è derivabile dall’esperienza: non quello psichico, perché la conoscenza non è un anello nella catena dell’esperienza, ma un suo aspetto interno; non quello fisico, perché l’esperienza è il risultato del nostro modo di percepire.
La materia, secondo Lange (che in questo segue Berkeley) è mera rappresentazione, pura sensazione, semplice “esser percepito”. Anche il nostro cervello e i nostri organi sensoriali esistono unicamente attraverso la nostra conoscenza di essi. Se noi percepiamo in un modo fissato, la ragione è perché così è la nostra “organizzazione”. È chiaro che una simile teoria della conoscenza non può avere relazioni con metafisica o religione.
ERNST TROELTSCH

A cura di IL DIOGENE
Ernst Troeltsch (1865 – 1923), teologo, filosofo e storico di grande cultura, si occupa soprattutto del rapporto tra storicismo e religione. Egli coglie ben presto i limiti delle due principali tendenze del pensiero a lui contemporaneo, ossia il naturalismo (a causa del suo esasperato determinismo) e lo storicismo (per via del suo nefasto relativismo): in tali tendenze crede di individuare i segni dell’indifferenza e della stanchezza che caratterizzano la sua epoca e a cui intende contrapporsi.
Secondo Troeltsch, storia e religione sono due termini antitetici. Da una parte, infatti, la conoscenza storica mette in evidenza il condizionamento di ogni forma di religione e la sua appartenenza a un processo di sviluppo; dall’altra, la religione pretende di valere universalmente. Questa contrapposizione dà origine a una crisi non soltanto della religione ma anche della teologia: la religione cristiana perde sempre più la propria base soprannaturale, mentre la sua giustificazione teologica si trova a fare i conti con la coscienza storica, la quale va vieppiù affinandosi. Troeltsch afferma che le religioni sono fatti storici individuali, storicamente condizionati, benché ci sia sempre la possibilità che certi eventi religiosi siano prodotti da fattori altrettanto religiosi (Weber arriverà a dire che certi eventi religiosi possono anche produrre fenomeni socio-economici). Questa indipendenza della religione dalla causalità naturale viene interpretata da Troeltsch come la presenza dell’infinito nel finito (col che egli, pur avendo di mira l’obiettivo di superare il relativismo storicistico, ricade nell’idealismo).
Il cristianesimo è considerato da Troeltsch non come l’unica religione valida, bensì come la religione più elevata: non quella che ha raggiunto la verità, ma quella che più le si avvicina. La possibilità della religione viene giustificata da un punto di vista formale con il richiamo alla teoria dei valori, e in particolare a Rickert, osservando che se è vero che le religioni sono molteplici, è vero anche che al loro interno sono individuabili verità o principi comuni nei quali gli uomini si riconoscono: sono quindi relative le forme storiche con cui le religioni si esprimono, ma non sono relativi i valori di cui esse sono portatrici. Troeltsch ha dunque preteso di respingere sia la soluzione positivistica che faceva della religione uno stadio primitivo dell’umanità, sia quella romantico-idealistica che vedeva nelle diverse religioni la realizzazione di un’essenza universale. Successivamente, per influsso di Weber, Troeltsch esaminerà i rapporti della religione da un punto di vista sociologico, rapportandola all’economia.
Secondo Troeltsch, il compito della filosofia del XX secolo è quello di portarsi al di là dello storicismo. Ciò era stato sottolineato anche dai neokantiani nella loro ricerca di nuove basi su cui fondare valori etici e conoscitivi. Ma, a differenza della “Scuola del Baden”, Troeltsch cerca di evitare il ricorso a valori soprastorici, riuscendo a trovare risposta ai problemi dello storicismo all’interno dello stesso storicismo.
Nelle forme mature della sua riflessione, ovvero nelle opere Lo storicismo e i suoi problemi e Lo storicismo e il suo superamento, Troeltsch traccia una strada che – a suo giudizio – permette di uscire dal relativismo e portare alla costruzione di nuovi valori. Essenzialmente, la proposta di Troeltsch poggia sul recupero della nozione romantica di “individualità”, che dovrebbe poter offrire, sia pur nella mutevolezza degli eventi, un punto di riferimento saldo e sicuro. Troeltsch osserva che se prendiamo in esame epoche diverse siamo costretti a riconoscere da una parte la relatività dei valori di ognuna di esse e dall’altra una sorta di ripetizione degli stessi valori, sia pur in forme sempre diverse. Nello scritto Lo storicismo e i suoi problemi, egli afferma che lo storicismo diviene la storicizzazione di ogni realtà (statale, religiosa, politica, culturale). La categoria fondamentale dello storicismo sarà allora quella di “totalità individuale” che corrisponde all’ unità autocentralizzata di Dilthey. Lo storicista deve trovare ciò che vi è di essenziale all’ interno della storia. I valori pur manifestandosi in forme diverse, soggiacciono ad un principio universale assoluto.
CESARE LOMBROSO

Cesare Lombroso nacque a Verona nel 1835. Incaricato di un corso sulle malattie mentali all’università di Pavia nel 1862, divenne in seguito (1871) direttore dell’ospedale psichiatrico di Pesaro e professore di igiene pubblica e medicina legale all’università di Torino (1876), di psichiatria (1896) e infine di antropologia criminale (1905). Morì a Torino nel 1909. Tra le sue opere più importanti, ricordiamo: La medicina legale dell’alienazione (1873); L’uomo criminale (1875); L’uomo delinquente (1876); L’antisemitismo e le scienze moderne (1894); Il crimine, causa e rimedi (1899), sintesi dei lavori precedenti.
La figura di Cesare Lombroso è emblema dell’influenza che il Positivismo francese e inglese esercitò anche in Italia, soprattutto nella forma evoluzionistica propugnata da Spencer. In Italia, il Positivismo attecchì soprattutto sull’onda del pur tardivo sviluppo industriale, che portò alla formazione di una nuova borghesia imprenditoriale: non stupisce allora se esso si affermò soprattutto negli studi di antropologia e di biologia.
Seguace e assertore del metodo positivistico, che lasciò una notevole traccia nelle varie branche medico-biologiche, Lombroso compì studi di medicina sociale che costituiscono una delle fonti principali della legislazione sanitaria italiana.
Ma il suo nome resta legato soprattutto all’antropologia criminale, di cui è ritenuto il fondatore, insieme con la “scuola positiva del diritto penale”, in cui influenzò le teorie poi sviluppate da E. Ferri.
Riallacciandosi alla dottrina di Galton, della criminalità innata e biologicamente condizionata, Lombroso sostenne che le condotte atipiche del delinquente o del genio sono condizionate, oltre che da componenti ambientali socioeconomiche (di cui non riconobbe però il vero peso), da fattori indipendenti dalla volontà, come l’ereditarietà e le malattie nervose, che diminuiscono la responsabilità del criminale in quanto questi è in primo luogo un malato. In particolare nell’opera L’uomo delinquente, Lombroso sostiene l’ardita tesi secondo cui i comportamenti criminali sarebbero determinati da predisposizioni di natura fisiologica, i quali spesso si rivelano anche esteriormente nella configurazione anatomica del cranio. L’idea che la criminalità sia connessa a particolari caratteristiche fisiche di una persona è molto antica: la si trova già, ad esempio, nell’Iliade di Omero, nel cui libro II la devianza di Tersite è direttamente legata alla sua bruttezza fisica; le stesse leggi del Medioevo sancivano che se due persone fossero state sospettate di un reato, delle due si sarebbe dovuta considerare colpevole la più deforme. Memore di questa tradizione, Lombroso è convinto che la costituzione fisica sia la più potente causa di criminalità: e, nella sua analisi, egli attribuisce particolare importanza al cranio. Studiando quello del brigante Vilella, rileva che nell’occipite, anziché una piccola cresta, c’è una fossa, alla quale dà il nome di “occipitale mediana”. La cresta occipitale interna del cranio, prima di raggiungere il grande foro occipitale, si divide talvolta in due rami laterali che circoscrivono una “fossetta cerebellare media o vormiense”, che dà ricetto al verme del cervelletto. Questa caratteristica anatomica del cranio è oggi chiamata fossetta di Lombroso: egli riteneva si trattasse di un carattere degenerativo più frequente negli alienati e nei delinquenti, che classificava in quattro categorie: i criminali nati (caratterizzati da peculiarità anatomiche, fisiologiche e psicologiche), i criminali alienati, i criminali occasionali e quelli professionali. Ma Lombroso non limita la propria indagine al cranio: considerando anche le altre parti del corpo umano, egli arriva a sostenere che il “delinquente nato” ha generalmente la testa piccola, la fronte sfuggente, gli zigomi pronunciati, gli occhi mobilissimi ed errabondi, le sopracciglia folte e ravvicinate, il naso torto, il viso pallido o giallo, la barba rada. Influenzato dalle teorie di Darwin, Lombroso sostiene poi che il “delinquente nato” presenta delle caratteristiche ataviche, ossia simili a quelle degli animali inferiori e dell’uomo primitivo; tali caratteristiche renderebbero difficile o addirittura impossibile il suo adattamento alla società moderna e lo spingerebbero sempre di nuovo a compiere reati. Nella prospettiva lombrosiana domina il determinismo più assoluto, per cui quel che si fa dipende necessariamente da ciò che si è: privo di ogni libertà, l’uomo agisce in maniera deterministica e necessitata. Anche in forza delle dure critiche a cui la sua teoria fu sottoposta, Lombroso andò via via correggendola, sempre più arretrando dal suo iniziale determinismo assoluto: egli arrivò a sostenere che i delinquenti nati fossero solo un terzo di coloro che infrangevano le norme e che ogni delitto aveva origine in una molteplicità di cause. Lombroso indicò anche le conseguenze giuridiche della propria dottrina: poiché il crimine non è il frutto di una libera scelta (il che striderebbe con l’adesione ai canoni del Positivismo), ma è piuttosto la manifestazione di una patologia organica, cioè di una malattia, allora la pena deve essere intesa non come una punizione (ché non ha senso punire chi non ha agito liberamente), ma semplicemente come strumento di tutela della società.
In Genio e follia (1864) Lombroso sostenne che le caratteristiche degli uomini di genio vanno ricercate nella loro anormalità psichica; quest’opera fu considerata un classico della scienza positivistica ed ebbe enorme fortuna. A Torino lo studio di Lombroso era presso la Facoltà di Medicina Legale, dove effettuò centinaia di autopsie sui corpi di criminali, prostitute e folli. Fondò poi il Museo di Antropologia Criminale di Torino, che raccoglie i materiali di tutte le sue ricerche (da cimeli a reperti biologici, da corpi di reato a disegni, da manoscritti a fotografie e strumenti scientifici). Così scrive Lombroso a riguardo dell’uomo-delinquente:
Uno studio antropologico sull’uomo delinquente, e particolarmente di quella sua varietà che chiamiamo delinquente – nato, deve di necessità prendere le mosse dai primi caratteri fisici fondamentali che si rilevano alla tavola anatomica, per passare a quelli che si riscontrano nei viventi. Ma la grande massa degli esaminati e la ristrettezza dello spazio, ci consigliano a darne solo un riassunto sommario.
1) La capacità cranica dei criminali misurata con pallini di piombo offre in media cifre inferiori alle normali, e con una seriazione diversa, cioè con un maggior numero di grandi, 1600-2000 c.c., e di piccole, 1100-1300 c.c., capacità: eccedono cioè nel troppo o nel troppo poco sugli onesti e sono inferiori sempre nelle cifre medie. Vi è prevalenza di capacità minime nei ladri; e quando le grandi capacità dei rei non sono effetto di idrocefalia, sono spesso giustificate da un’intelligenza maggiore del normale come in certi capibriganti: Minder-Kraft c.c. 1631, Pascal 1771, Lacenaire 1690.
Quanto alla circonferenza cranica i criminali sono nelle quote minime press’a poco pari o di poco superiori ai normali; nelle quote superiori manca ogni cifra nei ladri, e gli assassini sono o pari o superiori ai normali.
Cosí pure le cifre della semicirconferenza cranica anteriore e posteriore, della proiezione anteriore degli archi e delle curve craniche provano il maggior volume del cranio normale in confronto al criminale.
Tra i diametri, oltre al traverso ed al longitudinale che servono alla determinazione dell’indice cefalico, è importante il diametro frontale minimo ch’è inferiore nei criminali per rispetto ai normali e piú basso nei truffatori e borsaiuoli; esso rivela quindi, come la semicirconferenza cranica anteriore, il minor sviluppo della porzione frontale del cervello nei criminali.
I criminali presentano l’esagerazione degli indici etnici senza predominio dell’una o dell’altra forma in essi e secondo i vari reati. Etnicamente prevalgono i brachicefali nell’Italia settentrionale, i dolicocefali nell’Italia meridionale e insulare; è caratteristica l’iperdolicocefalia nella Sardegna, nella Garfagnana e Lunigiana (Lucchesia), nella Calabria e in Sicilia, e l’ultrabrachicefalia nel Piemonte e nel Veneto; però gli assassini avrebbero in molte regioni d’Italia l’indice cefalico piú elevato.
CHARLES DARWIN

“Per parte mia vorrei piuttosto esser disceso da quella piccola eroica scimmietta che sfidò il suo terribile nemico per salvare la vita del proprio guardiano, o da quel vecchio babuino che, discendendo dalle montagne, portò via trionfante un suo giovane compagno da una torma di cani stupiti, piuttosto che da un selvaggio che trae diletto a torturare i nemici, consuma sacrifici di sangue, pratica l’infanticidio senza rimorso, considera le mogli come schiave, non conosce il pudore ed è tormentato dalle piú grossolane superstizioni. ” (L’origine dell’uomo).
VITA E OPERE
A cura di R. Cattania
Charles Darwin nacque il 12 febbraio 1809 a Shrewsbury, cittadina vicina a Birmingham. Indirizzato dal padre agli studi di medicina, egli focalizzò ben presto i propri interessi sulla storia naturale e venne a conoscenza delle idee che iniziavano a circolare in zoologia e botanica, in particolare la teoria di Jean Baptiste Lamarck, che però non lo colpì in modo particolare. Alla fine del 1827, a causa dei deludenti risultati scolastici, il padre decise che Charles si sarebbe dedicato alla vita ecclesiastica e lo mandò a Cambridge per proseguire gli studi; qui frequentò lezioni di botanica, iniziò a collezionare e classificare insetti e apprese le prime conoscenze di geologia, partecipando a una breve spedizione geologica nel Galles del Nord. Il 21 dicembre 1831 s’imbarcò come naturalista sul brigantino Beagle, attrezzato per compiere ricerche scientifiche e rilevazioni geografiche: il viaggio intorno al mondo durerà fino al 2 ottobre 1836. Nel corso di questo viaggio, Darwin raccolse un’ingente quantità di materiale e compì numerose osservazioni: a ogni tappa scendeva a terra e conduceva esplorazioni all’interno, raccoglieva e catalogava campioni di specie animali e vegetali, di cui descriveva le abitudini. Nel 1839 pubblicherà, con il titolo Viaggio di un naturalista intorno al mondo, il diario di queste esplorazioni; ma già al ritorno in Inghilterra i resoconti che aveva inviato ai suoi corrispondenti lo avevano fatto conoscere negli ambienti scientifici.
Fu nel corso del viaggio sul Beagle e negli anni immediatamente successivi che Darwin, sulla base delle osservazioni compiute, giunse alla conclusione che le specie si modificano gradualmente; gli anni successivi saranno dedicati all’elaborazione della teoria dell’evoluzione, con un intenso lavoro di riflessioni e osservazioni. Particolare rilievo ebbe l’attività di raccolta di dati, tesa alla documentazione dei diversi aspetti della teoria, quali la distribuzione geografica delle specie, le leggi della variazione, la divergenza dei caratteri, l’estinzione delle specie meno adatte, e così via. Darwin dedicò otto anni al lavoro sistematico ai cirripedi, una classe di organismi ancora poco studiata; realizzò anche un allevamento di colombi, con razze provenienti da diverse parti del mondo, per studiarne somiglianze e differenze e condurre esperimenti di selezione artificiale. L’accettazione della teoria dell’evoluzione aveva infatti posto un problema: se le specie non sono state create così come le conosciamo da un Creatore divino, come spiegare il loro adattamento all’ambiente in cui vivono? La soluzione venne dall’analogia tra la selezione operata dall’uomo per migliorare le razze domestiche e quella che avviene in natura. La lettura del Saggio sul principio di popolazione di Thomas Robert Maltus gli suggerì il meccanismo attraverso cui la selezione agisce in natura: la lotta per la sopravvivenza.
Nel 1859, dopo oltre vent’anni di elaborazione, uscì On the Origin of Species by Means of Natural Selection (L’origine delle specie per mezzo della selezione naturale); seguiranno anni di discussioni accanite e decise prese di posizione, con una sostanziale accettazione, nell’ambito scientifico, dell’idea di evoluzione, mentre maggiori resistenze incontrò il concetto di “selezione naturale”. Molto più decisa fu l’opposizione degli ambienti religiosi, che restavano legati all’interpretazione letterale della Bibbia, alla quale la dottrina darwiniana si opponeva in maniera radicale.
Darwin non si limitò a fornire innumerevoli prove dell’evoluzione come principio coordinante della storia della vita e a sviluppare la teoria della selezione naturale, ma diede contributi altrettanto importanti con i concetti di evoluzione ramificata, che implica la discendenza da un’origine comune di tutte le specie viventi, e di evoluzione graduale, contrapposta a quella a salti (mutazionismo). In seguito, Darwin affrontò anche il tema dell’origine dell’uomo: in Descent of Men and Selection in Relation to Sex (L’origine dell’uomo e la selezione sessuale) formulò la concezione naturalistica dell’uomo e illustrò il principio di continuità con gli animali. Si chiese anche quale fosse il valore da attribuire alle razze umane e giunse alla conclusione della discendenza da un unico ceppo comune, con successiva diversificazione: da qui l’introduzione del concetto di popolazione, che rende conto della variazione delle caratteristiche umane.
L’autore dell’Origine delle specie si preoccupò di elaborare una metodologia per la scienza della vita, che non può essere ridotta alle leggi della chimica e della fisica; egli può essere considerato il fondatore di un nuovo ramo della filosofia della scienza, la filosofia della biologia, che ha avuto una profonda influenza nello sviluppo del metodo scientifico in diverse discipline come la biologia evoluzionistica, la paleontologia, la geologia e la cosmologia. Altre opere di Darwin degne di essere ricordate sono Espressione dei sentimenti nell’uomo e negli animali e Le variazioni degli animali e delle piante allo stato domestico.
IL PENSIERO
A cura di G. Tortora
Dal suo viaggio, Darwin tornò con molti appunti e con la convinzione che in campo biologico c’è stata evoluzione delle specie nel corso del tempo: questo solo poteva spiegare la successione delle forme viventi in uno stesso luogo, documentata dall’esistenza di fossili, e la distribuzione attuale delle specie viventi. Ma tale convinzione doveva essere argomentata a dovere: bisognava studiare soprattutto la riproduzione e le leggi dell’adattamento all’ambiente da parte degli organismi viventi. Continuò cosí in patria la sua osservazione e procedette a varie sperimentazioni.
Evidentemente fatti come questi (cioè quelli osservati durante il viaggio) e molti altri si potevano spiegare supponendo che le specie si modificassero gradualmente; e questo pensiero mi ossessionava. Ma era ugualmente evidente che né l’azione delle condizioni ambientali, né la volontà degli organismi (specialmente nel caso delle piante) potevano servire a spiegare tutti quegli innumerevoli casi di organismi di ogni tipo mirabilmente adattati alle condizioni di vita…
Questi adattamenti mi avevano sempre vivamente colpito, e mi sembrava che finché essi non fossero stati spiegati sarebbe stato inutile cercare di dimostrare con prove indirette che le specie si sono modificate.
Dopo il mio ritorno in Inghilterra pensai che se avessi lavorato come aveva fatto Lyell nel campo della geologia, cioè raccogliendo tutti i fatti che hanno avuto relazione con la variazione degli animali e delle piante sia allo stato domestico sia in natura, avrei potuto portare qualche luce sull’argomento.
Lavorai secondo i principi baconiani, e, senza seguire alcuna teoria raccolsi quanti piú fatti mi fu possibile, specialmente quelli relativi alle forme domestiche, mandando formulari stampati, conversando con i piú abili giardinieri e allevatori di animali, e documentandomi con ampie letture.
(Autobiografia)
E proprio la documentazione relativa alle forme viventi domestiche gli fece balenare in mente la possibile soluzione. Giardinieri e allevatori ottengono variazioni nelle forme biologiche con la selezione artificiale; forse allora le variazioni verificatesi, nel corso del tempo, in natura sono dovute ad una selezione naturale.
Non tardai a rendermi conto che la selezione era la chiave con cui l’uomo era riuscito ad ottenere razze utili di animali e piante. Ma per qualche tempo mi rimase incomprensibile come la selezione si potesse applicare ad organismi viventi in natura.
(Autobiografia)
La conferma teorica del fatto che in natura agisce una legge generale di selezione naturale gli venne dalla lettura di un’opera che non rientrava immediatamente nell’orizzonte dei suoi interessi scientifici.
Nell’ottobre 1838 … lessi per diletto il libro di Malthus sulla Popolazione, e poiché, date le mie lunghe osservazioni sulle abitudini degli animali e delle piante, mi trovavo nella buona disposizione mentale per valutare la lotta per l’esistenza cui ogni essere è sottoposto, fui subito colpito dall’idea che, in tali condizioni, le variazioni vantaggiose tendessero ad essere conservate, e quelle sfavorevoli ad essere distrutte. Il risultato poteva essere la formazione di specie nuove. Avevo dunque ormai una teoria su cui lavorare.
(Autobiografia)
Sicché, riordinando le informazioni ch’egli aveva parzialmente raccolto e catalogato, arrivò alle seguenti conclusioni: la variazione delle condizioni ambientali e l’accrescimento numerico degli individui di una stessa specie pongono agli organismi viventi «problemi di adattamento»; essi vivono una vera «lotta per l’esistenza»; quelli che riescono a produrre in sé le variazioni (nella loro organizzazione biologica e nelle loro funzioni) adatte alle nuove condizioni, sopravvivono; quelli che non vi riescono arrivano fino all’estinzione; in quelli che sopravvivono i nuovi caratteri acquisiti, stabilizzatisi, si trasmettono «per ereditarietà»; quando essi sono stati acquisiti in modo irreversibile, possono costituire una trasformazione anche tanto radicale da rappresentare una vera mutazione della stessa specie, cioè essi possono dare «origine ad una nuova specie». Con ciò Darwin aveva spiegato la selezione naturale e aveva dato un fondamento all’evoluzionismo; ma non tutti i quesiti erano risolti:
In quel tempo però non afferrai un problema molto importante … Mi riferisco alla tendenza degli organismi discendenti da uno stesso ceppo a divergere nei loro caratteri, quando si modificano. Che essi si siano molto differenziati è provato dal fatto che le specie di tutti i tipi possono essere riunite in generi, i generi in famiglie, le famiglie in sottordini, e cosí via… La soluzione secondo me consiste nel fatto che la discendenza modificata delle forme dominanti e in via di sviluppo tende ad adattarsi a parecchi luoghi che hanno caratteristiche molto diverse nell’economia della natura.
(Autobiografia)
Era dunque spiegata, con la stessa teoria. anche la diversificazione, la differenziazione nell’ambito della stessa specie. Tutto questo Darwin scrisse nell’opera Origine delle specie, libro che ebbe subito un notevole successo di vendite, e trovò fortuna anche all’estero, tanto che in breve tempo fu tradotto in molte lingue. Tra l’altro Darwin osserva con divertito stupore:
Ne è comparso anche un saggio in ebraico, in cui si dimostra che la mia teoria è contenuta nel Vecchio Testamento!
(Autobiografia)
Ma quel libro trovò anche irriducibili avversari. Infatti esso poneva il problema della collocazione dell’uomo nella natura. Tale problema «scoppiò» soprattutto quando T. Huxley fece una strenua difesa dell’evoluzionismo; biologo, uomo di ingegno e di cultura, buon oratore, dotato ugualmente di senso dell ironia e di spirito battagliero, Huxley sostenne senza mezzi termini che l’uomo derivava dalle scimmie; tale affermazione fu all’origine di un vivace scontro col vescovo anglicano S. Wilberforce. Infatti l’evoluzionismo sembrava a molti la negazione dell’origine divina dell’uomo, dell’immortalità dell’anima, e di ogni fondamento della vita morale. Questa convinzione alimentava le discussioni non solo nell’ambito della chiesa anglicana, ma anche nei circoli borghesi e conservatori inglesi, stretti nella difesa della posizione «aristocratica» dell’uomo nella realtà naturale; difesa che trovò una formula efficace nell’affermazione di Disraeli che, fra le scimmie e gli angeli, egli preferiva come antenati gli angeli. Lo stesso Darwin si rendeva conto che la sua teoria sollevava problemi d’ordine morale, religioso, teologico, … ed anche politico. Infatti anche Marx ed Engels scesero in campo manifestando il loro entusiasmo per il darwinismo, che a loro avviso poteva essere esteso alla concezione della storia e della società; infatti i concetti di selezione naturale e di evoluzione potevano costituire la spiegazione «naturale» dello sfruttamento, della lotta di classe, e, in generale, la base di tutto il materialismo storico-dialettico, smentendo quella che essi definirono «la falsa legge di Malthus», che spiegava la lotta tra gli uomini, semplicisticamente, con la sproporzione tra l’incremento della popolazione e quello dei beni di sussistenza.
Di fronte all’enorme cumulo di questi problemi, proposti da ammiratori e denigratori, Darwin conservò un atteggiamento di serietà scientifica, cercando di ribadire e confermare la validità della sua teoria limitatamente al campo biologico (col che, evidentemente, raffreddò gli entusiasmi di Marx). Nell’opera L’origine dell’uomo, egli infatti sostenne:
La conclusione principale a cui siamo giunti qui… è che l’uomo è disceso da qualche forma meno altamente organizzata. Le basi di questa conclusione non saranno mai scosse, data la intima somiglianza tra l’uomo e gli animali inferiori, nello sviluppo embrionale ed in infiniti punti di struttura e di costituzione, sia di grande che di lieve importanza; i rudimenti che l’uomo conserva e le anormali reversioni a cui è occasionalmente soggetto, son tutti fatti che non si possono confutare. Essi sono noti da lungo tempo, ma fino a poco fa non ci dicevano niente sull’origine dell’uomo. Ma ora, visti alla luce delle nostre conoscenze di tutto il mondo dei viventi, il loro significato non può sfuggire. Il grande principio dell’evoluzione domina chiaro e fermo, quando questi gruppi di fatti son considerati in rapporto con altri, quali le affinità reciproche dei membri dello stesso gruppo, la loro distribuzione geografica nel passato e nel presente, e la loro successione geologica. Non si può assolutamente pensare che tutti questi fatti dicano il falso. Chi non si accontenta di pensare (come un selvaggio) che i fenomeni naturali non sono collegati, non può credere che l’uomo sia opera di un atto separato di creazione. Egli sarà costretto ad ammettere che l’intima rassomiglianza dell’embrione umano con quello, ad esempio, di un cane, la struttura del cranio, delle membra, dell’intera forma somatica dell’uomo ripete lo stesso modello di quella degli altri mammiferi (indipendentemente dall’uso a cui le singole parti sono destinate), la ricomparsa occasionale di varie strutture, per esempio, di parecchi muscoli che normalmente non sono presenti nell’uomo, ma che sono normali nei quadrumani, ed una quantità di fatti analoghi, tutti portano nella maniera piú evidente alla conclusione che l’uomo discende da un progenitore comune agli altri mammiferi.
(L’origine dell’uomo)
Pertanto, come nei regni vegetale ed animale, cosí anche in quello degli organismi umani dominano le leggi dell’ereditarietà, della lotta per l’esistenza e della selezione naturale.
Abbiamo visto che l’uomo presenta continuamente differenze individuali in tutte le parti del corpo e nelle facoltà mentali. Queste differenze o variazioni dipendono dalle stesse cause generali e obbediscono alle stesse leggi che negli animali inferiori. In entrambi i casi valgono le stesse leggi dell’eredità. L’uomo tende a moltiplicarsi molto al di là dei suoi mezzi di sussistenza, e di conseguenza è soggetto occasionalmente ad una grave lotta per l’esistenza e la selezione naturale agisce su tutto ciò che è nel suo campo d’azione. Non è affatto necessaria una successione di variazioni molto spiccate di natura simile, piccole, fluttuanti differenze individuali bastano per l’azione della selezione naturale; non vi è ragione di pensare che nella stessa specie tutte le parti dell’organizzazione tendano a variare nello stesso grado. Possiamo esser certi che gli effetti ereditari del continuo uso o disuso di parti agiscono intensamente nella stessa direzione della selezione naturale. Modificazioni dapprima importanti, anche quando non servono piú in qualche funzione particolare, rimangono per lungo tempo ereditarie. Quando una parte si modifica, altre parti cambiano per principio di correlazione, di cui abbiamo esempi in molti strani casi di mostruosità correlative. Si può attribuire qualche effetto all’azione diretta e definita delle condizioni ambientali, come l’abbondanza di cibo, il caldo o l’umidità; infine molti caratteri di leggera importanza fisiologica ed alcuni invece di notevole valore sono stati acquisiti per selezione sessuale.
(L’origine dell’uomo)
Anzi, proprio in virtù delle leggi generali dell’evoluzione è possibile spiegare le differenze tra le diverse razze umane, e ricondurre queste ad un unico ceppo.
Mediante i mezzi prima detti e con l’aiuto forse di altri non ancora scoperti, l’uomo si è elevato al suo stato attuale. E dal momento in cui ha raggiunto il suo posto di uomo, si è distinto in razze, o, come si possono chiamare piú propriamente, sotto-specie differenti. Alcune di queste, come i negri e gli Europei, sono cosí diverse tra di loro, che se si portassero ad un naturalista degli esemplari, senza nessun’altra notizia, egli le giudicherebbe senza dubbio come specie differenti. Nondimeno tutte le razze umane concordano in tanti insignificanti dettagli strutturali e in tante particolarità mentali, da poterle soltanto attribuire all’eredità da un comune progenitore; un progenitore con queste caratteristiche avrebbe probabilmente meritato il posto di uomo.
(L’origine dell’uomo)
Ed è possibile pure individuare gli «antenati» prossimi e remoti dando loro una collocazione nella «serie zoologica».
Se consideriamo la struttura embriologica dell’uomo, le analogie con gli animali inferiori, i rudimenti che conserva, e la reversione cui è soggetto, possiamo in parte immaginare la condizione primitiva dei nostri progenitori e possiamo approssimativamente collocarli in un posto appropriato nella sene zoologica. Impariamo cosí che l’uomo è disceso da un quadrupede peloso, provvisto di coda, probabilmente con l’abitudine di vivere sugli alberi e che abitava il Vecchio Continente. Se un naturalista avesse esaminato l’intera struttura di questo essere l’avrebbe classificato tra i Quadrumani, con la stessa sicurezza con cui avrebbe classificato l’ancora piú antico progenitore delle scimmie del Vecchio e del Nuovo Continente. I quadrumani e tutti i mammiferi piú elevati derivano probabilmente da qualche antico marsupiale e questo, attraverso una lunga discendenza di forme che andavano divergendo, da qualche creatura simile agli Anfibi, e questi ancora da qualche animale simile ai pesci. Nella profonda oscurità del passato, possiamo intravedere che il primo progenitore di tutti i Vertebrati deve essere stato un animale acquatico, provvisto di branchie, coi due sessi riuniti nello stesso individuo e con la maggior parte degli organi piú importanti (come il cervello e il cuore) imperfettamente o per nulla sviluppati. Questi animali dovevano esser piú simili alle attuali ascidie di mare che a qualsiasi altra forma conosciuta.
(L’origine dell’uomo)
Certo, restano da «spiegare» le qualità intellettuali e morali, e le attitudini e capacità ad esse connesse, che sembrano essere caratteristiche specifiche ed esclusive dell’uomo. Ma Darwin non si sottrasse a questo compito. Egli infatti sostenne che le qualità morali sono espressione matura di istinti sociali propri anche degli animali, di quegli istinti per i quali gli animali si aggregano, ad esempio, secondo «vincoli familiari». E quanto alle facoltà intellettuali superiori (raziocinio, astrazione, autocoscienza), esse sono l’esito del miglioramento di quelle facoltà mentali che anche gli animali mostrano di possedere attraverso il linguaggio e l’arte con cui organizzano la loro vita.
Dopo essere giunti a questa conclusione sull’origine dell’uomo, la piú grande difficoltà che si presenta rimane l’alto livello delle nostre facoltà intellettuali e morali. Chiunque ammetta l’evoluzione sa che le facoltà mentali degli animali superiori, le quali sono della stessa specie di quelle dell’uomo, sebbene di grado cosí differente, sono suscettibili di progredire. Cosí il divario tra le facoltà mentali di una delle scimmie piú elevate e quelle di un pesce, oppure quelle di una formica e di un coccus, è immenso; inoltre il loro sviluppo non offre nessuna speciale difficoltà, infatti negli animali domestici le facoltà mentali sono variabili e le variazioni sono ereditarie. Nessuno dubita che le facoltà mentali sono della massima importanza per gli animali allo stato naturale. Vi sono quindi tutte le condizioni per il loro sviluppo mediante la selezione naturale. La stessa conclusione si può estendere all’uomo: l’intelletto deve essere stato molto importante per lui anche in un periodo molto remoto, perché gli ha permesso di inventare e usare il linguaggio, di costruire armi, utensili, trappole, ecc., in modo che con l’aiuto della sua abitudine di vivere in società, egli molto tempo fa riuscí a dominare tutti gli esseri viventi.
Un grande passo nello sviluppo dell’intelletto si ebbe non appena entrò in uso il linguaggio, per metà arte e per metà istinto; infatti il continuo uso del linguaggio deve aver agito sul cervello e determinato un effetto ereditario; e questo a sua volta ha agito sul miglioramento del linguaggio. La grandezza del cervello dell’uomo, relativamente al corpo, in confronto agli animali inferiori, può attribuirsi in massima parte ad un primitivo uso di una semplice forma di linguaggio, quel congegno meraviglioso che assegna parole ad ogni sorta di oggetti e di qualità, e suscita una serie di pensieri che non sorgerebbero mai dalla pura impressione dei sensi, o anche se si formassero non avrebbero alcun seguito. Le facoltà intellettuali piú elevate dell’uomo, come il ragionamento, l’astrazione, e la coscienza, probabilmente derivarono dal continuo miglioramento ed esercizio delle facoltà mentali.
(L’origine dell’uomo)
L’uomo dunque, per Darwin, è un essere «superiore», ma le sue origini biologiche sono animalesche; il che non deve procurar vergogna; anzi egli rappresenta proprio la punta piú avanzata dell’evoluzione naturale.
BRUNO BAUER

” Ora che la religione è stata recisa dalla ragione, dal pensiero, ormai il pensiero sarebbe emancipato, sarebbe in libertà come il contenuto religioso ed il cuore: ed allora si potrebbe passare ad una vera lotta tra le due parti, senza intermediari, ad una lotta sul cui esito, la distruzione della religione, non ci sarebbero dubbi. ” (La tromba del giudizio universale contro Hegel ateo e anticristo)
PRESENTAZIONE
La poliedrica attività di Bauer, il quale si interessò, oltre che di filosofia, anche di storia e teologia, si può dividere in due fasi distinte, separate dalle rivoluzioni del 1848. Negli anni ‘40 dell’Ottocento, in quel periodo noto come Vormärz, il preludio agli eventi rivoluzionari tedeschi del marzo 1848, Bauer era uno dei principali esponenti della sinistra hegeliana: propugnava un’interpretazione repubblicana di Hegel e sosteneva una lettura che riusciva a combinare temi etici ed estetici. La sua teoria dell’infinita autocoscienza, derivata dalla riflessione hegeliana sullo spirito soggettivo, poneva l’accento sull’autonomia razionale e sottolineava il valore del progresso storico. Studiando le fonti testuali del Cristianesimo, Bauer pervenne a definire la religione come una forma di alienazione, tramite la quale, a causa delle carenze della vita terrena, poteri irrazionali e trascendenti venivano proiettati fuori dall’individuo, mentre interessi particolari e materiali venivano privati di ogni valore. Egli assumeva inoltre una posizione critica nei confronti della Restaurazione, della sua base sociale e giuridica e della sua ideologia religiosa ortodossa. Dedicatosi all’analisi dell’emergente società di massa, da una parte rifiutava la teoria del liberalismo, a causa della sua irragionevole opposizione all’ordine esistente e della sua equazione “libertà = proprietà”, dall’altra, accusava il socialismo di non dare un’adeguata importanza all’autonomia individuale.
Dopo le sconfitte del 1848, Bauer ripudiò Hegel. Profetizzava un’imminente crisi generale della civiltà europea, dovuta alla sterilità della filosofia e al fallimento delle politiche liberali e rivoluzionarie. Nuove prospettive di liberazione, egli credeva, sarebbero però sorte da questa crisi.
Nei suoi scritti più tardi esamina l’emergere della Russia nel ruolo di potenza mondiale, potenza che avrebbe inaugurato un’era di imperialismo globale e di guerra: furono questi scritti che influenzarono Nietzsche nella formazione della sua idea di un rinnovamento culturale.
Friedrich Engels e Karl Kautsky rivendicarono il criticismo religioso di Bauer al movimento socialista, mentre il conservatorismo anti-tradizionalista e l’anti-semitismo delle sue opere più tarde contribuirono ad avvicinare il suo nome alla destra rivoluzionaria del XX secolo.
VITA E OPERE
La famiglia di Bauer si trasferì dalla Sassonia a Berlino nel 1815. All’università di Berlino (1828-1834), egli studiò sotto la guida di Hegel, di Schleiermacher e degli hegeliani Hotho e Marheineke. Il suo saggio del 1829 sull’estetica kantiana, segnalato da Hegel, vinse il Premio Reale Prussiano di filosofia.
Dal 1834 al 1839, tenne delle lezioni in teologia e testi biblici a Berlino, finché non fu trasferito alla Facoltà di Teologia di Bonn per aver attaccato in un suo scritto il suo collega ed ex-insegnante Hengstenberg. Insegnò a Bonn dal 1839 fino alla primavera del 1842, quando fu destituito per la non-ortodossia dei suoi scritti sul Nuovo Testamento: in particolare per l’opera La tromba del giudizio universale contro Hegel ateo e anticristo. Un ultimatum (1841). Il licenziamento fu la conseguenza di un consulto svoltosi tra il Ministero dell’Educazione e le Facoltà di Teologia delle sei università prussiane: l’ordine di licenziamento di Bauer venne direttamente dal re di Prussia, Federico Guglielmo IV. Il re decretò la sospensione dall’impiego di tutti coloro che avevano partecipato al banchetto in onore del liberale Karl Welcker a Berlino: in quella occasione, Bauer aveva proposto un brindisi alla concezione hegeliana dello Stato.
Dal 1842 al 1849, Bauer fu attivo sia nel giornalismo politico che nella ricerca storica, con particolare interesse all’Illuminismo e alla Rivoluzione Francese. Si schierò contro l’emancipazione degli ebrei prussiani nel 1842-43, considerando questa proposta una legittimazione politica di interessi religiosi particolari: fu perciò oggetto di attacchi polemici da parte di Marx ed Engels nella Sacra famiglia (1844) e ne L’ideologia tedesca (scritta nel 1845-46).
Con il fratello Edgar, Bauer fondò nel 1848 la “Società Democratica di Charlottenburg”, candidandosi senza successo alle elezioni per l’Assemblea Nazionale Prussiana, adottando un programma elettorale basato sulla sovranità popolare.
Rimanendo in Prussia dopo le sconfitte del 1848-49, Bauer continuò a scrivere opere di critica biblica e analisi politica.
Verso la metà degli anni 50, iniziò a lavorare per Die Zeit, un quotidiano sostenuto dal governo, nel quale il suo anti-liberismo ebbe una svolta conservatrice. Scrisse articoli su questioni di interesse internazionale anche per molti altri quotidiani, come Die Post, il Kleines Journal o il New York Daily Tribune.
Dal ’59 al ’66 collaborò col conservatore F.W.H. Wagener al suo Staats und Gesellschafts Lexikon, curando l’edizione di quasi tutti i 23 volumi e scrivendo numerosi articoli, alcuni dei quali evidenziano il suo antisemitismo. Nel 1865 acquistò una piccola fattoria a Rixdorf, alla periferia di Berlino. Lì morì nell’aprile del 1882.
I PRIMI SCRITTI
Bauer fu uno scrittore molto prolifico: pubblicò almeno una dozzina di libri ed oltre 60 articoli soltanto nel periodo 1838-48. Questi scritti comprendono analisi del pensiero di Hegel, della Bibbia, delle teologie moderne, dell’Illuminismo, della Rivoluzione Francese e le sue conseguenze storiche.
L’interpretazione delle opere di Bauer è problematica per varie ragioni. A causa dell’anonimato, dell’uso di pseudonimi e della collaborazione a pubblicazioni collettive, l’attribuzione di alcune opere è molto discussa; ed esistono inoltre parecchie divergenze tra i testi che Bauer ha pubblicato e la sua corrispondenza privata. Infine, nell’anonimo La tromba del giudizio universale (1841) e in La dottrina hegeliana della religione e dell’arte (1842), Bauer non parla in prima persona, ma indossa la maschera ironica di un critico hegeliano conservatore, attribuendo ad Hegel le proprie visioni rivoluzionarie.
Si possono distinguere tre linee interpretative del pensiero di Bauer, e tutte focalizzano l’attenzione sui suoi primi lavori (i suoi scritti più tardi hanno generalmente attirato una scarsa attenzione critica).
La prima linea interpretativa vede Bauer come un soggettivista radicale, la cui critica religiosa e sociale è più vicina al razionalismo illuminista che a Hegel.
La seconda, ampliamente influenzata da Marx, insiste sull’’abbandono da parte di Bauer della sinistra hegeliana dopo il 1843.
La terza sottolinea la continuità tra le due fasi del pensiero di Bauer attraverso il periodo del Vormärz e il suo repubblicanesimo, basato sull’idea hegeliana dell’unità di pensiero ed essere.
Lo scritto del 1829 dal titolo De pulchri princiipis, vincitore del Premio Reale Prussiano, presenta l’unità di concetto e realtà come idea centrale dell’idealismo hegeliano: esaminando questa unità, che si esprime nel suo livello più alto nell’opera d’arte, Bauer compara la teoria estetica di Hegel alla terza critica kantiana. Lo scritto integra il criticismo di Kant con le Lezioni di Estetica hegeliane di Berlino e con l’analisi logica delle categorie fornite dall’Enciclopedia delle scienze filosofiche (1827). Bauer sostiene che, mentre la Critica del Giudizio tenta di trovare un ponte tra pensiero ed essere, ripresenta in realtà le antinomie caratteristiche delle prime due critiche. La sintesi kantiana è fallita poiché continua a considerare il concetto come meramente soggettivo e l’oggetto come l’inconoscibile cosa in sé che trascende il potere cognitivo umano. L’autocoscienza, o il soggetto dell’unità dell’appercezione trascendentale, resta inaccessibile anche alla cognizione kantiana.
Nei sillogismi hegeliani dell’Idea, l’oggetto ottiene una forma razionale e contemporaneamente il concetto raggiunge un’esistenza esplicita, materiale. La bellezza, la vita e l’Idea sono momenti del processo che costituisce la realtà della ragione: come unità immediata di pensiero ed essere, come momento in cui lo Spirito acquista coscienza di se medesimo nella forma dell’intuizione sensibile, l’arte illustra l’inesauribile fecondità dell’Idea filosofica. Lo scritto sottolinea inoltre il contrasto tra fede e ragione tramite una critica alle concezioni religiose di unità di pensiero ed essere. La fede era considerata nemica del libero pensiero, caratteristica peculiare della Ragione.
Durante gli anni ’30, tuttavia, Bauer tentò di conciliare pensiero ed essere attraverso l’idea di una fede razionale. In Zeitschrift für spekulative Teologie, pubblicato tra il 1836 e il 1838, e in Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik, offre un’interpretazione delle dottrine cristiane come esemplificazione di categorie logiche. In La religione dell’Antico Testamento, del 1838, Bauer rappresenta l’esperienza religiosa come un prodotto dell’autocoscienza. Propone sia una spiegazione trascendentale, focalizzata sulle “condizioni di possibilità” delle varie esperienze religiose, sia un modello fenomenologico, incentrato sulla successione delle loro forme: la subordinazione gerarchica ad una divinità autoritaria nei primi libri dell’Antico Testamento esprime una rapporto meramente esteriore tra l’uomo e Dio, mentre la coscienza messianica dei libri successivi mostra il rapporto in una forma più elevata: non più la trascendenza di Dio, bensì l’immanenza dell’universale nella comunità umana; ma questa nuova coscienza può soltanto evidenziare l’inadeguatezza dei rapporti stabiliti con la vecchia alleanza, non può ancora portare all’effettivo superamento di quel distacco.
I testi degli anni ’30 individuano la struttura logica della coscienza religiosa: un’immediata identità tra il particolare concreto (soggetto o comunità) e l’universale astratto, un’unità raggiunta senza nessuna autotrasformazione. A partire dal 1839, Bauer cominciò a dedurre anche le implicazioni politiche di questa visione: a livello politico-sociale la coscienza religiosa asserisce questa identità immediata come una rivendicazione monopolistica e settaria che esclude ogni differente realtà particolare da una considerazione equivalente. L’essenza della religione è qui, per Bauer, un particolarismo arrogante, che conferisce all’universale uno status trascendente, come un dominio separato da ogni relazione sociale concreta. Questa posizione ebbe la sua esposizione più completa nell’opera Cristianesimo rivelato (1843). Bauer aveva già abbozzato questa tesi in Herr Dr. Hengstenberg (1839), rompendo pubblicamente con la linea ortodossa e conservatrice della cristianità ed evidenziando la discontinuità tra cristianesimo ed ebraismo.
Egli presenta la libera autocoscienza filosofica come opposta a tutte le forme di concezione religiosa. Il suo radicalismo politico e il suo repubblicanesimo sono tenuti insieme proprio dal riconoscimento di un’identità strutturale tra gli interessi privati portati avanti dalla Restaurazione e la monopolistica coscienza religiosa dominante.
GLI STUDI BIBLICI
La radicalizzazione politica e teoretica di Bauer è evidenziata soprattutto dai suoi studi biblici. Consideriamo la Critica del Vangelo di Giovanni (1840) e i tre volumi della Critica dei Vangeli Sinottici (1840-42): insieme ai suoi studi del 1838 sull’Antico Testamento, tutte queste opere sono dedicate alla critica dei vari stadi della religione rivelata e delle forme dello spirito auto-alienato nella storia. La critica di Bauer al vangelo di Giovanni è tesa a dimostrare l’opposizione tra la libera autocoscienza e lo spirito religioso: il suo scopo dichiarato era quello di restituire il principio cristiano alla sua fonte originaria, l’autocoscienza creativa; qui egli non si sta opponendo al principio in sé, ma cerca piuttosto di differenziarlo e di liberarlo dal dogmatismo ecclesiastico. La positività del cristianesimo deriva dalla comprensione astratta della teologia, piuttosto che dalla ragione speculativa: una comprensione che riduce l’esperienza religiosa ai suoi elementi soggettivi. Il nocciolo razionale del cristianesimo è l’identità di Dio e uomo, ma la teologia ha costruito su queste fondamenta un sistema dottrinale insostenibile. La speculazione teologica, secondo quanto Bauer afferma nei suoi articoli della metà degli anni ’30, è ciò che mina il dogma cristiano, non ciò che lo rafforza. Nelle lettere della sua corrispondenza privata, egli individua in questa ripristinazione dell’originario principio cristiano anche il suo rovesciamento, poiché l’unità di universale e particolare può ora essere ottenuta in forme più tangibili, terrene, concrete. Il cristianesimo è stata una tappa necessaria, ma ora superata, nello sviluppo dello spirito umano, una tappa che dovrà essere soppiantata dalle nuove espressioni dell’autocoscienza autonoma.
Nella Critica dei Vangeli Sinottici, l’obiettivo di Bauer è più apertamente quello di negare e confutare il cristianesimo dogmatico, ormai cristallizzato in forme atte a difendere l’ordine assolutistico. Nella sua visione, i fatti narrati nei Vangeli sono i prodotti della coscienza religiosa, piuttosto che di cronache fattuali: nello stesso modo in cui la critica del Vangelo di Giovanni aveva mostrato come la narrazione evangelica fosse solo un prodotto letterario, questa seconda opera sostiene che nemmeno i Sinottici contengono del materiale storico autentico. Bauer stabilisce la priorità storica di Marco, studiando le modificazioni specifiche operate successivamente da Luca e Matteo. Rappresenta i miracoli come delle false ostentazioni della causalità immediata dell’universale nella natura, rigettando le spiegazioni naturalistiche sostenute dal razionalismo teologico.
Il terzo volume della Critica dei Vangeli Sinottici arriva a negare la storicità di Cristo: l’idea cristiana di Dio e uomo che condividono la stessa essenza appare come la rappresentazione religiosa del singolo individuo che perviene ad assumere l’universale potere dello Spirito. Bauer, come i suoi contemporanei Strauss e Feuerbach, guarda a questa sintesi come al frutto di un progetto immanente alla storia umana. Come mostrano anche gli scritti politici di Bauer di questo periodo, egli ritiene che il raggiungimento dell’universalità e l’abbandono degli interessi particolari siano obiettivi storici di cui si deve fare carico lo Stato. Il cristianesimo, invece, elimina questa pur minima Sittlichkeit in favore di un “Io” puramente astratto, portando così a termine il processo di alienazione e rendendone necessaria una risoluzione. Analizzando i testi Sinottici, Bauer paragona il cristianesimo al feudalesimo, difendendo la libertà e l’uguaglianza dell’autocoscienza: religione e Stato assolutistico si sostengono vicendevolmente, condividendo le essenziali caratteristiche dell’alienazione e della repressione. In definitiva, il cristianesimo rappresenta l’ultima tappa della trasformazione della coscienza religiosa in astrazione pura e della dissoluzione di ogni vincolo etico e morale.
L’applicazione politica dell’autocoscienza può essere rintracciata in due scritti dei primi anni ’40. In Lo Stato-Chiesa evangelico della Prussica e la scienza (1840), Bauer descrive l’essenza dello Stato come libero sviluppo: lo Stato è l’agente dialettico del progresso storico e dell’universalità della volontà razionale, grazie alla sua peculiare capacità di astrarre da ogni contenuto dato ed esprimersi in forme sempre nuove. Pur segnalando quelle tendenze dannose che potrebbero limitare la funzione progressivo-dialettica dello Stato (come la preponderanza degli interessi religiosi o la titubanza nell’affrontare questioni sociali), Bauer afferma che lo Stato “genuino”, in quanto vera espressione della libertà, è ognora in costante mutamento. Nell’unione tra chiese luterane e riformate, avvenuta in Prussia nel 1817, egli vedeva il superamento politico dei contrasti religiosi, le basi dei quali erano già state intaccate dall’Illuminismo. Attraverso il suo (seppur ancora astratto) raggiungimento del concetto universale di uomo, l’Illuminismo aveva trasformato la coscienza religiosa in autocoscienza (questo processo è uno dei temi principali di Bauer in Cristianesimo rivelato, insieme ad una critica del materialismo francese, per lo scarso spazio che quest’ultimo lascia alla libertà).
La Chiesa è, per Bauer, incapace di reggersi senza il supporto dello Stato: opponendosi a quegli storici conservatori che, come F.J. Stahl, portavano avanti l’idea dell’indipendenza della Chiesa, il nostro indica invece lo Stato come il cuore della vita etica. Bauer denuncia non solo lo Stato cristiano di Federico Guglielmo IV, ma anche il formale Rechtsstaat, il costituzionalismo liberalistico: entrambe queste politiche, infatti, considerano la libertà come preservazione degli interessi privati, sia economici che religiosi. In realtà, questi interessi privati e particolari, sono proprio ciò da cui ci si deve liberare se si vuole raggiungere il nuovo ordine politico: l’eliminazione dell’egoismo atomistico tramite l’autocoscienza morale è il prerequisito principe per uno Stato libero e repubblicano.
A CONFRONTO CON HEGEL
L’anonimo La tromba del giudizio universale contro Hegel ateo e anticristo (novembre ’41) e il suo seguito La dottrina hegeliana della religione e dell’arte (1842) ci descrivono un Hegel che suona la campana della rivoluzione: Bauer mostra come tra le conseguenze del sistema si abbia anche il rovesciamento della Chiesa e dello Stato e ammette che la destra hegeliana abbia ragione a vedere nel filosofo di Stoccarda il più pericoloso avversario della Restaurazione. Ironicamente scritti come se fossero le parole di un critico pietista e conservatore, questi due testi attribuiscono ad Hegel una teoria dell’infinita autocoscienza nella quale il concetto di una sostanza o di un assoluto trascendente è un’illusione necessaria, ma autocontraddittoria. L’obiettivo che, dietro la maschera della narrazione, Bauer si pone è quello di mostrare come la filosofia di Hegel, se letta in trasparenza, sia incompatibile con le tesi della Destra, che, se onesta, in Hegel non può vedere altro che un ateo e un anticristo.
Più avanti, Bauer notò, nel pensiero hegeliano, una sorta di tensione tra Spinoza e Fichte, tra una sostanza inerte ed indifferenziata e la forma creativa: il momento spinozistico, tuttavia, sebbene necessario alla dialettica hegeliana, viene comunque superato e totalmente assimilato nell’infinita autocoscienza. Nello spirito assoluto, propriamente inteso, svaniscono tutte le pretese religiose, mentre l’assoluto stesso si dispiega nell’attività critica dei soggetti individuali: nulla di trascendente rimane. Ciononostante, riconosce Bauer, Hegel stesso sottolinea il concetto di sostanza, un concetto del cui ruolo bisogna rendere conto. Nella sua apparente trascendenza, la sostanza regola il soggetto particolare: ciò è necessario perché, come sostiene Hegel, la particolarità non può essere il criterio della ragione, né pratica né teoretica. Piuttosto, sono gli individui a dover interiorizzare la sostanza, come uno stadio del processo che porta al raggiungimento dell’autocoscienza. L’indifferenziata e pura universalità della sostanza sussume tutte le particolarità, incluso l’io, il sé.
Questo iniziale momento spinozistico crea un’apparenza di panteismo nel pensiero di Hegel, un’illusione che, secondo Bauer, ha ingannato critici del calibro di D.F. Strauss. Tramite il superamento dialettico dell’illusione della sostanza, l’unità di concetto e oggetto può per la prima volta essere intravista. Il soggetto deve apparire come potenzialmente universale e l’oggettività deve presentarsi come un ordine finalistico, in modo da rispondere alla tensione del soggetto verso la libertà razionale. La soggettività assimila così il principio dell’universalità, lo contiene in sé come una sua propria caratteristica, non come qualcosa che le è estraneo o alieno. Questa relazione, tuttavia, non è limitata all’esperienza interna, poiché la ragione realizza se stessa nella totalità del mondo: Bauer descrive l’autocoscienza così raggiunta come un’universalità soggettiva e immanente, come la forza motrice della storia. L’idealismo storico e critico che quest’opera attribuisce ad Hegel è politicamente rivoluzionario: sostiene, infatti, i diritti della libera autocoscienza contro ogni istituzione positiva (Stato, religione o gerarchia sociale).
Bauer utilizza il concetto-chiave di infinita autocoscienza per riconfigurare l’assoluto hegeliano, da un lato avvicinando tra loro l’arte e la filosofia e dall’altro escludendo la religione, in quanto forma alienata della ragione.
L’idealismo etico di Bauer ricorda ciò che Kant chiamava Vollkommenheit, una forma di eteronomia razionale per la quale l’azione è giudicata in base al suo contributo al progresso storico. I soggetti acquistano autonomia liberandosi dagli interessi particolari e ripudiando quei falsi universali rappresentati dalle istituzioni politiche e religiose. Bauer attacca l’ancien régime e i tutti quei surrogati prodotti dalla Restaurazione, definendoli un sistema feudale a tutela di privilegi irrazionali. Riservando arrogantemente per se stesso l’universalità, lo Stato autoritario sopprime le realtà particolari, frustra la libera attività del suo popolo e cela la fonte della sua autorità dietro ad un velo di santità religiosa. Bauer precisa che è lo Stato assolutistico, e non la religione, il vero avversario: la questione politica decisiva è quella di individuare la fonte dell’autorità statale, sia che essa risieda nella tradizione, nell’approvazione religiosa o nel volere popolare.
Questa questione dovrà essere affrontata senza compromessi; l’obiettivo finale è, infatti, un’emancipazione sociale, non solo politica. Questa questione potrà essere risolta solo con una lotta comune e repubblicana contro ogni tipo di privilegio. Il risultato di questa lotta sarà l’ottenimento della giustizia in tutte le sfere della vita sociale.
LA SVOLTA CONSERVATRICE
Sebbene Bauer proclamò a più riprese la continuità del suo pensiero, i suoi lavori più maturi furono caratterizzati dal definitivo abbandono delle tendenze repubblicane del Vormärz: le sconfitte del 1848 dimostrano il fallimento della tradizione filosofica europea. Al posto del trionfo della repubblica, Bauer profetizzava ora un’età di imperialismo mondiale. La questione politica decisiva dopo il ’48 era l’emergere della Russia, e Bauer sosteneva che proprio la crescente pressione della potenza russa avrebbe portato ad un’unione pan-europea, primo stadio del processo verso l’assolutismo globale. Il periodo storico che stava per venire sarebbe stato caratterizzato da una vera e propria crisi continentale: anticipando Nietzsche, Bauer affermava che l’imminente crollo della civiltà e della cultura europea avrebbe reso possibile un nuovo inizio, accompagnato dalla liberazione dai valori tradizionali e da tutte le menzogne metafisiche e religiose. La sua vecchia opposizione al liberalismo lo portò ora a schierarsi dalla parte dei conservatori, sebbene il suo conservatorismo rimase sempre non-ortodosso: come Nietzsche, infatti, un suo tratto precipuo fu il disprezzo per la tradizione e la religione.
A causa del suo antisemitismo, Bauer fu in seguito definito indebitamente un precursore del nazismo da qualche autore del Reich.
Per Bauer, i moti rivoluzionari del ’48 erano così legati ai progetti e alle idee illuministiche, kantiane ed hegeliane che il loro fallimento suona come il rintocco funebre di quella filosofia e dei suoi continui richiami ad un’autonomia razionale individuale. In questa critica, Bauer assimila Hegel a Spinoza e alla sua metafisica della sostanza, vista come la negazione di forma e soggettività. A differenza delle sue precedenti interpretazioni, nei testi dei primi anni ’50 egli afferma che Hegel aveva ceduto all’influenza di Spinoza, eliminando l’individualità e sommergendo le realtà concrete e particolari sotto categorie logiche illusorie ed astratte. Il nostro descrive ora l’Idea hegeliana come un’illusione trascendente: la sua incapacità di ammettere le realtà particolari deriva dalla sostanzialità del sistema stesso.
Sul fronte politico, mentre prima del ’48 Bauer era solito sostenere che Hegel aveva insegnato “la repubblica e la rivoluzione”, ora egli mostra tutte le tendenze assolutistiche del sistema hegeliano, la cui unità oppressiva può essere paragonata tendenza storica verso un dispotismo politico onnicomprensivo: egli accusa la filosofia di contribuire a quel processo di livellamento ed uniformità attuato nel periodo post-rivoluzionario (Bauer, Russland und das Germanenthum). Questo atteggiamento critico anticipa la polemica di Rudolph Haym in Hegel und seine Zeit (1857).
L’abbandono della metafisica, tratto che Bauer condivide con molti intellettuali post-1848, produce una nuova concezione della critica filosofica, vista ora come una scienza positiva o un’indagine empirica. Questa forma di critica permette all’osservatore di esaminare i fenomeni storici senza alcuna distorsione o parzialità, senza una concezione sistematica a priori. Bauer ritiene, ad esempio, che la ricerca scientifica debba rimanere indipendente e dalla religione e dalla politica: l’obiettivo principe della scienza è, infatti, quello di studiare le relazioni tra la natura e le leggi che la governano, nell’ottica della libera volontà dell’uomo (tutti concetti che Bauer mantiene anche in questa seconda fase, rifiutandone però il fondamento metafisico).
Il nuovo atteggiamento è quello di una disinteressata contemplazione dell’ineluttabile processo di decadimento e rigenerazione culturale.
La conclusione delle nuove riflessioni di Bauer è che in futuro dominerà la forma politica dell’imperialismo sovranazionale, una forma che implicherà il contrasto e il confronto fra due diverse realtà assolutistiche: l’Europa occidentale e quella orientale.
Nella realtà occidentale Bauer distingue due varianti: da una parte abbiamo lo stato socialista di Bismarck, costruito sul modello militare della Prussia del XVIII secolo, che cerca di assoggettare la produzione economica al controllo politico, soffocando l’innovazione e l’indipendenza personale; dall’altra l’imperialismo romantico di Disraeli, che tenta di uniformare la società inglese per poterla più facilmente sottometterla ad una monarchia paternalistica.
La seconda realtà assolutistica, quella orientale, è costituita dalla Russia, una potenza la cui coesione interna deriva dalla fusione del potere politico con quello ecclesiastico e dall’assenza delle moderne idee di soggettività ed individualismo. Bauer nota che Hegel aveva erroneamente escluso la zona orientale dalla sua visione di storia globale: come l’anarchico Michail Bakunin, il nostro sottolinea invece come la Russia possieda una sua propria ben definita struttura statale, totalmente distinta da quella tedesca.
La forza dell’avversario orientale costringerà l’Europa ad entrare in un processo di trasformazione che implicherà necessariamente l’estensione dell’imperialismo a tutto il mondo e lo scontro tra le potenze dominanti. La guerra mondiale sarà inevitabile.
Questa prognosi anticipa alcuni aspetti della teoria dell’ultraimperialismo che Karl Kautsky avrebbe elaborato nel 1915, sebbene in Bauer non sia presente la convinzione ottimistica che questa tendenza avrebbe comportato una riduzione dei conflitti tra i pretendenti all’egemonia. Nessuna forma di ottimismo è rilevabile in Bauer: l’imperialismo, ad esempio, non stimola, anzi, ostacola la crescita economica, in quanto l’insicurezza e la mobilitazione militare permanente penalizzano l’attività produttiva.
La funzione storica precipua del processo di globalizzazione è quella di eliminare le identità nazionali, gettando così le basi per un’eventuale rinascita cosmopolita. Bauer guarda infatti al nazionalismo come ad una forza dissipativa: il nuovo ordine mondiale non sarà caratterizzato dalla difesa degli interessi locali e nazionali, ma dallo sforzo per una comune supremazia sovranazionale. Il sempre più crescente accentramento del potere sarà favorito dalle tendenze internazionaliste ed uniformatrici del movimento socialista, che porterà con sé quello che Bauer definisce pauperismo politico, un generalizzato calo di potere partecipativo del singolo all’attività politica. La conclusione più logica di un simile processo sarà perciò la perfetta società di massa, fenomeno che Bauer aveva analizzato già a partire dai primi anni ’40.
L’ordine imperialistico mondiale implicherà l’apocalittica fine del vecchio ordine cristiano-germanico: solo allora emergeranno nuovi orizzonti culturali. Sebbene non si possa prevedere nel dettaglio, il nuovo ordine culturale determinerà il manifestarsi di una creatività individuale senza precedenti, finalmente libera dalle menzogne metafisiche e religiose.
LA NUOVA CONCEZIONE DEL CRISTIANESIMO
Nei suoi studi degli anni ’50, paragonando la crisi europea del suo tempo alla caduta del mondo classico e dell’Impero Romano, Bauer colloca le origini del cristianesimo nel II secolo d.C. e sostiene che il primo vangelo fu scritto sotto l’imperatore Adriano (117-138), nonostante alcune lettere paoline tendano a retrodatarlo. Bauer traccia il cammino e l’evoluzione delle idee cristiane dall’ellenismo e dallo stoicismo, facendo derivare la dottrina del logos giovanneo da fonti e scritti neoplatonici e negando, in Herr Dr. Hengstenberg, che il cristianesimo sia emerso direttamente dall’ebraismo.
Molto più che nei suoi lavori giovanili, Bauer ora rimarca il potere rivoluzionario del primo cristianesimo, visto come fonte di liberazione dalle ormai vecchie ed impoverite istituzioni dell’Impero Romano. Nel suo ultimo scritto arriva a descrivere il cristianesimo come l’apice socialista della storia greca e romana: nel necrologio scritto per la morte di Bauer, Friedrich Engels riconoscerà il valore e l’importanza di quest’ultimo scritto nell’ambito della critica socialista alla religione. Nel 1908 anche Karl Kautsky, nell’opera Le origini del Cristianesimo, farà proprie alcune tesi di Bauer, che ritorneranno anche in Ateismo nel cristianesimo di Ernst Bloch.
Gli ultimi scritti di Bauer indicano nei sentimenti e nelle idee del pietismo, piuttosto che nell’autonomia della ragione, le principali forze di modellamento della soggettività moderna: i suoi studi sui quaccheri e sul pietismo mostrano proprio come l’intimità passiva e il sentimentalismo fossero state le caratteristiche dominanti dell’illuminismo tedesco. La “ragion pratica” di Kant e Fichte ha semplicemente tradotto in un idioma razionale la voce interna della coscienza pietista. Bauer vede inoltre nel pietismo la fine del cristianesimo positivo, dal momento che questa corrente religiosa ha finalmente eliminato del dogma in favore dell’illuminazione interna e della rettitudine morale individuale. In accordo col suo Cristianesimo rivelato (1843), Bauer continua a definire positive e statutarie quelle religioni che si fondano esclusivamente su simboli, riti e cerimonie esteriori, elementi che egli considera mere illusioni. Nel nuovo impero mondiale si porterà a compimento lo sgretolamento interno dei dogmi e delle credenze religiose, non tramite la ragione speculativa, ma per mezzo del sentimento.
Un accentuato antinazionalismo ed non meno marcato antisemitismo caratterizzano l’ultima fase del pensiero di Bauer. Egli difende la cultura germanica dall’appropriazione politica tentata dal regime prussiano e da quello austriaco, ma ne critica anche i difetti, come, ad esempio, l’eccessiva fedeltà di Goethe alla tradizione metafisica europea. Degno di nota è come Bauer consideri la Germania non un’unità razziale, ma manufatto culturale e storico caratterizzato da una consolidata miscellanea etnica.
Tuttavia, è chiaro che alcuni elementi rimangono esclusi da questo melting pot: Bauer è convinto che sia una naturale differenza razziale a creare uno divisione insanabile tra ebrei ed europei, come emrge dal suo scritto del 1852 La posizione odierna degli ebrei. È forse superfluo segnalare che queste sue tesi saranno utilizzate da molti autori nazionalsocialisti.
Gli ultimi lavori di Bauer contengono osservazioni e analisi quasi profetiche riguardo a fenomeni come la globalizzazione o la guerra mondiale, oltre ad avere molte affinità con una grande varietà di forme ideologiche caratteristiche del XX secolo, quali il socialismo, l’imperialismo e l’antisemitismo. Le opere giovanili, al contrario, sono portavoce di un originale repubblicanesimo hegeliano e offrono interessanti riflessioni sulla pensiero politico della Restaurazione e sull’emergere della società di massa. L’eredità del suo pensiero è, anche per questi motivi, complessa e ricca di conflitti interpretativi.
A cura di Alessandro Sangalli
BRANI ANTOLOGICI
HEGEL È PIÚ PERICOLOSO DELLA RIVOLUZIONE FRANCESE
Utilizzando l’ironia ed il paradosso, Bauer suggerisce la possibilità che la filosofia di Hegel sia interpretata in modo radicalmente diverso dall’interpretazione ufficiale e invita la filosofia a riprendere la lotta contro l’alleanza trono-altare.
Secondo Bauer la Rivoluzione francese ha decretato il rifiuto del Dio cristiano in nome della ragione. Ma i vincitori della rivoluzione e di Napoleone non si accorsero che il nemico da loro sconfitto era rinato in modo ancora piú pericoloso nella filosofia di Hegel.
B. Bauer, La tromba del giudizio universale contro Hegel, ateo e anticristo. Un ultimatum
Con Hegel l’Anticristo è venuto e si è “rivelato”.
È dovere del credente sincero indicare a tutti il Maligno, accusarlo apertamente e veracemente, mettere in guardia tutti da lui e rendere vana la sua astuzia.
Dobbiamo soprattutto rivolgerci ai governi cristiani, e testimoniare di fronte a loro – il credente è tenuto infatti a predicare ed a testimoniare di fronte ai re, ai príncipi ed alle autorità – onde si accorgano infine quale pericolo mortale minaccia l’ordine costituito e soprattutto la religione, l’unico fondamento dello Stato, se essi non estirpano proprio le radici del male. Non c’è piú niente di fermo, di sicuro, di stabile se “il vigoroso errore” di quella filosofia è ulteriormente tollerato. Essi sono in grado di dedurre il finale dell’infelice tragedia che questa filosofia è costretta a rappresentare, e di cui i suoi seguaci sono gli attori, dal fatto che già nel momento presente ogni autorità divina ed umana è negata, scossa e resa vacillante da questa gente; la quale se ha cominciato col rovesciare la religione e col dare un colpo mortale alla Chiesa, vorrà certo rovesciare anche il trono. Oh! Vi supplichiamo con lacrime di dolore e di compassione, e con sospiri che ci sono spremuti dal pericolo che corrono “i piccoli, che hanno fede”, permettete che vi ammoniamo: siate senza pietà con questa banda; a voi è data la spada onde istituiate in questo mondo un ordine gradito a Dio; pronunziate la sentenza contro questi distruttori del santuario. Eseguite il giudizio di Dio. A voi essi sono affidati.
[…]
È suonata l’ora nella quale il peggiore, il piú superbo, l’ultimo nemico del Signore sarà abbattuto. Questo nemico però è anche il piú pericoloso. I francesi – il popolo dell’Anticristo – avevano, con scandalosa pubblicità, di giorno pieno, in piazza, alla luce del sole, che non ha mai visto tale empietà, e sotto gli occhi dell’Europa cristiana, negato l’esistenza del Signore dell’eternità, assassinando l’unto di Dio ed avevano commesso un idolatrico adulterio con la meretrice, la ragione; ma l’Europa, piena di santo zelo, represse tali orrori e si uní in una santa alleanza per gettare in catene l’Anticristo e per innalzare di nuovo gli eterni altari del vero Signore.
Allora venne – no! allora si chiamò, si coprí di attenzioni, si protesse, anzi, si onorò e si stipendiò lo stesso nemico che si era sconfitto all’esterno, e ciò nella persona di un uomo che era piú forte del popolo francese, di un uomo che ridiede forza legale ai decreti di quella diabolica Convenzione, che dette ad essi nuovi fondamenti, assai piú solidi, e che trovò il modo di metterli in circolazione sotto il nome, insinuante e particolarmente attraente per la gioventú tedesca, di filosofia. Si chiamò Hegel e se ne fece il centro dell’Università di Berlino! Quest’uomo – ammesso che lo si possa ancora chiamare uomo – quest’uomo corruttore, pieno di odio per tutto ciò che è divino e sacro, incominciò quindi, protetto dallo scudo della filosofia, ad attaccare tutto ciò che gli uomini dovrebbero considerare alto e sublime. Una schiera di discepoli si uní e mai – in tutta la storia – si è visto un’obbedienza, una devozione, una fiducia cieca come quella che ad Hegel fu tributata dai suoi discepoli e seguaci. Lo seguirono dove egli li conduceva, lo seguirono nella lotta contro l’Uno.
La Sinistra hegeliana, Testi scelti da Karl Löwith, Laterza, Bari, 1960, pagg.68, 105-106
RAGIONE E RELIGIONE
Hegel, con apparente innocenza, ha osservato che la Riforma ha separato il sentimento religioso dalla filosofia (scolastica). Ciò ha favorito un confronto-scontro fra la religione e la ragione il cui esito è scontato: la distruzione della religione.
B. Bauer, La tromba del giudizio universale contro Hegel, ateo e anticristo. Un ultimatum
Nella maligna e sorniona osservazione che nella Riforma il contenuto religioso si e separato dalla filosofia (dalla Scolastica), che esso si è trasferito nella sua purezza, per sé, nel cuore, nel sentimento, e che è diventato qualche cosa che riguarda soltanto il cuore non si esprime che la speranza di eliminare tanto piú facilmente la religione. Ora cioè, crede Hegel, che la religione è stata recisa dalla ragione, dal pensiero, ormai il pensiero sarebbe emancipato, sarebbe in libertà come il contenuto religioso ed il cuore: ed allora si potrebbe passare ad una vera lotta tra le due parti, senza intermediari, ad una lotta sul cui esito, la distruzione della religione, non ci sarebbero dubbi.
La Sinistra hegeliana, Testi scelti da Karl Löwith, Laterza, Bari, 1960, pag. 161
WILHELM MAX WUNDT

Wilhelm Max Wundt nacque il 16 agosto del 1832. Iniziò a frequentare l’Università di Tubinga nel 1851 e conseguì il Dottorato in Medicina all’Università di Heidelberg nel 1856 (l’anno di nascita di Sigmund Freud). Fu dapprima professore di Fisiologia, poi, a partire dal 1875, professore di Filosofia a Lipsia; si spense nel 1920.
La sua solida educazione scientifica e fisiologica lo portò ad individuare l’origine del comportamento umano nella struttura fisiologica dell’uomo e a studiare i fenomeni psichici prescindendo dall’esistenza di una sostanza spirituale e da ogni concezione mistica della mente come anima.
Nella seconda metà del XIX secolo, la psicologia rientrava più nell’ambito filosofico che in quello empirico-scientifico, e il grande merito di Wundt è proprio quello di aver dato un grande impulso alle ricerche di psicologia scientifica. A Lipsia fondò e diresse il primo Istituto di Psicologia Sperimentale, depurando la psicologia dalle nozioni metafisiche e medievali ed elevandola al livello di una scienza esatta: spesso perciò ci si riferisce a Wundt come al “padre della psicologia sperimentale” o come al “fondatore della psicologia moderna”. Fu anche uno degli iniziatori della cosiddetta psicologia sociale o psicologia dei popoli (Völkerpsychologie), e senza dubbio uno dei maggiori psicologi del suo tempo: il suo istituto fu il precursore dei laboratori psicologici odierni. I suoi Principi di psicologia fisiologica (1874) rivoluzionarono la scienza psichica: essi costituiscono il primo esempio sistematico di quella che fu definita psicologia senz’anima, una psicologia che sceglieva di studiare i fenomeni psichici senza far ricorso ad ipotetiche sostanze spirituali (res cogitans), ma considerandoli in strettissimo rapporto con i fenomeni fisiologici e applicando, fin dove era possibile, i procedimenti del calcolo matematico. Queste sue concezioni furono oggetto di polemica da parte di Henri Bergson nel Saggio sui dati immediati della coscienza del 1889.
Il rivoluzionario approccio di sperimentazione psicologica di Wundt contribuì a fare della psicologia una scienza naturale, soprattutto tramite tecniche fisiologico-sperimentali di laboratorio. Già Theodor Fechner (1801-1887) si era posto il problema di una psicologia sperimentale a base matematica e aveva formulato la cosiddetta “legge psicofisica fondamentale”, che concerneva il rapporto quantitativo tra l’intensità dello stimolo e l’intensità della sensazione da esso prodotta. Wundt estende il metodo sperimentale a tutto il dominio della psicologia, assumendo come presupposto per le sue ricerche il principio del parallelismo psicofisico, secondo il quale gli eventi psichici e gli eventi fisici costituiscono due serie causali indipendenti, che non interferiscono l’una sull’altra, ma che si corrispondono termine a termine (cfr. Spinoza, Etica II.7). Una simile concezione è stata sostenuta anche nel Novecento nell’ambito della filosofia della mente, in particolare dallo studioso americano Donald Davidson.
Wundt guarda alla psicologia come alla parte di un sistema filosofico più ampio nel quale la mente è attività, non più mera sostanza: l’attività psichica basilare è, leibnizianamente, l’appercezione. Ciò che Wundt si propone di fare, grazie alla ricca strumentazione scientifica, è di isolare i fatti psichici elementari (ossia le sensazioni) per poterne così studiare le leggi di connessione (delle quali la più importante è la legge della causalità psichica). Questo procedimento non comporta però un’assimilazione totale delle dinamiche psichiche a quell fisiche, né tanto meno una loro dipendenza dai processi bio-fisiologici. Secondo Wundt, infatti, le leggi della psicologia hanno una natura particolare che le diversifica da quelle della fisica e, in generale, delle altre scienze: inoltre, Wundt propugna la teoria del parallelismo tra mente e corpo, teoria che esclude nel modo più radicale ogni rapporto causale della sfera fisico-biologica sui processi psichici. Ma la psicologia, secondo Wundt, non studia solo fatti, ma anche atti: questi ultimi si distinguono dai primi perché dotati di spontaneità. Nel caso in cui tali atti diventino atti complessi (linguaggio, esperienza estetica, costumi, miti, e così via) diventa possibile studiarli comparativamente descrivendo i loro prodotti oggettivi: ad occuparsene è, per l’appunto, la psicologia dei popoli.
L’alter ego di Wundt negli Stati Uniti fu William James: i due condividevano il progetto di liberare la psicologia da superstizioni, pregiudizi e false credenze. Respingevano ogni elemento metafisico o mistico in psicologia e cercavano di condurre la loro scienza in una prospettiva etica ed evoluzionstica. Sebbene entrambi credenti, erano liberi pensatori in campo religioso, rifiutavano qualsiasi credenza di immortalità personale ed accettavano Dio solo come “energia divina del mondo” o come simbolo dell’unità dell’universo. Wundt, nel Sistema di Filosofia del 1889, arrivò a definire arditamente il cristianesimo “un cumulo di superstizioni”. Rispetto al positivismo, e in particolare rispetto a quello tedesco (che quasi sempre si tradusse in materialismo), Wundt ammette un margine di spontaneità che apre spiragli verso lo spiritualismo.
KARL VON CLAUSEWITZ

A cura di Marco Menicocci
“La guerra non è che la continuazione della politica con altri mezzi. La guerra non è dunque, solamente un atto politico, ma un vero strumento della politica, un seguito del procedimento politico, una sua continuazione con altri mezzi”.
Vita e opere
Nato nel 1780 da una famiglia della piccola borghesia, Karl von Clausewitz si arruolò nell’esercito prussiano a soli 12 anni, nel 1792. Nel 1794 divenne ufficiale e utilizzato in compiti di guarnigione sino al 1806. In questo periodo divenne amico di uno dei principali generali prussiani, Scharnhorst, e fu da lui introdotto a corte. Nel 1806 partecipò alla campagna di Jena e fu catturato dai Francesi. Tornato in Prussia nel 1808, si impegnò insieme a Scharnhorst nella riforma dell’esercito ma, in disaccordo con quella che gli sembrava una linea politica filofrancese, rassegnò le sue dimissioni dall’esercito prussiano e si arruolò, cosa frequente all’epoca, in quello russo. Membro dello Stato Maggiore russo, prese parte alla campagna del 1812 e fu tra i protagonisti dei negoziati che spinsero la Prussia ad abbandonare la coalizione napoleonica. Ritornato nell’esercito prussiano, partecipò alle campagne del 813-14 e a quella conclusiva del 1815. Divenuto generale nel 1818, si aspettava di poter ricevere adeguati riconoscimenti dal sovrano prussiano ma, sospettato di essere un riformista, venne nominato amministratore capo del Collegio militare: una carica che era a metà tra una sinecura e un insulto. Dal 1818 al 1830, lavorò al suo celeberrimo scritto “Della Guerra” (“Vom Kriege”), senza però che tutto questo periodo fosse sufficiente a fargli concludere il lavoro. Richiamato in servizio attivo a seguito degli eventi del 1831, fu inviato sul fronte polacco ove morì per la medesima epidemia di colera che uccise anche Hegel.
Il pensiero
Lo scritto in otto libri “Della Guerra” è probabilmente, oltre che il più noto, anche il più significativo tentativo nella storia occidentale di comprendere la guerra, sia nelle sue interne dinamiche sia come strumento di politica. Nella sua forma attuale il libro è giunto a noi quale fu pubblicato dalla vedova nel 1832, un anno dopo la morte di Clausewitz, raccogliendo insieme le carte del marito. Si trattava di studi che si trovavano ad un diverso livello di elaborazione e ancora largamente incompiuti. Questa incompletezza e l’assenza di una revisione finale pesano assai sul libro che risulta difficile e a volte contraddittorio. Giudizi lapidari e definizioni sintetiche si alternano a lunghe dissertazioni su minimi dettagli e anche il lettore più benevolo riesce a seguire con fatica capitoli quali quello sull’organizzazione delle marce o sulla disposizione difensiva delle truppe di montagna. Nonostante questi limiti, però, Della Guerra è ricchissimo di spunti e costituisce una lettura filosofica assai stimolante. La riflessione di Clausewitz non è indirizzata genericamente alla violenza né si occupa di considerare se la guerra sia intrinseca alla natura umana, o una dimensione permanente dello spirito. La sua indagine è assai più ristretta e presuppone l’esistenza degli Stati organizzati quali organismi politici in grado di rappresentare un intero popolo: la guerra è una delle possibili forme di relazione tra i vari Stati. Prescindendo da ogni considerazione di carattere morale, Clausewitz si prefigge di svolgere intorno alla guerra una trattazione scientifica: il suo scopo è spiegare cosa la guerra sia nella sua particolare realtà, cosa è possibile ottenere per il suo tramite, cosa invece non è lecito attendersi da essa; quale è il suo funzionamento, in che misura funziona, quali sono le linee probabili del suo sviluppo e in che modo è possibile giungere a tali previsioni. Questo non significa, però, ricercare una considerazione della guerra scientifica in senso fisico-matematico. La guerra sfugge ai rigidi modelli matematici perché è un fatto sociale ed è connessa con la competitività dei popoli: gli interessi, gli obiettivi, i mezzi e le masse delle forze che si oppongono, e che costituiscono la guerra, si influenzano continuamente e reciprocamente. In guerra le parti interagiscono tra loro cercando di spiazzarsi a vicenda, di ingannare l’avversario, di approfittare delle sue debolezze, di sorprenderlo con nuove soluzioni. La teoria dovrà dunque considerare principalmente i mezzi per giungere alla vittoria. La sintesi teorica e la sistematicità del sapere si realizzano nella coscienza del comandante di armata il quale deve saper trasformare il suo apparato concettuale in decisione: i suoi sono atti di consapevolezza trasformati in azione, in prassi. Suo compito quello di saper riportare ad unità i mille momenti scomposti e frammentari della battaglia. Questa soggettività del comandante, lontana tanto dall’arbitrio delle scelte casuali quanto dall’astrattezza di chi pretende l’applicazione di norme universali, ha un sapore hegeliano e ricorda il carattere della volontà determinata descritto nei primi paragrafi della Filosofia del diritto. In quella singolare unità di anima e corpo costituita dal comando e dalla sua armata si realizza un concetto concreto costituito dall’atto del comando. In guerra, secondo Clausewitz, tutto è finalizzato al combattimento ma questo non costituisce il fine della guerra bensì il mezzo mediante il quale si svolge. Una contraddizione soltanto apparente che trova soluzione nella distinzione tra guerra assoluta e guerra relativa. Ciò che distingue la guerra dagli altri comportamenti sociali organizzati è il fatto che lo scopo ultimo in guerra è abbattere l’avversario, piegarne la volontà sino alla cancellazione. A questo scopo, secondo la logica interna della guerra, tutto dovrebbe essere subordinato. In realtà, però, una serie di considerazioni pongono sempre dei limiti a come le guerre vengono condotte. Clausewitz distingue tra la logica interna della guerra e la sua funzione sociale. Egli mostra la guerra nel suo aspetto più puro, unilaterale, nei suoi caratteri più estremi, al fine di marcarne le differenze e le peculiarità esclusive, e poiché ciò che caratterizza la guerra è il suo carattere di violenza, Clausewitz ne estremizza le posizioni marcandole in modo assoluto: in guerra occorre colpire il nemico con forza, utilizzando subito tutta l’energia possibile, evitando ogni escalation ma cercando in tempi rapidi la decisione finale. Poiché ragionevolmente il nemico farà la stessa cosa, ogni utilizzo parziale delle forze a disposizione, ogni perdita di tempo, ogni ritardo, favorirà il nemico e danneggerà la nostra azione. Dal punto di vista della pura logica la guerra non può che tendere all’estremo assoluto. In realtà però le cose non vanno mai così e sempre una serie di considerazioni gradua lo svolgimento dell’azione bellica. Caratteri dei popoli, situazioni storiche, alleanze, disponibilità economiche, scopi politici: tutto questo spinge la guerra sempre lontano dalle sue conseguenze assolute e pone limiti costanti all’azione dei condottieri e dei governi. Dall’assoluto si passa alla condotta ragionevole della guerra, una ragionevolezza che comporta una serie di mediazioni. Tra queste Clausewitz rileva il ruolo dell’asimmetria delle forze, dell’incertezza, del maggior potere della difesa rispetto all’attacco, e soprattutto di quello che definisce l’attrito: l’inevitabile irrazionalità che si insinua nei movimenti di grandi masse di uomini e nella linea di comando, rendendo sovente vani i migliori piani militari. Tutto questo sembra rendere impossibile preparare un piano di guerra ispirandosi ai criteri della guerra assoluta. Il compito di sciogliere tutti questi nodi è affidato da Clausewitz alla politica. Come è noto una delle più celebri definizioni di Clausewitz è proprio quella relativa al rapporto tra guerra e politica: “La guerra non è che la continuazione della politica con altri mezzi. La guerra non è dunque, solamente un atto politico, ma un vero strumento della politica, un seguito del procedimento politico, una sua continuazione con altri mezzi”. È compito della politica dettare le regole della guerra, stabilire i suoi scopi e le sue modalità. “Lo scopo politico, motivo primo della guerra, darà dunque la misura tanto dell’obiettivo che l’azione bellica deve raggiungere, quanto degli sforzi che a ciò sono necessari”. È proprio la politica a riportare nella concretezza ogni azione bellica, a dettare le regole e a dare alla guerra il suo senso. Lontano da ogni bellicismo e militarismo, è proprio questo generale prussiano a suggerire che sia il governo politico e non il comando militare a dare le regole alla guerra. Alla fine, infatti, è sempre la politica ad avere il ruolo maggiore e la guerra resta sempre un evento eccezionale. La politica può ricorrervi, ma non deve necessariamente ricorrervi. Essa è un mezzo, tra tanti. È indicativo che neanche nella considerazione della guerra assoluta Clausewitz (al contrario di Platone ne Le Leggi: I, 625e; 626a; 626c) si spinga tanto in là da affermare che lo Stato debba sin dalla pace prepararsi per vincere ogni guerra. La mobilitazione delle masse e delle forze morali, delle risorse, delle armi rimane un evento possibile nelle vicende umane ma non tale da determinare ogni senso delle scelte politiche. Clausewitz non vuol spiegare la guerra in termini sociologici o con teorie politiche ma comprenderne la logica interna. Il suo interesse non è però solo quello di disegnare una fenomenologia della guerra, ma anche quello di evidenziare il ruolo della comunità politica. Molte delle sue pagine sono dedicate alla situazione morale delle popolazioni oltre che delle armate e alla loro influenza sugli eventi bellici. Non la competitività o l’aggressività spingono alla guerra: è chi si difende che vuole la guerra. L’aggressore non desidera la guerra, solo ottenere vantaggi sul difensore. È questo che, per evitare svantaggi troppo forti, è costretto a difendersi sul piano militare. Ma proprio queste considerazioni spalancano il rapporto con la politica. La decisione su quali siano i limiti dei compromessi accettabili, il problema dei costi e dei tempi delle azioni belliche, i possibili vantaggi cui mirare: tutte queste sono considerazioni politiche e costituiscono il quadro di riferimento all’interno del quale avvengono poi gli eventi bellici. Senza la politica la guerra è insignificante, inconcepibile, priva di senso e scopo: priva di realtà. Considerare la guerra in stretto rapporto con la politica non equivale, naturalmente, a dire che la politica e la guerra sono la stessa cosa, bensì che solo lo Stato è considerato il rappresentante della comunità nei confronti degli altri Stati. Una guerra senza politica sarebbe insensata, non così, ovviamente, una politica senza guerra. La guerra è uno degli strumenti di cui la politica si serve per i suoi fini. La guerra comporta ineliminabilmente un elemento irrazionale e la tecnica è il tentativo di ridurre questa irrazionalità. Se poi sia la politica stessa a poter contenere in sé nuclei di irrazionalità, questo, il filosofo-generale, al suo tempo non ha saputo valutarlo. Nel suo libro, Clausewitz distingue tra un modo antico di fare la guerra, nel quale a scontrarsi sono eserciti contrapposti di professionisti della guerra e di cui è emblema Federico II, e un modo moderno di fare la guerra, nel quale si scontrano popoli e di cui è emblema Napoleone, significativamente qualificato da Clausewitz come il “Dio della guerra”.
FERDINAND DE SAUSSURE

«Noi chiamiamo “segno” la combinazione del concetto e dell’immagine acustica: ma nell’uso corrente questo termine designa generalmente solo l’immagine acustica, per es. una parola (arbor, ecc.). Si dimentica che se arbor è chiamato “segno”, questo avviene perché esso porta il concetto “albero”, in modo che l’idea della parte sensoriale implica quella del totale. L’ambiguità sparirebbe se si designassero le tre nozioni qui in questione con dei nomi che si richiamano l’un l’altro pur opponendosi. Noi proponiamo di conservare la parola “segno” per designare il totale, e di rimpiazzare “concetto” e “immagine acustica” rispettivamente con significato e significante: questi ultimi termini hanno il vantaggio di rendere evidente l’opposizione che li separa sia tra di loro, sia dal totale di cui fanno parte. Quanto a “segno”, se continuiamo ad usarlo, è per il fatto che non sappiamo come rimpiazzarlo, poiché la lingua usuale non ce ne suggerisce nessun altro».
Ferdinand de Saussure nasce a Ginevra nel 1857 da una coltissima famiglia di scienziati e di naturalisti, che lo inducono a intraprendere studi di chimica e fisica. Ma egli ben presto abbandona tali studi per dedicarsi alla linguistica. Prosegue a Lipsia e a Berlino tali studi, approfondendo il persiano antico, l’antico irlandese, lo slavo e il lituano. Nel 1878 pubblica Memoria sul sistema primitivo delle vocali nelle lingue indoeuropee, in cui postula l’esistenza di entità vocaliche astratte, definite dalla loro funzione strutturale e non semplicemente dalla loro realtà fonetica. Nel 1880 consegue la laurea a Lipsia, per poi trasferirsi a Parigi e insegnare presso l’Ècole des Hautes Ètudes. Nel 1891 torna nuovamente a Ginevra, ove risdiede fino alla morte, sopraggiunta nel 1913. La sua opera più importante, apparsa postuma nel 1916, è il Corso di linguistica generale: essa si presenta come una raccolta di note autografe e di appunti trascritti da alcuni uditori delle lezioni che egli tenne tra il 1906 e il 1911; l’opera è stata redatta da alcuni allievi di Saussure (Charles Bally e Albert Séchehaye, con l’ausilio di Albert Riedlinger). L’opera è di importanza capitale, poiché produce, in ambito linguistico, una vera e propria rivoluzione che si rivelerà fondamentale anche per l’avvento dello strutturalismo. Ad avviso di Saussure, la lingua è un sistema di segni che esprimono idee. Se si ipotizza l’esistenza di una scienza generale dei segni sociali (scienza allora non ancora esistente, e che Saussure battezzò col nome di “semiologia”), allora la linguistica verrà ad essere una parte di quest’ultima; e in particolare sarà la scienza che si occupa di quello specifico segno che è il “segno verbale”; la semiologia, dal canto suo, studierà anche i segni non verbali (scrittura, alfabeto dei sordomuti, riti simbolici, segnali militari, e così via). Ma la linguistica non ha per oggetto specifico il linguaggio – esso è una massa eterogenea analizzabile sotto diversi punti di vista (fisico, psichico, fisiologico, e così via) – ma piuttosto quella sua parte essenziale che è la lingua. Ed è a questo proposito che Saussure distingue nettamente tra “lingua” e “parola”: la prima rappresenta il momento sociale del linguaggio ed è costituita dal codice di strutture e regole che ciascun individuo assimila dalla comunità di cui fa parte, senza poterle inventare o modificare. La parola è invece il momento individuale, cangiante e creativo del linguaggio, ossia la maniera in cui il soggetto che parla “utilizza il codice della lingua in vista dell’espressione del proprio pensiero personale”.
“Ma che cos’è la lingua? Per noi, essa non si confonde con linguaggio; essa non ne è che una determinata parte, quantunque, è vero, essenziale. Essa è al tempo stesso un prodotto sociale della facoltà del linguaggio ed un insieme di convenzioni necessarie, adottate dal corpo sociale per consentire l’esercizio di questa facoltà negli individui. Preso nella sua totalità, il linguaggio è multiforme ed eteroclito; a cavallo di parecchi campi, nello stesso tempo fisico, fisiologico, psichico, esso appartiene anche al dominio individuale e al dominio sociale; non si lascia classificare in alcuna categoria di fatti umani, poiché non si sa come enucleare la sua unità” (Corso di linguistica generale, Bari-Roma, Laterza, 1967, p. 19).
Il fatto che lingua e parola siano realtà distinte è suffragato, ad esempio, dalle afasie (il malato coglie i messaggi linguistici, ma ha perso l’uso della parola) o dalle lingue morte (assimilabili anche se non si parlano più). Un’altra importante conseguenza che discende dalla separazione della lingua dalle parole è che “si separa a un sol tempo: 1. ciò che è sociale da ciò che è individuale; 2. ciò che è essenziale da ciò che è più o meno accidentale”. In antitesi con la teoria “realistica” della lingua, Saussure spiega che il segno linguistico, lungi dall’unire una “cosa” a un “nome” (come sostiene una tradizione che va dalla Bibbia alla modernità), unisce un “concetto” a una “immagine linguistica”. Su questo presupposto, Saussure distingue tra “significato” e “significante”: il significato è ciò che il segno esprime; il significante è il mezzo utilizzato per esprimere il significato (l’immagine acustica). Ma il significato e il significante non sono separabili: come dice Saussure, sono come le due facce dello stesso foglio. Ma pur essendo inseparabili, il rapporto tra i due è arbitrario: ciò è dimostrato dal fatto che, per esprimere uno stesso significato (ad esempio, sorella), le diverse lingue usano significanti diversi (sorella in italiano, soeur in francese, e così via). Ma per Saussure “arbitrario” non vuol dire soggettivo e libero: ma piuttosto “immotivato”, cioè non necessario in rapporto al significato che viene espresso. L’inaggirabile limite che Saussure ravvisa nella linguistica a lui precedente (e in particolare nella scuola “storico-comparativa”) sta nell’aver indebitamente privilegiato la sfera evolutiva della lingua, a svantaggio di quella sistematica: in termini strettamente saussuriani, è stata privilegiata la sfera “diacronica” della lingua rispetto a quella “sincronica” (anche detta “statica”). La linguistica sincronica studia la lingua nella sua simultaneità, cioè come essa si presenta in un certo momento; la linguistica diacronica (anche detta “dinamico-evolutiva”) studia invece la lingua nella sua successione, cogliendone cioè lo sviluppo temporale. Anche se la sincronia non esclude la diacronia, Saussure sostiene il primato della dimensione sincronica: infatti, nella misura in cui la lingua è un sistema di valori determinato dallo stato momentaneo dei suoi termini, lo studioso della linguistica è necessitato a badare alla sincronia, trascurando la diacronia. Detto altrimenti, “se dépit ha significato in francese ‘disprezzo’, ciò non toglie che attualmente abbia un senso completamente diverso”. Ciò vuol dire che la sincronia (il valore attuale di un dato termine) e l’etimologia (la storia di un dato termine) sono assolutamente differenti, sicché per comprendere la prima non è necessario aver compreso la seconda, proprio come “in una partita a scacchi”, nella quale ogni posizione è indipendente dalle precedenti (non conta se si è arrivati a quella data posizione per una via piuttosto che per un’altra). Privilegiando la sfera sincronica, diventa possibile (e diventa evidente soprattutto con la futura “linguistica strutturale”) una considerazione matematico/quantitativa del linguaggio, incentrata su modellizzazioni astratte. Anche se Saussure non parla mai di “struttura”, innegabile è l’eredità da lui lasciata allo strutturalismo: in primo luogo, l’idea del carattere sistemico della lingua (ogni elemento ha un valore determinato dal rapporto con gli altri elementi); ma anche l’idea del primato della lingua sul parlante, e l’idea dell’egemonia della sincronia sulla diacronia. L’eredità saussureiana è decisiva anche nella cosiddetta “Scuola di Ginevra”, che ha per esponenti principali gli allievi di Saussure stesso: Charles Bally (1865-1947), Antoine Meillet (1866-1936). Importantissima fu la rivista di linguistica fondata nel 1941 dalla Scuola di Ginevra: i Cahiers Ferdinand de Saussure.
BERNHARD BOLZANO

Il contributo filosofico di Bernhard Bolzano, pensatore e matematico boemo, fu pienamente riconosciuto solo molto tempo dopo la sua morte. Il suo lavoro si rivelò particolarmente utile nel campo della logica, della geometria e per la teoria dei numeri reali.
Bernardus Placidus Johann Nepomuk Bolzano nacque a Praga, in Boemia (oggi parte della Repubblica Ceca), il 5 ottobre 1781. Il padre era un commerciante d’arte e, come la madre, un fervido cristiano. Bernard crebbe così con solidi valori morali e princìpi su cui fare sicuro affidamento: fu questa sua educazione a spingerlo verso la Chiesa e la vita sacerdotale.
Bolzano entrò all’Università di Praga nel 1796 e lì studiò filosofia, matematica e fisica. Dopo la laurea, entrò a far parte del Dipartimento di Teologia dell’istituto e fu ordinato prete cattolico nel 1804. Nonostante la sua piena dedizione alla vita ecclesiastica, egli non trascurò mai i suoi interessi negli studi matematici, tanto che fu segnalato per il ruolo di presidente del Dipartimento di Matematica universitario.
Il 1805 vide l’inizio della lotta che avrebbe caratterizzato tutta la vita di Bolzano. L’impero austro-ungarico comprendeva a quel tempo diversi gruppi etnici che non nascondevano desideri nazionalistici e movimenti per d’indipendenza: incoraggiati dal “libero pensiero” della recente Rivoluzione francese, questi movimenti stavano diventando un serio problema per l’unità dell’impero. Perciò, con una mossa politica, l’impero creò una cattedra di Filosofia della Religione in ogni università dello stato: questa mossa era parte di un più ampio progetto di sostegno della Chiesa cattolica, il cui conservatorismo avrebbe aiutato le autorità imperiali a tenere sotto controllo i liberi pensatori.
La cattedra dell’Università di Praga fu assegnata a Bolzano, ma, per quanto riguardava gli obiettivi dell’impero, questa fu una pessima scelta. Nonostante fosse un sacerdote, il nostro era in primo luogo un libero pensatore, che non aveva paura di esprimere il suo favore al sentimento nazionalistico boemo.
Nei quattordici anni che seguirono, Bolzano insegnò all’università, principalmente tenendo corsi su temi etici, sociali e sui rapporti tra matematica e filosofia. Era molto popolare sia tra gli studenti, che apprezzavano assai la schiettezza con cui esprimeva le sue convinzioni, sia tra i colleghi professori, che non potevano fare a meno di ammirare la sua intelligenza. Nel 1818 divenne Preside del Dipartimento di Filosofia.
Le autorità austro-ungariche, tuttavia, non gradivano le sue visioni liberali: per questo motivo nel 1819 fu sospeso dal proprio incarico di professore, gli fu proibito di pubblicare libri e fu posto sotto la sorveglianza della polizia. Bolzano non accettò l’idea di arrendersi, anche se, nonostante l’appoggio della Chiesa, non riuscì mai a riottenere il suo incarico. Nel 1824, dopo aver rifiutato di ritrattare ufficialmente le proprie idee nazionalistiche, rinunciò al proprio incarico in modo definitivo.
Abbandonata l’università, si trasferì nel piccolo villaggio di Techobuz, dove rimase fino al 1841, quando ritornò a Praga. Qui morì il 18 dicembre 1848. Bolzano elaborò molte nuove idee logiche e matematiche durante la sua vita, anche se, essendogli stato proibito di pubblicare scritti, molti suoi concetti erano noti solamente tramite i manoscritti che circolavano tra gli interessati. Una raccolta completa fu pubblicata solo a partire dal 1962.
Il contributo di Bolzano allo sviluppo della matematica fu davvero molto ampio. Nel suo lavoro si occupò principalmente di tre campi: la geometria, la teoria dei numeri reali e la logica. Per quanto riguarda la geometria, il nostro provò ad occuparsi della questione del quinto postulato di Euclide, trovando diversi punti problematici nel ragionamento dell’autore, ma non riuscendo a trovare una soluzione soddisfacente: non era stato infatti ancora inventato lo strumento matematico appropriato, la topologia. Fissò inoltre le definizioni dei fondamentali concetti geometrici. Dedicò molto tempo anche alla teoria dei numeri reali, cercando di trovare un fondamento matematico per la teoria che riuscisse a rendere conto anche delle quantità infinite, un concetto davanti al quale si erano arresi i matematici precedenti. Pur fallendo nel tentativo, fece alcune importanti scoperte, tra le quali il noto teorema di Bolzano-Weierstrass. Oltre a ciò, notò anche qualcuno dei paradossi degli insiemi infiniti, ma non continuò con questo lavoro che fu portato a compimento solo in seguito da Cantor. Nel campo della logica, le sue idee vennero invece ignorate fino a tempi abbastanza recenti. Non accontentandosi di fornire un fondamento logico alla matematica, Bolzano andò oltre e cercò di fondare su basi logiche le scienze e il pensiero umano nel suo complesso. Nei suoi scritti, egli affronta infatti concetti cardine quali giudizi, pensiero astratto e compiti della scienza. Bolzano è oggi considerato uno dei precursori della logica moderna.
Contrariamente a Immanuel Kant, Bolzano ha un programma di organizzazione delle scienze matematiche basato sulla teoria delle proposizioni in sé. È per certi versi un anticipatore della teoria degli insiemi e dell’analisi. Sconosciuto ai suoi contemporanei, è stato riscoperto all’inizio del Novecento da Casimir Twardowski e Edmund Husserl.
Nel 1805 difese il suo dottorato in matematica con lo scritto Betrachtungen über einige Gegenstände der Elementargeomatrie. Lo stesso anno fu ordinato sacerdote e gli fu assegnata la nuova cattedra di Filosofia della Religione creata alla Karol Universität di Praga. Nel 1819 fu sospeso dall’incarico a seguito dell’accusa di eresia e a causa delle sue idee politiche non ortodosse. Fino al 1841 visse nella tenuta del suo amico e mecenate A. Hoffmann, e fu proprio in questi anni che scrisse i suoi lavori più importanti: Dottrina della Scienza, parte di una Dottrina Generale che non fu mai completata, e Paradossi dell’infinito. Negli ultimi anni fu di nuovo a Praga, nel ruolo di direttore della sezione filosofico-matematica dell’Accademia Ceca delle Scienze.
MATEMATICA: Bolzano definisce la matematica come la scienza della quantità, e la quantità come il campo della relazione “minore o uguale a”. La matematica così concepita è divisa in due sezioni: la scienza pura della quantità e le scienze particolari della quantità. Queste ultime comprendono la teoria dei numeri reali, la teoria dei numeri complessi e immaginari, il calcolo integrale e differenziale, le scienze applicate della quantità (calcolo combinatorio, probabilità, teoria del tempo, geometria, fisica).
LOGICA: Nella sua monumentale Dottrina della scienza (1837), che è la sua opera principale, Bolzano identifica dottrina della scienza e logica; quest’ultima guida alla suddivisione del dominio della verità nelle singole scienze e fornisce le regole per acquisire le conoscenze e per articolarle e presentarle sotto forma di trattati. Le diverse espressioni linguistiche con cui è comunicato un pensiero possono per Blozano essere distinte in base al contenuto concettuale che esprimono. Tale contenuto è composto da unità minime, idee in sé, e da due concetti connessi da una copula. Questo dà luogo a quella che Bolzano chiama “proposizione in sé”. Le proposizioni sono assunzioni che qualcosa è o non è: esse hanno natura ideale, non linguistica, giacché gli eventi linguistici sono veneti empirici e spazio/temporali, generati da organi vocali di qualche essere umano. In questa maniera, la logica, assumendole a oggetto, acquista un carattere rigorosamente formale, scevro di ogni commistione con eventi linguistici e psicologici. Blozano rigetta l’uso di considerazioni geometriche nella dimostrazione dei teoremi dell’analisi infinitesimale, poiché è convinto che rispetto all’intuizione spaziale un rigore maggiore sia dato dai concetti aritmetici. La teoria delle proposizioni in sé può essere compresa come parte di una più ampia teoria dell’oggetto. L’insieme generale di tutti gli oggetti è composto dal sottoinsieme degli oggetti reali e da quello degli oggetti non-reali: un oggetto è reale se e solo se fa parte dell’ordine causale del mondo; oggetti reali sono sia le sostanze sia gli accidenti della metafisica scolastica. La teoria degli oggetti non reali è la parte più originale dell’ontologia di Bolzano, una teoria che comprende proposizioni in sé e rappresentazioni in sé.
La proposizione in sé è il puro significato logico della proposizione, in quanto indipendente dal suo essere vero o falso, dall’essere espresso o non espresso in parole, dall’essere pensato o non pensato da qualcuno. La rappresentazione in sé è l’aspetto oggettivo della rappresentazione, che non esige nessuna relazione con il soggetto e costituisce la materia della rappresentazione soggettiva, cioè della rappresentazione come atto di un soggetto pensante. Le proposizioni in sé non hanno alcuna esistenza reale: l’acquistano quando vengono riconosciute e così pensate, divenendo verità in senso soggettivo. La materia di queste verità soggettive è, tuttavia, una verità in sé, cioè ogni proposizione valida indipendentemente dal suo riconoscimento, ossia valida sia che venga e espressa o pensata, sia che non venga né espressa né pensata.
L’in sé di cui parla Bolzano è la dimensione logico-oggettiva dell’esperienza, in quanto ha una validità indipendente dalle condizioni soggettive del conoscere. Edmund Husserl si riconnetterà esplicitamente alle idee del nostro pensatore per l’elaborazione del suo discorso fenomenologico. Nel 1851 uscì postuma l’opera di Bolzano intitolata I paradossi dell’infinito: opera di cui Cantor tesserà le lodi.
ETICA e POLITICA: Nella sua opera Athanasia oder Gründe für die Unsterblichkeit der Seele, Bolzano elabora una visione del mondo che fa affidamento su una monadologia leibniziana leggermente modificata e dimostra l’esistenza e l’immortalità dell’anima.
Secondo Bolzano, il principio etico fondamentale reciterebbe: “fra tutte le azioni che tu puoi fare, scegli quella che, considerate tutte le possibili conseguenze, procura il bene più grande per il maggior numero di persone”. La sua morale può essere quindi considerata una forma di utilitarismo. Per quanto riguarda le sue idee politiche, egli auspicava una sorta di socialismo utopistico: chiedeva la promulgazione di una costituzione repubblicana, la limitazione della proprietà privata e dei diritti ereditari, la nazionalizzazione di terra, commercio e banche.
RALPH WALDO EMERSON

“Odio le citazioni, dimmi quello che sai”.
Introduzione
Saggista, poeta e filosofo molto popolare, Ralph Waldo Emerson (Boston 25/05/1803 – 1882) iniziò la sua carriera come pastore della Chiesa unitariana (l’unitarianismo è quella dottrina teologica che afferma l’unicità assoluta di Dio, negando quindi il dogma trinitario, l’incarnazione e la divinità di Cristo), ma ottenne lustro internazionale in quanto apprezzato lecturer e autore di saggi quali La fiducia in sé stessi, Storia, L’oltreanima e Destino. Personalità poliedrica, attinse da svariate correnti di pensiero: il romanticismo inglese e tedesco, il neoplatonismo, il kantismo e addirittura l’induismo. Intere generazioni di scrittori e intellettuali americani risentirono della sua influenza, a partire dall’amico Henry David Thoreau fino a John Dewey, senza tralasciare il fatto che anche un pensatore del calibro di Friedrich Nietzsche ne apprezzò esplicitamente gli scritti e dedicò gran parte della sua riflessione ai temi del nostro, in particolare alla potenza, al fato, alla poesia, alla storia e alla critica del cristianesimo.
Che cosa vuol dire lecture? Il dizionario suggerisce “lezione” e “conferenza”. Occorre tener presente, tuttavia, ciò che con questo termine si intende quando ci si riferisce all’America del 1800. Le lectures tenute da Emerson non erano delle lezioni universitarie. Egli parlava nei Lyceums, qualcosa di simile agli odierni circoli culturali, ad un pubblico costituito da persone in carriera, da self-made men. Una lecture durava solitamente un’ora, massimo un’ora e mezza: Emerson poteva tenere fino a ottanta conferenze l’anno, conseguendo un reddito vicino a quello di un normale professore di college. Emerson è generalmente considerato il massimo esponente di quella corrente filosofica fiorita specialmente a Boston e definita “trascendentalismo americano”. Il nostro autore, al pari degli altri “trascendentalismi”, si ritiene erede legittimo della tradizione kantiano-fichtiano-schellinghiana, ma legge poi la filosofia trascendentale attraverso le lenti interpretative del Romanticismo, finendo in tal maniera per riconoscere la superiorità assoluta del sentimento sulle altre facoltà conoscitive. Il suo pensiero, dunque, non deve essere qualificato come “filosofia trascendentale”, bensì come “trascendentalismo”.
1. Cronologia
1803
Il 25 maggio nasce a Boston da William e Ruth Haskins Emerson.
1811
Perde il padre, probabilmente per tubercolosi.
1812
Si iscrive alla Boston Public Latin School.
1817
Inizia i corsi ad Harvard: Greco, Latino, Storia, Retorica.
1820
Inizia a scrivere i suoi Journal, continuati poi tutta la vita, le cui annotazioni rappresentano la fonte originaria di gran parte delle sue opere.
1821
Dopo la laurea, inizia a insegnare alla scuola femminile di Boston diretta da suo fratello William.
1825
Frequenta corsi alla Facoltà di Teologia di Harvard.
1829
Sposa Ellen Tucker ed è ordinato pastore della Boston’s Second Church.
1831
Perde la moglie Ellen, morta all’età di 19 anni.
1832
Abbandona il suo incarico di pastore e parte per l’Europa.
1833
Incontra Wordsworth, Coleridge, J.S. Mill e Thomas Carlyle. Fa ritorno a Boston in novembre, dove inizia la sua carriera di lecturer.
1834
Riceve la prima metà della sostanziosa eredità di Ellen Tucker (riceverà la seconda metà nel 1837).
1835
Sposa Lidian Jackson.
1836
Pubblica il suo primo libro, Natura.
1838
In data 15 luglio, tiene il Discorso alla Facoltà di Teologia, che vuole essere una coraggiosa affermazione d’indipendenza culturale.
1841
Pubblica la raccolta Saggi (che contiene La fiducia in sé stessi, L’oltreanima, Cerchi, Storia).
1842
Perde il figlio Waldo, morto di scarlattina a soli 5 anni.
1844
Pubblica il volume Saggi, seconda serie (che contiene Il poeta, L’esperienza, Nominalismo e Realismo).
1847
È impegnato in una serie di lectures in Inghilterra, lavoro che lo terrà occupato anche l’anno successivo.
1850
Pubblica Uomini rappresentativi (una raccolta di saggi dedicati a Platone, Swedenborg, Montaigne, Goethe, Napoleone).
1851-60
Si pronuncia contro le leggi schiaviste e sostiene pubblicamente i candidati abolizionisti a Concord, Boston, New York e Philadelphia.
1856
Pubblica Caratteristiche inglesi.
1860
Pubblica Condotta di vita (che contiene Cultura e Destino).
1867
Tiene una serie di lectures toccando nove stati americani.
1870
Pubblica Società e solitudine. Allestisce e presenta sedici lectures per la Facoltà di Filosofia di Harvard.
1872
Superato un periodo di salute precaria, trascorre due anni viaggiando per l’Europa e visitando l’Egitto.
1875
Si interrompono le annotazioni sui suoi Journal.
1882
Muore a Concord il 27 aprile, all’età di 78 anni.
2. Temi principali del suo pensiero
2.1 L’educazione
Ne Lo studioso americano, un discorso tenuto il 31 agosto 1837 per la “Phi Beta Kappa Society” di Cambridge, Emerson afferma che l’intellettuale è educato dalla natura, dai libri e dall’azione. La natura è la prima sia in ordine cronologico (è presente da sempre) sia in ordine di importanza. Dietro la varietà delle forme naturali, si celano infatti le stesse leggi fondanti che governano la mente umana: la disciplina dalla quale la natura è regolata è una preziosa fonte d’insegnamento per l’uomo. L’antico precetto “conosci te stesso” e il moderno comandamento “conosci il mondo” diventano in ultima analisi una cosa sola. I libri, la seconda componente dell’educazione dello studioso, ci offrono l’opportunità di dialogare col passato: tuttavia, a detta del nostro, molto di ciò che passa ancora per insegnamento ed istruzione è in realtà semplice sacralizzazione del sapere scritto. Il corretto rapporto con i libri non è quello del “topo da biblioteca” o del bibliomane, ma quello del lettore creativo che usa i libri come stimoli per cogliere principi propri. Se usati bene, i libri ispirano l’anima attiva. La terza componente fondamentale dell’educazione è l’azione: senza di essa infatti, il pensiero non matura mai in verità. L’antenato di ogni azione è un pensiero. L’azione è anche il dizionario di uno studioso, la fonte di ciò che egli ha da dire: il vero intellettuale parla per esperienza propria, non per imitazione degli altri; le sue parole sono cariche di vita: “insisti su te stesso, non imitare mai”, afferma Emerson.
A suo avviso, questo modello educativo basato sull’esperienza e sull’espressione del sé non è indicato solamente a una ristretta classe di persone, ma è adatto a ogni uomo, essendo il suo obiettivo finale la creazione di una nazione democratica. Solo quando tutti impareremo a camminare con le nostre gambe e a pensare con le nostra testa esisterà per la prima volta una nazione.
Il segreto dell’educazione è, per il nostro, il rispetto dell’allievo: l’insegnante non deve decidere cosa l’allievo deve sapere e deve fare, ma lasciare che questi lo scopra da sé. Il maestro non deve far altro che “aspettare ed osservare il nuovo prodotto della Natura”, guidando le azioni dell’allievo in modo da incoraggiare quelle positive e da evitare quelle non appropriate ad una corretta educazione. Il modello di Emerson ricorda molto quello che Rousseau delinea nel suo Emilio: all’educazione tradizionale che opprime e distrugge con una sovrastruttura artificiale la natura originaria, bisogna sostituire un’educazione negativa che si proponga come unico fine la conservazione e il rafforzamento di tale natura. Nell’educazione di massa questo fine è sacrificato. “Invece di educare masse – sostiene Emerson – bisognerebbe educare persone”.
2.2 Il divenire
Emerson è per molti versi un filosofo del divenire, per il quale l’universo è essenzialmente un flusso continuo. Perfino quando parla dell’essere, egli non ha in mente una roccia inamovibile ma una serie di “oceani infiniti”. Il divenire è la base della successione dei modi che il nostro descrive in L’esperienza e dell’importanza che egli dà al tempo presente nella sua riflessione filosofica.
Alcune delle sue idee più originali circa la moralità e la verità discendono direttamente da questa metafisica del divenire: nessuna virtù è ultima o eterna; la verità è un insieme di occhiate fugaci, non una visione limpida. Noi possiamo scegliere tra la verità e la calma, ma non possiamo averle entrambe.
Ovviamente, anche le sue idee sulla religione si inseriscono in questa cornice metafisica. Si può trovare Dio solo nel presente: “Dio è, non era”. Al contrario, il cristianesimo storico procede “come se Dio fosse morto”. Anche la Storia, che sembra avere totalmente a che fare con il passato, ha per Emerson il suo vero valore in quanto serva del presente.
2.3 La morale
Le opinioni etiche del nostro si intrecciano naturalmente con la sua metafisica del divenire e con il suo perfezionismo, ovvero l’idea che il fine della vita sia quello di passare a forme sempre più alte e perfette. Emerson concepisce la morale in un continuo sviluppo storico, ma in alcuni passi sembra addirittura esprimere una posizione più scettica e radicale: che le nostre virtù debbano più spesso essere abbandonate che coltivate. “Il terrore che accompagna una riforma è rappresentato dallo scoprire che dobbiamo gettare via le nostre virtù – o ciò che abbiamo sempre considerato essere virtù – nella stessa fossa in cui abbiamo gettato i nostri vizi più grandi”. In questa frase, notiamo un significativo inciso che ci fa capire come Emerson non abbracci un facile relativismo secondo il quale è de facto virtù ciò che in ogni tempo è assunto come tale. Ciononostante egli getta un’ombra di sospetto su tutti modi di pensare ed agire stabiliti dal conformismo. “Sii libero da tutte le influenze”, scrive il nostro autore. Il male è, quindi, la cieca ubbidienza, la volontà di imitazione, di omologazione. Le virtù sopravvivono nel nuovo momento, il momento della verità, dell’originalità, della creazione; il momento in cui ciò che una volta sembrava importante può ora apparire come ridicolo o vano. In questa prospettiva, quindi, le virtù non scompaiono del tutto, ma devono essere significativamente alterate e riadattate.
Sebbene Emerson non sia intenzionato ad esporre un compiuto sistema etico, attraverso le sue opere non rinuncia a delineare vizi e virtù, eroi e furfanti. Nel Discorso alla Facoltà di Teologia, i furfanti sono gli “spettrali predicatori” i cui sermoni non offrono nessun suggerimento derivante da un’effettiva esperienza di vita; La fiducia in sé stessi condanna quelle virtù che sono in realtà “penitenze”, insieme alla filantropia di quegli abolizionisti che ostentano un amore idealizzato verso persone lontane, ma sono pieni di odio verso quelle che hanno a fianco.
Il conformismo è, per il nostro, il vizio principale, l’esatto opposto della virtù della fiducia in sé stessi: “chi vuol essere un uomo deve essere un anticonformista”. Ci lasciamo irretire dal conformismo quando prestiamo immotivata stima alla moda, all’abbigliamento o ad altri status-symbol, quando indossiamo una falsa maschera di adulazione, quando ci sforziamo di sorridere pur non sentendoci a nostro agio, quando fingiamo coinvolgimento per una conversazione che non ci interessa minimamente. Se il precetto fondamentale dell’etica è quello di non consentire a ciò che gli altri pensano, fanno, dicono, allora quel che Emerson impone è che, paradossalmente, non si debba seguire/consentire nemmeno alle nostre azioni passate, al “morto” altro che è in noi e che esige coerenza. Come ben scrive Beniamino Soressi, “solo chi si è allontanato da sé (dal sé passato) può confidare in sé (nel prossimo sé). Confidare nel sé passato (per una stupida coerenza) o nel sé conformista (per sentimenti di timore e vergogna) significa diffidare del prossimo, possibile, sé: significa negarlo”. Ma “chi rimuove il sé possibile rimuove anche la possibilità di esprimere una parola e un pensiero viventi anziché il pensiero di qualche morta istituzione” (B. Soressi, R.W. Emerson, Il pensiero e la solitudine).
La virtù cardine, come abbiamo appena visto, è quella della fiducia in se stessi o – come la chiama Emerson – della self-reliance: una locuzione in cui egli intende condensare originalità e spontaneità. Il concetto di self-reliance è efficacemente espresso dal nostro autore tramite l’immagine di un gruppo di ragazzi disinvolti che, sicuri di se stessi, fanno e dicono ciò che pensano, non curandosi di assecondare gli altri. Questi ragazzi giudicano liberamente il mondo e le persone che vivono in esso, condannando ciò che trovano sciocco o seccante ed elogiando ciò che ai loro occhi appare interessante e significativo. Quest’immagine illustra chiaramente la tipica combinazione emersoniana di classico (l’idea di una gerarchia in cui i ragazzi occupano un posto d’onore) e romantico (l’esaltazione dell’infanzia e della giovinezza). L’essenza della giustizia e della felicità è che ognuno segua la sua strada: “la fiducia in se stessi è l’essenza dell’eroismo”.
A prima vista, potrebbe sembrare che Emerson, parlando di self-reliance, entri in contraddizione con quanto sosteneva in precedenza: l’idea di un self già formato in cui noi dobbiamo avere fiducia cozza con il concetto del continuo divenire e con la “stupida coerenza” che esige il nostro sé passato. In realtà, il self cui si riferisce l’autore è il sé sempre nuovo e diverso nel processo di creazione nel quale siamo in ogni momento coinvolti. Un processo nel quale – per usare un’espressione di Nietzsche – si diventa ciò che si è.
I rapporti umani più riusciti e duraturi richiedono la confidenza e l’indipendenza che solo la virtù della fiducia in sé stessi può conferire: la società ideale di Emerson è quella formata da “divinità potenti e indipendenti, che conversano da un picco all’altro dell’Olimpo”. Sebbene il nostro accentui l’importanza dell’indipendenza interindividuale nella società – per evitare che la loro vicinanza si tramuti in omologazione e imitazione – pone il fine della self-reliance nella sfera pubblica e sociale: in altre parole, egli è ben consapevole che dall’influenza degli altri è possibile uscire solo attraverso l’influenza degli altri. È quindi necessario distinguere un’influenza cattiva da una buona. Quella cattiva separa il soggetto dal principio della creazione e dell’originalità, pietrificando il sé nella morta ripetizione del pensiero e dell’agire degli altri. Quella buona permette invece al soggetto di attingere possibilità di vita, di pensiero e di azione sconosciute o ancora non realizzate. Ed è proprio questo tipo di influenza che hanno sul mondo gli uomini rappresentativi: i loro nomi – Platone, Mosè, Gesù, Lutero, Copernico, Napoleone – “sono scolpiti nella storia del mondo”. In Uomini rappresentativi, Emerson contrappone all’intelletto, finalizzato alla scienza e alla prassi quotidiana, un’intuizione razionale preposta alla comprensione del Tutto, della totalità, in definitiva dell’essenza ultima del reale. L’intera storia del pensiero è divisa tra “uomini parziali”, che utilizzarono soltanto l’intelletto senza riuscire a cogliere il reale senso delle cose, e “uomini rappresentativi” (o “uomini totali”), i quali, grazie alla ragione, afferrano la potenza infinita che sta alla base di ogni manifestazione fenomenica e naturale.
Oltre alla virtù cardine della fiducia in sé stessi, Emerson riconosce valore anche ad altre qualità umane, in particolare un tipo di fede e la pratica di un “saggio scetticismo”. Ci sono occasioni, egli afferma, nelle quali dobbiamo lasciare andare il mondo come va ed avere fede nella natura dell’universo: “come il viandante che ha perso la strada lascia andare le redini del cavallo e ripone la sua fede nell’istinto dell’animale per ritrovare la via, allo stesso modo dobbiamo comportarci noi con l’animale divino che ci porta attraverso questo mondo”. Tuttavia, il mondo del processo e del divenire richiede una sorta di flessibilità epistemologica e pratica, che Emerson chiama “saggio scetticismo”. L’emblema di questo tipo di scettico è Michel de Montaigne, ritratto in Uomini rappresentativi non come un pirronista, ma come un uomo con un grande senso del sé, radicato nella terra e nella vita comune, la cui ricerca è rivolta verso la conoscenza. Montaigne sa che la vita è pericolosa e incerta, una tempesta di diversi elementi la navigazione attraverso la quale richiede un’imbarcazione flessibile, adatta alla forma dell’uomo.
2.4 Il cristianesimo
Benché figlio di un pastore della Chiesa unitariana, studente della Facoltà di Teologia e pastore egli stesso per circa tre anni, Emerson riserva nel Discorso alla Facoltà di Teologia del 1838 una profonda e sentita critica alla religione cristiana, insistendo sulla stessa linea argomentativa già tracciata ne Lo studioso americano. Il nostro autore si accorge di come il moderno cristianesimo – con le sue istituzioni educative – soffochi e mortifichi lo spirito creativo dell’uomo: il cristianesimo è diventato “una monarchia orientale”, nella quale Gesù è stato reso l’oppressore dell’umanità.
Sebbene Emerson consideri una vera e propria calamità la perdita della fede e del culto da parte di una nazione, trova strano il fatto che, vista la crisi e “la carestia delle nostre chiese”, la gente sia ancora obbligata frequentarle. Egli invita perciò i membri della Facoltà a procurare nuova linfa per le vecchie forme della loro religione, ad essere amici ed esempi per i loro parrocchiani, a ricordarsi che “tutti gli uomini hanno pensieri sublimi; tutti gli uomini meritano qualche ora per essere ascoltati: essi desiderano essere ascoltati”.
2.5 La potenza
Il tema della potenza si ritrova in molti degli scritti di Emerson: ne Lo studioso americano, questo concetto è strettamente correlato all’azione, in particolare là dove l’autore sostiene che il vero intellettuale ripensa con rimorso ad ogni opportunità di azione che ha sprecato, considerandola una diminuzione della propria potenza. Ne La fiducia in sé stessi, il nostro afferma che la potenza che risiede in ognuno di noi è novità e creazione per la natura; L’esperienza contiene un passo nel quale Emerson esalta una vita che definisce “forte” e “vigorosa”. Infine, nel saggio La potenza, egli esalta la figura del rude, del “duro” che vive seguendo le proprie regole. Il power cui si riferisce Emerson conserva tuttavia più un carattere artistico-intellettuale che politico-militare. Un passaggio de La potenza recita infatti:
“Il momento più alto della storia umana fu quello in cui l’uomo aveva da poco abbandonato il suo stato selvaggio, il momento in cui la sua rude forza pelasgica era tutta diretta verso il nascente senso della bellezza – e qui abbiamo Pericle e Fidia – prima del trapasso nella civiltà corinzia”
La potenza si trova tutt’intorno a noi, ma non è sempre possibile controllarla. È come “un uccello che si libra nell’aria senza meta”, passando incessantemente di ramo in ramo.
2.6 L’Oversoul
In molte pagine dei suoi saggi e dei suoi discorsi, Emerson ci illustra una grande visione di unità: ne Lo studioso americano, parla di una “unità originaria” o “sorgente di potenza” di cui ognuno di noi è parte; nel Discorso alla Facoltà di Teologia scrive che l’uomo è “un’insenatura nel mare della Ragione”. In La fiducia in sé stessi, il saggio che più di ogni altro celebra l’individualità e la soggettività, accenna a come il Tutto si risolva nell’Uno. Tuttavia – come abbiamo visto in precedenza – il nostro autore ha una concezione del mondo come un processo in continuo divenire, un ininterrotto processo di creazione nel quale siamo in ogni momento coinvolti: come si possono conciliare queste due prospettive a prima vista fortemente in contraddizione fra loro? Come tenere insieme l’istanza individualistica e soggettivistica della self-reliance con la concezione dell’unità appena esposta?
Per ciò che riguarda la questione ora esposta, va segnalato che in nessun punto della sua opera Emerson si esprime in modo così chiaro da permettere di formulare una risposta definitiva. Ciò detto, possiamo provare a riflettere sul concetto emersoniano del sé: esso non è e non può essere ridotto a quello dell’autoconsapevolezza di un individuo-monade, autonomo e separato dagli altri individui. Il sé di cui parla il nostro autore deve essere concepito come una sorta di momento attraverso cui l’individuo si apre a una creatività impersonale e transindividuale che Emerson definisce oltreanima (over-soul). L’oltreanima, commenta Soressi, “rappresenta una sfida al concetto tipicamente occidentale del sé come ego e alla logica che ‘vuole’ concepire la mente umana come separata”. Il concetto di oltreanima infatti “rappresenta l’unità dell’intelligenza, degli istinti e dei sentimenti dell’umanità tutta, è come il tesoro già presente di tutte le possibilità di un soggetto umano”.
Il tentativo più diretto che il nostro fece per cercare di riconciliare la successione temporale con l’unità, o – se si preferisce – i molti con l’Uno, lo si può leggere in Nominalismo e Realismo, ultimo saggio della raccolta Saggi, seconda serie: in un passo decisivo, Emerson parla dell’universo come “un vecchio bifronte… di cui si può dire tutto e il contrario di tutto”. È più che evidente l’esito scettico al quale approda lo scrittore americano. Una venatura scettica è presente anche in quella visione che Stanley Cavell ha definito “epistemologia dei modi”. Secondo questo modello gnoseologico – rintracciabile soprattutto nel saggio L’esperienza ma presente in tutti gli scritti del nostro autore – noi non conosciamo nulla in modo diretto e immediato, non conosciamo ciò che una cosa è in sé, ma solo ciò che una cosa è sotto un determinato aspetto o modo.
3. Alcune questioni su Emerson
3.1 Il problema della coerenza
Il pensiero di Emerson è stato a più riprese tacciato di incoerenza: da una parte, egli sostiene che il mondo è un processo e un divenire continuo; dall’altra, che è espressione di un’unità. Dice che il mondo procede per la sua strada e che non si cura del nostro volere, ma ci invita ad avere fiducia nel potere creativo e innovativo della nostra immaginazione; esalta i benefici del viaggio, esperienza capace di arricchire la nostra interiorità, ma contemporaneamente ce ne mostra la futilità, e seguendo il classico tema della commutatio loci, sostiene che, pur svegliandoci in posti sempre nuovi, troviamo comunque ad aspettarci il vecchio self che pensavamo di lasciarci alle spalle: “per quanto viaggiamo in tutto il mondo per trovare ciò che è bello, dobbiamo portarlo con noi oppure non lo troveremo”.
L’epistemologia dei modi – come abbiamo visto poco sopra – potrebbe essere vista come una struttura concettuale nella quale inserire e far convivere dottrine, teorie e punti di vista altrimenti inconciliabili. Oppure basterebbe semplicemente considerare che il pensiero di Emerson ammette lo scontro degli opposti, “the clangor and jangle of contrary tendencies”, facendogli affermare, con Eraclito, che è pòlemos il padre di tutte le cose. Oltre a ciò, è da notare come, nonostante le critiche, l’insegnamento del nostro possa comunque definirsi complessivamente coerente. Basti pensare all’idea dell’anima attiva e creatrice, nocciolo del concetto di self-reliance: su questo caposaldo Emerson fonda la discussione della maggior parte dei temi che tratta, dall’educazione alla religione, dalla morale fino al divenire del mondo.
3.2 I “due” Emerson
È difficile per un lettore attento non percepire alcune importanti differenze tra il giovane e il vecchio Emerson: ad esempio tra l’ottimistico autore di Natura (1836) e quello disilluso che emerge leggendo il finale de L’esperienza (1844); tra il fresco scrittore di La fiducia in sé stessi (1841) e quello fiacco di Destino (1860). Emerson stesso sembra rendersene conto quando, nel saggio appena citato, scrive: “una volta pensavo che il potere creativo e positivo fosse tutto. Ora ho imparato che il potere negativo, o le circostanze contingenti, sono la metà di questo tutto”. È la dimostrazione che Emerson col tempo ha imparato una lezione che ha modificato il suo modo di pensare e di scrivere? Una lezione concernente i molti modi in cui le circostanze su cui non possiamo esercitare il nostro controllo – malattie, catastrofi naturali, carattere, istinto, età – minano la fiducia in sé stessi e nella vita?
In questo senso, L’esperienza è un saggio chiave, uno scritto di transizione: sull’atmosfera dell’opera, pesa costantemente un terribile evento, la morte del figlio Waldo, avvenuta un paio d’anni prima. I toni sono naturalmente tristi: Emerson ci parla di confusione, turbamento, sconvolgimento, oscurità. Egli trova in questo episodio un esempio di quello sgradevole carattere dell’esistenza per cui essa sempre scivola e fugge via da noi, proprio come farebbe sabbia finissima tra le nostre dita.
Ciononostante, sebbene esista qualche significativa variazione nello stile e nel tono della prosa emersoniana, la visione che il nostro autore fa valere della condizione umana rimane sostanzialmente la medesima lungo tutta la sua opera. In generale, possiamo constatare come i primi lavori, più freschi e solari, lascino trapelare una maggiore fiducia nelle potenzialità umane, dipingendo un uomo in qualche modo pronto per un grande passo avanti; sulle opere più tarde, invece, sembra quasi gravare un peso, un fardello che soffoca la fiducia dell’uomo in se stesso e ne opprime la volontà.
3.3 Fonti del suo pensiero e fortuna della sua opera
La gamma degli interessi e delle letture di Emerson fu molto ampia: nei suoi saggi, cita spesso gli scrittori dai quali ha tratto ispirazione per una particolare riflessione. Nei suoi journals, troviamo vere e proprie liste di letterati, filosofi e pensatori religiosi a partire dalle idee dei quali egli ha sviluppato qualche nuova concezione. Tra i più importanti vanno sicuramente citati Platone e i neoplatonici maggiori (Plotino, Proco, Giamblico); ugualmente significativi per la formazione del nostro furono gli autori di tradizione kantiana e romantica (che egli conobbe probabilmente tramite la Biographia Literaria di Coleridge). Emerson si interessò anche della cultura orientale, in particolare della filosofia induista e del confucianesimo. Per dare un’idea della vastità delle influenze del nostro – senza tuttavia avanzare alcuna pretesa di completezza – elencheremo qui di seguito, in ordine sparso, alcuni degli scrittori che più frequentemente vengono citati nei suoi lavori: Berkeley, Wordsworth, Newton, Anassagora, Schlegel, S. Agostino, Bacone, Jacob Behmen, Cicerone, Lucrezio, Goethe, Socrate, Eraclito, Pitagora, Schiller, Shakespeare, Madame de Staël, Emanuel Swedenborg (ma l’elenco potrebbe continuare).
Oggigiorno le opere di Emerson sono abbastanza ben conosciute sia negli USA sia in Europa. Uno dei primi ad apprezzarlo nel vecchio continente fu Friedrich Nietzsche: a proposito dei Saggi di Emerson, il filosofo tedesco disse che mai in un libro si era sentito tanto a casa sua: non deve perciò stupire che molte idee e riflessioni del nostro – sulla storia, sull’educazione, sulla potenza, sul self – possano essere rintracciate anche negli scritti di Nietzsche. Per quanto riguarda il panorama culturale americano, non è da sottovalutare la profonda influenza che Emerson esercitò su personalità del calibro di William James e John Dewey, pensatori che, insieme a C.S. Peirce, possono essere considerati i principali esponenti del pragmatismo americano.
FEDOR MICHAILOVIC DOSTOEVSKIJ

“Se Dio non esiste, tutto è permesso”.
A cura di Loreti Matteo
Quella di Dostoevskij non è propriamente un’opera filosofica: se si escludono brevi saggi apparsi su varie riviste dell’epoca, oltre al suo diario nel quale esprime in forma concettuale le idee che poi si incarnano nei personaggi dei suoi romanzi, egli preferì alla schematicità e sistematicità del trattato la finzione letteraria; la sua è una filosofia dialettica che, come nei dialoghi platonici, lascia intravedere nella cadenza della conversazione, degli scambi di idee tra i suoi personaggi la sua concezione della vita umana, una concezione vorticosamente incentrata sull’idea di libertà e di dignità. Gide scrisse che i romanzi di Dostoevskij sono i libri più carichi di pensiero che esistano, pur essendo romanzi. In Dostoevskij filosofia e letteratura si fondono, si compenetrano, perché se la filosofia è riflessione sulla esistenza è propedeutica alla scelta tra le modalità che questa propone, e non mera speculazione; e quindi non può nascere che dall’esistenza, dalla vita. Il problema fondamentale che attraversa tutta la sua opera, almeno dalle Memorie del sottosuolo in poi, è un problema etico e metafisico insieme; quello del bene e del male, che l’uomo è chiamato a scegliere in virtù della libertà che Dio gli ha concesso.
Nel dibattito filosofico italiano, è stato il filosofo piemontese Luigi Pareyson a portare l’attenzione sulla figura di Dostoevskij, scorgendo in lui le radici di un pensiero tragico al cui centro stanno la libertà e la scelta.
Per capire l’opera, è tuttavia necessario conoscere la vita dello scrittore Dostoevskij, che contribuisce a mettere in luce il passaggio dalla concezione umanitaristica dei primi romanzi, da Povera gente a Memorie di una casa di morti a quella metafisica dei grandi romanzi e culminante nel potente e inquietante affresco de I fratelli Karamazov; e ovviamente il contesto storico e culturale della Russia della seconda metà dell’ottocento.
Fedor Michailovic Dostoevskij nasce a San Pietroburgo nel 1821. La sua famiglia discende dalla piccola nobiltà lituana del XVIII secolo. Il padre dello scrittore era un medico militare, diventato poi col tempo un piccolo proprietario terriero, dispotico e violento, tanto che verrà ucciso da uno dei suoi servi. La madre, una donna gentile, serena, profondamente cristiana, avvicina per prima Fedor alla religione, leggendogli fin da piccolo brani della Bibbia. Il futuro scrittore viene costretto dal padre a compiere studi tecnici, ma la vocazione letteraria si manifesta in lui immediatamente, tanto da fargli pubblicare a ventiquattro anni il primo romanzo, Povera gente, da lui definito “un romanzo dell’ampiezza di Eugenie Grandet” di Balzac.
Contemporaneamente, egli entra a far parte di un circolo letterario di orientamento politico sovversivo, dove si leggono testi di autori socialisti come Fourier e Saints Simon. Quando il circolo viene dichiarato fuori legge, Dostoevskij viene condannato all’esecuzione capitale con gli altri membri, ma proprio mentre i condannati sono di fronte al plotone di esecuzione arriva improvvisa l’ordinanza dello zar che commuta loro la pene capitale e dispone quattro anni di lavoro forzato in Siberia. Durante tale periodo, Dostoevskij si avvicina al pensiero slavofilo, riscopre il cristianesimo ortodosso abbandonando le posizioni politiche eversive prima appoggiate. Uscito dal carcere, fonda una rivista letteraria dove si scaglia più volte contro i nichilisti di orientamento socialista che, a suo dire, mettono a repentaglio lo spirito e il senso religioso russo, oltre a destabilizzare la situazione politica, con la loro dichiarata professione di ateismo e la proposta di rovesciare con la rivoluzione l’ordine sociale e politico esistente in nome della rivoluzione. Nel frattempo, è già iniziata la pubblicazione dei grandi romanzi; nell’ordine, Memorie del sottosuolo, Delitto e castigo, L’idiota, I demoni, e ultimo il capolavoro I fratelli Karamazov, ultimato poco prima della morte, avvenuta nel 1881.
Dostoevskij può essere considerato, come sostiene Nikolaj Berdjaev, “il più grande metafisico russo”. La sua è un’intuizione cristiana del mondo e dell’esistenza umana che ruota intorno alla sacralità della vita, una sacralità che non può avere altra motivazione che non derivi necessariamente dalla sua origine divina. La fede cristiana (ortodossa, s’intende) rappresenta quindi la stella polare che guida Dostoevskij nella sua analisi, a volte crudele ed impietosa, dell’animo umano, del quale scandaglia le profondità che si rivelano alla superficie quando questi abusa della sua libertà e la muta in arbitrio. L’uomo è libero, ci dice Dostoevskij, tragicamente libero, perché è stato creato a immagine e somiglianza di Dio che l’ha messo al mondo dotato di ragione, facoltà che deve saper incanalare per poter cogliere nel corso dell’esistenza la differenza tra il bene e il male. Quando però la “ruminazione cerebrale” (espressione usata da Gide) conduce alla pretesa superomistica di autodeterminarsi da sé, rinnegando Dio e perciò anche la natura divina dell’uomo, la libertà rinnega sé stessa e si ritorce contro l’individuo, conducendo la sua personalità alla dissoluzione. Nessuno come Dostoevskij ha rappresentato con così tanto vigore gli effetti a cui può portare il rovesciamento della natura divina dell’uomo dal Dio-uomo all’Uomo-dio.
La dialettica dostoevskijana squarcia i veli che la filosofia razionalistica aveva steso sui più bassi istinti della natura umana, impedendo di coglierne le contraddizioni. Sembra quasi di ritrovare qualcosa dello spirito di Eraclito nello scrittore russo: pur essendo una vera e propria gnosi, le sue idee sono percezioni dinamiche della realtà, non statiche come avviene in Platone; la sua filosofia è una percezione religiosa dell’esistenza umana, che si colloca però all’opposto dei grandi pensatori cristiani mistici proprio perché nei suoi personaggi rappresenta le conseguenze che la tragicità insita nella libertà umana può portare all’individuo. Emblematica, in questo senso, è la figura dell’“uomo del sottosuolo”, espressione indicante quel lato oscuro della personalità presente in ogni uomo che Freud più avanti chiamerà “inconscio”. Costui dichiara infatti nelle sue memorie (prima con una sconvolgente riflessione-confessione, poi con una serie di episodi della sua vita) che l’uomo sarebbe disposto, pur di conservare per sé la cosa più stupida e dannosa, la peggiore umiliazione o vergogna pur di conservare la sua libertà nei confronti degli alfieri del progresso sociale e politico che vogliono impostare la convivenza sociale e l’ordine politico in base a criteri di pura razionalità. L’uomo non sarà mai un tasto di pianoforte e non si rassegnerà mai al “due più due uguale quattro”.
Memorie del sottosuolo è forse l’opera più profonda e compiuta di Dostoevskij, quella dove la sua filosofia viene espressa in forma pura, e rappresenta un sconvolgente resoconto del più turpe lato dell’animo umano. Pochi hanno saputo trattari temi così alti e profondi con tale forza e chiarezza espressiva. Tra gli autori a lui contemporanei, si fa spesso il nome di Friedrich Nieztsche, a cui è accomunato dalla percezione tragica dell’esistenza che però nel filosofo tedesco si risolve nel nichilismo perché egli è troppo profondamente legato alla cultura greca e sostanzialmente estraneo al cristianesimo, incapace perciò di intravedere nella figura salvifica di Cristo il riscatto dell’umanità. La concezione di Dostoevskij è tragica, ma nella misura in cui il fardello della libertà pesa interamente sulle spalle dell’uomo conferendogli tutta la sua dignità. Quella di Nietzsche è concezione dell’assurdo, perché non riconosce alcun senso ontologicamente dato nell’essere: per riscattarsi, l’uomo deve darsi da sé un senso trasformandosi nel superuomo la cui volontà di potenza lo conduce però alla catastrofe dell’anti-uomo.
È impressionante come Dostoevskij abbia in questo anticipato la concezione superomistica di Nietzsche con Delitto e castigo prima e con I demoni poi, dove lo stesso problema viene affrontato a livello politico e collettivo anziché individuale. Il primo è la storia di un giovane studente, Raskolnikov, convinto di avere facoltà intellettive e personalità eccezionali, e per mettersi alla prova decide di uccidere una vecchia usuraia, odiata da tutti, pensando di realizzare un’azione positiva. In realtà, dopo l’omicidio, il giovane si trova gravato da un peso che lo porta a sfiorare la follia e lo costringe a confessare il delitto: la consapevolezza di aver oltrepassato i limiti della libertà umana, l’affermazione della quale si è scontrata con la brutalità di un’azione che ha leso la libertà e la dignità di una creatura che, per quanto insignificante possa essere, ha comunque diritto alla vita sulla base del presupposto che ogni uomo è a immagine e somiglianza di Dio e pertanto la sua sorte non può essere decisa da un altro uomo. Raskolnikov riuscirà a sottrarsi alla perdizione e allo sdoppiamento della personalità solo grazie all’amore della giovane Sonija, figlia di un impiegato conosciuto in una bettola al principio del romanzo e poi morto investito da una carrozza. Sonija viene tratteggiata da Dostoevskij come una ragazza giovane, semplice, umile, costretta a prostituirsi per pagare i debiti del padre e proprio per questo dotata di una grazia, di una bellezza interiore che poco a poco redime il giovane studente con la forza della compassione e della pietas cristiana. Solo nei semplici, nei puri di cuore, come nel Vangelo, Dostoevskij vede incarnata la capacità di sentire le sofferenze altrui e solo in esse la passione intesa come forza purificatrice lava l’animo di coloro che hanno imboccato la strada del male, redimendoli. Lo stesso avviene con la figura del principe Miskyn, il protagonista de L’idiota: il termine non è qui riferito alle scarse capacità intellettive del protagonista, quanto piuttosto alla sua purezza d’animo, alla sua ignoranza delle cose del mondo. Tornato in Russia all’età di ventisette anni, dopo aver passato gli anni precedenti in cura presso una clinica svizzera per epilessia che l’aveva ridotto, secondo egli stesso, “quasi un idiota totale”, viene introdotto nell’aristocrazia russa grazie a una lontana parente e coinvolto in una serie di episodi che lo condurranno alla pazzia perché incapace di comprendere la malvagità e la malafede delle persone con le quali si trova a che fare che tenta di comprendere nel profondo e redimere. Tutti considerano il principe un povero ingenuo sprovveduto, ma la sua capacità di leggere nell’animo delle persone talvolta è così straordinaria da disarmare; ma proprio il suo candore sarà la causa della sua rovina. Il suo amore per una giovane donna, Nastasja Filipovna, che il volgare Rogozin cerca di possedere e di comprare con la ricchezza, è un amore non passionale, ma “di compassione”, ma la giovane, l’unica ad aver veramente intuito la enorme nobiltà d’animo del principe, lo fugge continuamente proprio per l’incapacità di sostenere un simile amore, per il quale non si sente adatta, temendo di portare il principe alla pazzia, tra le cui nebbie egli però finisce ugualmente in tentativo quasi donchisciottiano (il personaggio che Dostoevskij amava più di tutti) di redimere il mondo che lo circonda. La capacità di Dostoevskij di ritrarre figure così estreme nella loro unicità, eppure contemporaneamente così realistiche, vive e vicine allo spirito dei nostri tempi raggiunge forse il suo apice ne I demoni: qui le straordinarie e inquietanti figure di Verchovenskij, Stavrogin, Kirillov, i cospiratori della setta socialista trasudano una forza spirituale e umana immensa. Nel personaggio di Stavrogin, Dostoevskij sembra aver voluto rappresentare gli effetti di quello che Kierkegaard in Aut-aut chiama lo “stato estetico”: dotato di una eccezionale forza spirituale e di un eccezionale carisma, Stavrogin non sa incanalare questa energia in nessuna direzione, perché incapace di scegliere: il bene e il male in lui producono lo stesso effetto, tanto da far dire a uno dei personaggi del romanzo, Sciatov, che in lui “l’ideale della madonna e quello di sodomia dispiegano la stesso fascino, tanto che il marchese De Sade avrebbe potuto prendere esempio da lui”. L’unica cosa che lo stimola è la sua abnorme avidità di sensazioni, che lo porta a provare qualsiasi esperienza, con sadico sarcasmo, senza che egli riesca a decidere fra il bene e il male. Ma proprio questa sua irresolutezza lo condurrà allo sdoppiamento della personalità e all’incapacità d’amare, fino al suicidio finale. Kirillov porta invece agli estremi l’idea del suicidio logico formulata da Dostoevskij nel Diario di uno scrittore; la sua idea è quella di uccidersi per poter diventare egli stesso un Dio, liberare l’uomo dalla paura della morte e donargli la libertà. Come ha efficacemente scritto Pareyson, nella prospettiva fatta valere da Dostoevskij “l’uomo non può riconoscere Dio senza volerlo essere”, con tutti gli effetti catastrofici che ne scauriscono. Negare Dio vuol dire divinizzare l’uomo: ma ciò porta a effetti disastrosi, alla luce del fatto che “se Dio non esiste, tutto è permesso” (I fratelli Karamazov), crolla ogni limite e l’uomo può commettere ogni sorta di nefandezza.
La sostituzione dell’uomo a Dio è così tratteggiata da Dostoevskij ne I fratelli Karamazov:
“Secondo me, non c’è nulla da distruggere, fuorché l’idea di Dio nell’umanità; ecco di dove occorre cominciare! È di qui, di qui che si deve partire, o ciechi, che non capite nulla! Una volta che l’umanità intera abbia rinnegato Dio (e io credo che tale epoca, a somiglianza delle epoche geologiche, verrà un giorno), tutta la vecchia concezione cadrà da sé, senza bisogno di antropofagia, e soprattutto cadrà la vecchia morale, e tutto si rinnoverà. Gli uomini si uniranno per prendere alla vita tutto ciò che essa può dare, ma unicamente per la gioia e la felicità di questo mondo. L’uomo si esalterà in un orgoglio divino, titanico, e apparirà l’uomo-dio. Trionfando senza posa e senza limiti della natura, mercé la sua volontà e la sua scienza, l’uomo per ciò solo proverà ad ogni istante un godimento cosí alto da tenere per lui il posto di tutte le vecchie speranze di gioie celesti. Ognuno saprà di essere per intero mortale, senza resurrezione possibile, e accoglierà la morte con tranquilla fierezza, come un dio. Per fierezza comprenderà di non dover mormorare perché la vita è solo un attimo, e amerà il fratello suo senza ricompensa. L’amore non riempirà che un attimo di vita, ma la stessa consapevolezza di questa sua fugacità ne rinforzerà altrettanto l’ardore quanto prima esso si disperdeva nelle speranze di un amore d’oltre tomba e infinito…”, e via di questo passo. Delizioso!”
In Kirillov c’è ancora quell’amore per gli uomini che in Stavrogin è spento, ma la radicalità della sua idea lo ha inghiottito e portato all’indifferenza verso ogni cosa, persuaso dall’ateismo che la vita non abbia nessun senso. Il suo suicidio deve allora essere un gesto di redenzione, come quello di Cristo, che però fallisce perché sono le sue stesse premesse ad essere assurde e quindi, di conseguenza, a rendere assurdo e irrealizzabile il fine. Kirillov accetta emblematicamente di firmare, prima di morire, una dichiarazione nella quale si assume per intero le responsabilità dei crimini commessi da Verchovenskij e dai suoi seguaci. Se Miskyn viene condotto alla pazzia dalla sua incapacità di fronteggiare la realtà, la quotidiane bassezze della lotta alla sopravvivenza, Kirillov tenta un sacrificio che non redime nessuno perché rappresenta una rivolta contro la natura umana, non la sua realizzazione. I demoni non è, come è stato detto, un romanzo politico, ma un romanzo profetico il cui contenuto è prima di tutto metafisico, in quanto Dostoevskij aveva già capito come quello del socialismo fosse, prima che un problema politico, un problema religioso; solo rinnegando la natura divina dell’uomo e quindi la figura di Cristo come fondamento della convivenza sociale era possibile pensare di costruire una società utopica in cui l’uomo avrebbe potuto realizzare da sé la perfezione facendo a meno di Dio, ma questo doveva necessariamente portare, secondo lo scrittore, a quelle tragedie che sempre si determinano quando viene meno la sacralità della vita umana e questa può essere di conseguenza concepita anche come fine per raggiungere propri scopi, come ben illustra la figura di Verchovenskij.
L’opera di Dostoevskij si conclude con I fratelli Karamazov, nel quale svetta l’episodio del grande inquisitore. Dostoevskij immagina lo svolgimento di un processo nei confronti di Gesù, responsabile secondo il grande inquisitore, ateo ma capace di un grande amore per gli uomini. Quest’ultimo accusa Gesù di aver fatto un torto donando all’uomo la libertà, della quale egli non sa che farsene, al posto della felicità: se infatti l’esistenza umana fosse ritmata dalla necessità, la felicità sarebbe stata facilmente accessibile, ma l’uomo avrebbe dovuto rinunziare alla libertà, alla dignità, alla ricerca di senso nel corso del proprio cammino. Anche negli abissi dell’oscurità del male, l’uomo deve sempre lasciarsi guidare dalla luce di Cristo, che è verità sulla libertà, perché la prospettiva della vita eterna le conferisce un senso, e libertà nella verità perché Dio lascia l’uomo libero di credere, libero di scoprire con le proprie azioni la distinzioni di bene e male. Per questo Cristo non è sceso dalla croce, perché è la fede che deve produrre il miracolo e non viceversa.
Il messaggio di Dostoevskij, come quello dei grandi filosofi e dei grandi tragici, acquisisce valore nel tempo, anziché perdere importanza, perché la sua sensibilità indaga gli eterni problemi dell’uomo. La sua straordinaria attenzione per la vita sociale e politica della sua epoca non rende certo anacronistico il suo messaggio, anzi lo rende vivo perché mostra gli effetti che grandi idee producono nella vita di persone comuni nella vita di tutti i giorni. La sua attualità è del resto evidente oggi: basta pensare al difficile tentativo di conciliare fede e scienza, al dibattito sulla laicità dello stato che oggi trovano ampio risalto nei nostri media. Su questi temi, lo sguardo di Dostoevskij può essere ancora illuminante e scuotere ancora le coscienze.
LA LIBERTÀ SECONDO DOSTOEVSKIJ
di Maria Russo
1. Introduzione: sul concetto di libertà e di libero arbitrio
2. Quali possibilità per la libertà? Dialogo tra Nietzsche e Dostoevskij dal sottosuolo
3. Cosa non è libertà? Incontri con anime belle e demoni
4. Oltre il libero arbitrio, la libertà
5. La libertà implica la tragedia dell’esistenza?
6. Conclusioni: felicità o libertà oppure felicità della libertà?
Introduzione: sul concetto di libertà e di libero arbitrio
Dostoevskij non è un filosofo. Eppure, presenta un carnevale di filosofie ognuna incarnata in un personaggio, che non solo espone ma anche vive: smaschera e/o mostra anche la coerenza con il discorso.
I personaggi in Dostoevskij sono indagati sempre “al limite”: niente può essere tiepido, si cerca appositamente il termine ultimo delle dinamiche di azione e reazione per esplorare ed indagare (e Pareyson arriva a definire questa ricerca “pneumatologica” anziché psicologica). Gli spesso improbabili esperimenti mentali della filosofia analitica sono insipidi e inefficaci a confronto di questi personaggi, reali estensioni della gamma delle emozioni umane. Ogni idea acquista così uno spessore organico, fino appunto a “pulsare”. L’idea è una sorta di ossessione, talmente ingombrante da assorbire interamente il personaggio. In Dostoevskij l’idea non è una dimensione dell’uomo; è l’uomo ad essere carne di tale idea. I personaggi che invece non si esauriscono in questa sintesi eccedono il carnevale di maschere e riescono ad emergere come persone.
Questione fondante, tarlo e dei suoi personaggi e dell’autore stesso, è l’individuazione dei confini e delle possibilità della libertà.
Essa per Dostoevskij non è il superamento di ogni limite orizzontale, uno sbarazzarsi di ogni vincolo (che bisogna ben distinguerla dal libero arbitrio), ma lo sprofondarsi in un abisso di verticalità: una vertigine, che rende difficile l’affacciarsi sull’abbandono della razionalità.
Quali possibilità per la libertà? Nietzsche e Dostoevskij dal sottosuolo
Le argomentazioni filosofiche che Dostoevskij propone rientrano nella logica narrativa del monologo e del dialogo, ma non si potrebbe esaurire all’interno di una trattazione saggistica. Eppure, egli non si è limitato a dare voce al pensiero contemporaneo o alla propria biblioteca di sapere: ci sono forme e contenuti originali, nuovi in virtù anche della loro visione “profetica” e lungimirante. Non sarà allora certo anacronistico o indebito acconsentire ad un dialogo tra lo scrittore russo e il più giovane F. Nietzsche, che si è definito suo “fratello di sangue”. In entrambi, vi è una moltiplicazione di giochi di maschere che lasciano spesso dubitare la critica quale sia il volto più rispondente al pensiero dell’autore. Ma le analogie non terminano qui: sia Nietzsche sia Dostoevskij hanno vagliato l’autenticità del valore della libertà, interrogando in modo lucido e spietato la tradizione, senza alcun pudore reverenziale nei confronti di un auctoritas ormai metabolizzata. Nietzsche però si è arreso di fronte alla decostruzione del significato “genealogico” della libertà, mentre Dostoevskij ha tentato di varcare le porte della storicità del termine per indicarne una possibilità normativa. Nietzsche e Dostoevskij sono campioni contro l’ingenuità; hanno alzato il velo di Maja e mostrato le ipocrisie e le illusioni dell’orizzonte comune della morale. La libertà, per essere scelta, ha bisogno di un soggetto forte che la affermi e la voglia. Nietzsche lascia la libertà impotente sostenendo l’inconsistenza dell’Io. La vera differenza tra Nietzsche e Dostoevskij non è la preferenza rispettivamente per il dionisiaco e per la croce, ma per la concezione della volontà: per il primo è un’energia indipendente ed autosussistente mentre per il secondo si tratta sempre della “volontà di qualcuno”. Nietzsche relega il senso di responsabilità e di colpa a ciò che deve divenire al più presto possibile un passato di mistificazione; Dostoevskij ne riconosce i limiti, ma sa bene che sono ineliminabili per ciò che l’uomo è dal punto di vista costitutivo (e, presumibilmente, continuerà ad essere).
Se si estrapolano alcune frasi o interi brani da Memorie del sottosuolo non sarebbe certo difficile attribuirli alla penna graffiante e scorretta del maestro del sospetto che chiama per nome l’intera tradizione “nichilismo”. Quello che Nietzsche descrive corrisponde alla confessione di quest’uomo del risentimento, che deride e prova disgusto nei confronti del costume, della società e del prossimo –ma in realtà anche di se stesso, ancora imbrigliato nei sentimenti morali.
L’uomo del sottosuolo è l’uomo occidentale che si risveglia dalle “essenze profumate” del Romanticismo e che nega con la forza di chi non è da sempre stato all’opposizione ma si è sentito tradito da quei valori falsi ed ambigui. Le dinamiche di vanità, orgoglio, invidia, ossessione, sdoppiamento,… sono da entrambi indagate. Nietzsche con estrema lucidità investe di luce fredda i “meccanismi” dell’uomo e li svuota, Dostoevskij li fa corrodere dall’interno. Nietzsche è esplosivo, Dostoevskij è implosivo. L’uno grida, l’altro conduce il lettore a vedere.
A Dostoevskij non importa dire che e se gli uomini del sottosuolo siano inferiori o superiori –cosa che invece è priorità per Nietzsche. È più probabile che Dostoevskij li veda come uomini più comuni di quanto diano a vedere, consapevoli sì, ma ben lontani dalle altezze vertiginose dei “peccatori santi”. L’uomo del sottosuolo è lucidamente aspro, si tormenta perché il suo unico interesse è essere spiacevolmente sincero, beffeggiandosi del benessere e della convenienza sociale e psicologica. Ma dalla propria consapevolezza non sa che ricavare altro che cinismo e osservazione voyeuristica della vita degli altri, fino ad arrivare ad essere spettatore della propria. Procedendo in questa direzione, si arriva a perdere il senso dell’agire e del riconoscimento della propria identità in ciò che si fa, si dice, si vive.
Per Nietzsche la libertà si identifica quasi totalmente nel libero arbitrio, che viene considerato come una sorta di trucco cattolico, tirato fuori dal cappello da prestigio di una morale nichilistica che si è assunta il ruolo di guida dell’Occidente per attuare la sua volontà di potenza e di vendetta. La libertà non è neppure attribuita all’Ubermensch, come a dire: che se ne fa della libertà l’Oltreuomo? Vecchia parola, gravida di fraintendimenti storici. La volontà di potenza è oggettiva; lasciarla fluire non è la scelta di un soggetto che si stempera sempre di più come puro fascio conduttore di un’energia che non può essere “mia” o “tua” scelta.
Dostoevskij invece crede concretamente e profondamente nel soggetto, e anche nella possibilità di una significazione nuova di libertà, dopo aver cancellato tutti gli equivoci superficiali legati a questa parola.
Cosa non è libertà? Incontri con anime belle e demoni
E d’altro canto Dostoevskij non propone affatto una proclamazione dei valori ingenua; l’anima bella schilleriana viene compatita, e presentata come figura tragicomica che si affaccia fallimentare nel mondo.
Basti pensare al principe Myskin de L’idiota, che come l’albatros di Baudelaire non è adeguato alla terra e non è portato alla vita; infatti, non riuscirà nemmeno ad esplicare la sua funzione salvifica, che sarebbe prerogativa essenziale per riconoscere la figura cristologica (si mantiene l’onniscienza, ma non certo l’onnipotenza: è un Cristo fine spettatore del mondo ma impotente –dopo il servo, ora l’idiota). Myskin è un uomo distaccato dalla vita tanto quanto la sua nemesi (che potrebbe essere lo Stavrogin dei Demoni): è un Cristo a cui mancano la volontà e l’incarnazione. Cristo ha una portata rivoluzionaria che non ha niente a che fare con la mitezza di Myskin: non vi è un corrispettivo dell’episodio del tempio. Nessuna spada promessa, e nessun tipo di manichea distinzione tra bene e male. Myskin nei suoi momenti “magici” intuisce che in fondo tutto può essere il contrario di tutto. La sua estrema tolleranza deriva anche dal fatto che sa bene quale sia il potere dell’ideologia e che ogni possibile alternativa non potrà che configurarsi come un’ulteriore dottrina dogmatica. Egli risulta inadeguato rispetto al “medio” (tanto è che solo i personaggi più estremi, Rogozin e Nastas’ja, possono instaurare con lui una sorta di empatia che portano, paradossalmente, il primo ad esserne profondamente geloso e la seconda ad innamorarsi); non è in cerca di proseliti, accenna all’azione, ma viene solo confermata la sua impossibilità di poter incarnare l’ideale di bene che pur intendeva. Alla fine dilegua, come il Cristo della Leggenda, e non si sa cosa sia venuto a fare e perché.
L’altra faccia della medaglia, in parte nemesi e in parte complemento del Myskin che sente sciogliere i propri limiti umani durante l’epilessia, è Stavrogin. I Demoni è il romanzo che si costruisce come vera Apocalisse risultato dell’esasperazione dell’affermazione dell’oltreuomo. Il “tutto è permesso” è qui indagato concretamente nei suoi esiti più catastrofici. Non è possibile costruire un edificio etico con ideali estremi astrattamente applicati nella realtà pratica; da qui, la confutazione del socialismo, dell’ateismo e del nichilismo.
I demoni vogliono liberarsi dal pensiero religioso, ma con un inno a un nuovo Dio, tutto fatto di negazione e decostruzione. Ma cosa è che davvero conta, la possibilità teor(et)ica di quel Dio –il cui carattere eccezionale già è affermato dall’autentico cavaliere della fede- o ciò che viene compiuto nel suo nome? Il Grande Inquisitore dei Fratelli Karamazov, ad esempio, usa Dio e Cristo come stendardo che faccia ombra al suo potere manipolatorio.
Stavrogin, il burattinaio diabolico che è sempre presente anche quando non è in scena come centro motore di tutti gli altri personaggi, non è altro che un “sepolcro imbiancato”, indifferente, privo di personalità e di umanità, mera energia che si manifesta. Infatti, lungi dall’essere un punto di orientamento è centro di attrazione magnetica che però conduce in un vortice caotico e privo di senso. Egli affida a tutti i suoi “adepti” una maschera, un’idea da portare, convince ad ideali che per lui sono solo possibilità che mai sceglie; e lui stesso sarà ben presto vittima di questa spirale di sperimentazione non finalizzata ad una posizione. Nessuna redenzione, nessun dispiacere morale: perfino il vescovo Tichon è costretto a riconoscere che neppure il suicidio e la confessione sono sintomo di salvezza nel suo caso. La perdizione di Stavrogin deriva dal suo freddo distacco dalla vita e dalla sua distanza rispetto agli altri: egli non guarda il suo prossimo, è incapace di vederlo come “persona”, e quindi non può riconoscersi e portare verso se stesso il rispetto di cui gode la “persona”. Si potrebbe forse definire Stavrogin come il demone di Kant, colui che nega nel modo più grave e convinto il regno dei fini in sé della Critica della Ragion Pratica. Una volontà che vuole senza contenuto sembra necessariamente andare a configurarsi come un capriccio. Stavrogin è l’emblema dell’indifferenza: è immorale, tutto vuole che sia suo campo d’azione ma in realtà è una figura aleatoria che non si può soffermare su niente.
Personaggi come Stavrogin o Raskol’nikov arrivano a preoccuparsi solo di categorie estetiche –laddove l’unico timore che può fungere da freno è l’ossessione di cadere nel ridicolo. Tanto è che si smaschera il vero volto del libero arbitrio, ossia un’autocelebrazione piuttosto narcisistica che ben poco si preoccupa seriamente dell’azione. Stavrogin si permette di non soffrire né amare proprio perché è spettatore disinteressato della propria vita e regista sperimentatore di quelle altrui (conservando però sempre il medesimo distacco scientifico). Tutti gli ideali che vengono qui messi in gioco da questa elite demoniaca della società pietroburghese sono ulteriori esemplificazioni del fraintendimento della libertà. L’idea è un Dio disumano, l’antitesi della libertà: si arriva a colpevolizzare il soggetto perché non è stato in grado di adeguarsi all’idea.
Non è un conservatore Dostoevskij: l’unione del potere temporale e spirituale, così come l’universalismo umanitaristico sono proposte di cui percepisce il fallimento e l’inumanità.
Ma di cosa è fatto l’uomo? E senza aspettare Freud, è il sogno a suggerire a Raskol’nikov (attraverso la metafora della cavallina, prefigurazione del delitto dell’usuraia e di Lizaveta) e a Stavrogin (attraverso il ricordo della bambina stuprata, riproposizione del suo misfatto) che la contraddizione non sussiste tra “uomo mediocre” e “idea nobile”, bensì tra “idea idolo” e “vita vera”.
Paradigmatica è la figura di Kirillov, che per affermare la massima libertà propone il suicidio scelto senza motivo e senza orrore (una sorta di “resurrezione in parodia” del Cristo). Nella teoria, Kirillov afferma un paradiso concreto, dove la morte viene sconfitta in quanto non più vissuta come un traguardo obbligatorio (in fondo la vera costrizione della natura umana, che si nasconde dietro a tutte le sue declinazioni quotidiane, negli impedimenti e negli ostacoli della sofferenza); tuttavia, al momento di compiere questo rito così programmato e giustificato razionalmente, in Kirillov si scatena l’atavica paura. Non si può essere Napoleone, oltreuomini, Dei incarnati, neppure Demoni. L’uomo “nuovo, felice e superbo” dovrebbe superare il dolore e la paura; ma questi sono sentimenti che appartengono costitutivamente all’uomo. Liberarsi dal tempo e dallo spazio interiore legato alla sofferenza significa snaturare l’uomo (e non nobilitarlo) cadendo in una contraddizione infinita: chi propone questo non è affatto indifferente alle conseguenze del tempo, agisce per paura della paura e per dolore del dolore.
Può essere questa la libertà? Essa è tragica solo nei suoi fraintendimenti. Kirillov voleva “suicidare” in sé l’uomo, e ci riesce, ma a parte la “prepotenza” del nulla, non vi è altro oltre-l’-uomo. Raskol’nikov e Kirillov compiono entrambi un atto terribile; essi sono convinti di non avvertirne il sapore del senso sostenendo la sua gratuità. Non si rendono conto, però, che la mancanza di ogni pretesto non può che far precipitare nell’orrore e nella follia. La storia di ognuno di questi personaggi, macchiette, marionette e manipolatori, non è altro che una tragedia annunciata.
Questo perché non esiste una libertà al di là del bene e del male; sembrerebbe davvero che “tertium non datur”: è una scelta binaria ineludibile, che però si può articolare su più livelli.
E l’ostinazione a non essere ciò che si è, ma il rifiuto della propria sagoma non conduce certo ad un’estensione di sé fino a ricoprire un’ulteriorità da sempre ambita: come una macchia, si dilata, si disperde, infine si asciuga.
Oltre il libero arbitrio, la libertà
In Delitto e castigo viene mostrato come la libertà non possa trovare la propria assoluta realizzazione nel rendersi dimentichi di tutti i valori della tradizione e perfino della propria etica interiore. Raskol’nikov uccide per essere un Napoleone, uccide per la sua personale idea, per la sua specifica volontà di potenza. E a partire da questo gesto, che sarebbe dovuto essere compiuto nella più totale indifferenza, il protagonista viene invece inghiottito in un tunnel senza luce di sensi di colpa, miseria ancora più nera e bassezza morale.
Raskol’nikov arriva addirittura ad invocare (senza crederci e senza esserne pienamente consapevole) una punizione oggettiva, un verdetto proprio da quella società da cui si era alienato in “quella stanzetta” che rappresenta esattamente l’ambiente interiore dello studente, con tutta la sua atmosfera di soffocamento e di involuzione del pensiero in un caos buio. Si pensi alla figura del giudice, solo un giocattolo nelle mani delle dinamiche più o meno inconsce della coscienza di Raskol’nikov (come se si invertisse il gioco di “guardie e ladri”). Con la punizione oggettiva non giunge anche il pentimento e quindi l’espiazione, poiché essa si può configurare solo come percorso assolutamente interiore. Il giudice è una figura impersonale, che non identifica l’altro (o meglio, lo spersonalizza nel suo atto) e che quindi non può neppure identificare se stesso con una ricchezza che vada oltre alla mera sintesi del suo ruolo.
Raskol’nikov è deluso da se stesso, e crede di essere stato lui, proprio lui, non in grado di negare il limite, che in fondo sarebbe bastato ancora poco, solo un altro passo, per non rimpiangere più, per non avvertire la colpa e la meschinità del suo gesto. In realtà, non è un fallimento di Raskol’nikov, non è mancanza di talento o qualità, ma è un volto ineliminabile dell’uomo; da questa impossibilità di oltrepassare ogni vincolo non si esce però attraverso la morale comune –che Dostoevskij non è certo un paternalista che punta il dito contro i tentativi di sfondare la gabbia di valori eteroimposti e non elaborati interiormente- ma mediante l’eccedenza positiva e “miracolosa” della stessa morale.
Tale eccedenza in Delitto e castigo è personificata da Sonja, che con tutta la sua umiltà e la sua vergogna è figura quasi impossibile: una prostituta che è emblema di pudore (nel senso greco del termine, αιδός, reverenza sacra), che vive nel degrado della metropoli noir di San Pietroburgo ma che tremante recita i brani di redenzione della Bibbia. La contraddittorietà è miracolosamente presente in Sonja: una Madonna apparentemente assorbita “dall’ideale di Sodoma” (questa duplicità nella figura femminile sarà più volte ripresa in modo analogo). Ed è proprio Sonja a prendere per mano Raskol’nikov, a mostrare l’inutilità del percorso punitivo della tradizione e dell’iter giuridico e sociale; la sua prima domanda, nel momento in cui viene resa partecipe del delitto di Raskol’nikov attraverso la sua confessione, non è “cosa hai fatto?” bensì “cosa ti sei fatto?”. Sonja mostra come la presunta negazione dell’orizzonte comune della morale apparentemente voluta e scelta da Raskol’nikov non sia altro che un dipendere da esso e non un suo superamento. Anche Sonja è un’emarginata, anche lei è schiava nel corpo della società; ma nonostante questo essere, a suo modo, un outsider, è invulnerabile nella sua fede e nel suo potere più profondo e autenticamente cristiano: il perdono.
Nietzsche aveva reso il cristianesimo sinonimo di inganno e contraffazione; eppure, nell’Anticristo, anch’egli aveva dovuto ammettere il suo fascino per la figura del Cristo, che pure nella sua crocifissione non adotta alcuna modalità di risentimento ed è sordo alle tentazioni di rivalsa e di instaurazione del potere. Cristo tace, assume su di sé il suo destino, lo afferma fino alla fine, avvertendo la solitudine tanto nei confronti del proprio padre divino tanto rispetto ai propri discepoli davvero umani troppo umani; è Paolo ad avere instaurato le dinamiche del reissentiment.
Il perdono non è un ulteriore ricatto che attende una risposta di gratitudine; è gratuità pura, redenzione libera da ogni reazione e ricompensa. In questo, Dostoevskij sembra non discostarsi molto da Kierkegaard e dai suoi tre “livelli”: l’uomo che si pone astrattamente fuori dalla morale, l’uomo etico che ingenuamente segue pedissequamente i dettami della Legge positiva e l’Abramo di Timore e tremore, che sa porsi davanti allo sguardo dell’intera comunità con quell’eccedenza che sola e terribile dice la vera fede.
Raskol’nikov parte da una logica ferrea, e le sue premesse razionalmente inconfutabili arrivano ad esaurirsi e a consumarsi attraverso la loro incarnazione. Affacciarsi sulle colonne d’Ercole del libero arbitrio diventa un’esplorazione superflua, pericolosa, ma, soprattutto senza meta e tesoro.
La libertà implica la tragedia dell’esistenza?
L’abisso inaccettabile della libertà è infine indagato nei Fratelli Karamazov dove ogni personaggio rappresenta un’esplorazione della libertà, e di quella più primaria e fondante tutte le altre: quella del rapporto che sussiste tra l’uomo e Dio. Questa compresenza è ancora più evidente in quanto nel palcoscenico della stessa famiglia, dello stesso sangue.
Si potrebbe raffigurare il sistema dei personaggi in relazione alla libertà in questo modo:
|
|
Affermazione teorica |
Affermazione concreta |
Libero arbitrio |
Ivan |
Smerdjakov |
Libertà |
Alesa |
Dmitrij |
Nella configurazione dei rapporti intercorrenti tra i quattro fratelli viene proprio posta in evidenza la differenza tra libero arbitrio e libertà, che per Dostoevskij è davvero essenziale. Ivan e Alesa si confrontano all’interno di una sfida tutta razionale e verbale, tesa a rispondere alla domanda cardine di ogni teodicea: perché c’è la sofferenza? I rispettivi campioni sono lo Starec Zosima che si inchina di fronte al peccatore pellegrino sulla Terra e il Grande Inquisitore che cinicamente sancisce come incompatibili la felicità e la libertà (senza considerare che vi è la possibilità, tutta realizzabile, della felicità della libertà).
Il perdono che Sonja sa offrire a Raskol’nikov, Alesa lo professa necessario per tutti. La “logica euclidea” di Ivan è limitata (a dimostrazione: la possibilità di poter dire qualcosa oltre il quinto postulato); la fede può essere intravista da questa ratio, ma si colloca ben al di fuori. La morte di Dio è funzionale alla liceità infinita e senza controllo di azione e distruzione; ed è proprio lo scandalo del dolore a dire potentemente il nome di Dio. Infatti, si domanda Dostoevskij: senza Dio, quale scandalo? Le sofferenze permangono, ma non possono più essere redente e compiante.
Smerdjakov e Dmitrij si confrontano invece nella reazione concreta alla sofferenza, nel campo della colpevolezza effettiva, delle mani sporche di sangue. Dmitrij è peccatore, ha voluto scendere nella dimensione del possesso materialista del padre (denaro e passione per la donna del vecchio Karamazov, Grusenka). Eppure egli è “anima larga”: tocca il fondo della bassezza ma lo usa come spinta propulsiva per ascendere alla nobiltà. Alesa è il Cristo prima delle tentazioni, mentre Dmitrij rappresenta il dubbio del Getsemani. E d’altronde per Dostoevskij il vero miracolo, la vera affermazione paradigmatica della libertà, è decisa nello scenario del deserto durante le tre tentazioni poste dal diavolo a Cristo. Il deserto simbolicamente rappresenta la solitudine nella quale ogni singolo nella sua irriducibile personalità deve decidere il proprio destino, la propria scelta e posizione (tanto è vero che Ivan si rende perfettamente conto del fatto che il diavolo è una propria oggettivazione, e in fondo non può dirgli nulla di nuovo, perché è l’uomo stesso). Seguire le tre tentazioni equivarrebbe ad esercitare il proprio libero arbitrio, al tentativo di sciogliersi da qualsiasi vincolo, infrangendo le leggi del fenomeno e della necessità attraverso l’irruzione del miracoloso. Ma sono solo effetti speciali che di certo non riempiono di contenuto l’eccezionalità della libertà e di Cristo.
La libertà è anche rinuncia e proposizione di un modus vivendi che forse è inconcepibile per i più ma è la vera santità concretamente realizzata sulla Terra. È come se Dostoevskij (come anche intuisce Pareyson) confutasse la possibilità di un uomo-Dio (soluzione androteistica), ma affermasse potentemente l’esempio del Dio-uomo (soluzione teandrica). Un esempio che non si risolve nella ripetizione meccanica di parole e gestualità; il Cristo della Spagna dell’Inquisizione nulla dice e nulla fa, ma da tutti è riconosciuto; si permette solo di sconvolgere ancora una volta le dinamiche del potere che nessun Diluvio universale è riuscito a cancellare. Dio ha una più alta considerazione dell’uomo in quanto pronto a scommettere il tesoro terribile della libertà; è l’uomo che si rende misero nel volersi sbarazzare a tutti i costi di questo onere/onore, scambiandolo per vaso di Pandora.
Resta da chiedersi se la libertà in Dostoevskij venga davvero percepita come tragedia. Per Lukacs Dostoevskij supera il romanzo proprio richiamando l’atmosfera dell’epos arcaico. Ma il dramma qui non è nell’abbattersi di situazioni esterne, dove il personaggio è impotente spettatore che può solo accettare a testa alta, bensì nel loro riflesso nell’animo del personaggio, dove si gioca eternamente la sfida.
Ma è davvero tragico l’uomo che sceglie di essere libero? Si immerge nel conflitto oppure lo supera mediante una conciliazione che ha il punto di partenza nel dolore e nell’amarezza e quello di arrivo, la meta finale, nella vera pace? Forse la libertà può essere intesa come tragedia solo prima di sceglierla: Ivan la demonizza come un potere troppo ingombrante, ma lo è per chi non è in grado di farne propria bandiera. La libertà libera dalla pesantezza, non è essa stessa un macigno: permette uno sguardo tutto nuovo, che non subisce ma che vive.
Dmitrij (che più di ogni altro personaggio si avvicina alla figura del peccatore santo) non parte per la Siberia in un clima interiore di rassegnazione, ma di serena accettazione. Egli ha riconosciuto mediante la libertà la propria profondità umana, la stessa per cui Dio ha voluto una propria incarnazione. Anzi, rovesciando: è il rifiuto della libertà e la sterile imposizione del libero arbitrio a condurre alle contraddizioni più gravi, fino a portare alla follia (si pensi al ruolo della febbre cerebrale in Raskol’nikov e in Ivan, e all’atmosfera di monologo esasperato e di delirio in cui vengono condotti).
Il vero parricidio, il più terribile, è quello dell’uomo nei confronti di Dio. Fondamentale per riflettere intorno alla concezione di libertà in Dostoevskij è proprio l’episodio del Grande Inquisitore (“risolvere il problema dell’uomo significa risolvere il problema di Dio” secondo Berdjaev). “Voi potete fare il bene e il male, ma il bene e il male che io vi dirò”; apparentemente l’Inquisitore ha spezzato ogni vincolo a favore dell’umanità intera, che ora è libera dalla libertà, dal suo abisso, dal suo carattere terribile e insostenibile. L’Inquisitore ha risposto affermativamente allo spirito negatore del deserto, concretizzandolo sotto le spoglie della Chiesa. Ma l’amore e la cura per il prossimo non devono diluirsi in un umanitarismo idealista e formale, devono realmente rivolgersi alla concretezza dell’individualità. La Spagna del Seicento sembra richiamare, con tratti trasfigurati, quella visione socialista dove le persone vengono raggruppate come un unico organismo complessivo a scapito delle singole personalità. È questa la scelta del Grande Inquisitore, la risposta alla tentazione di compiere un percorso più facile.
Dostoevskij rivendica la spiritualità, contrapponendola a quel materialismo che è tanto proprio del socialismo quanto dell’eudemonismo più in generale. È per questo che vale la pena accettare anche la sofferenza dei bambini: mentre Ivan vorrebbe restituire il biglietto allo spettacolo divino, Alesa comprende che non è attraverso il rifiuto di questo mondo che si può ricomporre la ferita infertagli.
Il male ed il dolore, addirittura, rovesciando, diventano in effetti la testimonianza ardente del Cristo. È proprio perché esiste la sofferenza inutile che Dio esiste, poiché a scandalo si risponde a scandalo (ed il primo non è confutazione, bensì dimostrazione del secondo). È solo il pensiero euclideo di Ivan che crede di aver trovato l’indiscutibile falla nell’architettura perfetta di Dio, senza aver capito invece che le effettive dinamiche dell’armonia sono ben altre. E pur non avendo mai parlato il Cristo della Leggenda, è in quel bacio che ha la prima e l’ultima parola; a questo, l’Inquisitore è incapace di trovare alcun tipo di risposta.
Dio e Satana non sono posti come cause fenomeniche, per cui in realtà non si genera un conflitto tra spazio umano e divino/diabolico. Come ben sottolinea Girard, sono l’emblema del modo in cui rivolgersi verso l’Altro (e, aggiungerei, del rivolgersi autenticamente verso se stessi).
Conclusioni: felicità o libertà oppure felicità della libertà?
“Solo la bellezza può salvare il mondo” lungi dall’essere un heideggeriano appello metafisico o un ritorno ad una prospettiva estetizzante, risulta essere un’invocazione fatta da Dio nei confronti dell’uomo, che può scegliere di creare il Bello.
Dostoevskij sottolinea come l’uomo debba essere artefice di se stesso: non si può limitare alla mera imitazione di modelli archetipi, o a una dialettica necessaria (l’espressione si trova sempre in Pareyson) per cui dalla ribellione si passa ineluttabilmente alla matura celebrazione di Dio.
Di fronte alla sofferenza, non è scontato l’adagio eschileo del “παθει μαθος”: l’uomo può scegliere, di fronte all’ostacolo, se aggirarlo, abbassarsi o saltarlo innalzandosi oltre ad esso. Il tragico non è una dimensione obbligatoria: l’uomo può attivamente reagire di fronte ad una realtà che pure si presenta come irriducibilmente contraddittoria. Ma nonostante questo, Pareyson forse inquadra ancora una volta la libertà in una sintesi, la intrappola in una definizione: essa non può essere associata alla tragedia, perché è ciò che permette di uscire dalle categorie del teatro.
Dostoevskij sa bene che non si può banalmente associare il male al libero arbitrio ed il bene alla libertà; il bene per essere davvero libero deve essere scelto, accolto fino in fondo e nel profondo delle sue conseguenze. Il dolore è davvero un “punto di svolta” (ancora Pareyson), ma non scontato: è una possibilità “tutta da giocare”. Nei confronti del dolore si può passivamente imbruttirsi e rintanarsi nel sottosuolo, oppure agire attivamente e non aspettare ma conferire senso alla propria esperienza ed esistenza.
La libertà non è indagata solo dal punto di vista metafisico, ma anche e soprattutto da quello ontologico: è la libertà quella caratteristica costitutiva dell’essere umano (ma non nel senso di funzione: essa è connessa inestricabilmente alla sostanza).
Dostoevskij non ha visto Auschwitz. Eppure il silenzio e il “piccolo testamento” sacro che propone non come soluzione ma come espiazione di fronte alla sofferenza dei bambini sono gli stessi che avrebbero permesso di non far precipitare Auschwitz nell’oblio, ma di inciderlo nella memoria (anche se “quel che resta del fuoco” è la cenere). Che sia questa la vera libertà, l’autentica cura alla ferita che pure non si cancella? Una fiamma che non si spegne, neppure nel gelo della Siberia. Ed è proprio grazie al contrasto con un crudo e spietato manto di niente che quella luce ha ancora più valore e grandezza.
EMILE LITTRÉ

Emile Littré (1801-1881) può essere considerato come uno dei discepoli più importanti di Auguste Comte, se non il più rappresentativo. Membro attivo della “Società Positivista”, fondata nel 1848, Littré entra in conflitto con Comte per motivi politici. Infatti, dopo il colpo di Stato di Luigi Napoleone, Comte appare immediatamente pronto a sacrificare le libertà politiche; Littré, invece, convinto repubblicano, non accetta i compromessi del maestro, e abbandona la Società con un gruppo di amici. Lo scopo fondamentale di Littré e dei suoi compagni “scissionisti” consiste nella volontà di purificare la dottrina positivista dalle “aberrazioni” introdottevi da Comte, aberrazioni che appartengono soprattutto al secondo periodo della sua speculazione; in particolar modo, Littré rifiuta l’elaborazione della “Religione dell’Umanità”.
Nonostante la rottura con Comte, Littré resta il maggiore divulgatore del Positivismo: in tal senso, nel 1867, egli fonda la Rivista di filosofia positiva, la cui pubblicazione cesserà sedici anni più tardi. All’inizio, per mostrare una certa imparzialità, la rivista ospita anche articoli di carattere non positivista; tuttavia, nell’arco di tre anni, il giornale si riduce a puro strumento di propaganda acritica della dottrina comtiana. Fra le opere di Littré, occorre ancora ricordare: Conservazione, rivoluzione, positivismo (1852); Frammenti di filosofia positiva e di sociologia contemporanea (1876); La scienza dal punto di vista filosofico (1873); egli propone anche una serie di scritti esclusivamente destinati alla diffusione del pensiero comtiano, e cura l’edizione di un dizionario di medicina insieme a Charles Robin.
Nell’importante monografia Auguste Comte e la filosofia positiva (1863), Littré chiarisce la propria adesione al pensiero positivistico nelle coordinate fissate da Comte nel suo Corso di filosofia positiva.
Secondo Littré, l’aspetto più rilevante della dottrina positivista consiste nell’aver applicato alla filosofia lo stesso metodo seguito dalle scienze positive. Si tratta di una scoperta capitale, che esclude dal discorso filosofico qualsiasi riferimento alla metafisica e alla trascendenza: la filosofia deve trovare nella natura e nella storia soltanto leggi empiriche ed immanenti. Pertanto, Littrè elimina dal campo filosofico tutte le ipotesi inverificabili, sia spiritualiste sia materialiste.
Pur manifestando un atteggiamento di incertezza a proposito del rapporto che dovrebbe intercorrere tra la filosofia e le singole scienze, egli ha idee molto chiare nei confronti della dottrina darwiniana: di questa non condivide la teoria della “selezione naturale”, perché la considera una semplice ipotesi; per quanto riguarda il problema dell’origine delle specie, egli preferisce l’istanza poligenetica, anche se in via provvisoria. In ogni caso, a suo parere la teoria darwiniana riguarda esclusivamente la biologia, e perciò non ha alcuna implicazione di carattere filosofico.
L’interesse di Littré si estende anche alla psicologia. Egli tende a ricondurre i fenomeni mentali a quelli fisiologici, essendo il sistema nervoso la sede di tali fenomeni; tuttavia, riconosce l’irriducibilità delle leggi del pensiero alla fisiologia. In sintesi, Littré considera la psicologia come la parte integrante di una teoria generale dell’essere umano, che giunge però soltanto al termine di tutte le scienze.
Nella riflessione di Littré trova ovviamente spazio anche la sociologia, che, a suo avviso, costituisce la parte culminante del Discorso di Comte; tuttavia, egli riconosce che si tratta di una disciplina troppo “giovane”, e così complessa da non poter essere trattata con leggerezza. A tale proposito, si può fare un esempio concreto: nell’elaborare predizioni socio-politiche, secondo Littré, bisogna accontentarsi di fare previsioni esclusivamente a breve termine.
Egli accetta poi un principio tipico del positivismo: il principio dello stretto legame esistente fra scienza e progresso sociale. In questa prospettiva, il positivismo diventa, ottimisticamente, la garanzia di ogni progresso futuro. Come afferma Littré,
“esso (il positivismo) ci dirige verso il lavoro, verso l’equità sociale, verso la pace internazionale, mediante l’industria, mediante il diffondersi della scienza e dei lumi, mediante la cultura delle arti belle, mediante il miglioramento graduale della morale”.
In generale, Littré e i suoi seguaci manifestano un particolare interesse anche per i temi politici. Ispirandosi a Comte, riprendono l’idea di un “potere spirituale”, ossia di un organismo volto a convincere la gente della giustezza del progresso scientifico, soprattutto della sociologia.
Oltre che filosofo, Littré fu un eminente filologo e linguista: frutto di questi suoi interessi sono le opere Storia della lingua francese (1862) e il fondamentale Dizionario della lingua francese (1863-1877), destinato a rimanere un imprescindibile punto di riferimento per la cultura francese. Con Littré, dunque, il positivismo di Comte trovava una sua specifica applicazione nell’ambito della linguistica.
Dopo la sospensione della pubblicazione della loro rivista, il gruppo dei littreisti si disperde, anche perché i suoi componenti non hanno mai costituito una vera “scuola”, e spesso si sono trovati in contrasto su questioni essenziali. Da questo momento, gli unici seguaci “ortodossi” di Comte restano coloro che si raccolgono attorno alla figura di Pierre Laffitte.
HIPPOLYTE TAINE

A cura di Gigliana Maestri
Nato a Vouziers nel 1828, Hippolyte Taine studia all’Ecole Normale. Dopo un periodo d’insegnamento trascorso in provincia, egli raggiunge la notorietà con una serie di saggi, grazie ai quali ottiene la cattedra di Estetica e di Storia dell’arte nella Scuola delle Belle Arti a Parigi, città dove muore nel 1893.
I saggi precedentemente citati sono: Saggio sulle favole di La Fontaine (1853), Saggio su Tito Livio (1856), Saggi di critica e storia (1856); a questi si deve aggiungere una Storia della letteratura inglese, del 1863. Si devono poi ricordare un libro sui Filosofi francesi del XIX secolo (1857) e il trattato Sull’intelligenza (1870); Le origini della Francia contemporanea (6 voll., 1875-93) e Il positivismo inglese. Studi su J. S. Mill (1864); Nuovi saggi di critica e di storia (1892) e Epistolario (1904-07, postumo). Le sue opere più originali riguardano però l’estetica: Filosofia dell’arte (1865), Viaggio ai Pirenei (1855), Viaggio in Italia (1866) e Note sull’Inghilterra (1872).
La riflessione filosofica di Taine, il quale contribuisce notevolmente alla diffusione del Positivismo in Francia, si configura come una critica molto circostanziata dello Spiritualismo: egli auspica, infatti, un ritorno della cultura francese alla tradizione illuministica, in modo particolare all’insegnamento di Voltaire e degli enciclopedisti, e ritiene che l’unico progresso possibile per la scienza consista nell’analisi dei fatti positivi, e nello spiegare un fatto con l’altro. Nel suo trattato Sull’intelligenza, Taine cerca di ridurre la vita spirituale a un meccanismo rigorosamente sorretto da leggi necessarie, simili a quelle naturali. In modo particolare, egli esamina e critica le dottrine psicologiche dei suoi tempi, entrando così nel vivo di un dibattito culturale di grande rilievo in questo periodo: il dibattito riguardante la fondazione della psicologia sperimentale, intesa come disciplina completamente autonoma. Taine sottolinea i denominatori comuni che indiscutibilmente legano filosofia, biologia e psicologia: l’idea del retroterra inconscio dei fenomeni coscienti ed il collegamento fra mondo mentale e mondo fisiologico, che s’identificano. Dopo queste premesse, egli si concentra a studiare i fatti psichici per tentare d’individuarne le leggi, evitando così le questioni, tipiche della psicologia tradizionale, a proposito della natura e della sostanza dell’anima.
Contro lo spiritualismo ordinario, egli rifiuta l’idea di una sostanza permanente nascosta, che sostenga le singole qualità e sopravviva agli avvenimenti passeggeri, e respinge il concetto di un’unità originaria dell’io in favore di uno studio analitico dei fenomeni di coscienza. A suo parere, l’osservazione psicologica scopre solo sensazioni e immagini di diverse specie, tanto che l’intera vita psichica si riduce allo scontro, al contrasto e all’equilibrio delle immagini derivate dalle sensazioni. In ultima analisi, coscienza e sensazione si configurano come movimento, essendo questo la minima oggettività comune che possiedono. Taine considera poi i concetti come “suoni significativi”, in origine prodotti dagli oggetti e in seguito usati indipendentemente da essi, in base a somiglianze ed analogie. Infine, ritiene che la cosiddetta “conoscenza razionale” sia costituita da giudizi generali, che possono essere considerati coppie di segni o suoni di questo genere.
Per quanto riguarda la riflessione estetica, che, come si è detto, costituisce la parte più originale e significativa della sua speculazione, Taine sostiene che un’opera d’arte non nasce mai a caso, ma, in quanto fatto storico, si configura come il risultato di una serie di circostanze fisico-ambientali ben determinate, quali il clima, le situazioni economico-geografiche e quelle socio-politiche. In altri termini, tutti gli individui, e quindi anche gli artisti, nel loro operare, sono necessariamente influenzati da un insieme di forze naturali e storiche cui non possono sottrarsi. Da queste imprescindibili “condizioni” derivano le leggi che spiegano, in ambito artistico, le variazioni stilistiche, le differenze esistenti fra le scuole nazionali, e persino i caratteri originali delle singole opere individuali.
Taine cerca di stabilire dei criteri che consentano di disporre le opere d’arte in una sorta di “scala di valore”: si tratta di criteri come la “generalità dell’idea”, il “valore morale”, la “pienezza dell’espressione”; inoltre, tenta di dividere le epoche della storia dell’arte in base alle categorie della dialettica hegeliana: tesi, antitesi e sintesi. Tali analisi costituiscono i limiti della sua riflessione, soprattutto perché lasciano irrisolto il problema schiettamente filosofico dell’essenza dell’opera d’arte; in ogni caso, lo stesso Taine non si sente di ridurre tale essenza ai soli elementi critico-genetici sui quali si è soffermato. Al di là di questo, il merito del filosofo consiste nell’aver cercato di conferire alla critica estetica un’autentica dignità scientifica. Nella prospettiva di Taine, l’opera d’arte è il risultato necessario delle sue condizioni esterne e interne: e, in base allo studio di tali condizioni, si possono determinare sia le leggi dello sviluppo dell’immaginazione umana sia, in particolare, le differenze tra gli stili artistici e tra le singole creazioni individuali. Grazie a Taine, il Positivismo inaugurato da Auguste Comte trovava un suo sviluppo nel campo dell’estetica.
LÉVY-BRUHL

La teoria del “prelogismo” dei “primitivi” elaborata da Lucien Lévy-Bruhl (1857 – 1939) si pone in totale distacco rispetto alle teorizzazioni dell’evoluzionismo e si colloca, invece, in una dimensione di consapevole e radicale relativismo culturale.
Per Lévy-Bruhl il contesto etnologico si configura come totalmente altro rispetto all’Occidente. In base alla teoria del “prelogismo”, i primitivi sarebbero caratterizzati da una struttura psichica in cui non vige il principio di non contraddizione, e in virtù della quale la loro mentalità, il rapporto soggetto/mondo, il rapporto naturale/sovrannaturale, sono differenti dai nostri. Per Lévy-Bruhl è dunque metodologicamente sbagliato utilizzare le rappresentazioni collettive dell’uomo occidentale per interpretare sistemi logico-culturali affatto diversi. Al contrario, rifiutando l’impostazione eurocentrica, “l’attività mentale dei primitivi non sarà più interpretata in partenza come una forma rudimentale della nostra, come infantile e quasi patologica. Apparirà anzi come normale nelle condizioni in cui essa si esercita, come complessa e, a suo modo, sviluppata.
La teoria del prelogismo costituisce il filo rosso che lega le maggiori opere di Lévy-Bruhl, da Les fonctions mentales dans les sociétés inférieurs a La mentalité primitive, fino a Le surnaturel et la nature dans la mentalité primitive.
Le rappresentazioni collettive dei primitivi – a differenza di quelle dell’uomo culto occidentale, dominate dal principio dell’identità personale rigorosamente distinta dalle altre individualità e dal mondo fisico -, sono dominate dal concetto di labilità, di fluidità, e hanno alla base quella che Lévy-Bruhl definisce “legge di partecipazione”. Secondo tale legge, lo stato mentale dei primitivi è caratterizzato da un’estrema intensità emozionale che induce ad una costante partecipazione mistica con l’universo. Il primitivo “sente” ciò che lo circonda come attraversato da una forza numinosa fluida, fisica e psichica. I confini che nel nostro mondo isolano nettamente l’uomo dall’ambiente esterno, la natura dalle forze soprannaturali, lo stato di veglia dallo stato di sogno, nel mondo primitivo sono estremamente labili o inesistenti. Dunque la mentalità primitiva, più che rappresentare l’oggetto, lo vive e ne è posseduta.
Parimenti la personalità è rappresentata come energia, qualitativamente identica a quella che promana dagli animali, dalle piante e dalle cose, e i suoi limiti, nella mentalità collettiva, sono labili, tanto che l’identità personale non è incompatibile con la dualità o la pluralità delle persone. Spesso le esperienze di compartecipazione mistica del primitivo, largamente documentate da Lévy-Bruhl, si riflettono nei miti. Nelle rappresentazioni collettive dei primitivi che fanno da sfondo all’esperienza reale, c’è fluidità anche tra il piano sacro e il piano “profano”. La sovrapposizione dei due piani rappresenta la norma. Non solo: il piano sovrumano finisce per calamitare interamente l’anima e la mente degli uomini. Le forze soprannaturali cingono in un perenne stato d’assedio l’esistenza umana e ciò fa in modo che la religiosità dei primitivi sia di stampo totalmente mistico, mentre le operazioni magiche hanno lo scopo di mediare la sfera delle potenze occulte.
Di fatto, come osserva Marcello Massenzio, nella visione che Lucien Lévy-Bruhl ha del mondo dei “primitivi”, l’uomo come soggetto di cultura finisce per sparire del tutto, poiché i margini di intervento culturale sulla natura sono completamente annullati.
L’ambiente scientifico del tempo, caratterizzato da un’impostazione razionalistica di tradizione illuministica, reagì molto negativamente alla proposta teorica di Lévy-Bruhl. Émile Durkheim, sostenitore dell’unità dello spirito umano e della sua omogeneità in tutte le epoche, evidenziò come nella vita quotidiana i primitivi applicassero una razionalità pratica del tutto simile a quella che governa le azioni di tutti gli uomini della terra. La forza delle argomentazioni indusse col tempo Lévy-Bruhl a recedere dalle sue posizioni più estreme, e a rivedere completamente le sue precedenti teorie, come si constatò dopo la sua morte, in una serie di quaderni che contenevano gli appunti dello studioso stesi nell’ultimo periodo della sua vita, i Carnets, pubblicati postumi nel 1949.
ALLAN KARDEC

A cura di Piero Ponti
Allan Kardec è lo pseudonimo di Hippolite Lèon Denizard Rivail (1804-1869).
Nato a Lione da una famiglia di avvocati e magistrati, dopo i primi studi nella città natale, fu inviato a completare la propria preparazione in Svizzera, a Yverdun, presso il celebre pedagogista Enrico Pestalozzi, del quale fu prima discepolo e, ben presto, collaboratore. Fu educatore della gioventù, e si distinse anche nel campo letterario, dove lasciò alcuni scritti istruttivi: “Piano di perfezionamento dell’istruzione pubblica”-1828; “Corso Pratico e teorico di Aritmetica”-1829; “Grammatica Francese Classica”-1831; il Manuale dei Test per l’ottenimento del Diploma di Capacità-1846; “Catechismo Grammaticale della Lingua Francese”-1848; ha anche pubblicato un’opera comprendente tutti i suoi corsi – fu insegnante di Filosofia, di Astronomia, di Chimica e di Fisica presso il Politecnico di Parigi.
Rivail aveva un naturale talento pedagogico, era attratto dalla filosofia e dalla scienza, e compì anche studi di medicina. Imparò varie lingue (italiano, spagnolo, tedesco e inglese) ed ebbe occasione di compiere molteplici esperienze professionali.
Allo Spiritismo (la filosofia che pone al centro dell’evoluzione universale il progredire degli spiriti attraverso molteplici incarnazioni) arrivò a cinquant’anni, nel 1854. Fu allora che sentendo parlare di sedute medianiche cominciò ad accostarsi a questo tema con la prudenza che lo distingueva e con il metodo serio e ponderato che aveva appreso in tanti anni di studio.
La presenza di Rivail dava alle sedute un carattere particolare: se prima del suo intervento le entità s’intrattenevano coi presenti soltanto su problemi di tipo personale e familiare di alcuno dei partecipanti, con lui i contenuti cambiavano e vertevano su temi filosofici, speculazioni religiose ed escatologiche.
«Arrivavo alle sedute», scrive Kardec rievocando quel periodo, «con una serie di domande preparate e ordinate metodicamente; e le risposte che ottenevamo erano sempre precise, profonde e logiche… Da principio ciò m’interessava soltanto per istruzione mia personale. Più tardi, quando vidi che il tutto assumeva le proporzioni di una dottrina, pensai di farne una pubblicazione per l’istruzione di tutto il mondo.»
Un lavoro paziente e metodico, portato avanti con logica e spirito critico, seguendo un sistema ben preciso. Rivail era una persona che doveva convincersi fino in fondo di una cosa, prima di comunicarla agli altri: le Entità, per dimostrargli la loro reale esistenza, gli rivelarono allora fatti che soltanto lui poteva sapere. Una volta convintolo, gli parlarono di una sua precedente incarnazione in Bretagna, presso gli antichi Celti, dove il suo nome era Allan Kardec, e gli spiegarono che il suo compito in questa vita era di contribuire alla diffusione degli insegnamenti che Esse gli avrebbero trasmesso: tali insegnamenti – di natura molto elevata – non solo potevano essere utili all’umanità, ma erano in grado di farla crescere spiritualmente.
Rivail, si convinse del compito che gli veniva affidato, e da quel momento adottò lo pseudonimo di Allan Kardec con cui firmò tutte le sue opere.
Autore dei libri:
1. Il Libro degli Spiriti
2. Il Libro dei Medium
3. Il Vangelo Secondo gli Spiriti
4. Le Rivelazioni degli Spiriti (Genesi – Miracoli – Profezie)
5. Le Rivelazioni degli Spiriti ( Il Cielo e l’Inferno)
6. Le Manifestazioni Spiritiche
7. Opere Postume
JOHN FISKE

A cura di Marco Machiorletti
Quando le prime opere di Herbert Spencer, caratterizzate da un’interpretazione dello sviluppo della società e delle istituzioni sociali in termini biologici, furono introdotte negli Stati Uniti, il clima culturale americano era propizio alla diffusione delle idee evoluzionistiche. Tuttavia, contro ogni previsione, l’accoglienza immediata fu fredda. Più che lo stesso contenuto della dottrina spenceriana, fu l’agnosticismo implicito in essa che rese esitanti i pensatori americani, i quali vi ravvisarono malcelate aspirazioni laiche. Nonostante tutto, però, vi furono alcuni che non si preoccuparono dell’ “Inconoscibile” di Spencer, ritenendo anzi di poter conciliare tale concezione con una credenza teistica accettabile. Il più eminente di questi epigoni spenceriani in America fu John Fiske (1842 – 1901), che non ancora ventenne già considerava Spencer il massimo filosofo. Non molto più tardi, però, lo stesso Fiske finì per ritenere che la propria interpretazione di Spencer costituisse uno spencerianismo migliore di quello di Spencer medesimo. Così, pur rimanendo un discepolo, egli in molti punti si staccò dal maestro.
Nel 1860, a soli 18 anni, Fiske recensì l’History of Civilization in England di Thomas Buckle (1821 – 1861). Ciò gli fornì l’occasione per esporre le proprie vedute, per manifestare la propria ammirazione nei confronti di Spencer, e per indicare il posto attribuito a questi nella storia del pensiero. Fiske dichiarò di credere nell’esistenza di leggi, “fisse ed accettabili”, implicite nei mutamenti sociali, ed affatto analoghe alle leggi dei processi civili. Ai suoi occhi la tesi opposta, secondo la quale lo sviluppo della società sarebbe imprevedibile, sembrò illusoria e dovuta, in parte, all’importanza attribuita all’intervento soprannaturale e miracoloso negli affari del mondo, in parte, alla credenza nella fondamentale inesplicabilità dell’azione umana, ed in parte, alla consuetudine intellettuale di considerare i fatti sociali isolatamente, anziché come serie coordinate di eventi sottoponibili a spiegazione scientifica. Il tardo sviluppo della scienza sociale fu una conseguenza dell’intrinseca complessità di essa e della sua dipendenza dalle scienze fisiche, relativamente più semplici. Finché queste restarono “metafisiche”, non poterono avere uno sviluppo completo, ritardando anche quello delle discipline sociali. Una volta liberatasi la scienza fisica dalle scorie metafisiche, “fu possibile concepire l’esistenza di una regolarità universale e costante nella successione degli eventi storici”. Fino ai tempi moderni non vi fu una scienza della società: Machiavelli, Vico e Montesquieu incominciarono l’opera; Condorcet e, soprattutto, Voltaire la continuarono nel diciottesimo secolo. Ma fu solo con la Filosofia positiva di Auguste Comte che si ebbe una vera scienza del genere, nella quale i mutamenti sociali furono ricondotti a leggi invariabili. Comte, tuttavia, non seppe mettere in luce l’onnicomprensiva legge dell’evoluzione, la legge fondamentale atta a spiegare sia la storia umana che la storia naturale. Una simile conquista spettò ad Herber Spencer. Fiske entusiasticamente asserì:
“Questa sublime scoperta – che l’Universo è un continuo processo di evoluzione dall’omogeneo all’eterogeneo – con la quale può reggere il confronto soltanto la scoperta della legge di gravità ad opera di Newton, costituisce la base non solo della fisica, ma anche della storia. Rivela la legge che regola i mutamenti sociali”. (John Fiske, Darwinism and Other Essays, Houghton Mifflin Co., 1885, p. 146).
Come suggeriscono queste parole, Fiske non ebbe alcuna perplessità nell’accettare l’ipotesi dell’evoluzione quale principio esplicativo, universale e trascendente, di ogni cosa esistente nel mondo; egli fu pronto a fare di tale ipotesi la base di una filosofia “cosmica”. Quando incominciò a scrivere l’opera intitolata Outline of Cosmic Philosophy, suo unico intento era comporre una serie di saggi per illustrare, elucidare, e sviluppare la “Filosofia Sintetica” di Spencer. “Cosmico” gli era sembrato un termine più adatto della stessa espressione spenceriana per indicare ciò che Spencer intendeva. Questi, però, non fu d’accordo, e fece insistentemente rilevare a Fiske che in un certo senso tutti i sistemi filosofici, essendo tentativi di spiegazione dell’universo (o Cosmo), potevano venire denominati “cosmici”. Fiske replicò, nel medesimo tono, che ogni filosofia, mirando a fornire una sintesi delle conoscenze intorno al mondo, poteva essere considerata “sintetica”; inoltre, egli difese il proprio uso del termine “cosmico” con una triplice argomentazione tendente a mostrare come altrettante filosofie correnti, inaccettabili ai suoi occhi, fossero escluse dal significato dell’espressione adottata. In primo luogo, cosmo non indica solo la totalità dei fenomeni, ma anche il loro ordine, la loro successione, e regolarità; nessun sistema teologico basato su miracoli, interventi soprannaturali, o speciali creazioni può essere cosmico, in quanto ammette violazioni dell’ordine universale. In secondo luogo, nemmeno i sistemi “ontologici” o metafisici possono essere cosmici, facendo riferimento ad entità ideali, che non appartengono al cosmo, od universo fenomenico. In terzo luogo, è pure impossibile che la filosofia “positivistica” sia cosmica, poiché essa esclude ogni spiegazione unitaria del mondo. Così Fiske difese il proprio uso del termine “cosmico” dalle critiche di Spencer. Una divergenza circoscritta e verbale come quella indicata può anche sembrare irrilevante, ma in realtà non lo è, suggerendo che Fiske non spinse mai la propria ammirazione per Spencer al punto tale da considerarlo infallibile ed inattaccabile. Fu un sintomo di contrasti sostanziali fra i due pensatori in rapporto a problemi di maggiore entità.
Una delle differenze più sensibili fra la posizione di Fiske e quella di Spencer fu costituita dalla divergenza di prospettiva. Spencer fu un riformatore sociale liberale, di un liberalismo ottocentesco, ed uno studioso di scienze naturali; non ebbe conoscenza profonda di nessuna di queste, ma familiarità con tutte, nutrendo per esse un interesse comparativo. Tentò di applicare i metodi di tali scienze ed anche, talvolta, i loro risultati, per promuovere lo sviluppo della scienza sociale come base di riforma della società. Fiske, invece, ebbe una conoscenza molto risicata delle scienze naturali, ed un interesse assai scarso per esse, come pure per le riforme sociali. Fu dedito, piuttosto, agli studi teorici, umanistici e letterari, raggiungendo la notorietà, soprattutto come storico. Anche dopo aver riconosciuta la necessità di un’impostazione scientifica delle indagini sociali, non arrivò mai in effetti a concepire la scienza sociale come una scienza naturale, ciò che invece fu caratteristico di Spencer. Data questa fondamentale divergenza fra il proprio atteggiamento e quello spenceriano, Fiske finì per occuparsi prevalentemente del problema dello sviluppo dell’umanità, cioè delle leggi della storia umana, dall’evolversi della religione e delle credenze, nonché (questo è il suo maggiore e più originale contributo alla filosofia evoluzionistica) del ruolo della prolungata infanzia dell’uomo all’inizio del processo di evoluzione della società. In base a tali differenze, è lecito affermare che la filosofia di Fiske segnò un avanzamento rispetto all’eredità spenceriana.
Dapprincipio, la teoria della conoscenza di Fiske ricalca fedelmente quella di Spencer, fino alla parziale conclusione che l’uomo può conoscere solo ciò che è causato, finito e relativo. Per la stessa natura del processo conoscitivo, sarà sempre impossibile attingere l’Assoluto, l’Infinito e l’Incausato. Dato che l’intima essenza della materia e dello spirito deve trascendere il finito, non si può affermare nulla di essa. Il sapere, quindi, non è altro che la classificazione degli stati di coscienza prodotti in noi da ignoti agenti esterni, intrinsecamente inconoscibili; tutt’al più è possibile conoscere l’apparenza delle cose, non le cose in sé. L’attività conoscitiva ha dei limiti invalicabili, dovuti alla finitudine della natura umana. Pertanto, data la situazione, ciò che conosciamo non sono le cose nella loro dimensione reale indipendente dalla nostra conoscenza, bensì solo le cose come ci appaiono nel processo conoscitivo. La verità, quindi, non concerne mai le cose, ma sempre il nostro rapporto con esse; agli occhi dell’uomo una proposizione vera è tale in quanto la sua negazione risulti inconcepibile per la mente umana. Fino a questo punto Fiske seguì Spencer, ma mentre Spencer non procedette oltre, Fiske ammise la possibilità dell’esistenza di qualche altro essere, capace di concepire l’umanamente inconcepibile; la conoscenza attinta da siffatto essere e la relativa verità avrebbero avuto carattere superumano. Così, nonostante l’accordo iniziale fra i due pensatori e il comune appello all’esperienza umana nello spirito della tradizione dell’empirismo britannico, il riconoscimento da parte di Fiske della possibilità di un sapere soprannaturale, opera di un essere superiore, suggerì una posizione filosofica di gran lunga più vicina all’idealismo teistico convenzionale.
Anche l’analisi della causalità intrapresa da Fiske, può servire ottimamente ad illustrare come piccole divergenze di prospettiva iniziale abbiano dato luogo a conclusioni disparate. Spencer, forse per la familiarità con le scienze naturali, considerò i problemi di successione causale in termini di persistenza di forze, ossia, attendendosi a un punto di vista fisico. Fiske, invece, in virtù della propria inclinazione per gli studi storici e letterari, preferì basare l’esame del principio di causa sul presupposto della relatività della conoscenza umana. Egli sostenne soprattutto l’importanza della scoperta della vera natura del legame causale, in quanto, secondo la teoria gnoseologica precedentemente elaborata, solo gli stati di coscienza determinati da tale legame, e non il rapporto causale in sé e per sé, potevano considerarsi conoscibili. Ma nonostante che la natura della causalità sfugga alla mente umana, date le limitazioni di cui questa è partecipe, sarebbe irragionevole negare l’esistenza di relazioni causali oggettive; non è quindi possibile respingere il principio di causa, secondo il quale ogni evento finito è causalmente determinato, trattandosi di una verità necessaria. Da tempo, l’analisi di questa legge ha suggerito che, essendo le cause degli eventi finiti esse stesse finite, debbono a loro volta dipendere da altre cause. Tale ricerca di cause può estendersi indefinitamente, senza che ci si avvicini mai ad un principio reale, a meno che, a qualche punto del processo, non venga postulata una Causa Prima o Causa Incausata. Questa non è concepibile finita, ché, altrimenti, dovrebbe essere a sua volta considerata causata. Pertanto, si è giunti ad identificarla con Dio, e gli attributi della Divinità sono stati progressivamente inclusi nel puro concetto filosofico della Causa prima. La quale idea, liberata dalle associazioni antropomorfiche, secondo Fiske avrebbe potuto costituire oggetto di culto. Lo stesso Fiske lo dichiarò in questi termini: la Causa prima “rappresenta il vero oggetto del sentimento religioso, anche se della sua natura – essenziale, distinta cioè dalle manifestazioni esterne – la mente umana non può formare alcuna ipotesi verificabile” (Outlines of Cosmic Philosophy, Houghton Mifflin Co., 1903, p. 268).
Mediante sottili accorgimenti verbali, Fiske trasformò il concetto agnostico di Spencer in un’idea più flessibile alle finalità del culto, suggerendo, inoltre, la sostituzione del Teismo Antropomorfico con il Teismo Cosmico senza prospettare mutamento alcuno nella funzione delle chiese. Ai suoi occhi, la scienza non era destinata ad allontanare l’uomo dalla religione, questi, anzi, come Fiske stesso ebbe a scrivere nel titolo di una delle proprie opere, apparendo guidato Through Nature to God. “L’ostilità fra la Scienza e la Religione, intorno alla quale si è tanto scritto e discusso, non è altro che una chimera dell’immaginazione” (Ibid., p. XIV). In realtà per Fiske la cosa difficilmente poteva essere diversa, identificando egli la scienza con la conoscenza umana, e la religione con le aspirazioni dell’uomo. Nessun evoluzionista del suo stampo, partecipe della fede ottimistica d’ispirazione spenceriana, avrebbe potuto sostenere l’esistenza di una “radicale ostilità” fra le aspettative ed il conoscere, in quanto ciò avrebbe implicato “una fondamentale deficienza nella costituzione delle cose” (Ibid.). Fiske si occupò di problemi religiosi in molti lavori filosofici e, nell’ultimo periodo di vita, ribadì spesso le conclusioni teistiche della propria concezione cosmica.
Un’altra interessante divergenza fra i due pensatori affiora nei rispettivi scritti dedicati all’analisi del problema delle fonti di energia sulla terra; problema in cui rientra la questione del rapporto fra l’energia connessa con i fenomeni fisici e quella riscontrabile nei fenomeni mentali o nervosi. Spencer fu incline ad una soluzione fisicalistica, e, per quanto possibile, cercò d’impostare la propria analisi dei fenomeni non-fisici in termini fisici. Questa tendenza riduzionistica l’indusse a sostenere l’ipotesi di una trasformazione di energie fisiche nei processi mentali, ed a tentare frequentemente di ricondurre le operazioni dello spirito a quelle della materia. Fiske, invece, non pensò mai alla possibilità di una simile riduzione. Egli credette piuttosto nell’esistenza di una correlazione fra le energie fisiche e quelle psichiche, ossia nell’esistenza di un “parallelismo psicofisico”. In tal modo, giunse ad affermare che “non vi è mutamento nella coscienza al quale non corrisponda una trasformazione chimica nel tessuto nervoso” (Outlines of Cosmic Philosophy, p.338), senza però suggerire con ciò che i fenomeni del primo tipo dovessero essere considerati causa di quelli del secondo, o viceversa. Accettato il parallelismo psicofisico, non procedette oltre, sostenendo che “l’abisso fra i fenomeni della scienza e tutti gli altri fenomeni è invalicabile” (Ibid., pp. 334 –335), tale, quindi, da permettere una corrispondenza, ma mai trasformazioni.
Fin qui, esaminando gli aspetti principali del pensiero di Fiske, siamo stati in grado di mostrarne il progressivo distacco dalle idee di Herbert Spencer e di spiegare la divergenza sulla base della disparità di carattere e d’interessi dei due autori. Abbiamo visto che Fiske finì per assumere un atteggiamento d’indipendenza nei confronti del proprio maestro, ciò che gli consentì di formulare una dottrina originale, senza riscontro nella filosofia spenceriana. Egli espresse le nuove idee brevemente nell’opera Outlines of Cosmic Philosophy, e con maggiore compiutezza in un saggio su “Il Significato dell’Infanzia”. In questo lavoro tentò di mettere in luce le radici naturali dei sentimenti etici e sociali del genere umano, risalendo all’infanzia relativamente prolungata propria dell’uomo.
Il cervello umano, affermò Fiske, a differenza di quello degli altri animali passa attraverso le fasi più importanti di sviluppo dopo la nascita. In confronto ai piccoli di qualunque altra specie, il bambino appena nato ha ben poche facoltà completamente sviluppate; inoltre, egli deve assimilare una serie di modelli di comportamento molto più ampia che qualsiasi altro animale. L’unico modo, affinché un cervello complesso come quello dell’uomo possa svilupparsi compiutamente, è di prolungare il periodo di dipendenza. I membri del gruppo preumano assistiti con ogni premura dai genitori avrebbero le maggiori possibilità di sopravvivere; parimenti, la selezione naturale tenderebbe a favorire gli individui più inclini a trasmettere ai propri discendenti le attenzioni ricevute. Attraverso un’evoluzione del genere deve essersi determinato un graduale incremento dell’interesse dei genitori per i giovani. Così, sempre secondo Fiske, dall’impulso a sorvegliare l’uomo nella sua prolungata infanzia emerse un’organizzazione familiare abbastanza stabile, anche se semplice, divenuta poi clan, e quindi società civile. Parallelamente a questo sviluppo sociale ebbe luogo un’evoluzione dei caratteri morali, essa pure esplicabile in base al processo di selezione naturale. I discendenti più atti a sopravvivere sarebbero quelli sorvegliati nel modo migliore e più a lungo dai genitori; tali genitori, tuttavia, sarebbero quelli cui non mancò la virtù della simpatia in forma embrionale. Della medesima virtù risulterebbero con molta probabilità dotati anche i discendenti, atti a trasmetterla alla loro progenie. Questo fu il processo, nell’opinione di Fiske, attraverso il quale i sentimenti umani divennero patrimonio comune di tutta l’umanità.
Grazie a tale teoria, Fiske concepì la moralità e la socialità in termini evoluzionistici, subordinandole entrambe al proprio singolo principio “cosmico” di sviluppo. Trasformata l’ipotesi dell’evoluzione biologica in una legge basilare della struttura universale, Fiske finì per costituire un caso estremo di filosofo sopraffatto da un’idea scientifica.
CHAUNCEY WRIGHT

“Tutti gli scopi della vita sono compresi, ritengo, nel suo stesso ambito, e coincidono in ultima analisi, o secondo la più ampia generalizzazione, con la difesa, la continuazione, e lo sviluppo della vita medesima”.
A cura di Marco Machiorletti
Chauncey Wright (Northampton, 1830 – Cambridge 1875). Studiò matematica e scienze a Harvard e nel 1852 prese impiego come contabile nella redazione di un almanacco nautico. Per breve tempo fu professore di filosofia in una scuola femminile, e in due occasioni insegnò a Harvard. La prima volta, ebbe un incarico di un anno per tenere un corso di psicologia; la seconda, gli venne affidata una cattedra di fisica matematica, e il provvedimento avrebbe avuto carattere permanente, se di lì a un anno egli non fosse prematuramente scomparso. I suoi scritti, per lo più recensioni pubblicate su “The Nation” e “The North American Review”, sono stilisticamente trascurati e spesso difficili da leggere. L’unico vero e proprio articolo, su “L’Evoluzione dell’Autocoscienza”, appare come uno studio preparatorio per un lavoro sistematico che non fu mai iniziato.
Chauncey Wright emerge come una delle figure centrali nello sviluppo del naturalismo evoluzionistico in America. Egli contribuì alla formazione intellettuale di Charles Peirce, William James, e Olivier Wendell Homes Jr. Per un certo periodo i suoi pochi scritti furono quasi ignorati e il suo nome fu ricordato solo in connessione con quelli degli amici più famosi. Oggi, tuttavia, Wright è considerato sempre meno un seguace di Peirce, o di James, o di Holmes, e sempre più un pensatore indipendente.
Wright ritenne che nessuna asserzione, anche se diffusamente accettata o garantita da qualsivoglia autorità, dovesse essere assunta come vera senza discriminazione. È probabile che proprio per aver cercato di applicare strettamente questo principio nella propria opera filosofica egli non sia riuscito a lasciare alcuno scritto sistematico. Il suo pensiero deve venire ricostruito in base ad annotazioni sparse soprattutto in lavori critici; non si presenta formulato in maniera organica e unitaria.
A causa del proprio temperamento scettico, Wright nutrì forti sospetti nei confronti delle larghe e poetiche generalizzazioni non verificabili sul piano dell’esperienza umana. Egli diffidò di ogni concezione dell’universo caratterizzata da elementi posti al di là di esso; nel suo pensiero filosofico e scientifico vi fu la tendenza a combattere l’impiego di un unico principio attraverso il quale estrapolare la spiegazione di tutti i fenomeni. Così, pur essendo stato uno dei primi pensatori americani ad accettare l’ipotesi darwiniana dell’evoluzione biologica, Wrigth, a differenza di John Fiske, rifiutò di considerare l’evoluzionismo un’ipotesi cosmica. In tal caso, come nelle questioni morali e religiose, egli osteggiò l’atteggiamento “trascendentale”, nei cui termini gli enunciati di qualsiasi disciplina erano elevabili al rango di princìpi universali. Questa opposizione affiorò con particolare chiarezza in una lettera a Miss Grace Norton, sua corrispondente abituale, che gli aveva chiesto: “Perché noi esistiamo?”. Wright rispose negando l’importanza per la nostra vita di qualsiasi remoto fine spirituale:
“tutti gli scopi della vita sono compresi, ritengo, nel suo stesso ambito, e coincidono in ultima analisi, o secondo la più ampia generalizzazione, con la difesa, la continuazione, e lo sviluppo della vita medesima” (Letters of Chauncey Wright, a cura di J.B. Thayer).
Il motivo fondamentale dell’antitrascendentalismo di Wright, quindi, fu la sua convinzione dell’impossibilità di un unico e onnicomprensivo sistema metafisico, atto a costituire la base di discussione dei problemi empirici e morali. Ciò comportò baconiana sfiducia e distacco nei confronti del pensiero metafisico tradizionale, imperniato su princìpi immutabili ed eterni nella “Ragione” umana anteriormente all’esperienza. A questo genere di pensiero Wright contrappose le osservazioni e gli esperimenti particolari, destinati a promuovere un avanzamento graduale del sapere. La ricerca scientifica gli parve il miglior tipo d’indagine empirico-conoscitiva, libera dai pregiudizi del ricercatore o dalle pressioni dell’ambiente sociale, e soggetta costantemente a procedimenti di verifica attraverso l’esperienza sensibile. Tale verifica fu per Wrigth un importante elemento del metodo scientifico, tanto che egli considerò la superiorità della scienza moderna in rapporto a quella dei periodi precedenti frutto del costante controllo empirico delle ipotesi da parte dei nuovi scienziati. Al pari di Auguste Comte, fondatore del positivismo, Wright suggerì di allontanare la ricerca della verità dai vicoli in cui era stata spinta a opera dei pensatori emotivamente condizionati dalle tradizioni teologiche o metafisiche. Egli rivendicò la libertà dello scienziato di fronte a tutte le forme di costrizione esterna rappresentate dai sistemi di metafisica, di teologia, o di etica. Pur condividendo molti aspetti del pensiero comtiano, Wright non fu in grado di accettare il positivismo come tradizione dottrinale, dato il proprio radicato atteggiamento scettico. Egli identificò il compito della filosofia soprattutto con lo studio del metodo, non potendo essa venire considerata una dottrina positiva, né un tipo speciale di conoscenza per intuizioni. Tuttavia Wright fece propria la dottrina comtiana delle fasi teologica, metafisica, e scientifica del pensiero umano ordinate in successione temporale, ammettendo però la coesistenza di tali alternative entro ogni civiltà matura, i cui membri avrebbero potuto pertanto adeguarsi a tre differenti modelli intellettuali: egli si orientò verso il terzo, e concepì filosofia e scienza unite da uno stretto legame.
Affatto insufficiente gli sembrò la difesa tradizionale della teologia e della metafisica come fonti del senso di devozione e di mistero, senso misconosciuto dalla scienza in quanto dedita all’esclusivo esame dei fatti. Nel pensiero metafisico (e, più ancora, in quello teologico) egli vide la matrice di un sentimento passivo, appunto di devozione e di mistero, simboleggiato dal culto religioso e destinato a sfociare nell’obbedienza e nella sottomissione assolute. Il modo di pensare scientifico, invece, gli parve incoraggiare sia la devozione che il mistero in forme attive: questo, come importante fattore di curiosità e ricerca, “sprone e guida, elemento di stabilità e di serietà, e nemico solo della dispersione e dell’ozio”; quella, come forma di utilità e di dovere, alleata della libertà. Mentre il carattere passivo dell’atteggiamento metafisico comporta un timore reverenziale nei confronti dell’ignoto, l’attivismo implicito nel metodo scientifico induce a esplorare le zone sconosciute. La scienza, è vero, formula princìpi astratti, ma non quali “compendi di verità”, bensì come utili strumenti per l’ampliamento della “conoscenza concreta della natura”. I princìpi generali nel lavoro scientifico sono “idee sussidiarie”, “mezzi di ricerca”, non finalità.
William James, nel cenno necrologico scritto per “The Nation”, dopo aver rilevato che la prospettiva di Wright escludeva tanto il pessimismo, quando l’ottimismo, essendo affatto neutrale, e dopo aver suggerito che lo stesso Wright, a differenza degli altri uomini, sembrava aver avuto il massimo interesse per le idee mano inerenti al destino umano, fece notare che, “considerata la mera totalità dei fenomeni dati sufficiente per la loro descrizione, egli ritenne superfluo ed ingenuo parlare di un’origine e di un destino metafisici, di una sostanza, di un significato, o di uno scopo”. Continuando, James ricordò che Wright aveva condannato soprattutto, “come idolo metafisico”, il concetto di sostanza. All’obiezione che dovesse esserci “una colla”, cui attribuire la coesione dei fenomeni dell’esperienza, egli avrebbe risposto “che di colla per tenere unite le cose non vi è bisogno alcuno, finché non ci si accorge di qualche motivo per il quale esse dovrebbero sfaldarsi. I fenomeni sono saldati insieme; non possiamo dire nulla di più”.
Wright respinse non solo le generalizzazioni cosmiche del positivismo e dell’evoluzionismo, di attualità ai suoi tempi, ma anche i sistemi più tradizionali dell’idealismo e del materialismo. Ognuna di queste dottrine, se accettata a esclusione delle altre, gli parve destinata a risultare insoddisfacente e parziale. Benché entusiasta della scienza, Wright non fondò mai su di essa alcuna pretesa estremistica, mantenendone sempre un concetto “metafisicamente neutro”.
Egli non cercò di scardinare la religione; d’altra parte, non ritenne che questa e l’etica fossero necessariamente legate. La sottomissione della moralità alla teologia suscitò in lui particolare risentimento, per il fatto che poterono derivarne quali conseguenze storiche il travisamento e la condanna dei valori della vita umana sulla terra. Personalmente, preferì discutere il problema del rapporto tra etica e religione attenendosi a un’interpretazione storica secondo la quale i concetti morali sarebbero emersi prima di quelli religiosi e le credenze teologiche sarebbero state, di conseguenza, accettate soprattutto in virtù delle loro associazioni con princìpi etici umanamente soddisfacenti. La scienza, l’etica, e la religione vennero così concepite quali aspetti collegati, ma indipendenti, della vita nell’universo.
Nel 1872, trovandosi in Inghilterra, Wright ebbe una serie di colloqui con Charles Darwin ed alla fine si dichiarò disposto, come fece sapere per lettera a un amico, “a scrivere una volta o l’altra un saggio su problemi di comune interesse… da intitolare, con espressione erudita, Psichozoölogy; questo, per porre in evidenza l’essenziale subordinazione della coscienza umana ed animale allo sviluppo ed alla situazione in natura” (Letters, p.248). Secondo quanto suggeriscono gl’indizi frammentari contenuti in questa lettera, il saggio prospettato, se fosse stato mai scritto, avrebbe costituito l’espressione definitiva della filosofia di Wright, combinazione dell’utilitarismo di John Stuart Mill e del punto di vista evoluzionistico darwiniano con le vedute dell’autore. In varie lettere vi sono elementi da cui è possibile arguire quale sarebbe stato il risultato, e nell’articolo del 1873, su “L’Evoluzione dell’Autocoscienza”, sembrano delineate le basi del sistema rimasto incompiuto.
All’inizio del proprio studio su “L’Evoluzione dell’Autocoscienza” Wright rileva che gli uomini hanno finito per riconoscere che l’ipotesi dell’evoluzione organica spiega lo sviluppo dell’umanità più semplicemente e più agevolmente di ogni altra dottrina. Eppure, vi è una notevole riluttanza ad ammettere che anche l’autocoscienza possa venire intesa come un fenomeno naturale soggetto a processi di trasformazione. Ma ciò, in parte, non è che la conseguenza di un fraintendimento della teoria evoluzionistica. Secondo Wright, il prodotto può differire solo in dimensioni, non in genere, dai propri fattori. Dove non esisteva nulla, non si delineano nuove facoltà. Si hanno invece nuovi usi di vecchie facoltà, i quali, pur acquistando sempre maggiore forza ed efficienza, erano però già strutturalmente distinti fin dall’inizio. Così, ogni nuovo uso di qualsiasi facoltà preesistente dapprima appare come un’appendice marginale o accidentale di vecchie funzioni. Molte facoltà dell’uomo hanno tale molteplicità funzionale: l’autocoscienza, ad esempio, pur non potendo mai essere affiorata in atti preumani “può – tuttavia – essere stata potenzialmente presente in facoltà o cause preesistenti” (PhilosophicalDiscussions, p. 201). Le nuove apparizioni, comunque, sono spiegabili in termini naturali; è inutile affannarsi a cercarne moventi miracolosi o soprannaturali. Il fatto che l’autocoscienza sia caratteristica dell’uomo non esclude la possibilità che essa rappresenti il risultato dello sviluppo di aspetti potenziali o latenti di facoltà biologiche più elementari. Vi sono “manifestazioni spirituali” negli animali, ed è solo al “misticismo” ancora dominante nelle scienze dello spirito che si deve il tentativo di ampliare lo “scarto, effettivamente profondo” , fra la coscienza umana e quella animale, allo scopo di soddisfare il “sentimento di assoluta eccellenza” nutrito dall’uomo. Ciò fornisce una semplice, eppure insoddisfacente, soluzione del problema dell’origine dell’autocoscienza. Più complicata, ma anche più rispondente ai fatti, è la spiegazione scientifica del medesimo fenomeno in termini degli antecedenti psicologici nella vita animale. L’uso riflessivo della coscienza nell’uomo emerge dallo sviluppo di nuove funzioni delle facoltà mentali degli animali. Gran parte del lavoro mentale di questi è stato considerato istintivo, e, come tale, contrapposto all’intelligenza dell’uomo. Secondo Wright, però, il contrasto è stato esagerato:
“la distinzione fra istinto e intelligenza, benché non meno reale ed importante per la classificazione delle azioni in psicozoologia, e di pari rilievo all’antitesi stabilita tra animale e vegetale in zoologia generale, o fra organico ed inorganico, vivente ed inanimato, nella scienza della vita in genere, sul piano delle applicazioni risulta altrettanto vaga e male definita” (Ibid. p.219).
La tesi di Wright potrebbe venire così formulata: vi è coscienza non solo nell’uomo, ma anche, in forme elementari, negli animali; la nuova funzione che essa assume nella specie umana è il proprio uso riflessivo. Tale uso induce il soggetto a distinguere nella memoria “i fenomeni concettuali da quelli della percezione esteriore” (Ibid., p. 223), ossia gli oggetti o gli eventi dalle espressioni, consistenti in suoni, figure, o gesti, di cui l’uomo si serve per denotarli. Gli oggetti esterni non possono venire sottoposti al diretto controllo della volontà, ciò che è invece possibile nel caso dei segni interni. Questi, quindi, sembrano costituire “una piccola rappresentazione del mondo evocabile nel pensiero a piacimento” (Ibid., p. 223). Gli aspetti dell’esperienza umana vengono classificati in base alla loro appartenenza al mondo oggettivo delle cose od al mondo soggettivo dei segni. La distinzione fra oggettivo e soggettivo non è un’intuizione fondamentale, ma una discriminazione analitica nell’ambito dell’esperienza. Non è tanto l’uso dei segni che differenzia l’uomo dall’animale, quanto il fatto che il primo riconosce il proprio impiego di essi. Egli è capace di fissare l’attenzione sui segni, di riflettere sul pensiero come sulle cose. Dalla coscienza, per riflessione, deriva l’autocoscienza: “per la genesi della matura autocoscienza espressa dall’ “Io penso”, fu necessaria solo la capacità di considerare i fenomeni del pensiero segni di altri pensieri, o d’immagini suggerite dalla memoria, e di concepirli con riferimento ad un “soggetto” (Ibid. pp. 251-252).
Incidentalmente, nel corso di questa discussione, Wright abbozzò un’analoga teoria della genesi del linguaggio. Il prelinguaggio consiste di gesti istintivi, non necessariamente intenzionali, nell’uso della voce e degli organi corporali; si tratta di un’attività comune agli animali e agli uomini. Sulla base dei suoni e dei movimenti disorganizzati, il linguaggio è creato dall’uomo per fini sociali, allo scopo di favorire la comunicazione. La scelta di suoni o gesti in ogni caso particolare può essere operata attraverso un’arbitraria associazione simbolica del segno con l’oggetto da esso designato. In questa fase, tuttavia, il linguaggio non è elaborato consapevolmente; esso serve a uno scopo, ma dei suoi creatori è difficile dire che abbiano uno scopo. Il linguaggio diviene una creazione cosciente solo quando i “motivi secondari” risultano connessi con “l’autochiarificazione del pensiero da parte del soggetto pensante, e non semplicemente con la sua comunicazione agli altri” (Ibid., p. 255). Sia nella prima fase, quella sociale, che nella seconda, quella mnemonica o riflessiva, il linguaggio appare chiaramente un sistema d’invenzioni. Tale aspetto è invece meno evidente nella terza fase, quella tradizionale. Si creano abiti linguistici e diventa più difficile per l’individuo introdurre dei mutamenti arbitrari nel linguaggio. A questo punto, lo sviluppo dei vari dialetti, delle differenti lingue, e delle famiglie linguistiche “presenta caratteristiche affatto parallele a quelle dell’evoluzione organica presupposta dalla teoria della selezione naturale” (Ibid., p. 257). Per quanto all’inizio possa essere stato arbitrario e dipendente dalla volontà dell’individuo, nelle fasi successive lo sviluppo del linguaggio finisce per risultare soggetto alla legge naturale, e non al capriccio umano.
LEOPOLD VON RANKE

A cura di Enrico Gori
Leopold von Ranke (21 dicembre 1795 – 23 maggio 1886) fu uno storico tedesco, considerato il fondatore della moderna ricerca storiografica sulle fonti. Von Ranke pose le basi per molta produzione storiografica successiva, introducendo idee quali l’importanza delle fonti primarie, l’enfasi sulla storia narrativa e sulle vicende di politica estera, l’imperativo di scrivere la storia “nella sua essenza fattuale”, come lui stesso diceva: “non [si ha] il dovere di giudicare il passato né di insegnare ai contemporanei per il futuro, ma solo di mostrare i fatti come furono”. Leopold von Ranke nacque nell’Elettorato di Sassonia. La sua educazione si compì parte in casa, parte nel Gymnasium di Schulpforta. Nei primi anni, egli sviluppò una grande passione per le lingue classiche e per il luteranesimo. Nel 1814 entrò all’Università di Lipsia, come studente di Antichità e Teologia luterana. Qui, von Ranke divenne esperto nella filologia e nella traduzione dei classici in tedesco. Egli prediligeva Tucidide, Livio, Dionigi di Alicarnasso, Goethe, Fichte, Niebuhr, Kant, Schelling e Schlegel. Aveva scarsa fiducia nella storiografia a lui contemporanea, giudicandola una mera congerie di fatti assembrata dagli storici. Tra il 1817 ed il 1825, Leopold von Ranke fu professore di Antichità a Francoforte sull’Oder. In questo periodo si appassionò alla Storia, vuoi per la ricerca di un campo di ricerca più professionale, vuoi per il desiderio di trovare la mano di Dio nello svolgersi della Storia. Le sue opere più importanti sono le seguenti: Geschichte der romanischen und germanischen Völker von 1494 bis 1514 (1824), Serbische Revoluzion (1829), Fürsten und Völker von Süd-Europa im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert, Die römischen Päpste in den letzen vier Jahrhunderten (1834-1836), Neun Bücher preussischer Geschichte (1847-1848), Französische Geschichte, vornehmlich im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert (1852-1861), Die deutschen Mächte und der Fürstenbund (1871-1872), Ursprung und Beginn der Revolutionskriege 1791 und 1792 (1875), Hardenberg und die Geschichte des preussischen Staates von 1793 bis 1813 (1877), Weltgeschichte – Die Römische Republik und ihre Weltherrschaft (1886, in due volumi). Nel suo primo libro, la Storia dei popoli germanici e latini dal 1494 al 1514, von Ranke utilizzò una mole di fonti insolita per uno storico del tempo: diari, ricordi, dispacci, missive formali e non, testimonianze oculari, applicando così i criteri filologici senza trascurare la letteratura “comune” in favore di reperti più antichi e particolari. Von Ranke inizia la sua opera affermando di voler dimostrare l’unità delle esperienze delle nazioni germaniche, Scandinavia, Germania e Inghilterra, e delle nazioni latine, Italia, Spagna e Francia attraverso le suggestioni della migrazione di popoli, le Crociate e la colonizzazione che, secondo Ranke, avrebbe unito tutte le nazioni, formando così la moderna civiltà europea. Nonostante le premesse, Ranke esamina separatamente tutte le nazioni fino alle guerre italiane del 1494. L’affermazione: “raccontare le cose come andarono effettivamente” è il principio guida di molti storici, anche se ha suscitato alcuni dibattiti: alcuni pensano che la frase denoti la necessità di narrare i fatti senza che lo storico intervenga con osservazioni proprie; altri sono invece dell’avviso che lo storico debba sì dire le cose come stanno ma anche ricercare la questione generale che fa da sfondo e cornice al momento storico. Secondo Ranke, bisognava ricercare il geroglifico sacro, la mano divina, con un occhio all’universale e godendo del particolare. Reinhart Koselleck ha messo in luce (cfr. Futuro passato) come Ranke resti legato al modo classico – soprattutto greco – di intendere la narrazione storica: in particolare alla triplice idea – tematizzata soprattutto dal Come si deve scrivere la storia di Luciano di Samosata – dello storico come “specchio” imparziale che riflette gli accadimenti, come “apolide” (ossia slegato a ogni partito e a ogni ideologia), e come amante della “nuda verità”. In questo senso – precisa Koselleck – Ranke resta poco sensibile all’idea, tipicamente moderna e precorsa da Chladenius, secondo cui la verità storica è essa stessa storicizzata e dipende dall’evolvere dei tempi e dal “punto di vista” (Sehepunkt) assunto. In seguito al successo della sua prima opera, il Ranke ottenne un posto all’Università di Berlino, dove fu profondamente coinvolto nella disputa tra i seguaci del professor Savigny e gli hegeliani: i primi sostenevano la diversità e la particolarità di ogni periodo storico; i secondi ritenevano che la Storia fosse il dispiegarsi dell’universale “Spirito del mondo” (Weltgeist), di cui le singole epoche non erano altro che tappe transeunti e subordinate al telos finale dell’affermazione dello stesso “Spirito del mondo”. Ranke si schierò al fianco di Savigny, criticando la visione hegeliana della storia e accusandola di univocità. Nell’ateneo berlinese, von Ranke fu il primo a usare i 47 volumi dell’archivio diplomatico di Venezia nel XVI e XVII secolo, prediligendo l’uso di fonti primarie. Più tardi, egli avrà modo discrivere:
“Verrà il tempo in cui la Storia si baserà non più sui relati degli storici, sia pure contemporanei, a meno che non siano in possesso di conoscenze dirette sui fatti, e ancor meno su documenti distanti dagli eventi; bensì su fonti originali e genuine”.
Un progetto che – inutile sottolinearlo – era destinato a restare in larga parte utopico. A partire dal 1831, su incarico del governo prussiano, von Ranke fondò e diresse lo Historisch-politisch Zeitschrift, la “rivista storico-politica”. Di vedute conservatrici, lo storico usò la rivista per attaccare duramente le posizioni liberali. Nell’articolo del 1833, Le Grandi Potenze, e nel 1836 con il Dialogo sulla politica, Ranke affermava che ogni Stato aveva ricevuto da Dio una precisa configurazione morale, e gli individui dovevano tendere al compimento dell’idea del proprio Stato. Così esortava i cittadini a essere leali allo Stato prussiano e a rifiutare le idee della Rivoluzione Francese, che si adattavano, secondo il Ranke, meglio alla Francia che non alla Prussia. Tra il 1834 e il 1836, von Ranke produsse la sua Storia dei Papi di Roma nel XVI secolo, Chiesa e Stato in più volumi. Ranke non poteva, essendo protestante, prendere visione degli archivi vaticani, ma riuscì a scrivere la storia del papato nel ‘500 servendosi di carte private a Venezia e Roma. Nell’opera, lo storico prussiano coniò il termine Controriforma e delineò vivaci ritratti di Paolo IV, Ignazio di Loyola e Pio V. Il papato la condannò come anticattolica, i protestanti perché eccessivamente neutrale. Tuttavia, von Ranke fu molto apprezzato dagli storici per aver inserito la chiesa del XVI secolo nel suo contesto cronologico e per aver evidenziato la particolare temperie nelle questioni politiche e religiose del tempo. Lo storico cattolico britannico Lord Acton in particolare, elogiò l’opera di Ranke come il più equilibrato e corretto lavoro mai scritto sul papato cinquecentesco. Seguì, nel 1845-47, una Storia della Germania al tempo della Riforma, anch’essa in più volumi, per cui utilizzò i 96 volumi della Dieta Imperiale di Francoforte per spiegare la Riforma in Germania quale risultato di politica e religione. Nel 1841 Leopold von Ranke fu nominato Storiografo Reale alla Corte prussiana. Nel 1849 pubblicò le Memorie della casata di Brandenburgo e Storia della Prussica, in cui si esaminavano le fortune degli Hohenzollern dal Medioevo al regno di Federico il Grande. Molti nazionalisti prussiani si sentirono offesi dall’opera, che dipingeva la Prussia come un tipico stato tedesco di media grandezza e non come una Grande Potenza. In una serie di conferenze tenute per il futuro re Massimiliano di Baviera, Ranke dichiarò che “ogni epoca è prossima a Dio”, volendo dire che ogni periodo storico è unico e deve essere compreso nel suo contesto, senza essere ricondotto a una presunta Totalità, secondo quello che invece era stato il metodo hegeliano. Dio osserva la Storia nel suo insieme, e considera uguali tutte le età. Von Ranke respingeva l’idea teleologica di Storia, per cui ogni epoca è inferiore a quella che la segue. Così, il Medioevo non è inferiore al Rinascimento, bensì diverso. Lo storico deve quindi comprendere i periodi nei loro contesti e individuare le idee generali che animano il dato periodo. La Storia non è il registro del progresso umano, poiché “dopo Platone non può esservi un altro Platone”. L’idea di progresso resta per Ranke un’illusione dell’Illuminismo. Il Cristianesimo era, per Ranke, già moralmente perfetto e non poteva migliorare ulteriormente. Infine, la storia per Ranke non è un tribunale. Nel 1865 gli fu conferita la nobiltà, nel 1882 divenne Consigliere e nel 1885 ottenne la cittadinanza onoraria di Berlino. Nel 1884 fu il primo membro onorario dell’American History Association. Dopo il suo ritiro nel 1871, von Ranke continuò a occuparsi di vari temi inerenti alla storia tedesca, come le guerre rivoluzionarie francesi, Albrecht von Wallenstein, Karl August von Hardenberg, e il re di Prussia Federico Guglielmo IV. Von Ranke iniziò nel 1880 una monumentale Storia universale in 6 volumi che cominciava con l’antico Egitto e gli Ebrei. Alla morte dello storico (1886) l’opera era giunta al XII secolo. I suoi assistenti usarono in seguito i suoi appunti per giungere fino al 1453.
METODOLOGIA
Leopold von Ranke non credeva che le teorie generali potessero valere in ogni spazio e tempo; egli trattava la cronologia utilizzando fonti primarie; diceva infatti:
“Intendo le ‘idee guida’ come tendenze dominanti in ogni secolo. Queste possono però essere solo descritte, non ricondotte ad un concetto”.
La polemica contro la filosofia della storia, quella hegeliana nella fattispecie, si basava sulla scarsa considerazione della stessa per l’azione umana, troppo importante per essere definita con una sola parola o con una sola idea o racchiusa in un concetto. Questa mancanza di enfasi sull’unificazione delle teorie portò alcuni a criticare il “cieco empirismo” di Ranke. Nel XIX secolo le sue idee sulla deontologia dello storico furono frequentemente copiate. Nel XX secolo qualche storico, come E.H. Carr, svalutò l’empirismo di Ranke come ingenuo, datato e poco interessante. Fernand Braudel può essere considerato un moderno oppositore della storiografia di Ranke: per Braudel infatti, la Storia si definisce nel momento in cui è scritta.
PËTR ALEKSEJEVIC KROPOTKIN
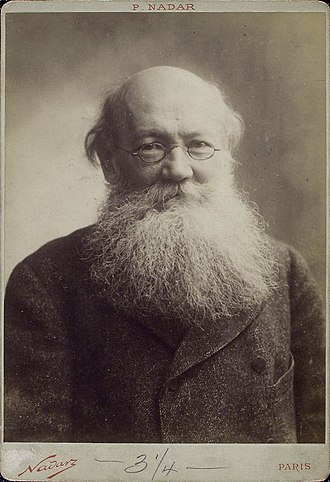
A cura di Silvia Ferbri
“È il fatto che ci darà la vera misura dell’idea”.
Introduzione
Pëtr Kropotkin è stato un rivoluzionario anarchico russo (possiamo considerarlo uno dei “padri fondatori” dell’anarchismo e dell’anarcocomunismo in particolare), ma anche uno scienziato e un filosofo. Il suo è però un pensiero poco conosciuto, pur essendo ricco e fecondo. La sua vita e la sua collocazione politica hanno probabilmente contribuito a metterlo in ombra, al punto che è praticamente ignorata anche la sua intensa opera geografica (a Kropotkin dobbiamo l’esatta conoscenza dell’orografia asiatica e delle varie fasi dell’era glaciale in Europa; compì infatti diverse esplorazioni nella prima parte della sua vita) così come il suo notevole contributo all’antropologia e all’etologia. Le sue ricerche e le sue riflessioni spaziano dall’analisi critica dell’evoluzionismo darwiniano (in occasione della quale emerge il concetto del “mutuo appoggio” come fondamentale fattore evolutivo) alle riflessioni sull’etica (proponendo un’etica solidale, dopo aver esaminato i vari stadi dello “sviluppo” etico); dall’anarchia e l’autogestione a un’approfondita e profetica analisi sociale ed economica; dalla ricerca di una filosofia anarchica della storia fino all’ipotesi di un fondamento scientifico vero e proprio per la teoria anarchica, da contrapporre al socialismo scientifico marxista; dalla sua particolare concezione antropologica a una sensibilità ecologica difficile da riscontrare ai suoi tempi.
Dal punto di vista filosofico rivestono un particolare interesse i suoi scritti sulla storia e la storiografia (quindi il suo concetto di rivoluzione e la sua teoria, sostenuta e messa in pratica con la sua stessa vita, dell’agire umano, che illustreremo più avanti), il concetto del “mutuo appoggio”, e senz’altro la sua opera incompiuta sull’Etica. Ugualmente notevoli, anche se riguardano altre discipline, sono la sua analisi e la sua concezione economica (un’opera come Campi, fabbriche e officine era estremamente all’avanguardia per l’epoca in cui è stata scritta) e, come abbiamo accennato, la sua attività di geografo. Le sue opere e i suoi studi spaziano quindi in svariati campi, a dimostrazione del suo amore per il conoscere e per il sapere, oltre a quello, altrettanto intenso, per la vita e per la lotta.
Kropotkin nei suoi lavori fa un costante riferimento alla scienza naturale, ponendo la scienza come base per le sue argomentazioni, approccio che venne spesso criticato da altri pensatori o attivisti anarchici. Se non può essere considerato quindi un “idealista”, come vedremo, neppure è corretto definirlo un “empirista” tout court. Potremmo qualificarlo come “naturalista”, ma se il suo naturalismo si basa sull’evoluzionismo, come vedremo meglio in seguito, neppure lo si può considerare del tutto un precursore dell’attuale epistemologia evoluzionistica di Campbell, Lorenz, Riedl e altri, in quanto l’evoluzionismo moderno, a differenza di Kropotkin, manifesta solo raramente un interesse sociale e politico. Interessante è poi la questione dell’individualismo e del rapporto individuo-società in Kropotkin, che analizzeremo tra breve, e che allo stesso modo il più delle volte non è stata valutata e compresa pienamente. Ma ciò che è più importante rilevare è che il suo pensiero e il suo punto di vista non hanno perduto oggi la loro attualità e meritano di essere tutt’ora conosciuti e ricordati. Il suo ottimismo e il suo entusiasmo, nonostante le mille difficoltà che ha dovuto affrontare nel corso della sua vita, affascinano e coinvolgono, in particolare la sua descrizione di un uomo davvero libero e capace di vivere sul serio la libertà, un uomo in grado di gestire totalmente l’intera organizzazione sociale ed economica, oltre alla sua vita privata, senza delegare alcunché a politici di mestiere o a veri o presunti esperti. Descrizione che non muove da una qualche teoria formulata astrattamente, ma dalla sua esperienza, diretta o indiretta, che egli costantemente pone non soltanto come concreto esempio da seguire ma anche come obiettivo da continuare a raggiungere. La sua ricerca di modelli di comunità autogestita, basata sulla conoscenza della natura sociale dell’uomo, può fornire importanti stimoli per la società intera, non soltanto per le varie reti o quei gruppi politicamente impegnati che provano al giorno d’oggi (di fronte alle attuali sfide poste dalla crescente emergenza ecologica e dall’espansione dell’imperialismo, da alcuni definito “globalizzazione”) a sperimentare al loro interno l’autogestione e il mutuo appoggio tentando di escludere qualsiasi rapporto di potere. E’ anche fondamentale, nell’attuale crisi della politica e a seguito dei cambiamenti dovuti alla cosiddetta “fine delle ideologie” e al crollo del comunismo sovietico, tentare finalmente (e non solo per la “sinistra” nelle sue varie componenti) di arrivare ad una fondata conoscenza dell’uomo, soprattutto riguardo la sua capacità di convivere pacificamente e in libertà, di cooperare e autoorganizzarsi in uguaglianza, senza costrizione esterna (capacità non riconosciuta da Marx e dai suoi discepoli, ma che andrebbe seriamente rivista, al fine di non ripetere i ben noti vecchi errori).
Non ultimo, il pensiero di Kropotkin può farci riflettere se sia ancora valido (come ritengono invece molti neokantiani e idealisti) continuare ad insistere sulla divisione tra naturale e sociale. Il materialismo di Kropotkin a questo proposito è ancora qualcosa d’altro e di più: egli non fu solo un seguace del principio antropologico di Cernysevskij, ma fu come abbiamo visto un geografo, esponente pertanto di una scienza che allora si definiva interdisciplinare, ovvero proprio una sintesi tra il sociale e il naturale. Le componenti del pensiero e dell’esperienza di Kropotkin sono quindi variegate e complesse, e la sintesi che ne deriva è particolarmente ricca e feconda, un patrimonio da non disperdere, ma da cui attingere e non da un unico punto di vista.
La vita e le opere
Pëtr Aleksejevic Kropotkin nacque a Mosca il 9 dicembre 1842, da una famiglia dell’aristocrazia russa. Fin da piccolo sviluppò quindi un rapporto molto intenso con i servi-contadini della famiglia paterna e un’istintiva empatia per le loro drammatiche condizioni di vita. Frequentò una esclusiva scuola militare (il corpo dei Paggi di Alessandro II, avendo così un contatto diretto con la famiglia imperiale e il mondo dell’autocrazia russa), quindi, nel 1862, rinunciando temporaneamente per motivi di rapporti familiari agli studi universitari, entrò a far parte del corpo dei Cosacchi e si recò in Siberia, esperienza determinante sia per i suoi studi di geografia, geologia e zoologia (che avranno in seguito un’influenza fondamentale nello sviluppo del suo pensiero filosofico), sia per i suoi primi atteggiamenti critici verso la società zarista e le sue enormi ingiustizie, stimolati proprio dal soggiorno siberiano. Restò inoltre particolarmente impressionato dall’organizzazione semicomunista della popolazione autoctona. “Gli anni che passai in Siberia”, scrisse in Memorie di un rivoluzionario, “mi insegnarono molte cose che non avrei potuto imparare altrove. Mi convinsi ben presto dell’assoluta impossibilità di fare qualcosa di veramente utile per il popolo servendosi del meccanismo amministrativo. Mi liberai per sempre di quella illusione. Incominciai poi a capire non solo gli uomini e la natura umana, ma anche le intime origini della vita della società. Il lavoro costruttivo delle masse ignorate, di cui così poco si parla nei libri, e l’importanza di quel lavoro costruttivo nello sviluppo delle forme sociali, mi si delineò con chiarezza.”. Kropotkin qui si riferisce a una comunità che si era stabilita nella regione dell’Amur. “Vedere gli immensi vantaggi della loro organizzazione fraterna semicomunista e constatare i buoni risultati della loro colonizzazione in mezzo ai tanti falliti della colonizzazione di stato, fu una lezione che avrei cercato inutilmente nei libri. E poi, vivere con gli indigeni, osservare le forme complesse di organizzazione sociale che essi hanno elaborato lontano dall’influenza di qualsiasi società, era fare provvista di una luce che avrebbe poi rischiarato i miei studi futuri.”. Dopo essere rientrato in Russia e aver intrapreso finalmente gli studi universitari nella facoltà di scienze (successivamente verrà nominato segretario della sezione geofisica della Società russa di geografia), nel 1872, dopo una spedizione in Finlandia, feconda e determinante soprattutto per la sua riflessione sulle scelte future, si recò in Svizzera, avendo nel frattempo maturato la decisione di impegnarsi nell’attività politica. La decisione di rinunciare all’offerta della Società geografica maturò in seguito al seguente quesito: “Ma quale diritto avevo io a queste gioie profonde, mentre intorno a me non vi era che miseria e lotta per un tozzo di pane ammuffito; quando tutto quello di cui io potevo aver bisogno per poter vivere in questo mondo di altissime emozioni doveva essere tolto dalla bocca di quelli che fanno crescere il grano e non hanno abbastanza pane per i loro bambini?” Vediamo così da subito qual’è il suo metodo di studio (partire sempre dalla realtà concreta, dalla vita vissuta, mai da teorie o principi astratti) e il suo atteggiamento di uomo, fortemente intriso fin dalla più giovane età di un profondo senso di giustizia. A Ginevra aderì alla corrente bakuniana della I Internazionale, ed entrò a far parte della Federazione del Jura. Abbracciò gli ideali di fratellanza socialisti e anarchici, e si impegnò per la partecipazione anarchica ai movimenti sindacali e rivoluzionari. Tornato nel suo paese, dove si unì al Circolo Cajkovskij, vivendo una delle sue esperienze più straordinarie in condivisione con tutti quei giovani, in gran parte ragazze, che rinunciarono a tutto, in molti casi alla loro stessa vita, per dedicarsi anima e corpo all’emancipazione del popolo, nel 1874 venne arrestato e rinchiuso (senza processo) nella fortezza di S. Pietro e Paolo a San Pietroburgo. Durante la prigionia continuò, nonostante le difficoltà, a scrivere i suoi lavori sulla glaciazione in Europa. Nel 1876 riuscì ad evadere con una fuga spettacolare e con l’aiuto dei suoi compagni di lotta, e raggiunse la Svizzera sotto pseudonimo, dopo un breve ma intenso soggiorno in Inghilterra. Diventò segretario generale del IX Congresso generale dell’Internazionale dei Lavoratori, prima di essere costretto a fuggire ancora in Inghilterra. Effettuò numerosi viaggi attraverso l’Europa, sostò a Parigi, dove conobbe Turgheniev, tornando poi a Ginevra nel 1878, dove l’anno successivo fondò e diresse «Le Révolté» (dal 1887 «La Révolte», poi dal 1895, «Les Temps Nouveaux»). La Federazione del Jura era stata ridotta al silenzio dalle persecuzioni, e Guillaume, che da otto anni teneva in vita il «Bollettino della Federazione», aveva dovuto abbandonare la Svizzera e rifugiarsi in Francia. Nel 1880 collaborò con Elisée Reclus, un grande geografo francese di idee anarchiche, anch’egli ingiustamente dimenticato, con il quale instaurò un rapporto di profonda amicizia, alla stesura della sua Geografia Universale.
Espulso nel 1881 dalla Svizzera (a seguito dell’uccisione dello zar Alessandro II), venne poi processato e condannato in Francia l’anno seguente per attività sovversiva. In carcere scrisse Paroles d’un révolté, (Parole di un ribelle). Victor Hugo presentò al ministro della giustizia francese una petizione per la sua liberazione, firmata da numerosi intellettuali. Nel 1886 Kropotkin ottenne la grazia e dopo un breve soggiorno a Parigi si trasferì in Inghilterra, dove fondò la rivista «Freedom». Seguì un periodo di intensa produzione letteraria, durante il quale scrisse alcune tra le sue opere più importanti, tra cui La conquête du pain, (La conquista del pane), La morale anarchiste in «La Révolte», (La morale anarchica), Fields, Factories and Workshops, (Campi, fabbriche e officine), Memoires of a Revolutionist, (Memorie d’un rivoluzionario), Mutual Aid. A Factor of Evolution, (Il mutuo appoggio), La grande révolution. 1789-1793, (La grande rivoluzione. 1789-1793).
I tentativi rivoluzionari in Russia nei primi anni del XX secolo risvegliarono l’interesse di Kropotkin per il suo paese d’origine; nel 1914 prese posizione in favore della guerra contro la Germania (nel 1916 aderì al Manifesto dei Sedici) suscitando numerose polemiche all’interno del movimento anarchico e una lite piuttosto aspra con l’amico Errico Malatesta. Nel 1917, allo scoppio della rivoluzione, Kropotkin tornò in Russia, dove prese immediatamente posizione contro la piega autoritaria che il movimento rivoluzionario stava assumendo, in particolare contro i bolscevichi; entrò in contatto con Alexander Kerenskij (dal quale rifiutò un ministero); e con Lenin, al quale scrisse denunciando il regime, quindi si stabilì a Dmitrov, dove scrisse la Lettera ai lavoratori d’occidente e dove visse i suoi ultimi anni in un isolamento che non poteva essergli proprio.
La sua morte, avvenuta l’8 febbraio 1921 a causa di una polmonite, gli impedì di completare L’etica (Etika, I), quella che lui stesso considerava la sua opera più importante.
La filosofia kropotkiniana della storia
Kropotkin, interrogandosi sul ruolo del popolo durante la Rivoluzione francese, si mise in contrasto con la maggior parte degli storici del tempo, sia per il suo approccio che per le conclusioni a cui giunse. Nel suo libro La grande rivoluzione riscopre ed esalta infatti il ruolo del popolo e della dimensione collettiva, svalutando invece la volontà rivoluzionaria della borghesia.
La borghesia per Kropotkin è controrivoluzionaria, ciò a cui mira è togliere il governo all’aristocrazia cortigiana ma non andare oltre; le sue aspirazioni non sono quelle del popolo; la borghesia ha le idee ben chiare ed è più forte: il popolo, senza il quale la rivoluzione non sarebbe avvenuta, viene utilizzato e sacrificato. L’unione della corrente delle idee con la corrente dell’azione è stata fondamentale, ma quest’ultima proveniva espressamente dalle masse popolari, dai contadini e dai proletari delle città. “E quando queste due correnti si incontrarono in un obiettivo inizialmente comune, quando praticarono per un certo periodo un appoggio mutuo, il risultato fu la rivoluzione.” Le idee dei filosofi del XVIII secolo, i principi di uguaglianza, libertà, sovranità della ragione da soli non potevano essere sufficienti: per provocare la rivoluzione, occorreva “dare inizio alla realizzazione dell’ideale.” E questo poteva avvenire soltanto, secondo l’analisi di Kropotkin, con l’azione rivoluzionaria proveniente dal popolo. Ma poi la rivoluzione autentica venne fermata, e la vera storia popolare della rivoluzione non venne mai scritta. Per Kropotkin, quest’ultima è la storia dei primi sintomi della corrente di pensiero e azione che nel secolo successivo prenderà il nome di anarchismo, è l’origine dei principi comunisti, socialisti, anarchici, la “nostra madre comune”; appartiene alla storia di tutti i libertari, che da sempre, secondo la visione di Kropotkin, è contrapposta a quella degli autoritari, i loro eterni nemici. Giacobini, quindi, contro antigiacobini (hebertisti, “arrabbiati”, anarchici..). E’ la storia delle istanze egualitarie del popolo, degli esperimenti di democrazia diretta e di vero socialismo dal basso e autogestionario. La storia che è sempre stata raccontata dagli storici, reazionari, liberali o marxisti, ritiene Kropotkin, è invece quella dell’involuzione rivoluzionaria compiuta dall’autoritarismo dietro la mistificazione della “necessità”.
L’anima della rivoluzione era nelle Comuni, realtà ben diverse dai corpi municipali realizzati in seguito, dove “i cittadini, dopo pochi giorni di eccitamento dovuto alle elezioni, ingenuamente affidano l’amministrazione di tutti i propri affari, senza occuparsi più di niente. La folle fiducia nel governo rappresentativo che caratterizza la nostra epoca non esisteva durante la Grande Rivoluzione. La Comune nata dai movimenti popolari non si separerà mai dal popolo.”
Kropotkin esaltava la meravigliosa attitudine del popolo per l’organizzazione rivoluzionaria, e la capacità delle masse di fare a meno dei corpi rappresentativi e di mettere in pratica l’autogoverno. L’unità dell’azione era cercata non sottomettendosi a un comitato centrale, ma all’interno di una confederazione. La Comune era una, composta dall’insieme di tutti i suoi distretti, ma il governo rappresentativo era ridotto al minimo indispensabile: era ai cittadini riuniti in assemblea che apparteneva il diritto ultimo di legiferare e amministrare nella Comune.
Kropotkin descriveva poi l’energia interiore che si era accumulata nei villaggi, a dispetto del lungo periodo di guerra seguito alla rivoluzione, e quindi la ricchezza e la produttività, dovute all’amore per la terra. “La rivoluzione ha portato un mutamento profondo, e il vecchio regime non verrà più restaurato.”.
Kropotkin illustrava il momento in cui ci si trova di fronte ad una svolta: riforma o rivoluzione. C’è sempre un momento, sosteneva, in cui la riforma è ancora possibile, ed è di quel momento che è necessario approfittare.
“Una riforma è sempre un compromesso con il passato, mentre il progresso ottenuto tramite una rivoluzione è sempre una promessa di progresso futuro.”.
Evoluzione e rivoluzione, libertà e dominio
Secondo la teoria di Kropotkin, sia i cambiamenti nel cosmo e nella natura vivente, che quelli nella società umana, sono un susseguirsi complementare di evoluzione e rivoluzione. (Intendendo la rivoluzione come conseguenza di un percorso evolutivo, o, più precisamente, un periodo di evoluzione accelerata). Questo è stato il cammino della storia.
Ma non abbiamo a che fare con una teoria astratta: le conclusioni a cui Kropotkin giunge, in questo, come negli altri casi, sono dovute sia ad uno studio approfondito che, in primo luogo, alla sua esperienza personale (non solo e non tanto una verifica, quanto una frequente e reale scoperta). La meravigliosa attitudine del popolo per l’azione rivoluzionaria, ad esempio, cui fa spesso riferimento, deriva dai suoi contatti e dai suoi rapporti, prima con i rivoluzionari russi, poi con il movimento dei lavoratori in Occidente.
Lo schema evoluzione-rivoluzione non è dato per scontato, e nulla può assicurare che continui: se per tutto un insieme di circostanze e di scelte (o non-scelte) si va verso la regressione, l’involuzione o la stagnazione, ecco che una rivoluzione non seguirà.
“Tutta la storia della nostra cultura è attraversata da due tradizioni, da due correnti opposte: la tradizione romana e quella popolare, l’imperiale e la confederativa, la tradizione autoritaria e quella libertaria.” Uno sviluppo, quindi, lungo la linea di conflitto tra libertà e dominio. Quella di Kropotkin è una concezione antagonistica della storia, che non si basa però esclusivamente sulla lotta di classe o sullo scontro delle varie élite per il potere: questo conflitto tra libertà e dominio attraversa e contiene anche gli elementi culturali e soprattutto quelli mentali e psichici.
Per Kropotkin, il cambiamento della società parte dagli individui: non vi sono “motori” esterni. L’agire umano è fondamentale: da esso dipendono le diverse condizioni sociali. Kropotkin si opponeva quindi alle concezioni deterministiche, pur essendo stato sovente accusato del contrario. E respingeva anche la «naturale necessità economica» chiamata costantemente in causa dagli storici e dagli economisti politici, sia borghesi che socialisti. Il «fattore umano» per lui era significativo e determinante, soprattutto nei movimenti rivoluzionari. (Lo «spirito della rivolta» descritto in Paroles d’un révolté).
L’andamento di una autentica rivoluzione, secondo la sua analisi, si svolge in tre fasi:
con l’immediata soddisfazione dei bisogni del popolo (e non attraverso una «dittatura del proletariato»), quindi con l’esproprio dei proprietari;
subito dopo, con una intensa produzione alla quale ciascuno contribuisce volontariamente secondo le proprie possibilità;
terza fase, nelle comunità così costituite (autonome, il più possibile autarchiche, in un equilibrio armonico tra città e campagna circostante) si sviluppano liberi accordi tra i membri che vi fanno parte. Liberi, senza costrizione alcuna.
Kropotkin non ipotizzava la costituzione di istituzioni di ordine “superiore”, che organizzino e controllino lo svolgimento delle diverse fasi rivoluzionarie, e questo a causa della sua fiducia nella maggiore età delle masse popolari. Fiducia nata e rafforzata durante la sua vita in comune con così tanti individui che lottarono e sacrificarono la propria vita per costruire una nuova società e una vera libertà, come egli ci racconta in Memorie di un rivoluzionario, che è molto di più di un romanzo autobiografico. Diversamente dallo scetticismo di altri pensatori anarchici, Kropotkin era assolutamente convinto della grande forza rivoluzionaria del popolo, e più precisamente del fatto che fosse lo spirito collettivo, il cuore del popolo intero, a far emergere le grandi idee nella storia, e non i concetti dei filosofi. “La ribellione proviene sempre dagli oppressi, dal popolo.”.
Chi è questo popolo, questa forza in grado di plasmare la storia? Per Kropotkin non si trattava di una astratta e confusa nozione generale, o di una specifica classe rivoluzionaria, ma di comunità costituite da uomini, da singoli individui concreti: quegli esseri umani che egli ha incontrato e con cui ha condiviso gioie e dolori, speranze e sconfitte, nel corso delle sue esplorazioni geografiche e nel corso delle vicende della sua vita. La sua antropologia è autentica, perché si basa su dati oggettivi. La sua è una conoscenza dell’uomo “scientificamente” fondata. Qualcosa che è in qualche modo mancato ai teorici del socialismo (per quanto definito “scientifico”) così come ad altri filosofi o pensatori che non sono mai usciti dalle aule universitarie. Kropotkin a volte è stato accusato di autoritarismo, in altri casi riduttivamente considerato un “positivista”. Il naturalismo di Kropotkin si basa sull’evoluzionismo, su un individuo, come abbiamo visto, formato via via dalla progressione delle sue conoscenze e da una crescita dovuta all’esperienza, quella propria e quella di chi l’ha preceduto, dotato pertanto sia di un certo numero di “a-priori” che di una serie pressoché illimitata di “a-posteriori”, questi ultimi suscettibili di variazioni che non possono essere previste o predeterminate. La libertà e la creatività umana sono quindi fondamentali. Nessun innatismo, nessun determinismo, né finalismi o teleologismi di alcun tipo.
Kropotkin ha vissuto un’esperienza molto vasta, che si potrebbe definire “completa”. Ha spaziato in quasi tutti i campi del sapere, è stato uno scienziato, un geografo, un geologo, un antropologo, un sociologo, un economista; ha avuto contatti strettissimi sia con l’aristocrazia che con i contadini, gli operai, gli studenti, gli esuli e gli emarginati; è stato un rivoluzionario in mezzo ad altri rivoluzionari; è stato probabilmente difficile valutare la sua opera per coloro che hanno provato a farlo partendo però da esperienze o visioni molto più circoscritte.
Egli ha esplorato la complessità e la molteplicità, ed è queste (non l’uniformità, come hanno voluto osservare alcuni critici) che ci descrive e su cui si basano i suoi lavori.
La ricerca di Kropotkin sulla natura dell’uomo, ricerca seria, ostinata, rigorosa, che ha impegnato tutta la sua vita, basata su esperienze concrete e su costanti verifiche, trova conferme nella psicologia del profondo e nell’antropologia culturale, così come le sue analisi e le sue previsioni economiche in primo luogo nei fatti.
Può essere difficile comprendere come possano coesistere la dimensione rivoluzionaria e quella evoluzionistica (vedi più avanti, ultimo capitolo), e si può ritenere, fraintendendo, che per Kropotkin l’etica e la libertà (che implicano coscienza e volontà) siano unicamente il risultato di un’evoluzione organica universale, che trascende quindi l’ambito della scelta e della conquista individuali, si può pensare che la società ipotizzata da Kropotkin sia un ulteriore esempio di oppressione del singolo individuo, che la socialità non possa essere una scelta ma soltanto una necessità della specie, ma leggendo le sue opere con piena attenzione si scopre che egli non intendeva affatto questo, che la sua visione è originale e svincolata dai consueti canali di pensiero e di interpretazione, così come dalle correnti filosofiche più accreditate. E non è mai una visione slegata dalla realtà: appartiene piuttosto a una realtà che è sempre molto rara, fragile, difficile da difendere e da estendere, perché continuamente ostacolata dal potere.
Individuo e società
Kropotkin non analizza il dualismo individuo/società come altri pensatori hanno fatto (possiamo citare Fourier, seguito da Freud, Marcuse, Foucault, quindi la problematica della repressione esercitata dalla società sulle passioni umane), partendo cioè dall’analisi di una società repressiva e gerarchica; egli ha un’altra visione del mondo e da questa sceglie di partire, pur non disconoscendo la realtà che lo circonda (che anzi critica e combatte) e non ritiene che la libera soddisfazione dei bisogni dell’uomo sia per forza incompatibile con qualsiasi tipo di società “civile”.
Qual’è il suo presupposto? Una società senza individui non può esistere: è chiaro perciò che sono gli individui stessi a formarla. La società è quindi il risultato, la somma, delle azioni e delle scelte degli individui che la compongono. Se la società si basa su rapporti gerarchici, di sfruttamento e dominazione, tutti coloro che sono dalla parte degli sfruttati, dei dominati, o in ogni caso sono esclusi dalle decisioni politiche, economiche e via di seguito, svilupperanno un sentimento di estraneità, di avversione, o di accettazione passiva. La società diviene un qualcosa di estraneo. Diviene un elemento a sé, il simbolo stesso della coercizione sull’individuo e della privazione della libertà (che in effetti è ciò che si realizza).
Più le decisioni, le scelte, le gestioni sono accentrate e autoritarie, e meno le singole persone sono in condizioni di parteciparvi, più si sviluppa questo sentimento nei confronti della società. Nello stato accentratore, con la sua legislazione, i suoi corpi militari, la sua burocrazia onnipervasiva, l’individuo, in quanto parte del corpo sociale, in realtà ne occupa un posto infinitamente piccolo, in qualche modo cessa quasi di esistere.
La convinzione che lo stato con le sue istituzioni sia assolutamente necessario per la gestione del vivere sociale, per evitare il caos, non essendo gli individui in grado di occuparsi delle questioni “pubbliche”, che pure li riguardano!, è un fatto ormai dato per scontato, pur rappresentando una vera e propria contraddizione in termini.
La società è vissuta come “aliena”, né si riesce ad ipotizzarla in altro modo, proprio per questa “separazione”, per questa frattura che è avvenuta nel corso della storia.
In una società di tipo gerarchico, l’individuo non ha occasione di sviluppare se stesso pienamente. Ma nessun essere umano può svilupparsi pienamente, come tale, in solitudine. Può farlo soltanto in unione con gli altri esseri umani. Lo sviluppo individuale e quello sociale sono complementari, dipendono uno dall’altro. Questo però non può avvenire attraverso alcun tipo di imposizione dall’alto. La coercizione, a qualsiasi livello e in qualsiasi grado venga subita, è del tutto opposta allo sviluppo e alla crescita. L’autodeterminazione, la capacità di assumere decisioni e responsabilità non hanno modo di realizzarsi in una società gerarchica e accentrata, tendono anzi ad esaurirsi e scomparire. (Cosa questa che avviene in misura analoga in una relazione più circoscritta, che siano rapporti familiari, di lavoro, personali; la gerarchia e la dominazione, essendo ormai parte di noi stessi, non si esercitano soltanto a livello politico o economico).
In una società non gerarchica, in una comunità libera, sviluppata in modo armonico, formata da uomini liberi, che hanno scelto da se stessi il proprio modo di vivere e di gestire la vita comune, questa frattura tra individuo e società non avrebbe ragione di esistere, non potrebbe probabilmente neppure venire pensata.
Kropotkin intendeva questo (come tanti altri prima e dopo di lui). Voleva ricostruire da cima a fondo la società (come ogni rivoluzionario e come ogni utopista; qualità che vanno necessariamente insieme), non abolirla del tutto.
Voleva una società libertaria, senza più contrapposizione tra dominanti e dominati.
Voleva che gli uomini riacquistassero la loro piena capacità di gestire ogni aspetto della vita sociale, e, prima ancora, la fiducia in questa capacità, che ritrovassero il loro istinto alla comunione e alla solidarietà, il loro antico se non innato rifiuto verso ogni forma di ingiustizia, di sopruso, di disuguaglianza. E’ importante sottolineare che questa visione non è astratta, idealizzata, “utopistica”, ma basata su alcune precise e circoscritte esperienze che Kropotkin stesso ha conosciuto e vissuto oltre che sui suoi studi. Esperienze circoscritte e limitate, abbiamo detto, ma non per questo meno vive e concrete, e da queste egli scelse di partire proprio per permettere di recuperare quello che era per lui l’autentico rapporto di ogni individuo con i suoi simili, onde evitare di dovervi rinunciare per sempre.
Kropotkin mirava ad una immediata realizzazione sociale (comprensiva di ogni attività umana) del comunismo anarchico, ma senza alcuna sottovalutazione dell’indipendenza individuale. La sua idea di “pianificazione” era del tutto opposta alla tradizione collettivistica autoritaria così come a quella comunista statale, in quanto non imposta dall’alto, ma delineandosi in risposta all’insorgenza dal basso, dal popolo.
La descrizione di Kropotkin nel Mutuo Appoggio e nell’Etica della capacità di vivere in società come di una tendenza naturale degli esseri viventi, quasi un qualcosa di innato, è stata talvolta fraintesa, ma la socievolezza a cui si riferiva Kropotkin non ha nulla a che vedere con la società deformata e gerarchica che conosciamo e a cui ormai siamo fin troppo abituati, è esattamente il suo contrario, ed è la negazione dell’esistenza di una malvagità intrinseca dell’uomo, pensiero centrale della filosofia politica dell’età moderna, dai giusnaturalisti, da Machiavelli e da Hobbes fino a Kant. Anche Kropotkin partiva dallo stato di natura (e dalle sue osservazioni dirette sul campo, come abbiamo visto), negando però la necessità di una forma di autorità al fine di controllare l'”asocialità” umana e garantire la convivenza “civile”. La libera convivenza è possibile per Kropotkin; anzi, l’irrinunciabile presupposto per lo sviluppo di ogni potenzialità dell’uomo e per la felicità di tutti è proprio l’abolizione di ogni forma di stato e di centralizzazione. L’uomo, in quanto prodotto di una natura in cui la cooperazione e il mutuo appoggio (e non la lotta e la crudeltà, come vedremo meglio più avanti), sono elementi determinanti al fine della conservazione e dell’evoluzione, è dotato di forti istinti sociali o meglio solidali, anche se questi possono venire meno per innumerevoli cause esterne. La natura quindi non è qualcosa di estraneo (da dominare e sfruttare; la lotta contro una natura avara e crudele è un altro mito da cui dobbiamo liberarci). E la storia non è un semplice prolungamento della natura, la storia dell’uomo aggiunge la creatività, la responsabilità, la razionalità, la scelta umana. L’uomo può ritrovare se stesso (riscoprendo il valore della solidarietà, della cooperazione e della complementarietà), e vivere pienamente la sua vita. Formando quindi una società piena, con la quale coesistere in armonia. Armonia che si compone del rispetto per la libertà e la diversità individuale, incoraggiata a svilupparsi nella sua ricchezza inestimabile, unito alla piena solidarietà, un’unione solo a prima vista impossibile a realizzarsi.
Una società libertaria, sviluppata in modo armonico, favorisce lo sviluppo dell’individualità, non lo inibisce. Si tratta però di un individualismo ben diverso da quello borghese, che è inevitabilmente egoistico, in quanto prodotto di una società e di una sensibilità gerarchiche e verticistiche.
Kropotkin non si arrogava il diritto e la capacità di stabilire aprioristicamente e una volta per tutte quali fossero i reali bisogni dell’uomo, la sua ricerca antropologica non era una astratta teoria che giungeva a una valutazione valida per tutti.. Kropotkin infatti non ha mai smesso di confrontarsi con altri uomini, vivi e reali, di imparare da loro e di condividere interamente le loro condizioni di vita e di lotta, i loro bisogni, le loro aspettative.
La storia, secondo l’analisi di Kropotkin, è colma di dimostrazioni della disponibilità e della capacità umana alla cooperazione, nonché dei continui tentativi di realizzare l’utopia anarchica comunista, lottando contro tutte quelle forme di potere che da sempre cercano di contrastarla. La linea di conflitto tra libertà e dominio di cui abbiamo già parlato.
Tutto questo non ha mai voluto dire però che la cooperazione implicasse l’annullamento della libertà individuale o la repressione delle differenze; ogni volta che si è cercato di seguire la via cooperativa, gli autori di questi tentativi erano proprio coloro che non si riconoscevano in alcun modo nell’autoritarismo, anzi lo combattevano e si sforzavano di realizzare il suo opposto.
Libertà non significa isolamento: significa essere liberi di partecipare a qualcosa di più grande del nostro ristretto spazio vitale; non subire, ma determinare in prima persona (e insieme ad altri) le modalità di vita, di lavoro, di studio della società di cui si è parte. E’ una libertà completa, quindi, ed è innanzitutto mentale e morale, per cui non esiste più la necessità di isolarsi o contrapporsi.
Kropotkin non riteneva di certo che tutte le persone fossero o dovessero essere uguali tra loro, ma desiderava che riuscissero ad unire in un tutto comune le loro molteplicità e le loro differenze, che avrebbero così arricchito la comunità tra di essi costituita. Comunità che non doveva necessariamente avere determinate caratteristiche al posto di altre. La sua convinzione che nessuna evoluzione può darsi nell’isolamento e nella solitudine, è anch’essa dovuta ai riscontri pratici e concreti delle sue numerose e variegate esperienze. La sua critica alla divisione del lavoro, alla condanna inflitta agli esseri umani a svolgere la stessa identica attività per tutta la vita, all’impedimento per alcune classi sociali a godere della bellezza dell’arte o della soddisfazione dello studio e della ricerca scientifica, il suo desiderio che ciascuno potesse avere l’occasione concreta di sviluppare al meglio le sue inclinazioni e le sue capacità, smentiscono in pieno simili affermazioni.
Solidarietà e fratellanza, inoltre, non significano affatto appiattimento e perdita della propria individualità, individualità che si perde molto più facilmente in una società basata sulla gerarchia e sul dominio, all’interno di uno stato accentratore, e sotto ogni tipo di oppressione.
Una libertà comune avrebbe favorito, e contenuto in sé, sotto qualsiasi aspetto, l’autentica libertà individuale. In altre parole, tante differenti libertà che si uniscono a formare una libertà più grande, una comunità libera e libertaria, realmente a “misura d’uomo”.
Kropotkin ha dimostrato con la sua stessa vita l’importanza e il valore che attribuiva all’autodeterminazione dell’individuo. L’individualismo di Nietzsche, ad esempio, più che non compreso da Kropotkin (come è stato affermato) diremmo piuttosto che non poteva essere condiviso, in quanto Kropotkin partiva dalla sua visione ideale di società (riscontrata per altro nell’ambito delle sue ricerche antropologiche; più reale, quindi, che ideale) e non dalla società contraddittoria e distorta da cui partivano Nietzsche ed altri. Se è esistita una critica dell’individualismo da parte di Kropotkin, per comprenderla occorre innanzitutto riuscire a distinguere tra individualismo borghese e individualismo anarchico. E poi tra un individualismo estremo e un individualismo inteso come libertà assoluta di spirito e di pensiero, ma non come isolamento e rinuncia, o distruzione, al posto di una qualsiasi progettualità.
L’individualismo borghese ed egoistico, l’individualismo degli “oppressori”, di chi vuole dominare i suoi simili, inoltre, è ben altro che “autodeterminazione”.
Kropotkin del resto si occupa ben poco di quell’individualismo che porta al nichilismo estremo (a proposito del nichilismo russo dei suoi tempi, così battezzato da Turgheniev in Padri e figli, secondo Kropotkin in Europa venne frainteso, non trattandosi di “terrorismo” ma di una guerra dichiarata a tutte le menzogne convenzionali e alle ipocrisie della civiltà; Kropotkin comunque non condannò mai totalmente la “propaganda del fatto” o le azioni terroristiche, comprendendo la lotta a cui dovette darsi la gioventù russa dopo averla rifiutata fintanto che ciò fu possibile, “quando il calice delle sue sofferenze fu troppo colmo.”), proprio per il suo personale approccio che è profondamente diverso da quello di un Nietzsche o anche di uno Stirner, così come si è interessato altrettanto poco della dialettica marxista. Egli non muove infatti dalla dialettica di tipo hegeliano, prodotto della cultura germanica e impregnata di metafisica, non essendosi svolta la sua formazione nel solco dell’idealismo tedesco: Kropotkin si basa sulle scienze naturali, sul metodo induttivo se vogliamo, sulla conoscenza diretta ed empirica; in lui troviamo poi tracce di quegli elementi così caratteristici del populismo e del romanticismo rivoluzionario russo, che si fondono e si intrecciano in modo quasi inscindibile e con particolare e feconda originalità allo scientismo evoluzionista occidentale. Il marxismo e poi il leninismo, inoltre, avrebbero ucciso la rivoluzione; questo fu un grande dolore per Kropotkin. Nelle Memorie scrisse: “La lotta fra bakunisti e marxisti (all’interno dell’Internazionale) non era una questione di uomini. Era la lotta inevitabile fra i principi del federalismo e quelli del centralismo, fra il Comune libero e l’autorità paternalistica dello stato, fra l’azione libera delle masse popolari e il miglioramento delle condizioni sociali attraverso la legislazione, una lotta fra lo spirito latino e quello tedesco.” La scelta di conquistare il potere negli stati attuali, spogliò i partiti socialisti del loro ideale originario e li condusse verso il socialismo o meglio capitalismo di stato e al tradimento delle masse lavoratrici. Il primato della società sull’individuo (tratto ricorrente nelle critiche rivolte dagli individualisti, anarchici e non, al pensiero di Kropotkin), è senz’altro riscontrabile nel comunismo autoritario, ma ha ben poco a che vedere con il comunismo anarchico e libertario propugnato da Kropotkin nel corso di tutta la sua vita.
L’etica di Kropotkin non è un’etica della ragione (in senso astratto): si basa sul risultato delle sue ricerche empiriche. Kropotkin in tutto il suo lavoro si è distaccato nettamente e coerentemente da ogni metafisica. Egli partiva dal fatto concreto e tangibile; ad esso seguiva la formulazione teorica.
Egli conobbe e studiò le caratteristiche del mutuo soccorso, della solidarietà, della fratellanza, dell’esperienza comunitaria e autogestionaria, e riscontrò che erano espressamente questi aspetti (piuttosto che i rapporti autoritari e burocratici) a poter mutare profondamente la società. Non giunse mai però ad affermare che queste caratteristiche sarebbero emerse in modo inevitabile e che il percorso della storia fosse segnato. Tutt’altro! E nessuno poteva saperlo meglio di lui.
Ma il “progresso” umano vero ed autentico, il “progresso” per tutti (lo sviluppo integrale di ogni singolo uomo) non poteva passare che di lì.
Se avesse creduto nel determinismo, non avrebbe compiuto tutta una serie di scelte e non avrebbe ritenuto necessario scrivere ciò che ha scritto. Le sue opere dovevano servire anche come stimolo alla riflessione sulle diverse possibilità di decisione. Egli sapeva bene che esistevano il rischio e una possibilità estremamente concreta di optare per altre vie, di non riuscire a contrastare la strada che la società stava prendendo. Per Kropotkin era decisivo l’agire umano, l’agire di ogni singolo individuo concreto, e non solo di coloro che condividevano le sue idee politiche. Egli scrisse per tutti, perché ogni coscienza si svegliasse. Per Kropotkin era anzi fondamentale che gli appartenenti alle classi privilegiate dalla storia (egli stesso era nato all’interno di una di quelle classi) arrivassero a condividere le istanze delle classi sfruttate e oppresse o addirittura si unissero a queste, mettendo a disposizione le loro forze migliori per intelligenza ed energia (così come aveva visto fare a molti giovani russi), affinché la società potesse realmente trasformarsi.
Scienza, progresso, economia
La fiducia nella scienza e nel progresso era tipica dell’epoca in cui visse Kropotkin. Si era inclini a pensare a una scienza al servizio dell’uomo e della sua necessità di utilizzare al meglio le risorse dell’ambiente naturale, piuttosto che a una scienza al servizio del potere e del profitto. Oggi forse è difficile per molti pensare alla scienza (e alla comunità scientifica) in modo positivo e propositivo. Il progresso, in maniera analoga, può essere inteso sia come aumento dei profitti e dello sfruttamento del lavoro e dell’ambiente, che, come lo intendeva Kropotkin, come miglioramento delle possibilità di vita materiali, intellettuali e psichiche dell’uomo nella sua interezza e di tutti gli uomini. Un progresso che abbraccia l’intera vita umana, e che è ben altro rispetto al mito ingannevole in cui erano indotti a credere tanti suoi contemporanei.
Un progresso che non può avere un percorso lineare (nessuno spirito e nessuna ragione guidavano il mondo secondo Kropotkin); l’antagonismo e la lotta, come abbiamo visto, sono inevitabili: l’evoluzione positiva dell’uomo può arrestarsi, può regredire; la lotta contro le tendenze autoritarie non avrà mai fine fintanto che queste tendenze non saranno state sconfitte. Se vincere questa lotta è possibile, non vi è però alcuna garanzia che ciò avvenga.
Per Kropotkin, le aspirazioni fondamentali di ogni uomo sono la sicurezza e il benessere, e la libertà individuale. Libertà di pensare, di esprimersi, di associarsi, di gestire la propria vita e il proprio lavoro. Come è possibile ottenerle? Attraverso la socializzazione della produzione e del consumo (a ciascuno secondo i suoi bisogni); attraverso l’abolizione del sistema salariale e di ogni forma di sfruttamento e disuguaglianza, attraverso liberi accordi tra gli individui o tra gruppi di individui, attraverso la conoscenza scientifica messa a disposizione di chiunque e vissuta come un dono, che nessuno scienziato desidererebbe tenere soltanto per sé (qualcosa di ben più ampio rispetto alla “comunità scientifica”, concetto che emerge in seguito alla ”rivoluzione scientifica” del seicento, che rimane però pur sempre ristretta ed escludente). Kropotkin descriveva nel dettaglio una possibile umanizzazione del lavoro, insistendo sull’abolizione della divisione gerarchica tra lavoro intellettuale e lavoro manuale, descriveva l’integrazione del lavoro, la decentralizzazione, i vantaggi della piccola produzione e della piccola industria, la socializzazione della produzione e del consumo, una nuova e più completa istruzione, che non scindesse mai la teoria dalla sua applicazione pratica, che accogliesse l’innato desiderio dei giovani di “fare”, tutti argomenti ancora oggi di estrema attualità. Studiò infatti a lungo un possibile nuovo ordine economico, una nuova economia sociale, l’importanza dell’unità tra sviluppo industriale e agricolo, occupandosi sempre dei bisogni reali e concreti dell’uomo, rifiutando con rigore e coerenza ogni idealismo e ogni costrizione dogmatica, ogni analisi che non partisse dall’osservazione diretta della realtà, senza rinunciare però alla indispensabile capacità di previsione e alla costante preoccupazione per le conseguenze dei nostri atti e quindi alla responsabilità nei confronti del domani.
Il mutuo appoggio e l’etica
Come abbiamo già accennato, l’antropologia kropotkiniana nasce dalla discussione critica del darwinismo e dei suoi successivi sviluppi, o meglio delle sue successive falsificazioni. Si occupò del darwinismo in una serie di saggi per la rivista The Ninteenth Century, pubblicati nel 1902 nel volume Mutual Aid: a factor of evolution. Continuerà ad occuparsi di questi problemi fino ai capitoli introduttivi della sua Etica.
La teoria evoluzionistica di Darwin era stata accolta dalla comunità scientifica e anche dalla società in modo sorprendentemente rapido, ma molto spesso, anziché accoglierla nel suo complesso, se ne erano privilegiati solo alcuni aspetti parziali, in particolare il concetto di lotta per l’esistenza, un fatto che non può sorprendere più di tanto, considerate le condizioni socio-culturali del tempo. Il “darwinismo sociale” diventava una possibile risposta alle esigenze di emancipazione dei gruppi sociali sfruttati e forniva una “teoria” in grado di legittimare le pratiche imperialistiche degli europei nei territori d’oltremare. Non era facile, pena l’isolamento scientifico, contrapporsi al darwinismo sociale dell’epoca. Kropotkin non fu il solo a contestare le concezioni proprie di tale teoria, ma fu l’unico a farlo nel modo più completo. Kropotkin non effettuò una critica ideologica: egli accettò la teoria evoluzionistica darwiniana quale fondamento “scientifico” dell’analisi della convivenza umana, ma ne modificò da un lato il concetto di “lotta per l’esistenza” e dall’altro aggiunse un secondo fattore, altrettanto importante, proprio dell’evoluzione: il mutuo appoggio. Tradusse quindi anch’egli il processo evoluzionistico (profondamente mutato) dalla storia naturale a quella umana. Kropotkin, partendo dall’analisi della lotta per l’esistenza come fattore evolutivo, arrivò a criticare l’accento posto sulla lotta tra individui della medesima specie (dimostrando che lo stesso Darwin si era distaccato in seguito da questa concezione) fino a concludere che la specie più adatta alla sopravvivenza non era quella caratterizzata dalla lotta interna tra gli individui della specie stessa, ma quella maggiormente capace di attuare al suo interno il mutuo soccorso e la cooperazione. Lo stesso Darwin aveva definito l’uomo un “animale sociale” e aveva affermato che il fondamento della socievolezza animale e umana è di tipo biologico, aggiungendo che l’istinto di reciproca simpatia negli animali sociali emerge più spesso del mero impulso egoistico all’autoconservazione. Queste concezioni darwiniane verranno ampliate da Kropotkin sino a una Teoria del mutuo appoggio quale fattore dell’evoluzione, valida non soltanto per la natura ma anche in ambito umano.
Con “mutuo appoggio” si intendono quindi due ambiti concreti: nell’evoluzione della specie, mutuo appoggio e reciproco sostegno costituiscono, accanto alla lotta per l’esistenza, un fattore di grande rilevanza per la sussistenza della vita e lo sviluppo della specie; nella storia dell’uomo, allo stesso modo, sono ugualmente rilevanti per lo sviluppo progressivo delle istituzioni sociali. Per Kropotkin il mutuo appoggio ha un’influenza predominante, e l’istinto sociale ha un peso maggiore rispetto all’impulso all’autoconservazione. Egli si impegnerà a dimostrarlo con un’accurata e dettagliata analisi del mutuo appoggio nella storia naturale e in quella umana, raccogliendo una grande quantità di materiale tra gli animali e tra diverse culture umane (aborigeni australiani, eschimesi) così come sulle comunità di villaggio e le città medievali, quest’ultime, secondo la sua analisi, la continuazione delle prime.
Proprio la teoria darwiniana dell’evoluzione costituirà per Kropotkin il presupposto per una nuova etica. Egli sentiva l’esigenza di un’etica scientificamente fondata, un’etica realistica, come lo stesso Kropotkin la definì. Quest’etica realistica si distingue da molti altri progetti etici per il fatto che Kropotkin non intendeva fondarla su un qualche criterio extranaturale o extraumano per la valutazione dell’agire umano buono e giusto, ma voleva ricavare tale criterio dalla natura stessa, partendo da ciò che è bene e male in natura. Il concetto del bene e del male ovviamente cambia, quindi ciò che Kropotkin si propone non è tanto di prescrivere, con l’aiuto di teoremi normativi, un agire qualificabile come buono, ma di osservare l’agire umano, di studiarlo, di valutarlo e di spiegarlo. Per questo l’etica è per Kropotkin anche scienza degli impulsi etici, scienza che esplora le fonti naturali del sentimento etico dell’uomo. L’etica diventa efficace quando all’uomo si dà un ideale: ma questo ideale, che guida quindi l’agire etico dell’uomo, appartiene comunque al mondo reale, deve cioè essere ottenuto per via empirica. Kropotkin non disdegna la ragione, anzi ad essa attribuisce un ruolo fondamentale, ma secondo il suo pensiero non è decisiva per il comportamento etico dell’uomo. L’etica di Kropotkin non è un’etica della ragione. Le motivazioni per l’agire etico, come abbiamo visto, sono infatti ulteriori sviluppi degli impulsi e delle abitudini propri degli animali sociali: la motivazione per l’agire umano è in primo luogo condizionata dalla natura, essa è cioè emozionale e impulsiva.
Kropotkin ritiene che la motivazione che sta alla base dell’agire etico dell’uomo non consista né in un sentimento innato né in un qualche vantaggio personale o generale razionalmente compreso. L’etica è un percorso, un complicato sistema di sentimenti e nozioni che si è sviluppato nella storia dell’umanità. Egli individua tre stadi di questo sviluppo: 1)la socievolezza e il mutuo appoggio, 2)la giustizia nel senso dell’uguaglianza dei diritti, 3)la generosità, la benevolenza, la rinuncia a se stesso (l’etica nel senso più stretto).
Si tratta quindi di una scala graduale dello sviluppo etico, non una costruzione arbitraria, come abbiamo visto, ma il risultato di una storia che si è svolta nel tempo, e soprattutto di una necessità organica che ha trovato in se stessa la sua giustificazione. La natura ci ha insegnato quindi qualcosa di più della semplice socievolezza. Anche elementi del secondo stadio dello sviluppo etico, quello della giustizia, sono infatti osservabili in natura. Kropotkin conferma quindi l’ipotesi di Herbert Spencer di una “giustizia preumana”. Questa nozione di giustizia si sviluppa gradualmente nel tempo (e l’evoluzione dell’eticità avviene in dipendenza dai mutamenti della vita sociale) fino ad arrivare al punto in cui solo la nozione consapevolmente acquisita dell’uguaglianza dei diritti di tutti i membri di una comunità garantisce la loro sopravvivenza. La relazione tra dignità personale e dignità umana che si viene a costituire nel corso di questo sviluppo (come già in Proudhon, la cui nozione di giustizia è valutata da Kropotkin come la più progredita, anche se egli non condivise in toto le teorie proudhoniane) porta ad un’unione armonica degli interessi comunitari con quelli individuali. Il punto estremo di arrivo è la capacità di sacrificarsi per gli altri, che Kropotkin ha visto mettere in atto con i suoi occhi nel corso della sua vita. Tutto questo è espresso nella sua etica del rivoluzionario, strettamente legata al discorso della giustizia sociale, dove l’accento è posto sulle qualità emozionali, sulla capacità di comprendere i sentimenti altrui e di immedesimarsi in questi fino in fondo.
KARL AUGUST GOTTLIEB KEIL

Karl August Gottlieb Keil (1754-1818) fu un filosofo che diede contributi decisivi per la nascita della moderna ermeneutica. Il suo pensiero si presenta, per molti versi, come una continuazione della riflessione ermeneutica avviata da Johann August Ernesti (1707-1781). Soprattutto nel suo scritto del 1818 Lehrbuch der Hermeneutik (Manuale di ermeneutica), egli andava sviluppando l’idea di una integrazione tra la “interpretazione storica” e la “interpretazione grammaticale”, alla luce del presupposto secondo cui le idee dell’autore da interpretare sarebbero un “fatto” e che, di conseguenza, la loro comprensione sarebbe in primo luogo un compito storico, indisgiungibilmente legato all’epoca in cui visse l’autore e scrisse le sue opere. Nell’orizzonte teoretico di Keil, l’interpretazione viene così delineandosi come il frutto di una sequela di operazioni differenti ma tra oro coordinate, in vista del rapporto esistente tra le differenti parole e le rappresentazioni dell’autore da interpretare. Però quel rapporto è inteso da Keil in modo spiccatamente “formalistico”, quasi meccanico, con la conseguenza – ed è questo il suo più grande limite – che gli restano oscuri due fenomeni: 1) la specificità di ogni autore (che non può mai essere interamente fatto derivare dalla sua epoca, ma che anzi conserva sempre una sua specificità personale indeducibile); 2) la congenialità tra l’autore e il suo interprete (tema che sarà invece al centro del dibattito posteriore rispetto all’opera keiliana). A parte questi due limiti, certo non secondari, resta comunque un enorme merito della riflessione di Keil l’aver posto enfaticamente l’accento sul rapporto storico che lega tra loro il testo da interpretare e il suo tempo, che si traduce in concreto nell’attenzione per la natura specifica delle idee e delle convinzioni non solamente dell’autore, ma anche dei suoi primi lettori, oltre che nel ricorso al confronto con scritti analoghi dello stesso periodo storico. Il Lehrbuch der Hermeneutik di Keil si configura, per molti versi, come un punto d’approdo nella lunga e tutt’altro che lineare vicenda evolutiva dell’ermeneutica quale si era sviluppata nel Seicento e nel Settecento, unificando in sé i diversi momenti e le principali esigenze che, nel corso dei due secoli, erano andate affiorando in Europa in seguito alla “rottura” epocale consumatasi con la Riforma protestante. Non senza buone ragioni, Dilthey ha sostenuto che l’opera di Keil giungeva troppo tardi: infatti, nel momento in cui essa vedeva la luce, nei primissimi anni del XIX secolo, avevano preso a farsi sentire, con una certa energia, nuove esigenze in ambito ermeneutica: si trattava di esigenze che venivano articolandosi grazie alle riflessioni di Ast, dei fratelli Schlegel, di Schleiermacher e, più in generale, del Romanticismo; riflessioni che avrebbero inciso in maniera profondissima sull’evoluzione della cultura europea. Stando così le cose, si può ben dire – seguendo lo spunto di Dilthey – che l’opera ermeneutica di Keil, più che inaugurare una nuova epoca, ne chiudeva una ormai in fase di tramonto.
AUGUST BOECKH

Allievo di Wolf e di Schleiermacher a Halle, August Boeckh (1785-1867) è un filosofo che ha fornito contributi molto importanti per l’ermeneutica. Essa assume, nella sua opera, il ruolo di concettualizzare le maniere in cui l’esegesi può essere svolta. Essa si configura dunque come “interpretazione filologica”, nella quale il “comprendere” (verstehen) di profila come Erkenntnis des Erkannten, ossia “riconoscimento del conosciuto”. Boeckh fu docente di filologia classica: dapprima a Heidelberg, successivamente a Berlino. Egli fu, inoltre, l’autore di una celebre edizione di Pindaro e della Staatshaushaltung der Athener (1817). Il suo lavoro teoricamente più denso e ricco di spunti è indubbiamente la Enciclopedia e metodologia delle scienze filologiche, che apparve solo nel 1877, dieci anni dopo la sua morte. È soprattutto in questo scritto che Boeckh va sviluppando l’ermeneutica a partire dalla filologia, intesa, quest’ultima, come conoscenza dell’antichità in ogni suo settore. L’ermeneutica così intesa ha, quale obiettivo, la conoscenza di tutto “ciò che è stato prodotto dallo spirito” e, sotto questo profilo, essa si configura come “conoscenza del conosciuto”. Il “conosciuto” in questione abbraccia l’insieme della cultura umana, dalla storia all’arte, dalla letteratura alla filosofia. In questo senso, per Boeckh comprendere significa – in termini platonici – riconoscere e, più precisamente, riconoscere le idee che si sono manifestate nel conosciuto. Ad avviso di Boeckh, sono quattro i tipi di interpretazione: 1) grammaticale, 2) storica, 3) individuale, 4) per generi letterari. Il senso delle parole, da un lato, e la situazione storica, dall’altro, rappresentano le condizioni oggettive della comprensione e dell’interpretazione dei testi, che vengono decifrate tramite l’interpretazione grammaticale e l’interpretazione storica. Vi sono poi le condizioni soggettive, date dal fatto che attraverso le parole, gli stilemi narrativi, i testi redatti in una certa lingua l’autore esprime le proprie specifiche idee e i propri sentimenti individuali. È qui che sorge il problema dell’interpretazione individuale: essa ha il difficile compito di interpretare i testi come espressione delle capacità creative del soggetto. Da ultimo, ogni comunicazione mira a un obiettivo, che può essere raggiunto tramite diversi tipi di discorso: da tale varietà traggono origine i generi letterari, con le loro specifiche norme e i loro principi; di essi deve dare conto l’interpretazione per generi letterari. Secondo Boeckh, a questi quattro tipi di interpretazione si accompagnano quattro tipi di critica: grammaticale, storica, individuale e per generi. Egli mira a mantenere vivo il nesso tra “interpretazione” e “critica”, poiché esso permette di porre il problema della fondatezza dei diversi generi di interpretazione: la critica infatti va in cerca di una unità di misura. L’interpretazione e la critica grammaticali rinvengono la loro unità di misura nell’impiego linguistico comune proprio dell’epoca in cui vennero scritti i testi da interpretare. Tuttavia, i singoli testi possono discostarsi dall’uso linguistico comune dell’epoca: l’interprete deve allora criticamente ricostruire il testo nella sua autenticità e nella specificità individuale propria dell’autore che l’ha composto. In modo affine, l’interpretazione storica trova un analogo nella critica storica, la quale deve secondo Boeckh vagliare la convergenza dei testi tramandati con le conoscenze storiche da noi possedute. La critica individuale, dal canto suo, si occupa dell’analisi della compatibilità tra il carattere specifico de un dato scritto e la personalità propria dell’autore che l’ha redatto. In vista di questo obiettivo, essa si serve di tutti i mezzi che già abbiamo esaminato, ossia degli elementi della critica grammaticale e di quella storica: da questo punto di vista, la critica individuale si profila come sintesi delle prime tre forme. Infine, la critica per generi letterari – la più originale di tutte – si occupa direttamente dei contenuti da interpretare, e non tanto della forma: essa guarda alla tradizione letteraria in cui si inserisce lo scritto da interpretare. A differenze delle prime tre, che erano formali, la critica per generi è sostanziale, contenutistica: essa si applica soprattutto alle opere d’arte, e la sua unità di misura, secondo Boeckh, dovrà essere quella della “verità poetica”, ossia – nei termini di Boeckh – “la coincidenza dell’immagine con l’idea artistica”. Nel caso dell’interpretazione di opere scientifiche, e non artistiche, le cose cambieranno radicalmente: qui sarà la verità come coincidenza con il reale a fare da criterio. Analogamente, un’opera storica dovrà essere misurata in base alla sua capacità di esporre i fatti come si sono effettivamente svolti. La critica per generi letterari non fu solo la più innovativa delle quattro prospettate da Boeckh: fu anche la più attaccata dai suoi contemporanei, soprattutto per la “fragilità” teorica su cui si reggeva. Tuttavia, al di là dei limiti, certo non assenti, nella posizione di Boeckh, una delle sue massime acquisizioni – destinate a incidere profondamente nel Novecento – fu l’intreccio, il nesso simbiotico tra ermeneutica e critica.
BENJAMIN CONSTANT

“Il pericolo della libertà antica era che gli uomini, attenti unicamente ad assicurarsi la partecipazione al potere sociale, vendessero a troppo poco prezzo i diritti e le soddisfazioni individuali. Il pericolo della libertà moderna è che, assorti nel godimento della nostra indipendenza privata e nel perseguire i nostri interessi privati, rinunciamo troppo facilmente al nostro diritto di partecipare al potere politico” (La libertà degli antichi comparata a quella dei moderni).
Dopo la Rivoluzione francese, alcuni pensatori ritennero che si dovesse tornare alla tradizione ad essa precedente, mentre altri la considerarono come un punto oltre il quale non si poteva tornare indietro, pur rigettandone gli esiti estremi culminanti nel Terrore giacobino, ma anche lo sviluppo autoritario impresso da Napoleone. Benjamin Constant de Rebeque (1767-1830) fu uno dei più accaniti esponenti dell’opposizione liberale a Napoleone: nato a Losanna da una famiglia protestante originaria della Francia, egli compì i suoi studi in Inghilterra e in Germania; nel 1795 ottenne la cittadinanza francese. Nel 1794 aveva conosciuto Madame de Staël (1766-1817), figlia del banchiere svizzero Necker, antico ministro delle finanze sotto Luigi XVI, alla quale Constant restò legato per quindici anni non solo in qualità di amante, ma anche in virtù di una collaborazione intellettuale e politica. Nel 1796, Constant pubblicò Sulla forza del governo attuale della Francia e sulla necessità di aderirvi, dove gli errori della rivoluzione sono criticati ma senza per ciò auspicare un ritorno alla situazione precedente. Eletto al Tribunato, Constant condusse una politica di rigida opposizione a Napoleone, primo console, finché fu costretto con Madame de Staël a prendere la via dell’esilio. Nel loro girovagare per l’Europa, i due incontrarono i grandi eroi della cultura tedesca: uno dei risultati di queste esperienze fu l’opera Sulla Germania di Madame de Staël, nella quale sono esaltati Goethe e Schiller e si dà un resoconto delle principali correnti filosofiche tedesche, oltre che dell’opposizione fra poesia classica e poesia romantica: quest’opposizione, frutto di un assai vivace dibattito in auge a quei tempi (Leopardi stesso interverrà in difesa della poesia classica), pende tutta a favore della poesia romantica, che è la suprema acquisizione di quella cultura tedesca fondata su un armonico equilibrio tra ragione e sentimento. Proprio per via di quest’esaltazione entusiastica della Germania, l’opera, già in bozze, fu sequestrata nel 1810 su ordine di Napoleone, cosicché fu pubblicata in Inghilterra e soltanto nel 1814 in Francia, dove venne considerata il manifesto del romanticismo. In quello stesso torno di anni, Constant scrisse il romanzo Adolphe, pubblicato poi nel 1816. Contro il militarismo napoleonico, egli compose Sullo spirito di conquista e di usurpazione (1814), ma durante i Cento Giorni si accostò a Napoleone, per il quale elaborò un progetto di costituzione liberale sul modello inglese, fondato sulla salvaguardia delle libertà personali. Con l’avvento di Luigi XVIII, Constant fu nuovamente costretto all’esilio, ma nel 1817 potè rientrare a Parigi e, successivamente, venne eletto al parlamento, ove si schierò tanto contro i reazionari quanto contro i democratici. In questo periodo, egli pubblicò una raccolta dei suoi più importanti saggi politici sotto il titolo Corso di politica costituzionale (1818/1820) e, a partire dal 1824, diede inizio alla pubblicazione della sua opera filosoficamente più impegnativa: Sulla religione considerata nella sua origine, nelle sue forme e nei suoi sviluppi, il cui quinto volume uscirà postumo nel 1831. Costantemente sorvegliato dalla polizia sotto Carlo X, dopo la rivoluzione del luglio 1830 fu nettamente favorevole all’avvento del regno di Luigi Filippo, che lo nominò presidente del Consiglio di Stato, ma in quello stesso anno Constant andò incontro alla morte. Il problema che anima l’intera filosofia di Constant è quello della libertà e dei suoi rapporti con il potere: naturalmente ciò è dovuto, oltre che all’indole dell’autore, anche al particolare momento storico in cui egli è vissuto. Due sono i tipi di libertà che Constant individua e distingue: da un lato, c’è la libertà tipica delle antiche democrazie dirette, nelle quali il potere era nelle mani di tutti i cittadini che partecipavano direttamente alla vita politica; dall’altro, c’è la libertà propria della società moderna, in cui tutti gli individui intendono primariamente perseguire i propri interessi e coltivare la propria sfera privata. Per usare la terminologia impiegata da Constant – e destinata a godere di grande fortuna (Hegel, Marx, ecc) -, la prima è la libertà del citoyen (cittadino), mentre la seconda è la libertà del bourgeois (borghese). La prima forma di libertà è possibile soltanto laddove lo Stato ha piccole dimensioni ed è caratterizzato dalla presenza della schiavitù, che consente ai (pochi) cittadini liberi di non lavorare e, dunque, di dedicarsi a tempo pieno alla vita politica. Tale era, ad esempio, la poliV di Atene nell’età periclea. Negli Stati moderni, caratterizzati da grandi dimensioni, ciò non è più possibile, poiché la schiavitù non è più presente. Il grande errore commesso da Rousseau e dai rivoluzionari che avevano seguito le sue dottrine sta nell’aver voluto ripristinare anacronisticamente la libertà degli antichi: è impossibile realizzare la libertà del citoyen all’interno dello Stato moderno, privo di schiavitù. Ma ciò non significa che si debba rinunciare alla libertà politica per puntare esclusivamente all’utile e alla libertà individuale: Constant non propone mai una libertà – meramente negativa – dalle ingerenze dello Stato, al fine di svolgere un’indisturbata attività economica. Si tratta invece di conferire una diversa forma alla libertà politica. In primis, poiché è di fatto impossibile la partecipazione diretta di tutti alla vita politica, sarà necessario introdurre l’istituto della rappresentanza e, in secundis, per sfuggire alla degenerazione del potere esecutivo in tirannide, sarà necessario introdurre salvaguardie istituzionali volte a garantire la libertà e i diritti individuali, dal diritto di proprietà alla libertà di pensiero e di stampa, da quella economica a quella religiosa, che sta a fondamento di tutte le altre coincide col sentimento religioso della libertà stessa. In quest’ottica, il potere è concepito non già come fine, bensì come garanzia per la libertà e per i diritti di tutti, cosicché diventa necessario evitare un’eccessiva concentrazione di esso. Ciò si ottiene attraverso la separazione dei poteri e l’attribuzione di competenze anche ai poteri municipali. L’importante è – agli occhi di Constant – evitare che l’individuo sia soffocato e che i suoi diritti siano calpestati da forme di governo dispotico.
PASSI DALLE OPERE DI CONSTANT
PENSIERO E OPPRESSIONE
Benjamin Constant afferma che quando si instaura un sistema oppressivo (il riferimento implicito è a Napoleone) la società intera ne ha un grande danno, le attività si isteriliscono e gli uomini d’ingegno si dividono in cortigiani e sovversivi:
L’uomo non ha soltanto bisogno di tranquillità, di industria, di felicità domestica, di virtú private. La natura gli ha dato anche alcune facoltà, se non piú nobili, almeno piú brillanti; e tali facoltà, piú di tutte le altre, sono minacciate dall’arbitrio, che dopo aver tentato di ridurle al suo servizio, irritato com’è dalla loro resistenza, finisce col soffocarle. “Vi sono”, dice Condillac, “due specie di barbarie: l’una precede i secoli civili, l’altra gli succede”. La prima, se la mettete a raffronto con la seconda, è uno stato desiderabile; ma soltanto verso la seconda l’arbitrio può oggi ricondurre i popoli; la cui degradazione, appunto per questo è piú rapida; giacché ciò che invilisce gli uomini non è di non avere una facoltà, ma di abdicare a lei.
Suppongo una nazione colta, arricchita dalle opere di parecchie generazioni studiose, che possegga capolavori d’ogni genere e abbia compiuto immensi progressi nel campo delle scienze e delle arti. Se l’autorità mettesse ostacoli alla manifestazione del pensiero e all’attività della mente, tale nazione potrebbe vivere per un po’ di tempo sugli antichi capitali, per cosí dire, con il sapere acquisito; ma nulla, nell’ambito delle sue idee, si rinnoverebbe; il principio riproduttore sarebbe isterilito.
[…]
Il pensiero è il principio d’ogni cosa; si applica all’industria, all’arte militare, a tutte le scienze, a tutte le arti; produce il progresso, e poi, analizzando tale progresso, allarga il proprio orizzonte. Se l’arbitrio vuole limitarlo, la moralità verrà ad essere meno sana, le cognizioni di fatto meno esatte, meno attive le scienze nel loro sviluppo, meno progredita l’arte militare, meno ricca di scoperte l’industria.
L’esistenza umana, aggredita nelle sue parti piú nobili, non tarda a sentire il veleno sin nelle parti piú lontane. Credete di averla soltanto limitata in una qualche libertà superflua, o diminuita di una qualche pompa inutile, e, invece, la vostra arma avvelenata l’ha ferita al cuore. Spesso, lo so, ci parlano di una presunta parabola che la mente umana percorre e che, dicono, riporta, per una inevitabile fatalità, l’ignoranza dopo il sapere, la barbarie dopo la civiltà. Malauguratamente per questo sistema, il dispotismo si è sempre introdotto tra l’una e l’altra di tali epoche; cosicché è difficile non accusarlo di contribuire in parte a codesta rivoluzione.
La vera causa di queste vicissitudini che si producono nella storia dei popoli è che l’intelligenza dell’uomo non può rimanere stazionaria: se non la fermate, avanza; se la fermate, indietreggia; se la scoraggiate riguardo alle sue possibilità, solo debolmente opererà ormai su ogni oggetto. È come se, indignata di vedersi esclusa dalla sfera che le è propria, volesse vendicarsi, con un nobile suicidio, dell’umiliazione che le. viene inflitta.
[…]
Aggiungiamo ora un’ultima considerazione, non priva d’importanza. L’arbitrio nel colpire il pensiero, ha chiuso all’ingegno la carriera sua piú bella; ma non può impedire che uomini d’ingegno vengano al mondo. Bisognerà pure che la loro attività si eserciti. Che cosa succederà, allora? Che si divideranno in due categorie: gli uni, fedeli al destino originario, avverseranno l’autorità; gli altri si precipiteranno nell’egoismo e asserviranno le proprie facoltà superiori all’accumulazione di tutti i mezzi atti a procurar piaceri, unico compenso che gli sia stato lasciato. In tal modo il dispotismo avrà diviso in due parti gli uomini d’ingegno. Gli uni saranno sediziosi, gli altri corrotti: verranno puniti, ma per un reato inevitabile. Se la loro ambizione avesse trovato campo libero per le sue speranze e i suoi onorevoli sforzi, gli uni sarebbero ancora pacifici e gli altri ancora virtuosi. La strada colpevole l’hanno cercata solamente dopo essere stati respinti dalle strade naturali che avevano il diritto di percorrere: e dico che ne avevano il diritto perché il lustro, la fama, la gloria appartengono alla specie umana: nessuno può legittimamente sottrarli ai suoi pari e fare appassir la vita privandola di ciò che la rende splendente.
[B.-H. Constant, de Constant, Dello spirito di conquista e dell’usurpazione]
LA PROPRIETA’ COME CONDIZIONE PER LA CITTADINANZA
“Nessun popolo ha considerato come membri dello Stato tutti gli individui che risiedano[…] sul proprio territorio. Non si tratta qui delle distinzioni che, presso gli antichi, separavano gli schiavi dagli uomini liberi, e che, presso i moderni, separavano i nobili dai plebei. […]Non voglio fare alcun torto alla classe laboriosa. Questa classe ha un patriottismo non minore delle altre classi. Spesso è pronta ai sacrifici più eroici, e la sua dedizione è tanto più ammirevole in quanto non è ricompensata né dalla fortuna né dalla gloria. Ma altro è, io credo, il patriottismo che dà il coraggio di morire per il proprio paese, e altro quello che rende capaci di conoscer bene i propri interessi. Occorre dunque un’altra condizione, oltre alla nascita e all’età prescritta dalla legge. Questa condizione è il tempo indispensabile all’acquisizione della cultura e di un retto giudizio. Soltanto la proprietà garantisce questa disposizione: soltanto la proprietà rende gli uomini capaci di esercitare i diritti politici”.
[B. Constant, Princìpi di politica]
LA PERFETTIBILITA’ DEL GENERE UMANO
“Solo il perfezionamento progressivo della nostra specie stabilisce dei legami sicuri fra le generazioni. Esse si arricchiscono senza conoscersi, e questa idea consolante è così congeniale all’uomo, che ognuna delle generazioni quaggiù di passaggio attende e trova la sua ricompensa nella stima delle generazioni lontane che un giorno calpesteranno le sue ceneri insensibili. In questo sistema le conoscenze umane formano una massa eterna alla quale ogni individuo porta il suo contributo particolare,[…].Così, l’amico della libertà e della giustizia lascia ai secoli futuri la parte più preziosa di se stesso la mette al riparo di disprezzo dell’ignoranza e dalla minaccia dell’oppressione; la depone in un santuario cui non potranno mai avvicinarsi le passioni degradanti o feroci.[…] Io mi propongo dunque di cercare se esiste nell’uomo una tendenza al perfezionamento, qual è la causa di questa tendenza, qual è la sua natura, se ha dei limiti o se è illimitata e infine quali ostacoli ritardano o contrastano le sue manifestazioni”.
[Benjamin Constant, La perfettibilità del genere umano]
AUGUSTE COMTE

Nato nel 1798 a Montpellier (Francia) da famiglia cattolica e monarchica, Auguste Comte frequentò la scuola politecnica di Parigi, il che incise vivamente sulla sua formazione filosofica. Al centro della sua filosofia, infatti, vi è la matematica e la convinzione che l’unica vera forma di sapere sia la scienza. La sua non fu una vita facile: le sue idee, quand’egli era ancora in vita (morì a Parigi nel 1857), non riscossero alcun successo e tutti i suoi tentativi di entrare pienamente nella vita accademica fallirono miseramente; questi continui insuccessi, uniti al fallimento amoroso, stanno probabilmente alla base dello squilibrio psichico che lo tormentò per il resto della sua vita. In particolare, nell’ultima fase del suo pensiero, vi saranno parecchi elementi che riveleranno la sua instabile condizione mentale: primo fra tutti, il tentativo di elaborare una vera e propria “religione positiva”, una sorta di istituzionalizzazione del sapere scientifico come sapere religioso; la scienza non solo sostituirà la religione come fede, ma, addirittura, vi sarà una Chiesa della scienza, con il suo stuolo di funzionari e di santi. Tuttavia questa evidente degenerazione non è solo alimentata dagli squilibri mentali che perseguitarono Comte per tutta la vita, bensì affonda, in qualche modo, le sue radici nella sua stessa concezione filosofica, basata su una fiducia ingenua ed acritica nei confronti della scienza e, più in generale, dei dati di fatto. E del resto, l’ultimo Comte rispecchia le posizioni di degenerazione fideistica della scienza che per davvero si sono realizzate: nella società moderna, di cui Comte è profeta, vi è in qualche misura un atteggiamento fideistico verso la scienza, cosicchè il pensatore francese ha lucidamente anticipato ciò che, successivamente, è diventato un modo di pensare comune. Egli ha sempre ammirato la Chiesa cattolica non per i suoi contenuti (che egli rifiuta, in nome del sapere scientifico), ma per l’organizzazione che dà alla società: si tratta pertanto, dice l’ultimo Comte, di sostituire ai dogmi del cristianesimo quelli scientifici, mantenendo però le istituzioni tipiche della Chiesa cattolica. Detto questo, il primo Comte ha un atteggiamento meno estremistico, ma pur sempre risoluto: egli getta le basi teoriche di quel movimento passato alla storia col nome di “Positivismo”. Al termine “positivo” (desunto dall’amico Saint-Simon) egli dedica il Discorso sullo spirito positivo (1844) : 1) positivo è anzitutto ciò che è reale, effettivo, sperimentale, in opposizione a ciò che è astratto, chimerico, metafisico; 2) positivo è anche ciò che appare fecondo, pratico, efficace, in opposizione a ciò che è inutile ed ozioso; 3) positivo è ciò che è preciso e non-vago; 4) positivo è ciò che dà certezze e si basa sul dato di fatto 5) positivo è contrapposto a negativo, ovvero non distrugge, bensì organizza la società. In Corso di filosofia positiva (1830) egli elabora la famosa legge dei ” tre stati “: come si può notare, neanche Comte (che pure si oppone ad Hegel per la ricerca di un’estrema concretezza e per l’accettazione del dato di fatto, nonchè della scienza) riesce a sfuggire alle influenze della triade hegeliana, ma anzi, conserva la convinzione (tipicamente hegeliana) che il terzo momento sia la sintesi dei primi due o, se preferiamo, un riproponimento del primo ad un livello superiore perchè passato per la “negazione”. Molto hegeliano è anche il fatto che i “tre stati” in questione sono, un pò come quelli della Fenomenologia dello spirito , stati della storia dell’umanità che ciascuno di noi è tenuto a ripercorrere nella propria vita; si tratta di stati della storia dell’umanità sotto un triplice aspetto, dello sviluppo scientifico, ma tendenti a corrispondere a stati delle forme organizzative-politiche-sociali della società e a corrispondere pure all’evoluzione individuale dei singoli individui. I tre stati sono, rispettivamente, lo stato teologico, quello metafisico e, infine, quello positivo. Nel primo stato, quello teologico, l’uomo si chiede il perchè dei fenomeni a cui assiste e prova a rispondere facendo ricorso a realtà sovrasensibili, approdando alla teologia: sicchè, quando vedrà la pioggia, risponderà che essa è causata da Zeus. Il secondo stato è metafisico: l’uomo si pone le stesse domande che si poneva nello stato teologico, ma formula una diversa risposta, non ricorrendo più a cause che trascendano la dimensione naturale, bensì facendo ricorso a cause immanenti. Si tratta dell’epoca (il cui eroe è Aristotele) in cui la causa dei fenomeni viene cercata nell’essenza e nella forma: alla domanda “come cresce l’albero?”, non si risponde più dicendo che c’è un Dio che provvede a ciò, ma, viceversa, si dice che vi è la forma dell’albero che ha in sè tutte le strutture che lo fanno sviluppare. Entrambe le fasi tentano di spiegare i fenomeni, ma diversa è la causa a cui pervengono, con il rischio, peraltro (ed è questo che fa scattare il passaggio al terzo stato, del positivismo) di rispondere ai perchè con delle tautologie. Infatti, per spiegare che cosa produca la digestione, si finisce per fare riferimento alle qualità digestive insite nell’uomo, ovvero si pronuncia in una nuova forma ciò che era già detto in maniera analoga nella domanda. Il terzo ed ultimo stato è quello positivo-scientifico, caratterizzato dalla rinucia al chiedersi i “perchè” e il “cosa” dei fenomeni (perchè avvengono? cosa è x?), ovvero rinunciando alle domande tipiche della religione e della metafisica: se in Aristotele (ma anche nella teologia, seppur diverse erano le risposte), i due concetti chiave erano quelli di sostanza e di causa, con cui si risponde alle domande “che cosa è x?” e “perchè si verifica x?”, nello stato positivo cambia la domanda, poichè si arriva a capirne l’inutilità (si può infatti solo rispondere in maniera tautologica alla domanda “cosa è x?” o “perchè avviene x?”). La nuova domanda a cui si è tenuti a rispondere nello stato positivo è “come avviene x?”, il che altro non è se non una riformulazione di quelle tesi proposte a suo tempo da Galileo: non mi interesso, aveva detto Galileo due secoli addietro, di cosa sia la forza di gravità e del perchè ci sia (e non me ne interesso proprio perchè non ho le possibilità di rispondere in maniera rigorosa), ma, al contrario, mi occupo di come essa funzioni. Di fronte alla caduta di un grave, non ci si deve chiedere che cosa è o perchè accade, ma come accade, ravvisando in tale avvenimento una legge matematica. La rinuncia alle domande della metafisica e della religione è dovuta al fatto che si tratta di domande a cui non si può rispondere in modo assolutamente certo, ma solo “chimerico” e “vago”; al contrario, come avvenga un determinato fenomeno è constatabile in modo rigoroso e, pertanto, ne nasce una conoscenza utile, poichè praticamente applicabile e dunque potenzialmente utile. Si può notare come in ciascuno dei tre stati vi sia una progressiva unificazione: si passa da una pluralità di princìpi ad una diminuzione graduale dei medesimi; e così le religioni nascono come politeistiche e, a mano a mano, diventano monoteistiche. Allo stesso modo, la metafisica consiste dapprima di una miriade di forme e poi giunge al concetto generalissimo di natura (sintesi di tutti i princìpi metafisici); anche la fisica segue un percorso analogo: cerca di ricondurre il maggior numero possibile di fenomeni al minor numero possibile di leggi. Non a caso, la grande intuizione di Newton è appunto quella di aver saputo unificare le leggi elaborate da Keplero e quelle elaborate da Galileo in una sola legge, la gravitazione universale. La legge dei tre stati, come abbiam detto, corrisponde a ciò che effettivamente è avvenuto nella storia: ai tempi degli antichi greci regnava la religione, poi con il cristianesimo è invalsa la metafisica e infine, con Comte, è stata spodestata dalla scienza positivistica. Tuttavia, oltre ad essere un processo avvenuto nella storia dell’umanità, la legge dei tre stati è anche un itinerario che ciascuno di noi percorre dentro di sè: da bambini, quando si è più creduloni, si tende a spiegare ogni fenomeno ricorrendo ad un Dio; man mano che si cresce, la religione è sostituita dalla metafisica, ed infine, divenuti adulti, la scienza ha la meglio. Essa ha anche, secondo Comte, una valenza politica e sociale: hegelianamente, la fase metafisica (antitesi) ha negato le certezze della fase religiosa (tesi), e il compito della fase positiva consiste nel riproporre la tesi ad un livello superiore, ovvero di creare una nuova fase organica quale era quella della religione dei Greci. Tutte le scienze esistenti, sostiene Comte, sono passate per i tre stati poc’anzi delineati, ma non tutte sono arrivate con la stessa rapidità: ci sono state scienze che sono arrivate prima e altre che sono arrivate dopo, e in virtù di questa diversità nei tempi d’arrivo esse vengono da Comte classificate secondo un ordine che è al contempo di complessità crescente e di generalità decrescente. Infatti, sul piano logico, meno fattori si considerano nel tratteggiare un concetto e più il concetto, per così dire, si allarga: il concetto di uomo, ad esempio, è più complesso del concetto di animale, proprio perchè implica il concetto di animale più qualcos’altro; ma il fatto che sia più complesso comporta che sia anche più ristretto (ovvero racchiude un minor numero di casi), poichè tutti gli uomini sono animali ma non tutti gli animali sono uomini. I concetti studiati dalla matematica sono, nel loro insieme, molto semplici, dice Comte, in quanto tale scienza si limita ad analizzare la quantità allo stato puro, senza porsi problemi più specifici. Quando esamina un libro, la matematica lo considera per il puro e semplice fatto di essere un parallelepipedo e nulla più; allo stesso modo, può studiare una persona solo come altezza, senza chiedersi se abbia un peso (come fa invece la fisica), una fisiologia (come fa invece la biologia), o un ruolo (come fa invece la sociologia). Emerge dunque la convinzione comteiana secondo la quale la matematica è una scienza semplice, poichè lavora su un solo concetto (la quantità) e proprio per questo è applicabile ad ogni realtà; e per la sua applicabilità ad ogni realtà, Comte è più propenso a considerarla una sorta di logica della conoscenza scientifica piuttosto che una scienza. In altri termini, la matematica svolge per Comte le stesse mansioni che la logica svolgeva per Aristotele. Nella sua classificazione delle scienze, il pensatore francese asserisce che ad ogni gradino successivo alla matematica si inserisce un nuovo elemento che deve essere opportunamente indagato: ne consegue che man mano che si sale la scala, le scienze diventano sempre più complesse (perchè studiano sempre più caratteristiche) e per ciò meno generali. La fisica, ad esempio, è meno generale rispetto alla matematica, perchè proietta la propria indagine su un maggior numero di caratteristiche (oltre alla quantità matematica, si interessa anche del peso e di mille altre cose) e in virtù di ciò è meno generale. Allo stesso modo, la chimica è più complessa della fisica ma è meno generale e la biologia è più complessa della chimica ma meno generale. Giunti al vertice della scala, troviamo la scienza che è la più complessa di tutte, ma anche la meno generale: si tratta di quella che Comte definisce, con un neologismo da lui coniato, “sociologia”; è un neologismo peraltro piuttosto bizzarro, visto che in esso troviamo una commistione di latino ( societas ) e di greco (logoV ). Tuttavia, come abbiamo accennato, le diverse scienze appena menzionate (1 astronomia, 2 fisica, 3 chimica, 4 biologia, 5 sociologia) non fanno il loro ingresso nello stato positivo (dopo aver percorso i precedenti due) tutte insieme, nel medesimo momento: seguono un ordine ben preciso, in cui a terminare per prime l’itinerario sono le scienze più semplici e generali. Storicamente, è giunta per prima al traguardo la matematica, poi l’astronomia (intesa da Comte come una sorta di fisica generalissima), poi la fisica, poi la chimica, poi la biologia e, infine, la sociologia; e in effetti la storia dà ragione a Comte. Infatti, la matematica come scienza ha trovato una sua prima formulazione al tempo degli antichi Greci, anche se non ancora del tutto depurata dai residui delle due tappe precedenti: ne sono l’emblema i Pitagorici, i quali (come attesta Aristotele) hanno realizzato grandi scoperte scientifiche, attribuendo però ad esse valori sacri e sostenendo (metafisicamente) che il numero fosse il principio dell’intera realtà. Dopo la matematica, è stato il turno dell’astronomia, divenuta anch’essa scienza ai tempi dei Greci: proprio come la matematica, però, anch’essa a quei tempi era carica di incrostazioni religiose e metafisiche (tant’è che sfumava nell’astrologia). In modo analogo, la fisica è uscita dai due stati religioso e metafisico per passare a quello positivo: questo è avvenuto nel Seicento, l’epoca della Rivoluzione Scientifica. La chimica, dal canto suo, ha ricevuto, con Lavoisier, nel Settecento la sua prima e matura formulazione in termini scientifici (depurandosi dai residui magici che l’avevano caratterizzata nei secoli precedenti), quando, ad esempio, si è cessato di intendere il fuoco come elemento e lo si è finalmente considerato in modo corretto come processo. Stessa sorte è toccata, nell’Ottocento, alla biologia e, infine, Comte riserva a se stesso il compito di far passare allo stato positivo quella scienza che lui stesso battezza “sociologia”, la più complessa e meno generale di tutte. A questo proposito si può osservare una cosa interessante: vi sono discipline a cui noi siamo soliti dare una collocazione conoscitiva molto diversa rispetto a quella che invece tributa loro Comte; ad esempio, diversamente da come siamo avvezzi a fare noi, Comte pone al gradino più basso la matematica e non considera affatto la psicologia come scienza. Altra curiosità è il fatto che, diversamente da come ci si potrebbe aspettare, Comte non è un riduzionista, ovvero non riconduce ad una sola scienza tutte le altre, come aveva invece fatto, due secoli addietro, Hobbes, ad avviso del quale, conoscendo le leggi della materia, allora è possibile spiegare con esse l’intero mondo vivente, umano e politico. Per Comte, è senz’altro vero che non si può costruire una scienza più complessa senza conoscere quella più semplice che la fonda, ma tuttavia sarebbe scorretto ricondurla in tutto e per tutto ad essa: per individuare le leggi della biologia, ad esempio, non potrò prescindere da quelle fisiche, dice Comte, ma non per questo si possono dedurre le une dalle altre. In altri termini, ogni scienza si appoggia a quella ad essa precedente (più semplice e più generale), ma non si riconduce in tutto e per tutto ad essa: questo atteggiamento risulta particolarmente rilevante perchè consente a Comte di garantire l’autonomia delle scienze, cosicchè un fisico, ad esempio, non potrà mai essere in grado di spiegare il mondo sociologico. Molto interessante è anche il rifiuto della psicologia come scienza: la scienza dell’uomo fondata da Comte non corrisponde minimamente a quella che siamo soliti definire “psicologia”, poichè, fa notare il filosofo francese, studiare la psiche di una persona in modo rigoroso è un’illusione, visto che, secondo i dogmi del Positivismo, è impossibile avere conoscenza rigorosa di un qualcosa che non implica dati di fatto e che non è consultabile in prima persona (non è infatti possibile “entrare” nelle menti altrui). Non potendo studiare rigorosamente la psiche degli altri, tuttavia, se ne può studiare il comportamento e questo studio è appunto la sociologia. Ne consegue che per Comte la scienza dell’uomo è non già la psicologia, bensì la sociologia; però, si potrebbe obiettare, che, nell’impossibilità di studiare rigorosamente la psiche altrui perchè è impossibile penetrarne la mente, si potrebbe studiare la propria psiche, superando l’ostacolo. Ma Comte non è d’accordo: la scienza, infatti, ha per oggetto ciò che è rigoroso, ma anche ciò che è oggettivo, e se lo studio della propria psiche può essere rigoroso, ciononostante, non può essere oggettivo e distaccato. Curioso è il fatto che, a cavvallo tra l’Ottocento e il Novecento, si sia sviluppata sulla base delle considerazioni di Comte la “psicologia comportamentalista”, caratterizzata dal rifiuto dello studio della psiche e dalla convinzione che si debbano invece studiare le reazioni agli stimoli. Fatta questa lunga carrellata di scienze, resta da chiedersi quale posto occupi per il filosofo francese la filosofia: avendo vivamente sostenuto che all’infuori della scienza non vi è vera conoscenza, pare che egli sia costretto dal suo stesso pensiero a sancire il rifiuto della filosofia in quanto sapere non scientifico. Il Positivismo in generale, sotto questo profilo, è una filosofia, per così dire, suicida, giacchè, nel proclamare la scienza unica forma di sapere, non fa altro che delegittimare il sapere filosofico. In realtà, quasi tutti i Positivisti, chi più e chi meno, riconoscono qualche campo di indagine alla disciplina filosofica (campo che varia da pensatore a pensatore), anche se, generalmente, si tratta di un margine piuttosto ristretto e subordinato alla scienza, di cui finisce per essere un completamento. Gli atteggiamenti adottati in merito dai Positivisti, sebbene piuttosto variegati, possono essere considerati tre. Il primo è quello proposto da Comte, secondo cui la filosofia altro non è se non una classificazione e una storia della scienza (ed è proprio ciò che egli fa nei suoi scritti), con l’inevitabile conseguenza che la filosofia si riduce ad epistemologia (studio della scienza e riflessione su di essa). E’ una concezione piuttosto riduttiva della filosofia, ma tuttavia si mantiene nell’alveo della tradizione platonico-aristotelica: ad esempio, se la matematica lavora coi numeri, spetta alla filosofia indagare sulla loro essenza. Del secondo atteggiamento è vessillifero John Stuart Mill: si tratta di un atteggiamento abbastanza simile a quello di Comte, ma comunque caratterizzato da una maggiore attenzione per i problemi logico-metodologici: la filosofia viene cioè ridotta a pura logica e metodologia, ovvero è tenuta a riflettere sui metodi e sulla logica dell’opera scientifica (e non è un caso che la principale opera di Mill si intitoli Logica ). Il terzo ed ultimo atteggiamento, proposto da Spencer, è quello che più di tutti dà peso alla filosofia, ma che tende anche di più a ridurla a scienza: in definitiva, per Spencer e per gli altri Positivisti che la pensano come lui, la filosofia è una specie di super-scienza; ciascuno di noi, infatti, ha le sue esperienze quotidiane e tende a generalizzarle per trarne delle regole di comportamento (e la scienza fa la stessa cosa, in maniera sistematica, per quel che riguarda la natura), ma poi, al di là delle leggi relativamente generali, è possibile individuare leggi generalissime che non valgono per un campo della realtà piuttosto che per un altro, ma, viceversa, valgono per tutta quanta la realtà. Proprio di queste leggi generalissime, valide per l’intera realtà, si occupa la filosofia. E proprio in virtù di questa concezione, Spencer e quelli del suo seguito tendono ad essere riduzionisti, ovvero a nutrire la convinzione che tutte le scienze siano riconducibili ad una sola scienza, la filosofia. Sono riduzionisti, in altre parole, perchè nutrono la convinzione che vi siano leggi generalissime valide per ogni realtà di cui le leggi studiate dalla scienza sono derivazioni particolari, come se, in ultima istanza, tutte le scienze fossero derivazioni particolari della super-scienza filosofia. La filosofia come la intendono questi pensatori , pertanto, svetta tra tutti i saperi, ma, qualitativamente, non è diversa dalle altre scienze. Il pensiero di Comte, dal canto suo, può talvolta sembrare un pò ingenuo per via di quell’esasperata fiducia nelle scienze che lo alimenta, e tuttavia presenta delle problematicità molto acute e profonde (il non-riduzionismo, ad esempio); tra le tante, merita di essere ricordata la convinzione secondo la quale il pragmatismo, per essere valido, non deve essere troppo rigido; come aveva mostrato Bacone, se l’uomo si fosse sempre e soltanto posto il problema di indagare solamente su ciò che gli occorreva al momento, il progresso sarebbe stato incommensurabilmente più lento di quel che è stato. Invece, si son fatti grandi progressi grazie al fatto che si sono realizzate conoscenze inutili al momento ma di fondamentale importanza in epoche successive, conoscenze che hanno fatto procere con grande celerità il progresso. Meglio gli esperimenti che gettan luce piuttosto che quelli che danno frutti immediati, diceva Bacone, e Comte concorda pienamente. Dobbiamo ora analizzare a fondo quella che Comte considera la sua grande scoperta: la sociologia . Essa si colloca al vertice della scala delle scienze in quanto è la più complessa e meno generale e perchè si occupa niente poco di meno che dell’uomo; tuttavia essa è anche alla base della scala, giacchè le scienze, secondo Comte, devono avere una valenza utilitaristica, devono cioè fornire indicazioni pratiche, e sotto questo profilo è la sociologia a permettere la piena affermazione dello spirito scientifico. Infatti, solo la sociologia può dare le indicazioni adeguate per governare la società in modo tecnocratico (come già aveva prospettato Bacone). La sociologia, pertanto, è al vertice della scala, ma, nella misura in cui influenza le altre scienze, ne è anche alla base. Non è un caso che il giovane Comte fu segretario di quel Saint Simon (etichettato da Marx come “socialista utopista”) che aveva teorizzato l’idea di una società governata dagli “industriali” (imprenditori + operai), di cui l’industria fosse il fulcro; Comte è molto influenzato da queste idee e lo si evince benissimo dalla stessa sua convinzione che la storia si articoli in fasi transitorie (la metafisica) in cui si distruggono gli assetti antichi e in fasi organiche in cui tali assetti vengono ripristinati ad un livello superiore. Naturalmente, si può osservare, questa particolare attenzione per l’organicità (che con il Positivismo dovrebbe toccare l’apice, dice Comte) lo inquadra a pieno titolo nell’età romantica. Egli studia la società avvalendosi di concetti desunti dall’ambito fisico, senza però considerare (come invece aveva fatto Hobbes) la società una derivazione della fisica: i due concetti basilari su cui fonda la sua indagine sono la statica e la dinamica. In qualche modo, dice il pensatore francese, è possibile ravvisare una specie di dinamica e di statica non solo nella fisica, ma perfino nella società: qualsiasi società, infatti, è caratterizzata da alcune funzioni statiche e permanenti, alle quali non può rinunciare; man mano che la società cambia, muta anche la fisionomia (e non l’essenza) di tali funzioni, quasi come se si nascondessero dietro maschere diverse. Proprio in questo mutamento per cui cambia la fisionomia ma non l’essenza consiste la dinamica sociale: ogni società, dunque, necessita di credenze di fondo, statiche nell’essenza ma mutevoli nella fisionomia, intorno alle quali ruota la società stessa e trova i suoi valori; oltre alle convinzioni, la società ha anche bisogno di custodi in grado di salvaguardare le medesime. Esempio classico che si può addurre è quello della società medioevale e della sua fede cattolica come grande credenza diffusa presso tutti e tesaurizzata nonchè custodita nella Chiesa; questo stesso meccanismo lo si avrà, dice Comte, anche nella società positiva, in cui restano le credenze di fondo, ma mutano radicalmente fisionomia (alle verità rivelate subentrano quelle scientifiche), il cristianesimo cede il passo allo scientismo. E i custodi delle nuove verità positivistiche diventano gli scienziati, i quali rappresentano il nuovo clero. Se prescindiamo da questa stranezza (che trova il culmine nell’idea di Comte di un papa della scienza), che gli scienziati siano sempre più diventati i custodi del sapere è un dato di fatto, soprattutto negli anni in cui vive Comte. Se statico è il fatto che vi siano verità e custodi addetti alla loro cura, dinamico è invece il fatto che da valori medioevali si passi a valori scientifici. Nella statica, osserva Comte, rientra anche la suddivisione tra potere spirituale del papa e potere temporale dell’imperatore: e questo sarà anche vero nella società positivistica, egli sostiene, dove i detentori del potere spirituale saranno gli scienziati, mentre i custodi di quello temporale saranno gli industriali; e così avremo uno scienziato per papa e un industriale per imperatore. Comte non ha affatto in mente una società retta da politici, ma, viceversa, da industriali imbevuti di scientismo. Per dimostrare che gli scienziati costituiranno il nuovo clero, Comte si serve di una terminologia piuttosto efficace: nella lingua francese, egli fa notare, la parola “cler” significa nello stesso tempo “uomo di Chiesa” e “intellettuale” e proprio su questa polisemia egli costruisce la propria filosofia, convinto che gli intellettuali siano i preti di ogni società, ovvero i custodi privilegiati del sapere dell’epoca. Una domanda che sorge spontanea è se la politica scientista di Comte sia progressista o conservatrice: che egli simpatizzasse per il mondo conservatore lo testimonia il suo amore per l’impero di Napoleone III, che però non si risolve solo come un amore meramente conservatore; infatti, dobbiamo tenere a mente che fu Napoleone III a creare in Francia le condizioni ottimali per quello sviluppo industriale tanto caro a Comte. In altri termini, non sarebbe scorretto dire che il filosofo francese è conservatore sul piano politico, ma progressista su quello scientifico. In questo si ditingue sia da chi in quegli anni è progressista su tutti e due i piani (i Marxisti) sia da chi è conservatore su tutti e due i piani (il Cattolicesimo). Anzi, si può affermare che per Comte i due aspetti si richiamano a vicenda: solo lo sviluppo scientifico garantisce una società statica e solo una società statica garantisce lo sviluppo scientifico.
PIERRE-SIMON DE LAPLACE

“Dio è un’ipotesi di cui non ho bisogno”.
A cura di Guido Marenco
Introduzione
Pierre Simon de Laplace (1749-1827) in Esposizione del sistema del mondo (1796) elaborò, parallelamente a Kant, l’ipotesi dell’origine del sistema solare a partire da una nebulosa primitiva; alla base della sua cosmologia, basata sulla non-necessità di ricorrere all’ipotesi di un Dio che intervenga nel mondo, vi è una concezione rigidamente meccanicistica, secondo la quale ogni stato o evento dell’universo è conseguenza di stati ed eventi precedenti e, a sua volta, causa di quelli successivi; sicchè, se si conoscesse lo stato di materia nell’universo in un dato momento, si potrebbero ricostruire meccanicamente tutti i momenti successivi e precedenti della materia. Ma Laplace è anche stato il fondatore moderno del calcolo probabilistico, il che sembrerebbe una contraddizione: come è possibile che, dopo aver sostenuto che tutto procede secondo il più rigido meccanicismo, egli ripieghi (in Teoria analitica delle probabilità , del 1812) su un calcolo basato non sulla certezza ma sulla probabilità? Tutto si spiega se teniamo presente che il meccanicismo e la conoscenza impeccabile che ne dovrebbe derivare funzionerebbe solo se fossimo dotati di una mente super-potente in grado di raccogliere e contenere tutti i dati possibili sullo stato della materia; ed è in assenza di questo strumento che bisogna accontentarsi non di verità inconfutabili, ma di probabilità. In altri termini, la necessità di formulare previsioni probabili dipende esclusivamente dall’ignoranza dei dati necessari per una previsione certa. Molto diverso sarà l’atteggiamento che assumerà su queste questioni il fisico novecentesco Heisenberg, il quale elaborò il “principio di indeterminazione”: esso prescrive che non si può calcolare contemporaneamente con precisione sia la posizione sia lo stato di movimento di una data particella. Ne consegue che se per Laplace tutto avviene in maniera rigorosamente meccanicistica ma si deve ricorrere al calcolo probabilistico perché non si hanno a disposizione strumenti adatti, per Heisenberg, invece, è assolutamente impossibile determinare insieme i due stati (posizione e movimento), indipendentemente dalle nostre facoltà. E Laplace, con la sua esasperata fiducia nel determinismo e nella scienza, rappresenta il modello positivistico e la formulazione più compiuta del meccanicismo come forma di conoscenza certa; è da queste considerazioni di carattere scientifico che muove i suoi passi il Positivismo, così battezzato da Comte (anche se il termine fu per la prima volta impiegato da Saint-Simon nel Catechismo degli industriali, del 1822).
L’importanza di Laplace come fisico e come filosofo della scienza
Pierre-Simon de Laplace nacque nel 1746, da genitori che erano modesti agricoltori, a Beumont-en-Auge. A 22 anni giunse a Parigi e venne in contatto con gli ambienti scientifici e gli enciclopedisti. L’appoggio di D’Alambert fu fondamentale per i suoi studi ed un immediato inserimento nella società culturale parigina. La sua educazione era avvenuta in un’Accademia militare, in un clima di ferrea disciplina formale e mentale, arido sotto il profilo sentimentale, ma nemmeno troppo stimolante sotto il profilo intellettuale. Laplace dovette metterci molto di sè; era già nato con molti handicap sociali, e se la vita fosse simile ad una corsa di cavalli, si potrebbe dire che, pur essendosi trovato subito lontano dalla pole position, ebbe una partenza bruciante. L’importanza di Laplace nella storia della scienza e del pensiero filosofico è strettamente legata al fatto che egli sia diventato il determinista per antonomasia, ovvero il sostenitore del carattere di prevedibilità che deve avere la teoria scientifica, perchè essa enuncia leggi che corrispondono ad un comportamento necessario degli oggetti fisici. In sostanza, esiste un ben preciso ambito, non solo del ragionamento, ma anche della realtà, nel quale non solo è ultragiustificato l’atteggiamento determinista, ma sarebbe del tutto illogico predicare l’opposto, ovvero un indetermismo secondo il quale è possibile che l’acqua posta in un recipiente sul fuoco non bolla, a meno che non si verifichino eventi che impediscono il normale corso delle cose. Le macchine costruite dall’uomo secondo ben noti principi fisici e e meccanici devono funzionare, ed anche i guasti dovuti all’usura o ad un difetto di costruzione, sono prevedibili. In medicina pratica è, del resto, altamente improbabile che una ferita non si rimargini, o che un raffreddore ed un’influenza non passino da sè, solo con il caldo ed il riposo. Questa convinzione era già alla base della natura vis medicatrix della medicina ippocratica, prima che Galeno rivoluzionasse tutto il sistema con la teorizzazione dell’indispensabilità dei farmaci. Ma anche il farmaco è di per sè legato ad una speranza determinista; a ben vedere è ancora più determinista della natura vis medicatrix. Non vi dovrebbe essere alcun dubbio, pertanto, che progresso scientifico e atteggiamento determinista siano fratelli gemelli almeno fino al XX secolo compreso. Il merito indubbio di Laplace fu quello di estendere l’atteggiamento determinista, in ambito fisico, ad aspetti della realtà non sufficientemente toccati dall’esperienza comune. Laplace fu sempre convinto che la legge di gravitazione universale scoperta da Newton non solo spiegava la struttura dell’universo, ma arrivava a spiegare il motivo per cui gli oggetti fisici, per così dire, stavano insieme e parevano animati da una ferrea coesione materiale. Al livello delle strutture molecolari costituenti la materia, si aveva un corrispondente della legge di gravitazione, ovvero una legge di attrazione tra le molecole. L’altro evento che lo rese famoso fu quello della formalizzazione della teoria della formazione del sistema solare da una nebulosa originaria (teoria a cui giunse anche Kant), mentre, in ambito matematico, ma in funzione della teoria fisica, egli introdusse metodi dotati di grande potenza di calcolo, quali la trasformazione di Laplace, ovvero l’equazione di Laplace, e l’abbozzo del calcolo delle probabilità, ovvero un tentativo di passare dal più disarmante indeterminismo su questioni ripetto alle quali, prima, non si poteva che ammettere l’impossibilità di prevedere, ad un atteggiamento di relativa capacità di prevedere. Recentemente, Bernard Bru, docente all’Université René Descartes, in una memoria intitolata Laplace probabilista, pubblicata nei Quaderni de Le Scienze, n 98, ottobre 1997, ha reinquadrato con grande lucidità la questione probabilismo di Laplace e conviene dare un’occhiata allo scritto. «La Natura non si sbaglia mai; essa non gioca, non sceglie. Essa fissa la successione “necessaria” degli avvenimenti, per quanto piccoli siano. Il fine precipuo della scienza consiste nel precisare questa determinazione sottomettendola al calcolo, e solo l’analisi (determinista) può contribuire a ciò. Attenendosi a questa osservazione, si conclude facilmente che Laplace non abbia compreso l’importanza della statistica nelle scienze, accecato da quelle “grandi leggi della Natura” che secondo lui avrebbero determinato la successione degli eventi più infimi, come la legge di Newton della gravitazione universale determina le rivoluzioni dei pianeti intorno al Sole. Il fatto che Laplace non abbia compreso il ruolo del caso nella Natura, sarebbe di per sè il male minore. Ciò che talvolta gli si rimprovera è piuttosto di avere instradato, grazie alla sua immensa autorità scientifica, il corso delle scienze nella via determinista da cui solo con molta fatica esso si sarebbe affrancato all’inizio del XX secolo. Si fustiga così questo determinismo laplaciano, ristretto e retrogrado, che avrebbe modellato a propria immagine tutta la fisica matematica, particolarmente in Francia. Questa visione dell’opera di Laplace è erronea. Se è vero che la scuola laplaciana ha privilegiato l’approccio meccanicista, essa è nondimeno all’origine dell’approccio statistico delle scienze dure, fisiche e biologiche, approccio che non consiste nell’esprimere le proprie convinzioni sulla Natura, ma a osservarlo, descriverlo e comprenderlo. Nella sua opera probabilista, è Laplace stesso a porre le basi di tale approccio statistico». L’aspetto curioso di questo articolo è che esso si conclude con una affermazione lapidaria: “la natura è sottomessa alle leggi del caso”. Affermazione che Laplace non avrebbe certamente condiviso e che uno dei più lucidi e conseguenti eredi di Laplace, il matematico Renè Thom, ha più volte contestato, al biologo Monod ed ad altri, con pregevoli argomentazioni. Dire chi abbia ragione non è scopo di questa scheda informativa. Tuttavia sarebbe sempre bene precisare che quando si parla di caso, si parla sempre di una dimensione selezionata e ristretta della realtà, rispetto alla quale è accaduto un evento le cui ragioni non si possono trovare nel sistema descritto, ma solo al di fuori di questa area ristretta, oppure al di sopra o al di sotto del livello e del modello di descrizione scelto. E’ un caso che un uccello entri nel motore di un aereo e lo faccia sfracellare al suolo. Ma non si può dire che questo caso fosse imprevedibile. Per Thom, ad esempio, finchè si rimane nell’indescrivibile, è ovvio che tutto è casuale. Ma nel momento stesso in cui emerge dall’indescrivibile il descrivibile, nella nostra testa, ovvero una linea di ragionamento in grado di spiegare perchè un cavallo brocco ha vinto una corsa battendo fior di rivali, parlare di caso è semplicemente un assurdo. Il caso esiste solo perchè siamo ignoranti. E nella fattispecie del cavallo brocco vincitore, una volta stabilito che tutti gli altri concorrenti sono andati meno velocemente del normale, si potrà legittimamente sospettare che la corsa sia stata truccata, mentre nel caso che il nostro brocco sia andato molto più veloce del suo standard, altrettanto più logicamente potremmo sospettare che fosse imbottito di pillole dopanti. Il determinismo di questo tipo ha sempre fornito modelli più che attendibili per il sospetto, e dunque per la ricerca della verità. Ciò detto, occorre tuttavia prendere atto che una parte della scienza moderna ha decisamente imboccato la via del probabilismo e che è nata un’epistemologia indeterminista che ha il suo fulcro nel pensiero di K.Popper. Ciò non significa, ovviamente, che la realtà sia in sè determinista, o all’opposto, indeterminista. Significa solo che il nostro approccio ad essa può gradualmente passare da un indeterminismo totale, infantile, animistico (oserei dire religioso e superstizioso) ad una forma mentale nella quale la nostra stessa conoscenza, forte di sensate esperienze e strumenti di calcolo, può articolarsi sia per certezze che per sensate e probabili previsioni, riservando all’incertezza nientaltro che il suo ruolo logico: non solo l’irruzione dell’imprevedibile, ma anche la certezza di non sapere come andranno certe cose, ed anche di temere che esse andranno male. Ciò su cui varrebbe sempre la pena di essere indeterministi ( nel senso di sentirsi ignoranti) è dunque il futuro che ci riguarda, come singoli, come gruppi, come nazioni, non il futuro della Terra in quanto terra, o dell’Universo in quanto universo: su queste cose si tratta solo di estendere le nostre conoscenze secondo l’ideale propugnato da Laplace. Non avremo mai certezze al mille per mille, ma nemmeno avremo la più totale ignoranza.
Grande opportunista, incapace come politico, talentuoso come scienziato
E’ certamente rilevante notare come Laplace sia appartenuto ad una generazione che aveva prodotto dei veri talenti matematici: Lagrange era nato nel 1736; Gaspard Monge nel 1746, Legendre nel 1752 e Lazare Carnot nel 1753. E il gruppo si potrebbe allargare al filosofo Condorcet, nato nel 1743, grande appassionato di matematica ed importante sostenitore del progetto di riforma del sistema scolastico francese dopo la rivoluzione. Dalla biografia di Laplace possiamo intendere che distribuì le proprie forze tra studi scientifici ed attività politica e governativa, passando tra l’altro indenne tra diversi e repentini cambiamenti rivoluzionari: sopravvisse, al contrario di Condorcet, al periodo del terrore giacobino; sopravvisse alla caduta dei giacobini e coesistette al direttorio di cui fu membro anche Carnot; poi entrò nelle grazie di Napoleone; infine sopravvisse anche alla rovinosa caduta di Napoleone e divenne persino marchese nel 1817, terminando la propria vita come sostenitore di Luigi VIII, re di Francia. Nel 1773 era entrato nell’Accademia parigina delle scienze e nel 1796 ne divenne presidente. Sempre nel 1773 diede un’importante contributo allo sviluppo della matematica con la cosiddetta trasformazione di Laplace, un’operazione funzionale analoga alla trasformazione di Fourier, ma probabilmente più importante. Si tratta infatti di un’applicazione possibile a tutti i generi. Un’equazione differenziale lineare a coefficienti costanti può venire ridotta a un’equazione algebrica lineare nella trasformata della funzione incognita. Da qui è poi possibile risalire, senza troppe difficoltà, alla cosiddetta funzione generatrice. Durante il periodo del terrore mantenne contatti con scienziati considerati sospetti dal regime, e non è escluso che corse anche qualche rischio, presentendo in più di un’occasione il gelido contatto tra il suo collo e la sottile lama della ghigliottina, ma il suo opportunismo, nonchè i meriti scientifici acquisiti, gli consentirono di navigare a vista fino alla fine dell’incubo. Quando più tardi Napoleone lo fece ministro della Pubblica Istruzione, sembra che egli non riuscì a dimostrare una particolare attitudine per la carica. Lo stesso Napoleone fece sul suo conto una battuta sarcastica: “Laplace ha introdotto lo spirito dell’infinitamente piccolo negli affari di stato.” Non geniale come politico, Laplace si rivelò tuttavia ai limiti del geniale come scienziato. « I lavori di Laplace – scrive Carl B. Boyer – comportavano una considerevole applicazione dell’analisi superiore. Tipico sotto questo profilo, era il suo studio sulle condizioni di equilibrio di una massa fluida in rotazione, argomento da lui considerato in relazione all’ipotesi cosmologica della nebulosa come origine del sistema solare […] Secondo la teoria di Laplace, il sistema solare si sarebbe formato a partire da un globo gassoso, o nebula, incandescente ruotante intorno al proprio asse. Raffreddandosi, questo globo si sarebbe contratto, causando una rotazione sempre più rapida per effetto della conservazione del momento angolare, fino a che dalla superficie esterna si sarebbero staccati uno dopo l’altro diversi anelli di materia che, condensandosi, avrebbero formato i pianeti. Il Sole, ruotante su stesso, costituirebbe il nucleo centrale rimanente della nebula.» Ovviamente l’idea della nebulosa originaria non era affatto originale; prima di Laplace erano già intervenuti Thomas Wright e Immanuel Kant; tuttavia Laplace, nel Trattato della meccanica celeste aveva saputo dare una formulazione matematica alla teoria. Ma prima del Trattato, composto in un ampio ventaglio di anni, con l’ultimo volume pubblicato solo nel 1825, Laplace aveva scritto, e pubblicato nel 1796, L’exposition du système du monde, testo nel quale egli espose anche la sua filosofia della scienza, ovvero la sua concezione di ricerca scientifica. «Secondo Laplace – scrive Enrico Bellone – la conoscenza era fondata sulla possibilità di interpretare i fenomeni, osservabili in natura, alla stregua di conseguenze matematiche di un ristretto gruppo di leggi. Di qui discendeva, a suo avviso, il ruolo centrale della matematica e dell’astronomia. La matematica consentiva infatti di enunciare i problemi mediante apparati formali rigorosi e l’astronomia era un modello per l’impresa scientifica in quanto le leggi del moto erano controllabili con particolare precisione negli spazi celesti. L’astronomia, intesa come teoria del sistema mondo, era una scienza che secondo Laplace godeva di privilegi specifici. I suoi progressi avevano infatti consentito di abbracciare gli stati passati e futuri dell’intero universo e di giungere alla comprensione del principio dal quale tutti i fenomeni dipendono: il principio della gravitazione. A partire da quest’ultimo era possibile, con la matematica, ridiscendere sino alla spiegazione completa di tutti i fenomeni celesti, fino alle loro più piccole particolarità». Ed ora guardiamo proprio a queste piccole particolarità nell’esposizione che ne fa Laplace, avvisando che Laplace parla qui di molecole di luce, secondo la vecchia teoria newtoniana della composizione corpuscolare della luce, che si sarebbe dimostrata sbagliata, almeno in parte, visto che i quanti di luce, ovvero i fotoni della scienza contemporanea, possono essere descritti sia sotto la forma di un modello ondulatorio che sotto quella di un modello corpuscolare.
La materia è soggetta all’impero delle forze attrattive
«L’attrazione -scrisse Laplace – sparisce tra i corpi di una grandezza poco considerevole: essa riappare nei loro elementi sotto un’infinità di forme. La solidità, la cristallizzazione, la rifrazione della luce, il sollevamento e l’abbassamento dei liquidi negli spazi capillari, e in generale tutte le combinanzioni chimiche sono il risultato di forze la cui conoscenza è uno dei principali obiettivi dello studio della natura. Così la materia è soggetta all’impero di diverse forze attrattive: una di esse, estendendosi indefinitamente nello spazio, regge i movimenti della terra e dei corpi celesti; tutto ciò che riguarda la costituzione intima delle sostanze che li compongono dipende principalmente dalle altre forze la cui azione è sensibile solo a distanze impercettibili. E’ quasi impossibile, per questa ragione, conoscere le leggi della loro variazione con la distanza; fortunatamente, la proprietà di essere sensibili soltanto assai vicino al contatto basta per sottomettere all’Analisi un gran numero di fenomeni interessanti che ne dipendono. Passo qui a presentare brevemente i risultati principali di quest’analisi, e completare così la teoria matematica di tutte le forze attrattive della natura. Si è visto nel Libro I che un raggio luminoso, passando dal vuoto in un mezzo trasparente, si inflette in modo che il seno dell’angolo di incidenza e quello dell’angolo di rifrazione hanno un rapporto costante. Questa legge fondamentale della diottrica è il risultato dell’azione del mezzo sulla luce, supponendo che questa azione è sensibile solo a distanze percettibili. Concepiamo in effetti, il mezzo limitato da una superficie piana; è evidente che una molecola di luce, prima di attraversarla, è ugualmente attratta da tutti lati rispetto alla perpendicolare di questa superficie, poichè ad una distanza sensibile dalla molecola vi è da tutti i lati lo stesso numero di molecole attiranti; la risultante delle loro azioni è dunque diretta secondo questa perpendicolare. Dopo essere penetrata nel mezzo, la molecola di luce continua ad essere attirata secondo una perpendicolare alla superficie, e se si immagina il mezzo diviso in strati paralleli a questa superficie e di uno spessore infinitamente piccolo, si vedrà che, essendo l’attrazione degli strati superiori alla molecola attirata distrutta dall’attrazione di un numero uguale di strati inferiori, la molecola di luce è attirata esattamente come lo era alla stessa distanza dalla superficie, prima di attraversarla; l’attrazione che essa subisce è dunque insensibile, quando è penetrata sensibilmente nel mezzo trasparente, e il suo movimento diviene allora uniforme e rettilineo» (Exposition du système du monde, in P.S. Laplace, Ouvres, Tome VI, Paris, Gauthiers-Villars, pp. 349-350 – trad. it di Arcangelo Rossi – pubblicata in Materia ed energia – antologia di testi – Feltrinelli, Milano 1978). Questo passo mostra di quanto ci si possa sbagliare muovendo da un’assiomatizzazione errata, in questo caso muovendo dal principio che la luce, composta di molecole, è attirata da forze analoghe a quella di gravità. . L’errore di Laplace è tuttavia spiegabile con la particolare venerazione che ancora un secolo dopo si portava a Newton, l’ipse dixit del ‘600. Già Huygens aveva avanzato l’ipotesi di una natura ondulatoria della luce, ma la sua interpretazione rimase minoritaria, come spesso succede, e fu solo grazie a Fresnel ed Thomas Young, un medico di professione e fisico dilettante per passione, che la teoria della luce come onda venne ad imporsi. Ma in Laplace, rispetto a Newton e rispetto alla trattazione settecentesca della teoria matematica dell’ottica, c’era anche qualcosa di nuovo. Nelle note che accompagnano il testo di Laplace tradotto in italiano, Angelo Baracca & Arcangelo Rossi scrivono: «1) la rinuncia a congetturare leggi di variazione con la distanza delle forze di attrazione molecolare in assenza di esperienze precise; 2) la derivazione della variazione costante della velocità della luce nel passaggio da un dato mezzo ad un altro dal principio di conservazione delle forze vive, secondo un punto di vista “energetico”. Come già in Lagrange, ancora su un piano puramente matematico, il principio di conservazione delle forze vive diviene cioè uno strumento di deduzione liberato il più possibile da implicazioni metafisiche e ipotesi su meccanismi inosservabili, e tale da giustificare a sua volta, e non già per presupporre, quel principio di minima azione, cui erano invece legate in particolare nel passato le discussioni metafisiche. Tali punti di vista nuovi vengono però ancora conciliati in Laplace con quella concezione corpuscolare che portava alla conclusione, rivelata poi empiricamente incosistente da L. Foucault nel 1850, della maggiore velocità della luce, perchè maggiormente attratta, in un mezzo più denso che in uno meno denso.» Proseguendo la lettura del testo laplaciano, si ricava la netta sensazione di quanto egli fosse ancora del tutto fedele alle impostazioni newtoniane, condivise peraltro dai chimici Berthollet e Gay-Lussac. «L’attrazione molecolare è la causa dell’aggregazione delle molecole omogenee e della solidità dei corpi. Essa è la fonte delle affinità delle molecole eterogenee. Simile alla pesantezza, non si arresta affatto alla superficie dei corpi, ma la penetra, agendo al di là del contatto a distanze impercettibili: è ciò che i fenomeni capillari mostrano con evidenza. Da ciò dipende l’influenza delle masse nelle affinità chimiche, o questa capacità di saturazione di cui Berthollet ha così felicemente sviluppato gli effetti. Così due acidi, agendo sulla stessa base, se la spartiscono in ragione della loro affinità con essa; ciò che non avrebbe affatto luogo, se l’affinità agisse solo per contatto; poichè allora l’acido più potente riterrebbe l’intera base. La figura delle molecole, l’elettricità, il calore, la luce ed altre cause, combinandosi con questa legge generale, ne modificano gli effetti. Alcune esperienze di Gay-Lussac sui fenomeni capillari delle mescolanze formate di proporzioni diverse di acqua ed alcool sembrano indicare queste modificazioni; infatti questi fenomeni non seguono affatto esattamente le leggi che risultano dalle attrazioni reciproche dei due fluidi mescolati insieme e dai pesi specifici. Si presenta qui una questione interessante. La legge di attrazione molecolare relativa alle distanze è la stessa per tutti i corpi? Ciò sembra risultare dal fenomeno generale osservato da Richter, e che consiste nel fatto che i rapporti tra le basi che saturano un acido sono gli stessi per tutti gli acidi; in questo caso, la legge della capillarità è la stessa per tutti i liquidi. Le molecole di un corpo solido hanno la posizione nella quale la loro resistenza a un mutamento di stato è massima. Ogni molecola, quando è infinitesimalmente spostata da questa posizione, tende a ritornarvi in virtù delle forze che la sollecitano. Ciò costituisce l’elasticità di cui si può supporre che tutti i corpi siano dotati, quando si muta di pochissimo la loro figura. Ma quando lo stato reciproco delle molecole subisce un mutamento considerevole, queste molecole ritrovano nuovi stati di equilibrio stabile, come capita ai metalli battuti a freddo e in generale ai corpi che per la loro mollezza sono suscettibili di conservare tutte le forme che si danno loro premendoli. La durezza e la viscosità dei corpi mi sembra non sia altro che la resistenza delle molecole a questi cambiamenti di stato d’equilibrio. Essendo la forza espansiva del calore opposta alla forza attrattiva delle molecole , essa diminuisce sempre più la loro viscosità o la loro aderenza reciproca per i suoi incrementi successivi, e quando le molecole di un corpo oppongono solo una resistenza assai leggera ai loro spostamenti reciproci al suo interno e alla sua superficie, esso diviene liquido. Ma la sua viscosità, per quanto assai debole, sussiste ancora finchè, per un incremento di temperatura, diviene nulla o insensibile. Allora, ritrovando ogni molecola in tutte le sue posizioni le stesse forze attrattive e la stessa forza repulsiva del calore, essa cede alla più leggera pressione e il liquido gode della più perfetta fluidità. Si può verisimilmente congetturare che ciò ha luogo per i liquidi che, come l’alcool, hanno una temperatura assai superiore a quella a cui cominciano congelare. E’ in questi liquidi che si osservano con esattezza le leggi dei fenomeni capillari, come quelle dell’equilibrio e del movimento dei fluidi; poichè le forze da cui dipendono i fenomeni capillari sono così piccole che l’ostacolo più leggero, come la viscosità dei liquidi e il loro attrito contro le pareti del recipiente, basta per modificarne sensibilmente gli effetti. L’influenza della figura delle molecole è assai notevole nei fenomeni del congelamento e della cristallizzazione, tanto che questi si rendono assai più rapidi immergendo nel liquido un pezzo di ghiaccio o di cristallo formato dallo stesso liquido, le molecole della superficie di questo solido presentandosi alle molecole liquide che le toccano nella situazione più favorevole alla loro unione con esse. Si comprende che l’influenza della figura, quando aumenta la distanza, deve decrescere ben più rapidamente della stessa attrazione. E’ così che, nei fenomeni celesti che dipendono dall figura dei pianeti, come il flusso e il riflusso del mare e la precessione degli equinozi, questa influenza decresce in ragione del cubo della distanza, mentre l’attrazione diminuisce solo in ragione del quadrato della distanza. Sembra dunque che lo stato solido dipenda dall’attrazione delle molecole, combinata con la loro figura, di modo che un acido, per quanto eserciti su una base un’attrazione a distanza minore che su un’altra base, si combina e cristalllizza di preferenza con essa se, per la forma delle sue molecole, il suo contatto con questa base è più intimo. L’influenza della figura, ancora sensibile nei fluidi viscosi, è nulla in quelli che godono di una fluidità completa. Infine tutto porta a credere che, nello stato gassoso, non solo l’influenza della figura delle molecole, ma anche quella delle loro forze attrattive è insensibile in rapporto alla forza repulsiva del calore. Queste molecole non sembrano allora nient’altro che un ostacolo all’espansione di questa forza; perchè si può in un gran numero di casi, senza cambiare la tensione di un gas contenuto in uno spazio dato, sostituire a molte delle sue parti parti di un altro gas, di eguale volume. E’ la ragione per cui diversi gas messi a contatto finiscono finiscono alla lunga per mescolarsi in modo uniforme; perchè solo allora sono in uno stato di equilibrio stabile. Se uno di questi gas è vapore, l’equilibrio è stabile soltanto nel caso che questo vapore disseminato sia in quantità uguale o minore di quella dello stesso vapore che si spargesse, alla stessa temperatura, in uno spazio vuoto uguale a quello che occupa la mescolanza. Se il vapore è in quantità maggiore, l’eccesso deve, per la stabilità dell’equilibrio, condensarsi sotto forma liquida» (Exposition du système du monde, in P.S. Laplace, Ouvres, Tome VI, Paris, Gauthiers-Villars, pp349-350, 388-390 – trad. it di Arcangelo Rossi – pubblicata in Materia ed energia – antologia di testi – Feltrinelli, Milano 1978) Il lettore contemporaneo, abituato a ragionare per quanto attiene il mondo microscopico in termini di legami chimici, di scambi di elettroni ed orbitali liberi, troverà forse ingenue e superate queste osservazioni laplaciane; del resto è così: esse appartengono ad un modello descrittivo di scienza non più attuale, e mostrano che il sapere scientifico non è cumulativo, ma selettivo, che le teorie meno soddisfacenti vengono accantonate e perfino dimenticate, e che potrebbe persino provocare una certa confusione il sottoporre queste letture a giovani impegnati nello studio della chimica e della fisica. Ma, chi conosce almeno i principi fondamentali della fisica, troverà anche che la stessa fisica procede per piccole approssimazioni, e che spesso le rivoluzioni non sono altro che approssimazioni del tutto nuove. Le attuali conoscenze sono il frutto di studi e scoperte precedenti, ma anche di errori, spesso colossali. E’ solo in base a questo passato che si è raggiunta una relativa conoscenza che consente di comprendere che utilizziamo modelli di descrizione, e che questi non sono la realtà, ma solo una selezione di essa, quella che ci consente di descrivere quanto accade e calcolare cosa potrebbe accadere. Lo studioso della storia, ed in particolare la storia della scienza e della filosofia, ha ovviamente il compito di conoscere e valutare le vecchie teorie, onde misurare criticamente il livello di consapevolezza scientifica raggiunta in determinate epoche. E qui corre l’obbligo di denunciare allora il ritardo con il quale non solo queste stesse opere sono state tradotte, o addirittura non lo sono state, ed anche il fatto che moltissime biblioteche territoriali non contengono nè le opere in lingua originale, nè le poche traduzioni disponibili. Riuscirà internet a colmare questo deficit? Non senza la buona volontà di operatori culturali che gratuitamente forniranno il loro contributo. Non mi stancherò mai di ripetere che invece di predicare, occorre dare buoni esempi. Emerge comunque da questo testo un elemento che smentisce un certo luogo comune secondo il quale Laplace era contrario all’empirismo, e che egli propugnasse un razionalismo di tipo cartesiano. Si tratta, evidentemente, di un equivoco legato alla confusione che induce un certo uso dei termini. Laplace si dichiarò contro un certo tipo di empirismo, l’empirismo degli scettici e dell’uso limitato dell’intelligenza, l’empirismo di chi, anche in presenza di fatti rilevanti, che “parlano” da soli, si ostina a non voler ricavare da essi alcuna ipotesi fondata, derivata dai fenomeni stessi, secondo la fondamentale lezione di Newton. Scrive ancora in proposito Enrico Bellone: « La storia dell’astronomia diventa dunque, per Laplace, la storia di un metodo vincente. Sono state necessarie, indubbiamente molte osservazioni sui movimenti dei pianeti, del Sole e della Terra prima di poter cogliere effettivamente quei movimenti nella loro realtà. Ma gli astronomi non si sono limitati a comporre elenchi di osservazioni. Essi hanno cercato di individuare i rapporti teorici esistenti tra i dati empirici, elevandosi gradualmente sino alle leggi dei moto planetari e, infine, sino al principio generale della gravitazione universale. Dopo di che l’astronomia ha potuto ridiscendere alla “folla dei fenomeni” osservabili, spiegandoli completamente come conseguenze necessarie di “un piccolo numero di cause” fondate appunto sulla gravitazione. Come si vedrà nel seguito, questa visione della scienza torna spesso nelle riflessioni di Laplace: non si tratta di dare scarso rilievo agli esperimenti, ma di insistere sull’idea che i soli esperimenti non riescono a dare una spiegazione scientifica ai fenomeni. La funzione della matematica è, in questo senso essenziale. Nelle Leçons Laplace tratta ad esempio l’aritmetica come “una lingua particolare il cui oggetto è costituito dai numeri” e, seguendo in ciò alcune idee diffuse nella cultura dell’illuminismo francese, parla di linguaggi matematici assimilandoli agli altri linguaggi dell’uomo: “La lingua filosoficamente perfetta sarebbe quella in cui si potesse esprimere il massimo numero di idee con il più piccolo numero possibile di termini.” Questa concezione del linguaggio è da Laplace collegata alla regola secondo la quale “tutte le idee complesse sono composte da idee semplici, combinate tra loro, secondo dei modi generali.” »
Il modello di conoscenza a cui dovremmo aspirare e non raggiungeremo mai
«Tutti gli avvenimenti – scrisse Laplace nel Trattato sulle probabilità – anche quelli che per la loro piccolezza sembrano non ubbidire alle grandi leggi della natura, ne sono la conseguenza necessaria come lo sono le rivoluzioni del Sole. Ignorando i legami che li uniscono al sistema intero dell’universo, li si è fatti dipendere dalle cause finali e dal caso, a seconda che che si manifestassero e si succedessero con regolarità o senza ordine apparente; ma queste cause immaginarie sono state successivamente arretrate sino ai limiti delle nostre conoscenze e spariscono del tutto davanti alla sana filosofia la quale non vede in esse che l’espressione dell’ignoranza in cui ci troviamo circa le vere cause. Gli avvenimenti attuali hanno coi precedenti un legame fondato sul principio evidente che nulla può cominciare ad essere senza una causa che lo produca. Quest’assioma, noto sotto il nome di principio della ragion sufficiente, si estende anche alle azioni che giudichiamo indifferenti. Neppure la volontà più libera può dar loro nascita senza un motivo determinante; giacchè, se essa stimando perfettamente simili le circostanze di due posizioni, agisse in una e si astenesse dall’agire nell’altra, opererebbe una scelta che sarebbe un effetto senza causa; che sarebbe insomma, dice Leibniz, il caso cieco degli epicurei. Ma l’opinione contraria alla nostra è un’illusione dello spirito che, perdendo di vista le ragioni fugaci della scelta della volontà nelle cose indifferenti, si persuade che essa si determini da sé e senza motivo. Dobbiamo dunque considerare lo stato presente dell’universo come l’effetto del suo stato anteriore e come la causa del suo stato futuro. Un’Intelligenza che, per un dato istante, conoscesse tutte le forze da cui è animata la natura e la situazione rispettiva degli esseri che la compongono, se per di più fosse abbastanza profonda per sottomettere questi dati all’analisi, abbraccerebbe nella stessa formula i movimenti dei più grandi corpi dell’universo e dell’atomo più leggero: nulla sarebbe incerto per essa e l’avvenire, come il passato, sarebbe presente ai suoi occhi. Lo spirito umano offre, nella perfezione che ha saputo dare all’astronomia, un pallido esempio di quest’Intelligenza. Le sue scoperte in meccanica e in geometria, unite a quella della gravitazione universale, l’hanno messo in grado di abbracciare nelle stesse espressioni analitiche gli stati passati e quelli futuri del sistema mondo. Applicando lo stesso metodo ad altri oggetti delle sue conoscenze, è riuscito a ricondurre a leggi generali i fenomeni osservati ed a prevedere quelli che devono scaturire da circostanze date. Tutti i suoi sforzi nella ricerca della verità tendono ad avvicinarlo continuamente all’Intelligenza che abbiamo immaginato, ma da cui resterà sempre infinitamente lontano. Questo tendere, che è proprio della specie umana, è ciò che ci rende superiori agli animali, ed i progressi nel campo della scienza distinguono le nazioni ed i secoli e rappresentano la loro vera gloria. Ricordiamoci che un tempo, ed in un’epoca che non è ancora molto lontana, una pioggia od una siccità eccessive una cometa che trascinasse dietro di sè una lunga coda, le eclissi, le aurore boreali ed in genere tutti i fenomeni straordinari, apparivano come altrettanti segni della collera celeste. Si invocava il cielo per allontanare la loro funesta influenza. Non lo si pregava invece di sospendere il corso dei pianeti e del Sole: l’osservazione ben presto fece capore l’inutilità di queste preghiere. Ma, poichè quei fenomeni si manifestavano e sparivano dopo lunghi intervalli, essi sembravano contrari all’ordine della natura; si supponeva che il cielo li facesse nascere e li modificasse a suo piacimento per punire i delitti della Terra. Così la lunga coda della cometa del 1456 sparse il terrore nell’Europa, già prostrata per il rapido successo dei Turchi che avevano abbattuto il Basso Impero. Quest’astro, dopo quattro rivoluzioni, ha suscitato in noi un interesse ben diverso. La conoscenza delle leggi del sistema del mondo, acquista acquisita in questo intervallo di tempo, ha dissipato i timori prodotti dall’ignoranza dei veri rapporti dell’uomo con l’universo; ed Halley, riconosciuta l’identità della cometa con quella del 1531, 1607 e 1682, annunziò il suo ritorno per la fine del 1758 o l’inizio del 1759. Gli scienziati attesero con ansia questo ritorno, che doveva confermare una delle più grandi scoperte che fossero mai state fatte nelle scienze e compiere la predizione di Seneca, quando, a proposito della rivoluzione di questi astri che vengono da remore distanze, disse: “Verrà giorno in cui, dopo uno studio di parecchi secoli, le cose attualmente incomprensibili saranno evidenziate, e la posterità si meraviglierà che verità così tanto chiare ci siano sfuggite.” Clairaut sottomise allora ad analisi le perturbazioni che la cometa doveva aver provato per l’azione dei due maggiori pianeti, Giove e Saturno: dopo lunghi calcoli fissò il suo prossimo passaggio al perielio per l’inizio circa dell’aprile 1759, cosa che l’osservazione non tardò a verificare. La regolarità. che l’astronomia ci presenta nel movimento delle comete, ha luogo, senza dubbio in tutti i fenomeni. La curva descritta da una semplice molecola di aria o di vapore è regolata con la medesima certezza delle orbite planetarie; non v’è tra di esse nessuna differenza, se non quella che vi pone la nostra ignoranza».
La probabilità: rapporto e frazione
Proprio a questo punto Laplace comincia esplicitamente a descrivere la probabilità, presentandolo come un concetto che appartiene all’ambito logico ed all’ambito empirico. “La probabilità – scrive Laplace – è relativa in parte a questa ignoranza, in parte alle nostre conoscenze. Sappiamo, ad esempio, che su tre o più eventi uno solo si verificherà; ma nulla ci porta a credere che uno debba accadere a preferenza degli altri. Data la nostra indecisione, ci è impossibile pronunciarci con certezza sul loro accadere. Tuttavia è probabile che uno di essi, preso ad arbitrio, non si verifichi, perchè vediamo che più casi ugualmente possibili ne escludono l’esistenza, mentre uno solo la favorisce. La teoria dei casi consiste nel ridurre tutti gli eventi dello stesso genere ad un certo numero di casi ugualmente possibili, cioè tali da renderci indecisi circa la loro esistenza, e nel determinare il numero dei casi favorevoli all’evento di cui si ricerca la probabilità. Il rapporto tra questo numero e quello di tutti i casi possibili è la misura della probabilità, la quale perciò non è che una frazione, il cui numeratore è il numero dei casi favorevoli ed il cui denominatore è il numero di tutti i casi possibili” L’esempio da cui mosse Laplace è quello di tre urne, due delle quali contengono solo palline bianche, mentre la terza contiene solo palline nere. Sapendo in anticipo come sono distribuite le palline, ma non dove sono, è ovvio che la frazione che descrive la probabilità di trarre da una delle tre urne una pallina bianca è di una su tre, pertanto la frazione che esprime il rapporto sarà di un terzo. Il calcolo delle probabilità risulta dunque particolarmente efficace quando conosciamo con esattezza il contesto entro il quale le possibilità che dobbiamo prevedere sono limpidamente distribuite. Le cose sono ovviamente più complicate quando questo non si verifica. In questi Essai philosophique sur les probabilites, Laplace si avvalse di un teorema scoperto da Jacques Bernouilli (1654-1705) e sviluppato Abraham de Moivre (1667-1754), e ne produsse uno di suo, nel 1810, dopo avervi riflettuto per oltre trentanni.
Il teorema di Bernouilli e il perchè tutte le generazioni animali ed umane producono maschi e femmine in un rapporto costante
Il teorema di Bernouilli era stato esposto in trattato divenuto classico intitolato Ars Conjectandi, pubblicato solo nel 1713, otto anni dopo la sua morte. Ma è corretto ricordare che la prima parte di questo testo era stata scritta da Huygens. E’ solo nella terza parte che Bernouilli trattò la teoria della probabilità, ed è nella quarta che egli enunciò, dopo una lunga corrispondenza con Leibniz su questo punto, la “legge dei grandi numeri”, poi ripresa da un allievo di Laplace, Denis Poisson (1781-1840) la versione elementare del teorema di Bernouilli afferma che tirando per lungo tempo a testa e croce una moneta perfettamente equilibrata, la frequenza delle “teste” si avvicina sempre più ad un valore fisso, pari ad ½. Laplace commentava così: « Consegue da questo teorema che, un una serie di avvenimenti indefinitamente prolungata, l’azione delle cause regolari e costanti deve prevalere alla lunga su quella delle cause irregolari. E’ ciò che rende i guadagni del banco della lotteria certi quanto i prodotti dell’agricoltura…» Ma anche il rapporto dei numeri di nascite maschili e femminili è tendenzialmente fisso. ( E questo tra l’altro è anche qualcosa che finora nessuno è riuscito a spiegare in maniera convicente: perchè non succede quasi mai su larga scala, che si verifichi un’esorbitante variazione del numero delle nascite a favore dell’uno o dell’altro sesso?)
La teoria degli errori di Laplace
Il secondo teorema utilizzato fu propriamente di Laplace ed il nostro ci meditò attorno per circa trentanni prima di enunciarlo nel 1810. Per Laplace i rapporti, o medie che si ricavano dall’osservazione dei lanci della moneta o dal numero delle nascite, non sono veramente costanti se non dopo una lunga serie. Pertanto ogni grande serie varia, ed ancora di più possono variare le serie piccole. Tuttavia, per Laplace anche le variazioni seguono una certa legge. Scrive Bernard Bru: «Esse si concentrano attorno ad un valore fisso, che corrisponde al vero rapporto costante che si otterrebbe dopo un numero infinito di lanci. Le frequenza dei rapporti osservati diminuiscono via via che esse si discostano da questo valore medio. Così, quale che sia l’ordine fisico o morale al quale si riferiscono i rapporti misurati, i loro valori si distribuiscono su una curva a campana, descritta da una formula matematica unica» (da Laplace probabilista, cit.). Muovendo da questa considerazione Laplace formulò la teoria degli errori, applicandola in particolare alla pratica delle misurazioni, che è alla base di qualsiasi procedura di fisica meccanica. Ad esempio, anche utilizzando strumenti di massima precisione, se proviamo a misurare il perimetro della casa in cui viviamo, ben difficilmente, otterremo il medesimo risultato, ma solo valori molto prossimi l’uno all’altro. Non solo: una delle prime cose che si imparano in fisica è che la precisione dello strumento non deve essere confusa con la precisione della misura. La media dei risultati di ogni misurazione garantisce che il valore della misurazione potrebbe approssimarsi alla reale lunghezza della casa, ma non fornisce la certezza dell’esattezza. Questa teoria degli errori di Laplace è ancora universalmente utilizzata per ridurre al minimo le imprecisioni.
Il tentativo di interpretare i fenomeni termici
Pur forte dell’abito mentale determinista e meccanico, Laplace riconobbe esplicitamente la difficoltà di spiegare matematicamente i fenomeni termici. La sua ipotesi poggiava su di una complicazione, ovvero che il calore fosse un fluido composto di particelle e che quindi occorresse studiare l’interazione tra molecole di gas e particelle di calorico per dedurre le leggi. Il modello di descrizione che si ricavava da questa ipotesi portava ad immaginare molecole di gas circondate da particelle di calorico come in una serie di microsistemi poco stabili nei quali le molecole acquisivano e perdevano particelle, pur rimanendo nel tempo una certa costanza. Ciò comportava la conseguente affermazione che il calorico esistesse all’interno del gas in due modalità distinte: come calorico libero costituito di particelle in movimento ad alta velocità e come calorico annesso alle molecole di gas. Questo tipo di spiegazione, basata comunque sempre sulla forza attrattiva della materia, si scontrava tuttavia con il problema della propagazione del calore. Se era certo che il calore fluiva spontaneamente dai corpi caldi a quelli freddi, era altrettanto certo che non accadeva il contrario, ovvero che un corpo freddo diventasse ancora più freddo a vantaggio di un corpo già caldo, rendendolo ancora più caldo. In sostanza, la meccanica laplaceana sembrava impotente di fronte a questi apparenti anomalie (anomalie, ovvio, rispetto al modello di descrizione prescelto). Un forte contributo al superamento di queste difficoltà verrà da Joseph Fourier (1768-1830), ma questo è un altro discorso.
HERBERT SPENCER

” L’uomo saggio deve ricordarsi che è un discendente del passato ma anche un genitore del futuro. “
Herbert Spencer nacque il 27 aprile 1820 a Derby in Inghilterra; compì studi di carattere scientifico e divenne ingegnere delle ferrovie a Londra. Pubblicò in un primo tempo solo alcuni articoli politici ed economici; nel 1845, ottenuta una piccola eredità, obbedì alla sua vocazione filosofica e abbandonò la carriera dell’ingegnere per dedicarsi all’elaborazione di saggi di filosofia. Dal 1848 al 1853 fu membro della redazione dell’«Economist». Nel 1850 pubblicò la Statica sociale , dove applicò il principio evoluzionistico alla vita sociale. Nel 1855 pubblicò i Princìpi di psicologia e nel 1857 un saggio sul progresso ( Il progresso, sua legge e sua causa ) che è molto significativo per il suo orientamento fondamentale. Nel 1862 usciva il primo volume del Sistema di filosofia sintetica progettato nel 1860, Primi princìpi , che è il suo scritto filosofico fondamentale e uno dei capisaldi del positivismo. Seguivano i due volumi dei Princìpi di biologia (1864-1867); e in seguito: Princìpi di psicologia e Princìpi di sociologia . A queste opere vanno aggiunti numerosi altri scritti collaterali, tra cui l’importante saggio Individuo e Stato (1884), che rappresenta quasi un manifesto dei princìpi liberali, seppure con una decisa inclinazione verso il darwinismo sociale. Morì a Brighton l’8 dicembre 1903. Spencer appartiene a quella corrente del Positivismo che si riaggancia saldamente alle dottrine evoluzionistiche maturate in ambito scientifico. A differenza di Darwin, che riduce l’evoluzionismo ad un ambito puramente biologico, Spencer parla esplicitamente di ” evoluzionismo cosmico “, con l’idea che esista, oltre a quella organica, anche un’evoluzione ad essa precedente, di tipo inorganico, ed una successiva, di stampo super-organico. Il filosofo nota con acutezza che, ancor prima che si possa realizzare l’evoluzione biologica (tratteggiata da Darwin), occorre la realizzazione di quella inorganica, la quale ha consentito, ad esempio, la formazione del sistema solare; solo successivamente a quest’evoluzione inorganica si è potuta realizzare quella organica: e la tappa successiva sarà costituita da quella super-organica, a cui sarà soggetto l’uomo con le sue realizzazioni (la cultura, le istituzioni e, in generale, la società). Se Comte era un non-riduzionista, Spencer, invece, è almeno in parte riduzionista, poichè a suo avviso esiste un unico processo governato fondamentalmente dalle medesime leggi (quelle dell’evoluzionismo) che coinvolge il mondo organico, quello inorganico e perfino quello super-organico: le leggi che regolano la biologia, dice Spencer, sono pressochè le stesse che presiedono all’andamento della fisica, della politica, della cultura, della società, ecc, sicchè basta, in linea di principio, individuare le leggi dell’evoluzionismo per poter studiare l’intera realtà, cosa che è agli antipodi rispetto alla concezione comteana. Con Spencer, poi, affiora l’elemento che forse più contraddistingue il Positivismo rispetto al razionalismo seicentesco e settecentesco: se è vero che in comune hanno il marcato interesse per le scienze (a tal punto da arrivare a considerarle come unico sapere valido), tuttavia è diverso il tipo di scienza a cui fanno appello. Infatti, quando la filosofia prende come modello di indagine la scienza tende sempre a scegliere quella più in voga al momento, cosicchè se ai suoi tempi Platone si era servito della scienza medica di matrice ippocratea, i filosofi del Seicento e del settecento, invece, avevano preferito la fisica matematizzata di stampo galileiano e newtoniano, e il “Discorso sul metodo” di Cartesio ne è una prova lampante, poichè il pensatore francese afferma esplicitamente di aver ravvisato nella matematica il vero modello conoscitivo. Spencer e i Positivisti, dal canto loro, vivono in un’epoca in cui sulla fisica newtoniana è prevalsa la biologia, maggiormente in sintonia con gli slanci vitalistici tipici dell’età romantica: ecco perchè, a differenza dell’Illuminismo e del razionalismo, il Positivismo sceglie la biologia e, in particolare, Spencer estende l’evoluzionismo biologico all’intera realtà. Riconoscendo il primato della scienza (in particolare quella biologica), sembra dunque che la filosofia sia delegittimata: i Positivisti e Spencer non solo riconoscono nella scienza il modello supremo di conoscenza, ma tendono addirittura a vedere tutti gli altri come inefficaci, sancendo così la morte della filosofia. Eppure trovano sempre, in qualche maniera, un modo per ritagliare qualche spazio alla filosofia: Comte la riduce a indagine ragionata sulla storia della scienza, Mill la concepisce come puro e semplice studio dei fondamenti metodologici della scienza e Spencer, da ultimo, le riserva un trattamento speciale. In primo luogo, con un discorso di forte sapore kantiano, egli dichiara la compatibilità fra scienza e religione , staccandosi così da certe frange positivistiche espressamente anti-religiose: infatti, se è vero che si può indagare sulla realtà e desumerne delle leggi di comportamento, è altrettanto vero che l’essenza della realtà resta inconoscibile, ossia sfugge ad ogni inquadramento conoscitivo. In altre parole, la scienza può spiegare come avviene un fenomeno e per quale motivo si verifica, ma non potrà mai attingerne l’essenza profonda: le generalizzazioni cui perviene la scienza non potranno mai racchiudere ciò che Spencer definisce l’Inconoscibile (una sorta di cosa in sè kantiana). Ed è proprio in virtù di questa impotenza della scienza che la religione e la sua indagine sull’Inconoscibile (cioè sull’essenza profonda della realtà) non solo è compatibile con la scienza, ma è anzi necessaria ad essa: le due discipline si supportano a vicenda, proiettando le loro indagini su questioni diverse ma ugualmente necessarie, e per di più la religione ci ricorda contemporaneamente i limiti intrinseci della conoscenza umana e il mistero profondo della realtà. Questo ci permette anche di capire perchè Spencer faccia riferimento non alla teologia in generale, ma a quella di tipo negativo, che cioè non ci dice cosa stia al di là della barriera conoscitiva, ma, al contrario, cosa non stia. Naturalmente, questo può avvenire solamente se la scienza e la religione non hanno la pretesa di sconfinare nel campo altrui: e a tal proposito la vicenda di Galileo simboleggia appunto lo sconfinare della religione nel campo scientifico. Chiarito il rapporto che intercorre tra la scienza e la religione, Spencer si sofferma su quello riguardante la filosofia e la scienza: se la scienza può e deve spiegare l’intera realtà secondo le leggi evoluzionistiche, a che serve la filosofia? In modo piuttosto originale, Spencer le attribuisce, contemporaneamente, il minimo e il massimo valore, sostenendo che la filosofia altro non è se non la scienza più importante, con la conseguente perdita di autonomia e di specificità. Egli è forse il positivista che più di tutti dà peso alla filosofia, ma che tende anche di più a ridurla a scienza: in definitiva, per Spencer, la filosofia è una specie di super-scienza. Ciascuno di noi, infatti, ha le sue esperienze quotidiane e tende a generalizzarle per trarne delle regole di comportamento (e la scienza fa la stessa cosa, in maniera sistematica, per quel che riguarda la natura), ma poi, al di là delle leggi relativamente generali, è possibile individuare leggi generalissime che non valgono per un campo della realtà piuttosto che per un altro, ma, viceversa, valgono per tutta quanta la realtà. Proprio di queste leggi generalissime, valide per l’intera realtà, si occupa la filosofia. E proprio in virtù di questa concezione, Spencer tende ad essere riduzionista, ovvero a nutrire la convinzione che tutte le scienze siano riconducibili ad una sola scienza, la filosofia. E’ riduzionista, in altre parole, perchè nutre la convinzione che vi siano leggi generalissime valide per ogni realtà di cui le leggi studiate dalla scienza sono derivazioni particolari, come se, in ultima istanza, tutte le scienze fossero derivazioni particolari della super-scienza filosofia. La filosofia come la intende il filosofo inglese, pertanto, svetta tra tutti i saperi, ma, qualitativamente, non è diversa dalle altre scienze. E’ curioso come, in questa prospettiva, si ritorni al concetto aristotelico di metafisica intesa come scienza (oltrechè delle cose “al di là del mondo fisico”) dello studio delle leggi generali dell’essere: proprio a questo studio si deve dedicare la filosofia, la quale assurge a regina delle scienze ma perde la sua autonomia. L’ evoluzionismo di Spencer non è però una pura e semplice estensione delle nozioni di Darwin all’intero universo: in realtà, i due pensatori elaborano le loro teorie separatamente, senza contatti; e quando si dice che per Spencer l’evoluzione è cosmica, non si deve pensare che vada interpretata a mò di analogia per cui, dalla constatazione che nel mondo biologico vige l’evoluzionismo, si suppone che esso valga anche per il resto della realtà. Viceversa, l’intero cosmo è sottoposto ad un unico processo evolutivo che si articola in fasi e aspetti differenti nonchè successivi. Il problema della filosofia è appunto quello di andare al di là della scienza per ricostruire le leggi dell’evoluzione in generale: tutte le scienze arrivano, in modi e in ambiti diversi, a ravvisare delle leggi di evoluzione. Ad esempio, la biologia scopre l’evoluzione nel mondo vivente, la fisica nella realtà materiale e così via: la filosofia, dal canto suo, deve ricucire tutte queste leggi generali elaborate dalle singole scienze per poter così ottenere delle leggi generalissime di evoluzione valide per il cosmo intero. E tutte le singole scienze, dice Spencer, pervengono tutte, sebbene per strade diverse, al riconoscimento di tre princìpi fondamentali: 1) indistruttibilità della materia, 2) continuità del movimento, 3) persistenza della forza. Tutti questi princìpi, naturalmente, sono, per così dire, risposte “penultime”, che spiegano che la materia non si può distruggere, che il movimento è continuo e che la forza tende a persistere, ma che non rispondono alla domanda decisiva (che varca le soglie dell’Inconoscibile): perchè è così? Cosa l’ha originato? Il compito della filosofia sarà, pertanto, quello di unificare questi tre princìpi in un’unica legge generale, che Spencer rintraccia nella legge dell’evoluzione . Questa legge, infatti, spiega la graduale integrazione (cioè concentrazione) della materia e la conseguente dissipazione del movimento (a cui sinteticamente sono riconducibili i tre princìpi poc’anzi elencati) mediante un triplice processo: a) come un passaggio dall’incoerente al coerente (passaggio di progressiva concentrazione); b) come un passaggio dall’omogeneo all’eterogeneo, dall’uniforme al multiforme (ovvero un processo di progressiva differenziazione); c) come un passaggio dall’indefinito al definito (ossia come un processo di progressiva determinazione). In concreto, immaginiamo di avere dinanzi un essere primitivo come un’ameba e uno più comeplesso come un cavallo: la materia che compone il cavallo è molto più concentrata e compatta rispetto a quella dell’ameba (passaggio evolutivo dall’incoerente al coerente); il cavallo, poi, è più complesso e articolato dell’ameba, tant’è che ogni singola cellula del cavallo è di per sè più complessa dell’ameba (passaggio evolutivo dall’omogeneo all’eterogeneo); infine, l’ameba è più indeterminata, il cavallo è più comoplesso e dunque gode di una maggiore identità, cioè si distingue di più dall’ambiente circostante (passaggio evolutivo dall’indefinito al definito). E queste leggi appena illustrate valgono non solo in ambito biologico (l’ameba e il cavallo), ma per l’intero universo: le si devono impiegare anche, dice Spencer, per interpretare la formazione del sistema solare a partire da una nebulosa originaria. Essa passò da omogenea ad eterogenea, da poco densa a densissima, da incoerente a coerente, fino a dar vita all’intero sistema solare. Le leggi evoluzionistiche, poi, devono anche essere applicate al mondo super-organico, ovvero alla società umana: e quel che è più curioso è che, dice Spencer, le leggi che regolano il processo evolutivo del mondo biologico sono pressochè le stesse che reggono l’andamento dell’evoluzionismo nel mondo inorganico e in quello superorganico; si tratta di leggi che il pensatore inglese desume in parte da Darwin e in parte da Lamarck. E’ infatti convinto che tutti gli enti si sforzino per adattarsi all’ambiente e che le mutazioni che derivano da questi sforzi siano poi a loro volta selezionate dall’ambiente. Tuttavia tra la società e il mondo bilogico, che pure seguono leggi evoluzionistiche quasi identiche, vi è un’enorme differenza: nel mondo umano, infatti, subentra la cultura e la consapevolezza di ciò che si fa, cosa che suggerisce che l’idea lamarckiana di trasmissibilità ereditaria dei caratteri acquisiti, falsa se applicata all’evoluzionismo biologico, è vera per quel che riguarda il mondo umano. E’ infatti vero che nella storia umana vi è uno sforzo cosciente di adattamento all’ambiente e che vi è una trasmissione dei caratteri acquisiti (le nozioni, le modifiche culturali, ecc), tant’è che l’idea di sopravvivenza viene adeguatamente corretta, altrimenti si finirebbe per vivere nello stato di natura delineato da Hobbes: oggi si vive molto più a lungo rispetto ad anni addietro perchè è stata superata l’idea secondo la quale solo il più forte possa sopravvivere e sono subentrate forme di solidarietà e norme di comportamento accettate da tutti. Se davvero dovesse continuare ad esistere il darwinismo sociale, nessuno potrebbe campare oltre i quarant’anni, perchè, perse le forze, sarebbe facilmente sopraffatto da uomini nel fiore dell’età. Anzi, nell’uomo tra l’evoluzionismo culturale e l’evoluzionismo biologico c’è quasi conflitto, poichè più si invecchia e più cresce la cultura e diminuisce la forza fisica adatta a sopravvivere nell’ipotetico stato di natura. Ai suoi tempi, però, Spencer credeva di poter applicare le leggi dell’evoluzionismo anche alla società, dando luogo a quello che è passato alla storia sotto il nome di darwinismo sociale : si deve accettare anche nel mondo sociale il criterio secondo cui a sopravvivere è il più forte ed è per questo che Spencer è uno strenuo difensore del liberalismo più sfrenato. Egli riprende quelle considerazioni di Malthus che Darwin si era limitato ad applicare alla realtà biologica e arriva a dire lo Stato non deve assolutamente intervenire con criteri di solidarietà o di agevolazioni, perchè sennò impedisce che maturino le forme di selezione naturale funzionali alla sopravvivenza della società stessa. E a tal proposito, il filosofo inglese opera una sfilza di paragoni tra il mondo biologico e la società umana, facendo notare come, evoluzionisticamente, le società moderne sono più coerenti, più eterogenee e più definite rispetto a quelle antiche: sono più articolate soprattutto in virtù della divisione del lavoro che le caratterizza, ma anche grazie al fatto di essere maggiormente staccate dall’ambiente (e il confronto verte soprattutto sulle differenze tra città moderne e villaggi antichi); e poi nelle società moderne i tessuti che svolgono determinate funzioni sono concentrati in luoghi ben precisi (pensiamo alle zone industriali), proprio come nell’individuo le cellule si differenziaziano qualitativamente e si posizionano in luoghi ben precisi. E’ molto curioso come Spencer raffronti perfino le società e le strutture degli animali: come i molluschi sono protetti dalla corazza, così anche alcune strutture sociali sono (al pari della corazza dei molluschi) rigide, inquadrate da strutture che ne vincolano l’andamento. E a tal proposito Spencer individua due diversi tipi di società: quella industriale e quella militare. Più una società è organica e meno necessita di un apparato esterno che la tenga insieme: ad esempio, la società industriale è talmente articolata e le parti che la costituiscono sono a tal punto legate tra loro che, in linea di principio, potrebbe procedere senza leggi e strutture che la tengano insieme, poichè starebbe tranquillamente in piedi per conto suo. Al contrario, una società che manchi di un apparato industriale evoluto necessita di una struttura che la tenga insieme affinchè non si sfaldi: l’esercito, la polizia, una serie di norme coercitive, ecc; proprio per questo viene da Spencer definita, quasi con senso dispregiativo, “società militare”. Resta ora da chiedersi quale sia il punto massimo a cui può pervenire la conoscenza della realtà: in definitiva, il problema da risolvere è come si possa comprendere il processo evolutivo dell’intera realtà tramite uno strumento di indagine così generale quale è la filosofia secondo Spencer. Egli dice che si devono ipotizzare due cose: una materia e una forza; più precisamente, una massa originaria e informe e una forza che agisca dall’esterno su di essa. Poichè tale forza non agisce in modo assolutamente uniforme sulla materia (vi saranno punti in cui spinge di più e punti in cui spinge di meno), scatta una differenziazione che fa sì che si avvii la reazione a catena che dà vita al processo evolutivo studiato da Spencer.
ROBERTO ARDIGÒ

Roberto Ardigò nacque a Casteldidone (Cremona) nel 1828 e morì a Mantova nel 1920. Ordinato sacerdote nel 1851, smise l’abito ecclesiastico nel 1871. Insegnò storia della filosofia a Padova dal 1881 al 1920. Morì suicida. Fu il più insigne rappresentante del positivismo italiano: abbandonò il sacerdozio e la fede sotto l’influenza della tradizione razionalistica rinascimentale (il suo primo scritto è su Pietro Pomponazzi , uno degli eroi della filosofia rinascimentale appunto). Sostenne l’esclusivo valore della realtà fenomenica e accettò il principio evoluzionista che vuole la morale prodotta dalla convivenza; tra le sue opere meritano di essere menzionate La psicologia come scienza positiva (1870), La formazione naturale nel fatto del sistema solare (1877) , La morale dei positivisti (1879), L’inconoscibile di Spencer e il positivismo (1883), Il vero (1891), La ragione (1894). Alla base della filosofia ardigoiano sta una teoria della sensazione di tipo empiristico, che collega la “formazione delle idee” alle “rappresentazioni sensibili”, attraverso una loro “confluenza” e un correlativo “passaggio dall’indistinto al distinto”. Da questa premessa Ardigò ricava pure conseguenze metodologiche e gnoseologiche. Le idee devono essere provate sui fatti e i fatti si danno nella sensazione; quindi anche la scienza deve confrontarsi coi dati sensibili e coll’esperienza diretta. Correggendosi e crescendo secondo questo metodo positivo che si oppone ad ogni apriorismo e ad ogni assolutizzazione. Si ha così la centralità de “fatto” che ha una propria realtà per sé: ” una realtà inalterabile, una realtà che noi siamo costretti ad affermare tale quale è data e la troviamo coll’assoluta impossibilità di toglierne o di aggiungerci nulla. Dunque il fatto è divino “. Questa divinizzazione del fatto esprime in modo assai caratteristico quella che è la metafisica positiva (o positivistica) di Ardigò. In accordo con la regola fondamentale del positivismo, Ardigò ritiene pertanto che ogni sapere si debba fondare sui dati di fatto. Questi ultimi devono successivamente essere connessi da leggi, ma tra gli uni e le altre rimane comunque un divario epistemologico: solo il fatto è definitivamente e assolutamente certo, mentre le leggi, dipendendo dalla ricerca umana, sono passibili di continua revisione. L’ordinamento dei fatti in base a leggi consente di giungere a considerare la realtà come un unico, grande sistema generale di fatti. A questo sistema, che raccoglie in sé in maniera unitaria e indissolubile sia i fatti fisici sia quelli psichici, diamo il nome di natura, nello stesso senso totalizzante con cui questo termine fu usato nel Rinascimento italiano. Mentre le singole discipline si occupano degli specifici ambiti di fatti e delle generalizzazioni relative a cui essi possono condurre, la filosofia ha per oggetto appunto l’intero sistema dei fatti, ovvero l’intera natura, che costituisce il limite assoluto e definitivo della conoscenza umana. Per questo assume in Ardigò il nome di peratologia , o scienza del limite (dal greco peraV , “limite ultimo”). L’autore che ha più influito sul pensiero di Ardigò è Spencer, dal quale egli accoglie l’estensione del principio dell’evoluzione alla realtà intera. Ardigò apporta, tuttavia, un’importante correzione alla concezione spenceriana dell’evoluzione, riconducendo le tre determinazioni che la caratterizzavano ad una sola: il passaggio dall’indistinto al distinto . Ciò è dovuto al fatto che, mentre Spencer, seguendo Darwin, aveva derivato la sua teoria evolutiva dall’ambito biologico, Ardigò la modella invece sui processi psicologici. Nella sensazione si percepisce dapprima qualcosa di complessivo e di indistinto: solo in un secondo momento la coscienza distingue tra un soggetto (o un “Me”). Questo processo di progressiva distinzione vale però per l’intera natura, la quale non è che una continua successione di momenti più distinti a momenti meno distinti. Ogni distinto è ovviamente a sua volta un indistinto per il distinto successivo, così che il processo non ha mai termine. In questo modo è ricuperabile la nozione di infinito, che non indica altro che l’inesauribile indistinto che non è ancora distinto, cioè appunto finito. Non è invece accettabile (ed è questa la seconda presa di distanza di Ardigò dal suo ispiratore) la concezione che Spencer aveva dell’Inconoscibile, inteso come una realtà prima al di là delle nostre possibilità di conoscenza. Ardigò obietta che l’Inconoscibile non esiste, così come non esiste il noumeno kantiano. Si può parlare soltanto di ignoto , cioè di ciò che finora non è stato spiegato dalla scienza, ma che è necessariamente destinato a diventare noto con il progressivo svilupparsi della nostra conoscenza scientifica. Sempre in ottemperanza ai canoni del positivismo, Ardigò ritiene che tutti i fenomeni siano determinati da leggi necessarie. Accanto alla necessità della legge egli riconosce tuttavia anche la presenza del caso nella natura. Infatti, se ogni serie causale è assolutamente determinata nei suoi passaggi interni, rimane indeterminato il rapporto tra le singole serie legali che si incontrano in tempi e modi assolutamente casuali. In qualche modo, quindi tutti gli aspetti della realtà sono prodotti dal caso; a questa regola non fa eccezione neppure il pensiero umano. Questa correzione del determinismo positivistico mediante l’inserimento del caso non impedisce tuttavia ad Ardigò di sostenere il carattere progressivo, e quindi razionale, dell’evoluzione cosmica, la quale, malgrado dell’incontro casuale delle serie casuali procede necessariamente verso gradi sempre più alti di distinzione. Il determinismo ardigoiano interessa anche i comportamenti umani, escludendo ogni possibilità di libertà del volere. Pertanto, la morale non può essere concepita come un insieme di norme che possono essere liberamente scelte o rifiutate dal soggetto agente. Al contrario, i valori etici sono il frutto del condizionamento della società, che coarta gli individui per reprimere la loro pericolosità sociale e per indirizzarli verso comportamenti collaborativi. Queste norme sociali, tuttavia, sono state con il tempo completamente interiorizzate dagli uomini e si sono quindi tradotte in principi ideali o, come Ardigò si esprime, in idealità umane . Appartengono ad esse, ad esempio, i valori della famiglia e della giustizia, la fede in un “diritto naturale” (che non è che l’introiezione dei fondamenti del diritto positivo) o gli stessi princìpi evangelici. Nella Psicologia come scienza positiva , il filosofo mantovano analizza la sostanza psicofisica del soggetto umano, dalla cui unità si vengono individuando, per successive distinzioni, le varie determinazioni del reale. In particolare Ardigò analizza il “me” (soggetto) e il “fuori di me” (oggetto) che divengono i princìpi capaci di organizzare i poli fondamentali della nostra esperienza (psichicità e materia) attraverso una sintesi che è rivolta verso l’io oppure verso l’esterno (autosintesi o eterosintesi). La stessa realtà naturale è concepita da Ardigò come materia-forza universale che si organizza secondo la legge del passaggio dall’indistinto al distinto. Con La formazione naturale nel fatto del sistema solare (1877) i risultati di riflessione psicologica ardigoiano vengono generalizzati a tutto l’universo. Nel mondo non resta nulla di “in conoscibile” come invece affermava Spencer. L’inconoscibile è soltanto l’entificazione di ciò che è sconosciuto qui e ora, ma che è virtualmente conoscibile dall’uomo e successivamente, di fatto, conosciuto. L’opera di Ardigò che ha suscitato forse più attenzione e più consensi, anche in tempi recenti, è stata La morale dei positivisti (1879) nella quale il positivismo ardigoiano esibisce il suo risvolto antropologico e il suo progetto di fondare sociologicamente l’etica. Contro ogni riduzione materialistica, l’etica di Ardigò tende in particolare a valorizzare il ruolo centrale e positivo degli ideali: essi, pur non essendo empiricamente reali, guidano e regolano l’agire umano. Provata l’esistenza della libertà come autonomia dell’uomo fondata sulla “idealità” volontà come libero arbitrio, attraverso il quale l’essere umano “disegna tipi di cose e di operazioni, che non si trovano nella natura”, Ardigò afferma l’esistenza di valori che chiama “idealità”, e ne sottolinea la convergenza in un fondamentale ideale sociale:
” l’atto umano per eccellenza è l’atto determinato dalla idealità sociale; e tutti gli atti liberi dell’uomo […] rivestono lo stesso carattere di umani in virtù della loro dipendenza da quella idealità […]. E siccome dire atto umano è come dire atto morale, così nella idealità sociale in discorso è tutta la ragione della moralità “ ( La morale dei positivisti, V, 3, I).
GIACOMO LEOPARDI

A cura di Giovanni Ipavec
Oh casi! oh gener vano! abbietta parte / siam delle cose; e non le tinte glebe, / non gli ululati spechi / turbò nostra sciagura, / né scolorò le stelle umana cura. (Bruto Minore)
LA VITA
Giacomo Leopardi nasce a Recanati nel 1798, dal conte Monaldo e Adelaide Antici. Nel 1803 l’amministrazione dei beni familiari è tolta al padre, che si ritira quindi in una velleitaria attività di letterato dilettante, e passa nelle mani della madre. L’atmosfera di casa Leopardi non è felice ed è caratterizzata dall’indole della madre, severa, bigotta e povera d’affetti. Il giovane Giacomo inizia nel 1807 gli studi con i fratelli Carlo e Paolina, inizia a comporre piccoli componimenti poetici e cerca un proprio spazio autonomo all’interno di un’educazione di chiaro stampo controriformistico. Tra il 1813 e il 1816 inizia da solo lo studio del greco; si dedica a ricerche erudite e a varie indagini filologiche sorprendentemente rigorose e precise. Politicamente sposa le idee ultralegittimiste del padre. Nel 1817 pubblica sullo «Spettatore» l’Inno a Nettuno, fingendo trattarsi della traduzione di un originale greco, e due odi apocrife in greco, presentate come autentiche. Inizia la sua amicizia epistolare con Pietro Giordani ed inizia lo Zibaldone, il grande diario intellettuale che continuerà sino al ‘32. Nel 1818 si conclude la sua conversione politica che lo porta a diventare un patriota repubblicano e democratico. Nel 1819 le cagionevoli condizioni di salute lo obbligano a sospendere gli studi; tutto ciò è una spinta a chiarire la propria condizione di solitudine, di noia, e a maturare il suo pessimismo ancora indeterminato. È in questo periodo che scrive L’infinito e Alla luna. nel 1820 continuano le composizioni poetiche come, ad esempio, La sera del dì di festa. Nel 1822 si reca a Roma, il primo viaggio fuori da Recanati: rimarrà molto deluso. Nel 1823 ritorna a Recanati dove analizza la decadenza nazionale e gli effetti nefasti della Restaurazione. Nel 1824 scrive la maggior parte delle Operette morali e l’anno dopo parte per Milano, dove prende contatto con l’editore Stella, e poi passa a Bologna. Nel 1827 si trasferisce a Firenze dove conosce Alessandro Manzoni; i due non si capiranno, troppo diversa è l’indole personale. Nel 1828, finiti i mezzi di sostentamento, dopo aver composto A Silvia, è costretto a far ritorno a Recanati. Nel 1829 compone: Le ricordanze, La quiete dopo la tempesta, Il Sabato del villaggio. Poco dopo aver concluso il Canto notturno, nel 1830, torna a Firenze ed inizia l’amicizia con un esule napoletano: Antonio Ranieri. Nell’aprile 1831, durante i moti dell’Italia centrale, escono i Canti per l’editore Piatti. Nel 1833 Giacomo si trasferisce con il Ranieri a Napoli; i due vivono in condizioni economiche estremamente precarie. Nel 1835 escono i Canti per l’editore Starita di Napoli; vi compaiono nuove poesie tra cui Il passero solitario e il cosiddetto ciclo di Aspasia (Il pensiero dominante, Amore e Morte, Consalvo, A se stesso, Aspasia). Muore, a 39 anni, nel 1837 a Napoli durante un’epidemia di colera: il Ranieri a stento riesce a sottrarne il corpo alla fossa comune.
INTRODUZIONE AL PENSIERO FILOSOFICO
Che Leopardi sia poeta nessuno l’ha messo in discussione. Che sia anche filosofo, invece, è stato oggetto di acceso dibattito. Alla base c’è il fatto che egli ha scritto di filosofia e, per così dire, da filosofo: sullo Zibaldone troviamo tanti e tali pensieri sull’anima, la metafisica, la religione, la società, la natura, la morale, e via dicendo, che l’opera, ancorché disorganica e non sistematica, ben potrebbe configurarsi come trattato filosofico. Né si può dire che manchi a Leopardi lo stile filosofico, perché alcune sue pagine, specie quelle relative alla teoria del piacere, sono di tale rigore e oggettività che sembrano stilate dalla penna di un Locke o di un suo seguace.
Ma non tutti i critici sono d’accordo su questo punto. Il vecchio filone della cultura laicista italiana, da De Sanctis a Croce, nega la filosofia di L., ritenendola scarsamente significativa, non originale né profonda.
Per Francesco De Sanctis (cfr. Schopenhauer e Leopardi), interessato all’uomo e all’artista, essa esprime un superficiale pessimismo, contraddetto dalla poesia, l’unica sua produzione genuina e profonda; il L. filosofo, che odia la vita, con la sua poesia ce la fa amare: “La vita rimane intatta quando ci sia la forza d’immaginare, di sentire e di amare: che è appunto il vivere. Dice l’intelletto: l’amore è illusione, sola verità è la morte. E io amo e vivo e voglio vivere. Il cuore rifà la vita che l’intelletto distrugge”. Vera poesia è l’idillio, che è mera espressione del sentimento; l’elemento raziocinante è un ostacolo, un pericolo, dal quale il poeta non riesce sempre a guardarsi nei “piccoli idilli”, quasi più nei Canti scritti dopo il ’30.
Benedetto Croce riprende la contrapposizione, ma restringe ancor più il campo poetico: la poesia del recanatese gli sembra oscillare tra filosofia e letteratura, quasi mai riuscendo a tenere la rotta mediana (di qui la sua sostanziale e netta stroncatura).
Una nuova linea, che rivaluta L. filosofo, è aperta nei decenni tra le due guerre. Giovanni Gentile, che legge L. con interessi filosofici, nell’intento di rivalutare le Operette morali, arriva ad affermare che L. è autentico e grande filosofo. Nel 1940 Adriano Tilgher sostiene che esiste una filosofia di L., che non è sistematica né procede per astrazioni (L. non indaga i problemi gnoseologici o metafisici); essa ora si serve di un’espressione lirica o letteraria (Canti, Operette morali), ora è comunicata in modo immediato, solitamente non elaborato, attraverso lo Zibaldone.
Nel dopoguerra si assiste ad un sostanziale rinnovamento degli studi leopardiani, grazie prevalentemente agli apporti della critica storicistico-marxiana, la quale mette in risalto l’ultimo L. (la produzione posteriore al ’30), sostenendo l’eccellenza del poeta impegnato e progressivo contro quello isolato e solitario dell’idillio. Saggi fondamentali sono i seguenti: L. progressivo di Cesare Luperini (Firenze, 1947), La nuova poetica leopardiana di Walter Binni (Firenze, 1947), Alcune osservazioni sul pensiero di L. di Sebastiano Timpanaro (Pisa, 1965), La protesta di L. di W. Binni (Firenze, 1973), La posizione storica di G.L. di Bruno Biral (Torino, 1974), L. – Schizzi, studi e letture di Carlo Muscetta (Roma, 1976). Questi contributi, tutti contrassegnati da una decisa matrice ideologica, individuano una linea “eroica” del pensiero leopardiano (L. consapevolmente eroico di fronte al proprio destino), pensiero che, non elevato al rango di filosofia, non è più un ostacolo alla poesia, ma piuttosto il suo vitale nutrimento. Notevole il saggio di Umberto Bosco Titanismo e pietà in G.L. (Firenze, 1957) per il tentativo di spiegare tutto il percorso intellettuale del poeta alla luce del motivo eroico-titanico.
Infine, entro l’ambito di una critica prevalentemente stilistica si sono mosse le ricerche di Bigongiari, Getto, Ramat, Solmi e Bigi.
In conclusione, mentre per alcuni studiosi L. è un filosofo esistenziale, che si pone problemi di ordine pratico-morale (la vita ha un senso? può l’uomo essere felice? dopo la morte c’è qualcosa o con la morte finisce tutto?), la maggior parte dei critici concorda oggi nel ritenere che L. non possa essere considerato filosofo per il fatto che, pur avendone l’attitudine e i mezzi “culturali”, era viziata in partenza la sua volontà di speculazione. Egli infatti, sollecitato da motivi biografici e storico-culturali (vedi sotto il punto 2), assunse sin dall’inizio un atteggiamento critico negativo nei confronti della vita e dei valori che essa esprime, considerati alla stregua di miti e illusioni. Tali convincimenti, penetrati profondamente e per tempo nel suo pensiero, ne condizionarono di fatto l’attività e gli intendimenti, cosicché, quando L. disporrà degli strumenti filosofici, se ne servirà non per sottoporre a critica razionale il suo atteggiamento di base, bensì per rafforzarlo, per aumentarne la consistenza logica e la naturale persuasione. Così facendo, però, si precludeva la via alla vera filosofia: il giudizio, se segue e scaturisce dall’analisi, è oggettivo e logicamente valido, ma se la precede diventa pregiudizio e strumentalizza e vizia gli esiti di quella.
2 – La formazione di Giacomo (1798-1816)
La genesi del pensiero di L. appare determinata da una progressiva presa di coscienza della propria infelicità. All’origine di questa si possono individuare due diversi ordini di fattori: biografico-ambientali e storico-culturali.
Tra i primi l’atmosfera affettivamente carente della sua famiglia e l’educazione retrograda e autoritaria, impartita da una madre bigotta e formalista e da un padre conservatore e chiuso; poi la formazione isolata e solitaria, da autodidatta, quello “studio matto e disperatissimo” che contribuì all’insorgere di diverse malattie croniche e alla malformazione fisica. Al gelo dei rapporti familiari vanno aggiunti lo scherno e la derisione dei concittadini, la mediocrità e la scarsa cultura dell’ambiente recanatese, la precoce sensibilità e la vivace intelligenza di Giacomo.
Motivi di ordine storico-culturale furono la crisi dell’illuminismo e l’insorgere inizialmente indistinto e confuso di nuove ideologie, la perdita d’identità e di funzione politico-civile dell’intellettuale, l’arretratezza sociale e culturale dello stato pontificio.
Né va dimenticato che il periodo storico in cui Giacomo raggiunge la maturità è l’età della Restaurazione, caratterizzata dal conflitto tra nazionalismo, liberalismo e romanticismo da una parte, cosmopolitismo, assolutismo e classicismo dall’altra. In ambito letterario nasce e si sviluppa la polemica classico-romantica attizzata dall’articolo di M.me de Stael, nella quale interviene anche L. (vedi sotto il punto 3).
Punto di partenza della speculazione leopardiana, volta a tentare di chiarire il senso della vita, è dunque il disagio esistenziale dell’autore, ovvero la sua infelicità fisica e psicologica. Tale disagio è all’origine di un pessimismo di tipo esistenziale, le cui caratteristiche si possono compendiare come segue: precoce venir meno delle illusioni e dei sogni infantili, sfiducia nella vita, sentimento (non ancora razionalizzato) di desolazione e di delusione, insofferenza verso i condizionamenti, sensazione di inutilità e di soffocamento.
3 – La fase del pessimismo storico (1816-1820)
Il pensiero leopardiano prende l’avvio da una meditazione sull’infelicità in sé, della quale vengono indagate le cause, le dinamiche e le conseguenze.
Alla base c’è la teoria dell’amor proprio (di derivazione illuministica), secondo la quale l’uomo è un essere che ama necessariamente se stesso e mira alla propria conservazione e alla propria felicità. L’altruismo è un controsenso: quando io faccio del bene ad un altro è perché provo piacere, quindi lo faccio sempre a me stesso. L’altruismo non è il contrario dell’egoismo, ma è una sublimazione dell’amor proprio, in quanto esistere significa amare se stesso, cercare la propria felicità. L’amor proprio non coincide con l’egoismo: quest’ultimo è una degenerazione dell’amor proprio causata dallo sviluppo della civiltà e dal predominio della ragione; è uno degli esiti di quel progresso storico negativo, all’indietro, che è, secondo L., il passaggio dai primitivi ai civilizzati. L’amor proprio è fonte di nobili azioni, di sacrifici eroici; l’egoismo, invece, è calcolo meschino. L’amor proprio è la volontà di potenza dei forti, l’egoismo è il calcolo razionale del debole che uccide la vita.
L. respinge le ideologie ottimistiche e le utopie rassicuranti del suo secolo, si ribella alla meschinità del suo tempo e alle convenzioni del suo ambiente, che giudica arido e gretto; rimpiange un mondo mitico di nobili virtù e di valori incorrotti, in cui gloria e fama, unici antidoti contro il grigiore della vita, erano possibili, conseguibili. Si scaglia con veemenza contro i miti dell’Ottocento, la storia e il progresso, e contro la stoltezza di un secolo che dalla filosofia della storia di Hegel fino al balletto Excelsior esalta l’uomo come creatore della realtà. Per L. si tratta di un antropocentrismo fanatico, al quale egli si oppone con forza, affermando che la storia non è progresso, ma regresso dal primitivo stato di natura, buono e felice, allo stato di civiltà, corrotto e decadente.
Nella storia del genere umano si distinguono quattro tappe:
1) l’età primitiva, quando gli uomini vivevano in uno stato di perfezione e di innocenza anteriore alla civiltà;
2) l’antichità classica, civiltà che L. ammira come sintesi equilibrata di natura e ragione (nello Zibaldone sostiene la superiorità del politeismo greco-romano rispetto alla religione cristiana);
3) il medioevo, nel giudicare il quale L. incorre nei tipici luoghi comuni dell’illuminismo (secoli bui, epoca negativa, trionfo della barbarie);
4) l’età moderna, con il predominio assoluto della ragione, la freddezza, il convenzionalismo, il calcolo, la funzionalità, in una parola la vita inautentica.
L. rifiuta il progresso civile e tecnologico, convinto che sia negativo in sé, poiché l’incivilimento è snaturamento, allontanamento dalla natura: il mondo è sempre più corrotto e non può essere corretto. Netta, quindi, per L. l’antitesi tra la remota grandezza e la miseria morale e materiale odierna.
L’antagonismo di L. con gli orientamenti spirituali e culturali del proprio tempo si manifesta anche nell’impegno in favore dei classicisti, i quali devono assolvere il duplice compito di riproporre i valori classici, che hanno funzione liberatoria e di stimolo delle coscienze, e di scrivere per il proprio tempo (= alfierismo).
Causa della decadenza è la ragione, “nemica della natura”, corruttrice dei costumi, madre della civiltà e della società con tutti i loro egoismi, distruttrice del rimpianto mondo eroico. Sogno è ritrovare la “favilla antica”, cioè la vivacità dell’immaginazione, la forza delle illusioni, la vitalità dell’ieri contro la delusione dell’oggi, attraverso il meccanismo della ricordanza.
Come già il Foscolo, anche L. avverte la necessità delle illusioni (gloria, amor proprio, amor di patria, libertà, onore, virtù, amore per la donna), che sono secondo natura e costituiscono l’unico antidoto agli effetti della civiltà e della ragione, i quali hanno guastato il mondo moderno, “tristissimo secolo di ragione e di lume”; e come il Foscolo nei Sepolcri, così anche L. concepisce la poesia come stimolatrice di illusioni.
Tutta la storia del genere umano è la storia della lotta tra la felicità e il vero, tra l’illusione e la realtà, tra la vita e il sogno. La realtà è banale e cattiva, vere sono solo le illusioni, ossia le speranze, di cui l’umanità si nutre e che non può abbandonare senza cadere nella disperazione. “Larve” definisce L. le illusioni in cui l’uomo crede nella sua età giovanile, ovvero in quel “sabato del villaggio” che precede il giorno più noioso che è il giorno della “festa di sua vita”; sono le illusioni che impediscono di scorgere la tragedia del vivere. E le illusioni rappresentarono veramente l’unica motivazione alla vita per l’adolescente Giacomo, che le ricorda con accenti commossi in uno degli squarci più elevati della sua lirica, i vv. 77-103 delle Ricordanze.
La realtà è illusoria: manifestando un’evidente consonanza con Schopenhauer, L. sostiene la coincidenza di vita e sogno, essendo la realtà niente altro che sogno, come scrive Calderòn de la Barca. Questo concetto è ribadito nelle opere della maturità (Operette morali e Canti posteriori al ’27). Nel Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare si legge: “Sappi che dal vero al sognato non corre altra differenza se non che questo può qualche volta essere molto più bello e più dolce, mentre quello non può esserlo mai”. E il verso conclusivo di A se stesso (“l’infinita vanità del tutto“) sottolinea che il vero è nemico della felicità. L. mostra qui il suo paradosso: un’educazione illuministica che si rivolta contro l’illuminismo, un illuminista antiilluminista, un uomo educato al culto della ragione (che dissipa le tenebre della superstizione e liquida come favole le verità della religione), il quale distrugge i miti stessi dell’illuminismo e afferma la superiorità rispetto al vero di ciò che è pensato, sognato e sperato. Nel Dialogo di Timandro e di Eleandro tale concezione è così espressa: “Si ingannano grandemente quelli che dicono e predicano che la perfezione dell’uomo consiste nella conoscenza del vero, e tutti i suoi mali provengono dalle opinioni false e dall’ignoranza, e che il genere umano allora finalmente sarà felice, quando ciascuno o i più degli uomini conosceranno il vero, e a norma di quello solo comporranno e governeranno la loro vita.” L. nega in tal modo l’essenza, il “vangelo” dell’illuminismo: la felicità è data non dalla conoscenza del vero, bensì dalla sua ignoranza; sapere di più significa soffrire di più, e chi aumenta la conoscenza aumenta anche il dolore, come dice la Bibbia. Tutta la poesia A Silvia esprime in termini altamente lirici questa concezione.
In conclusione, la sostanza del pessimismo storico leopardiano si esprime in quattro antinomie, nelle quali il primo termine ha valenza positiva, il secondo negativa:
| valenza positiva | valenza negativa | |
| natura | vs | ragione |
| antico | vs | moderno |
| stato naturale | vs | società |
| illusione | vs | vero |
4 – La fase del pessimismo cosmico (1823-1830)
A partire dagli anni del cosiddetto “silenzio poetico” (1823-27) L. opera un progressivo ribaltamento della concezione iniziale, giungendo a riabilitare la ragione contro la natura.
Continuando ad analizzare le cause dell’infelicità umana, egli osserva che il naturale impulso vitale è contrastato e ostacolato, a livello individuale, da un duplice limite, biologico e ontologico; a livello storico da un terzo limite, l’egoismo, che egli definisce “peste della società”.
Il limite biologico consiste nell’intrinseca debolezza dell’uomo, il quale, al pari di ogni altro essere vivente, è subordinato al ciclo meccanicistico della materia. Di qui la scoperta della propria fragilità e solitudine.
Il limite ontologico è dato dall’impossibilità di essere felici: la natura genera nell’uomo una tensione irrefrenabile verso la felicità, un anelito costante al piacere, ma la felicità è irraggiungibile, giacché, in quanto tale, deve essere infinita e pienamente appagante; di conseguenza la ricerca di essa conduce inevitabilmente ad una finita e concreta infelicità. I piaceri momentanei che si provano nella vita non sono altro che una tregua relativa e passeggera dell’infelicità.
Per comprendere a fondo queste ultime affermazioni, occorre rifarsi alla teoria leopardiana del piacere, secondo la quale il piacere non né è assoluto né infinito; anzi, il piacere in sé non esiste: esiste solo nel desiderio, essendo un “subbietto speculativo”, vale a dire un puro concetto. Il desiderio è immaginazione, speranza, sogno, proiettato sempre al futuro e sempre destinato ad essere deluso. Invece del piacere esistono i piaceri, intesi in senso negativo come cessazione dell’affanno, brevi momenti di assenza del dolore; concreti ed effimeri, rendono sopportabile il dolore, restituendo momentaneamente la vitalità, l’impulso vitale.
La teoria del piacere, il cui carattere è negativo, è strettamente legata alla teoria dell’amor proprio. L’amor proprio, infatti, implica la ricerca della felicità, ma questa ricerca è senza esito, non può avere fine, quindi non può mai appagarsi. L’uomo cerca il piacere sempre, ma non può accontentarsi del piacere che trova, che è finito; egli è pertanto destinato a cercare il piacere in qualcosa di sempre diverso, di sempre più alto: ciò significa che non lo trova mai. La tragicità della condizione umana è in questa ricerca dell’infinito, che conduce sempre allo scacco.
Il piacere è sempre sperato, mai posseduto, sempre futuro, mai presente: esso sfugge sempre. Non esistendo e non potendo esistere realmente, esiste solo nel desiderio del vivente e nella speranza o aspettativa che ne segue. In base a questa teoria il concetto di piacere è negativo, quello di dolore è positivo, per cui si può dire che il piacere è la mancanza del dolore, ma non si può dire che il dolore è la mancanza del piacere, ovvero di qualcosa che non esiste. Il concetto è espresso poeticamente nei seguenti versi tratti da La quiete dopo la tempesta:
| Piacer figlio d’affanno; Gioia vana ch’è frutto Del passato timore (…). … … Uscir di pena È diletto fra noi. Pene tu (= la Natura) spargi a larga mano; il duolo Spontaneo sorge: e di piacer, quel tanto Che per mostro e miracolo talvolta Nasce d’affanno, è gran guadagno. |
È questa la concezione del piacere negativo, perché, se per caso cessa il dolore, di cui il piacere è la negazione, non subentra il piacere, ma qualcosa di peggio, che nella dialettica di L. è la noia. Il dolore, infatti, non esclude che l’uomo cerchi e speri di superarlo, mentre la noia è angoscia e disperazione. E allora, per L. come per Schopenhauer, la vita oscilla inarrestabilmente come un pendolo tra il dolore e la noia, in un eterno meriggio privo di tramonto ristoratore.
Il limite storico è dato dalla inconciliabilità di individuo e società, tra i quali si determina uno scontro di egoismi. L’atteggiamento dei singoli è antisociale: ognuno cerca sempre di avere di più, di soverchiare gli altri, di sottomettere tutto e tutti al proprio utile o piacere. E ciò per natura. Ne consegue che tutte le società sono state cattive (superamento del pessimismo storico) e che, a causa appunto dell’egoismo e dell’aggressività umani, ci si avvia inesorabilmente alla distruzione del mondo, già data per avvenuta nel Dialogo di un folletto e di uno gnomo. Di qui la polemica contro l’ingenua fiducia del XIX secolo nel progresso scientifico e tecnologico, nelle macchine, nell’espansione economica, che comporta lo sfruttamento industriale e il colonialismo.
Considerati i tre suddetti limiti, L. conclude che tutto è male. Esistere equivale ad essere perennemente insoddisfatti, incontentabili, a soffrire per la propria fragilità. Il bene consiste nel non esistere. Responsabile del male è la natura, non più vista come provvida e benefica madre, bensì come causa dell’infelicità umana. Essa con l’esistenza ci dà i germi dell’infelicità, essendo l’insopprimibile bisogno di felicità destinato a restare insoddisfatto.
Documenti (testi che testimoniano la rottura del rapporto con la Natura):
a. La sera del dì di festa (idillio, 1820);
Cfr. vv. 11-15:
| … io questo ciel, che sì benigno Appare in vista, a salutar m’affaccio, E l’antica natura onnipossente, Che mi fece all’affanno. A te la speme Nego, mi disse, anche la speme; e d’altro Non brillin gli occhi tuoi se non di pianto. |
Commenta G. Oliva: “Il sonno silenzioso e tranquillo della donna si fa metafora di una indifferenza ben più dolorosa per il L.: quella della Natura, che mostra agli uomini il suo aspetto più delicato (il cielo, che sì benigno appare in vista) solo per nascondere la sua malvagia crudeltà”.
b. Ultimo canto di Saffo (canzone, 1822);
Imperscrutabile è il destino dell’uomo; uniche certezze sono il dolore e la morte:
| … i destinati eventi Move arcano consiglio. Arcano è tutto, Fuor che il nostro dolor. Negletta prole Nascemmo al pianto… Morremo. |
La Natura è beffarda, insensibile al dolore dell’uomo, intenta solo a perpetuare se stessa; come nella Sera del dì di festa cela sotto una struggente immagine di bellezza il suo disdegno (cfr. vv. 19-36). L. non sa proporre alcuna soluzione in grado di superare il dolore del mondo; l’assurdo non può essere vinto, ma solo accettato come tale. L’uomo non può sperare di vincere il nulla, da cui è sorto e a cui farà ritorno, ma può solo identificarsi con esso in un’operazione che ricorda quella orientale del “nirvana”, dell’annullamento.
c. Zibaldone (dal 1821);
Nella sua condanna della Natura il L. rifiuta qualsiasi provvidenzialismo, qualsiasi consolazione religiosa, qualsiasi soluzione irrazionale; al contrario, rivaluta pienamente la ragione: è la ragione che disinganna e guida l’uomo alla vera sapienza, che consiste nel prendere coscienza della propria inutilità; è la ragione che “atterra” (cioè riporta sulla terra dal cielo della metafisica) l’uomo e lo pone davanti all’ arido vero; è la ragione, infine, che scopre che tutta l’umanità è accomunata da un unico e identico destino (superamento del pessimismo individuale e psicologico).
d. Dialogo della Natura e di un Islandese (O.M., 1824);
Ogni tentativo di agonismo è votato a disfatta: la Natura è invincibile ed è indifferente alla felicità o meno dell’uomo. L’universo è dominato dall’irrazionalismo e dal casualismo: non c’è una ragione, un senso; non c’è un fine, una creazione, un orientamento; tutto è abbandonato al caso. Del tutto inutile è la ricerca di un significato: la Natura non dà risposte. L’estrema domanda dell’Islandese (“Dimmi quello che nessun filosofo mi sa dire: a chi piace o a chi giova cotesta vita infelicissima dell’universo, conservata con danno e con morte di tutte le cose che lo compongono?”) rimane senza risposta.
e. Cantico del gallo silvestre (O.M., 1824);
L’essere esiste, ma non c’è nessuna ragione perché esista anziché perché non esista; la vita non ha senso, né ha alcun senso la realtà. I positivisti, che collegavano il pessimismo di L. alle sue condizioni fisiche, nel centenario della nascita ne riesumarono il corpo per misurarlo ed espressero la tesi che egli, essendo infelice e gobbo, doveva diventare fatalmente pessimista. Ma tale tesi è del tutto insostenibile: il pessimismo di L. non è di ordine psicologico, bensì cosmico, poiché riguarda la realtà tutta, non solo l’uomo, né tanto meno l’uomo Giacomo Leopardi. Il quale, nella pagina più terribile delle Operette morali denuncia il radicale non senso della realtà. Si tratta della parte conclusiva del Cantico del gallo silvestre: “Tempo verrà, che esso universo, e la natura medesima, sarà spenta. E nel modo che di grandissimi regni ed imperi umani, e loro maravigliosi moti, che furono famosissimi in altre età, non resta oggi segno né fama alcuna: parimente del mondo intero, e delle infinite vicende e calamità delle cose create, non rimarrà pure un vestigio; ma un silenzio nudo, e una quiete altissima, empieranno lo spazio immenso. Così questo arcano mirabile e spaventoso dell’esistenza universale, innanzi di essere dichiarato né inteso, si dileguerà e perderassi”.
f. A Silvia (idillio, 1828);
La Natura tradisce, è matrigna, non mantiene le promesse, inganna, spegne le illusioni:
| O natura, o natura, Perché non rendi poi Quel che prometti allor? perché di tanto Inganni i figli tuoi? |
La vita si rivela aridità e disillusione:
| All’apparir del vero Tu, misera, cadesti: e con la mano La fredda morte ed una tomba ignuda Mostravi di lontano”. |
g. Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (idillio, 1830).
Il desiderio di sapere la verità non è appagato; uniche certezze il vuoto e il nulla; l’esistenza è assurda. “Perché siamo nati?”. A questa domanda L. risponde: “Per mostrare che era meglio che non nascessimo affatto”: per questo, non appena un bambino è nato, noi prendiamo a consolarlo dell’essere venuto al mondo. E forse la definizione più precisa del pessimismo cosmico, del non senso dell’essere, si trova in questa grande lirica, che è stata chiamata l’”anti Divina Commedia”, perché, se la Divina Commedia è senso dell’ordine, della provvidenza, della finalità, il Canto notturno, all’opposto, esprime una visione della vita improntata ad un totale casualismo. Effetto di questa presa di coscienza è il tedio, la noia, definita “la più sterile delle passioni umane”, “figlia della nullità e madre del nulla”, ma anche “il più sublime dei sentimenti umani”. Essa è tormento, è l’esaurirsi del mito vitalistico, è privazione del desiderio, è coscienza dell’inutilità del tutto; ed è sentimento nobile, perché distingue gli spiriti più sensibili e dotati. In questo risiede la grandezza dell’uomo.
In conclusione, una valida sintesi delle concezioni su cui si fonda il pessimismo cosmico di G.L. può essere la seguente:
- L’uomo nasce per il dolore e la gioia è cessazione momentanea dell’affanno.
- Dal punto di vista dell’uomo (piano esistenziale) tutto l’universo sembra cospirare contro di lui. Da quello dell’’ssoluto (piano metafisico) la vita è un processo naturale che alterna gli esseri attraverso la generazione e la morte.
- La natura, intesa come forza bruta e malefica, è responsabile della nostra sventura.
- L’uomo conosce il suo destino, ma ciò lo rende infelice, poiché da questa comprensione egli viene ricondotto in se stesso, alla sorgente prima della sua infelicità, che è il suo stesso esistere. Perciò la morte è l’unico rifugio per il vivente.
5 – L’ultimo Leopardi: il pessimismo eroico (1827-1837)
Dopo il definitivo addio a Recanati del 30 aprile 1830 il pensiero di L., sia sul piano ideologico sia su quello etico, fa registrare una svolta (anticipata dal Dialogo di Plotino e di Porfirio del 1827) nel senso di un superamento della visione materialisticamente negativa e nichilista maturata nella fase del pessimismo cosmico, per un messaggio agonistico positivo (di difficile comprensione e attuazione, perché “non apprezzato in questo secolo”).
Le ragioni di tale svolta sono molteplici e si possono sintetizzare nei punti seguenti:
- L’amicizia, per quanto effimera, con i liberali toscani dell’ Antologia.
- La fallimentare esperienza dell’amore (ultima delusione in ordine di tempo il rifiuto ottenuto da Fanny Targioni Tozzetti, che fu all’origine del Ciclo di Aspasia).
- I contrasti con gli spiritualisti napoletani dopo il trasferimento a Napoli in casa di Antonio Ranieri.
- L’assidua pratica della filologia, improntata a severo rigore scientifico, nella ricerca di risposte non evasive né fideistiche al dramma esistenziale.
- La scoperta del linguaggio satirico come strumento espressivo del titanismo e del pessimismo.
- La lettura di Epitteto (filosofo stoico greco, autore del Manuale) e di Teofrasto (discepolo di Aristotele, propugnatore dell’empirismo materialistico).
- Il superamento dell’etica stoica e dell’atteggiamento apolitico (dall’atarassia alla partecipazione).
- L’esigenza di un atteggiamento eroico e di una morale costruttiva, fondata esclusivamente sull’uomo e aliena dal trascendente.
Nel ricostruire, attraverso i documenti, le tappe di questa fase del pensiero leopardiano, troviamo nel Dialogo di Plotino e di Porfirio del 1827 la prima espressione della necessità di una solidarietà umana di fronte al destino. Il dialogo, incentrato sul tema del suicidio e volto a chiarire le ragioni che lo respingono come soluzione al dramma esistenziale, si conclude con un‘appassionata esortazione rivolta da Plotino all’amico: “Viviamo, Porfirio mio, e confortiamoci insieme: non ricusiamo di portare quella parte che il destino ci ha stabilita, dei mali della nostra specie. Sì bene attendiamo a tenerci compagnia l’un l’altro; e andiamoci incoraggiando, e dando mano e soccorso scambievolmente; per compiere nel miglior modo questa fatica della vita. La quale senza alcun fallo sarà breve. E quando la morte verrà, allora non ci dorremo: e anche in quell’ultimo tempo gli amici e i compagni ci conforteranno: e ci rallegrerà il pensiero che, poi che saremo spenti, essi molte volte ci ricorderanno, e ci ameranno ancora.”
Due anni più tardi L., in una famosa pagina dello Zibaldone, dissipa con forza i sospetti di misantropia di cui era fatto oggetto il suo pensiero: “La mia filosofia non solo non è conducente alla misantropia, come può parere a chi la guarda superficialmente, e come molti l’accusano; ma di sua natura esclude la misantropia, di sua natura tende a sanare, a spegnere quel mal umore, quell’odio, non sistematico, ma pur vero odio, che tanti e tanti, i quali non sono filosofi, e non vorrebbero esser chiamati né creduti misantropi, portano però cordialmente ai loro simili (…). La mia filosofia fa rea d’ogni cosa la natura, e discolpando gli uomini totalmente, rivolge l’odio, o se non altro il lamento, a principio più alto, all’origine vera dei mali dei viventi.”
Ma L. non trova rispondenza né comprensione nella classe politica e intellettuale del suo tempo, la quale professa fiducia nelle magnifiche sorti e progressive. Contro l’ottimismo storicistico del secolo, che egli giudica stolto, e contro lo stesso impegno politico e legislativo, che egli vede animato dalla sterile e ridicola pretesa di procurare agli stati il benessere e la felicità ignorando le reali esigenze degli individui, L. intraprende una vigorosa crociata solitaria. In una lettera al Giordani del 1828 scrive: “Mi comincia a stomacare il superbo disprezzo che qui si professa di ogni bello e di ogni letteratura: massimamente che non mi entra poi nel cervello che la sommità del sapere umano stia nel saper la politica e la statistica. Anzi, considerando filosoficamente l’inutilità quasi perfetta degli studi fatti dall’età di Solone in poi per ottenere la perfezione degli stati civili e la felicità dei popoli, mi viene un poco da ridere di questo furore di calcoli e di arzigogoli politici e legislativi; e umilmente mi domando se la felicità dei popoli si può dare senza la felicità degl’individui.” La polemica di L. è particolarmente dura contro il liberalismo cattolico e moderato, come attesta la satira dei Nuovi credenti, e la sua condanna coinvolge ogni tipo di conformismo, sia reazionario, sia liberale.
Negli ultimi anni L. abbandona il pessimismo più “metafisico” per acquisire un atteggiamento più “relativistico”, fondato sul riconoscimento di un doppio piano della verità, quello dell’”ordine delle cose” e quello del “modo dell’esistenza”, e, di conseguenza, di una duplice matrice del dolore. “C’è il dolore che deriva dall’ordine delle cose, dunque legato all’essenza stessa della vita e, come tale, è ineliminabile se non a costo della rinuncia alla vita stessa (si tratta del dolore inflitto all’uomo dai “mali esterni”, ai quali non ci si può sottrarre: malattie, eventi atmosferici, cataclismi, deperimento dovuto a vecchiaia). C’è poi un altro tipo di sofferenza, che invece rimanda al mondo dell’esistenza, cioè alla qualità della vita, alla storia, alla cultura. Questo secondo tipo di dolore può essere invece combattuto e rimosso in quanto dipende non dalla natura, ma dall’uomo: di qui il recupero del vitalismo e la scoperta, da parte della poesia leopardiana, della dimensione sociale.
Il male storico dipende dal libero sfogo dell’egoismo umano: noi viviamo tutti per la morte e, anche se accomunati dalla stessa miseria della vita e dall’odio implacabile della Natura, tendiamo a contrapporci l’un l’altro per desiderio di affermarci, voglia di prevalere, che sono la manifestazione degli istinti più bassi. Così accresciamo il già grande male di vivere. Ma l’uomo è essere razionale, soggetto di cultura, dunque può controllare i bassi istinti, che sono fondamentalmente antisociali, e produrre valori alternativi come la compassione, la solidarietà, l’amicizia, che invece fondano la società. E’ questo il compito della ‘filosofia dolorosa ma vera’, che riconosce francamente il male della vita e mostra concretamente come esso possa essere mitigato. Questo è il compito del nuovo poeta, che così recupera la funzione di vate al servizio tanto della verità quanto dell’intera umanità e si fa promotore di autentica cultura e autentico progresso sociale.”
L’etica della solidarietà è il tema centrale della Ginestra, concepito come un messaggio indirizzato sia ai contemporanei sia ai posteri: si impone una grande alleanza fra tutti gli uomini, una social catena che coalizzi i mortali contro l’empia Natura e abbia il coraggio della verità, rifiutando l’idea di una Provvidenza e le superbe fole del secol superbo e sciocco.
Il messaggio finale di L. è frutto di un razionalismo irriducibile. Progressismo e pessimismo convivono in quest’ultima fase del suo pensiero, caratterizzata dalla speranza che la riconquista del giusto sapere sia il fondamento di una società nuova, costruita con le sole forze umane.
INTRODUZIONE AI PARALIPOMENI
A cura di Giuseppe Bonghi
Leopardi scrive questo poemetto satirico di otto canti in ottave, presentandolo come continuazione del poema pseudomerico Batracomiomachia, che era stato tradotto per ben tre volte dal Leopardi:
1815 La guerra dei topi e delle rane
1821-1822 Guerra de’ topi e delle rane
1826 Guerra dei topi e delle rane
Leopardi finge che il poema sia tratto da antiche pergamene e che sia all’improvviso interrotto e non continuabile, per quanto abbia interrogato le antiche fonti.
Incerta è la data di composizione del poemetto, che sicuramente non viene cominciato prima del 1831, e questo lo si può dedurre dall’accenno alla sconfitta dei Belgi a Lovanio il 12 agosto 1831 e alla morte del Niebuhr avvenuta il 2 gennaio 1831. Quasi certamente vi lavorò mentre si trovava a Napoli nel 1834 e vi lavorò fino alla morte lasciandolo incompiuto, nel senso che non riuscì a dargli una veste definitiva. In una lettera scritta l’11 dicembre 1846 da Giuseppe Giusti a Vincenzo Gioberti.
Dei Paralipomeni abbiamo due copie manoscritte: una è fra le carte napoletane ed è di mano di Antonio Ranieri (ma il primo canto è di mano del poeta); l’altra è fra le carte che il Ranieri lasciò alla biblioteca nazionale di Napoli, ed è interamente di mano del poeta. Fu pubblicato per la prima volta nel 1842 a Parigi, per i tipi della Libreria europea di Baudry.
Con i Paralipomeni Leopardi scrive dei suoi tempi, ma erano tempi legati a un certo immobilismo: la napoletanità di Topaia, la città-stato dei Topi lo dimostra. Ma ne parla in modo letterario, lontano dai veri problemi sociali e politici che affannavano l’epoca della Napoli che lui ha conosciuto negli ultimi anni della sua vita, che non gli entrerà mai dentro e della quale conoscerà a malapena certi aspetti esteriori, riassumibili nelle vicende di Pulcinella e Colombina, che venivano rappresentati dai teatranti di strada col teatro dei pupi, unico divertimento della gente che si accalcava davanti al teatrino e partecipava in modo diretto alle vicende con incitamenti e richieste che spesso cambiavano la stessa vicenda come in una specie di “Commedia dell’arte” . È vero che i Topi sono i liberali italiani, le Rane i papalini e i Granchi i reazionari austriaci e l’autore crede di essere il Malpensante, il personaggio Assaggiatore, cioè l’uomo antiretorico e anticonformista, ma è anche vero che di quell’epoca non riesce a cogliere né la realtà storica né la realtà umana della gente che lo circondava, troppo assorbito forse dalla vasta e profondamente dolorosa vicenda personale.
I Paralipomeni sono un poemetto incompleto, perché manca una conclusione strutturalmente valida (troppo debole e letteraria risulta il marchingegno della trovata del manoscritto interrotto) e manca soprattutto un’idea-guida intorno alla quale far girare l’intera vicenda, che pure non manca di spunti importanti e sul piano poetico di ottave interessanti: e l’idea-guida poteva essere solo, in quei frangenti storici e la presenza dei tre gruppi Topi-Rane-Granchi, la soluzione di un’Italia unita; ma noi non sapremo mai, leggendo questo poemetto, cosa veramente Leopardi pensasse dell’Italia e della sua unificazione.
Dei Paralipomeni così scrive Novella Bellucci in Per leggere Leopardi, (Bonacci, Roma 1988, p. 194): “Con questa satira politica … Leopardi ha insegnato ai posteri una lettura certamente non conformista degli eventi prerisorgimentali, elaborata sullo sfondo di uno scenario di cui ormai l’autore ha smascherato ogni ornamento pseudoculturale o ideologico, ogni supporto aprioristico e consolatorio. Va tenuto presente che lo spirito polemico del poemetto è indirizzato verso dei destinatari concreti, i liberali in genere (molti Leopardi ne aveva conosciuti e frequentati nel soggiorno fiorentino), ma soprattutto gli spiritualisti cattolici della Napoli in cui si trovò a vivere negli ultimi anni della vita; eppure le ottave dei Paralipomeni, mentre si misurano con la polemica concreta, si situano anche in una prospettiva più generale, si riconducono al complessivo discorso poetico dell’ultimo Leopardi: sopra e oltre le vicende degli uomini, le loro micro e macro storie, incombe un “sistema” antiprovvidenziale, ugualmente indifferente a umani e bestie, impossibilitato nei suoi meccanismi essenziali a mutare o migliorare, identificabile con una natura “carnefice e nemica” o almeno non finalizzata alla cura degli eventi.”
Queste parole sono apparentemente chiare, ma difficili da capire per i nostri magri studenti (avrebbe, ad esempio, almeno potuto spiegare che cosa significa supporto aprioristico e consolatorio in un autore che chiede così poco di essere consolato ma tanto di sentire vicino una presenza amica); e noi le abbiamo riportate perché ci servono per mettere in evidenza due elementi, che appartengono non solo alla comprensione di questo poemetto, ma all’intera poetica leopardiana e che possiamo così enucleare:
1) il poemetto è indirizzato realisticamente a certi gruppi di persone, i liberali che aveva conosciuto soprattutto a Firenze e gli spiritualisti cattolici di Napoli eredi delle vittoriose giornate contro la Repubblica partenopea del 1799 e che continuavano imperterriti a fare disastri politici ed economici nella Napoli della prima metà dell’Ottocento;
2) ogni cosa è sottoposta a un sistema esterno e superiore all’individuo (identificabile con la Natura matrigna) che tutto vede e a tutto provvede senza tener conto degli individui ma perseguendo fini misteriosi ai quali l’uomo è completamente estraneo e contro i quali si rende conto di essere impotente. Se estendiamo questo concetto dal piano religioso a quello politico, ci accorgiamo che in effetti la situazione non cambia: il potere politico resta qualcosa di inaccessibile all’uomo che si rende conto allo stesso modo di essere estraneo e impotente.
Ma, al di là di queste due considerazioni, assodato che questo poemetto leopardiano viene letto solo dagli studiosi e da qualche appassionato, ci dobbiamo rendere conto che Leopardi stesso vive in una realtà sociale, politica e religiosa che gli resta estranea: non è l’interprete di quella realtà, come non può esserlo il romantico in genere tutto preso dai suoi grandi ideali che appartengono a una realtà storica sicuramente più evoluta, ma solo il visionario che con la realtà tende molto spesso a scontrarsi. Il romantico lotta per un’idea, non per la realtà, lotta per la libertà come ideale non per la libertà di un popolo che è anche progresso dell’uomo e non ci può essere progresso sociale se non si cancellano privilegi che allora come ora erano forti e tenacemente legati al modo di vivere e di pensare di coloro che in qualunque modo avevano in mano le leve del potere sia a livello generale che a livello locale.
Per avere scrittori che siano anche interpreti della realtà bisognerà aspettare almeno i poètes maudits e i veristi o naturalisti, che descriveranno la realtà come credevano che essa fosse. Insomma:
a) i romantici hanno una visione personale della realtà,
b) i romantici non sono interpreti della realtà.
Personaggi del poemetto
(I nomi di alcuni personaggi appartenevano già alla Batracomiomachia)
Miratondo, un guerriero dei Topi
Mangiaprosciutti, Re dei Topi, morto in battaglia
Leccamacine, figlia di Mangiaprosciutti, sposa di Rodipane
Rodipane, sposo di Leccamacine, successore di Mangiaprosciutti per elezione e quindi per volontà popolare
Rubabriciole, figlio di Rodipane e Leccamacine, per la cui morte scoppia la guerra fra Rane e Topi
Rubatocchi, generale dei Topi, valoroso come Achille, l’unico a morire eroicamente nella battaglia contro i Granchi
Leccafondi, Conte e Signore di Pesafondi e Stacciavento (identificato con Gino Capponi o Pietro Colletta)
Brancaforte, Generale dei Granchi (qualcuno lo ha voluto identificare col generale austriaco di origine italiana Federico Bianchi, che nel maggio del 1815 sconfisse Gioacchino Murat a Tolentino)
Senzacapo, Re dei Granchi (probabile allusione a Francesco I di Lorena, diciannovesimo imperatore della casa d’Asburgo, appartenente alla dinastia iniziata da Francesco di Lorena e Maria Teresa)
Camminatorto, ministro reazionario imposto dai Granchi a Rodipane
Assaggiatore, generale, che rispecchia idee e scelte dell’autore
Riassunto del poemetto
(I numeri tra parentesi indicano le ottave)
Canto primo:
Nella guerra tra Topi e Rane, scoppiata per la morte del principe Rubabriciole, nipote di Mangiaprosciutti re dei Topi e figlio di Leccamacine, i Topi sconfitti sono costretti a una ritirata precipitosa (1-4); morto in battaglia il loro re Mangiaprosciutti, durante una sosta eleggono il valoroso Rubatocchi come capo provvisorio (5-13) e inviano il conte Leccafondi come ambasciatore al campo nemico (32-47). Lunga digressione sull’antica grandezza d’Italia (14-31).
sconfitta dei topi
riferimento alla battaglia di Tolentino (3 maggio 1815) nella quale l’esercito napoletano comandato da Gioacchino Murat fu sconfitto dagli Austriaci venuti in soccorso delle truppe pontificie
fuga dei topi
terza ottava: viene paragonata a quella delle truppe pontificie nel corso della prima campagna d’Italia di Napoleone (1797), guidate dal generale imperiale Michelangelo Alessandro Colli-Marchini
fuga dei topi
quarta ottava: sconfitta degli Olandesi a Lovanio (12 agosto 1831) con una fuga interrotta dal soccorso delle truppe francesi di Luigi Filippo
nona ottava
riferimento all’episodio narrato da Senofonte nell’Anabasi, dei diecimila mercenari greci che, dopo aver partecipato alla sfortunata spedizione
Lucerniere
antico topolino filosofante, al quale è stata eretta una statua
Canto secondo:
Viaggio notturno del Conte Leccafondi (1-10) e descrizione del suo arrivo al campo dei Granchi (11-27); Brancaforte, generale dei Granchi, dapprima si rifiuta di riconoscere il mandato di Leccafondi; poi, per ordine del suo re Senzacapo, detta al conte le condizioni di pace: nomina, da parte dei Topi, di un re legittimo e insediamento di un presidio di trentamila granchi in Topaia, la capitale sotterranea dei vinti Topi e infine illustra la politica del suo sovrano, basata sui princìpi dell’equilibrio e del diritto d’intervento (28-46). Da notare che nelle ottave 30-39 è satireggiato il principio dell’equilibrio europeo, obiettivo della politica austriaca posteriore al congresso di Vienna.
Topaia
La città stato dei Topi, identificabile con la città di Napoli e/o col Regno di Napoli
Mezzofanti
cardinale Giuseppe Gaspare Mezzofanti (1774-1849), famoso poliglotta, professore all’Università di Bologna (sembra conoscesse una ventina di lingue)
Brancaforte
Generale dei Granchi (qualcuno lo ha voluto identificare col generale austriaco di origine italiana Federico Bianchi, che nel maggio del 1815 sconfisse Gioacchino Murat a Tolentino): è comunque l’emblema del militare austriaco rozzo e ottuso
Senzacapo (ott. 26)
probabile allusione a Francesco I di Lorena, diciannovesimo imperatore della casa d’Asburgo, appartenente alla dinastia iniziata da Francesco di Lorena e Maria Teresa
ottava 42
Forse c’è un riferimento alla guarnigione che l’Austria impose al Regno di Napoli nel 1821
Canto terzo
Rubatocchi, che ha condotto in salvo l’esercito dei Topi in salvo nella città-stato di Topaia (1-19), rinuncia al potere che gli viene offerto; digressione sul secolo XVI (20-34). I Topi instaurano allora un regime costituzionale ed eleggono come loro Re Rodipane, genero di Mangiaprosciutti (35-45).
Topaia
nella descrizione di Topaia Leopardi ha tenuto presente Napoli
ottava 7
Il castello di Topaia è paragonato alla città di Trevi con una lunga similitudine che si estende per tre ottave
Canto quarto
Dopo una lunga digressione satirica sui primordi della società umana in polemica con le teorie provvidenzialistiche della storia (1-25), il racconto riprende dalle elezioni di Rodipane: viene costituito un governo liberale, nel quale il liberale Leccafondi è nominato consigliere del re e ministro degli interni, e si adopera per il progresso culturale, civile ed economico del popolo (26-42. Ma Senzacapo, il re dei Granchi, non tollera questa svolta pericolosa ed invia a Topaia il suo messo Boccaferrata (43-47)0.
Senzacapo
nel ritratto di Senzacapo c’è un probabile riferimento a Francesco I d’Austria, il quale “si occupava personalmente di regolare con editti e decreti il numero e le qualità delle percosse, e la qualità della verga che era, secondo i casi, o bastone o verga di vimini. Francesco I fu veramente sonatore di violino e faceva parte di un quartetto speciale” (Allodoli)
Canto quinto
Lungo discorso (1-15) di Boccaferrata che cerca di costringere Rodipane di “legittimare” il suo potere, rifiutando la sua elezione avvenuta per volontà popolare e sancendo che il potere gli spetta per diritto dinastico. Rodipane si rifiuta (16-20) e scoppia la guerra: il popolo dei Topi approva sdegnati l’atteggiamento del suo re e si prepara allo scontro con i Granchi (21-34); ma alla sola vista del nemico i Topi fuggono e vengono sconfitti (35-48): tanto grandiosa ed epica è la descrizione della preparazione alla battaglia (basta vedere l’elenco dei personaggi mitici nominati). L’unico a non fuggire è Rubatocchi, contro il quale si rivolgono le schiere nemiche: dopo il tramonto del Sole, quando il buio è ormai completo, cade “ma il suo cader non vide il cielo”.
Canto sesto
Cade Topaia e cade il suo regime liberale (1-6): Camminatorto, il ministro reazionario che i Granchi impongono a Rodipane, abroga tutti i provvedimenti che aveva preso l’illuminato Leccafondi (7-13). A Topaia i Topi cominciano a tramare congiure velleitarie, mentre Leccafondi viene esiliato (14-23); durante la tempesta in una notte d’autunno trova rifugio nel palazzo di Dedalo (unico personaggio umano del poema) (24-36), che lo ospita generosamente e al quale narra le sue peripezie, come Enea a Didone (37-45).
Canto settimo
Ritratto di Dedalo che fa vedere a Leccafondi la sua biblioteca e le opere antiche e moderne dei Topi (1-7), convinto assertore dell’immortalità dell’anima delle bestie, guida Leccafondi verso l’Averno degli animali. Muniti di ali, i due sorvolano la meta Europa, Asia e Africa rappresentate in età preistorica (20-31) e infine raggiungono l’Averno degli animali (32-51).
Canto ottavo
Leccafondi discende nell’Averno dei Topi (1-19) e a fatica riesce a strappare un consiglio ai Topi defunti: rientri in Topaia e si rivolga al vecchio e prode generale Assaggiatore (20-31). Tornato in patria, il conte interroga più volte invano il generale (32-41); finalmente egli parla ma le sue dichiarazioni non possono essere riferite perché proprio a questo punto s’interrompe il manoscritto sul quale il poeta finge di aver condotto la sua storia (42-46) e più a nulla vale la conoscenza celata in mille biblioteche e in tante lingue diverse, antiche o moderne.
“Sotto le vesti animalesche si nascondono i contendenti dei moti risorgimentali dal 1821 al 1831, con particolare riferimento alle vicende napoletane: i topi sono liberali, le rane rappresentano i conservatori (con specifica allusione alle truppe pontificie), i granchi invece rappresentano gli Austriaci. Resta fondamentale il giudizio espresso sul poemetto da Vincenzo Gioberti (cfr. Il gesuita moderno, vol. III, Losanna, Bonamici 1847, pag. 484): “I popoli italiani sono forse educati alle grandi imprese? Il Leopardi verso la fine della sua vita scrisse un libro terribile, nel quale deride i desideri, i sogni, i tentativi politici degl’Italiani con un’ironia amara che squarcia il cuore, ma che è giustissima. Imperocchè tutto ciò che noi abbiam fatto in opera di polizia da un mezzo secolo in qua è così puerile, che io non vorrei incollerire contro gli stranieri quando ci deridono se anch’essi non fossero intinti più o meno della stessa pece”.
Alla fine resta la penosa impressione dell’esercito dei Topi che, schierato e pronto ormai per la battaglia, all’improvviso si slancia in una irrefrenabile fuga e giunge ad accalcarsi davanti alle quattro sole porte d’entrata nella città di Topaia, raggiunto e inesorabilmente decimato dall’esercito dei Granchi, dopo che era stato abbattuto l’ultimo eroico inutile baluardo, rappresentato dalla figura del generale Rubatocchi: una morte tanto eroica quanto farsesca se si pensa alla contemporanea oscena fuga del suo esercito.
Proprio le due dicotomie eroismo-farsa e storia-apparenza, introducono alla dicotomia più interessante presente nel poemetto e che affonda le sue radici nell’Illuminismo e nella Rivoluzione francese, quella fra potere regio e potere popolare, che così male era rappresentata dall’esercito francese in Italia, sia per quanto riguarda le esperienze infelici di Monaldo Leopardi, sia per le esperienze altrettanto infelici dei tempi di Giacomo; proprio quest’ultima dicotomia è ben rappresentate dalla presenza di Boccaforte che cerca di obbligare Rodipane a cambiare la legittimità della sua elezione da popolare in una più tradizionale, quella del potere che deriva dal diritto divino.
INTRODUZIONE ALLE OPERETTE MORALI
A cura di Giuseppe Bonghi
Le Operette Morali, progettate sin dal 1820 in un progetto “vago e sovrabbondante”, con l’idea di riprendere il genere dei Dialoghi dello scrittore greco Luciano, vengono scritte nel 1824 (le prime venti) e stampate a Milano dall’editore Angelo Stella nel 1827, dopo che tre di esse erano uscite nel 1826, due sul numero di gennaio dell’Antologia (Dialogo di Timandro e di Eleandro, Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare e Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez) del Viesseux e successivamente su due numeri del Nuovo Ricoglitore.
L’edizione completa con l’aggiunta delle ultime quattro scritte negli ultimi anni, uscirà nel 1835 a Napoli presso l’editore Saverio Starita, un’edizione che non ottenne il permesso di pubblicazione ufficiale, ma che ebbe lo stesso un buon successo. Nelle Operette Leopardi esprime la sua diagnosi della realtà, trattando la sua visione con assoluta libertà proprio assumendo le vesti più disparate dei personaggi dei suoi Dialoghi, che discutono con i morti o sono semplicemente animali domestici come il gallo silvestre; guida i suoi lettori verso traguardi noti a lui solo, a scoprire la vera essenza del quotidiano, quasi anticipando l’analisi umoristica pirandelliana, facendoci vedere l’altro aspetto della realtà, non quello più nascosto, ma quello più difficile da cogliere se si analizzassero le cose col solito modello di pensiero. Invita i lettori a svestorisi del proprio modo di pensare per vedere non dentro le cose (un’operazione che tutti fanno), ma dalla parte opposta e simmetrica, a sentire l’altro suono della campana.
Il ricorso alla fantasia della rappresentazione non si scontra mai con l’analisi della realtà, non è un’operazione dell’immaginazione, ma della logica seguendo strutture di ragionamento diverse, come diverse sono le epoche in cui sono situati i personaggi, come diversi sono i modi di pensare e di vedere: ma tutti dovrebbero condurre a una sola unità d’intenti, a una sola visione, agli stessi valori ed ideali, eliminando arrivismi ed egoismi che tutto distruggono.
Analizzando proprio il Dialogo cancellato dal poeta possiamo capire come i grandi valori sociali (la patria, l’onore) siano diventati la ricchezza sfrenata, i divertimenti, la voglia di primeggiare. Le Operette esprimono la meditazione leopardiana sulla condizione umana sospesa tra passato e presente, tra aspettative naturali e realizzazione pratica, sul destino, sull’aspirazione di ogni uomo a una felicità che sembra raggiungibile nella prima giovinezza ma che si rivela ad ogni anno che passa (Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere) sempre più un sogno impossibile; non a caso si aprono con la Storia del genere umano, in cui Leopardi rappresenta la successione delle tappe della sua storia spirituale che riflette quelle della storia del genere umano in generale, e si chiudono con il Dialogo di Tristano e di un amico che rappresentano la “virile attesa della morte, solo rimedio all’inutile miseria della vita… sottolineando così la sua solitudine e il coraggio con cui ricercava il vero, fra gli uomini che preferivano banali e confortanti illusioni. Scritte nel 1824, rappresentano la presa di coscienza del crollo delle sue illusioni giovanili, tornando a Recanati, il “natìo borgo selvaggio”, dopo che fiducioso tre anni prima era corso incontro al mondo allontanandosi da casa, in cui gli sembrava impossibile vivere e raggiungere un’accettabile condizione di vita felice.
L’ironia che le pervade non sono una ricerca spirituale di distacco dall’amarezza che la materia trattata gli infonde, ma sono la scoperta del senso fondamentale della vita che si nasconde dietro le banali apparenze quotidiane della cultura e dei modi di vivere. Proprio questa scoperta sarà alla base della sua grande poesia a partire dal 1827. É una scoperta dolorosa, ma rappresenta anche l’accettazione del male della vita, esclusa da ogni speranza di bene o contento, come dirà nel Canto notturno, che altri forse avrà, ma che lui non potrà mai raggiungere perché questa è la condizione umana.
Le domande che si pone, e che scaturiscono dai Dialoghi, rimangono senza risposta; il dialogo stesso diventa fittizio e apparente, perché resta un monologo che scaturisce dai due aspetti della realtà che lo affascina e lo intristisce, una, quella dell’apparenza, che l’uomo vive nella fiduciosa giovinezza, nel momento in cui le cose appaiono, e l’altro che si afferma all’apparir del vero.
Per questo le Operette rappresentano un punto di partenza fondamentale per la formazione umana e sociale dell’uomo moderno, lontano da tutto ciò che impoverisce l’esistenza umana, appiattendola su apparenze vuote o sospingendola verso chimeriche forme di vita ultraterrena; in esse il poeta tocca e rivela i più profondi motivi del nulla, della noia-angoscia, della vita come morte, senza mai cadere nel patetico, ma sempre stimolando l’energia virile dell’uomo ad affrontare l’esistenza con il coraggio che deve portare alla ricerca della verità.
FEUERBACH

Se l’essere umano è per l’uomo l’essere sommo anche nella pratica la legge prima e suprema sarà l’amore dell’uomo per l’uomo. “Homo homini deus est”: questo è il nuovo punto di vista, il supremo principio pratico che segnerà una svolta decisiva nella storia del mondo. (L’Essenza del Cristianesimo).
Con Ludwig Feuerbach si verificò un vero e proprio ribaltamento delle posizioni di Hegel. Nato nel 1804 a Landshut, in Baviera, Feuerbach studiò teologia a Heidelberg, ma nel 1824 si recò a Berlino, dove subì l’influenza di Hegel, sicché nel 1825 abbandonò la teologia per la filosofia. L’anno successivo andò a completare gli studi a Erlangen, dove nel 1828 ottenne la laurea e la libera docenza in Filosofia. Dal 1829 al 1836 tenne saltuariamente corsi presso l’università di Erlangen, ma non ebbe successo il suo tentativo di esservi nominato professore straordinario. Già nel 1830, infatti, egli aveva pubblicato anonimi i Pensieri sulla morte e l’immortalità , che lo avevano reso sospetto alle autorità accademiche e religiose del regno di Baviera. Nel 1837 egli si ritirò pertanto a Bruckberg, dove visse fino al 1860 grazie soprattutto ai proventi di una fabbrica di porcellane, di cui la moglie era comproprietaria. In quello stesso anno Feuerbach, che già aveva pubblicato tra l’altro una Storia della filosofia moderna da Bacone di Verulamio a Spinoza (1833), alla quale facevano seguito volumi su Leibniz (1837) e su Bayle (1838), fu invitato da Ruge a collaborare agli “Annali di Halle”. Nel 1839 Feuerbach, pubblica il saggio Per la critica della filosofia hegeliana , che dà inizio alla serie dei suoi scritti più noti, comparsi nell’arco di pochi anni: L’essenza del Cristianesimo (1841), Tesi provvisorie per la riforma della filosofia (1843), Princìpi della filosofia dell’avvenire (1843), L’essenza della religione (1845). Nell’anno della rivoluzione, il 1848, gli studenti lo chiamano a tenere un corso a Heidelberg, ma nel 1849 egli torna a Bruckberg; di qui egli si trasferisce nel 1860, dopo un dissesto finanziario, a Rechenberg, presso Norimberga dove vive in miseria i suoi ultimi anni sino alla morte avvenuta nel 1872. All’inizio Feuerbach si colloca nel solco della filosofia hegeliana, anche se già pone l’accento su elementi che lo allontaneranno da Hegel. Così, nei Pensieri sulla morte e l’immortalità , egli afferma con forza la connessione tra l’individualità e la sensibilità, propria di un corpo legato allo spazio e al tempo, e su questa base giunge a negare “l’immortalità” individuale. Progressivamente egli matura la convinzione che la filosofia abbraccia tutti coloro che si sono impegnati nella lotta per la libertà di pensiero, da Bruno a Spinoza a Fiche, e non ha il suo compimento in Hegel. Nello scritto del 1839, Per la critica della filosofia hegeliana , egli afferma che non è possibile considerare come assoluto un singolo sistema, neppure quello hegeliano, nonostante la sua rigorosa scientificità, universalità e ricchezza, perché questo significherebbe arrestare il tempo e portare gli uomini a rinunciare alla libera ricerca. A questa conclusione Feuerbach perviene partendo dal presupposto hegeliano che ogni filosofia è il proprio tempo espresso in concetti, ma applicandolo alla stessa filosofia hegeliana. Se il tempo non si arresta anche la filosofia hegeliana non può non essere una filosofia particolare e determinata : anch’essa infatti non rappresenta un inizio assoluto privo di presupposti, ma è sorta in un’epoca determinata e, in quanto ne è l’espressione anch’essa parte da presupposti legati a tale epoca. L’epoca futura non potrà non rendersi conto di questo fatto, cosicché anche la filosofia hegeliana apparirà allora una filosofia del passato. In qualche modo l’unica filosofia che inizia senza presupposti è quella che ha libertà e il potere di mettere in dubbio anche se stessa. La filosofia, in quanto libertà che vuole costruirsi da se e non soltanto come erede della tradizione, deve dunque procedere oltre Hegel, che non critica mai la realtà di fatto, ma si preoccupa soltanto di comprenderla nella sua razionalità e quindi giustificarla. Il compito dell’uomo pensante, consiste invece, nell’anticipare con la ragione gli effetti necessari e inevitabili del tempo. Attraverso la negazione del presentesi costituisce la forza per creare qualcosa di nuovo. ‘ Io sulla religione ho dedicato tutta la mia vita ‘ dirà Feuerbach; partendo dalla riflessione sul cristianesimo , Feuerbach giunge a comprendere che la filosofia di Hegel è in realtà teologia filosofica. Lo scopo di Feuerbach nell’ Essenza del cristianesimo non è di condurre una critica al cristianesimo di tipo illuministico, ossia di ridurlo a un cumulo di errori e superstizioni. Egli invece ritiene che la religione, in particolare quella cristiana, abbia un contenuto positivo che consente di scoprire quale sia l’essenza dell’uomo . Dalle tesi di Schleiermacher, secondo cui la religione consiste nel sentimento dell’infinito, egli trae la conclusione che tale infinito non esprime altro che l’essenza dell’uomo. Nessun individuo singolo contiene in sé quest’essenza nella sua compiutezza, ma ogni uomo ha il sentimento dell’infinità del genere umano. La religione ha un origine pratica: l’uomo avverte la propria insicurezza e cerca la salvezza in un essere personale, infinito immortale e beato, cioè in Dio. Ma, secondo Feuerbach, quando un soggetto entra in un rapporto essenziale e necessario con un oggetto, questo significa che questo oggetto è la vera e propria essenza del soggetto. Con Dio il sentimento umano è in un rapporto necessario: Dio dunque non è altro che l’essenza oggettivata dell’uomo . La religione è appunto l’oggettivazione dei bisogni e delle aspirazioni dell’uomo , la proiezione di essi in un ente, che viene considerato indipendente dall’uomo e nel quale tali aspirazioni si trovano pienamente realizzate. Nella religione è l’uomo a fare Dio a propria immagine e somiglianza, non viceversa ( ‘ Non è Dio che crea l’uomo, ma l’uomo che crea l’idea di Dio ‘ afferma Feuerbach): quando a Dio si attribuiscono la conoscenza o l’amore infinito, in realtà si intende esprimere l’infinità delle possibilità conoscitive e dell’amore propri dell’uomo. In Dio e nei suoi attributi l’uomo può quindi scorgere oggettivati i suoi bisogni e i suoi desideri e, dunque, conoscerli. Feuerbach ne conclude che la ” religione è la prima, ma indiretta coscienza che l’uomo ha di sé ” . La conoscenza che l’uomo ha di Dio non è altro, allora, che la conoscenza che l’uomo ha di se stesso, ma nella religione l’uomo non si rende conto che è la propria essenza a trovarsi oggettivata in Dio. Solo con la filosofia ciò può giungere a piena consapevolezza. Questo spiega, tra l’altro perché nella storia dell’umanità e degli individui la religione proceda ovunque la filosofia: l’uomo pone la propria essenza fuori di sé prima di riconoscerla come propria. Nella proiezione della propria essenza in Dio, l’uomo non possiede più tale essenza, che ha sede in un altro mondo, cosicché per riconquistarla l’uomo deve negare il mondo terreno. Qui si annida secondo Feuerbach, la vera colpa del cristianesimo nei confronti del genere umano l’aver condotto all’ascetismo, alla fuga dal mondo, al sacrificio e alla rinuncia, in ultima analisi alla spogliazione delle qualità umane a favore di Dio. Rispetto al cristianesimo, il panteismo ha il merito di aver riconosciuto che il divino non è un’entità personale, ma è il mondo stesso. Lo sviluppo della religione consiste dunque in una progressiva negazione di Dio da parte dell’uomo, la quale va di pari passo con la consapevole riappropriazione della propria essenza umana. Quanto c’è di vero e di essenziale nel cristianesimo deve quindi essere negato come teologia per essere conservato come Antropologia. In quanto antropologia, la filosofia si assume il compito di liberare l’essenza dell’uomo e delle sue infinite possibilità dalla sua alienazione religiosa in un ente estraneo. Secondo Feuerbach è ateo non chi elimina Dio, il soggetto dei predicati religiosi, bensì chi elimina i predicati con i quali Dio è designato nell’esperienza religiosa, come bontà o saggezza o giustizia. Anche quando si è riconosciuta la non esistenza di Dio come entità separata, questi predicati infatti permangono nella loro verità, ma come possibilità e prerogative dell’essenza umana. Il compito dell’età moderna è consistito secondo Feuerbach, nella trasformazione e dissoluzione della teologia in antropologia. Già il protestantesimo, secondo Feuerbach, è originariamente antropologia religiosa: in esso, infatti, è rilevante ciò che Dio è per gli uomini, non tanto ciò che egli è in sé, anche se in teoria gli è riconosciuta esistenza indipendente. Come si colloca la filosofia hegeliana rispetto a questa antropologia? Per Feuerbach essa non è altro che teologia filosofica: la filosofia speculativa, il cui culmine è rappresentato da Hegel, ha identificato ciò che nella teologia è concepito come oggetto ossia Dio come ente indipendente, con il soggetto, il pensiero o lo spirito assoluto. In tale filosofia Dio diventa l’essenza della ragione stessa, non è più rappresentato come essenza autonoma, distinta dalla ragione, e anzi, le determinazioni di Dio, per esempio l’infinità sono riconosciute come proprie della ragione stessa. Ma secondo Feuerbach ciò significa soltanto che, mentre nella teologia, l’essenza umana è alienata in Dio, nella filosofia speculativa essa è alienata nello spirito assoluto, ossia nel pensiero. Nelle Tesi provvisorie per la riforma della filosofia e nei Princìpi della filosofia dell’avvenire , Feuerbach mostra che Hegel ha commesso lo stesso errore della teologia, in quanto di fatto ha ricavato le determinazioni dell’infinito dalla realtà finita, ma ha preteso di dedurre il finito dall’infinito, considerando il finito soltanto un momento negativo dell’infinito. Secondo Feuerbach invece, è nel finito che deve essere ritrovato l’infinito , non viceversa; l’infinito stesso è pensabile soltanto attraverso il finito e la negazione del finito. L’inizio della filosofia non è dunque Dio o l’Assoluto, ma ciò che è finito, determinato e reale. La filosofia dell’avvenire, in quanto antropologia, riconoscendo il finito come infinito, deve partire, non da come aveva fatto Hegel, dal pensiero autosufficiente, inteso come soggetto capace di costruirsi con le sue proprie forze, bensì dal vero soggetto, di il cui pensiero è soltanto un predicato. Esso è l’uomo in carne e ossa, mortale dotato di sensibilità e bisogni: in questo consiste l’umanesimo di Feuerbach. Occorre dunque partire da ciò che dà valore al pensiero stesso, ossia dall’intuizione sensibile perché veramente reale è soltanto ciò che è sensibile . Solo attraverso i sensi un oggetto è dato come immediatamente certo: il sensibile infatti non ha bisogno di dimostrazione, perché costringe subito a riconoscere la sua esistenza. In questa prospettiva, la natura non si trova più ridotta a semplice forma estraniata dello spirito, come avveniva in Hegel, ma diventa la base reale della vita dell’uomo. Si apre così la possibilità di una nuova filosofia, il sensualismo , che è la risoluzione compiuta della teologia in antropologia: in essa è superata ogni scissione tra uomo e mondo, corpo e spirito. Solo dalla sensibilità deriva il vero concetto dell’esistenza: infatti, solo ciò che è piacevole o doloroso modifica lo stato dell’uomo e mostra che qualcosa esiste o manca. Passione, amore, fame sono dunque la prova ontologica dell’esistenza di qualcosa: solo esse, infatti, hanno interesse all’esistenza o meno di qualcosa. La corporeità, diversificandosi come maschio o femmina, conduce al riconoscimento dell’esistenza di un essere differente dall’io, che tuttavia è essenziale per la determinazione della esistenza. Il vero principio della vita e del pensiero non è dunque l’io, ma l’io e tu, il cui rapporto più reale si configura come amore, interesse per l’esistenza dell’altro. E Feuerbach afferma che ” la vera dialettica non è un monologo del pensiero solitario con se stesso, ma un dialogo tra l’io e tu “. L’uomo singolo non ha in sé l’essenza totale dell’uomo, come unità di vita, cuore e ragione; tale essenza è contenuta solo nella comunità, ossia nell’unità dell’uomo con l’uomo, fondata sulla realtà della differenza tra io e tu. In questa prospettiva, l’amore diventa la realizzazione dell’unità del genere umano. Il fenomeno religioso continuerà a rimanere al centro delle riflessioni di Feuerbach. Nell’ Essenza della religione , egli prende in considerazione non soltanto il cristianesimo, ma la religione in generale: essa ha la sua matrice nel sentimento di dipendenza dell’uomo dalla natura. Contrariamente a quanto pensava Stirner, Feuerbach considera l’individuo un’entità non assolutamente autonoma, ma dipendente da una realtà oggettiva: la natura . Per natura Feuerbach, in questa fase del suo pensiero, non intende più in primo luogo la natura dell’uomo, che si esprime sotto forma di sensibilità. La natura è più in generale il mondo da cui l’uomo dipende: tale dipendenza si manifesta all’uomo sotto forma di bisogno. Proprio dalla difficoltà di soddisfarlo nasce la religione. Di fronte al carattere illimitato dei propri desideri e delle proprie aspirazioni l’uomo si rende conto del carattere limitato dei suoi poteri. In questa situazione Dio viene immaginato come l’essere nel quale tutti questi desideri sono realizzati: a Dio, infatti, nulla è impossibile. Ma questa concezione della divinità rappresenta soltanto la forma più sviluppata di religione. All’origine, infatti, ciò che l’uomo divinizzò fu una natura non addomesticata, anche ostile, solo successivamente egli attribuì a questa natura caratteri simili all’uomo, sino a ravvisare nella natura stessa un ordine dovuto a Dio, inteso come principio ordinatore. Solo per quest’ultima fase dello sviluppo della religione vale la tesi secondo cui Dio e i suoi attributi non sono altro che la proiezione di sentimenti e desideri umani. Ma così facendo si è dimenticata la dipendenza essenziale dell’uomo dalla natura: questo è l’errore della forma più avanzata di religione, soprattutto del cristianesimo, che è dunque il più lontano dall’origine naturale della religione. Nella sua ultima produzione teorica Feuerbach insisterà sull’importanza della conoscenza della natura e di un rapporto armonizzato dell’uomo con la natura stessa. Ciò lo condurrà a guardare con interesse agli sviluppi di concezioni materialistiche nelle indagini scientifiche della metà del secolo e a continuare nella sua polemica antireligiosa. Nel 1850 egli recensisce favorevolmente uno scritto di Moleshott sull’alimentazione, interpretata come la base che rende possibile il costituirsi e perfezionarsi della cultura umana: un popolo può migliorare migliorandone l’alimentazione. Significativo è il titolo di uno scritto del 1862: Il mistero del sacrificio o l’uomo è ciò che mangia : cioè esiste un’unità inscindibile fra psiche e corpo, per pensare meglio dobbiamo alimentarci meglio. Dio è l’eco del nostro grido di dolore, Dio è una lacrima dell’onda versata nel più profondo dolore della miseria umana. Il cristiano vede nel miracolo l’opera di Dio, ma il miracolo è detto così perché non conosciamo le leggi fisiche che hanno prodotto il fenomeno. Tutti i popoli in principio sono religiosi, ma poi acquistano coscienza e si disalienano. Il compito degli scritti di Feuerbach, come egli stesso afferma, é di abbattere le illusioni e i pregiudizi del presente, traendo la filosofia da quello che egli chiama il ‘regno delle anime morte’ per reintrodurla nel dominio delle anime vive, radicalmente legate al corpo e alla sensibilità. Per ora il problema é di trarre l’uomo ‘ fuori dal pantano in cui era sommerso ‘ , non ancora di ‘ rappresentare l’uomo quale é ‘. Si tratta in altre parole di dedurre dalla teologia la necessità di una filosofia dell’uomo, di un’antropologia: a questa operazione Feuerbach provvede con i suoi scritti. Egli é infatti convinto, come dice nella premessa dei Princìpi della filosofia dell’avvenire , che ‘ solo alle future generazioni sarà concesso di pensare, parlare e agire in modo puramente ed autenticamente umano ‘. In una delle sue ultime opere, Spiritualismo e materialismo (1866), Feuerbach ribadisce la sua concezione dell’individuo come organismo sensibile caratterizzato da bisogni, polemizza contro il dualismo di anima e corpo e, facendo proprio un punto di vista deterministico, nega l’esistenza del libero arbitrio. Per molti aspetti le tesi di Feuerbach saranno uno spunto per il lavoro di Marx, che comunque non tarderà a criticare il lavoro di Feuerbach nelle Tesi su Feuerbach ; nei Manoscritti del 1844 Marx definirà Feuerbach ‘il solo che sia in un rapporto serio e critico con la dialettica hegeliana’.
L’essenza della religione
Di Matteo Alesina
Lo scritto L’Essenza della religione è steso sotto forma di un percorso unitario articolato in differenti pensieri. Le tappe più rilevanti dello sviluppo del pensiero feuerbachiano possono essere sintetizzate come di seguito:
La religione è la manifestazione di una dipendenza nei confronti della natura (§ 1/4)
Scrive Feuerbach: “Il sentimento di dipendenza dell’uomo è il fondamento della religione; l’oggetto di questo sentimento di dipendenza […] non è però altro, originariamente, che la natura”. Notiamo che il termine “natura” assume in Feuerbach il significato generale di un raggruppamento di oggetti e cose reali che l’uomo differenzia da sé e dai propri prodotti, e non un ente universale, astratto, “personificato e mistificato”.
Scrive Feuerbach: “…io sono soprattutto un ente che non esiste senza luce, senza aria, senza acqua, senza terra, senza cibo, un ente dipendente dalla natura”. Conscio del suo stato di subordinazione rispetto alla natura, l’uomo celebra questa sua dipendenza; tuttavia, in origine, egli celebra solamente la natura che gli è familiare e nella quale egli vive: così ogni stirpe antica ha glorificato solamente la regione che ha abitato o il fiume da cui ha tratto il proprio sostentamento.
L’analisi della causalità: perché l’uomo è ciò che è (§ 5/7)
Gli uomini non possono essersi elevati al di sopra dello stato bestiale grazie alla forza di geni, spiriti o angeli: Feuerbach definisce quest’ipotesi come una “idea fantastica”; al contrario, secondo il nostro filosofo, gli enti che hanno portato al passaggio alla civiltà sono stati gli animali. Nell’asserire ciò, Feuerbach cita un’analoga dottrina dello zoroastrismo, secondo cui la civiltà umana è stata resa possibile solo dalla fedeltà del cane, che tenendo alla larga i ladroni e i lupi ha permesso l’instaurarsi della proprietà privata.
Il cristianesimo, invece, venera un ente indipendente che è responsabile della creazione dell’uomo: nel culto professato dal cristiano è quindi evidente un culto dell’uomo, risultato della creazione. E Feuerbach scrive: “I cristiani si allietano della vita tanto quanto i pagani, ma le loro preghiere di gratitudine per i piaceri della vita sono dirette in alto, al padre celeste; essi muovono ai pagani il rimprovero di idolatria proprio per il fatto che questi ultimi si arrestano, nel loro rendimento di grazie […], alla creatura, senza innalzarsi alla causa prima, all’unica autentica causa di tutti i benefici”. Proprio per contrastare questa tendenza, Feuerbach scrive con sarcasmo: “Io ho tutte le ragioni di fare oggetto di devozione religiosa […] soltanto gli enti a me più prossimi, [ossia] i miei genitori”.
L’essenza divina della natura (§ 8/10)
“L’essenza divina che si manifesta nella natura non è altro che la natura stessa che si manifesta, si mostra e si impone all’uomo come un ente divino”. Trova quindi ragion d’essere l’ipostatizzazione dell’utile fatta propria dai popoli antichi, come per esempio i messicani dell’età precolombiana, i quali adoravano anche un dio del sale. E tuttavia “l’esistenza della natura non si fonda, come si illude il teismo, sull’esistenza di Dio – nemmeno per sogno, è proprio il contrario: l’esistenza di Dio, o piuttosto la fede nella sua esistenza, ha il suo unico fondamento nell’esistenza della natura. Tu sei costretto a pensare Dio come un ente esistente soltanto perché sei costretto dalla natura a presupporre alla tua esistenza e alla tua coscienza l’esistenza di essa – e il primo concetto base di Dio non è appunto nient’altro che questo, che esso è l’esistenza che precede la tua…”.
L’uomo erra attribuendo a Dio la potenza della natura (§ 11/16)
Feuerbach introduce la scena biblica di Giobbe al cospetto di Dio: in tale frangente, Dio ricorda all’uomo la sua impotenza e la sua limitazione (“«Puoi tu forse – dice Iddio a Giobbe – stringere insieme il gruppo delle Pleiadi, oppure disperdere il giro di Orione?»”). Ovviamente, il nostro filosofo è pronto ad accettare di asserire che l’uomo è finito e limitato, tuttavia egli pronuncia un veemente attacco contro chi attribuisce a Dio quella potenza che è proprietà della natura: “ma qual è la potenza che si manifesta nella violenza del tuono, nella forza del cavallo, nel volo dello sparviero, nel corso inarrestabile delle Pleiadi? La forza della natura”. E ancora, Feuerbach dimostra che la sovrapposizione tra Dio e natura è decisamente errata, anche se sembra evidente a tutti gli uomini: “Dio è l’ente infinitamente buono «perché egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti»; ma l’ente che non fa differenza tra buoni e cattivi, giusti e ingiusti, che non distribuisce i beni della vita sulla base dei meriti morali, e che, in generale, dà all’uomo l’impressione di essere un ente buono proprio perché le sue virtù, come per esempio la luce del sole o l’acqua piovana, apportatrici di ristoro, sono le fonti delle più benefiche sensazioni, questo ente è appunto la natura”. Infine, Feuerbach dimostra che la concezione che l’uomo ha di Dio si avvicina molto a quella che l’uomo ha della potenza della natura: Dio infatti appare misterioso ai credenti perché spesso la natura (alla quale Egli viene erroneamente sovrapposto) ci sembra misteriosa; infatti, nel racconto biblico, Dio chiede a Giobbe: “«Sai in qual modo si diffondono le nubi? […] Sei mai andato nel fondo del mare? Ti sei reso conto di quanto è vasta la terra? Hai visto di dove viene la grandine?»”.
L’ovvia conclusione è che “un culto che fosse rivolto a Dio inteso soltanto come artefice della natura, senza collegarvi determinazioni di altro genere, derivate dall’uomo, e senza che egli venga contemporaneamente pensato come legislatore politico e morale, cioè umano, un tale culto sarebbe rivolto esclusivamente alla natura”. E qundi, in definitiva, bisogna separare in maniera ferma e netta Dio e la natura, perché quest’ultima si può spiegare alla luce esclusiva della fisica e della meccanica: “è vero che l’artefice della natura viene dotato di intelletto e di volontà; ma ciò che questa volontà vuole […] è proprio ciò per cui non servono né volontà né intelletto, ciò per cui sono sufficienti forze e impulsi meramente meccanici, fisici, chimici, vegetali ed animali”. Con tono sprezzante, Feuerbach si accanisce fino all’estremo contro il cristianesimo (e in definitiva contro quello che egli denomina “manicomio della teologia”), dicendo che “derivare la natura dalla volontà e dall’intelletto, o genericamente dallo spirito, significa fare i conti senza l’oste, significa far nascere il salvatore del mondo, per opera solo dello spirito santo, da una vergine che non conosce l’uomo, significa trasformare l’acqua in vino, scongiurare le tempeste con le parole, spostare con le parole le montagne…”. Sembra ulteriormente ridicolo il fatto che i cristiani abbiano trasformato il loro Dio in “causa prima” capace di convivere con le infinite “cause intermedie”: il Dio dei cristiani quindi non è in grado di scagliare fulmini né di castigare gli empi con le piogge di fuoco, in quanto “è stato escluso dal regno delle cause intermedie, è soltanto una causa nominale, un innocuo e poco pretenzioso parto della nostra mente”.
Il senso della creazione è immanente al mondo (§ 17/23)
Feuerbach sposa la tendenza all’immanentismo diffusasi nell’Ottocento circa le caratteristiche del mondo fisico: la natura crea il mondo senza alcun concorso esterno, ed anzi essa stessa dimostra oscillazioni nelle sue condizioni di stabilità generale che favoriscono ora questa ora quella forma di vita: ne sono un esempio gli animali preistorici, che si sono estinti allorché le loro condizioni di vita si sono scontrate con le evoluzioni degli habitat naturali. Feuerbach rigetta pure la dottrina cristiana della creazione:“ingenerata è [solo] la materia”, infatti “niente è più contraddittorio, strampalato ed assurdo che far creare gli enti naturali da un ente spirituale supremo e perfettissimo”: tale ente avrebbe dovuto creare qualcosa di altrettanto perfetto e spirituale.
Chi crede invece che alla base di tutto ci sia veramente un ente spirituale unitario assomiglia agli antichi Greci, che identificavano nell’Oceano il padre di tutti i fiumi: “se un’acqua primordiale non ha potuto essere la fonte delle molte diverse acque […], tanto meno potrà un ente primordiale essere la fonte originaria dei molti diversi enti. L’unità è sterile, e fecondo è solo il dualismo, l’opposizione, la differenza”. E tuttavia i più ritengono valida la dottrina della creazione, perché essa è diventata una sorta di superstizione di massa, proprio come “quella spiegazione che i nostri devoti davano delle grandinate, delle morìe, della siccità, dei tuoni, da essi fatti risalire a maghi, incantatori e streghe”.
Il punto cruciale del discorso feuerbachiano è quindi questo: “«L’origine della vita è inspiegabile e incomprensibile»; ammettiamolo; ma questa incomprensibilità non ti autorizza a dedurre le conseguenze superstiziose che la teologia tira dalle lacune del sapere umano”, e come direttissima conseguenza “questa incomprensibilità non ti autorizza a spiegare l’inspiegabile supponendo enti inventati”. Il fondamento primo della superstizione religiosa è dunque da ricercarsi nell’ignoranza e nella fantasia umane.
Non è Dio che crea la natura, ma la natura che spinge l’uomo a creare Dio (§ 24/29)
Tutti possono capire che “tutte le proprietà o determinazioni di Dio […] non sono altro che proprietà astratte della natura”, che i metafisici hanno sempre esaltato come il plus che contraddistingue lo spirito; e tuttavia questo è un plus che si risolve in un minus, perché paradossalmente non gode delle intuizioni sensibili (che invece sono presenti nella natura). Inoltre Feuerbach scaglia un feroce attacco contro la metafisica, perché “tutte le deduzioni del mondo da Dio, della natura dallo spirito, della fisica dalla metafisica, del reale dall’astratto si mostrano per quello che sono: giochi logici”.
Ma perché l’uomo è spinto a ciò?
“L’atteggiamento che l’uomo ha nei confronti della natura […] è di considerarla come ciò che lui stesso è, come un ente personale”. Infatti è facile che l’uomo interpreti i frutti degli alberi o il chiarore del sole come “doni” di una natura amica e benevola, mentre la calura o la peste rappresenterebbero un momento d’ira di questa stessa natura personificata: “se la terra recasse i suoi frutti senza interruzione, che ragione ci sarebbe di fare cerimonie religiose per la semina ed il raccolto?”. Tutto ciò verifica ulteriormente quanto era stato detto nell’opera L’essenza del cristianesimo, ossia che l’uomo venera se medesimo nell’altro da sé: ed egli va a cercare nella natura una personalità capace di bontà ed ira, ed “adora l’ente non umano come se fosse l’ente divino soltanto perché esso sembra umano”.
In definitiva, “ove viene meno la certezza matematica […] incomincia la teologia”.
Una parte significativa della religione è quindi il sacrificio, perché “l’appropriazione o lo sfruttamento della natura si presenta all’uomo quasi come una infrazione, come un appropriarsi della proprietà altrui, come un sacrilegio. Per placare la sua coscienza, nonché l’oggetto che, nella sua rappresentazione, egli ha offeso, per mostrargli che se ne è impadronito per necessità, e non per arroganza, l’uomo si diminuisce il godimento, restituisce all’oggetto qualche cosa della proprietà che era sua, e che gli fu sottratta”.
Una teogonia della religione: i presupposti della religione secondo Feuerbach (§ 29/33)
“Il fondamento della religione è il sentimento di dipendenza dalla natura, ma il fine di essa è il superamento di questa dipendenza, è la libertà dalla natura. In altri termini: la base, il fondamento della religione […] è la divinità della natura, ma il fine ultimo della religione è la divinità dell’uomo”; la religione è figlia di un’opposizione fra il volere ed il potere dell’uomo: mentre la volontà dell’uomo è libera e illimitata (e in questo ambito ognuno di noi sembra un “piccolo dio onnipotente”), il suo potere è estremamente debole. Ogni religione nasce quindi per conciliare il contrasto tra la nostra volontà infinita e le nostre possibilità limitate.
Di conseguenza ogni religione è in grado di evolversi di pari passo con l’uomo; infatti, presso le popolazioni meno progredite, “Zeus è la causa o l’essenza dei fenomeni meteorologici: ma in ciò non è ancora posto il suo carattere divino, religioso”. Ciò significa che il primo passo della religione è quello di far “dipendere ciò che è indipendente dalla volontà umana […] dalla volontà di Dio”, il che è esemplificato al meglio dalla mutabilità dell’atmosfera, che è governata – nel paganesimo più antico – dai fulmini di Zeus. In questa prima fase, che è molto vicina ai culti feticistici e animisti, l’uomo interagisce con la sua divinità con la preghiera e col “fumo dei sacrifici”. Questo aspetto del culto batte notevolmente l’accento sulla volontà umana; capiamo quindi l’importanza dell’asserto “il desiderio è un’aspirazione il cui soddisfacimento […] non è in mio potere, è una volontà priva però del potere di tradursi in atto”; ecco quindi che “il desiderio è l’origine, è l’essenza stessa della religione”. Dato questo asserto, “chi non ha desideri non ha neppure dèi”: infatti “dove non ti accade di sentire lamentazioni sulla natura mortale e sulla miseria dell’uomo, ivi non ti accadrà nemmeno di udire gli osanna agli dèi immortali e beati”. E in conclusione, Feuerbach asserisce che “nella disgrazia, nel bisogno […] l’uomo fa la dolorosa esperienza che egli non può fare ciò che vuole, che ha le mani legate”.
Il fondamento della preghiera è vicino a quello della civiltà e si evolve parallelamente ad esso (§ 34/36)
La religione serve, quindi, a domare una natura che ci è ostile, e “ha lo stesso fine, insomma, della cultura o della civiltà, che è rivolta unicamente a fare della natura un ente che dal punto di vista teorico sia comprensibile, e da quello pratico sia condiscendente, comprensivo per i bisogni umani”; e tuttavia, sfortunatamente, “la civiltà non riesce mai a realizzare i desideri della religione; essa infatti non può togliere quei termini dell’uomo che hanno il loro fondamento nell’essenza di esso”: Feuerbach sostiene così che la religione riesce a risolvere (seppure in maniera fallace) quei problemi che risultano impenetrabili per il progresso della civiltà umana. La comprensione totalizzante della natura può essere quindi riscontrata solo nella religione, ma tutto è clamorosamente vano: “la natura non risponde ai lamenti e alle domande dell’uomo; lo respinge implacabilmente in lui stesso”. Oltretutto, nella religione feticistico-animistica, l’oggetto della venerazione è spesso un ente materiale privo di vita (come un ceppo d’albero o una pietra) che viene considerato autosufficiente e sussistente per sé.
Con il progredire dello stato di civiltà, l’uomo si trasforma in un ente morale e politico; ecco che, per superare le intime contraddizioni del feticismo, la divinità acquisisce l’attributo dello spiritualismo e soprattutto diviene il supremo reggitore dei valori etici e politici: Zeus quindi diventa il punitore degli empi e degli spergiuri, nonché il padre di tutti i re umani. Così “la forza della natura come tale, e il sentimento di dipendenza da essa, scompaiono di fronte al potere politico o morale”. L’uomo, a questo punto, è pronto a far dipendere tutto dalla sua stessa essenza, in quanto fonde i propri valori morali con gli attributi divini e viceversa: i sovrani mortali, ad esempio, sono lodati con prerogative non umane e innalzati a figli degli dèi.
La religiosità orientale è differente da quella occidentale (§ 38/39)
Secondo Feuerbach, la civiltà orientale “non dimentica per l’uomo la natura”, e dunque tende a vedere il sovrano terreno come un ente celeste. Anzi, il nostro filosofo stigmatizza così il rapporto tra la civiltà occidentale e la civiltà orientale: “nei confronti dell’occidentale l’orientale si trova nella situazione dell’abitante della campagna rispetto a quello della città. Il primo è dipendente dalla natura, il secondo dall’uomo, il primo si orienta sulla base delle indicazioni del barometro, il secondo sull’andamento della borsa”. E tuttavia il mondo occidentale è più progredito nella civiltà perché soltanto gli abitanti della città “fanno la storia”. E ancora, nel mondo orientale la natura è oggetto di adorazione, mentre nel mondo occidentale essa è oggetto di godimento.
Critica di antropocentrismo, creazionismo, monoteismo, razionalismo e teleologia (§ 40/49)
Man mano che la coscienza umana progredisce, aumenta pure la tendenza ad attribuire alle rappresentazioni umane il valore di “criterio della verità e della realtà”. Ecco che il mondo apparirà all’uomo come un “ente determinato e dipendente dall’intelligenza e dalla volontà”, in quanto l’uomo diviene capace di innalzarsi con la volontà e con l’intelligenza al di sopra della natura (e di conseguenza anche Dio si innalza alla trascendenza). È questo il difetto dell’antropocentrismo.
A questo punto, entra in gioco un attributo fondamentale di Dio: dal momento che Egli è trascendente al mondo, deve esserne il legittimo creatore: “se il signore della natura non ne è in pari tempo l’artefice, l’origine e l’esistere di essa saranno allora indipendenti da lui, il suo potere sarà limitato e difettoso”. È questo il vizio del creazionismo.
E ancora, i credenti non riflettono e non capiscono che “l’uomo ha in se stesso la fonte del monoteismo, che il fondamento dell’unità di Dio è l’unità della coscienza e dello spirito umano”. Infatti Feuerbarch spiega che “il Dio che ha creato il mondo dal nulla […] non è altro che l’essenza della facoltà umana di astrarre e di immaginare, facoltà nella quale io posso, a mio piacere, rappresentarmi il mondo come essente o no, porre il suo essere o toglierlo”, o meglio, “rappresentarmi questo mondo come non essente, e, come reali, infiniti altri mondi”. Quindi l’essenza prima del monoteismo si basa sull’unità della coscienza del soggetto rappresentante.
Il discorso culmina, in definitiva, con l’asserzione secondo cui “l’ente spirituale a cui l’uomo attribuisce un rango superiore alla natura […] non è altro che l’essenza spirituale dell’uomo”.
E tuttavia l’uomo spende tempo ed energie per trovare una connessione tra l’uomo e Dio: questo trait d’union è ben rappresentato dalla metafisica razionalista, che ha la pretesa di “concentrare Dio sulla terra”. A questo proposito, Feuerbach scaglia questa violenta invettiva: “tu non vedi, o miope razionalista, che ciò che in te si ribella all’unione di Dio con l’uomo, che ti fa apparire questa unione come una contraddizione priva di senso, non è Dio, ma quella della natura o del mondo”.
La piaga più devastante è però per Feuerbach quella della teleologia: l’uomo è portato ad umanizzare la natura, attribuendole qualità che sono in realtà sue proprie, e dotando in definitiva la natura di un’intelligenza che non ha ragione di essere. Il nostro filosofo prende come esempio gli oggetti celesti ed i moti stellari: siccome l’uomo riesce a prevedere con mezzi matematici i movimenti di tali corpi, la maggioranza degli uomini si convince erroneamente che tali mezzi matematici siano già frutto di un progetto latente divino scritto in lingua matematica: “così il principio del conoscere è per l’uomo […] il principio dell’essere, la cosa pensata è la cosa reale, il pensiero dell’oggetto è l’essenza dell’oggetto”, il che è ovviamente scorretto. Agendo in tale maniera, “l’uomo rovescia l’ordine naturale delle cose, egli pone, alla lettera, il mondo sulla testa, fa del vertice della piramide la base di essa”. La chiave di volta di tutto il discorso sta quindi nell’asserto secondo cui “il segreto della teleologia ha la sua base nella contraddizione tra la necessità della natura e l’arbitrio dell’uomo, tra la natura quale essa è realmente e la natura quale l’uomo se la rappresenta”. Di conseguenza, il comportamento degli enti naturali deve essere interpretato al di fuori dell’attributo dell’intelligenza fornito dalla teleologia classica. I volatili, ad esempio, volano perché non possono fare altrimenti, ossia non padroneggiano un’arte del volo che consenta loro di stimare le resistenze meccaniche e anche di evitare di volare; nel caso in cui si dotasse (come nella teleologia classica) la natura dell’arte e dell’intelligenza, si incapperebbe tuttavia in un’aporia ben più grave: come si potrebbero spiegare le malformazioni e le deformità naturali?
L’unico modo per risolvere il problema sta nel concepire la natura come autonoma, operante secondo una “necessità sensibile, e quindi eccentrica, eccezionale, irregolare”. Peraltro, la magnificenza di tutti gli enti naturali rimanda in ogni istante a questa necessità sensibile: i fiori rappresentano il momento riproduttivo della vita della pianta, la tela del ragno rimanda alla sua necessità di alimentarsi. Non vi è dunque motivo per cui i razionalisti esaltino la natura perché comandata da un’intelligenza divina.
La Provvidenza, i miracoli e Dio stesso sono riducibili all’antropologia (§ 50/52)
“La provvidenza che si esprime nell’ordine, nella regolarità e nella conformità ad un fine dei fenomeni naturali non è la provvidenza della religione”: da questo asserto, ormai ampiamente chiarito, Feuerbach parte per sconvolgere ogni convinzione comune sulla provvidenza divina: se consideriamo che molti individui muoiono in età più che giovanile, ad esempio, possiamo notare la “scarsa cura che la natura ha per le singole membra”, ossia per i singoli individui viventi. Ecco che viene meno uno dei capisaldi del pensiero razionalista; tuttavia, a questo punto, entra in gioco la provvidenza divina vera e propria: “l’oracolo e la preghiera sono i modi religiosi con cui l’uomo rende ciò che è contingente, oscuro e incerto oggetto della provvidenza, della certezza, o almeno della fiducia”. Infatti il tempo degli dèi è il futuro, mentre il prosaico presente è esclusivamente umano ed ateo: “io sono [qui] adesso; gli dèi non mi possono più togliere questo istante”. Se così è, gli dèi dovrebbero avere la possibilità di intervenire attivamente nel corso dello svolgimento temporale: “la bontà è la proprietà essenziale degli dèi, ma come possono essere buoni se non sono onnipotenti, se non sono liberi dalle leggi della provvidenza naturale […] – se dunque non fanno miracoli?”. Cade così pure l’ultima difesa del provvidenzialismo: e Feuerbach può ben affermare che “gli dèi ed i miracoli devono la loro esistenza soltanto all’eccezione della regola”. Gli dèi sono “senza termini ciò che gli uomini sono coi termini”.
Analisi del monoteismo, del senso dei miracoli, del teismo e prospettive per il futuro della religione (§ 53/55)
Per Feuerbach, il politeismo è la fede nella natura intesa come un’essenza umana, mentre il monoteismo è la fede nell’essenza umana intesa come l’essenza della natura. Il politeismo annulla l’uomo dinnanzi alla potenza della natura, mentre il monoteista stima la singola anima umana superiore ad ogni creatura naturale, innalzando l’uomo a punto culminante della creazione divina: nel monoteismo è dunque grazie all’uomo che la natura assume un senso vero e proprio. I miracoli attestano quindi, secondo Feuerbach, “il dominio dell’uomo sulla natura, la divinità dell’uomo”. “Ma verrà il tempo nel quale […] la fede di un Dio in genere […] verrà considerata superstizione”: questa è la prospettiva ottimistica del discorso del nostro filosofo. L’uomo infatti dovrà capire che “Dio è una parola religiosa, è un oggetto ed un ente religioso, e non un ente fisico, astronomico, o, in una parola, cosmico”: infatti l’essenza di Dio “presuppone dunque uomini che lo onorino e lo preghino”, ed è un “oggetto della fantasia e del sentimento” che si ritrova soltanto nella fede e nell’immaginazione.
La storia della religione insegna, inoltre, che gli dèi greci erano ancora “limitati” perché non erano pensati come creatori diretti della natura e soprattutto perché “nei loro desideri si adattavano ancora ai limiti della natura umana”: infatti “i greci non facevano dell’essenza divina, cioè possibile, il modello, il fine e il metro dell’essenza reale, ma facevano dell’essenza reale il metro di quella possibile”. Al contrario, il Dio dei cristiani deve essere innanzitutto beatitudine senza termine, “sconfinata, inesprimibile, indefinibile”. In definitiva, il passaggio successivo (come emerge nei Principi della filosofia dell’avvenire) dovrà essere la soppressione dei desideri soprannaturali: “chi non ha più desideri soprannaturali non avrà più nemmeno essenze soprannaturali”.
ARNOLD RUGE

A cura di Erica Onnis e di Diego Fusaro
LA VITA
A. RUGEArnold Ruge (1802-1880) appartiene a quel circolo di pensatori politici che è passato alla storia come “Sinistra hegeliana” (secondo la definizione di David Strauss) e che fece derivare conseguenze politiche rivoluzionarie dal pensiero del filosofo di Stoccarda. Il motto hegeliano “ciò che è reale è razionale; ciò che è razionale è reale” venne da loro inteso come un invito rivoluzionario a razionalizzare il reale. Ruge era un attivo partecipante del circolo, fin dagli anni in cui esso si concentrò sulla dialettica degli insegnamenti hegeliani e non solo propose l’abolizione politica del vecchio regime feudale, ma formulò anche teorie che si rivelarono fondamentali per lo sviluppo del socialismo e della democrazia. Negli anni ‘30, dopo aver scontato una condanna in carcere per aver aderito ad un’organizzazione giovanile, prese parte al movimento democratico la cui influenza si estendeva da Halle a Berlino, Dresda, Parigi e Lipsia. Ruge era anche fra coloro che svilupparono il progetto per una gioventù hegeliana e si interessò a fondo alla rilevanza pragmatica della teoria. Egli inoltre non perse mai di vista il rapporto del movimento politico con il fine di cambiare la situazione presente.
L’aspirazione politica di Ruge era quella di una repubblica borghese-democratica, idea che causò il definitivo allontanamento del filosofo dalle posizioni rivoluzionarie e totalmente antiborghesi di Karl Marx, con cui aveva pubblicato i Deutsch-franzosische Jahrbucher. Nella tarda estate del 1846, Ruge lasciò Parigi e, passando per la Svizzera, si recò a Lipsia, dove possedeva una libreria. Accogliendo con favore la rivoluzione parigina del 1848, appoggiò il diffondersi della rivoluzione in Germania. Nel periodo iniziale, prima della fondazione dei partiti politici, potè unicamente frequentare il circolo politico-letterario che si era formato attorno al Grenzboten. Ruge aderiva con convinzione alle idee democratiche, come è attestato dalla sua piena adesione alla rivoluzione del 48. Su di lui incise soprattutto l’insegnamento dei riformatori sociali francesi e dei socialisti utopisti come Proudhon e Blanc. Ruge incluse queste teorie nella sua opera L’istituzione della democrazia in Germania o lo stato popolare e la libertà socialdemocratica, in cui sottolineò gli interessi della classe operaia.
Dopo alcune incomprensioni che gli procurarono forti delusioni a Francoforte, spostò le sue speranze politiche a Berlino, dove sperava si sviluppasse il centro del movimento rivoluzionario. Propose di fondare una rivista radicale democratica e progettava di trasferirsi a Berlino. Il suo giornale fu pubblicato con il nome Die Reform nella casa editrice di Lipsia, con cui Ruge aveva già pubblicato le altre sue opere. Come membro dell’associazione democratica, egli sviluppò radicali concetti di democrazia e partecipò all’edizione in Germania del manifesto elettorale del partito radicale democratico del 16 Aprile 1848. Die Reform risultò in breve la rivista più radicale del partito dell’opposizione borghese-democratico. Ruge fu anche l’autore del primo manifesto programmatico della fazione Donnersberg e il suo impegno politico verso il movimento democratico ebbe una fondamentale importanza durante la rivoluzione. Nel Die Reform Ruge propugnò la costituzione di una repubblica tedesca, il disarmo generale e una lega europea dei popoli. Le sue frequenti assenze dal parlamento di Francoforte, dovute ai suoi numerosi viaggi, lo portarono, nel 1848, a perdere il mandato. Come membro della commissione che si occupava della questione austro-slava, supportò la democrazia umanitaria, in quanto considerava questa forma di governo la soluzione definitiva della questione polacca. Ma le forze conservatrici si rafforzarono provocando non solo la chiusura della rivista di Ruge, il Die Reform, ma anche la sua espulsione dalla Prussia in seguito alla quale il filosofo si trasferì a Lipsia e assunse un nuovo ruolo supportando la rivoluzione del maggio 1849 a Dresda: la sanguinosa repressione della rivolta lo obbligò a fuggire rischiando l’arresto. L’attività di Ruge negli anni 1848-9, durante le rivoluzioni, è sostanzialmente un’attività di ricerca. La sconfitta della rivoluzione però fu per lui una gran delusione e lo costrinse per la seconda volta ad abbandonare la Germania e a trasferirsi a Brighton, sulla costa meridionale dell’Inghilterra. Fu ancora attivo nei primi anni che seguirono la rivoluzione nella “Commissione democratica europea” a Londra, dove le figure-guida dell’emigrazione politica, compresi Ledru-Rollin e Mazzini, tentarono di coordinare i lavori dell’opposizione borghese-democratica. Da questo momento in poi rimase relativamente inattivo fino alla morte, che lo colse nel 1880.
IL PENSIERO
Per Ruge, fedele alla linea della Sinistra hegeliana, la realtà presente non ha ancora raggiunto la razionalità che le spetta: è infatti venata da infinite contraddizioni, soprattutto sul terreno sociale/politico. L’errore (o, come direbbe Marx, la “ideologia”) della Destra hegeliana sta nell’illudersi che il reale sia in sé razionale e pertanto degno di essere conservato nella sua interezza: proprio perché irrazionale, obiettano Ruge e gli altri della Sinistra, il reale dev’essere razionalizzato, ossia modellato in base all’idea di giustizia e di razionalità che per ora sussiste solo nelle menti degli uomini. Sicché il compito più autentico della filosofia è di negare lo status quo, smascherandone i vizi, le contraddizioni e le storture: la filosofia di Ruge e della Sinistra può allora essere tratteggiata come un costante anticipare il futuro attraverso la critica del presente. “Critica” è la loro parola d’ordine, accompagnata dalla negazione dialettica (mutuata da Hegel) del presente. Rispetto all’idea razionale dello Stato, inteso in modo liberale e democratico, la realtà presente non può che essere inadeguata: e pertanto ci si deve adoperare per trasformarla, per adeguarla al modello di Stato razionale. La religione stessa, per Ruge e per gli altri della Sinistra, deve cedere il passo alla filosofia, che – secondo gli insegnamenti di Hegel stesso – le è nettamente superiore perché fa uso del concetto anziché della rappresentazione. L’attività di Ruge e di buona parte dei membri della Sinistra è scandita soprattutto da pubblicazioni su giornali e riviste, anche alla luce del fatto che ad essi furono spesso preclusi l’insegnamento accademico e la pubblicazione di libri: comincia così ad affermarsi in Germania la nuova figura del letterato che vive solo dei proventi della sua attività professionale. A tal proposito, Ruge fonda nel 1838 gli “Annali di Halle per la scienza e l’arte tedesca” (poi intitolati “Annali tedeschi”), che saranno poi soppressi dall’agguerrita censura prussiana nel 1843. Nello stesso 1843, egli emigra a Parigi e incontra Marx: con lui fonda gli “Annali franco tedeschi”, di cui tuttavia vede la luce solo il primo numero. Ruge è perfettamente in sintonia con l’idea hegeliana secondo cui “la filosofia è il proprio tempo appreso in pensieri”: fare filosofia significa capire la propria epoca. Ma Ruge dissente da Hegel nella misura in cui riconosce che lo spirito del tempo è naturalmente progressivo, sempre in corsa verso il futuro: l’errore di Hegel sta nell’aver invece cristallizzato i singoli momenti storici in essenze metafisiche. Sicché, fa notare Ruge, l’identità di reale e razionale dev’essere intesa non già come il presupposto della storia (come credevano Hegel e i membri della Destra hegeliana), bensì come il compito che deve essere in essa realizzato. Si tratta pertanto di mutare l’atteggiamento contemplativo di Hegel, che non aveva fede nelle elezioni e nella maggioranza, in azione politica volta a trasformare la realtà razionalizzandola.
MARX & ENGELS
Cronologia della vita e opere
1818 Karl Heinrich Marx nasce il 5 maggio a Treviri, la più antica città della Germania, all’una e mezza di notte. Il padre è un affermato avvocato di origine ebraica, così anche la madre di Marx, Henrietta Pressburg.
1830 Si iscrive al Liceo-ginnasio di Treviri. Si dedica agli studi classici e letterari, trascurando la storia.
1835 Per volontà del padre, Karl si reca all’Università di Bonn a studiare diritto. Frequenta le lezioni di filosofia e di letteratura del vecchio A.W. Schlegel. Ma si dà anche alla vita godereccia e bohémienne che preoccupa la famiglia. Condannato per ubriachezza e schiamazzi notturni, trascorre perfino un giorno in prigione. Successivamente, in un duello fra studenti, è ferito al sopracciglio. Si sente portato per la poesia, altra inclinazione che non piace per nulla al padre.
1836 Si fidanza segretamente con Jenny von Westphalen. Il futuro suocero di Marx ha un affetto ricambiato dal filosofo tedesco. Nell’autunno Marx parte per Berlino per proseguire i suoi studi di diritto in un ateneo ancora più austero e prestigioso di quello di Bonn. Qui aveva insegnato Hegel. Tutta la cultura berlinese era dominata dal pensiero hegeliano, non soltanto in campo filosofico ma anche scientifico e giuridico.
1837-1841 A Berlino, Karl rafforza le sue inclinazioni romantiche. Scrive molte poesie a Jenny, raccolte poi in due libri: “Libro dei canti” e “Libro dell’amore”, che Jenny custodirà sempre gelosamente. Viene esonerato dal servizio militare per una malattia agli occhi. Entra in un circolo di giovani della “sinistra hegeliana” impegnati in politica su posizioni radicali. Sono mesi di studi e riflessioni. Inizia a scrivere la sua tesi di laurea sulla “Differenza fra la filosofia della natura di Democrito e quella di Epicuro”. Dopo la laurea decide di dedicarsi al giornalismo.
1842 Inizia la collaborazione con la “Rheinische Zeitung” (“Gazzetta Renana”), giornale liberale appena fondato dall’amico Arnold Ruge, esponente della sinistra hegeliana. La Gazzetta Renana avrà breve vita, per ragioni politiche. Marx vi scrive in merito alla libertà di stampa, sulla caccia di frodo e sul problema dei furti di legname e sulla divisione della terra.
1843 La Gazzetta Renana viene interdetta per ragioni di censura e, pochi mesi dopo, il 31 marzo è costretta a chiudere. Marx si dedica allora agli studi di filosofia, inizia a fare i conti con il “materialismo” di Feuerbach e scrive la “Critica del diritto pubblico di Hegel”. Ruge lo invita a raggiungerlo a Parigi, dove gli offre un posto di condirettore della rivista “Annali franco-tedeschi” e uno stipendio di 500 talleri. Questa prospettiva lo convince a sposare Jenny nella piccola chiesa luterana di Kranznach (19 giugno). Poi partono per la Francia. Destinazione: Parigi.
1844 Gli “Annali franco-tedeschi”, però, fanno la fine della Gazzetta Renana: Marx scrive due articoli, “Sulla questione ebraica” e “Sullo Stato e sulla religione” che provocano la reazione della Prussia che interdice ai redattori il rientro in Germania. Marx inizia a frequentare Blanc e Proudhon, ma anche l’anarchico Bakunin e il poeta tedesco Heine. Scrive i “Manoscritti parigini (Manoscritti economico-filosofici)” in cui denuncia l’alienazione del lavoro industrializzato. Entra nella “Lega dei Giusti” e collabora con il giornale comunista “Vorwarts”. Tutta questa attività gli procura l’espulsione dalla Francia.
1845-1846 Si trasferisce nella più tollerante Bruxelles. Pubblica in febbraio con FRIEDRICH ENGELS “La Sacra famiglia” contro le concezioni filosofiche di Bauer. A primavera Engels lo raggiunge a Bruxelles e nell’estate i due amici compiono un viaggio in Inghilterra per prendere i contatti con le associazioni operaie, in particolare con i cartisti. Sempre con Engels inizia la stesura dell’ “Ideologia tedesca”, prima organica esposizione del MATERIALISMO STORICO. Scrive le “Tesi su Feuerbach”.
1847 Primo congresso della Lega dei comunisti, nata dalla Lega dei giusti, che incarica Marx di stenderne il “manifesto”.
1848 L’Europa è scossa dalle rivoluzioni. Scrive insieme ad Engels il MANIFESTO DEL PARTITO COMUNISTA. Per la sua attività politica riceve l’ordine di abbandonare il Belgio. Visto il clima meno ostile della Germania verso i fuoriusciti, decide di rientrare in patria e fonda la “Neue Rheinische Zeitung”, che plaude alla rivoluzione parigina del giugno.
1847-1850 Nuovamente espulso dalla Prussia, Marx torna a Parigi, dove lo raggiunge la moglie, che aspetta un quarto bambino. Ma il governo francese gli vieta di rimanere sul suolo della Repubblica e Marx decide di trasferirsi a Londra. Qui, nonostante gli aiuti economici di Engels, vive in condizioni molto critiche.Tiene alcune conferenze presso l’Associazione culturale operaia comunista, prima traccia che lo avrebbe condotto alla stesura de IL CAPITALE.
1851-1856 Le sue condizioni economiche sono disastrose: “Non posso più uscire di casa avendo gli abiti impegnati”. Scrive “Il 18 Brumaio di Luigi Bonaparte” in cui analizza il colpo di stato del 2 dicembre 1851. Su sua proposta, la Lega dei comunisti viene sciolta. Nonostante i costanti aiuti dell’amico Engels e di altre persone, vive in condizioni di assoluta miseria. Nel 1854 la famiglia Marx si trasferisce in uno dei quartieri più malsani di Londra, Soho. Muore il piccolo Edgard, affettuosamente chiamato Musch. Per Marx è un dolore terribile. Nel 1856 grazie all’eredità della madre di Jenny, lasciano le due stanze soffocanti di Soho e si trasferiscono in Maintland Park, alla periferia di Londra.
1857 Marx riprende i suoi studi di economia. Inizia la stesura dei “Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica”, ampio lavoro preparatorio a “Il Capitale”.
1859-1863 Nel 1859 termina il manoscritto “Per la critica dell’economia politica”. Nel 1860 si intensificano i suoi rapporti con Lassalle che, come Marx, era giunto al socialismo attraverso la filosofia hegeliana. Per Marx sarà un poco un suo allievo. Lassalle morirà in duello nel 1864. Nel 1861 Jenny si ammala di vaiolo; qualche mese dopo anche Marx contrae e supera la stessa malattia. Per far fronte alla grave situazione economica della famiglia, fa domanda di assunzione nelle Ferrovie dello Stato, ma la richiesta viene respinta per la calligrafia pressocchè illeggibile. Alla fine del novembre 1863 muore sua madre; eredita un piccolo lascito dalla morte della madre che gli consente di superare i momenti peggiori.
1864 Nasce l’Associazione internazionale dei lavoratori (la PRIMA INTERNAZIONALE) e viene affidato a Marx il compito di redigere il programma. I primi anni di vita dell’Internazionale sono caratterizzati dalle polemiche tra la linea egemone di Marx e quelle minoritarie di Mazzini e Bakunin.
1865-1872 Nel 1865 scrive “Salario, prezzo e profitto”. Gli impegni per l’Internazionale gli consentono a fatica di trovare spazi per la stesura de “Il Capitale”. Nel 1867, presso l’editore Meissner di Amburgo esce il primo libro de “IL CAPITALE”, stampato in 1.000 esemplari. Le condizioni di famiglia sono sempre critiche sino a quando Engels non vende la sua parte di proprietà della fabbrica di Manchester e si impegna a corrispondere una somma fissa alla famiglia Marx, che finalmente può risolvere, in modo definitivo, i propri problemi economici. 1871: l’Impero francese cede sotto i colpi della Prussia di Bismarck e la Francia diviene nuovamente repubblicana. Quando i tedeschi chiedono il disarmo della Guardia nazionale (formata da proletari e borghesi radicali), l’insurrezione è generale: viene proclamata la COMUNE DI PARIGI e il potere passa nelle mani del popolo. Il governo di Thiers fugge a Bordeax. In maggio il governo decide la repressione sanguinosa della Comune parigina. I comunardi resistono ma sono battuti e massacrati (25.000 morti). Marx scrive la “Guerra civile in Francia” in cui esalta la Comune di Parigi come primo esperimento di “governo proletario” e grande bandiera del comunismo rivoluzionario.
1873-1880 Si aggravano le sue condizioni di salute, mentre sua figlia Eleanor si impegna in politica. Nel 1875 scrive il terzo volume de “Il Capitale”. In maggio, al Congresso di Gotha, nasce il Partito operaio socialdemocratico tedesco. Marx dissente dalla sua linea politica (“Critica al programma di Gotha”). Nel 1876 si scioglie, a Filadelfia, la Prima Internazionale. Anche lo stato di salute di Jenny diviene grave verso il 1879. Marx scrive e si occupa della situazione russa.
1881-1882 Il 2 dicembre del 1881 Jenny muore. Marx ne riceve un colpo tanto duro da non risollevarsi più: la sua salute è così sempre più minata. Sono ormai ricorrenti accesi colpi di tosse che non gli danno tregua. Passa, nel giugno del 1882, con i nipoti un periodo ad Argenteuil.
1883 A gennaio muore la primogenita di Marx, Jenny, a soli 38 anni. Questo ulteriore durissimo colpo lo ferisce a morte: alla bronchite si aggiunge un’ulcera polmonare. Il 14 marzo, alle 2 e 45 del pomeriggio, anche Marx muore. Viene sepolto nel cimitero londinese di Highgate il 17 marzo. Engels recita una breve orazione funebre che termina così: “I governi, assoluti e repubblicani, lo espulsero, i borghesi, conservatori e democratici radicali, lo coprirono a gara di calunnie. Egli sdegnò tutte queste miserie, non prestò loro nessuna attenzione, e non rispose se non in caso di estrema necessità. E’ morto venerato, amato, rimpianto da milioni di compagni di lavoro rivoluzionari in Europa e in America, dalle miniere siberiane sino alla California. E posso aggiungere senza timore: poteva avere molti avversari, ma nessun nemico personale. Il suo nome vivrà nei secoli, e così la sua opera!”.
Tutte e tre le figlie di Marx amavano un gioco di società, molto popolare in età vittoriana, chiamato ‘Confessioni’ e verso la metà degli anni Sessanta invitarono il padre Karl a sottoporsi all’interrogatorio. Ecco le sue risposte:
La virtù che preferisci: La semplicità
La qualità che preferisci in un uomo: La forza
La qualità che preferisci in una donna: La debolezza
La tua caratteristica principale: La determinazione
La tua idea della felicità: Lottare
La tua idea dell’infelicità: La sottomissione
Il difetto che scusi di più: La credulità
Il difetto che detesti di più La servilità
Ciò che ti disgusta di più: Martin Tupper
La tua occupazione preferita: Razzolare tra i libri
Il tuo poeta preferito: Shakespeare, Eschilo, Goethe
Il tuo scrittore preferito: Diderot
Il tuo eroe preferito: Spartaco, Keplero
La tua eroina preferita: Margherita
Il tuo fiore preferito: La dafne
Il tuo colore preferito: Il rosso
Il tuo nome preferito: Laura e Jenny
Il tuo piatto preferito: Il pesce
La tua massima preferita: Nihil humani a me alienum puto
Il tuo motto preferito: De omnibus dubitandum
Il pensiero di Marx
Breve introduzione
IL DENARO – “Il denaro, in quanto possiede la proprietà di comprar tutto, di appropriarsi di tutti gli oggetti, è dunque l’ oggetto in senso eminente. L’universalità della sua proprietà costituisce l’onnipotenza del suo essere, esso è considerato, quindi come ente onnipotente…Il denaro è il mediatore fra il bisogno e l’oggetto, fra la vita e il mezzo di vita dell’uomo. Ma ciò che media a me la mia vita mi media anche l’esistenza degli altri uomini. Per me è questo l’altro uomo. (—) Tanto grande è la mia forza quanto grande è la forza del denaro. Le proprietà del denaro sono mie, di me suo possessore: le sue proprietà e forze essenziali. Ciò ch’io sono e posso non è dunque affatto determinato dalla mia individualità. Io sono brutto, ma posso comprarmi la più bella fra le donne. Dunque non sono brutto, in quanto l’effetto della bruttezza, il suo potere scoraggiante, è annullato dal denaro. Io sono, come individuo storpio, ma il denaro mi dà 24 gambe: non sono dunque storpio. Io sono un uomo malvagio, infame, senza coscienza, senza ingegno, ma il denaro è onorato, dunque lo è anche il suo possessore. Il denaro è il più grande dei beni, dunque il suo possessore è buono: il denaro mi dispensa dalla pena di esser disonesto, io sono, dunque, considerato onesto; io sono stupido, ma il denaro è la vera intelligenza di ogni cosa: come potrebbe essere stupido il suo possessore? Inoltre questo può comprarsi le persone intelligenti, e chi ha potere sulle persone intelligenti non è egli più intelligente dell’uomo intelligente? Io, che mediante il denaro posso tutto ciò che un cuore umano desidera, non possiedo io tutti i poteri umani? Il mio denaro non tramuta tutte le mie deficienze nel loro contrario? (—) Poichè il denaro, in quanto concetto esistente e attuale del valore, confonde e scambia tutte le cose, esso costituisce la generale confusione e inversione di ogni cosa, dunque il mondo sovvertito, la confusione e inversione di tutte le qualità naturali e umane. (—) Il denaro, questa astrazione vuota ed estraniata della proprietà, è stato fatto signore del mondo. L’uomo ha cessato di essere schiavo dell’uomo ed è diventato schiavo della cosa; il capovolgimento dei rapporti umani è compiuto; la servitù del moderno mondo di trafficanti, la venalità giunta a perfezione e divenuta universale è più disumana e più comprensiva della servitù della gleba dell’era feudale; la prostituzione è più immorale, più bestiale dello ius primae noctis . La dissoluzione dell’umanità in una massa di atomi isolati, che si respingono a vicenda, è già in sè l’annientamento di tutti gli interessi corporativi, nazionali e particolari ed è l’ultimo stadio necessario verso la libera autounificazione dell’umanità”. (MARX e ENGELS dai MANOSCRITTI ECONOMICO-FILOSOFICI DEL 1844 e da altre opere)
DA DOVE NASCE LA RICCHEZZA? – “Il lavoro non è la fonte di ogni ricchezza. La natura è la fonte dei valori d’uso (e in questi consiste la ricchezza effettiva!) altrettanto quanto il lavoro, che a sua volta, è soltanto la manifestazione di una forza naturale, la forza-lavoro umana. I borghesi hanno i loro buoni motivi per attribuire al lavoro una forza creatrice soprannaturale; perchè dalle condizioni naturali del lavoro ne consegue che l’uomo, non ha altra proprietà all’infuori della sua forza-lavoro, deve essere, in tutte le condizioni di società, e di civiltà, lo schiavo di quegli uomini che si sono resi proprietari delle condizioni materiali del lavoro. Egli può lavorare solo col loro permesso, e quindi può vivere solo col loro permesso.”. (dalla CRITICA AL PROGRAMMA DI GOTHA – 1875)
LA STORIA UMANA – “La storia di ogni società sinora esistita è storia di lotte di classi. Liberi e schiavi, patrizi e plebei, baroni e servi della gleba, membri delle corporazioni e garzoni, in una parola oppressi ed oppressori sono sempre stati in contrasto fra di loro, hanno sostenuto una lotta ininterrotta, a volte nascosta, a volte palese: una lotta che finì sempre o con una trasformazione rivoluzionaria di tutta la società o con la rovina comune delle classi in lotta.”. (Marx-Engels, MANIFESTO DEL PARTITO COMUNISTA – 1848)
LE IDEE E CIO’ CHE SIAMO: IL MATERIALISMO STORICO – Le mie ricerche approdarono a questo risultato, che tanto i rapporti giuridici quanto le forme di Stato non devono essere concepiti né come autonomi né come prodotti del cosiddetto sviluppo generale dello spirito umano; le loro radici si trovano piuttosto nelle condizioni materiali di vita, che Hegel, seguendo le orme degli Inglesi e dei Francesi del XVIII secolo, indica, nel loro complesso, con il termine di società civile; ma l’anatomia di questa società deve essere cercata nell’economia politica… Il risultato generale a cui arrivai e che, una volta ottenuto, mi servì da filo conduttore del corso dei miei studi, può essere, in poche parole, così formulato: nella produzione sociale della loro esistenza gli uomini vengono a trovarsi in rapporti determinati, necessari, indipendenti dalla loro volontà, cioè in rapporti di produzione corrispondenti ad un determinato livello di sviluppo delle loro forze produttive materiali. Il complesso di tali rapporti di produzione costituisce la struttura economica della società, la base reale su cui si eleva una sovrastruttura giuridica e politica a cui corrispondono determinate forme di coscienza sociale. Il modo di produzione della vita materiale è ciò che condiziona il processo sociale, politico e spirituale. Non è la coscienza degli uomini che determina il loro essere, ma, al contrario, è il loro grado sociale che determina la loro coscienza . Ad un certo grado del loro sviluppo le forze produttive della società entrano in contraddizione con i rapporti di produzione esistenti o, per usare un termine giuridio, con i rapporti di proprietà nel cui ambito si erano mosse sino a quel momento. Da che erano forme di sviluppo delle forze produttive, questi rapporti si tramutano in vincoli che frenano tali forze. Si arriva quindi ad un’epoca di rivoluzione sociale. Cambiando la base economica viene ad essere sovvertita più o meno rapidamente tutta l’enorme sovrastruttura. (—) Inoltre con la divisione del lavoro è data altresì la contraddizione fra l’interesse del singolo individuo o della singola famiglia e l’interesse collettivo di tutti gli individui che hanno rapporti reciproci; e questo interesse collettivo non esiste puramente nell’immaginazione, come universale, ma esiste innanzi tutto nella realtà come dipendenza reciproca degli individui fra i quali il lavoro è diviso. Appunto da questo antagonismo, fra interesse particolare e interesse collettivo, l’interesse collettivo prende una configurazione autonoma come Stato, separato dai reali interessi singoli e generali, e in pari tempo come comunità illusoria, ma sempre sulla base reale di legami esistenti in ogni conglomerato familiare e tribale, come la carne e il sangue, la lingua, la divisione del lavoro accentuata e altri interessi, e soprattutto – come vedremo più particolarmente in seguito – sulla base delle classi già determinate dalla divisione del lavoro, che si differenziano in ogni raggruppamento umano di questo genere e delle quali una domina tutte le altre. Ne consegue che tutte le lotte nell’ambito dello Stato, la lotta fra democrazia, aristocrazia e monarchia, la lotta per il diritto di voto, ecc. ecc., altro non sono che forme illussorie nelle quali vengono condotte le lotte reali delle diverse classi, e inoltre che ogni classe che aspiri al dominio, anche quando, come nel caso del proletariato, il suo dominio implica il superamento di tutta la vecchia forma di società e del dominio in genere, deve dapprima conquistarsi il potere politico per rappresentare a sua volta il suo interesse come l’universale, essendovi costretta in un primo tempo. (—) Le idee della classe dominante sono in ogni epoca le idee dominanti; cioè la classe che è la potenza materiale dominante della società è in pari tempo la sua potenza spirituale dominante. La classe che dispone dei mezzi della produzione materiale dispone con ciò, in pari tempo, dei mezzi della produzione intellettuale, cossiché ad essa in complesso sono assoggettate le idee di coloro ai quali mancano i mezzi della produzione intellettuale. le idee dominanti non sono altro che l’espressione ideale dei rapporti materiali dominanti, sono i rapporti materiali dominanti presi come idee: sono dunque l’espressione dei rapporti che appunto fanno di una classe la classe dominante, e dunque sono le idee del suo dominio (—) Se ora nel considerare il corso della storia si svincolano le idee della classe dominante dalla classe dominante e si rendono autonome, se ci si limita a dire che in un’epoca hanno dominato queste o quelle idee, senza preoccuparsi delle condizioni della produzione e dei produttori di queste idee, e se quindi s’ignorano gli individui e le situazioni del mondo che stanno alla base di queste idee, allora si potrà dire per esempio che al tempo in cui dominava l’aristocrazia dominavano i concetti di onore, di fedeltà, ecc., e che durante il dominio della borghesia dominavano i concetti di libertà, di uguaglianza, ecc. Queste sono, in complesso, le immaginazioni della stessa classe dominante. Questa concezione della storia che è comune a tutti gli storici, particolarmente a partire dal diciottesimo secolo, deve urtare necessariamente contro il fenomeno che dominano idee sempre più astratte, cioè idee che assumono sempre più la forma dell’universalità. Infatti ogni classe che prenda il posto di un’altra che ha dominato prima è costretta, non fosse che per raggiungere il suo scopo, a rappresentare il suo interesse come interesse comune di tutti i membri della società, ossia, per esprimerci in forma idealistica, a dare alle proprie idee la forma dell’universalità, a rappresentarle come le sole razionali e universalmente valide. La classe rivoluzionaria si presenta senz’altro, per il solo fatto che si contrappone ad una classe, non come classe ma come rappresentante dell’intera società, appare come l’intera massa della società di contro all’unica classe dominante. (Marx-Engels, PER LA CRITICA DELL’ECONOMIA POLITICA, L’IDEOLOGIA TEDESCA)
LA RELIGIONE, IL MONDO CAPOVOLTO – “Il fondamento della critica alla religione é: è l’uomo che fa la religione, e non è la religione che fa l’uomo. Infatti, la religione è la coscienza di sè e il sentimento di sè dell’uomo che non ha ancora conquistato o ha già di nuovo perduto se stesso. Ma l’uomo non è un’entità astratta posta fuori del mondo. L’uomo è il mondo dell’uomo, lo Stato, la società. Questo Stato, questa società producono la religione, una coscienza capovolta del mondo, poiché essi sono un mondo capovolto. La religione è la teoria generale di questo mondo, il suo compendio enciclopedico, la sua logica in forma popolare, il suo punto d’onore spiritualistico, il suo entusiasmo, la sua sanzione morale, il suo solenne completamento, il suo universale fondamento di consolazione e di giustificazione. Essa è la realizzazione fantastica dell’essenza umana, poiché l’essenza umana non possiede una realtà vera. La lotta contro la religione è dunque, mediatamente, la lotta contro quel mondo, del quale la religione è l’aroma spirituale. La religione è il sospiro della creatura oppressa, è l’anima di un mondo senza cuore, di un mondo che è lo spirito di una condizione senza spirito. Essa è l’oppio del popolo. Eliminare la religione in quanto illusoria felicità del popolo vuol dire esigere la felicità reale. L’esigenza di abbandonare le illusioni sulla sua condizione è l’esigenza di abbandonare una condizione che ha bisogno di illusioni. La critica della religione, dunque, è, in germe, la critica della valle di lacrime, di cui la religione è l’aureola. La critica ha strappato dalla catena i fiori immaginari, non perché l’uomo porti la catena spoglia e sconfortante, ma affinché egli getti via la catena e colga i fiori vivi. La critica della religione disinganna l’uomo affinché egli pensi, operi, dia forma alla sua realtà come un uomo disincantato e giunto alla ragione, affinché egli si muova intorno a se stesso e, perciò, intorno al suo sole reale. La religione è soltanto il sole illusorio che si muove intorno all’uomo, fino a che questi non si muove intorno a se stesso. E’ dunque compito della storia, una volta scomparso l’al di la della verità, quello di ristabilire la verità dell’al di qua. E innanzi tutto è compito della filosofia, la quale sta al servizio della storia, una volta smascherata la figura sacra dell’autoestraneazione umana, smascherare l’autoestraneazione nelle sue figure profane. La critica del cielo si trasforma così nella critica della terra, la critica della religione nella critica del diritto, la critica della teologia nella critica della politica. (—) La critica della religione approda alla teoria che l’uomo è per l’uomo l’essere supremo”. (da varie opere)
IL CAPITALISMO – “La società borghese è la più complessa e avanzata organizzazione storica della produzione. Le categorie che esprimono i suoi rapporti e che fanno comprendere la sua struttura permettono, dunque, di comprendere parimenti la struttura e i rapporti di produzione di tutte le forme di società del passato sulle cui rovine e con i cui elementi essa si è costruita, e di cui sopravvivono in essa ancora residui parzialmente non superati. (—) L’economia politica, in quanto borghese, cioè in quanto concepisce l’ordinamento capitalistico invece che come grado di svolgimento storicamente transitorio addirittura all’inverso, come forma assoluta e definitiva della produzione sociale, può rimanere scienza soltanto finchè la lotta di classe rimane latente o si manifesta soltanto in fenomeni isolati. (—) Condizione essenziale per l’esistenza e il dominio della classe borghese è l’accumulazione della ricchezza nelle mani dei privati e la formazione e l’aumento del capitale; condizione del capitale è il lavoro salariato. (—) La ricchezza delle società nelle quali predomina il modo di produzione capitalistico si presenta come un’ immane raccolta di merci e la merce singola si presenta come una forma elementare. Perciò la nostra indagine inizia come analisi della merce.”. (da varie opere)
LA MERCE, “una cosa molto strana” – “La merce è in primo luogo un oggetto esterno, una cosa che mediante le sue qualità soddisfa i bisogni umani di qualsiasi tipo. (—) L’utilità di una cosa ne fa un valore d’uso. Ma questa utilità non aleggia nell’aria. E’ un portato delle qualità del corpo della merce e non esiste senza di esso. Il corpo della merce, come il ferro, il grano, il diamante, ecc. è, quindi, un valore d’uso, ossia un bene. (—) Il valore d’uso si realizza soltanto nell’uso, ossia nel consumo. (—) Una merce sembra, a prima vista, qualcosa di ovvio, di banale. La sua analisi mostra che essa è una cosa molto strana, piena di stravaganze metafisiche e di astruserie teologiche. Finchè è valore d’uso, nulla c’è di misterioso in essa. La forma del legno, per esempio, viene trasformata e si fa di essa un tavolo. Ciò non di meno un tavolo resta legno, una cosa comune e percepibile. Ma appena si presenta come merce, esso si trasforma in una cosa sensibile-sovrasensibile. Non soltanto si appoggia con le sue gambe al terreno, ma si contrappone a tutte quante le merci e tira fuori dalla sua testa di legno storie molto più stravaganti che se cominciasse spontaneamente a ballare. (—) La circolazione delle merci è il punto di partenza del capitale. Produzione di merci e circolazione perfezionata di merci, commercio, formano le premesse storiche della sua nascita. (—) In modo immediato il valore d’uso è la base materiale su cui si evidenzia un determinato rapporto economico, il valore di scambio. Il valore di scambio appare in primo luogo come un rapporto quantitativo, entro il quale i valori d’uso sono interscambiabili. (—) Così un’opera di Properzio e otto once di tabacco da fiuto possono avere lo stesso valore di scambio nonostante la diversità fra il valore d’uso di un tabacco o di un’elegia.”. (da varie opere)
LA FORZA-LAVORO – “Il valore della forza-lavoro, come quello di ogni altra merce, è determinato dal tempo di lavoro necessario nella produzione, e quindi anche nella riproduzione, di questo articolo specifico. (—) Il valore della forza lavoro si risolve nel valore di una certa somma dei mezzi di sussistenza. Quindi varia col variare di quei mezzi di sussistenza, cioè con la grandezza del tempo-lavoro richiesto nella loro produzione. (—) Ciò che l’operaio vende non è il suo lavoro , ma la sua forza-lavoro, che egli mette temporaneamente a disposizione del capitalista. (—) Che cosa è, dunque, il valore della forza-lavoro? Come per ogni altra merce il suo valore è determinato dalla quantità di lavoro necessaria alla sua riproduzione , ma l’uso di questa forza-lavoro trova un limite soltanto nelle energie vitali e nella forza fisica dell’operaio. (—) Originariamente l’operaio vende la sua forza-lavoro al capitalista perchè gli mancano i mezzi materiali per la produzione di una merce: ma ora la sua stessa forza-lavoro individuale viene meno al suo compito quando non venga venduta al capitalista; essa funziona ormai soltanto in un nesso che esiste solamente dopo la sua vendita, nell’officina del capitalista.”. (da varie opere)
DOVE NASCE LO SFRUTTAMENTO? – “Prendiamo l’esempio del nostro filatore. Per ricostruire ogni giorno la sua forza-lavoro, egli deve produrre un valore giornaliero di tre scellini, cosa che egli fa lavorando sei ore al giorno. Pagando il valore giornaliero o settimanale della forza-lavoro del filatore, il capitalista ha acquistato il diritto di usare questa forza-lavoro per tutto il giorno o per tutta la settimana. Perciò egli lo farà lavorare, supponiamo, dodici ore al giorno. Oltre le sei ore che gli sono necessarie per produrre l’equivalente del suo salario, cioè del valore della sua forza lavoro, il filatore dovrà, dunque, lavorare altre sei ore, che io chiamerò ore di sopralavoro e questo sopralavoro si incorporerà in un plusvalore e in un sopraprodotto.”. (da IL CAPITALE, 1867)
IL PROFITTO – “Il plusvalore, cioè quella parte di valore complessivo della merce in cui è incorporato il sopralavoro o lavoro non pagato dell’operaio, io lo chiamo profitto.”. (da SALARIO, PREZZO E PROFITTO – 1865)
LA RIVOLUZIONE – “Tanto per la produzione di massa di questa coscienza comunista quanto per il successo della cosa stessa è necessaria una trasformazione in massa degli uomini, che può avvenire soltanto in un movimento pratico, in una rivoluzione; quindi la rivoluzione non è necessaria soltanto perchè la classe dominante non può essere abbattuta in nessuna altra maniera, ma anche perchè la classe che l’abbatte può riuscire solo in una rivoluzione a levarsi di dosso tutto il vecchio sudiciume e a diventare capace di fondare su basi nuove la società. (—) Che le classi dominanti tremino al pensiero di una rivoluzione comunista. I proletari non hanno da perdervi altro che le proprie catene. Da guadagnare hanno un mondo”. (MARX e ENGELS)
SUPERAMENTO DEL CAPITALISMO – “I proletari non hanno nulla di proprio da salvaguardare; devono distruggere tutto ciò che fino ad ora ha garantito e assicurato la proprietà privata. (—) Per sopprimere il pensiero della proprietà privata è del tutto sufficiente il comunismo pensato. Per sopprimere la proprietà privata effettiva, reale, occorre una effettiva, reale azione comunista. (—) Tutti i movimenti precedenti sono stati movimenti di minoranze o avvenuti nell’interesse di minoranze. Il movimento proletario è il movimento indipendente della immensa maggioranza nell’interesse della immensa maggioranza. (—) La condizione dell’emancipazione della classe lavoratrice è l’abolizione di tutte le classi, come la condizione dell’emancipazione del ‘terzo stato’ dell’ordine borghese fu l’abolizione di tutti gli altri stati.”. (da varie opere)
LA LOTTA DI CLASSE – “La storia di ogni società è stata finora la storia di lotte di classe. Uomo libero e schiavo, patrizio e plebeo, barone e servo della gleba, membro di una corporazione e artigiano, in breve oppressore e oppresso si sono sempre reciprocamente contrapposti, hanno combattuto una battaglia ininterrotta, aperta o nascosta, una battaglia che si è ogni volta conclusa con una trasformazione rivoluzionaria dell’intera società o con il comune tramonto delle classi in conflitto. Nelle precedenti epoche storiche noi troviamo dovunque una suddivisione completa della società in diversi ceti e una multiforme strutturazione delle posizioni sociali. Nell’antica Roma abbiamo patrizi, cavalieri, plebei, schiavi; nel Medioevo, feudatari, vassalli, membri delle corporazioni, artigiani, servi della gleba, e ancora, in ciascuna di queste classi, ulteriori specifiche classificazioni. La moderna società borghese, sorta dal tramonto della società feudale, non ha superato le contrapposizioni di classe. Ha solo creato nuove classi al posto delle vecchie, ha prodotto nuove condizioni dello sfruttamento, nuove forme della lotta fra le classi. La nostra epoca, l’epoca della borghesia, si caratterizza però per la semplificazione delle contrapposizioni di classe. L’intera società si divide sempre più in due grandi campi nemici, in due grandi classi che si fronteggiano direttamente: borghesia e proletariato “. (Marx-Engels, MANIFESTO DEL PARTITO COMUNISTA – 1848)
COMUNISMO O BARBARIE – “Il comunismo non toglie a nessuno la facoltà di appropriarsi dei prodotti della società, toglie soltanto la facoltà di valersi di tale appropriazione al fine di asservire lavoro altrui. (—) Ciò che distingue il comunismo non è l’abolizione della proprietà in generale, bensì l’abolizione della proprietà borghese. Ma la moderna proprietà privata borghese è l’ultima e la più perfetta espressione dei modi di produzione e appropriazione di prodotti che poggia sugli antagonismi di classe, sullo sfruttamento degli uni da parte degli altri. In questo senso, i comunisti possono riassumere la loro teoria in quest’unica espressione: abolizione della proprietà privata. (—) Il comunismo è possibile empiricamente solo come azione dei popoli dominanti tutti ‘in una volta’ e simultaneamente, e ciò presuppone lo sviluppo universale della forza produttiva e le relazioni mondiali che il comunismo implica. Il comunismo, per noi, non è uno stato di cose che debba essere instaurato, un ideale al quale la realtà debba conformarsi. Chiamiamo comunismo il movimento reale che abolisce lo stato di cose presenti.”. (da varie opere)
LA PROPRIETA’ PRIVATA – “Voi inorridite perché noi vogliamo eliminare la proprietà privata. Ma nella vostra società esistente la proprietà privata è abolita per i nove decimi dei suoi membri; anzi, essa esiste proprio in quanto non esiste per quei nove decimi. Voi ci rimproverate dunque di voler abolire una proprietà che ha per condizione necessaria la mancanza di proprietà per la stragrande maggioranza della società.(—) Il comunismo non toglie a nessuno il potere di appropriarsi dei prodotti sociali; toglie soltanto il potere di soggiogare il lavoro altrui mediante questa appropriazione. E’ stato obiettato che, con la soppressione della proprietà privata, cesserà ogni attività e si diffonderà una pigrizia generale. Se così fosse, la società borghese sarebbe da parecchio tempo andata in rovina a causa dell’indolenza, dal momento che in essa chi lavora non guadagna e chi guadagna non lavora “. (Marx-Engels, MANIFESTO DEL PARTITO COMUNISTA – 1848)
UNA NUOVA UMANITA’ – “Al posto della vecchia società borghese con le sue classi e i suoi antagonismi sorgerà un’associazione nella quale il libero sviluppo di ciascuno sarà la condizione per il libero sviluppo di tutti.”. (Marx-Engels, MANIFESTO DEL PARTITO COMUNISTA – 1848)
L’ALIENAZIONE – ” Nell’alienazione dell’oggetto del lavoro si riassume solo l’alienazione, l’espropriazione, dell’attività stessa del lavoro. In cosa consiste ora l’espropriazione del lavoro? In primo luogo in questo: che il lavoro resta esterno all’operaio, cioè non appartiene al suo essere, e che l’operaio quindi non si afferma nel suo lavoro, bensì si nega, non si sente appagato, ma infelice, non svolge alcuna libera energia fisica e spirituale, ma mortifica il suo corpo e rovina il suo spirito. L’operaio si sente dunque con se stesso solamente fuori del lavoro, e fuori di sè nel lavoro. Come a casa sua è solo quando non lavora e quando non lavora non lo è. Il suo lavoro non è volontario, ma forzato, è lavoro costrittivo. Il lavoro non è quindi la soddisfazione di un bisogno, ma è solo un mezzo per soddisfare dei bisogni esterni ad esso. La sua estraneità risalta nel fatto che, appena cessa di esistere una costrizione fisica o d’altro genere, il lavoro è fuggito come una peste. Il lavoro esterno, il lavoro in cui l’uomo si espropria, è un lavoro-sacrificio, un lavoro mortificazione. In fine l’esteriorità del lavoro al lavoratore si palesa in questo: che il lavoro non è cosa sua ma di un altro; che non gli appartiene, e che in esso egli non appartiene a sè, ma ad un altro. Come nella religione l’attività spontanea dell’umana fantasia, dell’umano cervello e del cuore umano, opera indipendentemente dall’individuo, cioè come un’attività estranea, divina o diabolica, così l’attività del lavoratore non è attività spontanea. Essa appartiene ad un altro, è la perdita del lavoratore stesso. Il risultato è che l’uomo (il lavoratore) si sente libero ormai solo nelle sue funzioni bestiali, nel mangiare, nel bere e nel generare, tutt’al più nell’avere una casa, nella sua cura corporale, ecc. e che nelle sue funzioni umane si sente solo più una bestia. Il bestiale diventa l’umano e l’umano il bestiale. (—) Il lavoro alienato 1)aliena all’uomo la natura ; 2) aliena all’uomo se stesso, la sua attiva funzione, la sua attività vitale, aliena così all’uomo il genere; (—) il lavoro alienato fa dunque 3)della specifica essenza dell’uomo, tanto della natura che dello spirituale potere di genere, un’essenza a lui estranea, il mezzo della sua individuale esistenza; estrania all’uomo il suo proprio corpo, come la natura di fuori, come il suo spirituale essere, la sua umana essenza; 4)che un’immediata conseguenza, del fatto che l’uomo è estraniato dal prodotto del suo lavoro, dalla sua attività vitale, dalla sua specifica essenza, è lo straniarsi dell’uomo dall’uomo. Quando l’uomo sta di fronte a se stesso, gli sta di fronte l’altro uomo. “. (MARX: MANOSCRITTI ECONOMICO-FILOSOFICI DEL 1844)
LO STATO – “Lo Stato non è affatto una potenza imposta alla società dall’esterno e nemmeno ‘la realtà dell’idea etica’, ‘l’immagine e la realtà della ragione’, come sostiene Hegel. Esso è piuttosto un prodotto della società giunta ad un determinato stadio di sviluppo, è la confessione che questa società si è avvolta in una contraddizione insolubile con se stessa, che si è scissa in antagonismi inconciliabili che è impotente a eliminare. Ma perchè questi antagonismi, queste classi con interessi economici in conflitto non distruggano se stessi e la società in una sterile lotta, nasce la necessità di una potenza che sia in apparenza al di sopra della società, che attenui il conflitto, lo mantenga nei limiti dell’ ordine; e questa potenza che emana dalla società, ma che si pone al di sopra di essa e che si estranea sempre più da essa, è lo Stato. Nei confronti dell’antica organizzazione gentilizia il primo segno distintivo dello Stato è la divisione dei cittadini secondo il territorio. (—) Il secondo punto è l’istituzione di una forza pubblica che non coincide più direttamente con la popolazione che organizza se stessa come potere armato. (—) Lo Stato, poichè è nato dal bisogno di tenere a freno gli antagonismi di classe, ma contemporaneamente è nato in mezzo al conflitto di queste classi, è, per regola, lo Stato della classe più potente, economicamente dominante che, per mezzo suo, diventa anche politicamente dominante e così acquista un nuovo strumento per tener sottomessa e per sfruttare la classe oppressa. (—) Lo Stato non esiste dunque dall’eternità. (—) In un determinato grado dello sviluppo economico, necessariamente legato alla divisione della società in classi, proprio a causa di questa divisione, lo Stato è diventato una necessità. Ci avviciniamo ora, a rapidi passi, ad uno stadio di sviluppo della produzione in cui l’esistenza di queste classi non solo ha cessato di essere una necessità, ma diviene un ostacolo effettivo alla produzione. Perciò esse cadranno così ineluttabilmente come sono sorte. Con esse cadrà ineluttabilmente lo Stato. La società che riorganizza la produzione in base ad una libera ed uguale associazione di produttori, relega l’intera macchina statale nel posto che da quel momento le spetta, cioè nel museo delle antichità accanto alla rocca per filare e all’ascia di bronzo “. (ENGELS: L’ORIGINE DELLA FAMIGLIA, DELLA PROPRIETA’ PRIVATA E DELLO STATO)
LA FAMIGLIA E LE DONNE – “L’ordinamento comunistico della società farà del rapporto fra i due sessi un semplice rapporto privato che riguarderà solo le persone che vi partecipano, e nel quale la società non ha da ingerirsi. Potrà farlo perchè elimina la proprietà privata ed educa in comune i bambini, distruggendo così le due fondamenta del matrimonio come si è avuto finora; la dipendenza della donna dall’uomo e dei figli dai genitori dovuta alla proprietà privata. Qui sta anche la risposta alle strida dei filistei moralisti contro la comunanza comunista delle donne. La comunanza delle donne è una situazione legata totalmente alla società borghese e che oggigiorno esiste in pieno nella prostituzione. Ma la prostituzione poggia sulla proprietà privata e cade con essa. Dunque, l’organizzazione comunista, anzichè introdurre la comunanza delle donne, la abolisce invece. (—) ” (ENGELS e MARX)
CITTA’ E CAMPAGNA – “Solo una società che faccia ingranare, armoniosamente, le une nelle altre le sue forze produttive, secondo un solo grande piano, può permettere all’industria di stabilirsi in tutto il paese con quella dislocazione che è più appropriata al suo sviluppo e alla conservazione, e rispettivamente allo sviluppo, degli altri elementi della produzione. Conseguentemente la soppressione dell’antagonismo di città e campagna non solo è possibile, ma diventa una diretta necessità della stessa produzione industriale, così come è diventata del pari una necessità della produzione agricola ed inoltre dell’igiene pubblica. Solo con la fusione di città e campagna può essere eliminato l’attuale avvelenamento di acqua, aria e suolo, solo con questa fusione le masse che oggi agonizzano nelle città saranno messe in condizione in cui i loro rifiuti siano prodotti per produrre le piante e non le malattie”. (ENGELS)
PASSI ANTOLOGICI DI RILIEVO
Bisogna partire non dalla religione, ma dalla proprietà privata – “Si vede facilmente la necessità che l’intero movimento rivoluzionario trovi la propria base tanto empirica che teoretica nel movimento della proprietà privata, per l’appunto dell’economia. Questa proprietà privata materiale, immediatamente sensibile, è l’espressione materiale e sensibile della vita umana estraniata. Il suo movimento – la produzione e il consumo – è la rivelazione sensibile del movimento di tutta la produzione sino ad oggi, cioè della realizzazione o realtà dell’uomo. La religione, la famiglia, lo stato, il diritto, la morale, la scienza, l’arte, ecc. non sono che modi particolari della produzione e cadono sotto la sua legge universale. La soppressione positiva della proprietà privata, in quanto appropriazione della vita umana, è dunque la soppressione positiva di ogni estraniazione, e quindi il ritorno dell’uomo, dalla religione, dalla famiglia, dallo stato, ecc. alla sua esistenza umana, cioè sociale. L’estraniazione religiosa come tale ha luogo soltanto nella sfera della coscienza [,] dell’interiorità umana; invece l’estraniazione economica è l’estraniazione della vita reale, onde la sua soppressione abbraccia l’uno e l’altro lato. S’intende che nei diversi popoli il primo inizio del movimento è diverso a seconda che la vita vera e riconosciuta del popolo si svolga piú nella coscienza che nel mondo esterno, sia piú ideale che reale. Il comunismo comincia subito con l’ateismo (Owen), ma l’ateismo è ancora in principio ben lungi dall’essere comunismo: quell’ateismo è ancora piú che altro un’astrazione. […] si vede come la soluzione delle opposizioni teoretiche sia possibile soltanto in maniera pratica, soltanto attraverso l’energia pratica dell’uomo, e come questa soluzione non sia per nulla soltanto un cómpito della conoscenza, ma sia anche un cómpito reale della vita, che la filosofia non poteva adempiere, proprio perché essa intendeva questo cómpito soltanto come un cómpito teoretico”. (Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844)
Critica della critica filosofica – “Finora gli uomini si sono sempre fatti idee false intorno a se stessi, intorno a ciò che essi sono o devono essere. In base alle loro idee di Dio, dell’uomo normale, ecc. essi hanno regolato i loro rapporti. I parti della loro testa sono diventati piú forti di loro. Essi, i creatori, si sono inchinati di fronte alle loro creature. Liberiamoli dalle chimere, dalle idee, dai dogmi, dagli esseri prodotti dall’immaginazione, sotto il cui giogo essi languiscono. Ribelliamoci contro questa dominazione dei pensieri. Insegnamo loro a sostituire queste immaginazioni con pensieri che corrispondano all’essenza dell’uomo, dice uno; a comportarsi criticamente verso di esse, dice un altro; a togliersele dalla testa, dice un terzo, e la realtà ora esistente andrà in pezzi. Queste fantasie innocenti e puerili formano il nucleo della moderna filosofia giovane-hegeliana, che in Germania non soltanto è accolta dal pubblico con orrore e reverenza, ma è anche messa in circolazione dagli stessi eroi filosofici con la maestosa coscienza della sua criminosa spregiudicatezza. Il primo volume di questa pubblicazione ha lo scopo di smascherare queste pecore che si credono lupi e che tali vengono considerate, di mostrare come esse altro non fanno che tener dietro, con i loro belati filosofici, alle idee dei borghesi tedeschi, come le bravate di questi filosofi esegeti rispecchino semplicemente la meschinità delle reali condizioni tedesche. Essa ha lo scopo di mettere in ridicolo e di toglier credito alla lotta filosofica con le ombre della realtà, che va a genio al sognatore e sonnacchioso popolo tedesco”. (Marx-Engels, L’ideologia tedesca)
Comunismo e globalizzazione – “Questa “estraniazione”, per usare un termine comprensibile ai filosofi, naturalmente può essere superata soltanto sotto due condizioni pratiche. Affinché essa diventi un potere “insostenibile”, cioè un potere contro il quale si agisce per via rivoluzionaria, occorre che essa abbia reso la massa dell’umanità affatto “priva di proprietà” e l’abbia posta altresí in contraddizione con un mondo esistente della ricchezza e della cultura, due condizioni che presuppongono un grande incremento della forza produttiva, un alto grado del suo sviluppo; e d’altra parte questo sviluppo delle forze produttive (in cui è già implicita l’esistenza empirica degli uomini sul piano della storia universale, invece che sul piano locale), è un presupposto pratico assolutamente necessario anche perché senza di esso si generalizzerebbe soltanto la miseria e quindi col bisogno ricomincerebbe anche il conflitto per il necessario e ritornerebbe per forza tutta la vecchia merda, e poi perché solo con questo sviluppo universale delle forze produttive possono aversi relazioni universali fra gli uomini, ciò che da una parte produce il fenomeno della massa “priva di proprietà” contemporaneamente in tutti i popoli (concorrenza generale), fa dipendere ciascuno di essi dalle rivoluzioni degli altri, e infine sostituisce agli individui locali individui inseriti nella storia universale, individui empiricamente universali. Senza di che 1) il comunismo potrebbe esistere solo come fenomeno locale, 2) le stesse potenze dello scambio non si sarebbero potute sviluppare come potenze universali, e quindi insostenibili, e sarebbero rimaste “circostanze” relegate nella superstizione domestica, 3) ogni allargamento delle relazioni sopprimerebbe il comunismo locale. Il comunismo è possibile empiricamente solo come azione dei popoli dominanti tutti in “una volta” e simultaneamente, ciò che presuppone lo sviluppo universale della forza produttiva e le relazioni mondiali che esso comunismo implica”. (Marx-Engels, L’ideologia tedesca)
Il comunismo si identifica con l’umanismo – “Il comunismo come soppressione positiva della proprietà privata intesa come autoestraneazione dell’uomo, e quindi come reale appropriazione dell’essenza dell’uomo mediante l’uomo e per l’uomo; perciò come ritorno dell’uomo per sé, dell’uomo come essere sociale, cioè umano, ritorno completo, fatto cosciente, maturato entro tutta la ricchezza dello svolgimento storico sino ad oggi. Questo comunismo s’identifica, in quanto naturalismo giunto al proprio compimento, con l’umanismo, in quanto umanismo giunto al proprio compimento, col naturalismo; è la vera risoluzione dell’antagonismo tra la natura e l’uomo, tra l’uomo e l’uomo, la vera risoluzione della contesa tra l’esistenza e l’essenza, tra l’oggettivazione e l’autoaffermazione, tra la libertà e la necessità, tra l’individuo e il genere. È la soluzione dell’enigma della storia, ed è consapevole di essere questa soluzione”. (Manoscritti economico-filosofici del 1844)
Il lavoro nella società futura – “E infine la divisione del lavoro offre anche il primo esempio del fatto che fin tanto che gli uomini si trovano nella società naturale, fin tanto che esiste, quindi, la scissione fra interesse particolare e interesse comune, fin tanto che l’attività, quindi, è divisa non volontariamente ma naturalmente, l’azione propria dell’uomo diventa una potenza a lui estranea, che lo sovrasta, che lo soggioga, invece di essere da lui dominata. Cioè appena il lavoro comincia ad essere diviso ciascuno ha una sfera di attività determinata ed esclusiva che gli viene imposta e dalla quale non può sfuggire: è cacciatore, pescatore, o pastore, o critico, e tale deve restare se non vuol perdere i mezzi per vivere; laddove nella società comunista, in cui ciascuno non ha una sfera di attività esclusiva ma può perfezionarsi in qualsiasi ramo a piacere, la società regola la produzione generale e appunto in tal modo mi rende possibile di fare oggi questa cosa, domani quell’altra, la mattina andare a caccia, il pomeriggio pescare, la sera allevare il bestiame, dopo pranzo criticare, cosí come mi vien voglia; senza diventare né cacciatore, né pescatore, né pastore, né critico”. (Marx-Engels, L’ideologia tedesca)
Gli obiettivi dei comunisti – “Il proletariato si servirà del suo dominio politico per togliere gradualmente dalle mani della borghesia tutto il capitale, per accentrare tutti gli strumenti di produzione nelle mani dello Stato, cioè del proletariato organizzato come classe dominante e per accrescere con la piú grande celerità possibile la massa delle forze produttive. Va da sé che in un primo momento ciò può attuarsi solo grazie a interventi disposti nel diritto di proprietà e nei rapporti borghesi di produzione, quindi attraverso misure che da un punto di vista economico si presentano come insufficienti e inconsistenti, ma che nel corso del movimento vanno ben oltre i loro scopi e sono inevitabili come mezzi per rivoluzionare tutto il modo di produzione. Queste misure naturalmente saranno differenti a seconda dei diversi paesi. Per i paesi piú progrediti, tuttavia, potranno applicarsi quasi ovunque i seguenti punti: 1. Espropriazione della proprietà fondiaria e impiego della rendita fondiaria per le spese dello Stato. 2. Imposta fortemente progressiva. 3. Abolizione del diritto di successione. 4. Confisca della proprietà di tutti gli emigrati e i ribelli. 5. Accentramento del credito nelle mani dello Stato tramite una banca nazionale con capitale dello Stato e monopolio esclusivo. 6. Accentramento di tutti i mezzi di trasporto nelle mani dello Stato. 7. Aumento delle fabbriche nazionali, degli strumenti di produzione, dissodamento e miglioramento dei terreni secondo un piano collettivo. 8. Uguale obbligo di lavoro per tutti, formazione di esercizi industriali, soprattutto per l’agricoltura. 9. Unificazione dell’esercizio dell’agricoltura e dell’industria, graduale eliminazione dell’antagonismo tra città e campagna. 10. Istruzione pubblica e gratuita per tutti i bambini. Abolizione del lavoro di fabbrica per i fanciulli nella sua forma attuale. Unificazione dell’istruzione e della produzione materiale, ecc”.
Il sistema di produzione asiatico – “Ad esempio non è assolutamente in contraddizione con essa il fatto che, come accade nella maggioranza delle forme principali asiatiche, l’unità complessiva, che sta al di sopra di tutte queste piccole comunità, appaia come il proprietario supremo, o l’unico proprietario, sicché le comunità effettive appaiono solo come possessori ereditari. Poiché l’unità è l’effettivo proprietario, e l’effettivo presupposto della proprietà collettiva, essa può appunto cosí apparire come un qualcosa di particolare, che sta al di sopra delle molte particolari comunità reali dove il singolo poi in fact è privo di proprietà, o la proprietà – cioè il rapporto del singolo con le condizioni naturali del lavoro e della riproduzione, come corpo della sua subiettività a lui appartenente, obiettivo, trovato già pronto come natura inorganica, – gli appare mediata dalla cessione dell’unità totale – realizzata nel despota come padre delle molte comunità – al singolo attraverso la mediazione delle comunità particolari. Il prodotto eccedente – che del resto viene determinato legalmente in seguito all’effettiva appropriazione attraverso il lavoro – appartiene cosí, di per sé, a questa suprema unità. Pertanto nel dispotismo orientale e nell’assenza di proprietà, che giuridicamente sembra esistere in esso, esiste in realtà come fondamento questa proprietà tribale o comunitaria, prodotta essenzialmente dal combinarsi della manifattura e dell’agricoltura all’interno della piccola comunità che, in tal modo, diviene assolutamente self-sustaining e contiene in sé tutte le condizioni della riproduzione e della produzione in eccedenza. Una parte del suo lavoro eccedente appartiene alla comunità superiore, che alla fine esiste come persona, e questo lavoro eccedente si manifesta sia sotto forma di tributo, ecc., sia sotto forma di lavori collettivi, per esaltare l’unità, in parte il despota vero e proprio, in parte la tribalità idealizzata, il dio. Questa specie di proprietà comunitaria, può ora, in quanto essa qui si realizza effettivamente nel lavoro, manifestarsi o in modo che le piccole comunità vegetino l’una accanto all’altra indipendentemente, e il singolo lavori indipendentemente con la sua famiglia sul lotto assegnatogli (un lavoro determinato per la riserva comune, insurance per cosí dire, da una parte, e per fronteggiare le spese della comunità come tali, cioè per la guerra, il culto ecc.; il dominium signorile nel significato originario si trova qui per la prima volta, ad esempio nelle comunità slave, in quelle romene, ecc: Qui è insito il passaggio alla corvée, ecc.); o l’unità può estendersi fino alla comunanza nel lavoro, che può divenire un vero e proprio sistema come nel Messico, nel Perú in particolare, presso gli antichi celti e alcune tribú indiane. Inoltre la comunanza può manifestarsi all’interno dell’ordinamento tribale, in modo che l’unità sia rappresentata in primo luogo da un capo della famiglia tribale, o dalle relazioni reciproche tra i padri di famiglia. Corrispondentemente si ha allora una forma o piú dispotica o piú democratica di questa comunità. Le condizioni comuni dell’effettiva appropriazione attraverso il lavoro, sistemi d’irrigazione, molto importanti per i popoli asiatici, mezzi di comunicazione, ecc., appaiono allora come lavoro dell’unità superiore, del governo dispotico che si erge al disopra delle piccole comunità. Le città vere e proprie si formano qui, accanto a questi villaggi, solo laddove esiste un punto particolarmente favorevole per il commercio con l’estero; o dove il capo supremo dello Stato e i suoi satrapi scambiano il loro reddito (prodotto eccedente) con il lavoro, lo spendono come labour-funds.” (Marx, Forme economiche precapitalistiche)
Il socialismo come superamento dell’ateismo – “Ma siccome per l’uomo socialista tutta la cosiddetta storia del mondo non è altro che la generazione dell’uomo mediante il lavoro umano, null’altro che il divenire della natura per l’uomo, egli ha la prova evidente, irresistibile, della sua nascita mediante se stesso, del processo della sua origine. Dal momento che la essenzialità dell’uomo e della natura è diventata praticamente sensibile e visibile, dal momento che è diventato praticamente sensibile e visibile l’uomo per l’uomo come esistenza della natura, e la natura per l’uomo come esistenza dell’uomo, è diventato praticamente improponibile il problema di un essere estraneo, di un essere superiore alla natura e all’uomo, dato che questo problema implica l’ammissione della inessenzialità della natura e dell’uomo. L’ateismo, in quanto negazione di questa inessenzialità, non ha piú alcun senso; infatti l’ateismo è, sí, una negazione di Dio e pone attraverso questa negazione l’esistenza dell’uomo, ma il socialismo in quanto tale non ha piú bisogno di questa mediazione. Esso comincia dalla coscienza teoricamente e praticamente sensibile dell’uomo e della natura nella loro essenzialità. Esso è l’autocoscienza positiva dell’uomo, non piú mediata dalla soppressione della religione, allo stesso modo che la vita reale è la realtà positiva dell’uomo, non piú mediata dalla soppressione della proprietà privata, dal comunismo. Il comunismo è, in quanto negazione della negazione, affermazione; perciò è il momento reale, e necessario per il prossimo svolgimento storico, dell’emancipazione e della riconquista dell’uomo. Il comunismo è la struttura necessaria e il principio propulsore del prossimo futuro; ma il comunismo non è come tale la méta dello svolgimento storico, la struttura della società umana”. (Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844)
Individui e classi – “I singoli individui formano una classe solo in quanto debbono condurre una lotta comune contro un’altra classe; per il resto essi stessi si ritrovano l’uno di contro all’altro come nemici, nella concorrenza. D’altra parte la classe acquista a sua volta autonomia di contro agli individui, cosicché questi trovano predestinate le loro condizioni di vita, hanno assegnata dalla classe la loro posizione nella vita e con essa il loro sviluppo personale, e sono sussunti sotto di essa. Questo fenomeno è identico alla sussunzione dei singoli individui sotto la divisione del lavoro e può essere eliminato soltanto mediante il superamento della proprietà privata e del lavoro stesso. Abbiamo già accennato piú volte come questa sussunzione degli individui sotto la classe si sviluppi in pari tempo in una sussunzione sotto idee di ogni genere, ecc.” (Marx-Engels, L’ideologia tedesca)
L’uomo e il cittadino – “L’uomo non venne quindi liberato dalla religione, ma ottenne libertà di religione. Non venne liberato dalla proprietà, ma ebbe invece la libertà di possedere. Non venne liberato dall’egoismo del mestiere, ma ottenne la libertà di mestiere. La costituzione dello Stato politico ed il dissolvimento della società civile in individui indipendenti – il cui rapporto è il diritto, come il rapporto tra gli uomini dei ceti e delle associazioni di mestiere era il privilegio – si compie in un unico e medesimo atto. Però l’uomo che è membro della società civile, l’uomo non politico, appare necessariamente come l’uomo natura. I droits de l’homme si presentano come droits naturels, perché l’attività autocosciente si concentra nell’atto politico. L’uomo egoistico è il risultato passivo in cui ci si è imbattuti quando la società si è dissolta: è oggetto di certezza immediata, e quindi oggetto naturale. La rivoluzione politica dissolve la vita sociale nelle sue parti costitutive stesse. Essa considera la società civile, il mondo dei bisogni, del lavoro, degli interessi privati, del diritto privato come il fondamento della sua esistenza, come un presupposto che non ha bisogno di ulteriore giustificazione, e quindi come sua base naturale. Infine l’uomo che è membro della società civile viene considerato l’uomo autentico, l’homme che si distingue dal citoyen perché è l’uomo nella sua piú accessibile esistenza individuale sensibile, mentre l’uomo politico è soltanto l’uomo astratto, artificiale, l’uomo come persona allegorica, morale. Si vuol vedere l’uomo reale solo nella figura dell’individuo egoistico, e l’uomo vero solo nella figura dell’astratto citoyen. […] Ogni emancipazione implica il ricondurre il mondo umano, i rapporti umani all’uomo stesso. L’emancipazione politica è la riduzione dell’uomo da una parte a membro della società civile, ad individuo egoistico ed indipendente, e dall’altra a cittadino, a persona morale. Solo quando il reale uomo individuale riassorbe in sé l’astratto cittadino, e pur restando uomo individuale, è diventato elemento del genere umano nella sua vita empirica l’uomo ha riconosciuto le sue forces propres come forze sociali e le ha organizzate in conseguenza, e non separa quindi da se stesso la forza sociale che gli si presenta come forza politica, solo allora si può considerare compiuta l’emancipazione umana”. (Marx, La questione ebraica)
La borghesia – La moderna società borghese, nata dalla rovina della società feudale, non ha fatto sparire gli antagonismi di classe. Essa ha solo creato, al posto delle vecchie, nuove classi, nuove condizioni di oppressione, nuove forme di lotta. La nostra epoca tuttavia, l’epoca della borghesia, si distingue in quanto ha reso piú semplici tali antagonismi. Tutta la società si va dividendo sempre piú in due grandi campi nemici, in due grandi classi direttamente contrapposte tra loro: borghesia e proletariato. Dai servi della gleba del medioevo nacquero i piccoli borghesi delle prime città; da essi si svilupparono i primi elementi della borghesia. La scoperta dell’America, la circumnavigazione dell’Africa offrirono un nuovo terreno alla nascente borghesia. Il mercato delle Indie Orientali e della Cina, la colonizzazione dell’America, gli scambi con le colonie, l’incremento dei mezzi di scambio e delle merci in genere, dettero al commercio, alla navigazione, all’industria un impulso senza precedenti, e di conseguenza permisero un rapido sviluppo dell’elemento rivoluzionario all’interno della morente società feudale. Il modo di conduzione dell’industria, fino allora feudale o corporativo, divenne insufficiente per il fabbisogno, che aumentava con l’estendersi dei nuovi mercati. Al suo posto subentrò la manifattura. I maestri artigiani vennero rimpiazzati dal ceto medio industriale; la divisione del lavoro tra le varie corporazioni sparí dinanzi alla divisione del lavoro nella singola officina stessa. I mercati però s’andavano sempre piú estendendo, come costantemente cresceva il fabbisogno. Anche la manifattura divenne insufficiente. Allora il vapore e le macchine rivoluzionarono la produzione industriale. Al posto della manifattura nacque la grande industria moderna, al posto del ceto medio industriale comparvero gli industriali milionari, i capi di interi eserciti industriali, i borghesi moderni. La grande industria ha generato quel mercato mondiale che era stato preparato dalla scoperta dell’America. Esso ha dato un immenso sviluppo al commercio, alla navigazione, alle comunicazioni per terra. Questo sviluppo dal canto suo ha influito sulla espansione industriale, e, nella stessa misura in cui s’accrescevano industria, commercio, navigazione, ferrovia, s’è sviluppata la borghesia, che ha visto aumentare i propri capitali e ha cacciato in secondo piano tutte le classi d’origine feudale. Vediamo perciò come la borghesia moderna sia essa stessa il risultato di un lungo processo di sviluppo, di una serie di rivolgimenti nei modi di produzione e di traffico. Ciascuno di questi gradi di sviluppo della borghesia è accompagnato da un corrispondente sviluppo politico. Ceto oppresso sotto il dominio dei signori feudali, associazione armata e autonoma nel Comune, qui repubblica municipale indipendente, lí terzo stato tributario della monarchia, poi all’epoca della manifattura, nella monarchia controllata degli stati o in quella assoluta contrappeso alla nobiltà ed elemento basilare delle grandi monarchie in genere, la borghesia infine, una volta sorti la grande industria e il mercato mondiale, ha raggiunto il dominio politico esclusivo nello Stato rappresentativo moderno. Il potere politico moderno è solo un comitato che amministra gli affari comuni dell’intera classe borghese. Nella storia la borghesia ha ricoperto un ruolo estremamente rivoluzionario. Dove è giunta al potere, la borghesia ha dissolto ogni condizione feudale, patriarcale, idillica. Ha distrutto spietatamente ogni piú disparato legame che univa gli uomini al loro superiore naturale, non lasciando tra uomo e uomo altro legame che il nudo interesse, lo spietato “pagamento in contanti”. Ha fatto annegare nella gelida acqua del calcolo egoistico i sacri fremiti dell’esaltazione religiosa, dell’entusiasmo cavalleresco, del sentimentalismo piccolo-borghese. Ha risolto nel valore di scambio la dignità della persona e ha rimpiazzato le innumerevoli libertà riconosciute e acquisite con un’unica libertà, quella di un commercio senza freni. In conclusione, al posto dello sfruttamento velato da illusioni religiose e politiche ha messo uno sfruttamento aperto, privo di scrupoli, diretto, arido. La borghesia ha tolto l’aureola a tutte le attività fino a quel momento rispettate e piamente considerate. Ha trasformato il medico, il giurista, il prete, il poeta, l’uomo di scienza in salariati da lei dipendenti. La borghesia ha stracciato nel rapporto familiare il velo di commovente sentimentalismo riducendolo a un mero rapporto di denaro. La borghesia ha fatto vedere come la brutale manifestazione di forza, tipica del medioevo e ammirata dalla reazione, s’accompagnasse intrinsecamente alla piú oziosa infingardaggine. Per prima essa ha rivelato il potere dell’attività umana. Ha creato opere ben piú mirabili che piramidi egizie, acquedotti romani e cattedrali gotiche, ha condotto ben altre spedizioni che le migrazioni dei popoli e le crociate”. (Marx-Engels, Manifesto del partito comunista)
La critica filosofica pecca di astrattezza – “Poiché questi giovani hegeliani considerano le rappresentazioni, i pensieri, i concetti, e in genere i prodotti della coscienza da loro fatta autonoma, come le vere catene degli uomini, cosí come i Vecchi hegeliani ne facevano i veri legami della società umana, s’intende facilmente che i Giovani hegeliani devono combattere soltanto contro queste illusioni della coscienza. Poiché secondo la loro fantasia e i loro impedimenti sono prodotti della loro coscienza, i Giovani hegeliani coerentemente chiedono agli uomini, come postulato morale, di sostituire alla loro coscienza attuale la coscienza umana, critica o egoistica, e di sbarazzarsi cosí dei loro impedimenti. Questa richiesta, di modificare la coscienza, conduce all’altra richiesta, d’interpretare diversamente ciò che esiste, ossia di riconoscerlo mediante una diversa interpretazione. Nonostante le loro frasi che, secondo loro “scuotono il mondo”, gli ideologici giovani-hegeliani sono i piú grandi conservatori. I piú giovani tra loro hanno trovato l’espressione giusta per la loro attività, affermando di combattere soltanto contro delle “frasi”. Dimenticano soltanto che a queste frasi essi stessi non oppongono altro che frasi, e che combattono il mondo realmente esistente quando combattono soltanto le frasi di questo mondo. I soli risultati ai quali questa critica filosofica poteva portare erano alcuni e per giunta unilaterali chiarimenti, nel campo della storia della religione, intorno al cristianesimo; tutte le altre loro asserzioni non sono che altri modi di abbellire la pretesa di aver compiuto, con quei chiarimenti insignificanti, scoperte d’importanza storica universale. A nessuno di questi filosofi è venuto in mente di ricercare il nesso esistente tra la filosofia tedesca e la realtà tedesca, il nesso tra la loro critica e il loro proprio ambiente materiale”. (Marx-Engels, L’ideologia tedesca)
La critica filosofica si è appiattita sulla religione – “La critica tedesca non ha mai abbandonato, fino ai suoi ultimi sforzi, il terreno della filosofia. Ben lungi dall’indagare sui suoi presupposti filosofici generali, tutti quanti i suoi problemi sono nati anzi sul terreno di un sistema filosofico determinato, l’hegeliano. Non solo nelle risposte, ma già negli stessi problemi c’era una mistificazione. Questa dipendenza da Hegel è la ragione per cui nessuno di questi moderni critici ha neppure tentato una critica complessiva del sistema hegeliano, tanto è la convinzione, in ciascuno di essi, di essersi spinto oltre Hegel. La loro polemica contro Hegel e fra di loro si limita a questo, che ciascuno estrae un aspetto del sistema hegeliano e lo rivolge tanto contro l’intero sistema quanto contro gli aspetti che ne estraggono gli altri. Dapprima si estrassero categorie hegeliane pure, genuine, come la sostanza e l’autocoscienza, poi si contaminarono queste categorie con nomi piú profani, come Specie, l’Unico, l’Uomo, ecc. Tutta la critica filosofica tedesca da Strauss fino a Stirner si limita alla critica delle rappresentazioni religiose. Si cominciò dalla religione reale e dalla teologia vera e propria. Che cosa fosse la coscienza religiosa, la rappresentazione religiosa, fu variamente definito in seguito. Il pregresso consisteva nel sussumere sotto la sfera delle rappresentazioni religiose o teologiche anche le rappresentazioni metafisiche, politiche, giuridiche, morali, ecc. che si presumevano dominanti; nel proclamare cosí che la coscienza giuridica, politica, morale è coscienza religiosa o teologica, e che l’uomo politico, giuridico, morale, cioè “l’uomo”, in ultima istanza, è religioso. Fu presupposto il predominio della religione. A poco a poco ogni rapporto dominante fu dichiarato rapporto di religione e trasformato in culto, culto del diritto, culto dello Stato e cosí via. Dappertutto si aveva a che fare con dogmi e con la fede in dogmi. Il mondo fu canonizzato in misura sempre maggiore, finché da ultimo il venerabile san Max poté canonizzarlo en bloc e liquidarlo una volta per tutte. I Vecchi hegeliani avevano compreso qualsiasi cosa, non appena l’avevano ricondotta ad una categoria logica hegeliana. I Giovani hegeliani criticarono qualsiasi cosa scoprendo in essa idee religiose o definendola teologica. I Giovani hegeliani concordano con i Vecchi hegeliani in quanto credono al predominio della religione, dei concetti dell’universale nel mondo esistente; solo che gli uni combattono quel predominio come usurpazione, mentre gli altri lo esaltano come legittimo”. (Marx-Engels, L’ideologia tedesca)
La forza-lavoro come merce – Per forza-lavoro o capacità di lavoro intendiamo l’insieme delle attitudini fisiche e intellettuali che esistono nella corporeità, ossia nella personalità vivente d’un uomo, e che egli mette in movimento ogni volta che produce valori d’uso di qualsiasi genere. Tuttavia, affinché il possessore di denaro incontri sul mercato la forza-lavoro come merce debbono essere soddisfatte diverse condizioni. In sé e per sé, lo scambio delle merci non include altri rapporti di dipendenza fuori di quelli derivanti dalla sua propria natura. Se si parte da questo presupposto, la forza-lavoro come merce può apparire sul mercato soltanto in quanto e perché viene offerta o venduta come merce dal proprio possessore, dalla persona della quale essa è la forza lavoro. Affinché il possessore della forza-lavoro la venda come merce, egli deve poterne disporre, quindi essere libero proprietario della propria capacità di lavoro, della propria persona. Egli si incontra sul mercato con il possessore di denaro e i due entrano in rapporto reciproco come possessori di merci, di pari diritti, distinti solo per essere l’uno compratore, l’altro venditore, persone dunque giuridicamente eguali. La continuazione di questo rapporto esige che il proprietario della forza-lavoro la venda sempre e soltanto per un tempo determinato; poiché se la vende in blocco, una volta per tutte, vende se stesso, si trasforma da libero in schiavo, da possessore di merce in merce. Il proprietario di forza-lavoro, quale persona, deve riferirsi costantemente alla propria forza-lavoro come a sua proprietà, quindi come a sua propria merce; e può farlo solo in quanto la mette a disposizione del compratore ossia gliela lascia per il consumo, sempre e soltanto, transitoriamente, per un periodo determinato di tempo, e dunque, mediante l’alienazione di essa, non rinuncia alla sua proprietà su di essa. La seconda condizione essenziale, affinché il possessore del denaro trovi la forza-lavoro sul mercato come merce, è che il possessore di questa non abbia la possibilità di vendere merci nelle quali si sia oggettivato il suo lavoro, ma anzi, sia costretto a mettere in vendita, come merce, la sua stessa forza-lavoro, che esiste soltanto nella sua corporeità vivente. Affinché qualcuno venda merci distinte dalla propria forza-lavoro, deve, com’è ovvio, possedere mezzi di produzione, p. es. materie prime, strumenti di lavoro, ecc. Non può fare stivali senza cuoio. Inoltre, ha bisogno di mezzi di sussistenza. Nessuno, neppure un musicista avvenirista, può campare dei prodotti avvenire, quindi neppure di valori d’uso la cui produzione è ancora incompleta; l’uomo è costretto ancora a consumare, giorno per giorno, prima di produrre e mentre produce, come il primo giorno della sua comparsa sulla scena della terra. Se i prodotti vengono prodotti come merci, debbono essere venduti dopo essere stati prodotti e possono soddisfare i bisogni del produttore soltanto dopo la vendita. Al tempo della produzione s’aggiunge il tempo necessario per la vendita. Dunque, per trasformare il denaro in capitale il possessore di denaro deve trovare sul mercato delle merci il lavoratore libero; libero nel duplice senso che disponga della propria forza lavorativa come propria merce, nella sua qualità di libera persona, e che, d’altra parte, non abbia da vendere altre merci, che sia privo ed esente, libero di tutte le cose necessarie per la realizzazione della sua forza-lavoro. Per il possessore di denaro, che trova il mercato del lavoro come sezione particolare del mercato delle merci, non ha alcun interesse il problema del perché quel libero lavoratore gli si presenti nella sfera della circolazione. E per il momento non ha interesse neppure per noi. Noi teniamo fermo, sul piano teorico, al dato di fatto, come fa il possessore di denaro sul piano pratico. Una cosa è evidente, però. La natura non produce da una parte possessori di denaro o di merci e dall’altra puri e semplici possessori della propria forza lavorativa. Questo rapporto non è un rapporto risultante dalla storia naturale e neppure un rapporto sociale che sia comune a tutti i periodi della storia. Esso stesso è evidentemente il risultato d’uno svolgimento storico precedente, il prodotto di molti rivolgimenti economici, del tramonto di tutta una serie di formazioni piú antiche della produzione sociale. […] Ormai dobbiamo considerare piú da vicino quella merce peculiare che è la forza-lavoro. Essa ha un valore, come tutte le altre merci. Come viene determinato? Il valore della forza-lavoro, come quello di ogni altra merce, è determinato dal tempo di lavoro necessario alla produzione e, quindi anche alla riproduzione, di questo articolo specifico. In quanto valore, anche la forza-lavoro rappresenta soltanto una quantità determinata di lavoro sociale medio oggettivato in essa. La forza-lavoro esiste soltanto come attitudine naturale dell’individuo vivente. Quindi la produzione di essa presuppone l’esistenza dell’individuo. Data l’esistenza dell’individuo, la produzione della forza-lavoro consiste nella riproduzione, ossia nella conservazione di esso. Per la propria conservazione l’individuo vivente ha bisogno di una certa somma di mezzi di sussistenza. Dunque il tempo di lavoro necessario per la produzione della forza-lavoro si risolve nel tempo di lavoro necessario per la produzione di quei mezzi di sussistenza; ossia. il valore della forza-lavoro è il valore dei mezzi di sussistenza necessari per la conservazione del possessore della forza-lavoro. Però, la forza-lavoro si realizza soltanto per mezzo della sua estrinsecazione, si attua soltanto nel lavoro. Ma nell’attuazione della forza-lavoro, nel lavoro, si ha dispendio di una certa quantità di muscoli, nervi, cervello, ecc. umani, la quale deve a sua volta esser reintegrata. Questo aumento d’uscita esige un aumento d’entrata. Se il proprietario di forza-lavoro ha lavorato oggi, deve esser in grado di ripetere domani lo stesso processo, nelle stesse condizioni di forza e salute. La somma dei mezzi di sussistenza deve dunque essere sufficiente a conservare l’individuo che lavora nella sua normale vita, come individuo che lavora. I bisogni naturali, come nutrimento, vestiario, riscaldamento, alloggio ecc., sono differenti di volta in volta a seconda delle peculiarità climatiche e delle altre peculiarità naturali dei vari paesi. D’altra parte, il volume dei cosiddetti bisogni necessari, come pure il modo di soddisfarli, è anch’esso un prodotto della storia, dipende quindi in gran parte dal grado d’incivilimento di un paese e, fra l’altro, anche ed essenzialmente dalle condizioni, quindi anche dalle abitudini e dalle esigenze fra le quali e con le quali si è formata la classe dei liberi lavoratori. Dunque la determinazione del valore della forza-lavoro, al contrario che per le altre merci, contiene un elemento storico e morale. Ma per un determinato paese, in un determinato periodo, il volume medio dei mezzi di sussistenza necessari, è dato. Il proprietario della forza-lavoro è mortale. Dunque, se la sua presenza sul mercato dev’essere continuativa, come presuppone la trasformazione continuativa del denaro in capitale, il venditore della forza-lavoro si deve perpetuare, “come si perpetua ogni individuo vivente, con la procreazione”. Le forze-lavoro sottratte al mercato dalla morte e dal logoramento debbono esser continuamente reintegrate per lo meno con lo stesso numero di forze-lavoro nuove. Dunque, la somma dei mezzi di sussistenza necessari alla produzione della forza-lavoro include i mezzi di sussistenza delle forze di ricambio, cioè dei figli dei lavoratori, in modo che questa razza di peculiari possessori di merci si perpetui sul mercato”. (Marx, Il Capitale)
Struttura e sovrastruttura – “Il risultato generale al quale arrivai e che, una volta acquisito, mi serví da filo conduttore nei miei studi, può essere brevemente formulato cosí: nella produzione sociale della loro esistenza, gli uomini entrano in rapporti determinati, necessari, indipendenti dalla loro volontà, in rapporti di produzione che corrispondono a un determinato grado di sviluppo delle loro forze produttive materiali. L’insieme di questi rapporti di produzione costituisce la struttura economica della società, ossia la base reale sulla quale si eleva una sovrastruttura giuridica e politica e alla quale corrispondono forme determinate della coscienza sociale. Il modo di produzione della vita materiale condiziona, in generale, il processo sociale, politico e spirituale della vita. Non è la coscienza degli uomini che determina il loro essere, ma è, al contrario, il loro essere sociale che determina la loro coscienza. A un dato punto del loro sviluppo, le forze produttive materiali della società entrano in contraddizione con i rapporti di produzione esistenti, cioè con i rapporti di proprietà (che ne sono soltanto l’espressione giuridica) dentro i quali tali forze per l’innanzi s’erano mosse. Questi rapporti, da forme di sviluppo delle forze produttive, si convertono in loro catene. E allora subentra un’epoca di rivoluzione sociale. Con il cambiamento della base economica si sconvolge piú o meno rapidamente tutta la gigantesca sovrastruttura. Quando si studiano simili sconvolgimenti, è indispensabile distinguere sempre fra lo sconvolgimento materiale delle condizioni economiche della produzione, che può essere constatato con la precisione delle scienze naturali, e le forme giuridiche, politiche, religiose, artistiche o filosofiche, ossia le forme ideologiche che permettono agli uomini di concepire questo conflitto e di combatterlo. Come non si può giudicare una simile epoca di sconvolgimento dalla coscienza che essa ha di se stessa; occorre invece spiegare questa coscienza con le contraddizioni della vita materiale, con il conflitto esistente fra le forze produttive della società e i rapporti di produzione. Una formazione sociale non perisce finché non si siano sviluppate tutte le forze produttive a cui può dare corso; nuovi e superiori rapporti di produzione non subentrano mai, prima che siano maturate in seno alla vecchia società le condizioni materiali della loro esistenza. Ecco perché l’umanità non si propone se non quei problemi che può risolvere, perché, a considerare le cose dappresso, si trova sempre che il problema sorge solo quando le condizioni materiali della sua soluzione esistono già o almeno sono in formazione. A grandi linee, i modi di produzione asiatico, antico, feudale e borghese moderno possono essere designati come epoche che marcano il progresso della formazione economica della società. I rapporti di produzione borghese sono l’ultima forma antagonistica del processo di produzione sociale; antagonistica non nel senso di un antagonismo individuale, ma di un antagonismo che sorga dalle condizioni di vita sociali degli individui. Ma le forze produttive che si sviluppano nel seno della società borghese creano in pari tempo le condizioni materiali per la soluzione di questo antagonismo. Con questa formazione sociale si chiude dunque la preistoria della società umana.” (Marx, Per la critica dell’economia politica)
La proprietà privata è il frutto del lavoro alienato – “Se il prodotto del lavoro non appartiene all’operaio, e un potere estraneo gli sta di fronte, ciò è possibile soltanto per il fatto che esso appartiene ad un altro estraneo all’operaio. Se la sua attività è per lui un tormento, deve essere per un altro un godimento, deve essere la gioia della vita altrui. Non già gli dèi, non la natura, ma soltanto l’uomo stesso può essere questo potere estraneo al di sopra dell’uomo. Si ripensi ancora alla tesi sopra esposta, che il rapporto dell’uomo con se stesso è per lui un rapporto oggettivo e reale soltanto attraverso il rapporto che egli ha con gli altri uomini. Se quindi egli sta in rapporto al prodotto del suo lavoro, al suo lavoro oggettivato come in rapporto ad un oggetto estraneo, ostile, potente, indipendente da lui, sta in rapporto ad esso in modo che padrone di questo oggetto è un altro uomo, a lui estraneo, ostile, potente e indipendente da lui. Se si riferisce alla sua propria attività come a una attività non libera, si riferisce a essa come un’attività che è al servizio e sotto il dominio, la coercizione e il giogo di una altro uomo. […] Dunque, col lavoro estraniato, alienato, l’operaio pone in essere il rapporto di un uomo che è estraneo e al di fuori del lavoro, con questo stesso lavoro. Il rapporto dell’operaio col lavoro pone in essere il rapporto del capitalista – o come altrimenti si voglia chiamare il padrone del lavoro – col lavoro. La proprietà privata è quindi il prodotto, il risultato, la conseguenza necessaria del lavoro alienato, del rapporto di estraneità che si stabilisce tra l’operaio, da un lato, e la natura e lui stesso dall’altro. La proprietà privata si ricava quindi mediante l’analisi del concetto del lavoro alienato, cioè dell’uomo alienato, del lavoro estraniato, della vita estraniata, dell’uomo estraniato.” (Marx, , Manoscritti economico-filosofici del 1844)
La vera emancipazione – “È a questo punto che ci si accorge che il problema ebraico è stato impostato in modo unilaterale. Le domande “chi deve emancipare? Chi deve essere emancipato?” non avevano dato fondo al problema. C’era una terza questione che la critica doveva porsi. Essa doveva cioè domandarsi: Di quale tipo di emancipazione si tratta?”. Quali condizioni sono implicite nell’essenza dell’emancipazione che vien chiesta? La critica dell’emancipazione politica stessa sarebbe la critica definitiva della questione ebraica, ed equivarrebbe a risolverla senza residui nel “problema generale del nostro tempo”. Dato che Bauer non discute il problema a questo livello, finisce col cadere in contraddizioni. Egli pone condizioni che non sono implicite nell’essenza stessa dell’emancipazione politica. Mette in campo problemi che sono estranei al suo tema, e tratta temi che lasciano irrisolto il suo problema. Degli avversari dell’emancipazione degli Ebrei il Bauer dice: “Il loro solo errore fu di presupporre che lo Stato cristiano è l’unico vero Stato, e di non sottoporlo alla stessa critica che avevano esercitato contro l’ebraismo” (p. 3); e noi scorgiamo l’errore nel Bauer nel fatto che egli critica solo lo “Stato cristiano” e non “lo Stato” senza aggettivi, nel fatto che egli non analizza il rapporto tra emancipazione politica ed emancipazione umana, e pone quindi condizioni che si possono spiegare soltanto con una acritica confusione della emancipazione politica con l’emancipazione umana in generale. Dato che Bauer domanda agli Ebrei: “Dal vostro punto di vista, avete il diritto di aspirare all’emancipazione politica?” noi domandiamo, rovesciando il problema: “Chi imposta il problema in termini di emancipazione politica ha il diritto di esigere che l’Ebreo superi l’ebraismo e che l’uomo in genere superi la religione?”.(Marx, La questione ebraica)
La vera liberazione umana – “Naturalmente non ci daremo la pena d’illuminare i nostri sapienti filosofi sul fatto che la “liberazione” dell’“uomo” non è ancora avanzata di un passo quando essi abbiano risolto la filosofia, la teologia, la sostanza e tutta l’immondizia nell’“autocoscienza”, quando abbiano liberato l’“uomo” dal dominio di queste frasi, dalle quali non è mai stato asservito; che non è possibile attuare una liberazione reale se non nel mondo reale e con mezzi reali, che la schiavitú non si può abolire senza la macchina a vapore e la Mule-Jenny, né la servitú della gleba senza un’agricoltura migliorata, che in generale non si possono liberare gli uomini finché essi non sono in grado di procurarsi cibo e bevanda, abitazione e vestiario in qualità e quantità completa. La “liberazione” è un atto storico, non un atto ideale, ed è attuata da condizioni storiche, dallo stato dell’industria, del commercio, dell’agricoltura, delle relazioni. […] e in realtà per il materialista pratico, cioè per il comunista, si tratta di rivoluzionare il mondo esistente, di metter mano allo stato di cose incontrato e di trasformarlo.” (Marx-Engels, L’ideologia tedesca)
Lavoro generale astratto e socialità – “Caratteristico del lavoro che crea valore di scambio è infine che il rapporto sociale delle persone si rappresenta per cosí dire rovesciato, cioè come rapporto sociale delle cose. Soltanto in quanto un valore d’uso si riferisce all’altro quale valore di scambio, il lavoro di presone diverse è riferito l’uno all’altro come a lavoro uguale e generale. Quindi, se è esatto dire che il valore di scambio è un rapporto fra persone, bisogna tuttavia aggiungere: un rapporto celato sotto il velo delle cose. Allo stesso modo che una libbra di ferro e una libbra d’oro rappresentano lo stesso quantitativo di peso malgrado le loro qualità fisiche e chimiche diverse, due valori d’uso di merci, in cui sia contenuto lo stesso tempo di lavoro, rappresentano lo stesso valore di scambio. Il valore di scambio appare in tal modo come determinazione naturale sociale dei valori d’uso, come determinazione che spetta a questi in quanto cose, e a causa della quale nel processo di scambio essi si sostituiscono a vicenda secondo determinati rapporti quantitativi, costituiscono equivalenti, allo stesso modo che le sostanze chimiche semplici si combinano secondo determinati rapporti quantitativi, costituendo equivalenti chimici. È soltanto l’abitudine della vita quotidiana che fa apparire come cosa banale, come cosa ovvia, che un rapporto di produzione sociale assuma la forma di un oggetto, cosicché il rapporto fra le persone nel loro lavoro si presenti piuttosto come un rapporto reciproco fra cose e fra cose e persone”. (Marx, Per la critica dell’economia politica)
Meriti e demeriti di Lutero – “Infatti il passato rivoluzionario della Germania è teorico: è la Riforma. Allora la rivoluzione ebbe inizio nella testa di un monaco, oggi in quella di un filosofo. Lutero, invero, vinse la servitú per devozione sostituendovi la servitú per convinzione. Egli ha spezzato la fede nell’autorità, restaurando l’autorità della fede. Egli ha trasformato i preti in laici, trasformando i laici in preti. Egli ha liberato l’uomo dalla religiosità esteriore, facendo della religiosità l’interiorità dell’uomo. Egli ha svincolato il corpo dalle catene, incatenandone il cuore. Ma se il protestantesimo non costituí la vera soluzione, diede tuttavia origine a una giusta formulazione del problema. Non si trattava piú della lotta del laico contro il prete, ossia contro qualcosa di esterno, bensí contro il suo proprio prete interiore, contro la sua natura pretesca. E se la metamorfosi protestante dei laici tedeschi in preti ha emancipato i papi laici, ossia i príncipi con il loro clero, i privilegiati e i filistei, la metamorfosi filosofica dei preti tedeschi in uomini emanciperà il popolo. Ma come l’emancipazione non si limitò ai príncipi, cosí la secolarizzazione dei beni non si limiterà alla spoliazione delle chiese, che fu praticata soprattutto dall’ipocrita Prussia. Allora, la guerra dei contadini, l’evento piú radicale della storia tedesca, fu annientata dalla teologia. Oggi che la stessa teologia è tramontata, il fatto piú illiberale della storia tedesca, il nostro status quo, s’infrangerà contro la filosofia. Alla vigilia della Riforma, la Germania ufficiale era il piú incondizionato servo di Roma. Alla vigilia della sua rivoluzione, essa è il servo incondizionato di qualcosa di ben inferiore a Roma: della Prussia e dell’Austria, dei nobilastri di campagna e dei filistei”. (Marx, Critica della filosofia del diritto di Hegel. Introduzione)
Perchè scoppiano le rivoluzioni – “Questa contraddizione fra le forze produttive e la forma di relazioni, che come abbiamo visto si è già manifestata piú volte nella storia fino ad oggi senza però compromettere la base, dovette esplodere ogni volta in una rivoluzione, assumendo in pari tempo diverse forme accessorie, come totalità di collisioni, come collisioni di diverse classi, contraddizione della coscienza, lotta ideologica, ecc., lotta politica, ecc. Da un punto di vista limitato si può isolare una di queste forme accessorie e considerarla come la base di quelle rivoluzioni, ciò che è tanto piú facile in quanto gli individui da cui procedevano le rivoluzioni si facevano essi stessi delle illusioni sulla loro propria attività, a seconda del loro grado di cultura e dello stadio dello sviluppo storico. Secondo la nostra concezione, dunque, tutte le collisioni della storia hanno la loro origine nella contraddizione tra le forze produttive e la forma di relazioni. D’altronde non è necessario che per provocare delle collisioni in un paese questa contraddizione sia spinta all’estremo in questo paese stesso. La concorrenza con paesi industrialmente piú progrediti, provocata dall’allargamento delle relazioni internazionali, è sufficiente per generare una contraddizione analoga anche nei paesi con industria meno sviluppata (per esempio il proletariato latente in Germania, fatto apparire dalla concorrenza dell’industria inglese)”. (Marx-Engels, L’ideologia tedesca)
Diversità rispetto a Hegel – “Per il suo fondamento, il mio metodo dialettico non solo è differente da quello hegeliano, ma ne è anche direttamente l’opposto. Per Hegel il processo del pensiero, che egli, sotto il nome di Idea, trasforma addirittura in soggetto indipendente, è il demiurgo del reale, mentre il reale non è che il fenomeno esterno del pensiero; per me, viceversa, l’elemento ideale non è altro che l’elemento materiale trasferito e tradotto nel cervello degli uomini. […] Ho criticato il lato mistificatore della dialettica hegeliana quasi trent’anni fa, quando era ancora la moda del giorno. Ma proprio mentre elaboravo il primo volume del Capitale i molesti, presuntuosi e mediocri epigoni che dominano nella Germania cólta si compiacevano di trattare Hegel come ai tempi di Lessing il bravo Moses Mendelssohn trattava Spinoza: come un “cane morto”. Perciò mi sono professato apertamente scolaro di quel grande pensatore e ho perfino civettato qua e là, nel capitolo sulla teoria del valore, con il modo di esprimersi che gli è peculiare. La mistificazione alla quale soggiace la dialettica nelle mani di Hegel non toglie in nessun modo che egli sia stato il primo ad esporre ampiamente e consapevolmente le forme generali del movimento della dialettica stessa. In lui essa è capovolta. Bisogna rovesciarla per scoprire il nocciolo razionale entro il guscio mistico”. (Marx, Poscritto alla seconda edizione [1873] di Il capitale)
Breve riassunto delle opere di Marx
1841 Differenza tra la filosofia della natura di Democrito e quella di Epicuro : é la tesi con cui Marx consegue il dottorato a Jena. Marx interpreta la situazione della filosofia dopo Hegel in analogia con la situazione delle filosofie ellenistiche dopo Platone e Aristotele. E’ possibile un nuovo avvio filosofico dopo il compimento della filosofia nelle grandi sintesi sistematiche? Secondo Marx proprio in questi momenti diventa possibile la ripresa di contatto della filosofia con la realtà, la sua realizzazione nel mondo esterno. Fedele al principio hegeliano dell’unità di ragione e realtà, egli assegna a questo compito una valenza essenzialmente teorica: in sintonia con l’atteggiamento dei giovani hegeliani, esso si configura in primis come critica razionale della situazione esistente. Mostrando l’inadeguatezza della realtà rispetto a ciò che é razionale, la teoria diventa prassi. Dopo Hegel, la filosofia riprende la sua funzione illuministica di critica della realtà; così come, dopo Aristotele, Epicuro, ‘ il più grande illuminista greco ‘ , aveva portato fino in fondo la critica della religione, combattuto il fatalismo e rivendicato la libertà dell’autocoscienza umana.
1843 Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico : sebbene incompiuto, lo scritto presenta uno spunto geniale: la critica della teoria politica hegeliana è al tempo stesso la critica della rivoluzione francese e del mondo da essa scaturito, la società borghese che ha preso o sta prendendo il posto dell’antico regime. La religione é prodotta dall’uomo ed è l’oppio del popolo, lo strumento per tenere a bada le masse.
1844 Sulla questione ebraica : in esso Marx prende posizione sulla tesi di Bruno Bauer secondo cui l’emancipazione degli ebrei si sarebbe realizzata solo quando lo Stato avesse cessato di essere cristiano, riconoscendo l’uguaglianza di tutti i cittadini. Secondo Marx l’ emancipazione non é ancora quella umana: l’uguaglianza di fronte alla legge é puramente astratta e formale, non sostanziale, in quanto lascia sussistere, anzi favorisce, la disuguaglianza reale, ovvero quella economica e sociale. Nei cosiddetti ‘diritti dell’uomo’, sanciti dalle rivoluzioni americana e francese, si nasconde una mistificazione, quella di assolutizzare come essenza dell’uomo l’individuo privato della società borghese, il ‘bourgeois’ detentore di proprietà e perciò caratterizzato da interessi particolari e quindi ostile agli altri uomini, che considera limiti alla propria libertà. Nella società attuale l’uomo conduce, a parere di Marx, una doppia vita: la vita nella comunità politica e la vita nella società civile, nella quale agisce come individuo privato.
1844 Manoscritti economico-filosofici : in essi Marx denuncia l’alienazione del lavoro industrializzato, il rapporto dell’operaio con il prodotto del suo lavoro: tale prodotto é per lui un ente estraneo, che non gli appartiene, ma é esclusivo possesso del capitalista, per il quale egli lavora. In secondo luogo, nell’attività produttiva l’operaio si estrania da sè, ovvero non considera il proprio lavoro come parte della sua vita reale. Con l’alienazione l’uomo é privato anche della sua essenza sociale. I Manoscritti sono costituiti da tre parti, riguardanti essenzialmente tre temi: a ) la critica dell’economia classica; b ) la descrizione del comunismo; c ) la critica della dialettica hegeliana.
1845 La sacra famiglia : pubblicato insieme ad Engels, questo scritto prende ironicamente di mira i ‘giovani hegeliani’, specialmente i fratelli Bauer. Essi credono di svolgere una funzione rivoluzionaria limitandosi a proclamare una filosofia esaltata dell’autocoscienza, la quale nega sovranamente e con ostentato disprezzo non solo l’ordinamento esistente, ma anche il mondo comune degli uomini comuni, l’oggettività in quanto tale.
1845 Tesi su Feuerbach : la punta più avanzata del movimento filosofico contemporaneo era tuttavia rappresentata da Feuerbach: con lui soprattutto bisognava fare i conti. Feuerbach aveva smascherato il mondo rovesciato della religione, ravvisandone la radice antropologica, ma non aveva colto in modo adeguato il carattere storico della natura umana e le condizioni storiche che rendono possibile il costituirsi della religione stessa. Il problema per Marx ed Engels consiste nell’abolire, più che la religione, le condizioni storiche che la rendono possibile. Questo programma di modificazione storica della realtà trova espressione nella celebre tesi secondo cui ‘ I filosofi hanno solo interpretato il mondo in modi diversi; si tratta però di mutarlo. ‘ Nella filosofia di Feuerbach é ancora forte un’eredità di stampo illuministico, specialmente nella sua concezione della natura umana come essenza priva di storia e nell’interpretazione materialistica di tale essenza. Il materialismo di Feuerbach, vicino al materialismo settecentesco di La Mettrie, concepisce l’uomo come entità naturale dotata di corporeità e sensibilità e quindi fondamentalmente passiva, non come prassi attiva trasformatrice della natura; di conseguenza esso considera la realtà sensibile come oggetto già costituito, non prodotto dall’attività sensibile umana.
1846 L’ideologia tedesca : rivoluzionari dell’immaginazione, i giovani hegeliani vengono paragonati, già nella prefazione, a quel valentuomo che si immaginò che gli uomini annegassero nell’acqua perchè ossessionati dal pensiero della gravità, per cui, se si fossero tolti di mente quest’idea, si sarebbero liberati dal pericolo di annegare. I ‘giovani ribelli’, che credono di produrre il nuovo elaborando una teoria rivoluzionaria dopo l’altra, sono chiamati a ‘ricercare il nesso esistente tra la filosofia tedesca e la realtà tedesca, il nesso tra la loro critica e il loro ambiente materiale’. Affiora qui il materialismo storico: bisogna attingere l’oggettività materiale dei rapporti e delle contraddizioni, altrimenti frasi vuote diventano le proclamazioni rivoluzionarie.
1847 La miseria della filosofia : é l’opera con cui Marx risponde a Proudhon e alla sua Filosofia della miseria . Un’impietosa premessa bolla l’autore francese in quanto dilettante sia di filosofia sia di economia. Tramite queste polemiche sta maturando un’importante presa di coscienza: bisogna collegare lo studio della filosofia a quello della storia e dell’economia politica.
1848 Manifesto del partito comunista : ‘ Il comunismo viene ormai riconosciuto da tutte le potenze europee come una potenza. È gran tempo che i comunisti espongano apertamente a tutto il mondo la loro prospettiva, i loro scopi, le loro tendenze, e oppongano alla favola dello spettro del comunismo un manifesto del partito. ‘ Questo é lo scopo del manifesto, scritto da Marx ed Engels: in esso si chiariscono 1) i rapporti tra borghesi e proletari, 2)i rapporti tra i proletari e i comunisti, 3)le differenze tra il socialismo ‘utopistico’ e quello ‘scientifico’, di Marx ed Engels, 4)la posizione dei comunisti rispetto ai diversi partiti d’opposizione: 1)proletari e borghesi, insieme, han lottato contro l’aristocrazia: ora i proletari, presa coscienza di essere una potenza, devono combattere la borghesia. Questo é la moderna lotta di classe; tuttavia la lotta di classe c’é sempre stata, essa é il motore dello sviluppo storico. 2) i proletari aderiscono al comunismo per abolire la proprietà privata, che altro non é che un furto perpetrato dal possessore agli altri individui. La proprietà va abolita perchè é un furto e non si fonda sul lavoro (se si fondasse sul lavoro, l’operaio che lavora 12 ore in fabbrica avrebbe proprietà). 3) Il comunismo cui guarda Marx non é il comunismo rozzo, che mira solo all’abolizione della proprietà, e non è neanche il socialismo utopistico alla Fourier o alla Saint-Simon: é un socialismo scientifico, inevitabile: prima o poi la rivoluzione arriverà e travolgerà il capitale. 4) I comunisti appoggiano ogni movimento rivoluzionario che si proponga di cambiare le condizioni esistenti.
1852 Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte : Marx, rievocando il colpo di stato di Napoleone Bonaparte avvenuto appunto il 18 brumaio, prende in giro Luigi Bonaparte e mette in dubbio la legittimità del suo potere. ‘ Hegel nota in un passo delle sue opere che tutti i grandi fatti e i grandi personaggi della storia universale si presentano per, così dire, due volte. Ha dimenticato di aggiungere la prima volta come tragedia, la seconda volta come farsa ‘.
1857 Critica al programma di Gotha : Marx qui riprende e radicalizza l’idea di estensione dello Stato come approdo finale del comunismo. Ma ormai l’accento tende a spostarsi sull’approfondimento teorico. Marx descrive una nuova società, in cui non é più necessaria l’esistenza dello Stato, come il luogo in cui ‘ il libero sviluppo di ciascuno é la condizione per il libero sviluppo di tutti ‘. Alla prima fase, in cui il motto é ‘A ciascuno secondo il suo lavoro’ , sarebbe subentrato il comunismo pienamente realizzato, il cui motto é ‘ Ciascuno secondo le sue capacità, a ciascuno secondo i suoi bisogni ‘.
Breve riassunto delle opere di Engels
1842 Schelling e la rivelazione. Critica del più recente tentativo di reazione contro la filosofia libera : è un’aspra polemica contro Schelling, il filosofo chiamato a Berlino da Federico Guglielmo IV per dichiarare guerra ‘ alla sementa dei denti di drago del panteismo hegeliano ‘ ovvero alla ‘ scuola del vuoto concetto’ , ma che ora diventa il bersaglio dell’opuscolo di Engels, pubblicato a Lipsia.
1844 Schizzi di una critica dell’economia politica : scritto da Engels dopo il soggiorno a Manchester e ritenuto geniale da Marx; in esso si dimostra che l’aumento dell’accumulazione capitalistica genera crisi economiche, una riduzione dei salari e l’impoverimento progressivo delle classi lavoratrici, con il conseguente inasprirsi della lotta di classe. Questa situazione sembrava smentire l’esaltazione dei vantaggi della proprietà privata da parte dei teorici dell’economia: miseria e conflitti sociali potevano essere eliminati, secondo Engels, soltanto eliminando la proprietà privata, ossia instaurando il comunismo .
1851 Rivoluzione e controrivoluzione in Germania : Engels affronta la vittoria della reazione, nel 1848, tuffandosi negli studi storici. Anzichè sulla Francia (come fa Marx), egli però concentra la sua attenzione sulla Germania. Mentre in Francia il ’48 consolida la società borghese, in Germania la sconfitta della rivoluzione segna la vittoria di un antico regime ancora vivo e vegeto.
1851 Guerra tedesca dei contadini : anche in questo scritto la Germania é al centro. Si indaga sulle ragioni del ritardo storico tedesco. Vi campeggia la figura di Thomas Müntzer, protagonista della prima grande rivolta antifeudale, sfortunato campione di una modernità che in Germania stenta ancora ad attecchire. Però non c’é motivo per abbandonarsi allo scoramento: bisogna prestare attenzione all’aggettivo presente nel titolo. Il suo significato viene chiarito da Engels in apertura del libro: ‘ anche il popolo tedesco ha una tradizione rivoluzionaria. C’è stato un tempo in cui la Germania ha prodotto personalità che potrebbero figurare fianco a fianco dei migliori esponenti delle rivoluzioni di altri paesi. ‘ All’interesse scientifico s’intreccia quello politico. Bisogna evitare che la sconfitta della rivolta del ’48 si trasformi in un’irreparabile disfatta. Ecco allora che viene riportato alla luce il ricordo di una Germania fieramente rivoluzionaria e gravida di futuro.
1878 L’ Anti-Dühring : Engels polemizza contro le concezioni positivistiche della scienza, per le quali la scienza é un sapere fuori dal tempo, i cui oggetti sono fissi e immutabili, anch’essi fuori dal tempo. In realtà anche la scienza, a parere di Engels, é soggetto ad un processo di evoluzione storica e il materialismo moderno, che trova la sua espressione nelle scienze, é ormai essenzialmente dialettico e non richiede più una filosofia al di sopra delle scienze. Della filosofia restano in piedi solamente la dottrina del pensiero e delle sue leggi, ovvero la logica formale e la dialettica, che assume a proprio oggetto anche lo studio della formazione ed evoluzione delle teorie scientifiche, contribuendo per questo aspetto allo sviluppo tecnico delle varie scienze. A parere di Engels esiste una vera e propria dialettica della natura , non solo della storia. Per dialettica si deve intendere non solo ‘leggi del pensiero’, ma ‘leggi esistenti oggettivamente nella realtà’. Tali leggi vanno scoperte nelle cose, estratte da esse: qui sta la difficoltà, soprattutto per quel che concerne la natura. Sempre in questo testo, Engels sostiene che il modo di produzione capitalistico porta alla proletarizzazione della maggior parte della popolazione, la quale finirà per impadronirsi dello Stato, trasformando i mezzi di produzione in proprietà dello Stato. E’ questa la fase della dittatura del proletariato , ovvero dell’organizzazione politica del proletariato vittorioso, la quale però porterà alla soppressione del proletariato in quanto classe e di ogni conflitto di classe.
1884 L’origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato : Engels riprende molti dei risultati di Morgan, estendendoli anche allo studio del passaggio dalla gens allo Stato nell’Atene e nella Roma antiche, presso i celti e i germani, e utilizzandoli anche per criticare aspetti della realtà moderna. In particolare, egli é del parere che l’estensione del lavoro femminile nella società capitalistica sia la premessa indispensabile per la futura emancipazione della donna. Engels assume come principio che la dissoluzione della gens é la forza motrice del processo storico che porta alla formazione dello Stato ; esso non é dunque un’istituzione naturale ed eterna, ma il prodotto di una società arrivata ad un determinato grado di sviluppo economico-sociale: l’esistenza dello Stato é la dimostrazione che tale società si é scissa in classi antagonistiche con interessi economici in contrasto. In particolare, lo scopo dello Stato moderno é di mantenere a tempo indeterminato i rapporti di produzione capitalistici, ratificando democraticamente il dominio di classe mediante il suffragio universale, che tuttavia può diventare utile per la lotta rivoluzionaria del proletariato.
1893 L’Europa può disarmare? : si tratta di una serie di articoli pubblicati sul ‘Worwarts’ del 1893; si mette in evidenza la divisione in due campi contrapposti, l’uno e l’altro impegnati in una febbrile corsa al riarmo: si profila ‘ una guerra devastatrice quale il mondo non ha mai conosciuta ‘. Pur condannando il delirio militarista di entrambi i contendenti ( ‘ lo sciovinismo francese è idiota esattamente quanto quello tedesco ‘) Engels sembra prevedere la disfatta dell’arrogante Impero di Guglielmo II e persino le modalità con cui essa si verificherà: ‘ non dimentichiamolo: nella prossima guerra, chi deciderà sarà l’Inghilterra […] e sui mari l’ Inghilterra domina in modo incondizionato. Se essa pone la sua flotta a disposizione di una parte, l’altra verrà a trovarsi semplicemente presa per fame, perchè tagliata fuori dai rifornimenti di grano ‘.
I filosofi hanno solo interpretato il mondo in modi diversi; si tratta però di mutarlo.
Marx ed Engels sono passati alla storia come coppia indisgiungibile, come rivoluzionari di professione inseparabili; eppure ebbero una formazione molto differente, quasi antitetica. Infatti, Engels, nato a Barmen nel 1820, era figlio di un industriale bigotto e reazionario della classe capitalista ed è proprio in virtù di questa sua collocazione sociale che ha modo di venire a contatto con la classe operaia. Infatti, inviato dal padre in Inghilterra per affari, può osservare con particolare attenzione la condizione del proletariato inglese e trarne spunto per riflessioni che segneranno decisivamente la sua filosofia; in quest’occasione Engels scrive Le condizioni della classe operaia in Inghilterra (1845), una sorta di diario di bordo in cui raccoglie dati e annotazioni di rilievo. Al contrario, Marx, nato a Treviri nel 1818, ha una formazione più classicamente filosofica e muove i suoi primi passi nel contesto della Sinistra hegeliana, pubblicando articoli sulle varie testate politiche. I due futuri filosofi e compagni si incontrano a Parigi e stringono un’amicizia imperitura, a tal punto che anche quando Marx si troverà in difficilissime condizioni economiche (tanto da dover impegnare i propri vestiti), Engels lo aiuterà mantenendolo. Frutto della loro collaborazione è, ad esempio, il celebre Manifesto del partito comunista , redatto alla vigilia del rivoluzionario 1848 su richiesta di una piccola organizzazione operaia che aveva loro richiesto la stesura di un programma politico; e proprio per far sì che sia comprensibile a tutti gli operai, Marx ed Engels danno al Manifesto un taglio semplice e leggero. I due compagni negli anni Sessanta e Settanta vivono l’indimenticabile esperienza della Prima internazionale: tra gli organizzatori vi è Marx stesso, che polemizza aspramente sia contro la Sinistra borghese (di cui critica il rifiuto della lotta di classe) sia contro l’anarchismo alla Bakunin (a cui rimprovera il fatto di voler passare troppo bruscamente dallo Stato all’anarchia). Marx termina la propria esistenza nel 1883, ed Engels gli sopravvive fino al 1895, portando avanti l’attività filosofica e politica: già nel 1875 era nata la Socialdemocrazia Tedesca (SPD) dalla fusione di due partiti, uno di ispirazione marxiana, l’altro di ascendenza lassalliana. Dalla fusione, però, avvenuta con il congresso di Gotha, affiorarono problematiche apparentemente irrisolvibili: infatti, se Marx prospettava l’abbattimento del regime capitalistico attraverso la rivoluzione, Lasalle, dal canto suo, vedeva nel socialismo uno strumento riformista, in grado di ottenere pacificamente dei riconoscimenti a favore degli operai senza imboccare la via rivoluzionaria, ed è per questo che Lasalle tentò anche il dialogo con Bismarck, l’antidemocratico cancelliere tedesco. Ora, una volta nata la Socialdemocrazia sorgeva anche il problema riguardante quale prassi adottare (quella marxista della rivoluzione o quella lasalliana della riforma?), problema che resterà irrisolto per parecchio tempo fino alla scissione tra socialisti, favorevoli al riformismo, e comunisti, sostenitori della rivoluzione. Certo è che Marx non rimase soddisfatto del congresso di Gotha, poichè aveva già fiutato il rischio di una svolta riformistica che poteva far passare in secondo piano la rivoluzione e pertanto compose la Critica al Programma di Gotha (1875). Come accennavamo, Engels sopravvive a Marx e diventa una sorta di padre spirituale della SPD e della Seconda internazionale e le modifiche che egli apporta al marxismo prefigurano quella svolta riformista e democratica della SPD che esploderà in tutta la sua violenza nel celebre “dibattito sul riformismo”, con cui i comunisti rivoluzionari si distaccheranno dal partito. Tornando alla vita dei due filosofi, Marx, dopo aver frequentato il Liceo-ginnasio della sua città natale (Treviri), si era iscritto all’università laureandosi con la tesi Differenza tra la filosofia della natura di Democrito e quella di Epicuro (1839-41): quest’opera mette in luce come Marx, ancora giovanissimo, nutrisse già particolare interesse per il materialismo (rappresentato dalle filosofie di Democrito e Epicuro), interesse che non abbandonerà mai e che anzi lo porterà a dar vita ad una filosofia passata alla storia sotto il nome di “materialismo storico”; curioso è il fatto che Marx per primo soffermi insistentemente la propria attenzione sulla teoria epicurea del clinamen , ovvero della deviazione che gli atomi subiscono nella loro caduta e che permette ad Epicuro di lasciare un margine di libertà all’agire umano. Al giovane Marx interessa ogni forma di materialismo, da quello greco di Democrito ed Epicuro a quello tedesco allora in auge di Feuerbach; nello stesso tempo, però, com’egli stesso afferma, non riesce a passare indenne dalle ammalianti sirene dell’hegelismo. E la sfera materialistica convive in Marx con quella idealistica, tant’è che egli si propone come sintesi delle due tradizioni: dalla concezione materialistica desume la convinzione che l’elemento di base della realtà sia la materia, da quella idealistica, invece, mutua il procedimento dialettico elaborato da Hegel. Marx nota infatti, con straordinaria acutezza, come il limite di ogni materialismo sia sempre stata la scarsa attenzione rivolta alla storia, attenzione che invece è centrale nella filosofia hegeliana: ed è per questo che il pensatore di Treviri intende prendere il meglio dal materialismo e dall’hegelismo, scartando invece quegli aspetti ritenuti inadeguati. E mettendo insieme le due teorie, così diverse tra loro, nasce un ibrido esplosivo: un materialismo letto in chiave storica e dialettica , con il quale Marx dà una giusta sistemazione alla dialettica hegeliana, facendola poggiare dove è giusto che poggi. Hegel ha infatti avuto il merito di elaborare il celebre procedimento dialettico, ma la dialettica da lui intesa è una dialettica capovolta, che poggia sulla testa, ovvero sulle idee: e Marx, mantenendola invariata ma basandola sulla materia, la fa poggiare sui piedi, ponendo fine al suo stare a testa in giù. Al di là dell’influenza hegeliana sulla concezione filosofica, si può anche notare come le fonti a cui Marx si è ispirato coinvolgono anche sfere extra-filosofiche: Lenin, fervente marxista oltre che eroe della Rivoluzione russa, ha infatti notato che il marxismo si articola in tre ambiti (filosofia, politica ed economia) e per l’elaborazione di ciascuno di essi Marx ha tratto ispirazione da pensatori diversi. Per quel che riguarda la sfera filosofica, egli si è apertamente ispirato alla filosofia classica tedesca, quella cioè che da Kant giunge fino alla Sinistra hegeliana; per quel che invece concerne l’economia, ha preso spunto dall’ “economia classica inglese”, la quale trova il suo eroe in Adam Smith, acceso sostenitore del liberismo più sfrenato; oltre a Smith, Marx guarda anche a Davide Ricardo, che nei primi anni dell’Ottocento aveva sfatato il mito smithiano del capitalismo senza regole, facendo notare che gli interessi dei vari gruppi sociali sono inevitabilmente contrastanti tra loro e che, pertanto, non esiste quella mano invisibile ipotizzata da Smith che dovrebbe, dietro agli interessi personali perseguiti da ciascuno, aiutare in ultima istanza tutti. Per quel che riguarda la sfera politica, infine, Marx si ispira al socialismo francese, da lui bollato sarcasticamente come “utopistico” poichè si limita a tratteggiare società ideali sulla scia di quanto aveva fatto Platone. In questa lucida analisi condotta da Lenin si tende a mettere in evidenza la completezza del discorso marxista, nel senso che esso coinvolge tre diverse sfere fondamentali (filosofia, economia, politica) e attinge da tre diverse nazioni centrali nella cultura europea (la Germania per la filosofia, l’Inghilterra per l’economia, la Francia per la politica): infatti, la Francia aveva realizzato la sua rivoluzione politica, elaborando il socialismo e gettando le basi per ogni futura rivoluzione; l’Inghilterra si era avventurata, sul piano economico, nella rivoluzione industriale e, infine, la Germania aveva attuato con Kant una vera e propria rivoluzione filosofica. Queste tre rivoluzioni, così lontane tra loro, trovano in Marx la loro sintesi, spiega Lenin come corollario dell’intera sua riflessione. E può essere curioso rintracciare il primo tentativo di Marx di applicare la filosofia hegeliana all’economia e, in ultima istanza, alla politica: Marx ci prova per la prima volta nel 1844, in quel cospicuo gruppo di scritti pubblicati postumi con il titolo di Manoscritti economico-filosofici del 1844 , detti appunto “economico-filosofici” per via del tentativo di applicare le categorie della filosofia hegeliana all’economia. Marx è stato uno scrittore molto prolifico, che si è scatenato nella stesura di tantissimi libri, di cui meritano di essere menzionati le Tesi su Feuerbach (pubblicate nel 1888 da Engels), con cui Marx lancia il suo programma di materialismo storico, concependo la filosofia come un qualcosa volto a cambiare la realtà; in Critica alla filosofia hegeliana del diritto pubblico (1844) tuona contro la religione, in Critica dell’economia politica classica e in Per la critica dell’economia politica (1859) critica le concezioni di Smith e di Ricardo; in La guerra civile in Francia disserta dell’esperienza della Comune di Parigi, primo governo socialista: la frase conclusiva dell’opera è esemplare: ” Parigi operaia, con la sua Comune, sarà celebrata in eterno, come l’araldo glorioso di una nuova società. I suoi martiri sterminatori, la storia li ha già inchiodati a quella gogna eterna dalla quale non riusciranno a riscattarli tutte le preghiere dei loro preti. ” In Il 18 Brumaio di Luigi Bonaparte analizza il colpo di stato del 2 dicembre 1851, vedendolo come una banale ripetizione del 18 Brumaio di Napoleone I e precisando ironicamente che ” Hegel nota in un passo delle sue opere che tutti i grandi fatti e i grandi personaggi della storia universale si presentano per, così dire, due volte. Ha dimenticato di aggiungere la prima volta come tragedia, la seconda volta come farsa.” Un posto a parte in questa rapida carrellata di opere marxiane merita Il Capitale (1867), la grande opera di economia di Marx, un’opera che curiosamente verte non sulla società comunista, ma sul capitale, l’acerrimo nemico del marxismo. E del resto lo stesso Manifesto è in gran parte un’opera volta all’analisi del sistema capitalistico e non della futura società comunistica. Tutto ciò dimostra come Marx non voglia fare il profeta e sbizzarrirsi in fantasmagoriche previsioni del futuro, delineando società perfette, sulle orme dei socialisti utopisti. In questo egli resta fedele ad Hegel: la ragione può riflettere su se stessa solo in quelle realtà in cui è presente e tali realtà sono il passato e il presente. Ecco perchè Marx analizza la situazione passata e, soprattutto, presente per coglierne le contraddizioni di fondo e per far vedere dall’analisi di esse come il sistema in atto debba essere dialetticamente superato. In termini hegeliani, il futuro altro non è se non negazione del presente: l’attuale sistema capitalistico è destinato a “saltare” e a capovolgersi dialetticamente nel suo contrario, ovvero nel socialismo, in cui scompariranno le lotte di classe, lo stato e la proprietà privata. Marx non ci dice dunque che cosa sarà il socialismo, proprio perchè la ragione non può indagare su ciò che non si è ancora attuato; ma può dirci cosa non sarà, e visto che sarà la negazione dialettica del capitalismo, avrà tutte le caratteristiche ad esso opposte. In un certo senso, Marx si discosta da Hegel e apre qualche spiraglio verso il futuro, potendo dire ciò che in definitiva esso non sarà, ma non per questo egli arriva ai livelli dei socialisti utopisti, che con le loro aberrazioni mentali illustravano minuziosamente la società futura in tutti i suoi particolari (Fourier arrivando perfino a dire quanti individui ci sarebbero stati nelle costruzioni abitative). L’atteggiamento assunto da Marx è critico in ogni istante, prende e supera le tradizioni precedenti con il modello dialettico: e così, sul piano politico, accetta la critica al capitalismo ma ne critica il carattere utopistico che finora l’ha contraddistinta, precisando che dal socialismo utopistico si deve passare al socialismo scientifico , ovvero il socialismo va inteso non come delineamento mentale di una società ideale, bensì come necessaria conseguenza del tramonto imminente del capitalismo. Studiando in modo approfondito il capitalismo, infatti, è impossibile non vedere come esso si ribalterà, prima o poi, nel suo opposto: è un’analisi scientifica, una constatazione che si basa su dati di fatto e che porta a prevedere ciò che necessariamente sarà. La stessa considerazione di natura scientifica vale sul versante filosofico: l’hegelismo e il materialismo vengono dialetticamente superati dal materialismo storico; qualcosa di molto simile si può, infine, affermare anche per quel che riguarda l’economia: Marx riconosce che l’analisi dell’economia condotta da Smith e Ricardo è corretta, ma non accetta l’idea, da loro propugnata, che le leggi del capitalismo siano le leggi dell’economia in generale. Se lasciamo andare naturalmente l’economia, senza manipolarla, essa non potrà che comportarsi secondo le leggi dell’economia capitalistica, dicono Smith e Ricardo; Marx non è d’accordo e dà un’interpretazione più dinamica: quelle individuate giustamente da Smith e Ricardo sono sì le leggi del capitalismo, ma sono leggi storicamente determinate, ovvero in altre epoche le leggi dell’economia sono state e saranno altre, nettamente distinte da quelle del capitalismo. Il che vuol dire, in altri termini, che le stesse leggi che fanno funzionare il capitalismo lo porteranno anche al tramonto e al superamento: e Marx (ma soprattutto Lenin) ha in mente la concorrenza, su cui fa leva il capitalismo; se si lascia libera concorrenza, il capitalismo procede nel migliore dei modi, poichè si tende a vendere al prezzo più basso, ma presto nasce la concorrenza sfrenata che fa sì che si creino l’oligopolio e il monopolio e, in ultima istanza, l’eliminazione della concorrenza, causata paradossalmente dalla stessa concorrenza. Dunque, se per Smith e Ricardo le leggi dell’economia sono leggi eterne alla stregua delle leggi fisiche, per Marx, invece, cambiano, anzi sono esse stesse che si cambiano, con la conseguenza che il capitalismo porterà se stesso alla fine con un capovolgimento dialettico. In questo senso, Marx può presentare la sua teoria come scientifica, in antitesi alle teorie borghesi, da lui qualificate come “ideologie” in quanto cercano di dimostrare che le cose vanno bene così come sono: il caso più eclatante di ideologia, è senz’altro quello di Smith e della sua “mano invisibile”, con cui provava a dimostrare come le leggi del capitalismo, essendo leggi di natura, sono eterne e quindi giuste. Marx ritiene riprovevole questo atteggiamento, questa “falsa coscienza” con cui si tenta in tutti i modi di giustificare le posizioni dei ceti dominanti. Tuttavia, il dibattito storiografico e filosofico si è domandato fino a che punto il marxismo sia una scienza. A negare radicalmente ogni validità scientifica al marxismo è stato il filosofo liberale novecentesco Karl Popper, che in La società aperta e i suoi nemici presenta la società liberale, pluralista e dinamica culturalmente, e i suoi nemici: oltre a Platone (per via della sua “società ideale”) e ad Hegel (per via dello “stato etico”), Popper inserisce nelle sue “liste di proscrizione” anche Marx. Per Popper una teoria è scientifica non quando è verificabile, ovvero quando può appellarsi a dati di fatto che la avvalorino, poichè altrimenti anche la teoria secondo la quale Dio esiste potrebbe essere scientifica, in quanto provata da molteplici dati di fatto (le cose vanno bene perchè c’è un Dio, le cose vanno male perchè Dio vuole mettermi alla prova, ecc). Viceversa, una teoria può dirsi scientifica, prosegue Popper, se è falsicabile, ovvero se vi sono dati di fatto che possono smentirla: la teoria galileiana della caduta dei gravi è scientifica perchè sarebbe potuta essere smentita dai dati di fatto; al contrario, “Dio esiste” è una teoria priva di validità scientifica, poichè non c’è alcun dato di fatto che falsifichi la teoria: se anche tutto va storto, si può sempre dire che è nei progetti di Dio e perciò l’esistenza di Dio non sarà mai negabile. Allo stesso modo la teoria di Hegel non è scientifica, poichè non c’è dato empirico alcuno che possa smentirla; e lo stesso vale, secondo Popper, per il marxismo: esso non è scientifico poichè non può essere smentito da dati di fatto, tant’è che quando non si sono realizzate le previsioni di Marx secondo le quali la società si sarebbe sempre più polarizzata, i marxisti son riusciti in qualche modo ad aggiustare le loro teorie, spiegando ad esempio che il divario tra padrone e servo è comunque accresciuto o che le previsioni di Marx si sono avverate nei Paesi più poveri. Secondo molti altri pensatori di ispirazione marxista, invece, il marxismo è una dottrina scientifica, a tal punto che nella storia vi sono stati pensatori che hanno letto Marx in chiave più filosofica e altri che ne hanno dato invece una lettura più scientifica. Secondo questi ultimi (Althusser e Geymonat in primis), Marx sarebbe partito da confuse concezioni hegeliane per poi approdare, con Il Capitale , ad una vera e propria scienza del capitalismo, quasi come se nel Marx giovane prevalesse la filosofia e nel Marx anziano la scienza. C’è ovviamente anche stato chi ha letto Marx in termini più unitari, facendo notare come in realtà Marx non abbandoni mai del tutto la filosofia, tant’è che Il Capitale affonda le sue radici nel pensiero hegeliano, visto che Marx in esso fa vedere come siano le stesse leggi che governano il capitalismo a farlo tramontare. In molti hanno poi avanzato un’altra obiezione al marxismo: in Marx si sovrappongono, suo malgrado, due dimensioni eterogenee e apparentemente inconciliabili. Da un lato, egli diagnostica, con il piglio di uno scienziato, che il socialismo dovrà necessariamente esserci a seguito del crollo del capitalismo; dall’altro lato, poi, egli si spoglia della veste scientifica e si lascia trasportare dalla passione politica e dall’afflato morale, farcendo i suoi scritti di affermazioni moraleggianti, inneggiando alla rivoluzione e proclamando ingiusta, e pertanto da superare, la società capitalistica, ponendosi così in contrasto con la futura tesi di Weber secondo cui la scienza deve essere ” avalutativa “. La sfera scientifica (il capitalismo cade necessariamente) si sovrappone bruscamente a quella morale (il capitalismo è ingiusto e va abbattuto), quasi come se in Marx vi fosse una certa confusione della parola “dovere” nella duplice accezione di dovere morale e dovere come necessità fisica: è come se Marx dicesse che il capitalismo crollerà necessariamente ed è giusto moralmente che crolli. Questa contraddizione che serpeggia nella filosofia marxiana affiora anche quando egli dice che il capitalismo deve necessariamente crollare e poi invita ad organizzare il proletariato perchè si adoperi per abbattere il capitalismo: se il capitalismo deve necessariamente cadere, perchè allora bisogna lavorare per farlo cadere? Una spiegazione a ciò è possibile: dare agli operai la convinzione che il capitalismo crollerà necessariamente equivale a dar loro la certezza di lottare per una giusta causa, di stare dalla parte della storia, infondendo loro fiducia. E’ come dire che è giusto lottare per l’abbattimento del capitalismo perchè la storia stessa spinge in quella direzione; allo stesso modo, del resto, i Crociati combattevano gli “infedeli” con grande impeto poichè convinti di aver Dio dalla loro. Ritornando alla formazione di Marx, egli muove i suoi primi passi nel contesto della Sinistra hegeliana, costituita da quei sostenitori di Hegel che del suo pensiero privilegiavano il “tutto ciò che è razionale è reale”, convinti cioè che fosse opportuno realizzare anche in modo rivoluzionario ciò che si configurava come giusto e frutto di una certa razionalità. Ed è per questo che il giovane Marx, durante la sua provvisoria adesione alla Sinistra hegeliana, vede nell’hegelismo uno sforzo per cambiare la realtà verso un ampliamento dei diritti politici in senso democratico-borghese. Ma anche in questa fase giovanile affiorano delle novità contrastanti con il pensiero hegeliano e destinate a portare Marx a prenderne le distanze: nell’analisi che egli conduce hegelianamente sul rapporto tra Stato e società civile accentua radicalmente la contrapposizione tra i due “momenti”, mettendo in evidenza che lo Stato così come si configura nei regimi liberali è caratterizzato dall’uguaglianza giuridica e, tutt’al più, politica. Ed è sempre da quest’analisi che si possono evincere le differenze inconciliabili tra Marx e il socialismo in generale di stampo riformista: quest’ultimo, infatti, intendeva il socialismo come tappa ulteriore sulla strada che parte dal liberalismo e passa dalla democrazia, quasi come se con l’Inghilterra del Seicento si fosse giunti al liberalismo e all’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e con la Francia rivoluzionaria si fosse aggiunta la democrazia, ovvero l’uguaglianza dei diritti politici; si trattava ora, per i socialisti riformisti, di passare alla tappa successiva, il socialismo, ovvero l’uguaglianza dei diritti socio-economici, nella convinzione che una differenziazione sul livello socio-economico mettesse in crisi anche l’uguaglianza giuridica (se uno è più ricco può permettersi avvocati migliori) e quella politica (se uno è più ricco può comprare i voti corrompendo i più poveri). Il socialismo così inteso altro non è se non quella tappa che aggiunge all’uguaglianza giuridica (liberalismo) e politica (democrazia) quella socio-economica, con l’inevitabile conseguenza che liberalismo e democrazia non vanno abbattute ma integrate con il socialismo e anzi sono beni necessari poichè senza di essi non si potrebbe mai giungere al socialismo; tanto più che il socialismo, mirando agli interessi della stragrande maggioranza dei cittadini, può vincere attraverso il sistema democratico, dove ha la meglio chi prende più voti. La posizione di Marx è agli antipodi rispetto a quella appena illustrata: certo, anch’egli accetta l’idea di una democrazia socialista, pur restando sempre molto vago sul futuro del socialismo, ma comunque sui regimi liberal-democratici ha un’idea molto chiara, di netta ispirazione dialettica. Il processo evolutivo non è lineare, non si passa cioè dal liberalismo alla democrazia e, infine, al socialismo; al contrario, si tratta di un vero e proprio processo, in cui vi è una tesi, un’antitesi e una sintesi, sicchè il socialismo non può essere concepito come una tranquilla trasformazione del liberalismo e della democrazia, ma come drastico e violento capovolgimento di essi. Ne consegue che se per un socialista riformista malgrado ci sia la democrazia il socialismo, come tappa successiva, non c’è ancora, per Marx invece il socialismo non c’è proprio grazie al fatto che c’è il regime liberal-democratico, condizione politica dell’esistenza del capitalismo: fin tanto che ci saranno la democrazia e il liberalismo non potrà esserci il socialismo, dice Marx, il quale arriverà solo in seguito all’abbattimento di entrambi; il regime liberal-democratico, infatti, è la negazione stessa di ogni socialismo e anzi, in quanto condizione di esistenza del capitalismo, rappresenta una delle svariate forme in cui si è manifestato nel corso della storia lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo. La storia stessa, dice Marx nel Manifesto del partito comunista , ” è stata finora la storia di lotte di classe “, anche se tale lotta si è presentata sempre sotto forme diverse pur mantenendo la caratteristica di essere una rottura netta con il comunismo primitivo in cui tutto era di tutti. E quando Marx dice che la storia è lotta di classe intende dire che vi è sempre stata lotta tra chi detiene i mezzi di produzione (terre, fabbriche, ecc) e chi non li possiede; come dicevamo, nella storia tale lotta si è nascosta dietro maschere diverse ma ciononostante ” oppressore e oppresso si sono sempre reciprocamente contrapposti, hanno combattuto una battaglia ininterrotta, aperta o nascosta ” . Se nelle società precapitalistiche questa differenza economica, legata al fatto che qualcuno possiede i mezzi di produzione e qualcun altro no, è stata mascherata da forme di dominio extra-economiche: ad esempio, nell’antichità alla differenza economica di fondo si sovrapponeva, e anzi la offuscava, la differenza giuridica che faceva sì che per legge vi fossero padroni e schiavi, sicchè la differenza vera (ovvero il possesso dei mezzi di produzione) era nascosta; con il capitalismo moderno, invece, non vi sono più sovrapposizioni extra-economiche: con il liberalismo è invalsa l’uguaglianza di fronte alla legge e pertanto il capitalista in tribunale vale quanto l’operaio; con la democrazia è subentrata l’uguaglianza politica che fa sì che il voto del capitalista valga quanto quello dell’operaio. Ed è in questo contesto che emerge in tutta la sua tragicità e nella sua purezza la vera distinzione economica tra padrone e servo: tale distinzione, affiorata nella storia sotto diverse maschere che ne offuscavano la vera natura, può ora scaturire nella sua nudità, come meramente economica. Con la Rivoluzione francese è stata sancita l’uguaglianza degli uomini di fronte alla legge e nelle decisioni politiche: ed essendo i cittadini tutti uguali, ora le differenze perdono la loro giustificazione giuridica e si presentano nella loro realtà più profonda, ovvero come differenze economiche, tra chi detiene i mezzi di produzione e chi, sprovvisto di essi, non può far altro che vendere la propria forza-lavoro a chi li possiede. Proprio per questo lo studio della società capitalistica, come già aveva notato Hegel, è il metodo migliore per studiare anche tutte le altre società precedenti: infatti è in essa che si manifesta nella sua purezza quello scontro tra le classi sociali che nelle società precedenti era offuscato da differenze di altro genere; infatti, in un regime liberal-democratico che garantisce l’uguaglianza giuridica e politica si è, per dirla con Hegel, uguali nello Stato ma diversi nella società civile: si è cioè formalmente uguali (giuridicamente e politicamente), ma sostanzialmente diversi. Proprio per questo motivo il capitalista come citoyen ha gli stessi diritti dell’operaio, ma come bourgeois vale molto di più. E il regime liberal-democratico, in cui le differenze si estrinsecano nella loro purezza economica, è la condizione d’esistenza dello sfruttamento, poichè non è più, com’era nelle società antiche, che un uomo, essendo giuridicamente schiavo, è obbligato dalla legge a servire il padrone, ma al contrario si è tutti liberi ed è perciò la situazione in cui i rapporti di lavoro sono determinati da contratti: il capitalista ha i mezzi e l’operaio ha la forza-lavoro da vendere e si accordano in piena libertà giuridica. Il che significa che l’uguaglianza di diritti è per Marx la condizione formale per lo sviluppo dei meccanismi di sfruttamento tipici del capitalismo, vale a dire che se non ci fosse la libertà della repubblica borghese non potrebbe nemmeno svilupparsi il libero contratto tra capitalista e operaio. E’ come se il capitalismo si desse la repubblica borghese come forma politica in cui potersi sviluppare, per cui lo sfruttamento capitalistico non esiste malgrado l’uguaglianza sociale e politica, ma anzi esiste in virtù di esse, che permettono che il capitalista possa sfruttare l’operaio liberamente. Ne consegue che la repubblica borghese, nella prospettiva marxiana, non è un primo passo verso il socialismo, ma è, al contrario, l’habitat naturale dello sfruttamento capitalistico e proprio per questo non si tratta di aggiungere all’uguaglianza giuridica e politica quella economica riformando la repubblica borghese in direzione dell’equità sociale; viceversa, per Marx la repubblica borghese non va cambiata, va abbattuta . Ecco dunque che si delineano le differenze insormontabili tra la Sinistra hegeliana, pronta a far diventare reale ciò che è razionale, e Marx, convinto che si debba mutare la realtà per far sì che mutino anche le idee: la dialettica non deve poggiare sulle idee (come credeva invece Hegel), ma sui fatti materiali ed è proprio in questo che consiste il capovolgimento marxiano della dialettica hegeliana; non si tratta cioè di mutare idee per cambiare la realtà ma si tratta di mutare la realtà per cambiare idee: ” Il comunismo, per noi, non è uno stato di cose che debba essere instaurato, un ideale al quale la realtà debba conformarsi. Chiamiamo comunismo il movimento reale che abolisce lo stato di cose presenti […] Le posizioni teoriche dei comunisti non poggiano affatto su idee, su princìpi inventati o scoperti da qualche apostolo salvatore del mondo. Esse sono soltanto espressioni generali dei rapporti effettivi di una lotta di classe già in atto, di un movimento storico che si sta svolgendo sotto i nostri occhi “. Le divergenze che andavano acuendosi tra il pensiero marxiano e quello della Sinistra storica vengono a galla anche in uno scritto del 1844 Sulla questione ebraica : in quegli anni in cui divampavano i moti rivoluzionari del dopo restaurazione, sorge il problema dell’emancipazione degli Ebrei, fino ad allora privi di diritti pari agli altri cittadini. Se la Sinistra hegeliana si era scatenata in scritti a favore dell’emancipazione ebraica, Marx, interessato direttamente in quanto ebreo, interviene in modo piuttosto originale, sostenendo che il vero problema da porsi è la trasformazione radicale e rivoluzionaria della realtà in modo tale che perda di significato ogni differenza basata sulla religione, tanto odiata da Feuerbach. Le considerazioni religiose di Feuerbach si intrecciavano con quelle politiche in quanto egli sottolineava il carattere pericolosamente conservatore della religione, poichè in essa l’uomo tende a diventare schiavo, a sentirsi dipendente da un’entità superiore, e uno schiavo incatenato nel “mondo delle idee” diventa inevitabilmente anche schiavo nella realtà materiale, quasi come se oltre ad essere schiavo di Dio diventasse anche schiavo di un padrone materiale. Ne consegue che la liberazione politica dell’uomo dovrà per Feuerbach passare per l’eliminazione della religione: infatti, solo dopo la scomparsa della religione l’uomo cesserà di essere schiavo di Dio e, successivamente, dei padroni materiali. Diametralmente opposta è la concezione di Marx, ateo dichiarato, secondo la quale ” la religione è l’oppio del popolo ” : secondo Marx, infatti, l’uomo ricorre alla religione perchè materialmente insoddisfatto e trova in essa, quasi come in una droga (“oppio”), una condizione artificiale per poter meglio sopportare la situazione materiale in cui vive. Per Marx, dunque, non è la religione che fa sì che si attui lo sfruttamento sul piano materiale (come invece credeva Feuerbach), ma, al contrario, è lo sfruttamento capitalistico sul piano materiale che fa sì che l’uomo si crei, nella religione, una dimensione materiale migliore, nella quale poter continuare a vivere e a sperare. Ne consegue che se per Feuerbach per far sì che cessi l’oppressione materiale occorre abolire la religione, per Marx, invece, una volta eliminata l’oppressione, crollerà anche la religione, poichè l’uomo non avrà più bisogno di “drogarsi” per far fronte ad una situazione materiale invivibile. Con queste considerazioni sullo sfondo, Marx si distacca irreversibilmente dalla Sinistra hegeliana, la quale aveva dato una lettura progressista di Hegel ed era convinta che si potesse mirare al progresso attraverso una critica ideologica della religione e della società; Marx, invece, ipotizza un vero e proprio capovolgimento dialettico, poichè è convinto che con una semplice trasformazione dialettica di idee non si possa cambiare la realtà (come invece credeva la Sinistra), ma al contrario è cambiando dialetticamente la realtà, ovvero passando dalle ” armi della critica ” alla ” critica delle armi “, che cambiano anche le idee ed è proprio questo il succo del materialismo marxiano: ” per sopprimere il pensiero della proprietà privata è del tutto sufficiente il comunismo pensato; per sopprimere la proprietà privata effettiva, reale, occorre una effettiva, reale azione comunista. ” Ma, come abbiamo già detto, ” le idee non cascano dal cielo ” (come dirà Antonio Labriola): ” ci vuole forse una particolare perspicacia per comprendere che, cambiando le condizioni di vita degli uomini, i loro rapporti sociali e la loro esistenza sociale, cambiano anche le loro concezioni, i loro modi di vedere e le loro idee, in una parola anche la loro coscienza? Che cos’altro dimostra la storia delle idee, se non il fatto che la produzione spirituale si trasforma insieme a quella materiale? (Manifesto del partito comunista). Come già accennato, si tratta di un materialismo storico, ovvero di una sintesi tra il materialismo di Feuerbach e la storicità di Hegel. Ciò implica che per Marx la realtà fondamentale sia quella materiale, rispetto alla quale tutte le altre sono derivate: le idee esistono, ma sono derivate dalla materia. Di grande importanza nella formazione culturale di Marx sono anche i Manoscritti economico-filosofici del 1844 (pubblicati postumi): come recita il titolo, si tratta di manoscritti precedenti al Manifesto rimasti inediti e la coppia di aggettivi economico-filosofico rende bene l’idea dell’argomento che in essi si tratta. Con questi scritti, infatti, Marx analizza alcune questioni economiche avvalendosi, in modo molto originale, delle categorie della dialettica hegeliana: centrale è il concetto di alienazione , desunto da Hegel ma già presente nella filosofia politica del Seicento. Ripercorrendo a grandi linee il significato di tale termine, si può notare come da un significato prettamente giuridico, in cui “alienazione” era il cedere qualcosa a qualcuno, sia passato ad un significato più ampio nel Seicento, quando per “alienazione” si è inteso il cedere i propri diritti fondamentali al sovrano per poter così costituire la società civile. Infine, con Hegel il termine si era colorato di nuovi significati fino ad allora sconosciuti: “alienazione” è quella tappa in cui la coscienza si smarrisce nella materialità, quando cioè perde se stessa; ed Hegel ha soprattutto in mente il lavoro, con il quale lo spirito dell’uomo rimane catturato dalla materia e pertanto ne consegue che il lavoro è di per sè alienante. In altri termini, “alienazione” per Hegel vuol dire cedere parte della propria essenza, quasi come se il lavoro facesse smarrire nella materia una parte della spiritualità dell’uomo. Ecco perchè per Hegel il lavoro è intrinsecamente alienante e significa porre spiritualità nella materia; per Marx, invece, il lavoro non è alienante intrinsecamente, anzi, in una prospettiva in cui a contare per davvero è la materia, esso è considerato come la massima realizzazione dell’uomo, una sorta di umanizzazione della natura in cui si supera la distinzione tra soggetto e oggetto coi fatti e non con le idee: trasformare la natura col lavoro vuol dire, infatti, ricondurla al soggetto, antropizzarla. L’uomo, secondo Hegel, è per natura homo sapiens e dunque il lavoro è alienante perchè gli provoca la perdita di spiritualità; per Marx, invece, l’uomo è homo faber e pertanto il lavoro si colora di positivo, ed è anzi il miglior modo che l’uomo ha per realizzarsi. Ma il lavoro diventa alienante quando è sfruttamento, quando cioè il suo frutto è strappato al lavoratore tramite i rapporti di sfruttamento della produzione capitalistica, come se l’elemento di umanità posto nella materia venisse brutalmente strappato via. Il lavoro è oggettivazione dell’uomo rispetto alla natura sia per Hegel sia per Marx, ma per Hegel lo è intrinsecamente (l’oggettivazione stessa è alienazione) mentre per Marx lo è nella misura in cui si configura come sfruttamento. Dunque per Marx il lavoro di per sè non è alienato, ma lo è in determinate condizioni, ovvero nel caso dello sfruttamento tipico delle società divise in classi e, soprattutto, nella società capitalistica. Ed è con Marx che il significato del termine “alienazione” termina il suo percorso, dal momento che accanto al significato filosofico convive quello giuridico: il motivo per cui il lavoro è alienato dipende dal fatto che il prodotto del lavoro degli operai viene espropriato, vale a dire che l’operaio produce ma il frutto del suo lavoro gli viene brutalmente strappato cosicchè egli ” non si afferma nel suo lavoro, bensì si nega, non si sente appagato, ma infelice, non svolge alcuna libera energia fisica e spirituale, ma mortifica il suo corpo e rovina il suo spirito “. Dunque Marx si pone in antitesi con la tradizione ebraico-cristiana, secondo cui il lavoro è una condanna inflitta da Dio agli uomini in seguito al peccato originale; al contrario, per il filosofo di Treviri esso è la massima realizzazione dell’uomo, in quanto lavorare significa cambiare la natura, imporle il proprio suggello, estendere ad essa il proprio dominio, quasi come se lavorando, per dirla con Locke, la natura diventasse un’estensione del nostro corpo. Marx procede nella sua analisi mettendo in luce come l’alienazione investa molti altri aspetti dell’uomo: se in prima analisi l’uomo è alienato rispetto al prodotto del suo lavoro, è anche vero che egli si aliena anche dalla propria essenza. Infatti, in una realtà non alienata l’uomo dovrebbe trovare la propria essenza più compiuta nel lavoro e solo a margine dovrebbe adempiere alle sue funzioni più propriamente animali (il bere, il cibarsi, il riprodursi, ecc); ma quando il lavoro è alienato succede invece che l’operaio, non potendo più trovare soddisfazione nel lavoro, in quanto gli viene strappato via dal capitalista, allora ripiega esclusivamente sulle soddisfazioni extra-lavorative, ovvero su quelle più propriamente animali, sicchè nel proprio tempo libero si sfoga in piaceri meramente materiali (l’alcol e la prostituzione, ad esempio), trovando in essi gli unici momenti di libertà. E così, con un tipico capovolgimento hegeliano, Marx spiega come l’uomo diventi animale, in quanto perde completamente la propria essenza (che risiederebbe in quel lavoro, se non fosse alienato) e la ritrova solamente in quei piaceri ferini di cui abbiam detto: ecco dunque che l’operaio ” si sente libero ormai solo nelle sue funzioni bestiali, nel mangiare, nel bere e nel generare, tutt’al più nell’avere una casa, nella sua cura corporale, ecc. e che nelle sue funzioni umane si sente solo più una bestia. Il bestiale diventa l’umano e l’umano il bestiale. ” Ed è questo il contesto in cui matura l’astio fra gli uomini, ovvero quella che Marx definisce “lotta di classe”, in cui l’uomo vede i suoi simili come nemici. Il lavoro alienato, ricapitolando, ” aliena all’uomo la natura; aliena all’uomo se stesso ” e aliena all’uomo i suoi simili. Si può poi notare, come aveva fatto Adam Smith, che con la meccanizzazione del lavoro scaturita dalla rivoluzione industriale scompare anche l’elemento di creatività insito nell’attività degli operai, che si ritrovano così a dover compiere sempre e solo, come automi, le stesse operazioni. E’ bene ora entrare nel merito di uno dei capisaldi della dottrina marxiana, ovvero il materialismo storico, che abbiamo prima definito come materializzazione della dialettica hegeliana. Il presupposto di tale dottrina consiste nel fatto che la storia sia governata essenzialmente da fattori materiali e che questi fattori siano di carattere economico, cosicchè la storia è basata sull’economia, mentre tutto il resto (rapporti politici, giuridici, arte, religione, ecc) costituisce elementi sovrastrutturali. La struttura della realtà, pertanto, è la materialità economico-sociale e tutto il resto è una sovrastruttura ideologica: a tal proposito Marx può affermare, in opposizione alle idee di Hegel e della Sinistra, che ” non è la coscienza che determina la vita, ma la vita che determina la coscienza “; non sono cioè le idee a cambiare la realtà, ma è la realtà stessa a cambiare le idee. In questa prospettiva occorre affrontare il problema del rapporto tra struttura e sovrastruttura: alcuni interpreti del marxismo hanno letto, forzando un pò il pensiero marxiano, tale rapporto come meccanico, per cui la struttura dovrebbe determinare in modo meccanico e deterministico la sovrastruttura; ne consegue l’inevitabilità di ciò che avviene e questo servì a molti marxisti (tra cui Engels) per dilazionare nel tempo il momento dello scoppio della rivoluzione, come a dire che il capitalismo dovrà inevitabilmente cadere prima o poi perchè le condizioni economico-materiali portano inevitabilmente in quella direzione e pertanto non bisogna scendere in piazza a fare la rivoluzione. Questa interpretazione, che, propugnando un rigido meccanicismo, nega ogni forma di libertà all’uomo, fu adottata soprattutto dalla II Internazionale, ma in realtà è molto sganciata dal pensiero di Marx: infatti, egli è convinto che, accanto al rapporto fondamentale struttura-sovrastruttura, vi sia anche un effetto di rimbalzo per cui se è vero che la vita determina le idee è anche vero che le idee non sono stagnanti, ma, al contrario, possono trasformarsi in prassi ( ” la forza materiale deve essere abbattuta per mezzo della forza materiale, ma la teoria diventa, essa pure, una forza materiale, quando si impadronisce delle masse “, Tesi su Feuerbach). In altre parole, il fatto che il proletariato maturi una coscienza di classe è sì dato dalle condizioni materiali in cui vive, ma è poi necessario per far sì che esso scenda in piazza a fare la rivoluzione: è necessario che il proletariato diventi in sè e per sè , ovvero oltre a costituire un movimento (in sè) deve anche avere coscienza di costituirlo (per sè). Il fatto di esserlo è un elemento strutturale, ma il fatto di sapere di esserlo è sovrastrutturale, ossia ideologico: se lo fosse senza sapere di esserlo (ovvero se ci fosse la struttura senza la sovrastruttura) non potrebbe mai fare la rivoluzione. Dunque, è senz’altro vero e scientificamente provato, dice Marx, che il capitalismo crollerà, ma è altrettanto vero che non ci si deve limitare ad attendere inerti quel momento, bensì bisogna maturare una coscienza di classe che porti il movimento proletario a decidere di abbattere il capitalismo. Come per Hegel, anche per Marx la storia è un processo dialettico, ma si tratta di una dialettica materiale: nel suo complesso, la storia si articola in tre grandi tappe; 1) comunismo primitivo; 2)lotta di classe; 3) comunismo maturo. All’inizio della storia esisteva un comunismo primitivo (come già ipotizzava l’antropologia contemporanea a Marx) dovuto al fatto che non vi era ancora la divisione del lavoro e la lotta di classe che da essa scaturisce. La negazione di questo comunismo primitivo è data dalla nascita della divisione del lavoro, prima tra tutte quella paleolitica in cui al maschio spettava la caccia e alla donna la raccolta. La divisione del lavoro nasce perchè i bisogni umani tendono a non essere naturali: infatti, sebbene molti di essi si configurino come assolutamente biologici (bere e mangiare, ad esempio), tra uomo e natura si instaura un rapporto molto complesso, tant’ che, dice Marx, la natura che conosciamo è solo formalmente allo stato puro; essa, infatti, è sempre modificata dall’uomo e dalle sue realizzazioni. Ne consegue che l’uomo e la natura sono indissolubilmente congiunti fra loro e tendono a modificarsi reciprocamente: pertanto, sbaglia il materialismo di Feuerbach a trascurare la dimensione umana e sbaglia lo “spiritualismo” di Hegel a trascurare quella materiale; ecco perchè il materialismo storico di Marx si presenta come sintesi dei due, poichè egli è convinto che l’uomo abbia sì una sua base materiale per cui egli ” è ciò che mangia ” ma che allo stesso tempo anche il mondo sia il risultato delle realizzazioni e dei cambiamenti attuati dall’uomo stesso. In altri termini, l’uomo è ciò che mangia, ma egli non si accontenta di mangiare esclusivamente ciò che gli offre la natura e così la modifica per mangiare ciò che egli stesso produce. Ecco perchè man mano che si procede nella storia, per via del crescere della cultura, i bisogni umani diventano sempre più complessi e per poterli soddisfare occorre un lavoro sempre più complesso, che può essere attuato solo attraverso la divisione del lavoro. Essa genera ricchezza e progresso ma nello stesso tempo provoca divisioni di classe e disuguaglianze, suddivide gli uomini in sfruttati e sfruttatori, il lavoro in lavoro intellettuale e lavoro manuale. La divisione del lavoro è, in prima analisi, dannosa, poichè fa nascere lo sfruttamento: ma, molto hegelianamente, ” il negativo è sempre insieme anche positivo “; infatti, se è un male perchè ha generato disuguaglianza, è comunque un bene che ci sia stata perchè così può essere dialetticamente superata con la rivoluzione. Ecco dunque che la storia si prospetta come lotta di classe e il suo obiettivo è il ritorno al comunismo, ma non al comunismo rozzo e primitivo in cui regnava la povertà, bensì al comunismo della ricchezza, sintesi del comunismo originario e della divisione in classi: si tratterà infatti di un comunismo che manterrà l’apparato produttivo delle fabbriche, ma non sfrutterà nessuno. Quello appena tratteggiato è lo schema generale, ma, entrando nel dettaglio, a far muovere la storia è, come abbiamo ribadito, un procedimento dialettico di tipo economico-materiale e, in modo specifico, si tratta di ravvisare le contraddizioni che fanno scattare quel superamento che permette il passaggio da una tappa all’altra. A questo punto Marx introduce i concetti di forze produttive e rapporti di produzione : ogni società è caratterizzata da un insieme di capacità umane (conoscenze, abilità, ecc) con le quali può sfruttare la natura e tali capacità vanno appunto sotto il nome di forze produttive. Le forze produttive, aggiunge Marx, si sviluppano sempre nell’ambito di rapporti di produzione, ovvero in determinati rapporti sociali (nell’ambito dei quali rientrano anche le ideologie e, più in generale, le sovrastrutture): vi sono così state età in cui le forze produttive si sono sviluppate nell’ambito dello schiavismo e del servilismo, fino a giungere all’era capitalistica. E i rapporti di produzione vengono determinati dalla forza di produzione caratteristica di quello specifico momento storico: nell’antichità regnava lo schiavismo perchè in quel momento tale rapporto di produzione era il migliore che ci potesse essere per sfruttare in modo ottimale le forze produttive. Ogni forza produttiva, dunque, si dà il suo rapporto di produzione, sicchè questi ultimi rispecchiano e sono sempre funzionali alle forze produttive. Tuttavia, può succedere che all’interno di questo schema generale lo sviluppo vada avanti con eccessiva rapidità e ci si trovi in una condizione in cui i livelli di rapporti produttivi si trovano indietro rispetto alle nuove forze produttive emerse a tal punto da rivelarsi inadeguati: come se le forze produttive si trovassero ingabbiate in rapporti produttivi che impediscono loro di svilupparsi al meglio. Infatti, le forze produttive, proprio perchè hanno generarato esse stesse i rapporti produttivi per potersi sviluppare al meglio, funzionano fin troppo bene e progrediscono con gran rapidità mentre i rapporti restano immutati e si rivelano pertanto inadatti per il giusto sviluppo delle nuove forze sviluppatesi. Un’immagine che può chiarire cosa intendesse Marx può essere quella, di forte sapore hegeliano, del guscio: è quasi come se i rapporti produttivi fossero il guscio sociale dentro al quale si sviluppano le forze produttive; quando però si sono sviluppate, arriva il momento di spaccare il guscio e di prorompere all’esterno e per far ciò occorre la rivoluzione, intesa come capovolgimento dialettico in chiave materialistica. Quando i rapporti produttivi si rivelano ormai inadeguati alle nuove forze produttive, giunge il momento di far saltare tali rapporti con la rivoluzione: ed è quel che è accaduto in Francia, quando la borghesia, che si sentiva ingabbiata da rapporti sociali e ideologici che ne frenavano lo sviluppo, è scesa in piazza a fare la rivoluzione. Di rivoluzioni nella storia ce ne sono state tante: più precisamente, ve ne sono state ogni qual volta si è aperta la forbice forze produttive-rapporti produttivi; e ogni volta che vi è stata una rivoluzione, la classe dominante che traeva maggior vantaggio dai rapporti di produzione presenti è stata spodestata da una nuova classe dominante. Infatti, da quando la società si è frantumata in classi, la storia è sempre stata storia di lotte di classe e ciascuna rivoluzione attuatasi non ha abolito tale frantumazione, ma ha semplicemente cambiato la classe dominante: così con la Rivoluzione francese è stata spodestata l’aristocrazia ed è salita al potere la borghesia, dando vita a nuove lotte di classi, in particolare a quella tipica del mondo moderno, tra borghesi e proletari. Marx fa notare che tutte le rivoluzioni della storia sono sempre state rivoluzioni di una minoranza in favore di una minoranza: la borghesia della Rivoluzione francese, ad esempio, era in netta minoranza e ha tutelato esclusivamente i propri interessi, tant’è che anche il decreto apparentemente più socialista (i decreti di Ventoso), che prevedeva la spartizione delle terre, rientrava comunque in un’ottica pienamente borghese, che confermava la sacralità della proprietà privata. Le cose cambieranno del tutto nel momento in cui ci sarà la rivoluzione comunista, terza tappa della storia: essa sarà attuata dalla stragrande maggioranza degli uomini in favore della stragrande maggioranza degli uomini e anch’essa nascerà in modo ineluttabile dalle contraddizioni della situazione precedente (ovvero il capitalismo). E Marx di contraddizioni nel capitalismo ne riscontra a bizzeffe e, per il momento, possiamo notare quella forse più lampante: il capitalismo più va avanti e più la forma del lavoro tende ad essere cooperativistica, produrre qualcosa cioè vuol sempre più dire lavorare insieme agli altri; tuttavia, se le forze produttive tendono sempre più ad essere cooperativistiche, i rapporti di produzione spingono in direzione opposta, dal momento che la ricchezza prodotta dal lavoro compiuto in cooperazione tende sempre più ad accentrarsi nelle mani di pochi. In altre parole, la contraddizione insormontabile del capitalismo è che più tutti lavorano insieme e più il frutto del lavoro va in mano a pochi. Il capitalismo è destinato a saltare inevitabilmente per via di questa contraddizione e di molte altre e non perchè è un sistema iniquo, come invece credevano ingenuamente i socialisti utopisti: sono le contraddizioni stesse che lo erodono dall’interno che lo faranno, prima o poi, crollare, con la stessa inellutabilità con cui un grave lasciato cade al suolo. La questione dei socialisti utopisti merita attenzione: Marx, nel Manifesto , si sofferma accuratamente a smontarne le tesi e suddivide il socialismo che non è scientifico (come invece è il suo) in conservatore, reazionario e utopistico. Classico esempio di socialismo reazionario è quello di Lasalle, convinto che i proletari, nella loro battaglia contro i borghesi, debbano schierarsi al fianco di tutti coloro che avversano la borghesia, aristocratici compresi, tant’è che Lasalle tentò un rapporto privilegiato con Bismarck; Marx è però del parere che non si possa creare il progresso alleandosi con i reazionari. La storia, infatti, insegna che, con la Rivoluzione francese, borghesi e proletari, coalizzatisi, sono riusciti a cacciare il nemico comune, ovvero l’aristocrazia; con tale impresa, hanno aperto il campo allo scontro di classe moderno, tra borghesi e proletari, per cui allearsi con l’aristocrazia per vincere i borghesi vorrebbe dire tornare indietro nella storia, ai foschi anni del feudalesimo. Non a caso, nel Manifesto campeggia una vera e propria esaltazione della borghesia, di cui Marx tesse le lodi e che presenta come classe sociale rivoluzionaria che, con la Rivoluzione francese, ha saputo cambiare il mondo; ma ora essa va abbattuta perchè, preso il potere, ha perso le sue istanze rivoluzionarie e si è impantanata nel conservatorismo più totale, cercando esclusivamente di mantenere la realtà così com’è. Altrettanto aspramente, Marx critica anche il socialismo conservatore di Proudhon, personaggio per il quale nutriva una cordiale antipatia personale e al quale indirizzerà Miseria della filosofia (1847) in cui trapela un’ acredine personale per quest’uomo tale da lasciare sgomento il lettore e nella cui impietosa premessa bolla l’autore francese in quanto dilettante sia di filosofia sia di economia. L’idea centrale nella filosofia di Proudhon era quella di realizzare una società basata sulla cooperazione tra i piccoli produttori, con la scomparsa sia dei capitalisti sia dei proletari; e, pur essendo la proprietà privata per Proudhon un furto, essa starebbe alla base di tale cooperazione. Marx tuona contro questa prospettiva: una delle tante altre contraddizioni del capitalismo, infatti, è la polarizzazione della società, causata dal meccanismo capitalistico della concorrenza. Essa fa sì che ciascuno cerchi di produrre sempre di più e a costi sempre più bassi per non soccombere alla concorrenza, con la conseguenza che scompaiono gli elementi deboli e la concorrenza tende a negare se stessa portando all’oligopolismo e, in ultima analisi, al monopolismo. Il paradosso, dunque, consiste nel fatto che è la stessa logica del capitalismo a negarlo, in quanto un capitalismo senza concorrenza non è un capitalismo; la conseguenza di ciò, sul piano sociale, è che chi resta tagliato fuori dalla concorrenza finisce nei ranghi del proletariato, cosicchè i capitalisti sono sempre in meno, i proletari sono sempre in più e i borghesi sono pochissimi: la società assume così la forma di una piramide al cui vertice vi sono pochi ricchi e alla cui base vi sono caterve di masse diseredate. E una teoria come quella di Proudhon, che mira ad una società di piccoli produttori senza ricchi e poveri, è una società ideale sganciata dalla realtà e dalla scientificità (non c’è nessun dato di fatto che spinga in quella direzione): non si tratta di attenuare le contraddizioni del capitalismo, ma, al contrario, di far leva su di esse per farlo saltare; la proposta di Proudhon, del resto, vorrebbe trasformare tutti in borghesi, mentre Marx ha in mente una situazione in cui la borghesia sparisce e, con essa, anche il proletariato, poichè la ricchezza della borghesia si fonda sullo sfruttamento del proletariato. La società comunista si caratterizzerà, pertanto, per l’essere priva di classi, anche se, appena fatta la rivoluzione, per un certo periodo si dovrà instaurare una dittatura del proletariato; quando essa sarà terminata, si estinguerà lo Stato, in quanto altro non è se non lo strumento con cui una classe domina le altre. Ma in un contesto in cui non vi son più classi, lo Stato perde ogni significato e si sgretola, aprendo le porte all’anarchia (il grande errore dell’Unione Sovietica può essere letto nel fatto che non si è mai riusciti a superare la fase di dittatura del proletariato e, con essa, lo Stato). La proposta di Proudhon, conclude Marx, va respinta perchè va in direzione opposta alla realtà (che tende ad eliminare sempre più, con la concorrenza, i piccoli produttori) e perchè vorrebbe dire trasformare tutti in borghesi. Infine, l’ultima forma di socialismo che Marx analizza e critica è quello francese “utopistico”, di Saint Simon e di Fourier, socialismo nei confronti del quale si rivela più generoso e benigno rispetto agli altri due: a questi pensatori spetta il merito di aver denunciato le contraddizioni e la brutalità del sistema capitalistico, anche se, invece di costruire su queste considerazioni una dottrina scientifica, si sono messi a tavolino, come Platone, a delineare fantasmagoriche società ideali, per di più appellandosi non agli operai perchè imbracciassero i fucili per far la rivoluzione, ma ai capitalisti, affinchè umanamente accettasero di attuare le società giuste da loro tratteggiate. Ma Marx, pur criticandone questo aspetto, riconosce che i limiti degli “utopisti” sono giustificabili dal fatto che ai loro tempi il proletariato non aveva ancora acquisito coscienza di sè e dunque non ci si poteva rivolgere ad esso; è solo ai tempi di Marx che ” lo spettro del comunismo ” si aggira per l’Europa e ha piena coscienza di sè. Con il senno di poi, si può essere indotti a pensare che l’analisi marxiana, secondo la quale la società sarebbe andata sempre più polarizzandosi, non si sia avverata: infatti, dopo la morte di Marx, si è affermata una sempre più variegata composizione sociale, tant’è che la società si è dimostrata rappresentabile non già a forma piramidale (come credeva Marx), ma a forma romboidale. Non è vero, cioè, che ci sono pochissimi ricchi al vertice, pochi borghesi nel mezzo e una miriade di poveracci alla base; al contrario, vi sono pochi ricchi al vertice, pochi poveri al fondo, e una caterva di borghesi nel mezzo. La teoria marxiana sembra dunque aver clamorosamente fallito, ma in realtà, i marxisti più ferventi, sono riusciti a correre ai ripari, cercando di sostenere che la polarizzazione, contrariamente a quel che sembrerebbe, c’è stata. Si fa infatti notare che gli operai di oggi vivono senz’altro meglio rispetto a quelli di duecento anni fa, ma ciononostante il reddito medio dell’operaio di oggi è di gran lunga più distante da quello del capitalista rispetto a quanto non fosse per gli operai del passato. In altri termini, l’operaio oggi sta meglio di duecento anni fa, ma in sostanza il divario con il capitalista si è accentuato. E bisogna poi tenere in considerazione il fatto che, nell’ottica marxiana, il capitalismo è un fenomeno mondiale, che con l’età dell’imperialismo si spinge ad invadere l’intero pianeta. Dunque, se ragioniamo sul piano mondiale, la distanza tra ricchi e poveri è cresciuta, come aveva previsto Marx; semmai, si può notare che è cambiato il fronte della lotta di classe, ovvero il confine tra sfruttati e sfruttatori non è più tra operai e capitalisti dell’evoluta società europea, ma fra abitanti dei Paesi ricchi (operai compresi) e abitanti dei Paesi poveri, il che significa che oggi anche l’operaio europeo sta dalla parte di coloro che sfruttano il terzo mondo, giacchè acquista e vive grazie al benessere acquisito sulle spalle dei Paesi poveri. Ne consegue un progressivo depotenziamento della spinta rivoluzionaria del proletariato europeo, in quanto anch’esso siede al tavolo degli sfruttatori del “mondo civile”, pur accontentandosi delle sole briciole. Dunque la carica rivoluzionaria in ambito europeo si è attenuata nella misura in cui i proletari prendono parte alla spartizione dei beni del terzo mondo, sentendosi appagati e dimenticandosi della rivoluzione. Naturalmente questo tentativo di difendere il marxismo dall’accusa che, almeno in apparenza, la polarizzazione profetizzata da Marx non c’è stata, spiegando che in realtà c’è stata ma in modo diverso dal previsto, poteva costituire per Popper un fulgido esempio di teoria non scientifica perchè non falsificabile. Infatti, la teoria della polarizzazione è il classico esempio di teoria non falsificabile, poichè si può sempre trovare il modo di rispondere a qualsiasi obiezione le venga mossa. Marx sembra dunque, entro certi limiti, aver sbagliato, anche se egli sapeva benissimo che la società tende sempre a generare nuovi ceti medi: tuttavia, era convinto che il processo ai suoi tempi in atto creasse sì nuovi ceti medi, ma ne smantellasse, in misura notevolmente maggiore, di vecchi, sicchè sarebbero stati più i ceti medi a sparire che non a nascere. E Marx aveva soprattutto in mente i contadini e gli operai, che, di fronte alla tecnologia pulsante delle fabbriche, erano costretti a soccombere e a finire nelle compagini del proletariato. E qui si può effettivamente sostenere che le convinzioni marxiane fossero sbagliate: il ceto medio è cresciuto esponenzialmente; certo, i vecchi ceti medi sono, per lo più, spariti, ma quelli nuovi sono cresciuti in modo ragguardevole, contro ogni aspettativa marxiana. L’errore di Marx nasce dal fatto che egli, nella foga del suo materialismo storico, ha finito per dare troppo peso all’economia (che infatti spingeva verso la scomparsa dei piccoli borghesi) e non ha preventivato che la politica potesse frenare l’inarrestabile crisi dei ceti medi: e infatti nel Novecento, soprattutto negli anni successivi alla grande crisi del ’29, saranno sempre più frequenti le scelte politiche che tenderanno ad evitare il decadimento dei ceti medi; il fascismo e il nazismo, ad esempio, faranno di tutto per salvarli, proprio perché ne erano espressione politica. La politica prevalente negli anni ’30 del Novecento sarà dunque, in generale, volta a mantenere in vita i ceti medi perché essi costituivano un irrinunciabile serbatoio di consensi. Detto questo, passiamo ad esaminare il metodo di indagine marxiano della realtà: ridotto all’osso, esso consiste nel partire dal concreto e, passando per l’astratto, tornare al concreto ; vale a dire che le categorie interpretative da applicare alla realtà devono essere desunte dalla realtà stessa, rifiutando in tal modo l’elaborazione di categorie astratte entro le quali ingabbiare la realtà. Si parte dunque dal concreto della realtà, se ne desumono le categorie astratte di interpretazione e ci si reimmerge nella realtà concreta per interpretarla tramite quelle categorie. Ed è seguendo questa logica che Marx si addentra nello studio della realtà economica, studio che trova la sua massima espressione in Il capitale . In tale opera, l’economia viene sapientemente coniugata con la dialettica hegeliana, tant’è che Lenin potè affermare che ” non si può comprendere perfettamente il Capitale se non si è compresa e studiata attentamente tutta la logica di Hegel. Di conseguenza, mezzo secolo dopo nessun marxista ha compreso Marx “. Sullo sfondo delle riflessioni marxiane troviamo il pensiero degli economisti politici classici, in primis Simith. E Marx si avvale dei concetti elaborati dall’economia politica classica in modo originale, servendosi della dialettica hegeliana: gli economisti inglesi hanno magistralmente ravvisato le leggi di funzionamento del capitalismo, convinti che il capitalismo sia la forma naturale (e dunque giusta) di economia: come a dire che l’economia, lasciata a sè stessa, segue necessariamente le leggi capitalistiche; tale forma naturale di economia, dicevano gli economisti, è stata tenuta a freno, nel corso della storia, da fenomeni giuridici e solo oggi, nella società liberale, può emergere liberamente nella sua purezza . Ma Marx fa, hegelianamente, notare che tali leggi, oltre a far funzionare il capitalismo, fanno anche sì che esso venga superato dialetticamente, in quanto ne fanno emergere le contraddizioni insanabili (prima tra tutti quella della concorrenza). Perché, allora, gli economisti inglesi non sono arrivati a capire ciò che Marx ha colto, ovvero che il capitalismo sarà superato? Marx risponde che, poiché la coscienza è riflesso della vita, è evidente che tali pensatori, maturati in un contesto tipicamente borghese, elaborino tesi filo-borghesi; la loro è un’ ideologia , ovvero una falsa coscienza della realtà e Marx contrappone l’ideologia (ovvero l’interpretazione della realtà in modo non corrispondente alla verità, ma funzionale al dominio di una classe) alla scienza, che è invece interpretazione vera della realtà così come essa è effettivamente. Certo, non è che gli economisti inglesi abbiano voluto imbrogliare la gente propugnando la “bontà” del capitalismo; è il fatto stesso di vivere in quel contesto che li ha indotti e anzi li ha costretti a vedere la realtà come borghese, impedendo loro di scorgere le contraddizioni e l’ingiustizia tipiche di essa. In altre parole, la loro stessa vita borghese ne influenza in modo necessario la coscienza. Hegel stesso, dice Marx, fa poggiare la dialettica sulla testa (ovvero sulle idee) perché nel contesto in cui è vissuto il lavoro intellettuale era nettamente disgiunto da quello manuale ed Hegel, vivendo solo di idee, non poteva non credere che tutto dipendesse da esse. Sorge spontaneo chiedersi: e a che titolo Marx può bollare le teorie altrui come “ideologie” e riconoscere solo la propria come scienza? La questione si risolve tenendo presente che la società capitalistica, nella prospettiva marxiana, è sbagliata e ingiusta, quindi capovolta; e se la società in cui viviamo è capovolta, in essa sta a proprio agio la borghesia capitalistica, che ha solo da guadagnarci; il proletariato, dal canto suo, è in essa un pesce fuor d’acqua, sicchè è capovolto in una società capovolta e, pertanto, chi è capovolto in una società capovolta sta dritto; in altri termini, chi (il proletariato) vede le ingiustizie della società ingiusta, allora vede le cose come effettivamente sono. Ma il proletariato, da solo, non è in grado di produrre quelle teorie comuniste che pure ne rispecchiano le posizioni; ecco che, proprio in virtù della polarizzazione della società, fette consistenti della borghesia vengono respinte verso il basso, ovvero verso il proletariato, e questo fenomeno fornisce al proletariato stesso i quadri concettuali, dal momento che i borghesi piombati nel proletariato sono in grado di formulare teorie avanzate in difesa del proletariato stesso (di cui sono entrati a far parte). Sono, dunque, questi frammenti della borghesia che, scacciati dall’alto della borghesia o sganciatisi per loro volontà in quanto in disaccordo con le idee capitalistiche, che elaborano le idee di liberazione del proletariato. Soffermando la nostra attenzione sul Capitale , è bene notare come il titolo dell’opera suggerisca che Marx non intende studiare le posizioni individuali e soggettive dei singoli capitalisti, ma, al contrario, come oggettivamente agisca questo demone capitalistico che infesta la società: l’analisi marxiana prende il via dal concetto basilare di merce ( “ La ricchezza delle società nelle quali predomina il modo di produzione capitalistico si presenta come una immane raccolta di merci e la merce singola si presenta come sua forma elementare. Perciò la nostra indagine comincia con l’analisi della merce. “ egli dice in apertura dell’opera) . La merce ha due caratteristiche fondamentali: soddisfa determinati bisogni e ha un suo determinato valore. Sul fatto che soddisfi bisogni e su quali siano tali bisogni, Marx scrive: “ La merce è in primo luogo un oggetto esterno, una cosa che mediante le sue qualità soddisfa bisogni umani di un qualsiasi tipo. La natura di questi bisogni, p. es. il fatto che essi provengano dallo stomaco o che provengano dalla fantasia, non cambia nulla “ Merce è, in generale, qualcosa che viene scambiato, ovvero che si compra e si vende poiché è in grado di soddisfare bisogni, ossia non è inutile. Tuttavia, il fatto che soddisfi bisogni non basta a qualificare un oggetto come merce: ad esempio, l’aria soddisfa un bisogno fondamentale, ma ciononostante non ha un valore monetario, non è merce. Perché l’oggetto in questione sia merce deve, in altri termini, soddisfare bisogni e, al contempo, avere un valore (mancante nel caso dell’aria). A questo punto, Marx introduce un gioco di qualità e quantità che riecheggia la dialettica hegeliana: le merci si scambiano tra loro e anche il denaro, di per sé, serve a favorire gli scambi tra merci; infatti, se io produttore di patate ho bisogno di scarpe, non è detto che il produttore di scarpe abbia anch’egli, in quel momento, bisogno di patate e dunque potrebbe non accettare lo scambio merci; con il denaro, invece, io ho subito le scarpe ed egli può acquistare, quando gli fa comodo, le patate. Ma perché due merci possano essere scambiate devono essere uguali e contrarie, più precisamente, uguali quantitativamente ma diverse qualitativamente: diverse qualitativamente, perché nessuno scambierebbe mai delle patate con delle altre patate (si scambiano sempre merci tra loro diverse), ma uguali quantitativamente perché, per effettuare lo scambio, si deve essere d’accordo sul fatto che il valore delle due merci sia uguale. Si tratta dunque di capire che cosa ci possa essere di uguale tra due merci tanto diverse quali possono essere le patate e le scarpe: di uguale vi è, dice Marx, il lavoro necessario per produrle, ovvero il lavoro cristallizzato in esse; si tratta di lavori qualitativamente diversi, è vero, ma quantitativamente uguali, nel senso che ci si mette lo stesso tempo per realizzarli. Pertanto, una merce vale in relazione al tempo impiegato per produrla; per riprendere l’esempio dell’aria, non è una merce perché, pur appagando dei bisogni, in essa non è cristallizzato alcun lavoro. Marx, poi, sottolinea come prezzo e valore siano due concetti diversi, poiché i prezzi possono oscillare (a seconda della maggiore o minore richiesta sul mercato) intorno al valore effettivo della merce, valore che, come abbiamo visto, è il lavoro cristallizzato in quella merce; le oscillazioni dei prezzi, in realtà, sono contingenti rispetto al valore intrinseco ed immutato della merce. Addentrandoci nella terminologia marxiana, viene definito valore di scambio quell’elemento di lavoro utilizzato per realizzare la merce, mentre è designato col nome di valore d’uso il fatto che serva per soddisfare bisogni (“ L’utilità di una cosa ne fa un valore d’uso. Ma questa utilità non aleggia nell’aria. E’ un portato delle qualità del corpo della merce e non esiste senza di esso “ ). L’aria ha un valore d’uso immenso, ma è del tutto priva di valore di scambio. Si può notare come il valore d’uso sia un concetto relativo, che varia da persona a persona: una merce può soddisfarmi bisogni che ad un altro non soddisferebbe, ad esempio bisogni spirituali o estetici. Ad esempio, il diamante ha senz’ombra di dubbio un valore d’uso nettamente inferiore rispetto a quello dell’acqua, ma il suo valore di scambio è incommensurabilmente superiore, per cui costa molto di più. Da notare, anche, che quando Marx parla di “ tempo di lavoro”, alludendo al fatto che più ore di lavoro ci sono in un oggetto e maggiore è il suo valore, si riferisce al tempo socialmente necessario in media: non vuol dire, infatti, che il prodotto dell’operaio pigro, realizzato in dieci ore, vale di più di quello dell’operaio solerte, portato a termine in un’ora, perché vi è cristallizzato più lavoro; al contrario, Marx allude al tempo necessario in media in quella determinata società. E il valore varia da società a società: se una società ci impiega più tempo, in essa la merce avrà un valore maggiore rispetto ad un’altra società in cui viene prodotta in minor tempo. Entrando nello specifico, nella società capitalistica impera la trasformazione della forza-lavoro in merce: nei sistemi pre-capitalistici, ad esempio nell’era medioevale, la terra e il lavoro non erano merci, poiché vincolati da legami giuridici che ne impedivano il libero scambio; nella società di stampo capitalistico, invece, dove il lavoro è “libero”, il datore di lavoro è libero di assumere un operaio, ma quest’ultimo, invece, non è libero di effettuare una scelta; o meglio, è libero di scegliere se accettare quel lavoro o morir di fame, ma non è una scelta definibile come libera. Si tratta ora di analizzare il funzionamento dello sfruttamento nei sistemi capitalistici: già nei Manoscritti Marx ha chiarito il concetto di alienazione, spiegando come il proletario che vende la sua forza-lavoro venda anche il frutto del proprio lavoro (che gli viene brutalmente strappato); ora Marx porta avanti il ragionamento e dice che nell’ambito di un lavoro non-alienato, il prodotto del lavoro sarebbe estrinsecazione in positivo dell’essenza umana, ma in una condizione alienata di tipo capitalistico l’oggetto del lavoro tende a diventare ostile nei confronti del lavoratore stesso, gli si presenta addirittura come simbolo della sua oppressione, quasi come se il proletario catapultasse fuori di sé se stesso nell’oggetto prodotto, che gli si presenta pertanto come un qualcosa di autonomo e di divinizzato (proprio come il Dio di Feuerbach); e così la merce diventa un feticcio ( feticismo delle merci ), ovvero è divinizzata, l’operaio non la vede più come una sua produzione, ma come un qualcosa di estraneo. In termini meno mistici, lo sfruttamento avviene perché l’operaio produce ma il prodotto del suo lavoro gli viene strappato, diceva Marx nei Manoscritti ; ora il discorso è più profondo e più strettamente economico: il perno dello sfruttamento è che la forza-lavoro è diventata una merce, e da un lato è una merce come tutte le altre, ovvero si compra e si vende ad un valore determinato dal lavoro cristallizzato in essa; dall’altro lato, è diversa da ogni altra merce perché è in grado di produrre, a sua volta, lavoro e, con esso, valore. Tutte le altre merci (il cibo, ad esempio), infatti, son fatte per essere consumate nel soddisfacimento di bisogni; la forza-lavoro, invece, si consuma anch’essa, ovvero le forze dell’operaio si “scaricano” nelle otto ore di lavoro in fabbrica, ma nel consumarsi producono valore. Quale è, dunque, il valore della forza-lavoro? A che prezzo viene retribuita? I socialisti di allora (nonché il Marx dei Manoscritti ) sostenevano che il lavoratore produce un oggetto che gli viene sottratto in cambio di un salario inferiore rispetto all’oggetto prodotto, altrimenti non potrebbe esserci il profitto per il capitalista: quest’ultimo, si diceva, gli pagherà il lavoro 50 e venderà il prodotto di tale lavoro a 100, commettendo un vero e proprio furto ai danni dell’operaio. Il problema, dice ora Marx, è che, se accettiamo la logica capitalistica, questo non è ingiusto né è un furto, poiché il valore della forza-lavoro non può essere uguale al valore della merce prodotta: se infatti il lavoro è merce, allora non è corretto attribuire ad essa il valore delle merci che produce, ma le si dovrà attribuire il valore in essa cristallizzato. In altri termini, come per tutte le merci, anche per produrre la forza-lavoro è stato necessario lavorare e la vita stessa del lavoratore altro non è se non un caricare continuo la sua forza-lavoro per far sì che egli produca ancora; e per caricare la forza-lavoro occorrerà darle da mangiare, da bere e, in generale, da vivere, tutte cose che hanno un valore (il cibo, le bevande, ecc) e quindi, indirettamente, la forza-lavoro è essa stessa prodotta da una quantità di lavoro (il cibo, le bevande) e dunque il valore della forza-lavoro sarà dato dal valore delle merci che l’operaio consuma per sopravvivere, non dal valore delle merci che egli produce. Naturalmente, non rientrano nelle merci che il capitalista deve dare all’operaio per sopravvivere i bisogni di piacere, mentre invece rientrano i mezzi per il sostentamento della prole necessaria per il ricambio della forza-lavoro e che contraddistingue il proletario (così chiamato proprio perché tutto ciò che possiede, accanto alla propria forza-lavoro, è la prole). E lo sfruttamento avviene proprio in quest’ottica: il lavoratore lavora per dieci ore della giornata, ma quante gliene vengono retribuite? Supponendo che 1 sia il valore di un’ora lavorativa, l’operaio che lavora 10 ore produce un valore 10, ma in busta paga non si trova il valore che egli ha prodotto (10), bensì si trova solo quanto è necessario per mantenerlo in vita, ovvero per mantenere la forza-lavoro, per far sì che mangi e viva, non in base al valore che produce, ma in base al lavoro che serve per conservarlo in vita. Supponendo che tale valore di sussistenza sia 5, il lavoratore è pagato 5 ma produce 10, dunque le prime 5 ore di lavoro gli vengono retribuite, mentre le restanti 5 sono un lavoro in più che non gli è pagato: tale lavoro in più è, nella terminologia marxiana, un pluslavoro che genera un plusvalore e quest’ultimo va nelle tasche del capitalista sotto forma di profitto. Infatti, egli paga solo 5 delle 10 ore lavorative all’operaio, sicchè si trova in tasca 5 ore di lavoro regalate, a cui però dobbiamo sottrarre qualcosa per le materie prime e i macchinari che egli acquista; di tale profitto, infatti, una parte gli serve per vivere, un’altra per effettuare investimenti, come ad esempio l’acquisto di macchine sempre più sofisticate e di mille altre cose che gli servono per non soccombere al turbine della concorrenza. E in questo quadro si realizza il tipico meccanismo del profitto: investe denaro (D) per comprare “fattori di produzione” (forza-lavoro, macchinari, materie prime), ottiene una merce (M) come risultato e la rivende ad un prezzo maggiore (D1), trovandosi così in tasca più denaro di quanto ne avesse in partenza ed avendo dunque un profitto (D1 – D = P):
D-M-D1
E il profitto, ovviamente, deriva da un meccanismo in cui l’operaio viene sfruttato; infatti, se da un certo punto di vista è giusto pagare il lavoratore in tal modo, giacchè il prezzo della forza-lavoro è necessariamente quello, da un altro punto di vista è un’azione ingiusta, poiché la forza-lavoro produce 10 e andrebbe retribuita 10. Se nel 2° caso si bada al lato umano, ovvero al porre nel prodotto parte di sé, nel 1° caso, invece, si guarda ad una forza lavoro “reificata”, ovvero diventata una cosa puramente materiale, senza nulla di umano. Dunque, riassumendo, la domanda “dove nasce il capitale?” può essere letta come “dove nasce lo sfruttamento?” , visto che il capitale affonda le sue radici nello sfruttamento dell’operaio da parte del capitalista, e la risposta, in breve, che Marx dà nel Capitale è la seguente: ” prendiamo l’esempio del nostro filatore. Per ricostruire ogni giorno la sua forza-lavoro, egli deve produrre un valore giornaliero di tre scellini, cosa che egli fa lavorando sei ore al giorno. Pagando il valore giornaliero o settimanale della forza-lavoro del filatore, il capitalista ha acquistato il diritto di usare questa forza-lavoro per tutto il giorno o per tutta la settimana. Perciò egli lo farà lavorare, supponiamo, dodici ore al giorno. Oltre le sei ore che gli sono necessarie per produrre l’equivalente del suo salario, cioè del valore della sua forza lavoro, il filatore dovrà, dunque, lavorare altre sei ore, che io chiamerò ore di pluslavoro e questo sopralavoro si incorporerà in un plusvalore e in un sopraprodotto. ” Detto questo, Marx analizza dettagliatamente i meccanismi di contraddizione che porteranno inevitabilmente al superamento del capitalismo: in primis, il fatto stesso che la produzione si configuri come sempre più cooperativistica ma i meccanismi di redistribuzione delle ricchezze che ne derivano siano destinati a sempre meno uomini è un elemento che non può non portare all’inceppamento e al superamento del sistema. Anche la crescente polarizzazione della società spinge in quella direzione: e Marx nota, con un’analisi lucida e brillante, che borghesia e proletariato si generano a vicenda (il capitalismo genera il proletariato e il proletariato genera il capitale) ma si disintegrano anche a vicenda (la borghesia annulla il proletariato sfruttandolo e il proletariato spazza via la borghesia facendo la rivoluzione); e quando uno dei due poli della contrapposizione sparisce, anche l’altro si sgretola, per cui il proletariato, annientando la borghesia attraverso la rivoluzione, annulla anche se stesso e, pertanto, il comunismo sarà caratterizzato dall’assenza di classi e dall’assenza dello strumento del dominio di classe (lo Stato). Altra contraddizione insuperabile destinata a far crollare il sistema capitalistico consiste nel fatto che la concorrenza, ossigeno del capitalismo, tende essa stessa a negarsi, per i motivi evidenziati in precedenza. Fatta questa carrellata di contraddizioni del sistema capitalistico, Marx dà il meglio di sé nell’individuazione della contraddizione capitalistica forse più tipica della filosofia marxista: la legge della caduta tendenziale del saggio di profitto , dove il saggio di profitto è il rapporto tra il capitale investito e il profitto ricavato, e risponde essenzialmente alla domanda “quanto profitto ottengo con quel dato investimento?” . Quando si investe il capitale, nota Marx, lo si investe in parte in capitale costante (macchinari, che restano invariati nel tempo e dunque vengono pagati una volta per tutte) e in parte in capitale variabile (salari, che variano nel tempo). Nella somma totale del capitale investito (variabile + costante) può prevalere, a seconda dei casi, il capitale costante o quello variabile e il rapporto percentuale tra i due tipi di capitale prende il nome di composizione organica del capitale . Solitamente, però, la variazione avviene in favore del capitale costante, poiché nel tempo la meccanizzazione aumenta sempre più; tale capitale costante, dunque, sarà sempre maggiore, mentre quello variabile sarà sempre minore. Ma il meccanismo dello sfruttamento, come abbiamo visto, si verifica nell’ambito del salario, ovvero del capitale variabile, dal momento che l’operaio, invece di essere retribuito in base a quel che produce, riceve uno stipendio che gli permetta di sopravvivere. E dire che lo sfruttamento dell’operaio avviene nell’ambito del capitale variabile equivale naturalmente a dire che il profitto per il capitalista si realizza nel capitale variabile, che però ogni giorno che passa perde terreno rispetto al capitale costante. In altre parole, più passa il tempo e più scende il capitale variabile cristallizzato nella produzione di x, con la conseguenza che anche il profitto del capitalista cala in continuazione. Se però il profitto tende a calare di continuo perché cala il capitale variabile, è anche vero che è in atto una controtendenza: con la meccanizzazione, infatti, la produttività cresce sempre di più, per cui è vero che avrò sempre meno capitale variabile, ma è altrettanto vero che il profitto che ne verrà fuori sarà sempre maggiore in virtù della produttività accresciuta grazie alle macchine. Se prima avevo bisogno di 10 lavoratori da sfruttare, con le macchine me ne servono solo più 5 e dunque ne tirerò fuori un plusvalore che non sarà più 10, ma 5. Tuttavia, in virtù della meccanizzazione che fa crescere vertiginosamente la produttività, non pagherò più a ciascun operaio 5, ma solo 3, perchè occorrono meno soldi di prima per mantenerlo in vita; l’operaio produce sempre di più, ma viene retribuito sempre meno, in quanto il suo salario dipende non da ciò che egli produce, ma da quanto costa ciò che serve per mantenerlo in vita (e con le macchine costa sempre meno) . Infatti, grazie alle macchine, non accade più che l’operaio lavori 7 ore per sé e 3 ore le regali al padrone; al contrario, al lavoratore (che si trova a produrre più ricchezza) il capitalista pagherà 5 ore per sé e 5 se le terrà come “regalo”. Riassumendo, se la tendenza spinge verso la diminuzione della base di sfruttamento e dunque verso la riduzione del profitto, al contrario la controtendenza spinge verso una sempre maggiore intensità dello sfruttamento, giacchè il singolo operaio è sfruttato sempre di più. Però, dice Marx, la tendenza prevale sulla controtendenza: la diminuzione del saggio di profitto prevale sull’intensità di sfruttamento e, dunque, esiste una legge tendenziale della caduta del saggio di profitto, ovvero in proporzione al capitale investito il profitto ricavato è sempre minore; si tratta di una caduta “tendenziale” e non repentina perché è rallentata dalla controtendenza, ovvero dall’aumentare dell’intensità dello sfruttamento. Infatti, se di per sé il calo di profitto porterebbe immediatamente alla caduta, a frenarla e dilazionarla nel tempo è il sempre maggiore sfruttamento che il capitalista fa dei singoli operai. Tutto questo ragionamento porta Marx a concludere che il capitalismo si sta esaurendo, poiché gli sta venendo gradualmente a mancare il suo ingrediente portante: il profitto. E caduto il capitalismo, grazie alla rivoluzione finale, fiorirà il socialismo, nella cui descrizione Marx non si sbilancia troppo, visto che, hegelianamente, la ragione può solo tratteggiare ciò che è stato o, tutt’al più, ciò che è. Una cosa è però certa: il socialismo sarà agli antipodi del capitalismo, dal momento che si pone come superamento di esso. La produzione della ricchezza, per dirne una, sarà messa in comune e non si addenserà nelle mani di pochi; la proprietà dei mezzi di produzione verrà abolita, in quanto sta alla base dello sfruttamento e della lotta di classe (la distinzione tra borghesi e proletari risiede appunto nel possesso o meno dei mezzi di produzione).; certo Marx non ipotizza una collettività di ogni cosa (come invece aveva fatto Platone), per cui verrebbe a sciogliersi ogni forma di proprietà e si tornerebbe al comunismo primitivo. Conquistato lo Stato, il proletariato deve instaurare la propria dittatura ed espropriare ai borghesi i mezzi di produzione, facendo così venir meno la borghesia come classe e dunque la distinzione tra proletari e borghesi, tipica della società moderna. E venuta meno la distinzione in classe, anche la dittatura del proletariato si sgretolerà e con ciò lo Stato si avvierà al tramonto, cedendo il passo all’anarchia. Pesanti sono sempre state le critiche di dittatura mosse al marxismo: ciò perde di significato se teniamo presente che per Marx ogni forma di governo è una dittatura, in quanto ogni forma di governo è la dittatura di una determinata classe che si trova al potere; la stessa democrazia di stampo borghese è una dittatura, più precisamente è la dittatura ordita dalla borghesia. Non c’è dunque da stupirsi se anche il proletariato instaurerà una propria dittatura, tanto più se consideriamo che essa è destinata a dissolversi: si può poi notare (e ci penserà soprattutto Lenin a farlo) come, a differenza delle altre, la dittatura del proletariato non può neanche, propriamente, essere bollata come dittatura, poiché è una “dittatura” in favore della stragrande maggioranza degli uomini. In uno dei pochi passi in cui Marx si sofferma a delineare la futura società socialistica, egli vagheggia una forma di democrazia diretta, sul modello di quella che verrà attuata con i Soviet nella Rivoluzione Russa (Marx aveva in mente la comune di Parigi). Una delle altre contestazioni mosse al marxismo è di non rispettare la libertà umana: infatti, sostenendo che è la vita a determinare la coscienza, ovvero che il comportamento umano è influenzato dalle condizioni materiali e che, luteranamente, l’arbitrio dell’uomo è servo, viene meno la libertà umana. In realtà, è bene ricordare come per Marx la storia che arriva fino all’epoca del capitalismo non è la vera storia, ma è una sorta di lunga preistoria in cui l’uomo è stato soggetto alle forze economiche senza riuscire a dominarle ( il feticismo delle merci ne è la più fulgida espressione: il prodotto si erge a dominare l’operaio); una volta che questa fase verrà superata, anche il rigido materialismo potrà in qualche misura risultare sorpassato e sarà, finalmente, l’uomo a dominare l’economia (e non viceversa). Oggetto di aspre critiche sono anche state le connotazioni eccessivamente utopistiche del marxismo: Marx stesso ha condotto un’analisi impeccabile del capitalismo, ma di per sé non era affatto convinto che la meccanizzazione tipica del sistema capitalistico fosse un male; anzi, essa, avulsa dal contesto dello sfruttamento capitalistico, è un gran vantaggio e non solo perché produce tanto accontentandosi di poco, ma anche perché conduce all’interscambiabilità dei mestieri. Infatti, poiché la macchina fa tutto, ciascuno può cambiare continuamente attività senza annoiarsi mai. Tuttavia, questo non è mai avvenuto nella pratica: e del resto Marx stesso si trova in imbarazzo quando deve descrivere la poliedricità dell’uomo nella società moderna, tant’è che ricorre sempre ad esempi arcadici e molto poco moderni (pescare di mattina e cacciare di pomeriggio). Con l’avvento della nuova società, pertanto, si espanderà il dominio dell’uomo sulla natura (e cesserà quello dell’uomo sull’uomo): con l’estinguersi dello Stato, inoltre, sparisce anche la politica come gioco della lotta di classe e si passa al regno dell’anarchia, in cui manca lo Stato, ma non il governo; è infatti impensabile una società in cui ciascuno faccia ciò che gli pare, tanto più che anche solo per produrre del cibo che possa sfamare i componenti di tale società è necessario prendere decisioni. Tuttavia, esse non saranno decisioni politiche, poichè la politica implicherebbe un confronto di interessi diversi a seconda della classe sociale in questione (cosa impossibile in una società senza classi), ma, al contrario, non saranno a favore di certi gruppi sociali e a discapito di altri, bensì saranno decisioni meramente tecniche, alla stregua di quelle che vengono prese nelle aziende, in vista non di una classe sociale ma del funzionamento ottimale dell’azienda stessa. Si tratterà, in altri termini, di scelte collettive volte al bene della collettività stessa: ne consegue che dall’amministrazione politica si passa a quella tecnica. Occorre poi ricordare che nel dibattito sviluppatosi in seguito alla morte di Marx si è sempre stati più propensi a distinguere due diverse fasi in quella che sarà la futura società postcapitalistica: in un passo della Critica al programma di Gotha , infatti, Marx fa notare che, crollato il capitalismo, vi sarà una prima fase di “socialismo” seguita da una seconda fase di “comunismo”; nella fase del “socialismo” vigerà il motto ” a ciascuno secondo il suo lavoro “, ovvero, ridotto all’osso, il socialismo che scaturirà nell’immediato post-capitalismo realizzerà ciò che il sistema capitalistico si era sempre proposto di fare senza però mai riuscirci: ciascuno prenderà in base a quanto avrà effettivamente lavorato; non come nel sistema capitalistico, dove all’operaio che produce 10 viene dato in busta paga 3. Il socialismo della prima fase si configurerà dunque come piena realizzazione di quella meritocrazia per cui ciascuno guadagna in base a quanto produce; meritocrazia che nel capitalismo era esaltata ma, con immensa ipocrisia, non veniva applicata. Naturalmente poi una società, per essere davvero socialista, dovrà comunque soddisfare i bisogni elementari di tutti, indipendentemente dal lavoro compiuto da ciascuno, ma ciò non toglie che il merito dei singoli verrà premiato secondo giustizia; ecco dunque che per Marx la società non deve essere egualitaria, ma giusta e una società in cui tutti prendessero le stesse cose pur producendo chi più e chi meno sarebbe ingiusta. Questa prima fase in cui imperererà il socialismo verrà superata da quella del “comunismo”, il cui motto sarà ” ciascuno secondo le sue capacità, a ciascuno secondo i suoi bisogni “: in tale società ciascuno dà per quello che può e riceve in base a ciò di cui ha bisogno, il che implica che una persona possa ricevere di meno rispetto a ciò che produce. Se nel socialismo si dava a seconda dei meriti, nel comunismo, invece, si dà a seconda dei bisogni, ma, ciononostante, neanche quella comunistica è una società egualitaria, poichè, essendo intesa la ricchezza come un bene comune, ciascuno darà alla società il proprio massimo, sapendo che a sua volta la società gli darà tutto ciò di cui ha bisogno. Ci sarà chi darà di più e chi darà di meno, ma ciascuno riceverà non in proporzione a ciò che ha dato (come avveniva nel socialismo), ma in proporzione a ciò di cui ha bisogno. Viene però spontaneo chiedersi che cosa può mai indurre una persona ad essere disponibile a dare di più di quel che poi riceve: la risposta sta nel fatto che la nuova società sarà senza classi e, pertanto, l’interesse dei singoli o delle parti sarà indisgiungibile da quello della collettività. Altra domanda che potrebbe sorgere spontanea: perchè mai Marx suddivide la società futura in due tappe, socialismo e comunismo? In realtà è il suo stesso materialismo storico a spingerlo in quella direzione: dopo anni e anni che si è vissuti nella società borghese, è evidente che le coscienze di tutti (operai compresi) ne saranno influenzati, quasi come se avessero assimilato in cuor loro il sistema capitalistico e la sua concezione di fondo secondo cui a ciascuno bisogno dare a seconda dei meriti. Sarebbe dunque troppo brusco il passaggio diretto al comunismo, dove non si dà più in base ai meriti, ma in base ai bisogni: ecco allora che Marx pone come tappa centrale il socialismo, che del capitalismo mantiene i princìpi (a ciascuno secondo i suoi meriti) e anzi li realizza concretamente; solo con il passare degli anni potrà sempre più affermarsi, gradualmente, il comunismo, basato sulla piena solidarietà. Ovviamente sono state innumerevoli le critiche e le obiezioni mosse alla concezione marxiana: al di là dell’obiezione secondo la quale è impossibile che l’uomo cessi di badare, egoisticamente, al proprio interesse (obiezione alla quale Marx rispondeva fieramente che l’uomo di cui stava parlando era l’uomo del futuro), si è criticato il fatto che Marx, come tutti i pionieri che scoprono qualcosa di importante, finisce per dare alla sua scoperta più peso di quel che in realtà ne avesse. La grande scoperta marxiana in questione consiste nell’aver colto l’importanza dell’economia per capire la storia (merito riconosciutogli perfino da un liberale moderato come Croce), ma tuttavia Marx si è lasciato troppo prendere dalla sua scoperta e non si è accorto che il comportamento umano non è solamente governato da fattori economici. Marxianamente, infatti, la gelosia (ed in generale tutti gli altri sentimenti) deve essere letta in senso economico, riconducendosi all’idea che il matrimonio sia un contratto e che dunque il tenere legato a sè il coniuge rientri nella sfera economica; però pensare che tutti i sentimenti siano riconducibili ad un livello economico è, francamente, molto riduttivo, come ha fatto notare Freud; ed è anche molto riduttivo pensare che l’eliminazione dei conflitti economici, avvenuta grazie all’abolizione delle classi, porti all’eliminazione di ogni tipo di conflitto. Quando Marx muore, nel 1883, a portare avanti il discorso filosofico è Engels, il quale, però, dà ad esso nuove sfumature: Engels, riconosciuto da molti come ingegno meno vivace rispetto a Marx, nutre maggior interesse per le scienze della natura rispetto al compagno ormai scomparso. Tali scienze, infatti, sono agli occhi di Engels un modello di scientificità universale ed è dunque necessario dedicarsi allo studio di esse se si vuole dare al marxismo una veste scientifica (cosa che gli interessa più di quanto interessasse a Marx stesso). Queste riflessioni sullo sfondo, portano Engels ad interessarsi particolarmente alle dottrine evoluzionistiche (soprattutto darwiniane) che andavano sviluppandosi in quegli anni. L’idea stessa di trasformazione proposta dall’evoluzionismo a livello della natura pare ad Engels molto prossima alla trasformazione su cui si concentra, a livello di storia, il marxismo: per di più, l’evoluzionismo presenta un rapporto dialettico per cui l’animale è continuamente modificato dal confronto con l’ambiente circostante. Tuttavia vi è una forte differenza (non colta da Engels) tra marxismo ed evoluzionismo: infatti, essi ipotizzano due forme diverse di trasformazione della realtà; la trasformazione tratteggiata dall’evoluzionismo è graduale e unidirezionale, un qualcosa di simile all’idea di progresso storico che avevano gli illuministi. La trasformazione della realtà ravvisata dal marxismo, invece, è quella dialettica, in cui si supera, ovvero si toglie e si ripropone ad un livello più alto. Quest’osservazione, contrariamente a ciò che si potrebbe pensare, non è marginale ma, al contrario, ha un suo peso politico: se infatti si prende a modello l’evoluzionismo darwiniano, si finisce per accettare, anche inconsapevolmente, l’idea del progresso gradualistico e, non a caso, Engels è considerato il padre del “revisionismo”, ovvero di quella corrente politica che tende ad eliminare dal socialismo la fase rivoluzionaria. In realtà, Engels è del parere che, in ultima istanza, una spallata rivoluzionaria al capitalismo andrà assestata, tuttavia tende ad insistere sempre più sul fatto che a contare per davvero non è la rivoluzione, ma la prassi democratica volta al miglioramento progressivo della società e destinata a far crollare il capitalismo, concepito quasi come un muro vacillante a cui basta dare un pugno finale per farlo franare. E’ evidente che in una concezione del genere si afferma sempre di più il riformismo che sarà tipico della Socialdemocrazia tedesca e che prevede che non si debba scendere in piazza a fare rivoluzioni ma, al contrario, che si debba lavorare riformando la società in senso democratico. La distinzione tra socialisti e comunisti nascerà proprio su questi presupposti: per i comunisti bisogna abbattere con la rivoluzione il sistema capitalistico, per i socialisti invece si tratta di renderlo più vivibile. Non c’è dunque da stupirsi che Engels arrivi ad elaborare una dialettica della natura : egli infatti è convinto, da buon hegeliano, che non solo la storia, ma anche la natura sia permeata dalla dialettica; Marx non si era mai sognato di fondare una dialettica della natura, anche perchè sapeva benissimo che essa, già nel sistema hegeliano, era il punto debole, una sorta di tallone d’Achille. Engels invece si lascia trasportare in questo progetto, che gli costerà molte critiche; e, non a caso, il materialismo dialettico sarà la dottrina ufficiale dei Sovietici (da loro ribattezzata col nome di “diamat”), i quali tenderanno ad ingabbiare perfino la conoscenza scientifica nella dialettica della natura. In conclusione, bisogna riconoscere ad Engels il merito, oltre a quello di aver mantenuto Marx, di aver analizzato in profondità le tre leggi dialettiche che reggono la natura: 1) la conversione della quantità in qualità e viceversa , con cui Engels intende dire che certi processi quantitativi tendono irresistibilmente a trasformarsi in qualitativi (il capitalismo, ad esempio, oltre a mutare la quantità di produzione muta anche la qualità della società); 2)la compenetrazione degli opposti, per cui in una totalità a un elemento se ne trova opposto un altro che lo implica ed é, a sua volta, implicato dal primo: ; 3) la negazione della negazione, per cui ogni realtà é negata per dar luogo ad una formazione più alta.
La religione, oppio del popolo
Dopo il Giudizio Universale Dio incontra Carlo Marx: ” Ah, tu sei quello che mi ha dato tutte quelle preoccupazioni nel XX secolo. Visto che hai sempre detto che io non ci sono, sarai condannato a farmi da portinaio. E quando non vorro’ essere disturbato sei autorizzato a dire: Dio non c’e’ “. (Roberto Benigni)
Il fondamento della critica alla religione é: è l’uomo che fa la religione, e non è la religione che fa l’uomo. Infatti, la religione è la coscienza di sè e il sentimento di sè dell’uomo che non ha ancora conquistato o ha già di nuovo perduto se stesso. Ma l’uomo non è un’entità astratta posta fuori del mondo. L’uomo è il mondo dell’uomo, lo Stato, la società. Questo Stato, questa società producono la religione, una coscienza capovolta del mondo, poiché essi sono un mondo capovolto. La religione è la teoria generale di questo mondo, il suo compendio enciclopedico, la sua logica in forma popolare, il suo punto d’onore spiritualistico, il suo entusiasmo, la sua sanzione morale, il suo solenne completamento, il suo universale fondamento di consolazione e di giustificazione. Essa è la realizzazione fantastica dell’essenza umana, poiché l’essenza umana non possiede una realtà vera. La lotta contro la religione è dunque, mediatamente, la lotta contro quel mondo, del quale la religione è l’aroma spirituale. La religione è il sospiro della creatura oppressa, è l’anima di un mondo senza cuore, di un mondo che è lo spirito di una condizione senza spirito. Essa è l’oppio del popolo. Eliminare la religione in quanto illusoria felicità del popolo vuol dire esigere la felicità reale. L’esigenza di abbandonare le illusioni sulla sua condizione è l’esigenza di abbandonare una condizione che ha bisogno di illusioni. La critica della religione, dunque, è, in germe, la critica della valle di lacrime, di cui la religione è l’aureola. La critica ha strappato dalla catena i fiori immaginari, non perché l’uomo porti la catena spoglia e sconfortante, ma affinché egli getti via la catena e colga i fiori vivi. La critica della religione disinganna l’uomo affinché egli pensi, operi, dia forma alla sua realtà come un uomo disincantato e giunto alla ragione, affinché egli si muova intorno a se stesso e, perciò, intorno al suo sole reale. La religione è soltanto il sole illusorio che si muove intorno all’uomo, fino a che questi non si muove intorno a se stesso. E’ dunque compito della storia, una volta scomparso l’al di la della verità, quello di ristabilire la verità dell’al di qua. E innanzi tutto è compito della filosofia, la quale sta al servizio della storia, una volta smascherata la figura sacra dell’autoestraneazione umana, smascherare l’autoestraneazione nelle sue figure profane. La critica del cielo si trasforma così nella critica della terra, la critica della religione nella critica del diritto, la critica della teologia nella critica della politica. La critica della religione approda alla teoria che l’uomo è per l’uomo l’essere supremo. (MARX, Critica alla filosofia hegeliana del diritto pubblico)
Le considerazioni religiose di Feuerbach si intrecciavano con quelle politiche: egli sottolineava, infatti, il carattere pericolosamente conservatore della religione; in essa, l’uomo tende a diventare schiavo, a sentirsi dipendente da un’entità superiore, e uno schiavo incatenato nel “mondo delle idee” diventa inevitabilmente anche schiavo nella realtà materiale, quasi come se oltre ad essere schiavo di Dio diventasse anche schiavo di un padrone materiale. Ne consegue che la liberazione politica dell’uomo dovrà per Feuerbach passare per l’eliminazione della religione: infatti, solo dopo la scomparsa della religione l’uomo cesserà di essere schiavo di Dio e, successivamente, dei padroni materiali. Diametralmente opposta è la concezione di Marx, secondo la quale ” la religione è l’oppio del popolo ” : secondo Marx, infatti, l’uomo ricorre alla religione perchè materialmente insoddisfatto e trova in essa, quasi come in una droga (“oppio”), una condizione artificiale per poter meglio sopportare la situazione materiale in cui vive. Per Marx, dunque, non è la religione che fa sì che si attui lo sfruttamento sul piano materiale (come invece credeva Feuerbach), ma, al contrario, è lo sfruttamento capitalistico sul piano materiale che fa sì che l’uomo si crei, nella religione, una dimensione materiale migliore, nella quale poter continuare a vivere e a sperare. Ne consegue che se per Feuerbach per far sì che cessi l’oppressione materiale occorre abolire la religione, per Marx, invece, una volta eliminata l’oppressione, crollerà anche la religione, poichè l’uomo non avrà più bisogno di “drogarsi” per far fronte ad una situazione materiale invivibile. Marx ha praticamente dimostrato che l’alienazione che l’operaio della società capitalistica vive e avverte di vivere sul piano economico, trova il suo equivalente sovrastrutturale in quello che accade al credente sul piano religioso. Ovverosia, ” l’operaio si viene a trovare rispetto al prodotto del suo lavoro come rispetto ad un oggetto estraneo “(così nei Manoscritti economico-filosofici). Estraneo appunto perché, pur essendo la merce un suo prodotto, di fatto non gli appartiene, essendo a lui separata giuridicamente la proprietà della fabbrica. Questa alienazione materiale trova il suo riflesso in quella spirituale della religione, la quale recepisce e giustifica, modificando continuamente i suoi contenuti, l’estraniazione materiale del capitalismo. E così, ” quante più cose l’uomo trasferisce in Dio, tanto meno egli ne ritiene in se stesso “. Un legame così esplicito di capitalismo e religione sarà ricorrente in tutta l’opera marxiana, anche se mai sviluppato in maniera analitica. Nel capitalismo, quindi, persino la legge naturale dello sviluppo industriale, che dovrebbe portare direttamente, sul piano spirituale, all’ateismo, diventa motivo di perpetuazione dell’alienazione religiosa. Nel senso che se è vero che ” i miracoli divini diventano superflui a causa dei miracoli dell’industria “, è altresì vero che, col capitalismo, i miracoli dell’industria tornano a vantaggio solo di poche persone proprietarie, mentre al lavoratori non resta che continuare a sperare -come vuole la religione- nei miracoli divini, almeno sino a quando essi non si accorgeranno che ” non gli dèi, non la natura, ma soltanto l’uomo stesso può essere questo potere estraneo al disopra dell’uomo “. Questa è una delle ragioni per cui secondo Marx “la critica della religione” va considerata come “il presupposto di ogni critica”. Cioè l’operaio può iniziare a criticare il capitalismo partendo dalla critica della religione (in questo Marx si mostrava erede di tutti gli studi compiuti in Germania dalla Sinistra hegeliana. Viceversa Lenin non avrà bisogno di questo passaggio intellettualistico, in quanto per lui il capitalismo andava criticato per le proprie contraddizioni interne, e questo allo scopo di organizzarne un superamento di tipo politico. La critica della religione è sempre stata considerata da Lenin un aspetto di secondaria importanza, anche se proprio lui pretendeva da parte del partito una propaganda ateo-scientifica). Marx assegnò all’ateismo un valore di ” presupposto di ogni critica ” perché nei paesi capitalisti qualunque aspetto sovrastrutturale, in aperta contraddizione con quelli strutturali (rivoluzione industriale, macchinismo, dominio della natura, benessere materiale…), si è sempre caratterizzato per il suo stretto legame con l’ideologia religiosa, o comunque con l’illusione di matrice religiosa. Prima del socialismo scientifico ogni morale era di origine religiosa, persino quella del socialismo utopistico, è così ogni diritto, ogni politica, arte o scienza. Il contenuto di tutte le scienze era costretto a esprimersi in un involucro religioso. Riflettendo le contraddizioni antagonistiche della loro epoca, tutte le scienze manifestavano in modo illusorio, cioè sostanzialmente religioso, il loro tentativo di risolverle, e questo avveniva anche quando gli uomini cercavano di emanciparsi dalla religione. Ecco perché sino al socialismo scientifico la lotta contro la religione altro non è stata che la lotta di alcune idee religiose contro altre. Oggi, sotto il capitalismo, le forme ideologiche conservano il loro carattere illusorio pur avendo perso lo stretto legame con la religione (legame che comunque può sempre essere ripristinato, all’occorrenza). Nei confronti della religione la borghesia ha sempre avuto un duplice e apparentemente contraddittorio atteggiamento: di critica, nel momento dell’ascesa al potere economico e politico; di compromesso, nel momento della conservazione di tale potere. Di critica per potersi emancipare dal modo di produzione economico cui la religione era legata (quello feudale); di compromesso (o meglio di strumentalizzazione, per quanto reciproca) per poter impedire alla classe operaia di emanciparsi dal modo di produzione borghese. Nel Terzo mondo, ove la critica della religione non ha raggiunto le punte ateistiche dell’Occidente, quando l’operaio credente abbraccia ideologie di tipo socialista (ad esempio la Teologia della liberazione) facilmente gli viene attribuito dalla chiesa l’appellativo di “eretico” ed ovviamente lo si minaccia di “scomunica”. Un atteggiamento così autoritario, da parte della chiesa romana, è stato tenuto in Italia e per buona parte d’Europa almeno sino agli anni ’70. Di qui la decisione, da parte degli operai credenti, di abbandonare la religione, proseguendo in maniera laica la propria opposizione al capitalismo. Se la chiesa cattolica non si fosse legata così strettamente agli interessi del capitale, probabilmente gli operai cattolici avrebbero smesso d’essere credenti con meno facilità, o forse avrebbero contestato il capitalismo con meno decisione. In ogni caso questo spiega il motivo per cui nel socialismo il regime di separazione di Stato e chiesa è un aspetto sovrastrutturale necessario alla socializzazione dei mezzi di produzione. Certo, se la religione non si fosse compromessa nel difendere il capitalismo (o il feudalesimo), il legame tra i due aspetti (separazione giuridica e collettivismo economico) potrebbe anche non essere indispensabile, ma è fuor di dubbio che là dove esistono più religioni (senza peraltro considerare l’ateismo), il socialismo non può che optare per il regime di separazione. A Marx comunque non bastava l’emancipazione meramente “politica” dalla religione (come per Bauer); voleva anche quella umana, e questo inevitabilmente implicava il rovesciamento dei rapporti produttivi, in quanto l’umano per lui coincideva col sociale e non solo -come per Feuerbach- con la coscienza personale. L’atteggiamento dei confronti della religione andava privatizzato, ma non quello nei confronti della società che produce l’illusione religiosa. La religione si pone sempre laddove esistono delle contraddizioni socioeconomiche basate sui conflitti di classe. Quando le classi antagonistiche si servono della religione politicamente (come fenomeno sociale) o ideologicamente (come convinzione personale), esse lo fanno o per illudersi (se sono oppresse), o per illudere (se invece opprimono). La religione infatti è allo stesso tempo -come dice Marx- ” l’espressione della miseria reale e la protesta contro questa miseria ” (ovviamente sempre nell’ambito dell’illusione). Rovesciare i rapporti di produzione antagonistici significa ” rinunciare non solo alle illusioni sulla propria condizione, ma anche a una condizione che ha bisogno di illusioni “. Il proletariato -secondo Marx- sa che la sua emancipazione umana è legata al possesso dei mezzi produttivi e se questo obiettivo riesce a conseguirlo non può trasformarsi in un nuova classe dirigente che usa la religione in maniera strumentale, perché vuol rendere partecipe tutta la società di questo suo possesso. Sì, perchè la religione non è altro che uno strumento per tener buono il popolo, per impedire che esso si ribelli di fronte alle disuguaglianze: la religione promette un mondo in cui regnerà l’uguaglianza e non fa niente perchè essa regni in questo mondo, che è poi l’unico, il solo, il vero mondo. L’uguaglianza il proletariato la vuole immediatamente, in questo mondo, ed è pronto ad ottenerla con una rivoluzione che distrugga il capitalismo e le ingiustizie da esso derivate. Ma Marx sa bene che non è facile smascherare la religione; essa non è crollata nei secoli, mai nessun impero ha durato tanto: tale successo è riconducibile all’essenza stessa dell’uomo, il quale sente l’esigenza di credere in qualcosa, non può accettare che la vita non abbia un senso e sente il dovere di conferirgliene uno, inventando, con un’aberrazione fantastica, la religione: ecco perchè la religione è ‘ la realizzazione fantastica dell’essenza umana, poiché l’essenza umana non possiede una realtà vera ‘. Ma, inventatala, l’uomo non riesce più a distaccarsene, proprio come, entrati nel giro, non ci si riesce più a distaccare dall’oppio: ecco perchè ‘la religione è l’oppio del popolo ‘. Essa nasce come contro-offensiva alle ingiustizie del mondo, come tentativo di trovare una felicità immaginaria, un riparo da questo mondo crudele, ed è per questo che ‘ eliminare la religione in quanto illusoria felicità del popolo vuol dire esigere la felicità reale ‘, in modo che essa possa regnare in questo mondo.
ETICA E RELIGIONE
Il rapporto che Marx stabilisce tra economia borghese e protestantesimo non è mai stato molto chiaro nelle sue opere. Da un lato infatti egli ha sempre considerato la religione una sovrastruttura dell’economia; dall’altro però ha spesso scorto nell’economia borghese delle caratteristiche tipicamente religiose (che assumevano forme laicizzate). Marx ha costatato lo stretto rapporto tra i due aspetti, ma ha scarsamente analizzato l’evoluzione del fenomeno religioso in rapporto all’evoluzione del contesto storico ad esso correlato. Marx in effetti non è uno storico in senso lato, ma uno storico dell’economia o al massimo della politica. Engels, in tal senso, ha prodotto qualcosa di significativo con gli studi sul Cristianesimo primitivo (che però riprendono le tesi della Sinistra hegeliana) e sulla Riforma protestante. Marx non ha analizzato per niente il riflesso del fenomeno religioso sul contesto socioeconomico corrispondente, ovvero i condizionamenti culturali della religione sui rapporti sociali. Qui occorre servirsi dei lavori di Weber -il “Marx della borghesia”.
MARX E WEBER
Il nesso che Marx poneva, nei Manoscritti parigini del ’44, tra economia capitalistica e religione cristiana, racchiude, in nuce, tutte le analisi sociologiche di Weber, anche se Marx ha avuto il torto di non proseguire quelle ricerche, essendosi dedicato esclusivamente all’analisi economica. Weber ha proseguito quelle ricerche, ma da punto di vista borghese, cioè mascherando le contraddizioni antagonistiche del capitalismo. Ora bisognerebbe proseguire quelle ricerche dal punto di vista dell’umanesimo socialista.
Il Capitale
Il capitale è la maggiore e più importante opera del filosofo ed economista tedesco Karl Marx. È un’opera complessa e poderosa che affronta diversi temi e problemi, tutte parti, tuttavia, del suo oggetto d’indagine principale: il modo di produzione e distribuzione capitalistico. L’opera è divisa in tre libri, di cui solo il primo però fu dato alle stampe, ad Amburgo nel 1867, dallo stesso Marx. I Libri II e III furono invece pubblicati postumi, sulla base dei manoscritti originali, daEngels, rispettivamente nel 1885 e nel 1894. Appartiene al corpus del Capitale, in verità, anche tutto il materiale di storia e critica delle teorie del valore che, nelle intenzioni di Marx, avrebbe dovuto costituire il IV Libro del Capitale. Esso, tuttavia, pubblicato da Kautsky tra il 1905 e il 1910 in tre volumi sotto il titolo di Theorien über den Mehrwert (Teorie sul plusvalore) ha avuto una storia editoriale autonoma da quella del Capitale. Trascurando, perché non più adoperate, le edizioni ottocentesche del I Libro e quella del II edita da Corticelli a Milano nel 1946, del Capitale in Italia sono disponibili due edizioni: quella degli Editori Riuniti, comparsa per la prima volta tra il 1951 e il 1956, che si avvale delle traduzioni di Delio Cantimori per il I Libro, Raniero Panzieri per il II, e Maria Luisa Boggeri per il III, e quella della casa editrice Newton Compton, pubblicata nel 1969 per la cura e la traduzione di Eugenio Sbardella. Riassumere il contenuto del Capitale è opera non facile e, per definizione, quasi irrealizzabile. Ciò che segue è solo l’esposizione, la più sintetica possibile, dei suoi capisaldi e delle sue strutture teoriche più generali. Estremamente ricco ed impegnativo si presenta il I Libro, “Il processo di produzione del capitale”, in cui Marx ha inteso esporre le categorie basilari della struttura sociale capitalistica, quelle categorie che ne rappresentano il nòcciolo e il fondamento. Preso atto che la forma elementare in cui si presenta la ricchezza nella società capitalistica è la singola merce, Marx ne analizza le determinazioni teoriche: la merce è unità di valore d’uso e valore, e cioè è, nello stesso tempo, oggetto delle specifiche qualità sensibili e cristallizzazione del dispendio di forza-lavoro umana indistinta, ossia risultato di erogazione di energia fisica ed intellettuale senza riguardo per la forma e le modalità con le quali questa erogazione avviene. Il valore di una merce è costituito, per Marx, dal tempo di lavoro socialmente necessario a produrla. Essendo il valore qualità comune a tutte le merci, diversamente dal valore d’uso che è proprio solo di ogni singola merce, esso permette alle merci di scambiarsi vicendevolmente in modo quantitativamente proporzionato alla spesa di energia lavorativa oggettivata in ciascuna di esse. Questa proprietà delle merci è ciò che, per Marx, sta alla base della genesi del denaro, particolarissima merce che è, nello stesso tempo, l’equivalente universale di tutto il restante mondo delle merci. Il denaro svolge, secondo Marx, essenzialmente, tre funzioni: è misura dei valori, poiché fornisce alle merci il materiale attraverso il quale esse possono rappresentarsi come grandezze quantitativamente comparabili; è mezzo di circolazione, giacché permette l’acquisto e la vendita delle merci; è rappresentante materiale della ricchezza, in quanto unico modo di esistenza adeguato del valore in quanto tale. Terminata l’analisi della merce e del denaro, Marx passa ad analizzare i diversi momenti dell’accumulazione capitalistica, che è una particolare e specificamente determinata forma di accumulazione di denaro. Quest’ultima non può realizzarsi, per Marx, attraverso lo scambio, mediato dal denaro, di una merce contro un’altra merce. Due merci si scambiano, infatti, osserva Marx, solo se hanno un valore eguale. Marx ipotizza, quindi, che l’accumulazione capitalistica si realizzi attraverso l’acquisto di una merce che vale di più di quanto venga pagata. Questa merce è la forza-lavoro degli operai salariati. La differenza fra il valore prodotto dal lavoratore nel processo produttivo e il valore del salario ricevuto dallo stesso lavoratore è ciò che Marx chiama plusvalore, “incremento eccedente sul valore originario” della forza-lavoro espresso dal salario. Una volta acquisito il plusvalore, il capitalista lo reinveste nell’acquisto di nuovi mezzi di produzione e nell’assunzione di nuovi operai. È questo il meccanismo di espansione del capitalismo che Marx chiama riproduzione allargata del capitale. Individuato il plusvalore come il principio motore del processo di accumulazione capitalistica, Marx passa ad esaminare le due forme in cui esso si manifesta: come plusvalore assoluto, attraverso l’allungamento della giornata lavorativa, e come plusvalore relativo, attraverso la riduzione, ottenuta con l’introduzione di tecnologie più sofisticate, del tempo necessario a produrre una merce; fermo restando, infatti, il tempo della giornata lavorativa di un operaio, se occorre meno tempo a produrre una merce, allora occorre meno tempo per produrre quelle merci di cui ha bisogno l’operaio per riprodursi. In questo modo l’operaio impiega meno tempo per guadagnare il salario necessario alla riproduzione della sua vita e, quindi, si libera un tempo supplementare per la produzione delle merci. Marx àncora poi l’analisi del plusvalore assoluto e relativo all’analisi del passaggio della produzione capitalistica dalla sua fase manifatturiera al macchinismo e alla grande industria. Conclusa la parte dedicata allo studio del plusvalore assoluto e relativo, Marx passa ad analizzare la categoria e le varie formule del saggio del plusvalore, esprimente il tasso di sfruttamento esercitato sulla forza-lavoro. La trattazione del salario apre la parte finale del I libro, il cui oggetto principale è la descrizione dell’insieme dei fenomeni legati al processo di accumulazione del capitale. Si va dalla disamina del problema dell’accumulazione originaria all’evidenziazione della contraddizione fra produzione e distribuzione, dalla rilevazione dei meccanismi di generazione della sovrappopolazione all’introduzione del problema delle crisi periodiche del capitalismo. Il II Libro, “Il processo di circolazione del capitale”, ha come suo oggetto principale le diverse forme assunte dal capitale nel suo ciclo di riproduzione. Il problema, i cui primi elementi sono già abbozzati nel I Libro, viene trattato in relazione alla distinzione fra capitale fisso e capitale circolante, cioè fra capitale che si consuma solo parzialmente, e cede quindi solo una parte del suo valore, nel processo di produzione (le macchine) e capitale che invece nel processo di produzione si consuma integralmente, e cede tutto il suo valore (materie prime e forza-lavoro). Esaminata questa distinzione anche alla luce delle teorie economiche, quelle dei fisiocratici, di Smith e di Ricardo, che per prime l’avevano introdotta, Marx passa ad analizzare prima la circolazione e la riproduzione dei capitali individuali e poi le fasi di riproduzione e di circolazione del capitale sociale complessivo, di cui i capitali individuali sono nient’altro che le parti costitutive. La terza ed ultima sezione del Libro indaga le dinamiche della riproduzione semplice (la riproduzione del processo produttivo senza che il plusvalore ogni volta ottenuto venga reinvestito nella produzione) e quelle della riproduzione allargata (la riproduzione del processo produttivo su una base ampliata dal continuo reinvestimento di parti o di tutto il plusvalore), avvalendosi, tuttavia, delle categorie, già esposte nel I Libro e introdotte per la prima volta da Marx nel pensiero economico, di capitale costante (macchine, materie prime etc.) e di capitale variabile (salari). Il capitale costante è quella parte del capitale che convertendosi in mezzi di produzione (macchine, materie prime etc.) non cambia la propria grandezza di valore nel processo di produzione mentre il capitale variabile è quella parte del capitale che convertendosi in forza-lavoro (salari) cambia il proprio valore nel processo di produzione, ossia riproduce il valore dei salari e inoltre produce un’eccedenza, il plusvalore. Il III Libro è più direttamente interessato degli altri due agli aspetti empirici e di superficie della società capitalistica. Esso tratta, in particolare, della categoria di profitto e dei suoi molteplici aspetti e forme. Il profitto è, secondo Marx, una forma mutata del plusvalore, il guadagno del capitalista visto in relazione però non solo alla forza-lavoro impiegata, ma al capitale totale impiegato, costituito sia dai mezzi di produzione che dalla forza-lavoro. La categoria di prezzo di costo riunisce la spesa complessiva che il capitalista ha dovuto compiere per dotarsi dei fattori oggettivi, mezzi di produzione, e soggettivi, forza-lavoro, necessari al processo produttivo. La categoria di saggio di profitto esprime invece il rapporto tra il plusvalore e il capitale totale impiegato; rapporto che varia tra impresa e impresa, poiché in ogni impresa è differente la proporzione che all’interno del capitale totale impiegato si stabilisce tra la spesa in mezzi di produzione e la spesa in forza-lavoro. La proporzione tra spesa in mezzi di produzione e spesa in forza-lavoro è ciò che Marx chiama composizione organica di capitale. Essendo dunque in ogni impresa diversa la composizione organica di capitale è diverso in ogni impresa anche il saggio di profitto. La categoria di profitto medio è il risultato, ottenuto in virtù dell’azione della concorrenza, della media fra i saggi di profitto di tutte le imprese. Il prezzo di produzione di una merce è dato dalla somma fra il suo prezzo di costo e il profitto medio. Le categorie di saggio di profitto e di profitto medio sono le premesse necessarie all’enunciazione della celebre legge della caduta tendenziale del saggio di profitto, esprimente il fatto che l’aumento di produttività, che caratterizza il modo di produzione capitalistico, non può essere realizzato che con la sostituzione di forza-lavoro con tecnologia. Ma sostituendo forza-lavoro, si ricordino le premesse della teoria del valore, si riduce il plusvalore; riducendosi, però, il plusvalore si riduce anche il saggio di profitto. Per opporsi a questo movimento di riduzione del saggio di profitto è allora necessario, secondo l’analisi di Marx, aumentare il saggio del plusvalore, e cioè il grado di sfruttamento della forza-lavoro. La legge della caduta tendenziale del saggio di profitto è, per Marx, alla radice delle ricorrenti crisi che funestano il modo di produzione capitalistico. Concluso l’esame di questa legge, Marx prosegue l’analisi delle diverse forme in cui si divide il profitto. Esso si spartisce innanzitutto in interesse e guadagno d’imprenditore, e cioè nella remunerazione dovuta a chi, in generale il banchiere, ha prestato all’industriale il capitale iniziale per avviare la sua impresa e nella remunerazione acquisita dall’industriale stesso. Questo dà modo a Marx di porre la distinzione fra capitale monetario e capitale industriale – ossia fra capitale esistente sempre in forma di denaro, detenuto dalle banche, e capitale esistente in mezzi di produzione e forza-lavoro – e di esaminare, quindi, la loro rispettiva incidenza nel generale processo di accumulazione capitalistica. Da questa analisi consegue l’ulteriore suddivisione del profitto in profitto industriale, commerciale, bancario, di interesse e, infine, in rendita fondiaria, che Marx ritiene in ambito capitalistico sdoppiarsi in rendita assoluta e rendita differenziale, e cioè in rendita costituita dall’eccedenza sulla parte del plusvalore della merce agricola che è misurata dal profitto medio e in rendita ottenuta in proporzione alla quantità di investimenti terrieri effettuati e alla diversa fertilità dei diversi appezzamenti di terreno. Il profilo unitario degli argomenti trattati in tutti e tre i libri appare bene nell’ultima sezione, rimasta interrotta, del III Libro in cui l’analisi della formula trinitaria del processo di produzione capitalistico, capitale-profitto, terra-rendita fondiaria, lavoro-salario, permette a Marx di indicare negli operai salariati, nei capitalisti e nei proprietari fondiari le tre grandi classi fondamentali della società capitalistica moderna.
COMMENTI AD ALCUNI PASSI E TEORIE DEL CAPITALE (tratti da HOMOLAICUS)
1] Premessa
2] Il Denaro
3] Introduzione
4] Capitolo IV del libro I
5] Il processo di scambio
6] Il plusvalore
7] Il lavoro astratto
8] Il feticismo delle merci
9] La merce
10] L’accumulazione originaria
11] Il processo di accumulazione
12] La manifattura
13] La cooperazione
14] L’importanza della cultura
15] Schiavismo, servaggio e capitalismo
16] Capitalismo e ideologia
17] Le tre fasi di sviluppo
18] La questione contadina
19] Macchinario e grande industria
Riflessioni significative
Che le classi dominanti tremino al pensiero di una rivoluzione comunista. I proletari non hanno da perdervi altro che le proprie catene. Da guadagnare hanno un mondo.
La religione é l’oppio del popolo.
L’arma della critica non può sostituire la critica delle armi, la forza materiale deve essere abbattuta per mezzo della forza materiale, ma la teoria diventa, essa pure, una forza materiale, quando si impadronisce delle masse.
Come non é la religione che crea l’uomo, ma é l’uomo che crea la religione, così non é la costituzione che crea il popolo, ma il popolo la costituzione.
Le armi con cui la borghesia ha annientato il feudalesimo si rivoltano ora contro la borghesia stessa. Ma la borghesia non ha solo forgiato le armi che la uccidono; ha anche prodotto gli uomini che imbracceranno queste armi: i lavoratori moderni, i proletari.
I filosofi hanno solo interpretato il mondo in modi diversi; si tratta però di mutarlo.
Il punto di vista del vecchio materialismo è la società “borghese”; il punto di vista del nuovo materialismo è la società umana, o l’umanità socializzata.
Ciò che gli individui sono dipende dalle condizioni materiali della loro produzione.
Voi inorridite perché noi vogliamo eliminare la proprietà privata. Ma nella vostra società esistente la proprietà privata è abolita per i nove decimi dei suoi membri; anzi, essa esiste proprio in quanto non esiste per quei nove decimi. Voi ci rimproverate dunque di voler abolire una proprietà che ha per condizione necessaria la mancanza di proprietà per la stragrande maggioranza della società.
Il proletariato deve marciare con il grande esercito democratico alla punta dell’ala sinistra, ma guardandosi bene dal rompere ogni legame con il grosso dell’esercito. Il proletariato non ha il diritto di isolarsi, ma esso deve, per quanto ciò possa sembrare duro, respingere quanto potrebbe separarlo dagli alleati.
Le idee dominanti non sono altro che l’espressione ideale dei rapporti materiali dominanti, sono i rapporti materiali dominanti presi come idee: sono dunque l’espressione dei rapporti che appunto fanno di una classe la classe dominante, e dunque sono le idee del suo dominio.
Il movimento proletario é il movimento autonomo della stragrande maggioranza nell’interesse della stragrande maggioranza.
Il comunismo non toglie a nessuno il potere di appropriarsi dei prodotti sociali; toglie soltanto il potere di soggiogare il lavoro altrui mediante questa appropriazione. E’ stato obiettato che, con la soppressione della proprietà privata, cesserà ogni attività e si diffonderà una pigrizia generale. Se così fosse, la società borghese sarebbe da parecchio tempo andata in rovina a causa dell’indolenza, dal momento che in essa chi lavora non guadagna e chi guadagna non lavora.
Non è la coscienza che determina la vita, ma la vita che determina la coscienza.
MAX STIRNER

La vita
Max Stirner (pseudonimo di Johann Caspar Schmidt) nasce il 25 Ottobre del 1806 a Bayreuth,figlio di un intagliatore di flauti; sulla sua vita sappiamo ben poco. Studia a Berlino, ascoltando corsi di Hegel, Schleiermacher, Michelet. Finite le scuole, trova impiego come insegnante in una scuola privata per fanciulle di famiglie agiate,il “Lehr und Erzihungs Anstalt fur hohere Totcher” di Madame Gropius, situata a Berlino. Il primo ottobre del 1844, all’età di 38 anni, abbandona l’impiego. Nel mese stesso l’editore Wigand di Lipsia,a cui faceva capo il radicalismo politico e filosofico del momento, pubblicava in una tiratura di mille copie ” L’unico e la sua proprietà “, primo libro di Stirner. L’opera è dedicata alla seconda moglie dell’autore, Marie Dahnhardt, che presto si dividerà dal marito, lasciandolo nella più completa solitudine. Stirner muore il 26 Giugno del 1856,a pochi mesi dal compimento dei 50 anni, oppresso dai debiti e dopo due appelli pubblici sui giornali (ricordiamo che morì in circostanze misteriose). Aveva passato anche due brevi periodi in prigione, proprio per i debiti. Alla sua morte,c he venne annunciata da pochi giornali, la salma di Stirner fu accompagnata da Bruno Bauer e da pochi amici. Il primo accenno all’ Unico apparso sulla stampa si trova in una rapida corrispondenza da Berlino della “Mannheimer Abendzeitung” del 12 Novembre 1844. Dopo aver presentato Stirner come amico intimo di Bruno Bauer, l’anonimo giornalista spiega che però “L’unico” è un attacco a fondo contro il punto di vista del liberalismo umanitario(che era quello di Bauer). Ma ciò che lo impressiona innanzitutto è l’eccessività di Stirner: con questo libro la tendenza neo-hegeliana si è spinta al suo estremo:la libertà dello spirito soggettivo viene qui cercata nella sfrenatezza del singolo, nell’individualità propria d’ogni uomo, nell’egoismo, ma l’egoismo stirneriano va inteso come “unicità”,come il singolo (l’io vero) legge a se stesso. Stirner vuole far del bene a se stesso e non all’umanità; ed è proprio lui a dircelo: ” Deciditi a non lasciar più vagare il diritto in libertà:riconducilo alla sua origine,a te,ed esso diventerà il tuo diritto, e giusto sarà solo ciò che ti andrà bene. “Anche se impaurito, Bauer è attratto da Stirner: seppure questo principio, quale è qui presentato, sia ancora troppo unilaterale e insostenibile, esso si fonda però su intuizioni giuste e vere e, se opportunamente filtrato, si potrà rivelare fecondo. Dall’unico questo primo recensore si aspettava un brivido, e l’aveva avuto. Appariva naturale l’attesa di un qualcosa che obbligasse a dire un qui si va troppo in là, che sbaragliasse tutti i precedenti scritti come troppo timidi e cauti. E quell’opera finalmente c’era! L’ultima fase del processo di decomposizione dello spirito assoluto(Marx-Engels, L’ideologia tedesca ) si stava compiendo. Dopo essersi già fatto notare con alcuni brevi saggi,tra cui il più importante,il falso principio della nostra educazione,era apparso sulla “Rheinische Zeitung”, la rivista a cui collaborava anche Marx che ne divenne caporedattore due giorni dopo che Stirner aveva pubblicato il suo ultimo articolo, il silenzioso, appartato Stirner si presentava ora con un’opera massiccia che aveva una sola pretesa: quella di seppellire la filosofia in generale. Dopo l’Unico, l’attività pubblica di Stirner sembra sfilacciarsi, sino a scomparire. Pubblica traduzioni di J.B. Say da Adam Smith, che dovrebbero essere accompagnate da un suo commento annunciato, ma nella prima si annuncia il commento per la seconda, ma in questa il commento annunciato manca senza alcuna giustificazione. Nel 1848 scrive per il “Journal des osterreichischen Lloyds” (giornale dei lyod austriaci), ma non firma questi articoli. Poi pubblica a Berlino nel 1852 i due volumi di Storia della Reazione , un saggio sulla reazione controrivoluzionaria ai moti tedeschi ed europei del 1848,dietro un titolo così interessante essi celano un lavoro di compilazione, un’antologia dal profilo sfuggente, dove lo Stirner de L’Unico compare beffardamente in poche occasioni.Con la sua opera principale e le due repliche ai suoi primi recensori si può affermare che Stirner abbia dichiarato il silenzio e lo abbia poi mantenuto. Stirner non ha trovato particolare favore presso la critica filosofica. Se ha incontrato una certa notorietà, ciò è avvenuto nell’ambito ideologico. Il suo nome fa parte ormai della cerchia dei classici teorici dell’ anarchismo , i cui esponenti principali agiscono più o meno nel decennio 1840-1850. Negli Stati Uniti J.Warren, in Francia P.J.Proudhon, in Germania lo stesso Stirner, in Russia il romantico M.Bakunin e più tardi, l’altro grande, P.Kropotkin. Ma bisogna anche dire che questo appropriarsi di Stirner da parte degli anarchici è andato ben al di là delle intenzioni stesse di Max Stirner, che non ha mai avuto alcuna intenzione di fondare una scuola di pensiero nè tantomeno di tracciare guide ed indicazioni a chicchessia:la sua dimensione dell’individualismo, dell’egoismo, termine questo da lui ampliato ed ingigantito fino a diventare un valore e una vera categoria di pensiero nonché un atteggiamento complessivo verso tutte le manifestazioni della vita e della realtà, ha trovato una connotazione sociale soltanto nella concezione da lui teorizzata, e neanche tanto intensamente proposta, della Unione dei Liberi, che deriva dalla frequentazione a Berlino del circolo intellettuale dei Liberi, appunto, alle cui riunioni e discussioni movimentate partecipò lo stesso Engels (e fu lì che Engels fece degli schizzi a matita dei partecipanti, e a lui si deve l’unica immagine conosciuta dello stesso Stirner, l’essenziale profilo a matita conosciuto da tutti i lettori dell’autore).Tale concezione prevedeva un’unione di individualità che, salvaguardando strenuamente la propria peculiarità, avrebbero comunque potuto fondare un progetto politico e organizzativo capace di guidare la vita dell’intera società. Ma su questo concetto Stirner non insistette mai più che tanto. E’ evidente che alla formazione di Stirner come anarchico è stato determinante il pesante giudizio di Engels, espresso in particolare nel suo breve scritto del 1886 ” Ludwing Feuerbach e la morte della filosofia tedesca “, in cui Engels prende in considerazione alcuni rappresentanti della “hegelei” che dominava allora in Germania. Dopo aver accennato alla nascita dell’ala sinistra verso la fine del 1830 Engels passa a parlare piuttosto sinteticamente dell’opera “la vita di Gesù” di F.Strauss, nonché della successiva polemica con Bruno Bauer, ed infine fa il nome di Stirner, dicendo che egli è il profeta e il propugnatore dell’odierno anarchismo e ispiratore dell’opera di Bakunin. Più precisamente Bakunin (ricordiamo che Bakunin era un aristocratico) avrebbe amalgamato Stirner con Proudhon, e proprio a tale amalgama si sarebbe dato il nome di anarchismo. E ancora, per Engels, tra gli ultimi esponenti della filosofia hegeliana Strauss, Bauer, Stirner e Feuerbach soltanto quest’ultimo sarebbe significativo nel campo filosofico,e Stirner sarebbe soltanto un “personaggio curioso”. C’è da dire che Stirner criticò Feuerbach poiché quest’ultimo non fece altro che proiettare un Dio in un altro Dio; questo “nuovo Dio” prese il nome di “uomo”o “umanità”. Quindi, per Schmidt, non è cambiato assolutamente niente, è solo un altro essere al di sopra del singolo e quindi da combattere e distruggere). Appena il libro “L’unico e la sua proprietà” è stampato e la prima recensione pubblicata, tre lettere ne commentano l’apparizione incrociandosi per l’Europa. Engels scrive a Marx, Feuerbach a suo fratello, Ruge all’editore Froebel. Reazioni febbrili alla travolgente lettura dell’opera e per diverse ragioni ognuno ammette, pur timorosamente, un certo entusiasmo per il libro di Schmidt. Poi passeranno gli anni, i destini degli scriventi divergeranno sempre di più ma in una cosa saranno, senza accorgersene, d’accordo, ovvero nel condannare Stirner, e soprattutto nel tacere su di lui. Feuerbach in una lettera al fratello,alla fine del 1844: la prima impressione è che “L’Unico e la sua proprietà” sia un’ opera di estrema intelligenza e genialità, che ha la verità dell’egoismo-anche se eccentrica, unilaterale, non vera- dalla parte sua. Feuerbach prosegue dicendo che la polemica di Stirner contro l’antropologia (cioè contro lui stesso) è fondata su un malinteso. Per il resto lo considera lo scrittore più geniale e libero che mai abbia conosciuto. Così all’inizio Feuerbach pensò di dare a Stirner una risposta leggera e amichevole, nella forma di una lettera aperta che avrebbe dovuto iniziare con le seguenti parole: “indicibile e incomparabile, amabile egoista: come il Suo scritto stesso,il Suo giudizio su di me è veramente incomparabile e unico.” Ma presto la prudenza e il sopravvento ebbero la meglio: in un’altra lettera al fratello, del 13 Dicembre 1844, Feuerbach insinua che gli attacchi di Stirner tradiscono una certa vanità, come se volesse farsi un nome a sue spese. Infine, nella recensione che poi decise di dedicare all’Unico, Feuerbach appare intimorito e preoccupato soprattutto di difendersi. Non vuole fare concessioni a Stirner e tutela l’onorabilità della propria dottrina. Poi è il silenzio. Nel 1861, in una lettera a Julius Duboc, ricorderà quella vecchia polemica come una causa liquidata per sempre. Ruge, in un biglietto del Novembre 1844 all’editore Frobel, spedito da Parigi, dice che le poesie di Heine e L’Unico di Stirner sono le due apparizione più importanti degli ultimi tempi. Le audacie dei Deutsch-franzosichen Jahrbucher (ovvero di Marx) appaiono ormai, di gran lunga, superate! Ruge era stato prima protettore e amico e poi aspro nemico di Marx. Nella lettera a Frobel del 6 Dicembre 1844 mescola le lodi a Stirner con le stoccate a Marx e ,anzi, per la prima volta usa Stirner contro Marx: Marx professa il comunismo, ma è il fanatico dell’egoismo, e con una coscienza ancora più occultata in rapporto a Bauer. Si sappia che Stirner vede il comunismo come “società degli straccioni”. L’egoismo ipocrita e la smania di fare il genio,il suo atteggiarsi a Cristo, il suo rabbinismo, il prete e le vittime umane (ghigliottina) riappaiono perciò in primo piano. Il fanatismo ateo e comunista è in realtà ancora quello cristiano. L’egoismo di una persona meschina è meschino, quello di un fanatico è ipocrita, falso e avido di sangue, quello di un uomo onesto è onesto. Perché ognuno vuole e deve avere se stesso (Stirner vuole che ogni uomo riconduca il proprio “io” da dove è nato, ovvero a se stessi, e non ad alienarlo in “fantasmi”come Dio o l’umanità ), e nella misura in cui ciascuno lo vuole veramente le sopraffazioni si equilibrano. Poi, in una lettera del 17 Dicembre alla madre, Ruge riprende il discorso su Stirner: “Il libro di Max Stirner, che forse anche Ludwing conosce, è una strana apparizione. Molte parti sono assolutamente magistrali, e l’effetto del tutto non può che essere liberatorio. E’ il primo libro leggibile di filosofia che appaia in Germania; e si potrebbe dire che è apparso il primo uomo del tutto privo di pedanteria, anzi del tutto disinvolto, se non fosse che lo rende assai meno disinvolto la sua propria fissazione, che è quella dell’unicità. Comunque mi ha dato una grande gioia vedere che la dissoluzione ha raggiunto ormai questa forma totale, per cui nessuno può giurare impunemente su niente. ” Ma anche in questo caso l’entusiasmo per Stirner avrebbe retto per poco. Già nel 1847 Ruge approva con zelo il violento attacco di Kuno Fischer contro Stirner e i sofisti moderni, che segna l’inizio della pratica per etichettare “L’Unico e la sua proprietà” come libro famigerato. E, quando Stirner pubblica la sua replica, Ruge suggerisce subito a Fische: “E’ senz’altro una buona cosa se risponde a Stirner con una lettera e lo fa inciampare un’altra volta pesantemente sulla sua fondamentale stupidità. Questa gente si infuria se uno prova loro la loro mancanza di genialità e arguzia, perché alla fine tutto sfocia nel fatto che loro sono geni e gli altri sono asini. Confondono il movimento teologico col movimento filosofico o, in altri termini, la pratica dell’arbitrio con la pratica della libertà.” Engels scrive una lettera a Marx il 19 Novembre 1844 da Barmen a Parigi dove esplica: “Avrai sentito parlare del libro di Stirner, l’Unico e la sua proprietà, se non ti è già arrivato. Wigand mi aveva spedito le bozze impaginate, che mi ero portato dietro a Colonia e poi avevo lasciate ad Hess. Il principio del nobile Stirner è l’egoismo di Bentham, solo che nel suo caso viene sviluppato per un verso più consequenzialmente, per un altro meno consequenzialmente. Più consequenzialmente perché Stirner pone il singolo in quanto ateo al di sopra di Dio o addirittura come entità ultima, mentre Bentham lascia ancora stare Dio al di sopra di tutto in una qualche nebbiosa lontananza. Meno consequenziale Stirner lo è in quanto vorrebbe evitare la ricostruzione della società dissolta in atomi, quale viene messa in opera da Bentham, ma non ci riesce.Questo egoismo non è che l’essenza portata a coscienza della società di oggi, la cosa ultima che la società di oggi può dire contro di noi, la punta acuminata di ogni teoria che si muova all’interno della stupidità corrente. Ma appunto per questo la cosa è importante, non dobbiamo accantonarla, bensì sfruttarla proprio in quanto perfetta espressione della pazzia corrente e,operando in essa un ribaltamento, continuare a costruirci sopra. Questo egoismo è così spinto all’estremo, così pazzo e al tempo stesso così cosciente di sé che nella sua unilateralità non può mantenersi un solo momento, ma deve subito rovesciarsi in comunismo.” Più avanti dice che Stirner ha ragione, quando rifiuta l’uomo di Feuerbach, per lo meno quello dell’Essenza del cristianesimo,l’uomo di Feuerbach è derivato da Dio, Feuerbach è arrivato da Dio all’uomo, e così l’uomo è incoronato da “un’aureola teologica” di astrazione. La vera via per giungere all’uomo è la via inversa. Noi dobbiamo partire dall’io, dall’individuo empirico, corporeo, non per restarci attaccati,come succede a Stirner, ma per innalzarci da lì all’uomo. Poco più avanti Engels arriverà al punto di esigere un’ulteriore acutizzazione dell’egoismo stirneriano: ma se l’individuo in carne e ossa è la vera base, il vero punto di partenza per il nostro uomo, così anche ovviamente l’egoismo-naturalmente non solo l’egoismo stirneriano dell’intelletto, ma anche l’egoismo del cuore-è il punto di partenza per il nostro amore per gli uomini,altrimenti esso resta sospeso per aria.(Stirner vede l’amore come un sentimento di cui l’uomo deve servirsi;”L’amore è mio! “). Il libro di Stirner mostra ancora una volta quanto profondamente radicata sia l’astrazione nell’essenza berlinese. Fra i liberi, Stirner è evidentemente quello che ha più talento. Per capire meglio “L’unico e la sua proprietà” è consigliabile leggere “L’ideologia tedesca”, le pagine rabbiose dedicate a Stirner (che hanno la mole dello stesso libro di Stirner). Marx,che fin dall’inizio, con la sua consueta chiaroveggenza politica, aveva visto in Stirner il nemico per eccellenza, dovette rispondere ad Engels con asprezza. Ma purtroppo quella lettera è andata perduta. In risposta, nel Gennaio 1845, Engels fa ammenda più tosto senza ritegno. Passano diversi mesi e, al ritorno da un viaggio nell’Estate 1845 in Inghilterra, Marx ed Engels decidono di procedere a una definitiva liquidazione dei giovani hegeliani fra i quali erano cresciuti. Una prima liquidazione, la Sacra Famiglia, era già apparsa pochi mesi prima: ma questa volta il libro è centrato chiaramente su un avversario: Max Stirner! Ne viene fuori una critica all’Unico che occupa 320 delle fitte pagine delle opere complete di Marx ed Engels. Riga per riga le affermazioni di Stirner vengono isolate, aggredite. Le astuzie del procedimento riveleranno non tanto i segreti di Stirner, quanto quelli di Marx ed Engels in una loro fase di irreversibile trasformazione,quella in cui Marx inventa il “marxismo”come lingua franca. Ancora a molti, oggi, il nome di Stirner dice qualcosa solo perché Marx ed Engels parlano di lui ne “L’ideologia tedesca” e, di fatto, leggere “L’Unico”tenendo accanto il commento di Marx ed Engels rimane un esercizio ascetico inevitabile per ogni buon lettore di Stirner (e di Marx). Portata a termine l’opera distruttiva, che criticava aspramente anche altri pensatori, come si è detto, come lo stesso Bruno Bauer, Marx ed Engels tentarono per vari mesi di pubblicare il loro testo. Ma,d opo laboriose trattative, ad un certo punto i fondi vennero a mancare. Ad altri nemici dovevano rivolgersi ancora, soprattutto Proudhon, e a tal proposito Marx avrebbe chiesto ad Engels il permesso di travasare vari temi dell’ideologia tedesca e “la miseria della filosofia”. Così quel grosso libro rimase fra gli inediti. Marx non ne fu molto dispiaciuto: come avrebbe accennato nella introduzione a Per la critica dell’economia politica ,del 1859, quello scritto aveva già assolto alla sua funzione occulta, quella di un chiarimento di se stessi da parte dei suoi due autori. E quel chiarimento era stato al tempo stesso troppo intimo e troppo drastico perché lo si potesse rendere pubblico. Qualcosa di simile doveva pensare anche Engels: nel 1883 propose a Berstein di pubblicare il manoscritto de “L’ideologia tedesca” a puntate sul Feuilleton del “Sozialdemokrat” e definì il testo la cosa più insolente che sia mai stata scritta in lingua tedesca. Ma si pentì subito della sua idea perché, secondo Berstein, temeva che il testo avrebbe offeso una certa destra social-democratica. Quanto a Stirner, Engels si sarebbe lasciato sfuggire su di lui un ultimo giudizio illuminante, che spiega retrospettivamente in termini ben diversi le ragioni politiche dell’ideologia tedesca, e ben più convincenti, rispetto a quelli che Marx ed Engels avevano proposto nel loro testo: “Stirner ha vissuto una sua rinascita attraverso Bakunin, il quale fra l’altro era anche lui a Berlino a quel tempo e stava seduto davanti a me, con altri quattro o cinque russi, al corso di logica di Werder (era il 1841/42). L’innocua, e soltanto etimologica, anarchia-cioè l’assenza di una autorità statale-di Proudhon non avrebbe mai portato alle dottrine anarchiche di oggi se Bakunin non vi avesse versato una buona parte della `ribellione`stirneriana. In conseguenza gli anarchici sono diventati altrettanti unici, così unici che non se ne trovano due che riescano ad andar d’accordo” (lettere a Max Hildebrand del 22 Ottobre 1889). E’ questo il controcanto privato al breve, allusivo riconoscimento pubblico che Engels aveva appena dedicato a Stirner: “E alla fine venne Stirner, il profeta dell’anarchismo attuale-Bakunin ha preso moltissimo da lui-e al di sopra della sovrana autocoscienza fece svettare il suo unico sovrano”.L’anti-Stirner,come sarebbe giusto chiamare il libro contro di lui,che erompe dalla cornice dell’ideologia tedesca,finì per essere pubblicato postumo sia a Marx cri ad Engels.Nel 1903-04 Bernstein ne offriva un’edizione parziale sotto il titolo “Il santo Max”. Fino ad allora non si sapeva dunque che Stirner era un avversario a cui Marx ed Engels avevano dedicato qualche centinaio di pagine per infamarlo. E questo aiuta a capire come mai,ancora negli anni ’90 del XIX secolo,vari teorici e studiosi socialisti mostrassero ancora una evidente simpatia per Stirner.
L’unico e la sua proprietà
” Io ho fondato la mia causa su nulla! ” Questa affermazione apre e conclude il libro si Stirner, con essa l’autore sintetizza la sua filosofia: la filosofia dell’egoismo, del singolo,dell’unico; ” Io che al pari di Dio e dell’umanità sono il nulla di ogni altro, io che sono il mio tutto,io che sono l’unico! ” Max Stirner con la sua opera distrugge tutta la filosofia del suo tempo, detronizza Hegel e Feuerbach sbattendoli nel più profondo degli abissi; per Stirner le idee, in quanto non sono materia, non possono esistere realmente, e quindi critica Hegel, il quale diceva che è tutto un’idea, e critica Feuerbach, accusandolo del fatto di aver soltanto dato un altro volto a Dio, ovvero di averlo chiamato uomo (umanizzato) e Bauer. Nel suo libro Stirner punta il dito contro tutto ciò che gli sta intorno,la Chiesa,lo Stato,i liberali etc… E’ la vera “filosofia del martello”, che non si fa alcun scrupolo a far tramontare completamente alcune delle tesi degli altri filosofi del suo tempo e non solo. Stirner nel suo scritto inneggia all’egoismo, alla individualità propria e assoluta; incoraggia gli uomini alla ribellione (insurrezione) perché essa deriva da uno stato di insoddisfazione e malcontento di sè e non alla rivoluzione, perché essa sarebbe qualcosa di organizzato, di politico. Inoltre inneggia all’insurrezione poiché essa non vuole cambiare la costituzione vigente ma bensì annientarla, al contrario della rivoluzione, che vorrebbe solo cambiarla. Stirner è stato guardato con sgarbo da Chiesa e Stato: c’è chi lo credeva addirittura il male fatto persona; ma in realtà egli era un ribelle interiore, un teorico. Da qualsiasi punto di vista sia letto, “L’Unico e la sua proprietà” è un capolavoro, un’opera d’arte nella sua sublime completezza: nel libro c’è una spiegazione a tutte le idee, i concetti proferiti dall’autore, ed è questo a rendere il suo scritto così gradevole. E’ certamente un libro difficile da accettare se si è convintamene devoti a Stato e Chiesa; a queste persone consiglio comunque di analizzare nel modo più oggettivo possibile le parole di Schmidt, che sono una compagine perfettamente unita,come già suddetto, di concetti, certo molto duri da comprendere e poter pensare come reali, ma è lo stesso Stirner a farci luce su quella che chiamiamo “utopia”, ed infatti egli scrive: ” L’utopia è l’irrealizzato, non l’irrealizzabile. ” Nelle sue circa 380 pagine, “L’Unico e la sua proprietà” combatte contro tutto ciò che sta al di sopra dell’egoista, dell’unico; nelle parole di Stirner si sente palesemente quella voglia di rivincita da parte dell’uomo singolo, questo concetto si esprime così: ” riconduci l’io da dov’è nato, ovvero in te stesso, e non alienarlo in Dio o nell’umanità “. Stirner vuole valorizzare l’uomo singolo ed anche la proprietà (al contrario del comunismo che vorrebbe invece abolirla), ed infatti leggiamo nella sua opera :” valorizza la tua proprietà! ” L’Unico e la sua proprietà si può sintetizzare-per quanto questo sia possibile, vista la sua mole del libro- negli ultimi sprazzi di inchiostro dello scritto: ” Proprietario del mio potere sono io stesso, e lo sono nel momento in cui so di essere unico. Nell’Unico il proprietario stesso rientra nel suo nulla creatore, dal quale è nato. Ogni essere superiore a me stesso, sia Dio o l’uomo, indebolisce il sentimento della mia unicità e impallidisce appena risplende il sole di questa mia consapevolezza. Se io fondo la mia causa su di me, l’unico, essa poggia sull’effimero, mortale creatore di sé che se stesso consuma, e io posso dire: Io ho fondato la mia causa su nulla. ” L’anarchia può però essere appannaggio tanto delle sinistre quanto delle destre ed è per questo che se la Sinistra, ispirandosi a Bakunin, mira all’individualismo come estrema libertà, la Destra, invece, (ispirandosi a Stirner) tende all’individualismo come superiorità del singolo sulle masse. In L’unico e la sua proprietà , Stirner arriva a sostenere che ad esistere è solo l’individuo e ciò che per lui conta è, paradossalmente, solo lui stesso; tutto il resto (le cose, gli animali e perfino gli altri uomini) è solo uno strumento per l’affermazione di sè. Il mondo stesso viene concepito come strumento volto ad attuare la realizzazione del singolo. Se Kant ha riconosciuto (nella Critica della ragion pratica ) che nell’uso strumentale che facciamo delle persone non possiamo non tenere presente che esse hanno un valore intrinseco, Stirner dice che l’unico fine, l’unico valore per noi stessi, paradossalmente, siamo noi stessi e tutti gli altri sono semplici mezzi per realizzare i propri fini.
MICHAIL BAKUNIN

Chi dice stato o diritto politico, dice forza, autorità, predominio: ciò presuppone l’ineguaglianza di fatto.
Il maggior rappresentante del movimento anarchico internazionale nell’Ottocento e, allo stesso tempo, il primo agitatore che cercò di dare una giustificazione teorica alla sua azione rivoluzionaria è stato Michail Bakunin, nato in Russia (a Tver, l’odierna Kalinin) da nobile famiglia il 30 maggio 1814 e morto il 1° luglio 1876. La sua vita si svolse prevalentemente in Occidente (in Svizzera, in Francia ed in Italia), alla cui cultura si era formato studiando la filosofia tedesca particolarmente di Fichte e di Hegel. Partecipò attivamente al 48 francese e all’insurrezione di Dresda del 1849. Fu arrestato e condannato alla pena di morte, commutata nella detenzione a vita; fu dunque incarcerato e in seguito confinato in Siberia fino al 1861, quando era fuggito a Londra, in Svizzera e in Italia. Il suo modello di rivoluzione, più rispondente alle arretrate condizioni economiche e sociali delle periferie orientali e meridionali, faceva leva su due elementi centrali:
– le masse diseredate e degradate, soprattutto le plebi contadine
– un’avanguardia intellettuale declassata, emarginata dagli strati sociali superiori.
Sul piano organizzativo Bakunin rimase sempre fedele alla formula della setta clandestina; sul piano politico la sua rivoluzione, molto simile alle jacqueries contadine e al ‘banditismo sociale’, avrebbe dovuto immediatamente abolire lo stato e ogni altra autorità: ” Chi dice stato o diritto politico, dice forza, autorità, predominio: ciò presuppone l’ineguaglianza di fatto “. Accusava i comunisti di essere ” nemici delle istituzioni politiche esistenti perché tali istituzioni escludono la possibilità di realizzare la propria dittatura ” e di essere al tempo stesso ” gli amici più ardenti del potere statale “, poiché volevano costruire una società integralmente dominata e programmata dall’alto. Su queste basi, Bakunin riteneva che il movimento operaio dovesse rifiutare programmaticamente l’azione politica per praticare esclusivamente il terreno sociale. Su questa linea il conflitto con Marx era inevitabile. Marx aveva posto come priorità la lotta politica del movimento operaio, considerando la conquista del potere da parte della classe operaia come il superamento della società borghese e della divisione tra le classi. La dittatura del proletariato, ossia la costituzione della classe operaia in classe dominante, la distruzione dello stato borghese e la sua sostituzione con lo stato proletario erano considerate da Marx come l’inevitabile fase di transizione per attuare il passaggio al comunismo, la società senza classi in cui lo stato, in quanto strumento del dominio di classe, avrebbe dovuto estinguersi. Dopo il congresso dell’Aja (1872) , nel cui documento si proclama definitivamente la necessità di attuare una dittatura proletaria (secondo la linea di Marx), Bakunin fu espulso dall’associazione internazionale per volere di Marx stesso. Ritornando al pensiero di Bakunin, esso, apparentemente privo di sistematicità, è in realtà caratterizzato da una forte coesione intorno ad alcune tesi fondamentali: la liberazione totale dell’uomo attraverso l’abolizione dello stato, il rifiuto di qualunque socialismo di stato, la valorizzazione di quelle forze sociali che il processo d’industrializzazione tendeva ad emarginare . L’opera principale nella quale ha trovato espressione il suo pensiero è ” Stato e anarchia ” pubblicata in russo nel 1873, alla quale si devono aggiungere le lunghe lettere indirizzate agli amici e i numerosi opuscoli che venne componendo per le esigenze dell’azione rivoluzionaria, scritti in lingue (il francese o il tedesco) che non erano la sua e pubblicati occasionalmente. Nei suoi scritti Bakunin prende decisamente posizione contro Mazzini il cui rivoluzionarismo, alla metà dell’Ottocento, non faceva più paura ai governanti europei. Di Mazzini non condivide la concezione teocratica dello stato, la “teologia politica” che pone al suo centro lo “Stato-Chiesa”, per usare le parole dell’anarchico russo: per Bakunin l’impegno di un vero rivoluzionario non deve proporsi la riforma o la separazione delle due istituzioni, ma la loro abolizione. Anche il dissenso con Marx ha trovato ampia espressione negli scritti di Bakunin, secondo il quale il nucleo centrale del pensiero marxiano sta nella conquista dello stato, nella centralizzazione del potere per emancipare il proletariato (ma anche l’accusa per il sostegno di Marx per l’unificazione della Germania sotto la guida dei socialdemocratici). Va detto chiaramante che Bakunin nutriva per Marx una forte antipatia, per altro cordialmente ricambiata: ai compagni italiani, nel gennaio del 1872, scrisse a proposito del filosofo tedesco: ” Marx è un comunista autoritario e centralista. Egli vuole ciò che noi vogliamo: il trionfo completo dell’eguaglianza economica e sociale, però, nello stato e attraverso la potenza dello Stato, attraverso la dittatura di un governo molto forte e per così dire dispotico, cioè attraverso la negazione della libertà “. Ciò che lo divide da Marx, quindi, è la concezione decisamente pessimistica che egli ha dello stato, fondato esclusivamente sul principio d’autorità, concepito come oppressione dell’uomo, identificato con quelle strutture repressive (la polizia, la magistratura, il carcere, l’esercito) che, nell’Ottocento, la borghesia capitalistica utilizzava per imporre il proprio dominio di classe al proletariato. Lo stato, sostenne per tutta la sua vita Bakunin, dovunque sia presente e in qualunque forma istituzionale operi (borghese, socialista o comunista), non è altro che ” sinonimo di costrizione, di dominazione attraverso la forza, camuffata se possibile, ma, al bisogno, brutale e nuda “. Per attuare pienamente la sua libertà, l’uomo non ha altra via che la lotta a fondo contro lo stato e contro quella che, secondo Bakunin, ne è la prima conseguenza: la proprietà privata ereditaria (mentre può essere consentita la proprietà privata non trasmissibile ereditariamente). Una vera rivoluzione deve porre termine definitivamente a quello stato d’assoggettamento in cui sono vissute fino ad oggi le masse popolari, sempre guidate dall’alto “metafisicamente” (cioè per quanto concerne la visione della vita) dalla religione, politicamente dal governo, psicologicamente dalle leggi ed economicamente tramite la ricchezza e la proprietà. Lo stato è contrario alla natura dell’uomo, che è un essere sociale e non può fare a meno di vivere in società, ma senza alcun bisogno di una struttura statale, che non è altro che tirannia ed oppressione. Combattendo lo stato, Bakunin ovviamente prende posizione anche contro la chiesa e la religione in tutte le loro manifestazioni, considerandole oppressive ed autoritarie allo stesso modo, se non in misura peggiore. La società futura a cui l’uomo approderà è descritta da Bakunin in termini ottimistici, che mostrano chiaramente quale influenza egli abbia subito da parte degli utopisti a lui precedenti di qualche decennio. In questo senso giunse a proporre una modificazione delle risoluzioni del Congresso Internazionale dei Lavoratori di Ginevra, del 1866 sostenendo, ” la necessità di distruggere l’influenza d’ogni dispotismo in Europa, mediante l’applicazione del diritto d’ogni popolo, grande o piccolo, debole o potente, civile o non civile, di disporre di se stesso e di organizzare spontaneamente, dal basso in alto, attraverso la via di una completa libertà, al di fuori d’ogni influenza e d’ogni pretesa politica o diplomatica, indipendentemente da ogni forma di stato, imposta dall’alto in basso, da un’autorità qualunque, sia collettiva, sia individuale, sia indigena, sia straniera, e non accettando per basi e per leggi che i principi della democrazia socialista, della giustizia e solidarietà internazionali “. Bakunin non ha sentito l’esigenza, presente invece in Marx, di approfondire i concetti di classe e di capitalismo come produttore o condizionatore della condizione d’oppressione e sfruttamento in cui l’uomo vive. Non a caso Marx criticava delle concezioni bakuniane soprattutto il fatto che ” la volontà, non le condizioni economiche, è fondamento della sua rivoluzione sociale “. Per Bakunin è lo stato la causa principale d’ogni forma di oppressione e di tirannia, per cui il capitalismo non è altro che lo strumento di cui questo ente superiore, burocratizzato e gerarchizzato, si serve per attuare i suoi disegni. Sono queste le considerazioni che portano Bakunin a guardare più che alla classe operaia, nel senso marxiano del termine, alle masse popolari: invece di agire sul proletariato, che si serve della lotta di classe, egli propone di trasformare lo stato usando la violenza del sottoproletariato e quindi di rinviare ad un momento successivo l’attuazione di quei mutamenti sociali da cui scaturirà la società anarchico-egualitaria. Al centralismo soffocante e burocratico, nato con l’assolutismo e affermatosi ovunque con la rivoluzione francese, Bakunin contrappone il comune popolare, dove il cittadino ha la possibilità di manifestare il proprio patriottismo, identificandosi col libero sviluppo della collettività di cui fa parte. A loro volta i comuni si riuniscono in una libera federazione su scala regionale e in seguito le regioni si uniranno in una federazione ancora più ampia, che, al limite, potrà estendersi a tutta l’umanità. Per queste idee federalistiche Bakunin è influenzato dal pensiero di Proudhon, con il quale condivide la convinzione che per questa via l’umanità possa garantirsi non solo il progresso, l’armonia e la solidarietà, ma anche la pace. Le tesi libertarie di Bakunin comportano un’ulteriore conseguenza: il rifiuto dell’organizzazione politica dei lavoratori, pur nel riconoscimento della necessità di muoversi entro il movimento operaio. Per questo Bakunin propone di lasciare all’azione spontanea dei lavoratori la possibilità di agire in senso rivoluzionario, usufruendo della violenza e dello sciopero politico e facendo leva sugli strati più miseri della popolazione. La guida delle masse popolari deve essere assunta da una ristretta minoranza di rivoluzionari, interamente dediti alla causa anarchica e impegnati totalmente nella lotta per abbattere l’attuale ordinamento politico. In questo modo Bakunin anticipava la tesi bolscevica, sostenuta da Lenin, che rese possibile il successo della rivoluzione in Russia nell’ottobre del 1917. Bakunin aveva molta fiducia nei contadini, che sono portati naturalmente al federalismo e all’antiautoritarismo. Per questo raccolse proseliti, più che in mezzo al proletariato operaio, in mezzo al sottoproletariato delle campagne, composto da braccianti e da lavoratori precari e stagionali, cui affidava, specie in paesi arretrati economicamente e socialmente come la Spagna e l’Italia, il compito di guida rivoluzionaria. Gli obiettivi a cui la rivoluzione deve tendere sono riassumibili, per Bakunin, nell’emancipazione universale, che consisterà nella liberazione dal bisogno, nell’eguaglianza economico-sociale di tutti gli uomini e nella libertà politica. Quest’ultima però non deve essere confusa con la libertà politica borghese, che in realtà per il proletariato è schiavitù ed oppressione, ma deve essere identificata con ” la grande libertà umana che, distruggendo tutte le catene dogmatiche, metafisiche, politiche e giuridiche, da cui tutto il mondo è oggi oppresso, restituirà a tutti, collettività quanto individui, la piena autonomia dei loro movimenti e del loro sviluppo, liberati per sempre da tutti gli ispettori, direttori e tutori “. L’anarchismo bakuniniano si affermò nell’Associazione Internazionale dei Lavoratori, in particolare in Italia e in Spagna, e costituì la principale corrente di pensiero che disputò al marxismo la guida del movimento operaio nella seconda metà del secolo scorso. Le teorie del filosofo russo seppero coinvolgere gli operai di tutta Europa, infondendo in essi la speranza di un cambiamento radicale della società attuale, cercando di ottenere quel che sembrava impossibile perchè, come disse Bakunin, ‘ E’ ricercando l’impossibile che l’uomo ha sempre realizzato il possibile. Coloro che si sono saggiamente limitati a ciò che appariva loro come possibile, non hanno mai avanzato di un solo passo ‘.
ANTONIO LABRIOLA

Il materialismo della interpretazione storica non è se non il tentativo di rifare nella mente, con metodo, la genesi e la complicazione del vivere umano sviluppatosi attraverso i secoli.
VITA E OPERE
Antonio Labriola nacque a Cassino, in provincia di Frosinone, il 2 luglio 1843, fu professore di filosofia teoretica all’ Università di Roma dal 1847 fino alla morte, sopraggiunta il 12 febbraio 1904, e nel 1887 ottenne anche la cattedra di filosofia della storia. Fu discepolo di Bertrando Spaventa e si orientò dapprima verso l’hegelismo, e solo in un secondo tempo verso la filosofia di Herbart, dedicandosi anche ad intensi studi di psicologia sociale e di filosofia della storia. Ma già intorno al 1879 cominciò a muoversi nell’orbita del pensiero socialista, la cui interpretazione e divulgazione in Italia divennero fin d’allora uno degli impegni maggiori del Labriola nella sua duplice veste di scrittore e di insegnante di filosofia. Inizialmente vicino alla Destra storica, nel 1897 compì un viaggio in Germania, su incarico del ministero dell’ Istruzione Pubblica, per studiarvi l’ordinamento scolastico: qui cominciò a nutrire simpatia per il socialismo, ma solo nel 1890 aderì ufficialmente al marxismo, intrattenendo rapporti epistolari con Engels e Kautsky. Della concezione marxista del materialismo storico chiarì l’origine e spiegò il significato in due scritti di fondamentale importanza, che ancor oggi conservano una loro attualità: In memoria del ‘Manifesto dei comunisti’ (1895) e Del materialismo storico, Dilucidazione preliminare (1896), ambedue tradotte in lingua francese precedute da una prefazione di Sorel. Nel 1898 apparve una raccolta di lettere a Sorel, Discorrendo di socialismo e di filosofia , la quale comprendeva anche un’interessante appendice in cui si discutevano le ben note critiche di Croce alla dottrina del materialismo storico. Postumi invece furono pubblicati da Luigi Dal Pane un quarto saggio, Da un secolo all’altro (1925) e le Lettere ad Engels (1927-1928).
IL PENSIERO
Il grande merito di Herbart e dei suoi discepoli, in particolare della cosiddetta ‘psicologia dei popoli’, consisteva, ad avviso di Labriola, nella ricerca dell’origine storica delle idee, non tanto nella psicologia individuale quanto nella psicologia sociale, tramite la comparazione tra le rappresentazioni mentali dei vari popoli. Labriola riteneva, però, che questa impostazione non fosse in grado di dare una spiegazione unitaria della realtà storica. Nel discorso tenuto nel 1887 su I problemi della filosofia della storia , egli rifiutava le interpretazioni della storia di tipo hegeliano, ma pure quelle evoluzionistiche, ritenendo che i fenomeni storico-sociali fossero la risultante del gioco di tre fattori, 1 ) l’attività produttiva, 2 ) le istituzioni della convivenza civile (cioè il diritto e lo Stato), e 3 ) il piano culturale dell’arte, della religione e della scienza. Labriola escludeva tassativamente che le produzioni politiche e culturali fossero ‘ un puro riflesso e completamento ‘ dei mezzi materiali di esistenza. Nel 1980, poi, la lettura delle opere di Marx e di Engels lo portò a scorgere nel materialismo storico la spiegazione oggettiva della dinamica storica mediante la lotta di classe, in polemica contro l’interpretazione revisionistica che ne aveva dato Bernstein. Labriola indicò il nucleo specifico del materialismo storico non tanto in una concezione materialistica ed evoluzionistica della realtà in generale, quanto nello studio della realtà umana nel suo sviluppo in condizioni storicamente variabili. Alle teorie che separavano il piano dei valori da quello degli interessi materiali di cui le classi sociali sono portatrici, Labriola contrappose la tesi che ‘ le idee non cascano dal cielo ‘ e la storia delle idee ‘ non consiste nel circolo vizioso delle idee che spieghino se stesse ‘. In questo modo, Labriola respingeva la teoria dell’indipendenza dei fattori storici, che non era appunto in grado di cogliere un principio unitario dell’interpretazione storica: questo era invece dato dal materialismo storico, secondo il quale i mutamenti nella struttura economica trovano ‘ la loro adeguata espressione solo nell’alterarsi delle relazioni esistenti fra le diverse classi sociali ‘. Per questa strada Labriola si riagganciava al grande tema del rapporto fra struttura e sovrastruttura, ma respingendo ogni interpretazione deterministica implicante una dipendenza immediata dalla struttura economica. Si trattava invece di un processo complicato di derivazione e mediazione tra questi piani, che invitava a guardarsi dalla tentazione di dedurre meccanicamente i prodotti dell’attività storica umana, che si esplica nella religione, nell’arte e nell’agire morale del singolo, a partire dalla situazione economica e sociale, che pure era il fondamento imprescindibile di essi. Labriola asserisce che ‘ l’uomo produce e sviluppa se stesso, come causa ed effetto, come autore e conseguenza ad un tempo, di determinate condizioni, nelle quali si generano anche determinate correnti di opinioni, di credenze, di fantasia, di aspettazioni ‘. In particolare, il rapporto dell’arte, della religione e della scienza con la realtà economica era molto meno diretto e immediato di quello che intercorreva fra gli ordinamenti giuridici e politici e le condizioni economiche e sociali. L’esposizione che Labriola elaborò del materialismo storico, dunque, rifuggì sempre da impostazioni dogmatiche ed astratte, tendendo anzi a porre in evidenza proprio le caratteristiche di concretezza e di oggettività del marxismo, contrario tanto ad ogni mitologismo ideologico quanto ad ogni forma di verbalismo vuoto. Per Labriola ‘ il materialismo della interpretazione storica non è se non il tentativo di rifare nella mente, con metodo, la genesi e la complicazione del vivere umano sviluppatosi attraverso i secoli. La novità di tale dottrina non è difforme da quella di tutte le altre dottrine, che, dopo molte peripezie entro i campi della fantasia, son giunte da ultimo assai faticosamente ad afferrare la prosa della realtà, ed a fermarsi in essa ‘. Pur tenendo fisso, infatti, il principio fondamentale che ogni fatto storico trovi la sua origine necessaria nella struttura economica, la quale condiziona altresì l’arte, la religione e la scienza, tuttavia egli si oppose ad ogni forma di fatalismo deterministico e puntò piuttosto a ricostruire la dialettica interiore della società umana nella sua unità. Contro l’astrattismo Labriola combatte con tutte le sue forze: ‘ nello studio dei rapporti e delle vicende umane, le passioni, e gl’interessi, e i pregiudizi di scuola, di setta, di religione, e poi l’abuso letterario dei mezzi tradizionali della rappresentanza del pensiero, e poi la scolastica non mai vinta e anzi sempre rinascente, o fanno velo alle cose effettuali, o inavvertitamente le trasformano in termini, e parole, e modi di dire astratti e convenzionali ‘. Il ‘verbalismo’ , ossia il mito e il culto delle parole, avverso al materialismo propugnato dal marxismo, ‘ oblitera il senso dei problemi, perchè non vede che denominazioni. ‘ Labriola combatte contro le volgari interpretazioni del marxismo date dai cosiddetti ‘riformisti’ o ‘revisionisti’; contro costoro e contro la loro astratta antitesi di reale e ideale, di strutture e di sovrastrutture, ‘ come se le cose stessero da un canto e avessero dall’altro canto le proprie ombre e fantasmi nelle idee ‘, egli ha riaffermato con Marx che la storia, al contrario, ‘ è sempre tutta d’un pezzo, e poggia tutta sul processo di formazione e di trasformazione della società ‘ : per questo reale e ideale o, come dice Labriola, ‘ nocciolo e scorza fanno uno ‘; il grande merito di Labriola resta comunque quello di non aver considerato il marxismo come rigida teoria o come sistema volto a costringere in prefissi schemi l’infinita varietà dei fatti storici, ma solo come metodo di ricerca, come il nuovo metodo per intendere la storia. Perché, come egli asserisce integrando il pensiero di Marx con quello di Vico, la storia è il prodotto dell’umano lavoro : è l’uomo che, producendo i vari ambienti sociali, produce via via se stesso.
BERTRANDO SPAVENTA

Il far intendere Hegel all’Italia, vorrebbe dire rifare l’Italia.
Bertrando Spaventa fu il maestro per eccellenza dell’hegelismo italiano, sia per la struttura filosofica sia per la ricchezza e l’organicità della sua posizione filosofico-culturale. Nato a Bomba, in provincia di Chieti, nel 1817, studiò nei seminari di Chieti e di Montecassino e si fece prete nel 1840. Successivamente insegnò a Napoli e si avvicinò ai circoli liberali, partecipando alla redazione del “Nazionale”. Nel 1848 lascerà Napoli per trasferirsi prima a Firenze, poi a Torino. Ed è nel periodo torinese (chiusosi intorno al 1860) che Spaventa viene elaborando il suo sistema filosofico e il suo pensiero politico. L’uno e l’altro muovono inizialmente dalla duplice riflessione sul distacco (avvenuto con la Controriforma) della filosofia e della stessa società italiana da quella europea, e sulle “terapie” intellettuali ed educative necessarie per superarlo. Spaventa si sofferma inoltre, con particolare attenzione, sul pensiero di Hegel, concepito come il punto più avanzato del pensiero europeo e come il mezzo più adatto per costruire, anche in Italia, una cultura di tipo moderno: poichè, secondo Spaventa, ” il far intendere Hegel all’Italia, vorrebbe dire rifare l’Italia “. In questi anni il filosofo abruzzese pubblica gli articoli (più tardi riuniti da Giovanni Gentile) su La politica dei gesuiti nel secolo XVI e XIX e su La libertà d’insegnamento , alcuni studi su Campanella e Giordano Bruno (1854-55), un lavoro su Kant (1856), e alcuni Studi sopra la filosofia di Hegel (1850). Tornato dopo il 1860 a Napoli, approfondisce la sua interpretazione di Hegel e quella della filosofia italiana moderna, polemizzando, da una parte, con il Positivismo e, dall’altra parte, con lo spiritualismo. Nel 1862 pubblica le lezioni napoletane del novembre-dicembre 1861, raccolte da Gentile sotto il titolo La filosofia italiana nelle sue relazioni con la filosofia europea . Nel 1863 escono Le prime categorie della logica di Hegel , nel 1867 i Princìpi di filosofia , nel 1868 Positivismo, paolottismo, razionalismo , nel 1874 Idealismo o realismo? . Spaventa muore nel 1883, nello stesso anno in cui muore anche Marx. La filosofia italiana nasce, sostiene Spaventa, col Rinascimento, con Bruno; Campanella è già il “pensiero” di Cartesio, come Spinoza è ” la chiarezza di Bruno “. Con Giambattista Vico si afferma il principio dello “sviluppo” che esige una nuova “metafisica”: quella attuata più tardi da Kant e successivamente da Fichte, Schelling e Hegel. Con l’Ottocento la filosofia europea ritorna (dopo una lunga assenza) in Italia, con Galluppi che è un pò il “nostro Kant”, con Rosmini che è “Kant inteso bene” e con Gioberti che “compie” Rosmini, come Fichte, Schelling ed Hegel “compiono” Kant. A proposito di Gioberti, scrive Spaventa in La filosofia italiana nelle sue relazioni con la filosofia europea (lezione VIII): ” Gioberti rappresenta la vera unità dello spirito, il vero concetto dello sviluppo, la vera ed assoluta psiche: una attività che come due attività è una attività, un ciclo che come due cicli è un unico ciclo. Tale è il vero ed assoluto spirito: il Creatore. Così e solo così, il psicologismo di Gioberti è psicologismo assolutamente trascendentale, cioè il vero ontologismo, e, direi io, il vero spiritualismo “. “Correggendo” Gioberti si trova infine Hegel, e così la filosofia italiana si riallaccia definitivamente alla filosofia europea. Il disegno di Spaventa è certamente forzato, ma la linea culturale che esso implica ha un preciso significato. Si tratta di stabilire e sviluppare una rete di scambi organici tra la cultura della nazione appena nata nella nostra penisola e quella dei Paesi stranieri intellettualmente e socialmente più evoluti. In questo contesto, il punto di riferimento privilegiato da Spaventa è il pensiero tedesco, soprattutto quello hegeliano. L’interpretazione che Spaventa viene elaborando di Hegel (soprattutto dopo il 1848) è fondata sull’inversione, rispetto all’interpretazione ortodossa, del rapporto tra Fenomenologia dello spirito ed Enciclopedia e sulla complementare “riforma della dialettica”. Per Spaventa la Fenomenologia precede e fonda l’ Enciclopedia e la Logica stessa, poichè senza coscienza non c’è scienza e poichè il pensiero è sempre soltanto uno: pensiero che pensa. L’itinerario gnoseologico-coscienzale della Fenomenologia non è l’introduzione al sapere ma il sapere stesso. Non dunque il Sistema è il cuore stesso del pensiero hegeliano, ma il metodo, cioè la dialettica: una dialettica che però Spaventa riforma in senso quasi fichteano, dando maggior importanza al momento della soggettività della coscienza e dell’atto del pensare rispetto ai momenti e fasi dell’oggettivazione e della sintesi. Anche la politica di Spaventa, a parte la parentesi liberale del “Nazionale”, si ispira ad Hegel: è laica, ma legata ad un forte senso dello Stato. In esso Spaventa scorge non solo l’unico organismo che dà unità e senso politico alla nazione, ma anche la sorgente dei princìpi e dei valori ispiratori di un armonioso sviluppo civile e culturale. In altre parole, sia gli individui sia la comunità devono trarre dallo Stato l’alimento necessario ad una crescita ordinata e corretta. E’ questa la teoria dello ” stato etico ” accolta dalle più disparate forze politiche, e utilizzata nel Novecento anche in una prospettiva totalitaria ben lontana dagli ideali e dai programmi di Spaventa. In questa concezione della politica si saldano insieme il concetto di “tradizione nazionale italiana” e quello di “sovranità etica razionale” che implica, accanto alla sostanziale laicità, anche una funzione educatrice dello Stato.
SILVIO SPAVENTA

Vita
Nacque a Bomba, nei pressi di Chieti, il 10 maggio 1822 da un’agiata famiglia abruzzese; fratello minore di Bertrando e figlio di Eustachio e Marianna Croce la cui famiglia era la stessa del filosofo Benedetto. Dopo aver ricevuto la prima educazione a casa, nel 1836 prosegue gli studi nel seminario di Chieti e poi in quello di Montecassino dove insegnava suo fratello.
Nel 1843 giunse a Napoli e fece da precettore ai suoi cugini, figli di Benedetto Croce nonno dell’omonimo pensatore. Nella capitale del Regno delle Due Sicilie viene a contatto con gli ambienti liberali ed introdotto al pensiero di Hegel. Il Regno era allora dominato del potere dispotico di Ferdinando II di Borbone che non vede di buon occhio l’orientamento politico liberale.
Così il filosofo abruzzese è costretto a lasciare Napoli per dirigersi in Toscana, a Firenze, dove frequenta i circoli dei moderati.
Intanto, Re Ferdinando si decise a concedere la Costituzione suscitando le speranze di Spaventa che tornò a Napoli nel febbraio 1848 e fondò il quotidiano Il Nazionale il cui primo numero uscì il 1° marzo dello stesso anno. Il quotidiano divenne il punto di riferimento principale per la borghesia liberale ma trovò una grande stima anche tra i conservatori ed i filoborbonici.
Inoltre, fu eletto deputato e si impegnò per far partecipare le truppe del regno borbonico alla prima guerra d’Indipendenza. La sua dedizione alla causa fu inizialmente premiata dal Re, che inviò le sue truppe comandate da Guglielmo Pepe in appoggio al Regno di Sardegna contro l’Austria.
Tuttavia, le opinioni di Ferdinando cambiarono molto presto ed il 15 maggio effettuerà il suo ignominioso colpo di stato: revoca la Costituzione concessa poco prima e fa bombardare Napoli per fiaccare una possibile rivolta. La guerra, però, continua e Pepe combatte strenuamente per difendere Venezia ma a Napoli è sostenuto solo da Spaventa e non più dalla corte.
A causa di questo suo appoggio venne arrestato il 15 maggio 1849 e rinchiuso nel carcere di San Francesco; sottoposto a processo, l’8 ottobre 1852 fu condannato a morte per impiccagione con l’accusa di cospirazione alla sicurezza interna dello Stato. La pena fu commutata in ergastolo e per sei anni il filosofo rimase nel carcere di Santo Stefano, dedicandosi agli studi politici e filosofici.
L’11 gennaio 1859 la sua pena viene ulteriormente rivista e trasformata in esilio perpetuo. Il piroscafo Stewart avrebbe dovuto condurre in America 69 prigionieri politici tra cui il nostro Spaventa; grazie però ad un ammutinamento organizzato da un ufficiale della marina britannica la nave giunse in Irlanda. Da qui il pensatore raggiunse Londra e poi Torino, in cui fece un fondamentale incontro con Cavour diventando uno dei più grandi fautori della sua politica.
Dedito alla causa dell’Unità d’Italia, nel luglio 1860 viene inviato a Napoli per preparare il meridione all’annessione al Regno di Sardegna, cercando di fare prima di Garibaldi che con i suoi Mille è diretto verso la capitale del Regno borbonico ora comandato dall’inetto Francesco.
L’eroe dei due Mondi autoproclamatosi dittatore supera il filosofo ed in settembre lo espelle; Spaventa ritorna a Napoli un mese dopo per assumere la carica di Ministro della Polizia impegnandosi da novembre al luglio 1861 per fronteggiare la difficile situazione napoletana.
Nel neonato Regno d’Italia assunse molte cariche politiche a partire dalla lunga permanenza da deputato (dal 1861 al 1889) tra le file della Destra storica. Fu inoltre sottosegretario all’Interno (1862-64), consigliere di Stato (1868) e ministro dei Lavori Pubblici (1873-1876). Nel 1889 viene nominato Senatore del Regno.
Tra il suo operato politico spicca la strenua difesa della sicurezza interna dello Stato culminata nella repressione del brigantaggio meridionale e delle manifestazioni torinesi in protesta con lo spostamento della capitale a Firenze. Come consigliere di Stato divenne celebre il suo discorso sulla giustizia nell’amministrazione pronunciato il 6 maggio 1880. In qualità di ministro dei Lavori Pubblici provocò la caduta della Destra storica (1876) dopo il suo progetto di nazionalizzazione delle ferrovie.
Dopo il terremoto di Casamicciola (1883), diede ospitalità al giovane Benedetto Croce rimasto orfano, nella sua casa romana in via della Missione, oggi sede dei gruppi parlamentari della camera dei deputati.
Morì a Roma il 23 giugno 1893, gli furono riservati degni funerali di Stato e la sua salma è sepolta nel cimitero del Verano.
Pensiero
L’impegno politico di Silvio Spaventa nelle file della Destra non deve trarci in inganno nel considerarlo solo un politico o un giurista e non un filosofo. Infatti, fu anche un filosofo nonostante la politica ed il problema dello Stato e della giustizia sia in lui centrale. Per Spaventa la filosofia non è inutile contemplazione ma comprensione dell’utile pratica quotidiana sino ad arrivare alle origini di questa nella coscienza della storia; dunque la filosofia assume il ruolo di investigatore delle azioni che fanno la realtà. Spaventa era un idealista ed un liberale; solo nello Stato infatti si può attuare la soluzione liberale.
·Idealismo
Il pensiero di Hegel fu importante per la sua formazione soprattutto negli anni napoletani, in cui dirigeva il quotidiano “Nazionale” e si dedicò allo studio del pensatore di Stoccarda di cui Bertrando fu storico interprete. Per il pensatore l’ “idealismo” è opposto ad un piatto materialismo ma è realista: concepisce l’uomo come «una dolente e potente creatura che vive di pane ed è materia, vive di idea ed è spirito».
Il primo problema che Spaventa si pone è quello della storia: tra la storia razionale hegeliana ovvero lo svolgimento necessario e la rivoluzione dogmatica o il mutamento improvviso. Se la storia è “ragione tutta spiegata” come nasce l’atto rivoluzionario e che diritto ha l’uomo di cambiare la storia? Il pensatore abruzzese risolve la questione con l’immanenza con cui lo spirito vive nell’individuo e la società nel cittadino, come la coscienza di un valore universale storico e civile in continua formazione. Non si tratta della scoperta dell’infinito che è la Società ma della piena consapevolezza di esso; per questo lo Stato non è più la verità dell’individuo come esterno da questo ma la verità della sua libertà.
È comprensibile a tutti quanto la sua visione della storia non sia tanto dissimile da quella di Hegel e della sua dialettica. Silvio Spaventa però ci mette del suo legando questa concezione al Diritto, da buon giurista. La libertà non è esterna alla legge ma una sintesi di arbitrio e volontà legale il cui risultato è il principio dello Stato.
·Stato
Il compito che Spaventa si diede fu quello di porre lo Stato in una posizione centrale nello spirito, senza nessuna trascendenza; per far questo era necessario formare il liberalismo superando il pensiero di Hegel e quello di Gioberti. Lo Stato non è per lui in contrasto con la libertà particolare, anzi, lo Stato rappresenta la perfezione della libertà del singolo che si fa Stato in quanto giunge a diventare l’autocoscienza della propria ragione. Quindi lo Stato si fa nazionale in quanto è concreto, determinato e storico, per cui non vi può essere trascendenza.
Lo Stato non può estendere senza confini la propria libertà: è il prodotto di un’elaborazione eterogenea, per questo è impossibile negare l’individualità e la volontà dei singoli individui nell’universale. Le individualità si muovono all’interno dello Stato e per lo Stato che dunque non può annullarle se non vuole minare la propria base- “come l’albero ha bisogno della propria radice come nutrimento della propria vita”- e se non vuole rischiare il ritorno ad un’epoca di degrado. Infatti, la volontà soggettiva è necessaria per il progresso della libertà e della legge e ne costituisce la forma primaria su cui si sviluppa quella perfetta della organizzazione statale.
Sulla base di queste teorie il filosofo legittima il regime rappresentativo in cui può esprimersi l’iniziativa particolare e giustifica l’esistenza dei valori politici locali quali il municipio, la provincia o la regione.
Allo stesso modo è assurda la negazione della statalità da parte degli elementi particolari. Quando si nega lo Stato si vuole allora affermarne un altro ed è questo l’atto rivoluzionario che si presenta come il nuovo che vuole abbattere l’antico. Tuttavia, quasi sempre la rivoluzione è figlia dello stesso regime che si vuole abbattere, inserito in un campo più vasto di giudizio.
Lo Stato spaventiano doveva essere: monarchico, laico e neutrale. Monarchico perché deve unificare democrazia ed aristocrazia, libertà ed autorità, governo rappresentativo e potere sovrano; solo la monarchia costituzionale sembra capace di far ciò.
Laico perché ha già in se stesso il divino e dunque una propria religione; questo concetto sta al centro della sua spiritualità anticlericale: la coscienza dell’infinito in cui si attua lo Stato- infinità temporale- esclude e supera ogni altra infinità e non può piegarsi a nessuna di queste. Era sua idea il fatto che un rinnovamento politico porti inevitabilmente anche un rinnovamento religioso; infatti, lo Stato nuovo crea già in sé la sua Chiesa: questa è la forma degli stati moderni colpiti dal protestantesimo. Spaventa non riesce a ben definire la sua laicità: si ferma ad un compromesso tra la statolatria e il riconoscimento di due libertà autonome: una della Chiesa e l’altra dello Stato.
Infine lo Stato deve essere neutrale ma non nel senso di indifferenza bensì nel senso di amministrazione al di sopra delle classi. Questo, per Spaventa, deve essere il compito della politica e perciò chi amministra l’interesse pubblico assume un valore. Il filosofo di Bomba così definisce il suo Stato neutrale: lo “ Stato nasce come eguaglianza di tutte le classi nell’obiettività della legge, neutralità della sua azione, nella obiettività degli interessi”. Inoltre, la giustizia in uno Stato neutrale non deve essere intesa come mera tutela degli interessi individuali ma come comprensione degli interessi vitali e totali della società. Lo Stato non è il diritto contro l’individuo così come il cittadino non può essere l’individuo contro il diritto, bensì lo Stato è la coscienza del diritto e della giustizia che si attua nel cittadino ed è questa la forma della storia nazionale che assume i valori singoli senza annullarli. Sulla base di questo delinea il suo Stato di diritto in due sensi: la collettività per i suoi membri ed i membri per la propria comunità.
Per poter affermare il proprio divenire lo Stato non può rompere i legami con il passato ma neanche deve rifuggire dalla utopia. Ancora ritorna la dialettica hegeliana in cui ogni cosa si afferma (passato), si nega (utopia) e si supera (Stato).
·Liberalismo
Spaventa fu un grande liberale e giornalista esemplare. Il suo era un liberalismo particolare, quel “liberalismo italiano” tanto decantato dal grande Giovanni Gentile secondo cui il pensatore abruzzese direbbe ai liberali del novecento che hanno smarrito il senso dello Stato.
Infatti, vuole distanziarsi sia dal liberalismo anglosassone che dalla democrazia di sinistra; non ammetteva l’introduzione di valori economici nella politica liberale come divenne purtroppo tipico nella Destra “degenere”. Poiché in questa visuale economica del governo liberale, una classe non accetta più di essere uguale nella legge ma vuole anche modificare lo Stato secondo le sue concezioni del bene pubblico.
Come grande giornalista, Spaventa si impegnò per una stampa libera e da uomo politico ebbe sempre un occhio di riguardo per i giornalisti. La sua casa romana era luogo d’incontro per molti giornalisti e lui fu sicuramente il politico dell’epoca con maggiori contatti con loro.
La sua attività giornalistica iniziò a Napoli durante il 1848 come direttore del Nazionale, il giornale durò molto poco (sessantasei numeri in tutto) ma a causa della sua ispirazione liberale gli costò dieci anni di carcere. Esule a Firenze collaborò con la Nazione prima che il suo impegno politico prendesse il sopravvento.
Le sue idee sulla stampa sono tuttora attualissime e fu lungimirante quando, passata un’epoca in cui i giornali non si facevano rabbiosa concorrenza tra loro, affermò che si sarebbe corso il rischio di compromettere l’indipendenza della stampa. Infatti, questa, per potersi finanziare, si stava esponendo troppo all’influenza del potere politico ed economico.
La stampa deve anche avere una certa morale, poiché è essenziale il suo ruolo in un sistema politico democratico. Compito dei giornali, per lui, è quello di giudicare gli atti della politica e mettere così i cittadini nella situazione di potersi opporre a leggi autoritarie. Ciò non è in contraddizione con la sua idea di Stato forte dato che, come già abbiamo visto, questo doveva saper coniugare libertà ed autorità e quindi non era uno Stato autoritario. La morale della stampa doveva anche essere patriottica e badare agli interessi e alla dignità del proprio Paese; dunque, doveva fare a meno di pubblicare certe indiscrezioni sulla politica estera o sulla sicurezza interna soltanto per poter vendere più copie.
·Spaventa oggi
Analizzando la sua esemplare figura, si rimane scoraggiati e ci si accorge di quanto il nostro paese abbia purtroppo dimenticato Silvio Spaventa. La cosiddetta Destra odierna sembra averlo cancellato per inseguire il liberalismo anglosassone tutto su valori economici (vedi Forza Italia); i giornalisti d’oggi sembrano aver dimenticato il suo impegno per una stampa libera, morale ed indipendente e ci appaiono- salvo alcune eccezioni- sempre più servi di questo o quel politico o di questo o quello imprenditore e sempre attenti a vendere copie più di un quotidiano concorrente che ad offrire un reale servizio al paese ed ai suoi cittadini; i liberali italiani non lo citano mai preferendogli qualche figura anglosassone o anglicizzata. Infine si vuole negare e ripudiare lo Stato etico di Spaventa o Gentile affermando erroneamente che questi avrebbe legami con il totalitarismo. Sappiamo bene invece che ben diverse furono le intenzioni dell’idealista abruzzese e ben pochi o nulli i suoi legami con l’autoritarismo.
JOHN STUART MILL

Chiedetevi se siete felici, e cesserete di esserlo.
Riassunto su Mill
Il problema fondamentale che John Stuart Mill si propone di affrontare nella sua filosofia (soprattutto in Sistema di logica deduttiva e induttiva ) è la logica, in particolare il rapporto tra la deduzione e l’induzione. Che tra le due intercorresse un rapporto era cosa certa: tradizionalmente, o si è convinti che vi siano idee innate da cui dedurre tutto, oppure, come fa Mill, si segue la tesi empiristica, secondo cui al momento della nascita la nostra mente è (secondo la celebre concezione aristotelica) una “tabula rasa” da riempire con le esperienze. In questo secondo caso, naturalmente, senza l’apporto di idee innate, il problema si complica esponenzialmente. Come aveva sottolineato Aristotele, il più grande empirista dell’antichità, la deduzione (=dall’universale al particolare) è la forma più pura di ragionamento, ma per potersene avvalere servono princìpi generali da cui dedurre facendo preventivamente un’induzione (=dal particolare all’universale): si deve cioè partire dal particolare per conquistare l’universale e con quest’ultimo costruire i sillogismi. Questo è il grande problema su cui si arrovella Mill, il quale, oltre ad essere positivista, è empirista. In primo luogo, egli effettua una distinzione tra termini denotativi e termini connotativi (riprendendo quell’attenzione per il linguaggio tipica di Bacone e della tradizione inglese in generale): i termini denotativi mi permettono di individuare una cosa, mentre i termini connotativi me la individuano e in più mi danno informazioni sulle caratteristiche di essa. Classico esempio di termini denotativi è dato dai nomi propri, che individuano con precisione la cosa a cui si riferiscono, ma non danno informazioni sulle sue caratteristiche. Esempi di termini connotativi sono, ad esempio, l’aggettivo “razionale” o “bianco”: dicendo che “questo essere è razionale” o che “quel libro è bianco”, “connoto” l’oggetto in questione con delle caratteristiche. Ma Mill fa notare che sono sempre connotativi anche tutti i nomi comuni e che denotativi sono solo i nomi propri (che indicano una cosa e basta); i nomi comuni, infatti, non sono solo un’etichetta, ma forniscono precise indicazioni sulle cose a cui si riferiscono. Se infatti dico che “Marco è un uomo” il termine “uomo” sembra denotativo, perchè non sembra dare suggerimenti sulle caratteristiche di Marco, ma se ben analizzato, si scopre che le dà eccome. Dicendo che “è un uomo” sto dando suggerimenti sulle caratteristiche di Marco (non è una pianta, nè un vegetale); alla distinzione tra termini denotativi e termini connettivi è connessa quella (di forte sapore kantiano) tra proposizioni reali (legate ai termini connotativi) e proposizioni verbali. Le proposizioni verbali sono quelle proposizioni che non dicono nulla di nuovo (“tutti gli uomini sono razionali”) e corrispondono per questo ai giudizi analitici a priori di Kant; con le proposizioni reali (corrispondenti ai giudizi sintetici a posteriori di Kant) , invece, si dicono cose nuove e arricchenti e, proprio per questo, sono connotative (“il libro è blu”). A questo punto il problema centrale che Mill si pone riguarda l’inferenza, ovvero il ragionamento: bisogna stabilire quale valore abbiano soprattutto le inferenze che si avvalgono di proposizioni reali. E Mill sulle orme di Kant vuole, in sostanza, sapere come siano possibili i giudizi sintetici a priori, ovvero come sono possibili i ragionamenti che portano ad un ampliamento delle conoscenze. Come è possibile il ragionamento arricchente “Socrate è uomo, l’uomo è mortale, dunque Socrate è mortale”? In altre parole, come faccio a sapere che Socrate morirà ancor prima di aver empiricamente constatato la sua morte effettiva? E’ un ragionamento valido? E se sì, perchè? Mill, da buon empirista, tende a non credere che siano possibili i giudizi sintetici a priori, poichè essi implicano in qualche modo la presenza innata di concetti nella mente: al contrario, ogni conoscenza (perfino quella matematica) passa attraverso l’esperienza; se le cose stanno così, però, resta da chiedersi come si possano giustificare proposizioni reali che siano valide ed universali. In altri termini, Mill perviene alla presa di coscienza che se si ammette la validità del metodo induttivo (=dal generale al particolare) le possibilità sono due: la prima consiste nell’ ammettere che, attraverso l’induzione, si giunga a verità generali da cui dedurne altre particolari già implicite; in questo caso, la deduzione funziona ma è del tutto inutile. Infatti, quando, ad esempio, considero i 12 apostoli e dico che ciascuno è ebreo, arrivo all’affermazione generale che i 12 apostoli sono tutti ebrei e da essa potrò dedurre che uno qualsiasi dei 12, proprio perchè apostolo, è ebreo. Il che è perfettamente logico, ma anche totalmente inutile: questa deduzione, infatti, ha carattere tautologico, giacchè non dice nulla di nuovo che non fosse già implicito in partenza. E Mill fa notare che le deduzioni interessanti sono quelle che ampliano la conoscenza, quelle cioè che predicano qualcosa di nuovo: ed è questa la seconda possibilità. Quando dico che tutti gli uomini sono mortali e che Socrate, in quanto uomo, è anch’egli mortale, amplio per davvero la mia conoscenza, dal momento che affermo che Socrate morirà ancor prima che egli sia effettivamente morto. Nel caso dei 12 apostoli, si parte da verità particolari per approdare a verità generali per poi far ritorno a verità particolari; nel secondo caso, invece, si constata empiricamente la mortalità degli uomini e per induzione si arriva a dire che, poichè tutti gli uomini presi in esame sono morti, allora tutti gli uomini sono mortali. Quella degli apostoli (che Mill definisce “enumerazione completa” per il fatto che non si è tralasciato nessun elemento), per dirla con Kant, è una verità analitica, certa ma tautologica; quella di Socrate, invece, (che Mill designa col nome di “enumerazione semplice”, poichè non si esaminano tutti gli uomini esistenti, ma solo una parte di essi) è sintetica, ovvero arricchisce la conoscenza; tuttavia questo secondo tipo di induzione, a differenza del primo tipo, crea dei problemi. Infatti, quella degli apostoli è un’induzione per enumerazione completa, dove cioè affermo che tutti e 12 gli apostoli sono ebrei perchè l’ho appurato empiricamente esaminando ciascuno di essi; con il caso dell’induzione per enumerazione semplice (il caso di Socrate), la situazione cambia, visto che si predica la mortalità di Socrate mentre egli è ancora in vita, il che equivale a dire che si predica un qualcosa senza averlo constatato empiricamente. E del resto, nota Mill, effettuare un’enumerazione completa su tutti gli uomini per dire che sono tutti (dal primo all’ultimo) mortali sarebbe impossibile: dovrei infatti analizzare uno ad uno tutti gli uomini del presente, del passato e del futuro per vedere se sono effettivamente morti; e anche fatta questa operazione, resterei fuori dall’enumerazione io che la sto facendo. Tuttavia, quando ci si trova di fronte ad una miriade di casi (come per la mortalità degli uomini), si è costretti, nell’impossibilità di esaminare uno ad uno i singoli casi, a ricorrere all’enumerazione semplice: ma che cosa legittima questo tipo di induzione? Infatti, se l’enumerazione completa si giustifica da sè, quella semplice (basata su pochi casi) implica la deduzione per Socrate di ciò che si è dedotto per altri. Questo procedimento può essere legittimato solo se si ricorre ad una logica di tipo realista, che ammette cioè l’esistenza reale degli universali: in tale situazione, in cui non esistono solo gli individui, ma pure gli universali, si può ricorrere (nell’esempio della mortalità degli uomini) all’universale “umanità”, intesa appunto come universale di cui partecipano tutti i singoli esseri umani, per cui ciascuno può dire di essere umano perchè partecipa dell’universale “umanità”. E l’ammissione degli universali permette di effettuare affermazioni generali: attraverso l’esperienza di un numero limitato di casi (A,B,C), diceva Aristotele, posso cogliere non solo i tre casi presi in considerazione (A,B,C), bensì anche le caratteristiche inerenti all’essenza universale di uomo. Il caso estremo di questo procedimento è rappresentato dalla geometria, in cui una volta fatta la dimostrazione del teorema di Pitagora per un singolo triangolo rettangolo, si ha la certezza che esso sia valido per tutti gli altri triangoli rettangoli possibili ed immaginabili. Ne consegue che, in una prospettiva realista che ammette gli universali, si può dire che, attraverso una serie di casi limitati si perviene all’universale, anche se magari i casi esaminati sono pochissimi, cosicchè potrò affermare che tutti coloro i quali partecipano della forma uomo saranno necessariamente mortali, proprio perchè tutti gli uomini singoli esaminati sono morti. Il problema risiede però nel fatto che, da Ockham in poi, la logica realista è stata sostituita da quella nominalista (che non ammette l’esistenza degli universali): questo esclude la possibilità che da pochi casi si possa pervenire ad un’affermazione generale valida universalmente, proprio perchè nulla esiste all’infuori dei casi singoli. E, saltato l’universale, salta anche la possibilità di fare il gioco (lecito nell’ambito di una logica realistica) per cui passo dalla mortalità di A, B e C alla mortalità dell’universale uomo e, infine, a quella di Socrate. E nel caso della logica realista, l’universale altro non era se non la mediazione che mi consentiva di passare dalla mortalità di A, B e C a quella di Socrate, proprio perchè ammettevo che A, B e C e Socrate avessero in comune il fatto di partecipare dell’universale “umanità”. Come giustifica, dunque, Mill il processo di enumerazione semplice nel nominalismo? Nella concezione nominalista, egli dice, non esistono realtà universali, ma, ciononostante, esistono cose che hanno funzioni universali: ed è il caso dei nomi comuni, per cui quando dico “uomo” non alludo all’universale “uomo”, ma a tutti quegli enti dotati di determinate caratteristiche comuni, quali l’avere due gambe, due occhi, una testa, ecc. Nella definizione di uomo come essere avente due gambe, due occhi e una testa, attenzione, non rientra la mortalità: considerando tre uomini, A, B e C, ci accorgiamo che tutti e tre muoiono e per induzione affermiamo che tutti gli uomini sono mortali; dopo di che, esaminiamo Socrate e ci accorgiamo che, alla pari di A, B e C, è dotato di due gambe, due occhi e una testa, ma è vivo e vegeto: come possiamo affermare che anch’egli è mortale? Che sia un uomo lo so dal fatto che ha due occhi, due gambe e una testa e, spiega Mill, posso arrivare a dire che è mortale attraverso il principio dell’uniformità delle leggi di natura , secondo cui quando dei singoli casi presentano costantemente un gruppo di caratteristiche comuni (occhi, gambe, testa) più un altro gruppo (la mortalità), allora anche l’ennesimo caso considerato (Socrate) che presenterà il primo gruppo di caratteristiche, avrà anche il secondo gruppo. Ma allora si torna al passaggio mediato dall’universale, obietterà qualcuno. E invece no, dice Mill, poichè al posto dell’universale c’è il principio, il quale implica che la natura non si comporti a caso, ma con regolarità ( ” è una legge che in natura ci siano leggi “, dice Mill), per cui tutti gli uomini del passato, oltre ad avere la testa, le gambe e gli occhi, sono morti e dato che la natura si comporta secondo una certa regolarità, anche gli uomini del futuro dotati di gambe, occhi e testa saranno pure loro mortali. Si deve però legittimare tale principio di uniformità delle leggi di natura e la risposta di Mill è paradossale: egli dice che lo si fonda induttivamente, ovvero da quando siamo nati abbiamo sempre sperimentato che la natura segue una regolarità definita. Al che si potrebbe obiettare che, in fin dei conti, tale principio altro non è se non un postulato; già Hume si chiedeva con insistenza che cosa facesse sì che ciascuno di noi nutra in sè la certezza di vedere ogni mattina sorgere il sole e rispondeva dicendo che è l’abitudine di vederlo sorgere ogni mattina; ora Mill si chiede, in modo analogo, “che cosa mi garantisce che, visti morire tutti gli uomini finora considerati, anche Socrate un giorno dovrà morire?” Se Hume rispondeva servendosi dell’abitudine, Mill invece si serve del principio dell’uniformità delle leggi di natura, che a suo avviso non è un mero postulato, bensì è fondato sull’esperienza. Però egli commette l’errore di fondare induttivamente la verità del principio quando dovrebbe essere questo principio ad autorizzare l’uso dell’induzione; si tratta, evidentemente, di un circolo vizioso, visto che Mill ricorre al principio per legittimare l’induzione e poi fonda tale principio sull’induzione stessa! Ma Mill obietta che si tratta di un’induzione talmente vasta che possiamo considerarla non per enumerazione semplice, ma per enumerazione completa, giacchè il numero di esperienza su cui si fonda tale principio non le esaurisce tutte, ma è comunque talmente vasto (si tratta di tutte le esperienze fatte nella storia!) che, se in teoria appartiene all’enumerazione semplice, in pratica finisce per appartnere a quella completa. E, come abbiamo visto nel caso dei 12 apostoli, l’enumerazione completa si autolegittima, per cui il principio dell’uniformità delle leggi di natura non è un postulato e può fondare l’induzione per enumerazione semplice senza propriamente appartenere ad essa. Si è pertanto superato il circolo vizioso e si è fondata l’induzione per enumerazione semplice sulla base di quella per enumerazione completa. Certo, in termini strettamente matematici, sarebbe errato dire che il principio dell’uniformità delle leggi di natura è per enumerazione completa, poichè, pur essendo assai vasto, non esaurisce tutte le esperienze possibili; ma tuttavia, sul piano pratico (che è quello che sta a cuore ad un positivista quale è Mill) si può approssimare e legittimare l’idea (su cui si fonda il sapere umano) secondo la quale dai casi particolari è lecito effettuare generalizzazioni per poi trarne delle conclusioni. Una volta giustificata l’induzione semplice, sorge il problema di indicare quale è il metodo per indagare la realtà e a tal proposito Mill riprende la tradizione empirista inglese di stampo baconiano: proprio Bacone, infatti, aveva elaborato la teoria delle tre tavole, volta a render praticabile un’induzione che si effettuasse attraverso un numero relativamente limitato di casi. Mill resta fedele alle tre tavole ma, per così dire, ne aggiunge una quarta, una sorta di nuovo principio che prescrive l’uso di uno strumento efficace per individuare la causa di un fenomeno; nel constatare che, in due situazioni pressochè analoghe, il fenomeno esaminato si verifica solo in una delle due, si deve cioè individuare quell’unica differenza che distingue le due situazioni: tale elemento (presente solo nella situazione da cui si è verificato il fenomeno analizzato) sarà appunto la causa dell’evento. Facciamo un esempio concreto: nel Settecento scompare definitivamente dal mondo occidentale la peste, che però continua a flagellare quello orientale; sia l’Oriente sia l’Occidente hanno pressochè le stesse condizioni (guerre, climi simili, etc), ma vi è una differenza imprescindibile ed è lo Stato assoluto, presente in Occidente e non in Oriente. Se ne ricava che è lo Stato assoluto la causa della scomparsa della peste dal mondo occidentale. Dopo di che, Mill concentra la sua attenzione sulla psicologia , che Comte si era rifiutato di annoverare fra le scienze: il pensatore inglese, invece, assume un atteggiamento diametralmente opposto e non si limita a riconoscere che la psicologia è una scienza legittima, ma arriva addirittura a ravvisare in essa il fondamento delle scienze. Tutta la conoscenza umana, infatti, secondo Mill, si struttura attraverso l’acquisizione per via empirica di idee semplici che si aggregano per via associazionistica (Mill conosceva benissimo le tesi formulate in merito da suo padre) attraverso norme psichiche. Ne consegue che la conoscenza umana non può non passare attraverso la psiche e, pertanto, la psicologia assurge a vera e propria scienza fondatrice delle altre scienze. A questo punto, poi, Mill si pone un annoso problema su cui da sempre si interroga la filosofia: si tratta del problema della prevedibilità dell’agire umano . Come è possibile creare le scienze umane (psicologia, antropologia, sociologia) se l’uomo (a differenza degli altri enti) ha un comportamento non rigorosamente prevedibile? Le risposte possibili sembrano essere due: o si presuppone (sulla scia di Cartesio, Hobbes e Spinoza) che gli uomini siano macchine del tutto prevedibili e prive di libertà e pertanto si ammette la possibilità di fondare delle scienze umane davvero rigorose; oppure si ammette la libertà umana e, in questo caso, salta la prevedibilità del comportamento e, con essa, la possibilità di creare delle scienze umane. Mill dà una risposta che si distacca dalle due appena proposte: si tratta di una risposta che molto risente della lezione positivistica ed è, per molti versi, semplice e coerente. Mill non fa altro che fare una distinzione tra metafisica e vita quotidiana: se anche ammettiamo che l’uomo (tanto il singolo quanto i gruppi), metafisicamente, sia libero, ciò non toglie che egli, nella vita di tutti i giorni, si comporti con una certa regolarità e che tale regolarità possa essere espressa sotto forma di norme. Pertanto, Mill, pur riconoscendo la libertà metafisica all’uomo, riconosce una certa prevedibilità del comportamento nella vita pratica ed è proprio su questo che, egli afferma, diventa possibile studiare le leggi di comportamento degli individui (psicologia), della collettività (sociologia), e così via. E Mill è convinto di dover usare, nel campo delle scienze sociali, quello che lui definisce metodo deduttivo concreto , il quale si fonda sul fatto che le realtà sociali sono le più complesse e sul fatto che su di esse non si possono fare esperimenti, come invece avviene nei laboratori chimici. Nel caso delle scienze sociali, egli dice, a fungere da esperimento è la storia stessa: il che significa che, di fronte alla domanda “che cosa causa quel determinato fatto sociale?”, la prima cosa da fare è elaborare un’ipotesi su quale combinazione di cause potrebbe averlo determinato; e poi bisognerebbe effettuare la verifica sperimentale, che, nel caso delle scienze sociali, è inattuabile: si deve pertanto ripiegare sulla storia, esaminando dove si è verificata storicamente quella data combinazione di cause e se ha generato lo stesso evento sociale che stiamo esaminando. La verifica sperimentale cede il passo a quella storica. Accanto alle considerazioni logiche, Mill si è anche occupato molto di politica , cercando di organizzare un movimento radicale che coinvolgesse l’ala progressista del partito liberale inglese: egli si fa portavoce di ideali definibili, in senso lato, di “liberalismo radicale”. In un’epoca e in uno Stato in cui il liberalismo aveva attenuato ogni punta rivoluzionaria e, anzi, era divenuto la struttura portante del sistema, è significativo che il filosofo inglese ne dia una lettura in chiave progressista: egli separa la politica e l’economia, condannando (da buon liberale) il socialismo, inteso come ingabbiamento del libero corso dell’economia e brutale collettivizzazione dei mezzi di produzione; se Mill non condivide il socialismo, è però un dato di fatto che il socialismo novecentesco condividerà (e farà sue) le teorie politiche di Mill. L’economia, secondo il filosofo inglese, può solo funzionare in una situazione di libero mercato e, pertanto, bisogna riconoscere piena libertà all’economia; ma (e qui sta la novità) altra cosa è la politica e, in particolare, la distribuzione delle ricchezze: si deve, dice Mill, creare una volontà umana tale da creare una maggiore equità sociale. Da ciò ben si intuisce come la politica e l’economia risultino divise: economicamente deve regnare la massima libertà in modo che si produca il più possibile; sul piano politico, però, si deve far sì che si attui una più equa distribuzione dei beni. Proprio da queste considerazioni traspare l’ utilitarismo (maggior felicità possibile per il maggior numero possibile di persone) che informa la filosofia milliana: non solo si deve fare una specie di calcolo dei piaceri, ma all’interno di tale calcolo bisogna anche inserire piaceri di tipo spirituale, tra cui l’ altruismo , ovvero l’idea che diffondere il piacere ad altre persone crei piacere anche a se stessi. Interessante è il fatto che il liberalismo inglese di ispirazione lockeana aveva insistito sul principio che si dovesse fare di tutto per difendere la libertà dell’individuo dalla potenziale autorità statale, servendosi soprattutto di strutture della società civile: l’idea era che l’individuo, lasciato in balia di se stesso, viene sopraffatto dallo Stato e pertanto deve essere protetto da tali sopraffazioni attraverso organismi intermedi (le corporazioni, gli ordini, la famiglia, i partiti, i sindacati, ecc). Mill, invece, stravolge la tradizione liberale e scopre che la vera minaccia per la libertà dell’individuo non è più lo Stato, ma è quella società civile che i liberali classici vedevano come strumento di difesa: in particolare, il vero pericolo è rappresentato dalla pressione sociale verso il conformismo, pressione che tende ad uniformare la società intera. La libertà dell’individuo, dice Mill, deve assolutamente essere garantita non solo perché è un principio della morale liberale, ma anche perché la libertà di non essere conformisti, oltre ad essere un vantaggio per l’individuo, è anche un bene per la società. Una società condannata ad essere omogenea, infatti, non potrebbe sperimentare nulla di nuovo e ciò nuocerebbe sia ai singoli sia alla società nel suo complesso. E così lo Stato, non solo cessa di rappresentare una minaccia per la libertà degli individui, ma anzi ne diventa il garante; è infatti lo Stato che garantisce la libertà contro le pressioni sociali. Se del resto ci chiediamo da che cosa è garantita la parità dei sessi al giorno d’oggi non possiamo certo rispondere che è garantita dalla società: è lo Stato ad assicurarla. Per quel che riguarda la religione , la filosofia milliana, così impegnata in ambito politico e sociale, riprende la remota idea, di ascendenza platonica, di Dio come puro e semplice artigiano che si limita a plasmare e ad ordinare il mondo. Il Dio di Mill, dunque, non è onnipotente, poiché si limita ad ordinare un materiale che non è stato da lui creato: e dalla non-onnipotenza divina, Mill deduce l’idea secondo la quale Dio ci chiama tutti a collaborare con lui per rendere migliore il mondo. Del resto, se Dio fosse onnipotente, non si spiegherebbe perché il mondo non è perfetto e ogni nostra azione perderebbe di significato. Questa riflessione religiosa è il coronamento generale di una filosofia orientata in tutto e per tutto all’azione utile.
UTILITARISMO DELLE NORME
Influenzato dall’utilitarismo di Jeremy Bentham, Mill è convinto che, accanto ai piaceri di natura fisica, ne esistano altri, spirituali e intellettuali: questi, almeno per il dotto, hanno intensità decisamente superiore rispetto ai primi. In questo modo, Mill abbandona la “quantificazione del piacere” (il piacere è quantificabile soltanto se riferito alla sensibilità) e arriva a sostenere apertamente la natura qualitativa dei piaceri. Anch’egli, come gli altri utilitaristi, è convinto che il motore dell’agire umano sia il piacere, inteso però in maniera qualitativa: viene così a cadere l’accusa di quanti liquidavano l’utilitarismo come mera riproposizione dell’etica epicurea. Su questa scia, Mill distingue attentamente tra “soddisfazione” (della quale si accontentano gli animali) e “felicità”, tipica degli uomini e caratterizzata da un senso di realizzazione implicante la soddisfazione di piaceri intellettuali. Mill critica Bentham accusandolo di non aver considerato i piaceri intrinsecamente, ma sempre solo per le loro conseguenze contingenti. L’introduzione dell’elemento qualitativo fa sì che la matematizzazione dei piaceri operata da Bentham sia impossibile: la conseguenza è che la valutazione dei piaceri qualitativamente intesi sfugge alla calcolabilità e al cognitivismo etico; l’utilitarismo dell’azione di Bentham cede il passo ad un utilitarismo della norma. Quest’ultimo mantiene il principio per cui le azioni devono essere valutate in base alle conseguenze, ma nella consapevolezza che, perché ciò sia possibile, si debbano impiegare regole accumulate tramite esperienze pregresse. Questa mossa teorica permette a Mill di difendersi dall’accusa tradizionalmente mossa all’utilitarismo, accusa secondo la quale esso sarebbe inapplicabile perché destinato a rimanere in un’insuperabile condizione di attesa di verifica delle conseguenze di ogni azione. Le norme con cui secondo Mill deve operare l’utilitarismo gli permettono di evitare le secche dell’attesa inattiva e, al tempo stesso, gli forniscono criteri operativi alternativi all’algebra dei piaceri. Queste norme sono, in definitiva, il risultato dell’esperienza che l’uomo ha storicamente fatto a partire dalla preistoria per arrivare fino ad oggi. Con l’utilitarismo delle norme diventa però difficile riconoscere quali siano le azioni positive, nella misura in cui il piano del piacere è passato al piano qualitativo e soggettivo e investe tutta un’esperienza storica. A questo punto, Mill introduce il senso del dovere come componente interna all’uomo che lo esorta ad agire in un determinato modo: è infatti il senso del dovere che fa sì che io valuti come positiva un’azione sulla base del patrimonio storico sedimentato nella mia coscienza. Tale senso del dovere non deve essere confuso con l’imperativo categorico kantiano, che prescinde dalle determinazioni storiche e ha un valore assolutamente aprioristico: il senso del dovere di cui dice Mill ha una sua storia, si basa sull’utile, proviene da un sentimento poggiante su tutte le esperienze passate tradottesi in dimensione coscienziale. In questo modo, Mill si sta avvicinando inaspettatamente al “sentimento morale” di Hutcheson, secondo il quale vi sono azioni che dispiacciono immediatamente al mio sentimento morale e vanno perciò incontro a una condanna morale.
COMMENTO DEL SAGGIO SULLA LIBERTA’
Il principio guida e’ quello dell’importanza per l’uomo e per la societa’ di una larga varieta’ di caratteri e di una completa liberta’ della natura umana. Cio’ spiega il principio forte milliano di limitazione dell’intervento statale: la societa’ puo’ interferire solo per proteggersi. L’individualismo di Mill si rifa’ al principio di von Humboldt:(1767-1835) dell’assoluta ed essenziale importanza dello sviluppo umano nella sua piu’ ricca diversita’ che costituisce il motto di On Liberty. Esso impone di proteggersi dalla tirannia dell’opinione e del sentimento predominanti che come l’ispettore onniveggente e invisibile del Panopticon bentamiano toglie anche il desiderio di pensare. E con Tocqueville, Mill sottolinea come trovandoci tutti piu’ o meno al medesimo piano (per esempio con la tv)diremo noi oggi), cio’ che conta e’ il numero e la fede dell’opinione pubblica diviene una specie di religione e la maggioranza e’ il suo profeta. Ecco profilarsi il conflitto come garanzia di base di una societa’ aperta. Quindi esiste una stretta connessione tra liberta’ di opinione e liberta’ di espressione.
ON LIBERTY (1858)
Introduzione
Argomento del saggio è la liberta’ civile o sociale: la natura e i limiti del potere che la societa’ puo’ legittimamente esercitare sull’individuo. Attenzione al concetto di volonta’ del popolo che significa la volonta’ della parte del popolo piu’ numerosa: la maggioranza che inaugura quella tirannia della maggioranza, talvolta piu’ potente di molti tipi di oppressione politica. Si ricorda che dovunque vi sia una classe dominante, la morale del paese emana dai suoi interessi di classe e dai suoi sentimenti di superiorita’ di classe. Il principio e’ che l’umanita’ e’ giustificata, individualmente o collettivamente, a interferire sulla liberta’ d’azione di chiunque soltanto al fine di proteggersi, per evitare danno agli altri. Il bene dell’individuo, sia esso fisico o morale, non e’ una giustificazione sufficiente. Non lo si puo’ costringere a fare o non fare qualcosa perché e’ meglio per lui, perché lo rendera’ piu’ felice, perché nell’opinione altrui, e’ opportuno o perfino giusto. Si deve rendere conto solo per cio’ che riguarda gli altri: su se stesso sulla sua mente e sul suo corpo, l’individuo e’ sovrano. Mill esclude i minori, le societa’ arretrate. Il criterio che informa Mill e’ l’utilita’, ma nel suo senso piu’ ampio, fondata sugli interessi permanenti dell’uomo in quanto essere progressivo. La regione propria della liberta’ umana e’ quella parte di vita che riguarda soltanto lui ed e’ la sfera della coscienza interiore, ed esige la liberta’ di coscienza di pensiero, di opinione e di espressione e di associazione. Ciascuno e’ l’unico autentico guardiano della propria salute , sia fisica, sia mentale e spirituale.
Della liberta’ di pensiero e discussione
Impedire l’espressione di un’opinione significa derubare la razza umana, e procurare un dano a coloro che dall’opinione dissentono ancor piu’ di chi la condivide: se l’opinione e’ giusta essi non possono passare dall’errore alla verita’, se e’ sbagliata perdono la percezione piu’ chiara e viva della verita’. Inoltre, quando le dottrine contrastanti contengono entrambe una parte di verita’, l’opinione dissidente e’ necessaria per integrare la dottrina piu’ generalmente accettata con cio’ che le manca. Essere certi della falsita’ di una opinione senza ascoltarla significa presupporre che la propria certezza coincida con la certezza assoluta. Mill, cita Socrate, i cristiani ortodossi, Marco Aurelio. Il reale vantaggio della verita’ e’ che quando un’opinione e’ vera, pur soffocandola, riapparira’ in circostanze che le permetteranno di sfuggire alla persecuzione. Mill si scaglia contro la intolleranza dei cristiani e contro il silenzio degli eretici. Ci sono uomini che esauriscono il loro ingegno nel tentativo di conciliare gli impulsi della coscienza e della ragione con l’ortodossia. Un pensatore deve seguire il suo intelletto indipendentemente dalle conclusioni cui esso conduca. Inoltre quando una verita’ non si discute finisce per essere un freddo dogma. Le religioni all’inizio sono sentite tutte piene di significato e vitalita’; quando una religione ha il sopravvento e diviene l’opinione generale arresta il suo progresso: i suoi seguaci la ereditano e non l’adottano, assistendo passivamente al declino della forza vitale di una dottrina. Quando una fede non lotta per sopravvivere, ma e’ ereditata, ricevuta passivamente, si dimentica tutto salvo le formule e la si accetta cosi’ tiepidamente sulla fiducia, sentendosi dispensato dalla sperimentazione personale. La fede resta esterna alla mente, e la incrosta e la calcifica contro tutto cio’ che e’ nuovo e vivo. Il cristiano ha da una parte le leggi del NT e dall’altra la consuetudine del suo paese: al primo criterio offre il suo omaggio, al secondo la sua reale sottomissione. A chi afferma che la libera espressione vada consentita a condizione che si discuta educatamente, si risponde che e’ difficile definirne i limiti leciti. Inoltre le scorrettezze piu’ gravi: sofismi, nascondere fatti, esporre la questione in modo inesatto, travisare l’opinione avversa, vengono fatte spesso in buona fede.
Dell’individualita’ come elemento del bene comune
L’unanimita’ non e’ auspicabile e cosi’ e’ utile che vi siano differenze d’opinione e differenti esperimenti di vita. Il libero sviluppo dell’individualita’ e’ uno degli elementi fondamentali del bene comune anche se il valore intrinseco della individualita’ e’ male riconosciuto. E’ decisiva la dottrina di von Humboldt La natura umana non e’ una macchina da costruire secondo un modello e da regolare perché compia esattamente il lavoro assegnatole, ma un albero, che ha bisogno di crescere e svilupparsi in ogni direzione, secondo le tendenze delle forze interiori che lo rendono una creatura vivente. Il genio puo’ respirare solo in un’atmosfera di liberta’: se non esiste la societa’ non trarra’ alcuno beneficio dal loro genio. Il dispotismo della consuetudine e’ ostacolo del progresso umano: un popolo si ferma quando cessa di possedere l’individualita’.
Dei limiti all’autorita’ della societa’ sull’individuo
Il fatto di vivere in societa’ rende indispensabile che ciascuno sia obbligato a osservare una certa linea di condotta nei confronti degli altri: egli non deve danneggiare certi interessi , denominati dalla legge o per tacito accordo i diritti, e poi deve sostenere la propria parte per difendere la societa’. Al di la’ di questo, nessun gruppo e’ autorizzato a dire a un adulto che per il suo bene non puo’ fare della sua vita quel che sceglie di farne. Ciascuno e’ la persona maggiormente interessata al proprio benessere, l’interesse che chiunque altro puo’ avervi e’ minimo in confronto al suo, inoltre l’uomo o la donna piu’ ordinari hanno mezzi di conoscere i propri sentimenti incommensurabilmente superiori a quelli di cui puo’ disporre chiunque altro. Esiste il diritto ad esortare, a disapprovare, a provare sentimenti rispetto al comportamento della persona, ma non costringerla a fare cio’ che e’ per noi il suo bene. Gli atti che danneggiano altre persone vanno trattati in modo completamente diverso. Violare i diritti altrui merita la riprovazione morale e il castigo. In presenza di un preciso danno, o di un preciso rischio di danno, per il pubblico o per un individuo il caso esula dalla sfera della liberta’ e rientra in quella della moralita’ e della legge. Per il danno che l’uomo fa a se stesso si tratta di un fastidio che la societa’ puo’ permettersi negli interessi di un bene maggiore: la liberta’ umana.
Applicazioni
Mill e’ a favore della liberta’ ed e’ contro il proibizionismo, contro la chiusura delle bische. L’uomo, pero’, seppure volontariamente, non puo’ vendere se stesso: vendendosi come schiavo rinuncia proprio alla liberta’. Il principio della liberta’ non puo’ ammettere che si sia liberi di non essere liberi. Per il resto, per von Humboldt il matrimonio puo’ essere disciolto quando i due contraenti sono d’accordo. Mill e’ piu’ cauto per la grande rilevanza morale di questo particolare rapporto. Poi si scaglia sul potere dispotico dei mariti sulle mogli. Mill sostiene, inoltre che deve essere riconosciuto il dovere di attuare l’istruzione dei bambini la cui educazione non puo’ essere lasciata al potere assoluto dei genitori. Lo Stato deve rende obbligatoria l’istruzione, ma non e’ detto che debba dirigerla: cio’ contraddirebbe la necessita’ di diversita’ di opinione. Obiezioni all’interferenza governativa che non costituisca violazione della liberta’.
1. L’azione puo’ essere compiuta meglio da singoli individui che dal governo. Infatti nessuno e’ tanto adatto a condurre degli affari, quanto coloro che vi hanno un interesse personale.
2. Anche se i singoli individui non sono mediamente in grado di svolgere una data attivita’ altrettanto bene che i funzionari governativi e’ auspicabile che sia svolta da loro come mezzo di educazione intellettuale.(Giurie popolari).
3 ciascuna funzione che viene ad aggiungersi a quelle che il governo gia’ svolge, amplia il suo campo di influenza sulla speranza e sul timore umani, e trasforma sempre piu’ gli individui in parassiti del governo.
Nei paesi in cui tutto e’ svolto tramite la burocrazia, non e’ possibile fare assolutamente nulla cui essa sia realmente contraria. Il principio pratico e’ la massima disseminazione del potere che non vada a scapito dell’efficienza e la massima centralizzazione, e diffusione dal centro, dell’informazione
ERNST MACH

Non sono i corpi che generano le sensazioni, ma sono i complessi di sensazioni che formano i corpi
Ricca, sottile e storicamente influente è l’opera dello scienziato e filosofo Ernst Mach (1838-1916), grande esponente di rilievo del movimento empiriocriticista e, insieme, uno dei principali pensatori della cultura tardo-ottocentesca. Professore a Vienna dal 1895, vi svolse attività che costituirà uno dei principali termini di riferimento dell’indirizzo neo-positivistico. Le sue principali opere sono La meccanica nel suo sviluppo storico-critico (1883), L’analisi delle sensazioni (1886), Conoscenza ed errore (1905). Il punto di partenza di Mach è analogo a quello di un suo contemporaneo: Avenarius. Anch’egli intende escludere dall’ambito della riflessione tutto quanto non può essere riportato alla diretta esperienza empirica. Bisogna rinunciare, scrive in un’ispirazione che sarà più tardi quella del neopositivistico Circolo di Vienna, ” a rispondere a domande riconosciute prive di senso “; e il “senso” manca dove non è possibile mostrare i dati sensibili che potrebbero confermare una determinata asserzione. Insensata o addirittura mitica (e questo è uno degli aspetti della diretta polemica machiana contro il positivismo) appare a Mach l’odierna fede ” nel potere magico della scienza “: una fede, appunto, magica (ossia non razionale e non verificabile) nella misura in cui si manifesta come pretesa di ” giungere fino al fondo dello sconfinato abisso della natura, nel quale ai nostri sensi non è dato penetrare “. In realtà, là dove i sensi non possono giungere non v’è per Mach, propriamente parlando, nulla. Ma anche per quanto riguarda i corpi empirici (che pure sembrerebbero oggetto di esperienza sensibile) bisogna evitare pericolosi fraintendimenti, derivanti da presupposti realistici e fattualistici che Mach combatte con ancor maggior radicalità di Avenarius. Considerati con rigore, i corpi empirici non esistono come tali, non hanno alcuna consistenza di tipo sostanzialistico. Ciò che esiste è solo una serie di sensazioni semplici, irriducibili, tra loro intimamente congiunte in una sorta di flusso continuo. Spesso anche Mach preferisce chiamare queste sensazioni “elementi”, per cercare (ma lo sforzo è parso ad alcuni non del tutto riuscito) di non dare una connotazione soggettivo-psicologica al suo pensiero. La sua tesi principale è, in ogni caso, che ” non sono i corpi che generano le sensazioni, ma sono i complessi di sensazioni che formano i corpi “. Le sensazioni – aggiunge Mach – non sono i simboli delle cose. Piuttosto è la cosa un simbolo mentale per un complesso di sensazioni relativamente stabili”. E ancora: ” Non le cose, ma i colori, i suoni, le pressioni, gli spazi, i tempi (ciò che noi ordinariamente chiamiamo sensazioni) , sono i veri elementi dell’universo “. Non bisogna peraltro interpretare queste tesi come ritorno puro e semplice a un vecchio sensismo fenomenistico di tipo berkeleyano. Nell’ Analisi delle sensazioni lo stesso Mach, pur non tacendo la sua simpatia per Berkeley (e per Hume), respinge esplicitamente un avvicinamento delle sue posizioni a quelle del filosofo irlandese. In effetti egli considera la realtà come qualcosa di più complesso che la mera risultante di un insieme di sensazioni: egli scrive a questo proposito “devo osservare che neppure per me il mondo è una semplice somma di sensazioni. Io parlo piuttosto, espressamente , di relazioni funzionali degli elementi “. Dove lo sforzo machiano, come si è detto sopra, è di sottolineare il contenuto non meramente psico-soggettivo dei fenomeni costituenti il mondo. D’altronde anche la sensazione in sé e per sé tende in Mach a sganciarsi da un troppo immediato riferimento all’io, al soggetto. La sua oggettività è garantita dall’oggettività delle sue matrici fisiologiche e dall’elaborazione scientifica cui è sottoposta. In effetti, uno degli aspetti più significativi del pensiero machiano è proprio il tentativo di autonomizzare i fenomeni, e la riflessione su di essi, dalla soggettività. Non può, egli scrive, interpretare correttamente il mondo chi ” non è in grado di abbandonare l’idea dell’io considerato come una realtà che sta alla base di tutto “. La modernità del pensiero machiano sta, tra l’altro, proprio in questa sua concezione di un mondo senza “base”, senza fondamento; cioè un mondo dove semplicemente avvengono certi fenomeni che si tratta di spiegare nel modo più immediato e sobrio possibile, attraverso l’uso di quelle osservazioni empirico-sensoriali e di quelle misurazioni fisico-matematiche che saranno di lì a poco privilegiate dai neo-positivisti del Circolo di Vienna. Un altro aspetto del machismo sul quale occorre richiamare l’attenzione è l’efficacia con cui l’autore dell’ Analisi delle sensazioni si è saputo sbarazzare di tutta una serie di categorie e principi gnoseologici (la sostanza, l’accidente, lo stesso assetto categoriale Kantiano) che apparivano non più attuali. Di altre nozioni – lo spazio, il tempo, il movimento – Mach dà una nuova versione in chiave empiristica, che eserciterà una notevole influenza sulla riflessione epistemologica tra Otto e Novecento. In sede più propriamente scientifica Mach, che aveva una rilevante competenza nel campo delle scienze fisiche, è uno dei filosofi i tardo-ottocenteschi che meglio comprendono certe radicali trasformazioni teoriche del sapere (scientifico) dell’epoca. Nella Meccanica nel suo sviluppo storico egli dà anzi un importante contributo a tale trasformazione rivedendo criticamente i concetti di forza o di causa, ridimensionando il prestigio paradigmatico della meccanica classica, storicizzando le pretese verità “universali” della scienza, delineando una concezione non più assoluta ma ‘funzionale’ (cioè relativa a determinati presupposti e contesti) della legge scientifica. Con molta – e molto moderna- lucidità egli assegna al sapere il compito non già di cogliere improbabili (e comunque meta-empiriche) “essenze” naturali, bensì di comprendere le strutture e i comportamenti dei dati fenomenici. ” Nella ricerca scientifica importa solo la conoscenza della connessione dei fenomeni ” egli scrive. In conformità al principio dell'”economicità” della conoscenza egli aggiunge che le connessioni più importanti sono quelle più semplici, più rapide e più controllabili. D’altra parte a Mach sta a cuore, insieme alla semplicità, anche il graduale allargamento del sapere: ” le idee sono tanto più scientifiche quanto più esteso è il dominio in cui hanno validità e più ricco è il mondo in cui completano l’esperienza ” egli sottolinea: accanto a questa concezione del sapere comune crescita oggettiva delle cognizioni intorno ai fenomeni, v’è in Mach anche un filone in qualche misura convenzionalistico-pragmatistico, che si sviluppa in sintonia con quanto l’epistemologia più avanzata del tempo andava elaborando. Per Mach la scienza è costruzione di “simboli”, ossia di concetti e di leggi che devono non già “riflettere” specularmente il reale, bensì organizzarlo in rapporto agli interessi umani. Da questo punto di vista, Mach non esita ad affermare che la scienza produce ” finzioni provvisorie “, ” espedienti utili all’orientamento provvisorio e per determinati fini pratici “. E’ su questi fondamenti che acquista nuova attendibilità la riproposizione machiana della natura ‘economica’ della conoscenza . Il compito primario del sapere scientifico è quello di ” esporre il più completamente possibile i fatti col minore impiego di pensieri “. I costrutti teorici della scienza servono solo a raggruppare o ad ‘abbreviare’ in modo efficace i fenomeni o a prevederli con il minor dispendio di energie. Per quanto riguarda la realtà del soggetto umano, Mach non riserva ad essa alcun trattamento privilegiato. Così come le ‘cose’ sono solo insiemi di sensazioni (o di “elementi”), anche l’io deve essere privato di qualsiasi particolare consistenza ontologica. Esso è composto degli stessi “elementi” che si ritrovano sia nelle ‘cose’ che negli altri soggetti: ciò consente, fra l’altro, di garantire la relazione io-mondo nonché la comunicazione intersoggettiva. Certo, ” non si può considerare esaurito l’io quando, in modo del tutto provvisorio, si dice che consiste in una connessione peculiare degli elementi “. Occorre, in effetti, approfondire la natura di questa connessione, sollecitare ” psicologi, fisiologi e psichiatri ” ad un’analisi più sistematica di questo ente. Ma fondamentalmente Mach ribadisce il suo rifiuto di considerare l’io come qualcosa di ‘consistente’, di ‘oggettivo’, di ‘sostanziale’. L’io, per lui, è solo un complesso di ” ricordi, disposizioni, sentimenti “; esso è ” così poco persistente in assoluto, come i corpi “. Non può non colpire il fatto che questa radicale demitizzazione dell’io avvenga negli stessi anni in cui tanti esponenti della cultura europea d’avanguardia (da Nietzsche, a Strindberg, a Freud) andavano anch’essi ‘de-costruendo’ in più modi la soggettività umana. Tra le critiche suscitate dalle dottrine degli empirocraticisti la più famosa è quella delineata da Lenin nel suo noto saggio Materialismo ed empiriocriticismo (1909). E’ interessante che Lenin accusò Mach (e ancor più i suoi seguaci tedeschi e russi) di minare la consistenza della realtà. Riportiamo ora un passo estrapolato dal capitolo conclusivo dell’opera Conoscenza ed errore (1905):
Si parla spesso di leggi di natura. Cosa significa questa espressione? Avviene spesso di imbattersi nell’ opinione che le leggi di natura sono regole secondo le quali devono muoversi i processi naturali, in modo simile alle leggi civili, secondo le quali devono orientarsi le azioni del cittadino. In genere se ne vede una distinzione nel fatto che le leggi civili possono anche essere trasgredite, mentre si ritiene impossibile che i fenomeni naturali deviino dalle loro leggi. Ma questa concezione della legge di natura viene scossa se riflettiamo che prendiamo, astraiamo le leggi di natura dai fenomeni stessi e che nel far questo non siamo affatto garantiti contro gli errori. Ovviamente ogni violazione delle leggi, di natura è spiegabile con l’erroneità della nostra interpretazione, e l’idea della loro inviolabilità perde di senso e di valore. Se invece si enfatizza il lato soggettivo dell’interpretazione della natura si arriva facilmente all’idea estrema che sono solo la nostra intuizione e i nostri concetti a prescrivere leggi alla natura.[…] Le leggi di natura, come noi le interpretiamo, sono un prodotto del nostro bisogno psicologico di orientarci nella natura, di non assumere una posizione di estraneità e di disordine di fronte ai suoi processi. Tutto questo si esprime chiaramente nelle motivazioni di tali leggi, che corrispondono sempre a un bisogno siffatto, ma anche alla situazione culturale contemporanea. I primi, rudimentali tentativi di orientamento sono di tipo mitologico, demonologico, poetico. Nell’epoca della rinascita delle scienze, nel periodo copernicano-galileiano, che tende a un orientamento provvisorio, prevalentemente qualitativo, la facilità, semplicità e bellezza è la motivazione che guida l’individuazione delle regole per la ricostruzione mentale della fattualità. L’indagine quantitativa tende ad una determinazione il più possibile compiuta, a una determinazione univoca, quale si manifesta già nella storia piú antica della meccanica. Quando le conoscenze particolari si accumulano, si fa valere con maggior forza l’esigenza di diminuire lo sforzo psichico, l’esigenza di economia, continuità, stabilità, applicabilità più generale possibile e utilizzabilità delle regole istituite. Basta menzionare la storia successiva della meccanica e pensare a qualche parte piú progredita della fisica. Ma allora le leggi di natura, intese come mere prescrizioni soggettive per l’aspettativa dell’osservatore e alle quali non è connessa realtà, sono forse prive di valore? Assolutamente no! Perché se anche la realtà sensibile corrisponde all’aspettativa solo entro certi limiti, la giustezza dell’aspettativa si è confermata più volte, e si conferma ogni giorno di più. Postulando l’uniformità della natura, dunque, non abbiamo fatto un passo falso, anche se l’inesauribilità dell’esperienza non consentirà mai l’applicabilità assoluta del postulato in modo rigoroso, spazialmente e temporalmente illimitato: come ogni strumento ausiliario della scienza, resterà sempre un ideale. Oltre a ciò, il postulato si riferisce solo all’uniformità in generale, ma non dichiara nulla sulla loro specifica modalità. Nel caso che l’aspettativa venga disattesa, si è sempre liberi di cercare nuove uniformità, anziché quelle che ci si aspettava.
GIOVANNI VAILATI

Carattere molto particolare ebbe il pragmatismo di Giovanni Vailati (1863-1909). Di formazione scientifico-matematica (fu allievo del grande studioso Giuseppe Peano ed ebbe incarichi di insegnamento all’università di Torino), Vailati manifestò subito vivi interessi per l’epistemologia e la storia delle scienze, espressi in un primo tempo in tre importanti prolusioni accademiche (1896-1899). Nella prima ( Sull’importanza delle ricerche relative alla storia delle scienze ) Vailati difende il “mondo di carta” (i libri, le teorie) studiato dagli storici contro il primato dei puri fatti d’esperienza. Nella seconda ( Il metodo deduttivo come strumento di ricerca ) egli polemizza contro il privilegiamento positivistico dell’induzione, rivendicando l’utilità euristica della deduzione e dello stesso sillogismo. Nella terza ( Alcune osservazioni sulle questioni di parole nella storia della scienza e della cultura ) egli mostra tutto il peso teorico del linguaggio, talvolta maggiore delle “questioni di fatto” accentuate unilateralmente dagli empiristi. E’ proprio nel corso di questi studi che Vailati si allontanerà dai positivisti, accostandosi a quei filosofi e scienziati stranieri che potevano indicargli strade alternative. Studiò così, tra i primi in Italia, Mach, Brentano e Russell. Allontanatosi dall’ambiente universitario, capitò nei primi anni del nuovo secolo a Firenze, dove entrò in rapporto con Giovanni Papini, Prezzolini e il “Leonardo”, rivista d’avanguardia di ispirazione nietzscheana. Pur non condividendone certi orientamenti dei due nuovi animatori della rivista, Vailati collaborò al periodico fiorentino, elaborando un’interpretazione diversa e più rigorosa del pragmatismo rispetto a quella di Papini stesso. Spinto dai suoi interessi epistemologici, antepose Peirce a James e si diede ad approfondire problemi strettamente teorici, quali la funzione e la controllabilità degli enunciati linguistici, la questione del significato e della verità, i rapporti tra la filosofia pragmatistica e la logica matematica. A quest’ultimo tema è dedicato un importante articolo del 1906. Vailati vi esprime un significativo elogio di Peirce, e sottolinea le possibili, fruttuose convergenze tra pragmatismo e logicismo contemporaneo. Una di queste è ravvisata nella teoria del significato, per la “comune tendenza” dei due orientamenti teorici “a riguardare il valore, e il significato stesso, di ogni asserzione come qualche cosa di intimamente connesso all’impiego di determinate conseguenze”. Molto importante è anche la critica di Vailati del valore oggettivo-assoluto attribuito dal sapere formale tradizionale ai postulati. A suo avviso, sia i logici matematici moderni sia certi pragmatisti hanno giustamente individuato nel postulato “delle proposizioni come tutte le altre, la cui scelta può essere diversa a seconda degli scopi ai quali la tradizione mira”. E’ assai opportuno, aggiunge Vailati, riconoscere ai postulati un “carattere di arbitrarietà”, ed essere ben consapevoli che la sola “giustificazione” delle proposizioni postulatorie “consiste nell’importanza e nell’utilità delle conseguenze che da esse sarà possibile trarre”. Come si vede, Vailati non soltanto distrugge ogni pretesa universalizzante assoluta coi postulati, ma ne sottolinea il carattere convenzionale: ossia il fatto che tali proposizioni sono costituite indipendentemente da vincoli oggettivi, in modo esclusivamente linguistico-formale, alla luce di determinate esigenze funzionali e di convenienza pratica. In tal modo Vailati media tra loro posizioni convenzionalistiche e posizioni pragmatistiche secondo quanto andava facendo una parte più avanzata dell’epistemologia moderna. Data questa prospettiva d’assieme, non reca meraviglia che nella conclusione del suo articolo Vailati insista sul “carattere strumentale delle teorie”, cioè sul fatto che le teorie debbono essere considerate “dei mezzi, degli ‘organismi’, la cui efficacia e potenza è strettamente connessa alla loro agibilità, all’assenza d’ingombri, d’impacci ai loro movimenti”: ossia all’elaborazione di costrutti interpretativi elastici, utili e controllabili. Su un piano filosofico più generale, di particolare importanza è il saggio su Le origini e l’idea fondamentale del pragmatismo (1909). Scritto in collaborazione con Mario Calderoni (altro grande eroe del pragmatismo ‘scientifico’ fiorentino), stabilisce alcune significative distinzioni all’interno del movimento pragmatistico. Vailati respinge soprattutto l’identificazione del pragmatismo con l’utilitarismo e col soggettivismo. Il pragmatismo è, in realtà, una dottrina epistemologica riguardante i modi più rigorosi per verificare la validità degli enunciati linguistici e scientifici. A questo proposito Vailati sottolinea che il principio fondamentale del pragmatismo è quello secondo cui “il solo mezzo di determinare e chiarire il senso di una asserzione consiste nell’indicare quali esperienze particolari si intenda con essa affermare che si produrranno, o si produrrebbero, date certe circostanze”. Una menzione particolare merita anche la simpatia che Vailati nutre per Berkeley: non certo per il Berkeley metafisico, ma per il sottile studioso della dipendenza cognitiva delle cose dalle passioni umane. In prima approssimazione, il riferimento a Berkeley ( presente anche in James, Peirce e Mach) serve a Vailati per distanziarsi da ogni concezione ingenuamente realistica del mondo. D’altra parte lo studioso italiano cerca di delineare un’originale interpretazione del filosofo irlandese in chiave non soggettivistico-percezionistica, ma metodologico-formale. In altri termini, Vailati tende a sostenere (leggendo assai liberamente Berkeley) che l’essere di un fenomeno dipende non tanto dal suo immediato essere-percepito, bensì dalle condizioni formali, dalle esperienze possibili (le une e le altre tutt’altro che soggettive, anzi suscettibili di rigorosi controlli oggettivi) nelle quali l’osservatore considera il fenomeno dato. “Così quando diciamo che un oggetto ha un determinato colore, non intendiamo dire che percepiamo il colore in questione, ma che lo percepiamo in certe circostanze (data cioè una certa luce, o dato che il nostro sguardo sia verso di esso ecc.)”.
GEORGES SOREL

Oltre che sul terreno religioso, il pensiero di Bergson esercita una viva influenza anche sul terreno sociale, per il singolare innesto che dei motivi bergsoniani ha operato in seno al marxismo il celebre autore delle “Réflexions sur la violence” (1906) Georges Sorel (1847-1922). La coscienza, cui gli spiritualisti fanno riferimento, è solitamente intesa come la via interiore che porta alla conoscenza delle più profonde regioni dello spirito e, anche quando viene interpretata in senso pratico, cioè come volontà e azione, essa ha genericamente esiti intimistici e religiosi. Nel caso di Sorel, invece, che si richiama esplicitamente a Bergson, la coscienza è anche la sede di un “mondo fantastico” in cui si esprime la volontà di un’azione politica tutta esteriore, intesa a promuovere quella rivoluzione che libererà le masse oppresse dal capitalismo. In Sorel si realizza pertanto una strana commistione di temi spiritualistici e di fede marxista, da lui abbracciata nell’ultimo decennio dell’Ottocento. Anche per Sorel la realtà dell’uomo si riduce all’azione: un’azione che scaturisce spontaneamente dalla libera volontà dell’uomo. Ma a questo scopo occorre che nella coscienza umana sia presente un complesso di immagini in grado di agire sull’istinto, sprigionando in questo modo l’azione. A questo complesso di immagini spontanee ed istintive Sorel dà il nome di mito . Benchè entrambi rivolti alla prassi futura, il mito si definisce attraverso la sua contrapposizione all’utopia: mentre quest’ultima è una rappresentazione intellettuale che può essere razionalmente esaminata e discussa, e che quindi non ha un effetto pratico dirompente (siamo negli anni in cui sul Positivismo prevale il vitalismo), il mito è l’espressione immediata per immagini della volontà che attende di tradursi in azione. In questo senso, non ha alcuna rilevanza il fatto che il contenuto del mito sia o non sia realizzabile: in ogni caso esso diventa il potente motore dell’azione dell’uomo e la sola fonte di creazione di nuova realtà: ” si può parlare all’infinito di rivolte senza mai provocare un movimento rivoluzionario, fin tanto che non vi sono miti accettati dalle masse […] il mito è un’organizzazione di immagini capaci di evocare istintivamente tutti i sentimenti che corrispondono alle diverse manifestazioni della guerra intrapresa dal socialismo contro la società moderna “. Nei tempi passati hanno svolto la funzione di mito la credenza dei primi cristiani nella prossima fine del mondo, oppure i sogni di rinnovamento nutriti dai grandi riformatori religiosi. Oggi il mito riveste la forma di “mito sociale” e trova il suo soggetto nelle masse popolari oppresse dal capitalismo e il suo oggetto nello sciopero generale : ” lo sciopero generale è proprio ciò che ho detto: il mito nel quale si racchiude tutto intero il socialismo “. L’azione che il mito deve sprigionare è, dunque, l’azione rivoluzionaria e la “guerra di classe”. Lo sciopero generale è infatti sentito come un’attività catastrofica, che porta alla paralisi, all’inceppamento e alla distruzione del vecchio regime capitalistico, creando le condizioni per la formazione di una nuova umanità. Per questo, dice Sorel, esso viene rifiutato dai socialisti riformisti, che sono piuttosto guidati da un’utopia da realizzare, intellettualisticamente, attraverso trasformazioni graduali. Al socialismo riformistico Sorel contrappone pertanto il suo sindacalismo rivoluzionario e anarchico . T7 Il pensiero di Sorel si prefigge dunque una giustificazione della violenza , intesa però non come forza impiegata con calcolo razionale per ottenere risultati specifici (quale è quella usata dal sistema capitalistico per imporre il suo dominio), ma piuttosto come un bergsoniano slancio vitale e creatore che sprigiona energie spirituali in attesa di manifestazione: la violenza è la condizione e il mezzo per l’istituzione di forme via via più alte di organizzazione. E tutta la storia dell’umanità è solcata, nel suo processo, da fratture violente: il Cristianesimo, la Riforma, la Rivoluzione francese, il Mazzinianesimo; e a far sì che avvengano queste fratture sono le rappresentazioni da parte degli uomini di mondi fantastici, cioè di miti. Di qui il carattere profondamente etico della violenza, che assolve una funzione di liberazione e di creazione. L’impianto concettuale del pensiero di Sorel è particolarmente debole, risolvendosi in una forma di volontarismo e di spontaneismo irrazionalistico che ben si inquadra nel clima di avversione per il razionalismo positivistico che aleggiava in quegli anni. L’impatto che le sue teorie ebbero soprattutto sul mondo politico dei primi decenni del Novecento fu tuttavia enorme, anche se (proprio per via del suo carattere sfuggente) esso si prestò ad essere utilizzato sia da parte comunista sia da parte fascista (Sorel era la lettura preferita di Mussolini). Del resto, le stesse posizioni personali di Sorel non furono esenti da ambiguità: dopo aver difeso l’anarco-sindacalismo, egli si accostò, verso il 1910, al movimento di destra dell’ “Action française” e non mancò di manifestare le sue simpatie per il nascente fascismo italiano. Con il sindacalismo rivoluzionario di Sorel emerge in primo piano la rivoluzione in quanto tale, quasi come se si verificasse una sorta di mitizzazione del cambiamento della società, una volontà cieca di fare la rivoluzione a mano armata e in modo violento. L’obiettivo, però, viene perso di vista e questo è molto importante perché farà sì che si ispirino a Sorel sia esponenti dell’ala progressista sia esponenti dell’ala reazionaria e fascista.
CARLO MICHELSTAEDTER

VITA E OPERE
Carlo Michelstaedter nasce a Gorizia il 3 giugno 1887 e muore suicida per un colpo di rivoltella, sempre a Gorizia, il 17 ottobre 1910. In quei brevi ventitré anni di vita, o meglio nell’arco dei suoi ultimi cinque anni, elabora la tesi di laurea La persuasione e la rettorica e affianca agli studi universitari la composizione di saggi, racconti e poesie. Inoltre, disegna e dipinge. Sembra l’attività di un giovane d’ingegno che non ha ancora scelto il campo a cui dedicarsi completamente; e invece diventa il dare tutto se stesso, il mettere negli scritti il proprio “sangue incontaminato”, quando la fiamma a cui aveva attinto tutta la sua energia diventa tanto ardente da bruciarlo. È l’ultimo dei quattro figli di Alberto Michelstaedter ed Emma Luzzatto Coen: Gino (1877-1909, Elda (1879-1944), Paula (1885-1972) e Carlo. Carlo Raimondo (Ghedalià Ram) è il nome che gli viene imposto. Della sua infanzia sappiamo poco: la sorella Paula lo ricorda come un bambino pauroso del buio e dell’altezza, ostinato e per nulla disposto a chiedere scusa per qualche mancanza. Frequenta lo Staatsgymnasium senza eccellere particolarmente: non figura mai tra gli studenti che ricevono a fine anno la menzione d’onore, e nel certificato di maturità la sua condotta viene giudicata “poco confacente (“minder entsprechend”) per aver disturbato frequentemente e intenzionalmente lo svolgimento delle lezioni nel corso dell’anno. All’esame di maturità dichiara di voler seguire gli studi di diritto, ma si iscrive alla facoltà di matematica dell’Università di Vienna: non frequenta però le lezioni e nell’autunno del 1905 si stabilisce a Firenze, iscrivendosi all’Istituto di Studi Superiori. Sono anni di studio e di soddisfazioni, ma anche di dispiaceri. Cerca di entrare nella redazione di qualche giornale, ma pubblica solo tre articoli sul “Corriere friulano” diretto dalla zia Carolina Luzzatto (e uno di questi a sua insaputa, tratto da una lettera scritta ai familiari) e uno sul “Gazzettino popolare”. Si offre anche come traduttore dal tedesco e dal francese, ma senza molto successo. Il rapporto intellettuale e con ogni probabilità anche sentimentale con una signora russa residente a Firenze, Nadia Baraden, si conclude bruscamente con il suicidio di questa; il successivo progetto di fidanzamento con una compagna di studi, Iolanda De Blasi, viene troncato sul nascere per l’opposizione della famiglia Michelstaedter; il fratello Gino muore a New York in circostanze non chiarite che fanno parlare di suicidio. Ha problemi di salute non seri ma che lo irritano, attivo com’è. Alla visita di leva, nonostante tutti i suoi sforzi per farsi riformare provocando una momentanea tachicardia, viene dichiarato “tauglich” (abile), ma ancora molti anni dopo la sua morte in ambienti goriziani si attribuisce il suo suicidio alla consapevolezza di una grave malattia. Sono voci senza conferma, ma che si tramandano negli anni. Nel giugno 1909 ritorna definitivamente al Gorizia. Lavora alla tesi di laurea: è legato sentimentalmente a un’amica di Paula, Argia Cassini, pianista di talento, dalla forte personalità, a cui dedica le poesie “A Senia” e “I figli del mare” e che resterà poi fedele alla memoria di lui, senza indulgere a sentimentalismi, ma facendo parte della resistenza e finendo deportata ad Auschwitz. Carlo lavora accanitamente alla tesi nell’estate del 1910 e nel caldo inizio d’autunno, teorizzando una filosofia della persuasione, del superamento delle illusioni offerte dalla non-filosofia, la rettorica. L’uomo schiavo della rettorica è infatti vittima di una persuasione illusoria, attraverso la quale viene indotto a soddisfare i suoi bisogni e i suoi desideri e adattarsi alla vita. La “philopsichia” (amore della vita), che Michelstaedter chiama anche dio del piacere, inganna l’uomo, facendogli credere di poter ottenere quello che desidera – il conseguimento del piacere, il soddisfacimento dei propri bisogni, lo stesso perseguimento di un ideale – fuori si sé. L’istinto che è alla base della “philopsichia” è la sopravvivenza dell’uomo, non la sua realizzazione: fa sì che egli si adatti, che sfugga al rischio e al dolore, amando irrazionalmente la vita e provando paura della morte. La persuasione invece porta al superamento delle illusioni, alla constatazione che né dagli altri uomini né dalle cose ci si deve aspettare nulla – e allo stesso modo non si deve temere nulla. Chi raggiunge il possesso di se stesso possiede la libertà assoluta: libertà dai bisogni quotidiani, dai desideri e dai timori. Il dolore allora non è subìto, ma accettato con coraggio; la morte non è temuta né desiderata, ma è disarmata, come disarmata è la vita, davanti a chi non chiede la vita e non teme la morte, a chi dà tutto e non chiede niente, a chi non si accontenta, non si adatta, non si adegua; a chi sceglie con coraggio la strada difficile della filosofia, della solitudine, del possesso di sé mai definitivo ma da conquistarsi ogni giorno; a chi si salva da solo. E Carlo è proprio solo negli ultimi giorni: la famiglia è in villeggiatura in collina, al Rafut, mentre lui lavora alla tesi, mette la sua anima nei fogli, li ricopia aiutato dall’amico Nino Paternolli e dal cugino Emilio Michelstaedter. Il 17 ottobre la tesi è finita. Proprio in quel giorno la madre Emma compie cinquantasei anni. Pare che i Michelstaedter usassero scambiarsi i doni e festeggiare le ricorrenze la sera della vigilia. Carlo la sera del 16 ottobre resta nella casa di città, tutto preso dal lavoro. Il regalo per la madre è pronto: un piccolo quadro a olio dipinto da lui, un raggio di sole che si fa strada attraverso un cielo coperto di nubi: sul retro ha scritto la significativa frase “E sotto avverso ciel – luce più chiara”. Poche settimane prima madre e figlio si erano scambiati delle lettere toccanti. La madre vedeva il figlio migliore degli altri giovani, ma solo e scontento; lui le prometteva un futuro migliore, la realizzazione della vita dopo tanto studio, sempre nello stretto rapporto con lei, cui niente del figlio era estraneo. Invece Emma si sente dimenticata nel giorno della sua festa. Scende la collina del castello, rimprovera aspramente Carlo. “Fammi il regalo di non arrabbiarti”, gli aveva scritto ai primi di settembre. Ma questa volta non trova le parole giuste, e il figlio reagisce con uno scatto di collera. Dopo, se ne pente. Viene Emilio per proseguire il lavoro di trascrizione, ma Carlo gli chiede di tornare più tardi. Ha appuntamento per una passeggiata con Argia nel pomeriggio, ma non aspetta che venga pomeriggio. Rimasto solo, non affida alla carta nessun messaggio. Non chiude neanche la porta a chiave. Ha una rivoltella, tolta a un amico per evitare che potesse compiere un gesto inconsulto. Si spara. Sono le due del pomeriggio. È una giornata molto calda, quasi estiva. I vicini sentono il colpo, ma non ci badano. Sarà Emilio a trovare il cugino due ore dopo. Carlo spira prima di notte, senza riprendere conoscenza. Da quel momento vive il ricordo, vive la carta scritta al suo posto. Era il 1910.
IL PENSIERO
Michelstaedter ha scritto molto, sperimentando diversi generi letterari, ma, nonostante questo, ha sempre mantenuto un punto fermo: il nucleo attorno al quale, seppure con delle evoluzioni, si sviluppa il suo pensiero. Questo nucleo è costituito dalla riflessione sul rapporto tra individuo, vita e morte. Michelstaedter sceglie alcune figure come ideali interlocutori e ispiratori di tutta la sua opera: essi sono Parmenide, Socrate, Eraclito, Empedocle, Simonide, Eschilo, Sofocle, Cristo, Buddha, Petrarca, Leopardi e infine Ibsen. Ad essi si oppongono, come campioni della rettorica , Platone, Aristotele e Hegel. La rettorica è antitetica alla persuasione e corrisponde al non essere; mentre la persuasione è l’essere. La vita (o rettorica), così come noi la viviamo e ci appare, è come il desiderio che il peso ha del più basso: esso non si esaurisce mai ed è infinita tensione verso l’illusione del possesso del punto più basso. Il peso è in uno stato di continua insufficienza e sofferenza. ” La vita è questa mancanza della sua vita “. Come il peso non riesce mai a possedersi, finché è peso (cioè volontà inesausta di soddisfazione della sua eterna mancanza), così tutto ciò che vive, vive nella mancanza totale della propria vita. Fanno parte del mondo della rettorica il sapere accademico, che duplica l’uomo in ciò che è e in ciò che sa (in questo modo si viene meno al detto di Parmenide per cui pensiero ed essere sono lo stesso); e la società, che duplica l’uomo in ciò che è ed in ciò che fa ( e qui Michelstaedter fa suo, attraverso un’interpretazione personale, il concetto di alienazione). La persuasione è, invece, quell’ideale, che le parole non riescono a descrivere totalmente, per cui ciò che vive cessa di vivere nel dolore, e, decidendo di dipendere solo da se stesso, diventa uno, non più duplice nell’animo. Il più grande nemico all’attuazione della persuasione è il tempo: in esso le cose attuano la loro volontà infinita di dipendere da altro. Il tempo è la conseguenza della volontà che si esplicita come volontà di cose determinate, per una coscienza che è correlazione. La correlazione, ossia relazione fra determinatezze, è l’origine della vita inautentica. Nella continua e reciproca correlazione, gli uomini sentono l’eco del tu sei, che però è illusorio, perché fondato sul limite. La determinatezza, che si relaziona, è segnata, infatti, per sempre dal limite che, nella relazione, è posto dall’altro da sé, ed equivale al proprio nulla, al proprio non-essere. Il limite viene ripetuto infinitamente nelle differenti relazioni, nel vano tentativo di udire quell’autentico tu sei, che restituisca al singolo il potere su se stesso. Per questo il tempo, che è il luogo dove l’esistenza del limite si rende palese, è ciò che la persuasione deve distruggere. Solo nell’attualità del possesso assoluto il singolo è in grado di distruggere la sua relazione con il non essere (cioè l’altro), che lo getta nella deficienza e nella instabilità. La relazione con l’altro è violenza, perché è tentativo di appropriarsi della propria realtà e stabilità, annientando ciò che dichiara, invece, la propria determinatezza e morte. La paura della morte che spinge l’uomo a rifugiarsi nelle false certezze della rettorica (cioè nella vita inautentica) è in realtà la paura della vita, che nasce quando l’uomo nasce come colui che, inesorabilmente, è costretto alla morte; ma il pensiero, che il presente deve essere in ogni attimo come l’ultimo, distoglie dalla paura della morte. Il tempo è paura della morte, distrutto il tempo si distrugge anche la paura, perché la morte toglie solo ciò che è “per il continuare”. La persuasione si raggiunge con un atto della volontà, che affermi il valore individuale. Esso consiste nel prendere su di sé la responsabilità della propria vita: l’uomo risvegliato è il giusto. Nella persuasione, il dare è avere, continua e instancabile attività di identificazione e appropriazione del mondo, di modo che non è più la dipendenza a formare l’uomo, ma l’uomo a formare il suo mondo, ed esso sarà uno e identico con il tutto. Nella visione filosofica di Michelstaedter l’uomo di adatta alla vita perché è indotto a soddisfare i suoi bisogni e i suoi desideri dalla “philopsichìa”, dall’amore della vita, che Michelstaedter chiama anche “ il dio del piacere “. L’irrazionale brama di vivere e per raggiungere il suo scopo inganna l’uomo tramite le illusioni. Illusione è conseguimento del piacere, illusione il soddisfacimento dei propri bisogni, illusione lo stesso perseguimento di un ideale. La philopsichìa provoca attraverso la rettorica una persuasione illusoria, per cui l’uomo crede di poter ottenere quello che cerca fuori di sé: piacere, amore, felicità, in una parola un rapporto soddisfacente con il mondo esterno e con gli altri. E sempre l’amore della vita provoca l’adattamento del debole, e la rinuncia quando le circostanze non permettano un facile adempimento del suo ideale. Dice Michelstaedter: ” e a questo lo guida il dio della philopsichìa: tu vuoi questo, ti sei impegnato a ottenerlo – che importa – cedi, quando non lo puoi, quando ci va della vita; quello che volevi qui, in fondo lo puoi aver in altra parte, in altro modo, con lo stesso piacere, senza pericolo “. L’amore della vita ha dunque come scopo la sopravvivenza, non la realizzazione dell’uomo. La persuasione consiste invece nel superamento delle illusioni, nella convinzione che nulla conta, che ” non c’è niente da aspettare, niente da temere – né dagli altri uomini né dalle cose “. La realizzazione dell’uomo non dipende dal mondo esterno, in cui egli è ” solo e diverso “, ma consiste nel ” possesso di se stesso “, attraverso il quale ” possiede tutto in sé “, superando con ciò la solitudine e l’alterità del mondo. L’uomo che si sente mancare nella solitudine chiede ” di essere per qualcuno “, ma l’altro gli viene meno e lo delude; l’uomo persuaso invece basta a se stesso, ” vive solo di se stesso “, e nella sua autorealizzazione non teme la morte, perché ” la morte nulla [gli] toglie; poiché niente in lui chiede più di continuare “, dal momento che niente chiede a un tempo futuro, niente gli manca e può ancora desiderare, quando la sua anima ” vive libera nell’assoluto “. La realizzazione, la libertà non possono venire che dall’uomo stesso. Scrive Michelstaedter: ” ognuno è solo e non può sperar aiuto che da sé: la via della persuasione non ha che questa indicazione: non adattarti alla sufficienza di ciò che t’è dato “. L’uomo ” è solo nel deserto, e deve crear tutto da sé: dio e patria e famiglia e l’acqua e il pane “. Ognuno deve essere salvatore di se stesso, non può attendere la salvezza da altri: neanche da Dio. ” Cristo ha salvato se stesso poiché della sua vita mortale ha saputo creare il dio: l’individuo “, ma ” nessuno è salvato da lui “, se non si ottiene la salvezza da se stesso. Fin qui abbiamo citato passi da La persuasione e la rettorica : ma a questo proposito il discorso filosofico della tesi di laurea si collega a quello della poesia a cui Arangio Ruiz ha dato titolo ” I figli del mare “. È una della ultime composizioni poetiche di Michelstaedter, scritta nel settembre 1910. Nella poesia si rappresenta la vita dei due figli del mare Itti e Senia costretti a vivere la morte dei mortali. La morte, non la vita, perché l’atteggiamento dell’uomo che si adagia nella rassegnazione, nella paura della morte, nell’accontentarsi della propria condizione, questo è morte. La philopsichìa diventa qui il richiamo del focolare domestico:
Ritornate alle case tranquille
alla pace del tetto sicuro,
che cercate un cammino più duro?
che volete dal perfido mare?
Passa la gioia, passa il dolore,
accettate la vostra sorte,
ogni cosa che vive muore
e nessuna cosa vince la morte.
Ritornate alla via consueta
e godete di ciò che v’è dato:
non v’è un fine, non v’è una meta
per chi è preda del passato.
Ritornate al noto giaciglio
alle dolci e care cose
ritornate alle mani amorose
allo sguardo che trema per voi
a coloro che il primo passo
vi mossero e il primo accento,
che vi diedero il nutrimento
che vi crebbe le membra e il cor.
Adattatevi, ritornate,
siate utili a chi vi ama
e spegnete l’infausta brama
che vi trae dal retto sentier.
Ma a questo invito alla rassegnazione Itti, il persuaso, il salvatore di se stesso, ribatte che la morte temuta dai figli della terra non è l’abbandono, ma il coraggio: ” il coraggio di sopportare / tutto il peso del dolore “, di navigare verso il mare libero, di non adeguarsi solo per non perdere comodità e affetti. Il porto, il rifugio dei figli del mare è la furia dello stesso mare in tempesta ” quando libera ride la morte / a chi libero la sfidò “. Perché ” chi vuole fortemente la sua vita, non s’accontenta “, nel timore della sofferenza, dell’apparente piacere che non elimina, ma solo nasconde il dolore, bensì affronta e sopporta il dolore stesso, accettandone interamente il fardello. ” Egli deve avere il coraggio di sentirsi ancora solo, di guardar ancora in faccia il proprio dolore, di sopportarne tutto il peso “. Una filosofia pessimista, senza mondo e senza Dio, anche se Michelstaedter è attratto dalle esperienze religiose, specie da quelle estranee alla sua cultura di ebreo non osservante: cita infatti, oltre all’Ecclesiaste, massime di ascetismo buddista e il Nuovo Testamento. La sua filosofia trova significato nella volontà di potenza, nella sete di assoluto, nella realizzazione di sé non nonostante ma attraverso il peso del dolore, della solitudine, della consapevolezza della morte. Il filosofo non teme la morte e non la sceglie: la supera, vive con la stessa intensità ogni attimo e quindi è andato oltre la morte stessa. Quando tutto gli appartiene, anche la morte non gli è estranea, e una volta accettata questa esperienza, niente resta che possa incutere timore, e il persuaso può dire nietzscheanamente, a spiegare la sua noncuranza delle cose contingenti: ” cosa potrebbe capitarmi ancora che non fosse già cosa mia? “. Ma il filosofo, il saggio, l’uomo superiore, il persuaso, alla fine resta, per dirla con le parole di Michelstaedter, solo, lontano, diverso. Il suo non accontentarsi, non risparmiarsi, se lo innalza rispetto agli altri uomini lo allontana anche irrimediabilmente da loro. E il punto debole della pratica della persuasione consiste proprio nella difficoltà di accettare questa assoluta solitudine morale e mentale. È possibile farlo, anche se alcuni si rifugiano nella pazzia: ma è molto duro farlo a 23 anni. Si è parlato per lui di ” suicidio filosofico “, è parso avvincente ipotizzare un concetto filosofico che si traduceva in realtà: ma Michelstaedter teorizza non il suicidio, non la scelta della morte quanto la sua indifferenza. Per il saggio vita e morte si equivalgono, sono uguali, e se la morte niente toglie, niente può anche dare. La morte, quando viene, è un fatto per così dire accidentale: indifferente. L’essenziale è che non sia temuta o subita, ma affrontata. Sia nella Persuasione che nel Dialogo della salute Michelstaedter compie chiaramente una scelta di vita e non di morte; e anche in precedenza, nel 1906, in una recensione a L’età critica di Max Dreyer criticava il suicidio di un giovane infelice come l’azione di un debole che si era ucciso per non poter sopportare il dolore, commiserandolo ma concludendo: ” che c’importa? “. Eppure, nel privato, qualche inclinazione alla morte si trova: nel cosiddetto “questionario fiorentino”, una sorta di test del marzo 1906, alla domanda “a quale età vorreste morire” rispondeva “Subito!!”; e prima di trovare nella furia del mare il coraggio che libera dall’illusoria philopsichìa aveva annotato nel suo taccuino, nell’autunno del 1905, con ben più pessimistico atteggiamento: ” l’Arno violento dalle onde gialle, come ci simboleggia bene la vita, la vita eternamente fangosa. Invano le onde s’alzano, si ribellano, lottano con disperata energia rabbiosamente, la corrente le trascina inesorabile “. Già allora, a 18 anni, la vita gli appariva come lotta, anche se la persuasione non era ancora delineata, anche se il risultato gli appariva una sconfitta. Essenziale resta dunque affrontare la vita, non accontentarsi, non risparmiarsi mai, non adagiarsi. Il possesso di sé non può mai essere definitivo, ma si conquista momento per momento, attimo per attimo.
PERSUASIONE E RETTORICA
I due termini “persuasione” e “rettorica” rappresentano non solo un’alternativa filosofica ma soprattutto etico-esistenziale: vivere in modo rettorico significa infatti optare per un’esistenza inautentica, caratterizzata dal fatidico sintagma bisogno e soddisfazione del medesimo, soddisfazione che a sua volta innesca la necessità di un altro bisogno ugualmente da soddisfare. E così all’infinito, in una sorta di spirale che non ha fine e che soprattutto non porta da nessuna parte. L’individuo rettorico infatti non riconosce o, meglio, non vuole riconoscere che la sua natura è ontologicamente deficiente e quindi sempre bisognosa di trovare la propria essenza in qualcosa fuori da sé, che erroneamente egli tenta di ottenere realizzando ciò che al momento non possiede, sempre proteso verso un tempo al di là da venire, mai ben definito. Per converso, l’uomo persuaso è colui che non soggiace alle lusinghe della vita mondana, contraddistinta appunto dall’illusione di poter rendere felice l’individuo semplicemente soddisfacendo via via tutto ciò che egli ritiene indispensabile per il suo quieto vivere. Il persuaso vive totalmente nel presente, non preoccupandosi affatto né di ciò che è stato né tantomeno di ciò che sarà. Per Michelstaedter è necessario che l’uomo abbandoni la falsa strada della rettorica, che certo è più sicura e tranquillizzante ma che è anche più fallace e illusoria perché con i suoi “kallwpismata orjnhs” (gli abbellimenti dell’oscurità), che tutto oscurano, impedisce di vedere l’esistenza per quello che veramente è, ossia intrisa di insoddisfazione e quindi di dolore. Certo optare per la via della persuasione non è corsa anche perché Michelstaedter non dà molti chiarimenti in merito. Essa infatti non è definibile se non per negazioni, ossia viene determinandosi come tutto ciò che non è la rettorica. Arduo è dunque il cammino che l’uomo deve intraprendere se veramente aspira ad una dimensione autentica: è un percorso che si sa dove ha inizio ma che non si può assolutamente prevedere né come né dove andrà a finire.
IL DIO DEL PIACERE E IL DOLORE
La paura della morte è correlata in modo inseparabile con la “jiloyucia” , ossia l’attaccamento alla vita, il dio del piacere, il principio organizzatore dell’universo in virtù del quale le realtà manchevoli si sorreggono l’un l’altra, dandosi reciprocamente ragione sufficiente di sé. Grazie ad esso ogni ente attribuisce realtà e valore a se stesso in quanto bisognoso perché manchevole, riuscendo così ad occultare ogni volta l’unica vera richiesta, ossia l’esigenza dell’Assoluto, in una miriade di bisogni di volta in volta determinati e correlati tra loro. L’uomo è incessantemente proteso alla ricerca del piacere ed è convinto che soddisfacendo tutti i bisogni che via via il dio del piacere gli procura egli riuscirà a raggiungere una dimensione edenica. In realtà non si rende conto che impossibile è soddisfare tutti i bisogni poiché essi sono infiniti: l’uomo infatti avrà sempre necessità da soddisfare poiché la sua essenza è manchevole ed è proprio questa deficienza che lo fa soffrire. Di ciò essi non sono consapevoli, non capiscono la vera ragione del loro dolore e perciò non hanno mezzo alcuno per rimuoverlo ma sono costretti a tenerlo come cieco e muto compagno di ogni istante della vita e credendo di salvar questa non fanno altro, in realtà, che sancirne tutta l’insufficienza: la loro vita non è che paura della morte . Per uscire da questo circolo vizioso è necessario per Michelstaedter rendersi consapevoli della causa del dolore: a questa consapevolezza giunge chi volendo fortemente la propria vita non sa accontentarsi della sufficienza di ciò che gli è dato né può rassegnarsi all’idea di protrarre nel tempo la sua insoddisfazione senza cercare di porvi rimedio. Tale riconoscimento è la porta d’accesso alla via della persuasione e dunque il diverso atteggiamento di fronte al dolore è ciò che segna il discrimine tra la rettorica e la persuasione. Persuaso è, pertanto, colui che osa squarciare la fitta trama delle illusioni lasciando trasparire l’oscuro abisso dell’insufficienza e riconoscendo sul fondo il termine reale della volontà, il motore primo del meccanismo perverso bisogno-soddisfazione. Nello stesso tempo però comprenderà anche che fino a che egli chiederà il possesso della sua vita, la sua vita non sarà mai sua ma suo sarà solo il non essere, il vuoto, la morte appunto. Per possedere realmente la propria vita dunque il persuaso non dovrà far riferimento né a Dio né a qualsivoglia essere trascendente ma sarà egli stesso a crearla e, parafrasando le parole stesse di Cristo, così afferma: ” io sono l’alfa e l’omega “, ognuno è il primo e l’ultimo e non trova niente che sia fatto né prima né dopo di lui. L’uomo dunque deve prendere su di sé la responsabilità della sua vita, deve creare sé e il mondo che prima di lui non esiste. In verità però arduo è scegliere questa strada perché troppo rischioso e troppo raramente tentata da altri: l’individuo comune preferisce quindi perdere l’occasione di possedere realmente se stesso e si accontenta di ripercorrere le vie già segnate, fallaci ed illusorie ma quantomeno tranquillizzanti e sicure. Del resto la dimensione della persuasione è talmente oltre ciò che l’umano linguaggio può definire che persino Michelstaedter non riesce ad aggettivare la persuasione; anzi paradossalmente egli afferma che il silenzio è l’unico mezzo di espressione e di comunicazione di questa dimensione.
MORTE RETTORICA E MORTE PERSUASA
Ma allora se anche la dimensione della persuasione, che doveva rappresentare un’alternativa etico-esistenziale alla rettorica, non riesce a consistere, che cosa rimane all’uomo? A parole ed anche nei fatti Michelstaedter risponde: la morte. Mentre tutti gli uomini la considerano lontana, non prevedibile, sempre rimandata in un tempo futuro al di là da venire e con ogni mezzo tentano di occultare il suo spettro, il filosofo goriziano ha il coraggio di guardarla in faccia, di sopportare con gli occhi aperti l’oscurità. Solo la morte, infatti, può realizzare l’Assoluto poiché essa rappresenta la negazione del finito, dei bisogni e delle determinazioni. Del resto per Michelstaedter inseparabile è il legame tra vita e morte come splendidamente scrive nella poesia Il canto delle crisalidi :
Vita, morte
la vita nella morte
morte vita
la morte nella vita.
Noi col filo
col filo della vita
nostra sorte filammo a questa morte.
Per vivere intensamente insomma bisogna essere in contatto costante con la morte, è necessario stare sempre sull’orlo del precipizio per provare le emozioni più forti. Anche di fronte a questo evento, diverso è l’atteggiamento del persuaso e del rettorico: al persuaso la morte non può togliere nulla poiché egli vive solo del e nel presente, per cui quando la morte sopraggiunge è come un ladro che spoglia un uomo ignudo. Tutto per il persuaso è presente proprio perché tutto accade nell’istante stesso dell’annientamento. Anzi per l’individuo persuaso la morte come esperienza del limite incita a pensare ad essa come radice ontologica dell’Esserci, dalla quale partono le autentiche intuizioni dell’esistenza: bisogna dunque avere il coraggio di guardare in faccia la morte e ” fare di se stesso fiamma ” per riuscire a percepire e finalmente a far proprie quella verità e quell’autenticità che in vita sono ineffabili. Per l’individuo rettorico, al contrario, la morte è ciò che massimamente desta in lui timore, a tal punto che egli vive per morire, nel senso che imposta tutta la sua esistenza in prospettiva dell’evento ultimo e sua massima preoccupazione non è quindi vivere la vita per quella che essa offre ma creare tutta una serie di artifici, di strutture psicologiche, di illusioni che in qualche modo allontanino dalla morte, peraltro inevitabile. All’uomo rettorico la morte toglie tutto perché egli consegna il proprio essere integralmente al futuro, tempo nel quale ha riposto tutte le sue speranze di realizzare se stesso e di raggiungere la felicità. La paura della morte diventa così l’unico motivo per cui si vive e Michelstaedter afferma che una vita dominata da questo timore non è nemmeno degna di essere vissuta poiché sempre la costringerà entro la cerchia delle necessità, in un sordo e continuo dolore. Michelstaedter nella sua opera filosofica, poetica e pittorica ma soprattutto nella sua vita dà, in questo senso, una lezione di serietà, d’impegno morale, di coerenza fino al sacrificio ultimo. Estraneo al mondo della fede, indifferente ai successi mondani, scettico riguardo agli ideali tradizionali tutti basati sul compromesso, egli vuole costruire il suo mondo con sincerità estrema e ad esso mantenersi fedele. Questo suo mondo è quello del vero pensare, che scarnifica i lati più attraenti della vita, mostrandoli per quello che veramente sono, senza più orpelli e maschere che conducono a travisare. Il suo è un messaggio di grande coraggio e forza: bisogna guardare il mondo con occhio distaccato, estraneo, non imprigionarlo nelle necessità; bisogna riuscire a viverci con il carico dell’amarezza che la sua inutilità comporta, viverci con tutto il dolore che l’esistenza offre: insomma è necessario essere consapevoli che ” non c’è premio, non c’è posa, la vita è tutta una dura cosa “. La filosofia di Michelstaedter che vorrebbe porsi come una filosofia della vita autentica è sin dall’inizio una filosofia della morte. L’esistenza di Michelstaedter è votata al nulla come al proprio destino più essenziale e ineludibile ed il suo pensiero è votato al silenzio. L’istanza vitale si rovescia in un vero e proprio anelito verso la morte che pone fine ad ogni possibile senso dell’essere, perché la morte è il silenzio del senso, la pura essenza di significato. Tuttavia questo ribaltamento dell’autenticità nella morte nasce dalla preoccupazione di Michelstaedter per l’essere dell’uomo che egli vede pericolosamente alienato ed espropriato della propria autenticità essenziale, gettato in un mondo all’interno del quale la relazione con le cose, in quanto impegna totalmente l’attenzione e la cura dell’individualità, svia quest’ultima dall’autentica comprensione della propria essenza esistenziale.
GOTTLOB FREGE

Friedrich Ludwig Gottlob Frege (Wismar, 8 novembre 1848 – Bad Kleinen, 26 luglio 1925) è stato un matematico, logico e filosofo tedesco, padre della logica matematica moderna e della filosofia analitica. Frege è uno dei più grandi logici dopo Aristotele ed è il padre del pensiero formale del Novecento. La sua rivoluzionaria opera Begriffsschrift del 1879 ha segnato l’inizio di una nuova epoca nella storia della logica, sostituendo la vecchia logica del rapporto genere-specie, che era rimasta pressoché inalterata per secoli dopo la formalizzazione di Aristotele, in una logica delle funzioni n-esime mutuata dalla matematica. Frege è stato il primo propugnatore del logicismo — la prospettiva secondo la quale la matematica, in quanto costituita da proposizioni analitiche cioè, è riducibile alla logica. Il suo Grundgesetze der Arithmetik fu il tentativo di derivare esplicitamente le leggi dell’aritmetica da un sistema di assiomi mediante un calcolo logico. Dopo la pubblicazione del primo volume (a spese dell’autore), Bertrand Russell mediante il paradosso che porta il suo nome, scoperto in realtà da Zermelo qualche anno prima, mostrò che la quinta legge fondamentale delle Grundgesetze portava ad una contraddizione e scrisse a Frege, il quale riconobbe la contraddizione in un’appendice al secondo volume dell’opera, abbozzando una riformulazione dell’assioma che però risultava insoddisfacente date le pretese dell’opera di emendare la matematica dall’intuizione intellettuale. Frege fu costretto a dichiarare «risolti in un completo fallimento» i suoi sforzi di chiarire il concetto di numero. Dopo la sua morte i teoremi di incompletezza di Gödel dimostrarono formalmente che lo scopo perseguito da Frege non era raggiungibile. L’ultimo disperato tentativo di Frege fu la riduzione della matematica alla geometria e all’intuizione sensibile pura, determinando i numeri complessi (non più i numeri interi positivi) nei termini del rapporto tra punto e linea nel piano. Ma l’opera rimase incompleta e comunque infruttuosa.
APPROFONDIMENTO
A cura di Matteo Areni
Friedrich Ludwig Gottlob Frege è stato un matematico, logico e filosofo tedesco che può essere considerato il padre della logica moderna e della filosofia analitica. Infatti, la sua opera Begriffsschrift (Ideografia) del 1879 ha segnato una vera e propria rivoluzione della logica, che era sostanzialmente rimasta inalterata dopo la formulazione di Aristotele. In quest’opera, che è stata addirittura definita “la singola opera più importante che mai sia stata scritta in logica”, Frege sviluppa un linguaggio formale che rappresenta tuttora il punto di partenza per quelli utilizzati in età contemporanea.
Frege professava una spiccata diffidenza nei confronti dei cosiddetti “linguaggi ordinari”; pur riconoscendone l’indispensabilità per gli scopi della vita quotidiana, egli li considerava strumenti inaffidabili per chi volesse impegnarsi nella ricerca teorica. Frege fu spinto a questo pensiero dalla constatazione che i linguaggi ordinari sono ambigui, presentano insidie e problemi che spesso ci portano a gravi incomprensioni:
«compito della filosofia è spezzare il dominio della parola sullo spirito umano, svelando gli inganni che, nell’ambito delle relazioni concettuali, traggono origine, spesso quasi inevitabilmente, dall’uso della lingua, e liberare così il pensiero da quanto di difettoso gli proviene soltanto dalla natura dei mezzi linguistici».
Nonostante quest’avversione verso i linguaggi ordinari Frege li tiene in grande considerazione, anzi, nelle opere del logico sono presenti alcune delle pagine di analisi dei linguaggi naturali più lucide che siano mai state scritte. Questo perché Frege credeva che per eliminare le insidie dei linguaggi naturali fosse fondamentale capire il loro esatto funzionamento, sia per quanto riguarda le strutture che per quanto concerne le parole. L’ideografia, infatti, oltre a mostrarci questo nuovo linguaggio, alternativo a quello naturale, può anche essere letta come un’esplicitazione dei meccanismi espressivi che nel linguaggio ordinario rimangono celati, non compresi. Procedendo nella sua indagine Frege elabora quindi la sua teoria semantica basata su alcuni principi che assumeranno un valore importantissimo nello studio della logica successiva tanto che, anche se alcune soluzioni del filosofo non sono probabilmente più sostenibili, nelle discussioni contemporanee i temi trattati in materia sono i classici temi su cui si dedicò lo stesso Frege.
Über Sinn und Bedeutung
Frege contro Agostino
Senso e denotazione, testo pubblicato nel 1892, è forse il più importante articolo di filosofia del linguaggio scritto da Frege. Senza pretendere di esaurire i compiti della disciplina, possiamo dire in breve che la filosofia del linguaggio si occupa di comprendere il linguaggio umano e di capire i suoi rapporti con pensiero e realtà. Per comprendere le idee di Frege possiamo partire dall’analizzare un’immagine del processo di apprendimento donataci da un famoso passo delle Confessioni di Agostino che, almeno in linea generale, rappresenta l’idea che si aveva in materia prima della logica contemporanea.
Confessioni,I,8: « Quando (gli adulti) nominavano qualche oggetto, e, proferendo quella voce, facevano un gesto verso qualcosa, li osservavo e ritenevo che la cosa si chiamasse col nome che proferivano quando volevano indicarla. (…) Così, udendo spesso le stesse parole ricorrere al posto appropriato in proposizioni differenti, mi rendevo conto poco a poco di quali cose esse fossero i segni e avendo insegnato alla lingua a pronunziarle, esprimevo ormai con esse la mia volontà».
Questo passo non rappresenta una vera e propria teoria del significato tuttavia estrapolandone i concetti possiamo formularne una in questo modo: le parole del linguaggio denominano oggetti e gli enunciati sono connessioni di tali denominazioni. Il significato di una parola è dunque l’oggetto per il quale la parola sta. Comprendere una parola, “sapere cosa significa”, equivale a sapere per quale oggetto essa stia.
La logica contemporanea nasce proprio quando Frege avanza delle tesi per respingere questa immagine che giudica troppo superficiale; in particolare secondo Frege il significato di una parola non si esaurisce nell’oggetto che essa denota, ci deve essere qualcosa in più. Non solo la denotazione/riferimento (Bedeutung) dunque, ma anche qualcos’altro. In particolare se il rapporto con l’oggetto denominato esaurisse il significato di una parola, allora non riusciremmo a spiegare certe differenze evidenti tra enunciati riguardo al loro diverso “valore informativo”. Per fare un esempio freghiano, considerando la tesi agostiniana non si riesce a comprendere come mai gli enunciati “Espero è uguale ad Espero” e “Espero è uguale a Fosforo”, pur denotando lo stesso oggetto (il pianeta Venere), ci forniscano valori informativi molto differenti; infatti il primo enunciato non ci dice nulla di nuovo, mentre il secondo reca con sé un importante valore informativo poiché rappresenta una scoperta astronomica di notevole importanza (Fosforo ed Espero, rispettivamente il primo pianeta a comparire la sera e il primo a comparire la mattina, in realtà sono lo stesso pianeta, cioè Venere). Appare dunque chiaro che la parola non esaurisce il suo significato nel denotare l’oggetto per cui sta, ma porta in sé qualcosa che è appunto responsabile della differenza di valore informativo. Frege nella sua terminologia distinguerà appunto la denotazione (Bedeutung), ossia l’oggetto per cui la parola sta, dal senso (Sinn), ossia dal suo valore informativo e applicherà questa distinzione a tutte le categorie di espressioni linguistiche (termini singoli, enunciati e predicati).
Senso e denotazione nei termini singolari
Per capire meglio questa distinzione fondamentale analizziamola innanzitutto in riferimento ai termini singolari, che possiamo distinguere in “nomi propri” ed “descrizioni definite”. Cosa sono i nomi propri non è necessario spiegarlo; per eventuali esempi nel corso della trattazione useremo il nome proprio “Aristotele”. Per descrizioni definite intendiamo invece i termini singolari che iniziano con un articolo determinativo e singolare; in questo caso useremo come esempi “il maestro di Alessandro” e “ il discepolo di Platone”.
Definiamo denotazione/riferimento di un nome N, l’oggetto di cui N è nome, mentre definiamo denotazione/riferimento di una descrizione definita D, l’oggetto/cosa inanimata/entità astratta che D descrive. La denotazione del nome “Aristotele” è dunque Aristotele in carne ed ossa; la denotazione della descrizione definita “il discepolo di Platone” è Aristotele.
La nozione di senso rappresenta invece il “differente modo di essere dato del riferimento”. Prendendo in esame le descrizioni definite, notiamo come ognuna di esse ci presenta l’oggetto in un determinato modo, ce lo mostra da un punto di vista particolare. Ad esempio se uso la descrizione definita “il discepolo di Platone” induco a pensare ad Aristotele da quel determinato punto di vista mentre se uso “il maestro di Alessandro”, pur continuando a denotare lo stesso individuo, lo mostro da un altro punto di vista. Notiamo come il riferimento sia lo stesso ma preso in considerazione da due diversi punti di vista, da due sensi differenti.
Ora che abbiamo chiarificato in parte la complessa nozione di senso possiamo cercare di comprenderla in riferimento ai nomi propri. È infatti difficile attribuire la nozione di senso ai nomi propri come “Aristotele”. Secondo Frege il nome proprio può essere considerato un’abbreviazione di una descrizione definita ed il senso del nome è quello della descrizione definita. Tuttavia è difficile comprendere di quale descrizione definita il nome “Aristotele” sia abbreviazione; infatti potrebbe essere sia “il discepolo di Platone” sia “il maestro di Aristotele” (e tanti altri). È proprio notando questa difficoltà che Frege individua il primo difetto del linguaggio naturale: l’impossibilità di attribuire uno specifico senso ad un nome proprio è dovuta al fatto che parlanti diversi associano ad un medesimo nome sensi diversi. Questo naturalmente genera grandi ambiguità e incomprensioni che in un linguaggio formale dovrebbero essere evitate; in particolare un linguaggio ideale dovrebbe associare a ogni nome uno e un solo senso fissato in modo preciso. Questo punto è riproposto in modo sistematico da Frege, il quale non esita ad affermare che è solo in virtù del senso che le espressioni hanno un riferimento. Se a un nome N non corrisponde alcun senso, nessun modo di essere dato, non c’è nulla che determini di quale oggetto N è nome, e quindi N non è nulla, non esiste. Comprendiamo, dunque, che il senso associato ad un nome N ci permette di richiamare nel discorso l’ente che gode di quelle determinate proprietà espresse dal senso, di isolarlo e di attribuirgli il nome N.
Differenze tra senso e tono e tra senso e rappresentazione
Frege ci avverte che nel considerare il senso di un termine singolare bisogna stare attenti a non confonderlo con le “rappresentazioni” (Vorstellungen) che a esso si collegano. Il senso è infatti una nozione logica che può essere afferrata da chiunque e su questo si basa la possibilità della comunicazione per mezzo del linguaggio. Le rappresentazioni, che sono propriamente le immagini, le sensazioni e gli stati d’animo che evocano in noi le parole, sono invece nozioni psicologiche e “eminentemente soggettive”. Si ricordi che Frege attribuisce anche al senso un certo grado di soggettività (parlanti diversi associano a uno stesso nome sensi diversi), tuttavia tutti siamo in grado di cogliere un senso e riferirlo al nome che denota mentre l’incomunicabilità rappresenta l’essenza stessa delle rappresentazioni.
Frege ci ricorda anche di non confondere la nozione di senso con quella di tono. Il tono di una parola è una particolare sfumatura che il termine possiede, ed essa non influisce sul senso. Per fare un esempio, le espressioni “cavallo” e “destriero” hanno il medesimo senso ma varia il loro tono, ossia la sfumatura estetica/linguistica dell’espressione. Questo principio si applica anche alle traduzioni (“la regina di Inghilterra” e “la Reine d’Angleterre”), che sostanzialmente variano il tono dell’enunciato ma non il loro senso. Certo, sarebbe auspicabile che la traduzione mantenesse anche un tono più vicino possibile all’enunciato di partenza, tuttavia ciò che risulta veramente importante è il non variarne il senso. Partendo da queste considerazioni sul tono Frege individua un altro problema del linguaggio naturale che consiste nel veicolare contenuti in forma implicita. In particolare questa considerazione nasce dall’osservare che l’espressione “e” e “ma” hanno lo stesso tono quindi una frase del genere “Benedetta è bella e intelligente” dal punto di vista logico ha lo stesso senso di “Benedetta è bella ma intelligente”. Tuttavia queste due espressioni differiscono in qualcosa perché la seconda ci comunica implicitamente un’opposizione tra bellezza e intelligenza. In effetti, sentendo pronunciare questo secondo enunciato, il pensiero che ci viene veicolato sarebbe grossomodo questo: “Benedetta pur essendo bella è intelligente”. Per alcuni questa capacità di comunicare implicitamente contenuti, insita nei linguaggi naturali, rappresenta la potenza e la ricchezza degli stessi; tuttavia dal punto di vista logico questo deve essere considerato un difetto poiché è una delle cause principali di ambiguità e fraintendimenti, che un linguaggio ideale non dovrebbe possedere.
Der Gedanke
Senso e denotazione negli enunciati
Ora occupiamoci della distinzione di senso e significato per quanto riguarda gli enunciati. Prima di introdurre il discorso ricordiamoci alcuni concetti fondamentali. Gli enunciati sono quelle proposizioni alle quali possiamo attribuire un valore di verità (vero o falso) mentre le condizioni di verità di un enunciato rappresentano il modo in cui il mondo dovrebbe essere affinché l’enunciato sia vero. Comprendere un enunciato significa dunque sapere quali sono le sue condizioni di verità, ossia sapere come dovrebbe essere il mondo per far si che l’enunciato né costituisca una descrizione appropriata.
Secondo Frege il senso di un enunciato è il pensiero (Gedanke) che esso esprime, il suo contenuto oggettivo. Il logico aggiunge che agli enunciati, nonostante la definizione secondo la quale possono essere veri o falsi, non si potrebbe attribuire verità o falsità perché queste proprietà sono da attribuire essenzialmente ai pensieri che gli enunciati esprimono. Infatti, i valori di verità (vero e falso) di questi ultimi sono oggettivi e stabiliti una volta per tutte; i pensieri sono veri o falsi in maniera assoluta indipendentemente da qualunque essere umano. Questi concetti espressi da Frege vanno opportunamente discussi in quanto a prima vista sembrano assolutamente inverosimili. Se prendiamo un enunciato del tipo ”Io sono italiano”, il suo valore di verità varia secondo chi pronuncia tale enunciato; per esempio si dirà qualcosa di vero se e solo se chi lo proferisce è realmente italiano. Questo sembra contraddire la teoria freghiana appena esposta, in base alla quale i pensieri esprimono un valore di verità assoluto e oggettivo. Frege si occupa di questo problema in un articolo del 1918 chiamato “Der Gedanke” e lo risolve in maniera molto semplice. Infatti, quando un enunciato viene proferito da persone differenti cambiano anche le sue condizioni di verità e quindi sostanzialmente cambia anche il pensiero espresso. L’enunciato “Io sono italiano” esprime dunque pensieri diversi secondo chi li proferisce; se Matteo proferisce questo enunciato il pensiero espresso sarà del tipo “Matteo è italiano”, se invece lo proferisce Benedetta il pensiero espresso sarà del tipo “Benedetta è italiana”. Sono questi due pensieri a essere oggettivamente veri o falsi in maniera assoluta e non l’enunciato di partenza. Infatti, l’enunciato esprime un pensiero diverso a seconda del contesto d’uso e ognuno dei possibili pensieri esprimibili ha proprie condizioni di verità e propri valori di verità oggettivi e assoluti.
Ricordiamo inoltre che la stessa distinzione tra senso e rappresentazione valida per i termini singolari vale anche in relazione agli enunciati, e quindi al pensiero. Anch’esso infatti, come il senso dei termini singolari, ha una natura logica e non psicologica; le rappresentazioni sono sempre rappresentazioni di soggettive di qualcuno mentre i pensieri non hanno bisogno di un portatore perché sussistono autonomamente.
Sinn und Bedeutung: «Col termine pensiero intendo non l’atto soggettivo del pensare, ma il suo contenuto oggettivo che può costituire il possesso comune di molti».
Der Gedanke: «Se ogni pensiero ha bisogno di un portatore alla cui coscienza appartenere, è un pensiero di questo portatore soltanto, e non vi è mai una scienza comune a molti e alla quale in molti possono lavorare. (…) In questo modo la discussione sulla verità è altrettanto oziosa, fino al ridicolo, quanto lo sarebbe la discussione sull’autenticità di una banconota da cento marchi tra due tizi ciascuno dei quali intenda la banconota che lui ha in tasca e dia al termine “autenticità” un senso del tutto particolare noto soltanto a lui. (…) Sembra che quindi il risultato sia che i pensieri non sono né cose del mondo esterno né rappresentazioni».
Costatiamo, dunque, che secondo Frege i pensieri appartengono platonicamente ad un “terzo regno” distinto sia dal regno degli oggetti materiali sia dal regno dei processi psicologici; essi sono oggettivi e sussistono autonomamente al di fuori del tempo e indipendentemente dal fatto che qualcuno li pensi o no. Quest’ oggettività dei pensieri è fondamentale perché, come possiamo leggere nel frammento, rende possibile la scienza e la comunicazione. Quando pensiamo noi entriamo in rapporto, attraverso operazioni mentali, con questo terzo regno. Come questo accada non è esaminato da Frege perché, dal suo punto di vista, si sfocerebbe in problemi psicologici che il logico non è tenuto ad affrontare.
Ora non ci resta che parlare della denotazione degli enunciati. Per Frege la denotazione di un enunciato è il suo valore di verità (vero o falso). Dato che potrebbe essere complicato comprendere il motivo per cui il logico dà questa definizione, è importante sottolineare che per Frege il vero e il falso sono oggetti, e come tali sono denotati dagli enunciati; così tutti gli enunciati veri hanno come riferimento il vero e tutti gli enunciati falsi hanno come riferimento il falso. Da un altro punto di vista potremmo dire che così come ai nomi corrispondono oggetti allo stesso modo ai pensieri corrispondono oggetti. La necessità che gli enunciati, così come i nomi, abbiano non solo un senso ma anche una denotazione e che in qualche modo alle nostre parole corrispondano elementi della realtà extralinguistica, quali sono appunto le denotazioni, è spiegato da Frege in questi termini: « il dare nomi alle cose non è una pratica fine a se stessa, noi vogliamo poter parlare delle cose, e il parlare delle cose comporta il comporre enunciati che possano essere veri o falsi a seconda della relazioni che gli oggetti intrattengono tra di loro; noi siamo interessati al pensiero espresso dall’enunciato solo quando siamo interessati anche al problema della verità dell’enunciato in questione». Si noti bene che gli enunciati sono veri o falsi indipendentemente dal fatto che noi sappiamo effettivamente quale sia il loro valore di verità; essi descrivono delle situazioni reali che noi possiamo anche non conoscere ancora. In ogni caso Frege vuole dirci che la nozione di verità ha un ruolo prioritario; il correlare parole e cose non ha altro scopo se non quello di ancorare il linguaggio alla realtà in modo tale che gli enunciati possano avere un valore di verità magari sconosciuto, ma comunque ben definito.
Der Gedanke: «Il pensiero che articoliamo nel teorema di Pitagora è vero atemporalmente, vero indipendentemente dal fatto che qualcuno lo ritenga vero… È vero non soltanto a partire dal momento in cui è stato scoperto, così come un pianeta è in un rapporto di azione reciproca con altri pianeti già prima che lo si scopra».
I tre problemi della teoria Agostiniana
Avendo compreso chiaramente il significato dei termini Sinn e Bedeutung possiamo ora analizzare le tre critiche rivolte da Frege alla teoria Agostiniana. Il logico sostiene infatti che se il significato di una parola si esaurisse nella denotazione, ossia nell’oggetto per cui la parola sta, non si potrebbero spiegare questi tre “problemi”: variazioni di valore informativo negli enunciati di identità, “enunciati contenenti termini non denotanti”, problema della “sostituitività”. Il primo problema sostanzialmente è stato già chiarito in precedenza: se prendiamo in considerazione “Espero =Espero” ed “Espero=Fosforo” la teoria agostiniana non è in grado di spiegare la differenza di valore informativo perché non tiene conto della nozione di senso. Per quanto riguarda il problema degli enunciati contenenti termini non denotanti, Frege ci mostra come la teoria Agostiniana non è in grado di spiegare neanche enunciati del tipo “Il re di Francia non esiste” o “Ulisse sconfisse i Proci”. Infatti, questi due enunciati, siccome non esiste un re di Francia e non esiste Ulisse, non si riferiscono a nessun individuo nel mondo e quindi non hanno denotazione; eppure noi comprendiamo benissimo questi enunciati, dunque il valore dei nomi non può esaurirsi nella denotazione. Per ultimo Frege ci ricorda che la teoria agostiniana non può neanche spiegare la differenza di valore informativo che si ottiene sostituendo in un enunciato due termini con la stessa denotazione. Consideriamo ad esempio gli enunciati “Matteo crede che Mark Twain abbia scritto le avventure di Tom Sawyer” e “Matteo crede che Samuel Clemens abbia scritto le avventure di Tom Sawyer”. In questo caso abbiamo semplicemente sostituito due termini che denotano la stessa persona e quindi, per il principio di sostituibilità, gli enunciati sono logicamente identici. La teoria agostiniana però non riesce a rendere conto della differenza di valore informativo del secondo enunciato, che effettivamente, nel caso non sapessimo che i due nomi si riferiscono alla stessa persona, ci fornisce questa preziosa informazione. Questi problemi sono spiegabili, per Frege, solo introducendo la nozione di senso.
Principio di composizionalità e principio di sostituibilità
Frege comunque sviluppa riflessioni molto interessanti a partire da questi problemi della teoria agostiniana, tuttavia prima di affrontarle è necessario spiegare i concetti di “principio di composizionalità” e “principio di sostituibilità” relativi agli enunciati. Secondo il principio di composizionalità noi siamo in grado comprendere enunciati complessi che non abbiamo mai sentito prima poiché conosciamo le parole che lo compongono; infatti, i linguaggi naturali, con un numero finito di espressioni semplici e di regole sintattiche sono in grado di creare un numero infinito di espressioni complesse. Questo principio vale anche per senso e denotazione; noi calcoliamo il senso e i valori di verità delle espressioni complesse a partire dal senso e dal valore di verità degli enunciati componenti.
Il principio di sostituibilità ci dice invece che sostituendo parti con uguale denotazione, la denotazione del tutto non cambia. Allo stesso modo sostituendo parti con uguale senso, il senso del tutto non cambia. Naturalmente questo principio è strettamente legato al precedente, infatti, esso è valido solo per i linguaggi composizionali.
Considerazioni sui problemi della teoria agostiniana
Tenendo conto di tali principi, Frege afferma che l’espressione “Ulisse sconfisse i Proci” è non denotante poiché contiene l’espressione semplice “Ulisse”, anch’essa non denotante. Queste espressioni esprimono dunque un pensiero (senso) ma non hanno un valore di verità (denotazione), non sono né vere né false. Infatti, nella finzione narrativa, quando leggiamo un libro o vediamo un film, non siamo particolarmente interessanti al valore di verità degli enunciati ma solamente al loro senso, al pensiero che essi esprimono. Viceversa l’indagine scientifica è caratterizzata da una forte tensione verso la verità e quindi focalizza la sua attenzione non sul senso ma sulla denotazione. Per questo motivo nei linguaggi ideali non sono ammessi termini non denotanti poiché in matematica non è tanto il senso che conta ma la denotazione).
Sinn und Bedeutung: «Perché mai vogliamo che ogni nome proprio abbia non solo un senso ma anche una denotazione”? Perché non ci basta il pensiero? Perché ciò che ci interessa è il valore di verità dell’enunciato».
Frege, riflettendo sul problema della sostituibilità, scopre alcuni limiti del principio di composizionalità dei linguaggi naturali. Ad esempio nei contesti enunciativi indiretti non sembra valere il principio per cui sostituendo parti con uguale denotazione la denotazione del tutto non cambia. I concetti enunciativi indiretti sono quegli enunciati composti con verbi come credere, volere, sperare, dire che seguono lo schema “X crede che P”, dove P è chiamato enunciato incassato. Per fare un esempio, l’enunciato “Copernico crede che le orbite dei pianeti fossero circolari” che ha come valore di verità (V), dovrebbe mantenere lo stesso valore di verità (V) se sostituisco parti con stessa denotazione. Però sostituendo l’enunciato incassato falso “le orbite dei pianeti sono circolari” con un altro enunciato falso, ad esempio “la luna è fatta di formaggio”, l’enunciato complesso “Copernico credeva che la luna è fatta di formaggio” ha cambiato valore di verità; non è più vero ma falso, poiché Copernico non aveva assolutamente tale credenza. Frege tenta di risolvere tale problema dicendo che nei contesti enunciativi indiretti la denotazione dell’enunciato incassato non è quella consueta, ossia il suo valore di verità, ma il suo senso usuale (pensiero espresso), che Frege chiama denotazione indiretta. Secondo questo ragionamento per fare valere il principio di sostituibilità bisogna quindi sostituire un enunciato con lo stesso senso e non con la stessa denotazione. Nel nostro caso bisognerebbe sostituire all’enunciato “le orbite dei pianeti sono circolari” un enunciato del tipo “i pianeti seguono delle traiettorie a forma di cerchio”. Tuttavia questa spiegazione è incompleta giacché non si capisce allora quale sia effettivamente il senso dell’espressione; inoltre le cose si complicano esponenzialmente se costruiamo enunciati che contengono non uno ma numerosi enunciati incassati. In ogni caso la semplice violazione del principio di composizionalità, in logica, decreta che la teoria presenta delle lacune e va sostituita o al massimo modificata.
I predicati
Rimangono ora da analizzare le nozioni di senso e denotazione relative ai predicati. I predicati possono essere definiti come quelle espressioni che, combinate con un termine singolare e opportunamente modificate, producono un enunciato. Prendiamo come esempio il predicato “essere nero”; se lo combiniamo in modo opportuno con il termine singolare “il mantello di Zorro” otteniamo l’ enunciato “Il mantello di Zorro è nero”.
Per Frege la denotazione di un enunciato è un concetto. Nella complessa terminologia freghiana il termine concetto non ha la sfumatura classica ma è definito come una funzione i cui valori sono valori di verità. Comprendere questa definizione non è per niente semplice, anche perché richiede la conoscenza e di nozioni logico-matematiche e di nozioni di teoria degli insiemi; per di più lo stesso Frege non è mai stato chiarissimo nello spiegare questa teoria. Per questi motivi la spiegazione della denotazione dei predicati in termini di concetto elaborata da Frege non verrà analizzata accuratamente ma si prediligerà la spiegazione posteriore elaborata da Carnap sulla nozione di “estensione” (che comunque si deriva dal sistema freghiano, tanto che molti hanno sostenuto che egli avesse proprio l’idea di estensione in mente). Per estensione di un predicato P si intende l’insieme di tutti gli oggetti cui P si applica veridicamente; l’estensione di “essere nero”, ad esempio, è l’insieme delle cose nere. Per Carnap appunto il riferimento di un predicato coincide con la sua estensione. Questa idea sarebbe perfettamente applicabile anche al sistema di Frege e sostanzialmente non è molto lontana da quello cui il logico voleva arrivare; tuttavia Frege né parla in modo diverso. Egli dice che il riferimento di un predicato P è la funzione F tale che, per ogni oggetto x, F(x)= il vero, se x appartiene all’estensione di P; e F(x)=il falso, se x non appartiene all’estensione di P. Nel nostro esempio diremmo che il riferimento di “essere nero” è la funzione N tale che, per ogni oggetto x, N(x)=il vero se x è nero e R(x)=il falso, se x non è nero. Senza dimenticare che quest’ argomento dovrebbe essere approfondito per comprendere quale sia la definizione più appropriata, noi considereremo come buona la definizione elaborata da Carnap. Anche per quanto riguarda il senso dei predicati, siccome Frege non dice quasi nulla a riguardo, utilizzeremo sempre la spiegazione di Carnap. Il senso di un predicato è l’intensione, ossia il suo contenuto. Questa nozione ci permette di comprendere come mai predicati del tipo “essere un animale con il cuore” e “essere un animale con i reni”, pur avendo la stessa estensione (tutti gli animali), esprimono intuitivamente due concetti diversi (hanno due sensi diversi).
W. WHEWELL

A cura di Guido Marenco
William Whewell fu certamente una delle più importanti e influenti figure di intellettuale, filosofo, “polymath”, cioè individuo di vastissimi interessi ed erudizione enciclopedica, del XIX secolo nel Regno Unito di Gran Bretagna.
Lo testimoniano le opere composte su svariati argomenti quali la meccanica, la mineralogia, la geologia, l’astronomia, l’economia politica, la teologia e, persino, l’architettura.
Fu per lungo tempo Presidente della British Associastion for the Advancement of Science, membro della Royal Society e Master del Trinity College di Cambridge.
La sua importanza in ambito filosofico deriva dalle sue opere di storia della scienza e di filosofia della scienza.
Questo scritto si basa in gran parte sulle note di Laura Snyder reperibili all’indirizzo , ma sviluppa alcuni punti in modo sicuramente diverso.
Qualche nota biografica
William Whewell nacque nel 1794 a Lancaster, primogenito di un mastro-carpentiere.
Di intelligenza precoce, fu ritenuto molto promettente dal suo parroco che persuase il padre a fargli proseguire gli studi all’Haversham Grammar School a Westmoreland.
Nel 1812 entrò al Trinity College e nel 1814 vinse anche un premio per la composizione del poema epico Boadicea. Nonostante la scoperta della vena letteraria, non trascurò affatto il lato matematico della sua formazione, ed, anzi, lo intensificò, dimostrando di avere una grande attitudine a questo tipo di studi.
Nel 1825 divenne prete anglicano; nel 1828 ottenne una cattedra in mineralogia, ma fu solo nel 1838 che divenne Professor of Moral Philosophy.
Nel 1841 sposò Cordelia Marshall, e poco dopo fu nominato Master of Trinity College, su calda raccomandazione del primo ministro Robert Peel.
A seguito della scomparsa della prima moglie, si sposò una seconda volta con Lady Affleck. Morì nel 1866.
Il contesto culturale: tra romanticismo ed empirismo risorge il criticismo
Per avere idea dell’importanza di Whewell occorre un rapido colpo d’occhio allo stato del dibattito filosofico in Inghilterra nei primi decenni del secolo.
Scrive in proposito Stefano Poggi: «I mutamenti che lo sviluppo della conoscenza scientifica nella riflessione filosofica, nelle “concezioni del mondo” non mancano di dar luogo, anche in Gran Bretagna, ad un certo movimento di reazione o, comunque di conservazione. Viene così rivendicata l’importanza dell’individualità, della riflessione interiore. Con Coleridge – e poi, ma ormai verso la metà del secolo, con Carlyle – prende consistenza un atteggiamento di pensiero ormai sensibile ad alcuni motivi della filosofia dell’idealismo tedesco: una forte ispirazione non solo idealistica, ma romantica (da ricondurre assai spesso a Schelling) spinge alla polemica contro la tematica del “senso comune” e, più in generale, induce a negare che la conoscenza scientifica possa assicurare una reale liberazione dello “spirito”. » ( da Introduzione al Positivismo)
Allo stesso tempo anche la tradizione empirista trovò nuovo slancio, soprattutto attraverso John Stuart Mill, il quale non mancò di introdurre nel dibattito filosofico di quegli anni alcuni elementi della filosofia comtiana.
Ma in contrasto con queste tendenze, specie a partire dagli anni ’30, si ebbe una riapertura al pensiero kantiano, soprattutto grazie a W.H. Hamilton.
Annota ancora Stefano Poggi: « Il criticismo sembrava fornire strumenti assai potenti per operare una sorta di “revisione” dei temi di fondo della tradizione empiristica. Questa linea di riflessione contraddistinta anche dall’attenzione per la storia del pensiero scientifico e filosofico moderno – affrontava sopratutto i problemi dell’induzione e dell’ipotesi. Il dibattito apertosi con il Preliminary Discourse di Herschel veniva così ad ampliarsi, in primo luogo con il contributo di una delle figure più rappresentative ed attive sul piano della riorganizzazione degli studi scientifici in Inghilterra: William Whewell. Nella sua History of the Inductive Sciences (1837) e ancor più nella Philosophy of Inductive Sciences (1840), Whewell assegnava rilievo particolare al problema della formulazione delle ipotesi. » (idem)
La storia delle scienze
Per Whewell fu subito evidente che per portare alla luce i modelli ed i metodi utilizzati nelle scienze era fondamentale privilegiare la ricostruzione storica ed obiettiva delle scoperte scientifiche.
Lo storico della scienza deve saper trovare una sintesi, laddove sia possibile, o comunque trovare quanto vi è di comune a discipline anche distanti, obbligandosi a rispettare le eventuali anomalie e discordanze di procedura.
Nel tentare questa sintesi, Whewell scelse di evidenziare che tutte le scienze si sviluppano dal confronto tra idee e dati di fatto. Che era come dire che la tradizione razionalista (la preminenza delle idee da cui dedurre) e quella empirista (i fatti da cui indurre), in filosofia fiere avversarie, solo nella scienza da un lato, e nel criticismo kantiano dall’altro, avevano trovato un modo di convivenza accettabile, se non proprio armonioso.
L’interpretazione dei processi cognitivi e della conoscenza scientifica in generale doveva pertanto cominciare dalla constatazione che esisteva una polarità tra idee (spesso frutto della conoscenza preesistente individuata da Aristotele) e dati di fatto dell’esperienza.
“Armato di questo principio – scrive John Losee – cercò di dimostrare il progresso di ciascuna scienza ricostruendo la scoperta dei dati di fatto ad essa pertinenti e la loro integrazione nel contrasto di idee appropriate. ” (da Filosofia della scienza – Il saggiatore – Milano, 2001)
Idee e dati di fatto: quando un’idea è anche un dato di fatto
Tutta la conoscenza trae origine da questo dualismo tra la dimensione oggettiva e la dimensione soggettiva; Whewell definì questo dualismo la fondamentale antitesi della conoscenza.
Per Whewell le idee fondamentali non vengono solo dalle percezioni e dalle osservazioni del mondo, “non sono una conseguenza dell’esperienza, ma un risultato della particolare costituzione ed attività della mente, che è indipendente da tutte le esperienze nella sua origine, sebbene costantemente combinata con l’esperienza nel suo esercizio.” (1858 a, I, p. 91)
Whewell parlò a volte di dati di fatto in termini di resoconti delle nostre percezioni di eventi ed oggetti, ma sottolineava anche che questi resoconti erano solo un tipo di dati di fatto.
Esistevano altri dati di fatto e, per esempio, mostrò che anche le leggi di Keplero erano state per Newton dati di fatto. Fu muovendo da essi che Newton aveva elaborato la propria teoria. Per Whewell una teoria poteva essere, dunque, un dato di fatto alla stessa stregua di un oggetto o di un evento nel momento stesso in cui serviva da supporto ad un’altra teoria.
Le idee, dal canto loro, erano per Whewell sopratutto principi razionali, una sorta di regole finalizzate al collegamento appropriato dei dati di fatto. D’accordo con Kant, fu quindi persuaso che le idee si imponevano alle sensazioni, e non venivano derivate da esse.
Ma cosa intendeva, più precisamente, Whewell per idea?
Questo punto sarebbe da chiarire con maggiore dovizia di particolari. Per ora dovremo accontentarci di questo: oltre alle idee intese come nozioni generali e fondamentali quali quelle di spazio, tempo, causa, numero, Whewell riconobbe l’esistenza di idee elementari di particolari scienze, quali l’affinità elettiva in chimica, le forze vitali in biologia e i tipi naturali in tassonomia. Ma Whewell si guardò bene dall’elaborare una lista delle idee elementari. Credeva che esse sarebbero emerse dallo sviluppo delle singole scienze.
Il contenuto della percezione e la contestualizzazione dell’evento o dell’oggetto
Per Whewell il dato di fatto puro, separato da ogni idea, o meglio, da ogni categoria, non esiste. Spazio, tempo, numero, inquadrano ogni oggetto ed ogni evento, lo contestualizzano. Di conseguenza, perfino i dati più elementari implicano qualcosa che ha il carattere della teoria. Quando parliamo di fatti, ecco che voleva dire Whewell, non siamo sempre consapevoli del modo con il quale le nostre fondamentali categorie mentali (quelle che rispondono alle domande: dove, quando, quante volte, perchè?), leggono la nostra esperienza sensibile. Ma esse intervengono sempre a priori.
Ovviamente anche le teorie che sono insieme dati di fatto, vengono contestualizzate.
Quando definiamo un ragionamento generale come teoria, attribuiamo grandissima attenzione alle teorie che supportano il ragionamento stesso e pertanto non ricorriamo a leggi chimiche se dobbiamo spiegare come si ottiene il volume di un tronco di cono.
Tuttavia, se la teoria è sempre un’inferenza conscia, il dato di fatto a volte è un’inferenza inconscia.
Scriveva in proposito: «…abbiamo ancora una distinzione intellegibile tra dato di fatto e teoria, se consideriamo la teoria un’inferenza conscia, e il dato di fatto un’inferenza inconscia che prende le mosse da fenomeni che si presentano ai nostri sensi. » (da The Philosophy of Inductive Sciences founded upon their History – Parker – London – 1847)
L’induzione
Un volume della 3° edizione di Philosofy of Inductive Sciences founded upon their History si intitolò Novum Organum Renovatum.
Era evidente, ai limiti della provocazione, che Whewell aspirava ad un tempo sia a richiamare l’attenzione su Bacone ed il metodo induttivo, sia a criticarlo per rinnovarlo. Da quel che ho capito, anche Whewell considerava ristretto il concetto di induzione come semplice enumerazione di istanze. Nell’induzione c’è un nuovo elemento aggiunto alla combinazione di istanze, ed esso è il risultato di un atto del pensiero che con esse si combina.
Whewell definì questa mossa del pensiero colligation, in antitesi a collection, e voleva significare che l’induzione produce la colligation, ovvero l’operazione capace di selezionare e tenere insieme un certo numero di fatti empirici, descrivendoli con una legge generale in grado di mostrarne le proprietà.
In sostanza Whewell mostrò che l’induzione è un processo dinamico, e che la spinta proviene sia dallo stimolo, ciò che attira la nostra attenzione, sia dal nostro modo interno di organizzare e combinare in modo appropriato i dati.
Modelli di scoperta scientifica
Whewell asserì di aver riconosciuto nella sua ricognizione della storia delle scoperte uno sviluppo articolato in tre fasi: un preludio, un momento induttivo e un seguito.
Intendeva per preludio la raccolta dei dati, la loro configurazione e scomposizione, il chiarimento dei concetti.
Il momento induttivo era concepito da Whewell come l’applicazione di un certo modello concettuale ai dati stessi.
Il seguito veniva descritto come integrazione e consolidamento tra dati e teoria.
E’ importante osservare che il preludio per Whewell non è una qualsiasi fase congetturale, un guesswork; infatti affermò: « Here is a special process in the mind, in addition to the mere observation of facts, which is necessary. » E ancora: ” We infer more than we see.”
Il problema fu dunque trovare le regole con le quali collegare una classe di fenomeni, oggetti, eventi, attraverso inferenze appropriate. Si tratta di un problema delle pertinenze, presentabile come the generalization of the shared property over the complete class, including its unknown members, ovvero come l’estensione-generalizzazione di proprietà condivise di una classe completa anche ad ai mebri sconosciuti della classe stessa.
Whewell fece riferimento alle procedure newtoniane come esempio. Newton aveva inglobato nel suo metodo, come dato di fatto, la teoria di Keplero sulle ellissi formate dai pianeti in orbita attorno al sole.
Ma lo stesso Keplero aveva, a sua volta, sempliicemente esteso le proprietà osservate nell’orbita di Marte a tutti i membri della classe pianeti.
Questo tipo di approccio portò Whewell a rifiutare l’idea di Herschel, secondo la quale anche ipotesi scientifiche non avanzate attraverso procedure razionali, potevano essere confermate da tests. Nel recensire il Preliminary Discourse on the Study of Natural Philosophy, Whewell affermò che non è possibile alcuna verifica di ipotesi non risultanti da un procedimento induttivo.
Tuttavia, è necessario sottolineare che Whewell non volle negare con ciò il talento del singolo: infatti anche se la procedura induttiva è comune a tutti, solo alcuni sono in possesso di “quel lampo di genio” in grado di portare alla formulazione esatta di una teoria.
John Losee scrive in proposito: « La principale tesi whewelliana sull’induzione afferma che il processo della scoperta scientifica non può essere ridotto a regole. Comunque Whewell riconosceva che considerazioni di semplicità, continuità e simmetria venivano spesso affermate come principi regolativi nella scelta delle ipotesi. (idem)
La conferma
In questa luce assumeva decisiva importanza il problema della conferma, che per Whewell, a differenza che per Herschel, non si pone in termini di falsificazione della teoria (tutto ciò che la può smentire) ma di verifica, ovvero tutto ciò che depone a suo favore.
Indubbiamente quello di Whewell potrebbe sembrare un passo indietro, ma lo è solo in apparenza perchè mentre Herschel, vedeva di buon occhio chiunque avanzasse qualsiasi ipotesi, Whewell si era mostrato molto più cauto: prima di aprir bocca sincerarsi che le cose stiano proprio così. In altre parole: per Whewell era ovvio che qualcosa di simile alla falsificazione avviene prima che la teoria sia stata resa nota; con ciò evitiamo brutte figure.
La prudenza dell’induttivo, dunque, era per Whewell il non plusultra. Ogni nuova teoria doveva passare una seri di tests deduttivi prima di essere considerata come vera.
Con ciò si intende che se è vero che tutti gli uccelli hanno le ali, allora, sillogisticamente, deve essere che quello, essendo un uccello, ha le ali. Punto di non poco conto è che si deduce dalla proprietà universale riconosciuta, l’avere le ali, solo che gli uccelli hanno le ali, non l’inverso, perchè, ad esempio, anche il pistrello ha le ali, ma non è un uccello.
Ora è evidente che questo tipo di asserzione non ha particolare bisogno di falsificazione, ma solo di conferme.
Al contrario: l’asserzione tutti gli animali con le ali sono uccelli potrebbe essere smentita dal fatto che noi incontreremo un giorno un cavallo alato, un pipistrello, od anche un volatile rettile od un pesce volante, o una farfalla. Ed è questa asserzione azzardata che richiede falsificazione, cioè tutte le riserve che riusciamo ad avanzare rispetto alla nostra asserzione, piuttosto audace ed entusiastica.
I tests deduttivi invocati da Whewell furono sostanzialemente tre: predizione (prediction), concordanza (consilience, parola che nemmeno l’Hazon riporta) e coerenza (coherence)
L’esame della predizione consisteva ovviamente nel fatto che una teoria deve poter prevedere i fenomeni. E così spiegava la questione: « Affinchè il nostro assenso alle ipotesi implichi che sia tenuta ferma la verità di particolari istanze, sia che queste appartengano al passato o al futuro, sia che siano o non siano accadute, non fa differenza nell’applicabilità delle regole ad essi. Perchè la regola persista, essa include tutti i casi (185b, p. 86)
Un esempio di predizione fu l’applicazione della teoria newtoniana alla scoperta del pianeta Nettuno (1846). Solo utilizzando il modello newtoniano fu infatti possibile stabilire a priori che doveva esistere un pianeta, con quella locazione e quella massa per spiegare le anomalie dell’orbita di Urano. Chiunque non avesse confidenza con la teoria newtoniana, non avrebbe potuto e non potrebbe che considerare sbalorditiva e miracolosa la predizione. In realtà essa era solo il frutto di una deduzione.
La consilience (concordanza) era, secondo Whewell, un tipo particolare di evidenza che chiamò jumping together, probabilmente nel senso di superare con un balzo il limite che recinge una classe di fatti.
La concordanza consente di collegare fatti, oggetti ed eventi appartenenti ad un’altra classe. Ciò è particolarmente significativo quando la seconda classe di fatti è apparsa in un primo tempo non collegabile alla prima. Ad esempio Whewell citò la forza di gravitazione universale, dalla quale furono inferite le perturbazioni dei moti planetari, e la processione degli equinozi (1847, II, p. 66)
Quanto al criterio della coerenza va inteso subito che Whewell rimarcò la forte differenza rispetto alla concordanza.
Spiegò così la questione: nel caso di una teoria vera, essa può essere estesa ulteriormente e senza modificazioni. Nel caso di una teoria falsa, questo non può succedere senza modificazioni ad hoc dell’ipotesi di partenza. Newton non ebbe difficoltà ad estendere la sua teoria dei moti planetari e lunari alla classe della tidal activity, cioè alle maree. Al contrario, la teoria del flogisto in chimica fu seriamente messa in discussione in quanto inadatta a spiegare il peso dei corpi.
L’analogia degli affluenti: come Whewell interpretò la storia della scienza
Per Whewell la storia della scienza si presenta come uno sviluppo evolutivo simile alla confluenza di affluenti che riforniscono un fiume. Le scienze non procedono per balzi e rivoluzioni, ma per integrazioni e correzioni successive. La sua concezione fu dunque insieme sia selettiva che cumulativa nel quadro di una visione di un progresso tranquillo che non quadra esattamente con la storia vera, caratterizzata da rotture e rivoluzioni.
Per giustificare questa interpretazione singolare, egli considerò che anche una teoria sbagliata come quella del flogisto in chimica aveva svolto un ruolo positivo, stimolando i chimici a trovare soluzioni più soddisfacenti e complete. Inoltre questa stessa teoria sbagliata avrebbe consentito, secondo Whewell, una classificazione unitaria dei processi di combustione, acidificazione e respirazione.
Indubbiamente tutto ciò è vero in parte, ma l’idea del sapere cumulativo pare francamente piuttosto contestabile. In realtà tutto ciò che la scienza ha superato, cadde e continua a cadere spesso e volentieri nel dimenticatoio, gettando via bambino ed acqua sporca, quindi anche quelle contestualizzazioni che proprio Whewell aveva tanto care. Ma, quel che è peggio, è che nel superarsi continuo della scienza, vanno perduti sia antichi saperi che non erano semplici credenze o superstizioni, ma scienza nel vero senso della parola, ad esempio le proprietà medicinali delle erbe, e sia piste battute fino ad un certo punto e poi tralasciate perchè richiedevano investimenti di tempo e denaro inauditi. Del resto Whewell, nel suo tempo decisamente filantropico, popolato da studiosi del tutto eroici e disinteressati al guadagno (al più attirati dall’idea di farsi un nome), non poteva avere ancora chiaro che 1) la scienza poteva essere usata anche in senso distruttivo; 2) che a decidere cosa studiare e ricercare sarebbero stati i privati per trarne vantaggi economici, e i governi per trarne vantaggi di prestigio, militari e così via.
La verità necessaria
Come scrive D. Oldroyd, dunque, «Whewell credeva […] che le tendenze complessive della ricerca scientifica implicasse un avvicinamento progressivo alla scoperta della verità. A suo giudizio, la ragione per cui si poteva aver fiducia nel carattere progressivo della scienza consisteva nel fatto che di tanto in tanto era possibile conseguire concordanze (consiliences) di induzioni che consentivano di accertare qualche verità. […] nella storia della scienza, quelli che inizialmente erano formule disparate, fatti o teorie isolate, venivano gradualmente sussunte sotto leggi e teorie di livello di generalità crescente. Per esempio, fenomeni in apparenza distinti e separati come i moti osservati dei pianeti, le maree e la caduta delle mele dagli alberi di mele, potevano infine essere spiegati tutti in riferimento alla teoria newtoniana della gravitazione universale. »(da Storia della filosofia della scienza, Il Saggiatore – Milano 1989)
Questa lunga marcia di avvicinamento rappresentava per Whewell lo stesso scopo della filosofia della scienza, ovvero la ricerca della verità necessaria, la quale può essere conosciuta a priori solo se non si tratta di una verità sintetica.
Su questo piano egli si scostò quindi da Kant, per il quale 2+3 = 5 era una verità sintetica a priori.
Il ragionamento di Whewell muoveva dal fatto che solo la nostra idea di numero, di 2, di 3, di 5, di addizione, e, aggiungerei io, di risultato, ci consente di arrivare alla verità necessaria di 5 come risultato di 2+3.
Probabilmente Whewell fraintese Kant nel senso che l’affermazione di verità sintetica a priori circa una qualsiasi operazione aritmetica andava intesa come qualcosa che non richiede verifica empirica, ovvero: noi possiamo sbagliare i conti, ed è questo che va verificato, ma non possiamo avere dubbi sul fatto che 2+3 è sempre, e sotto qualsiasi condizione = 5.
Le operazioni matematiche contribuiscono dunque a costruire un insieme di certezze su cui contare stabilmente.
Whewell, in un primo tempo, si era convinto, proprio per i ragionamenti summenzionati, che il mondo dell’esattezza fosse circoscritto a quello degli assiomi della matematica, mentre le leggi della natura godevano di uno status cognitivo differente. (nel testo Astronomy and General Physics Considered with Reference to Natural Theology – Carey, Lea & Blanchard – Philadelphia 1836)
Solo le verità matematiche erano quindi verità necessarie. Ma poi cambiò opinione, asserendo che alcune leggi naturali erano verità necessarie.
John Losee spiega così la vicenda: « Whewell era pronto ad ammettere la natura paradossale di questa affermazione. Era d’accordo con Hume che nessun quantitativo di leggi empiriche, per quanto ingente sia, può dimostrare che una relazione non possa essere diversa da quello che è; eppure credeva che certe leggi scientifiche avevano conseguito lo status cognitivo di verità necessarie. » (Losee – idem)
In realtà, si potrebbe dire che Whewell non era affatto d’accordo con Hume; semplicemente aveva preso in considerazione il punto di vista scettico in modo sostanzialmente corretto, ovvero scorgendo tutto quanto di paradossale esiste non solo nell’affermare senza dubbio l’esistenza di leggi causali certe, ma anche la paradossalità dell’affermazione opposta: ovvero che le nostre convinzioni sulla causalità sarebbero solo credenze e abitudini mentali.
Tra questi due estremi non è che esista una semplicistica via di mezzo: esiste semplicemente il buon senso di comprendere che un’arma da taglio calata con violenza sulla carne viva produce una ferita e che questa è la causa della ferita. Ora, al di là di questa semplice ed immediata constatazione della causa della ferita, si potrebbe anche risalire alle condizioni di tutto l’universo in quel determinato istante, si potrebbe richiamare persino una presunta volontà di Dio circa la mia ferita, ma tutto ciò che a noi serve è capire quale mano abbia colpito, perchè ha colpito, con quale intenzione ha colpito.
Tutto questo è realisticamente comprensibile ed a questo livello di verità necessaria nessuna mente umana è preclusa.
Whewell, nel tentativo di mostrare quanto fosse insensata l’estremizzazione di un atteggiamento scettico, riprese una distinzione kantiana tra forma e contenuto della conoscenza, estendendola alle leggi fondamentali della natura.
Rientrava, dunque legittimamente in gioco l’dea basilare di causa ed il derivato concetto di causalità.
Scrive Losee: « Secondo Whewell, il significato dell’idea di causalità si può riassumere in tre assiomi: 1) nulla avviene senza una causa; 2) gli effetti sono proprozionali alle loro cause; e 3) la reazione è uguale ed opposta all’azione. Spetta all’esperienza, tuttavia, specificare il contenuto di tali assiomi. L’esperienza insegna che la materia bruta non possiede cause interne intrinseche dell’accelerazione, che le forze sono composte in un certo modo e che alcune definizioni di “azione” e “reazione” sono appropriate. Le leggi del moto di Newton esprimono queste scoperte. Whewell riteneva che le leggi newtoniane fornissero le interpretazioni empiriche adeguate degli assiomi di causalità, attingendo così allo status di verità necessarie. » (Losee – idem – riferimento a pp. 245-254 di Philosophy of Inductive Sciences)
Whewell seguì dunque una linea di ragionamento empirico induttiva ed analitica per dimostrare il principio delle verità necessarie, ma al fondo del suo ragionamento stavano anche considerazioni teologiche, ricavate per via intuitiva.
Secondo Whewell, infatti, il mondo fu creato da Dio in modo conforme alle sue “idee divine”.
L’idea di causa, che porta all’assioma “nulla avviene senza una causa” è un’idea di questo tipo.
Seguendo Whewell, noi saremmo in grado di comprendere la struttura della realtà perchè la nostra scienza tende ad assomigliare alle idee impiegate da Dio nella creazione del mondo fisico. Ciò non è casuale: Dio avrebbe creato le nostre menti ed i nostri sensi in modo tale da poter comprendere e non per venire ingannati.
Whewell, in sostanza, era convinto che il procedere della scienza avrebbe portato a ravvisare nell’universo un disegno intenzionale, e dunque la mano di un creatore.
Su questo piano, dunque, si differenziò in misura notevole dal mainstream del positivismo, reintroducendo teologia e metafisica, e puntando decisamente a mostrare che la scienza non solo non smentisce la teologia, ma condurrà a confermarla.
Questo atteggiamento di gran apertura del teologo Whewell era quanto di meglio si potesse trovare a quel tempo da parte di un uomo di fede e ragione.
La filosofia morale
La filosofia morale di Whewell fu criticata da Stuart Mill perchè questi ne vide un prototipo dell’etica intuitiva e deduttiva. Mill forzò certamente la mano in modo plateale asserendo che l’impostazione di Whewell veniva a giustificare pratiche come la schiavitù, i matrimoni forzati e la crudeltà sugli animali. Ciò si spiega col fatto che la morale di Whewell si fondava sostanzialmente sul convincimento interiore profondo e non su ragionamenti utilitaristici di morale e senso della giustizia derivati da accordi di cooperazione civile, politica ed economica.
Ovviamente le due concezioni erano molto distanti: la morale di Whewell era totalmente deduttiva; muoveva da un modello assiomatico. Quella di Mill era induttiva: muoveva da necessità pratiche, anche se poi finiva col dedurre diversi principi morali dal più generale diritto utilitaristico alla felicità.
Probabilmente Whewell trascurò l’aspetto storico- evolutivo del progresso morale. In realtà, prima della comparsa di forme rudimentali di legislazione che, se non altro, proibissero, all’interno della stessa comunità, il furto, l’omicidio ed il matrimonio tra consanguinei, pare assai difficile trovare nella storia umana un saldo principio morale da cui derivare assiomaticamente tutti gli altri.
Forse, si potrebbe dire che le prime disposizioni legali furono emanate per evitare uno stato di guerra e tensione permanente all’interno dello stesso clan. Furono fatte, insomma, per favorire la convivenza pacifica, limitando il potere dei forti e dei prepotenti, ed aumentando il diritto dei deboli.
E dalla necessità pratica di impedire un regime di violenze e sopraffazioni continue, si originò un primo nucleo di senso morale.
CHARLES RENOUVIER

“Forse che il fatto che la coscienza è identica col filosofo, deve impedire a quest’ultimo di farle una parte dell’opera che essa rivendica tutta? L’oggetto della critica è precisamente quello di studiare l’io come altro dall’io e come una fra le altre cose rappresentate”.
A cura di Renzo Grassano
Charles Renouvier (1815-1903) fu allievo di Comte ed amico dello spiritualista Jules Lequier, del quale curò l’edizione degli scritti quando questi morì annegato. Tra il 1854 ed il 1864 pubblicò i quattro volumi che compongono i Saggi di critica generale: nel 1854 Analisi generale della conoscenza, nel 1859 Psicologia razionale, nel 1864 Principi della natura, nel 1864 Introduzione alla filosofia analitica della storia. Rispetto al positivismo insegnato da Comte, Renouvier prese ben presto una posizione originale. Di esso accettò la limitazione della conoscenza alla legge dei fenomeni, del resto conforme a quanto aveva già scritto Kant, e di qui ricavò l’idea che lo scopo della filosofia sia quello di stabilire in primo luogo le leggi ed i limiti della conoscenza. Respingendo, quindi, ogni seduzione metafisica, Renouvier si volse decisamente alla riflessione sulla filosofia kantiana, proclamando esplicitamente di voler continuare l’opera critica di Kant. Ma, anche rispetto a Kant, venne ben presto a precisare di non credere alla cosa in sé. La realtà è fenomeno, e tutti i fenomeni che compongono la realtà sussistono solo in quanto connessi e dipendenti da altri fenomeni in una catena che costituisce un tutto. In quest’ambito la conoscenza è rappresentazione e l’indirizzo critico in filosofia consiste nel ridurre la realtà alla rappresentazione. Pertanto, si tratta di comprendere come ogni rappresentazione sia relativa (tesi già sostenuta da Comte) e che sia contraddittorio, secondo Renouvier, parlare di una cosa in sé in termini di assoluto ed inattingibile. Fedele, almeno in questa fase, sia alla dottrina comtiana che a quella kantiana, Renouvier dipinge la coscienza come comprensione dei fenomeni che si manifestano nella sfera dell’organico. La funzione del sapere e della scienza è trovare le relazioni del fenomeno con il fenomeno, della legge naturale con la legge naturale. In tale prospettiva, Renouvier introduce il concetto di categoria della relazione, rispetto alla quale ricava altre categorie della conoscenza: il numero, l’estensione, la durata, la qualità, il divenire, la forza, la finalità ed, infine la personalità. Finalità e personalità sono categorie inedite ed originali. La finalità è spiegata da Renouvier come una legge del fine, non meno importante di quella di causalità. Ogni giudizio umano non può fare a meno di vedere la finalità, da intendersi come conseguenza, di fenomeno a fenomeno. Kant, aveva in qualche modo già parlato della personalità, non come categoria, ma come “io pensante”. Per Renouvier, al contrario, la personalità è la forma dei nostri giudizi. Scriveva: “Forse che il fatto che la coscienza è identica col filosofo, deve impedire a quest’ultimo di farle una parte dell’opera che essa rivendica tutta? L’oggetto della critica è precisamente quello di studiare l’io come altro dall’io e come una fra le altre cose rappresentate.” La fede che Renouvier nutre nei confronti della possibilità di rappresentare, attraverso il suo sistema di categorie, la totalità del reale come sintesi completa delle relazioni sussistenti, lo porta a negare le celebri antinomie kantiane, rigettando le antitesi ed accettando le tesi. La conclusione cui perviene Renouvier, pertanto, è che il mondo reale consiste in un tutto finito, essendo l’infinito contraddittorio in sé. Bisogna riconoscere, allora, che il mondo è limitato nello spazio e nel tempo, che la sua divisibilità abbia un termine e che esso dipenda da una o più cause che non sono, a loro volta, effetti ma cause prime. Questa “fisica” di Renouvier, capace di richiamare insieme l’antica visione di Aristotele e di Democrito (la non divisibilità dell’atomo) porta decisamente, a mio avviso, a far risorgere la metafisica proprio laddove viene negata. Non a caso, il ragionamento sulle cause prime ripropone il problema di Dio e del rapporto tra il mondo dei fenomeni e Dio stesso. Renouvier esclude in maniera perentoria l’ipotesi della creazione perchè si darebbe il paradosso di “una forza che produca la forza, di un amore che ami l’amore, un pensiero che pensi il pensiero”. Trova più appropriata la tesi dell’emanazione, denunciandone, tuttavia, il carattere problematico. Se si considera l’Uno originario in senso assoluto, come esclusione di ogni pluralità, non si potrebbe spiegare la pluralità stessa; se si considera come una vera coscienza, la pluralità si deve trovare già posta in esso. Ne viene che la pluralità coinciderebbe con la pluralità originaria delle coscienze. L’affermazione, non poco sconcertante, che ne segue corrisponde ad una riaffermazione veramente inattuale di politeismo: “Noi sostituiamo l’unità multipla, il tutto, all’Uno puro, idolo dei metafisici, per questa sola ragione che il mondo, attualmente ed originariamente, è una sintesi determinata, non una tesi astratta.” Nelle considerazioni sull’emanazione sembre mancare il tratto decisivo che ha sempre caratterizzato queste teorie, ovvero che in ogni emanazione, pur accettando che nell’emanato rimane qualcosa dell’emanante, il risultato è inferiore all’originale. Rispetto ad esso, è un’imperfezione, qualcosa che deve essere solo riassorbito ed annullato. Il Dio che emana, non ama la propria emanazione, il proprio odore diffuso, il proprio calore disperso, il proprio seme gettato; è solo una specie di oggetto di nostalgia per la emanatura imperfetta, che altro non dovrebbe desiderare che il riassorbimento nella dimensione perfetta. Vi era, e vi è quindi, alla base della teoria dell’emanazione, una irriducibile componente determinista: il che, rispetto ad ogni discorso sulla libertà dell’uomo risulta fortemente limitante. Renouvier ritiene che altro non si possa dire sulla sintesi fisica del mondo in cui siamo, ma è palese che il suo è un ragionamento del tutto metafisico, condotto con mezzi ed argomenti che vanno ben oltre i limiti fisici. In un’opera successiva, la Nuova monadologia, del 1899, egli tornerà su queste tematiche per precisare, in contrasto con ogni determinismo emanatorio, che il passaggio da un mondo successivo ad un mondo ulteriore è determinato dall’uso che l’uomo fa della libertà. Il destino del mondo è nelle mani dell’uomo. Questa concezione si dispiega a partire dal saggio Introduzione alla filosofia analitica della storia che, come s’è già detto, comparve nel 1864. Renouvier afferma che, esaminando la storia, si possono individuare due speci di leggi: le leggi empiriche e le leggi a priori. Mentre le prime suppongono il libero arbitrio umano e la non predeterminazione degli avvenimenti dal punto di vista della nostra ignoranza, le seconde implicano un determinismo assoluto ed incoraggiano l’uomo a fare previsioni fondate. Secondo Renouvier, il riconoscimento di leggi storiche a priori conduce al fatalismo, posizione comune sia ad Hegel che a Saint-Simon. Al pessimismo fatalista ed all’ottimismo altrettanto determinista degli storicismi a priori, Renouvier oppone la sua filosofia critica della storia, la quale si pone l’obiettivo di ricostruire analiticamente “le origini e le concatenazioni delle idee, delle credenze e dei fatti”. La prima importante conclusione dell’analisi della storia consiste nell’affermazione che il progresso non è una legge fatale, un destino. Rimanendo in questa ottica determinista a priori, che fu soprattutto di Comte e della sua legge dei tre stadi, si finirebbe, secondo Renouvier, con l’indebolire la coscienza morale e, persino l’impegno. Ma, soprattutto, si finirebbe col giustificare – ritendolo necessario – tutto ciò che è accaduto. Per Renouvier, al contrario, la storia dovrebbe essere considerata come il teatro delle libertà. Nel libro intitolato Scienza della morale, del 1869, il nostro riprende il concetto illuminista l’uomo è dotato di ragione e si crede libero il fondamento della morale ed una concezione della storia basata sulla possibilità. In Ucronia (l’utopia nella storia), opera del 1876, Renouvier abbozza una storia apocrifa dello sviluppo della civiltà europea, elencando tutto ciò che avrebbe potuto essere, e non è stato. Con i se e con i ma, egli si dichiara convinto che l’Europa avrebbe potuto trovarsi già nella seconda metà dell’ottocento in un epoca di pace e giustizia sociale, senza più conflitti nazionali e guerre economiche. Il vero intento di Renouvier, e del suo paradossale tentativo, che potrebbe far sorridere i realisti, ma anche incoraggiare gli utopisti, era comunque quello di mostrare come non esista in politica, e quindi in storia, che della politica è il romanzo, un punto di non ritorno. E’ come a dire che se quando si riceve uno schiaffo, si porge l’altra guancia, il corso dell’inevitabile, cioè il conflitto, può essere mutato. Tutto questo, in qualche misura, riporta effettivamente a Kant, ed alla dottrina dell’imperativo categorico. Solo laddove, sembra dire Renouvier, si realizza in primo luogo un’azione ispirata ad imperativi categorici del tipo pace e giustizia, si possono realizzare possibilità utopiche, cioè solo sognate ma, mai realizzate, quali la pace perpetua. Ma, già se si aggiunge a pace e giustizia, il categorico comandamento della sicurezza individuale, sociale e nazionale, ecco che la possibilità utopica viene in qualche modo incrinata nel profondo: si vis pacem, para bellum.
VICTOR COUSIN

Victor Cousin (28 novembre 1792 – 13 gennaio 1867) era un filosofo francese. Figlio di un orologiaio, nacque a Parigi, nel quartiere Saint-Antoine. All’età di dieci anni fu mandato nella scuola secondaria del luogo, il Lycée Charlemagne, dove condusse gli studi fino al diciottesimo anno d’età. Il lycée era collegato all’università e quando Cousin lasciò l’istruzione secondaria fu “incoronato” nell’antica sala della Sorbona per l’orazione latina da lui lì pronunciata in occasione del concorso generale tra colleghi di studi. La preparazione classica del liceo lo rese decisamente incline alle materie letterarie. Era già noto tra i suoi compagni per la sua conoscenza del Greco. Dal liceo passò alla Scuola Normale di Parigi, dove Pierre Laromiguière stava allora tenendo lezioni di filosofia. Nella seconda prefazione ai Fragments philosophiques [Frammenti filosofici], nei quali egli dichiara candidamente quali furono le varie influenze filosofiche della sua vita, Cousin parla del senso di gratitudine suscitato dal ricordo del giorno del 18.., quando ascoltò per la prima volta Laromiguière. “Quel giorno decise la mia intera vita”. Laromiguière insegnava la filosofia di John Locke e di Etienne Bonnot de Condillac, felicemente modificata in qualche punto, con una chiarezza ed una grazia che, almeno in apparenza, sembravano rimuovere le difficoltà, e con un’aria di affascinante bonomia che faceva breccia e soggiogava.” Cousin fu assegnato a tenere lezioni di filosofia, ed ottenne velocemente la carica di “Maestro di congresso” (maître de conférences) all’interno della scuola. Il secondo grande impulso filosofico della sua vita fu l’insegnamento di Pierre Paul Royer-Collard. Questo insegnante, ci racconta, “grazie alla severità della sua logica, alla gravità e al peso delle sue parole, mi fece volgere gradualmente, e non senza resistenze, dal sentiero battuto di Condillac al cammino che è da allora divenuto così agevole, ma che era allora doloroso e imbattuto: quello della filosofia scozzese”. Tra 1l 1815 1 il 1816 Cousin raggiunse la posizione di assistente di Royer-Collard nella cattedra di storia della filosofia moderna della facoltà di Lettere. Un altro pensatore che lo influenzò in questo suo primo periodo fu Maine de Biran, a cui Cousin guardava come all’ineguagliato osservatore psicologico della Francia contemporanea. Questi uomini esercitarono una forte influenza tanto nel metodo quanto nella sostanza del pensiero filosofico di Cousin. Egli attribuisce a Laromiguière la lezione di scomposizione del pensiero, per quanto la riduzione del pensiero a sensazione fosse inadeguata. Royer-Collard gli insegnò che anche la sensazione è soggetta ad alcune leggi interne e principi che non riesce a spiegare per se stessa, che sono superiori all’analisi ed alle naturali proprietà della mente. De Biran compì uno studio speciale del fenomeno della volontà. Gli insegnò a distinguere, in ogni conoscenza, ed in particolare nei più semplici fatti della coscienza, l’aspetto dell’attività volontaria, quello in cui la nostra personalità è autenticamente rivelata. Fu attraverso questa “tripla disciplina” che il pensiero filosofico di Cousin venne una prima volta sviluppato .Nel 1815 egli iniziò l’insegnamento pubblico della filosofia presso la Scuola Normale e la facoltà di Lettere. Quindi intraprese lo studio del tedesco, lavorò su Immanuel Kant e su F.H. Jacobi e cercò di raggiungere la padronanza della Filosofia della natura di F.W.J. Schelling, dal quale fu in un primo momento profondamente attratto. Simpatizzò per il principio di fede di Jacobi, considerandolo tuttavia arbitrario, dal momento che le sue fondamenta non poggiavano sulla ragione. Nel 1817 andò in Germania ed incontrò G. Hegel ad Heidelberg. L’Enciclopedia del sapere filosofico di Hegel apparve in quello stesso anno, e Cousin ne ebbe una delle prime copie. Per quanto non ritenesse Hegel una persona particolarmente amabile, i due divennero amici. L’anno successivo Cousin andò a Munich, dove incontrò Schelling per la prima volta, e trascorse un mese con lui e Jacobi, ottenendo un maggiore capacità di discernimento della Filosofia della Natura. Le questioni politiche francesi interferirono con la sua carriera. Nei fatti del 1814-1815 si schierò dalla parte dei fedeli al re. Adottò le posizioni del partito conosciuto come “doctrinaire”, il cui leader era Royer-Collard. Successivamente superò le posizioni dello stesso partito collocandosi all’estrema sinistra . A seguito della reazione contro il liberalismo, nel 1821-22, Cousin fu sollevato dai suoi incarichi presso la facoltà di Lettere e presso la Scuola Normale, la scuola stessa venne spazzata via, e Cousin condivise il destino di Guizot, che venne rimosso dalla cattedra di storia. Questo abbandono forzato dell’insegnamento pubblico si rivelò essere in parte una benedizione, infatti si stabilì in Germania con l’intenzione di compiere ulteriori studi filosofici. Ma nel 1824, a Berlino, fu rinchiuso in prigione su richiesta della polizia francese a seguito di alcune sue affermazioni. Liberato dopo sei mesi, fu considerato una persona sospetta dal governo francese per tre anni. Fu durante questo periodo che trovò e sviluppò ciò che vi è di peculiare nella sua dottrina filosofica. Il suo eclettismo, la sua ontologia e la sua filosofia della storia vennero enunciate nei loro principi e nelle loro più importanti caratteristiche nei Fragments philosophiques (Parigi, 1826). La prefazione alla seconda edizione (1833) e alla terza (1838) miravano ad una giustificazione dei suoi principi in opposizione al contemporaneo criticismo. Anche il migliore dei suoi libri più tardi, la Philosophie écossaise [La filosofia scozzese] (quarta ed. 1863); il Du vrai, du beau, et du bien [Del Vero, del bello e del bene] (XII ed. 1872; traduzione inglese, III ed. Edinburgo, 1854) e la Philosophie de Locke [Filosofia di Locke] (IV ed. 1861) erano semplicemente revisioni mature delle letture compiute tra il 1815 ed il 1820. Le letture su Locke furono abbozzate per la prima volta nel 1819 e pienamente sviluppate nel corso del 1829. Durante i sette anni in cui gli fu proibito insegnare, si occupò, oltre che dei frammenti, dell’edizione delle opere di Proclo (6 volumi, 1820-1827) e delle opere di René Descartes (2 volumi, 1826) iniziò inoltre la sua Traduzione di Platone (13 volumi), che occupò il suo tempo libero dal 1825 al 1840). Nei Frammenti possiamo individuare molto distintamente la fusione delle differenti influenze filosofiche grazie alle quali le sue opinioni giunsero finalmente a maturazione. Perché Cousin era un eclettico sia per quanto riguarda il pensiero e l’abito mentale che per quanto concerne il principio e il sistema filosofico. È alla pubblicazione dei Frammenti del 1926 che viene associato il suo primo grande successo che contribuì a migliorare la sua reputazione. Nel 1827 seguì il Corso di Storia della Filosofia (Cours de l’Histoire de la Philosophie). Nel 1828 M. de Vatismenil, ministro della pubblica istruzione nel governo Martignac, richiamò Cousin e Guizot ai loro incarichi professionali all’interno dell’università. I tre anni che seguirono segnarono il periodo del massimo successo delle lezioni di Cousin. Il suo ritorno in cattedra era il simbolo del trionfo delle idee costituzionali e fu accolto con entusiasmo. La sala della Sorbona fu affollata come quella di nessun altro professore dai tempi di Pierre Abelard. L’oratore aveva uno stile potente ed efficace. La sua eloquenza si univa ad un’esposizione speculativa; il suo stile oratorio era chiaro, elegante ed energico. A tutto questo va aggiunto una peculiare capacità di creare un potente climax retorico. La sua filosofia manifestava in maniera sensazionale la tendenza alla ’, e la sua necessità logica di raggruppare i dettagli intorno a principi centrali. Ci fu un’elevazione morale nella sua filosofia dello spirito che fu accolta dai suoi ascoltatori, e sembrò costituire la base per uno sviluppo della letteratura, dell’arte e della politica della nazione superiore a quello della tradizionale filosofia francese. Le sue letture forgiavano discepoli, permeati del suo spirito, più appassionati di quelli di ogni altro professore di filosofia contemporaneo. Giudicato sulla base della sua influenza come insegnante, Cousin occupa un posto di primordine nel gruppo di professori di filosofia che, come Jacobi, Schelling e Dugald Stewart riunivano in sé molteplici doni: capacità speculative ed espositive unite ad una potente immaginazione. La sua opera rinnovò in Francia il gusto per la storia della filosofia che conobbe un successo pari a quello fino ad allora ineguagliato del XVII secolo.Tra coloro che subirono l’influenza di Cousin vi furono Théodore Simon Jouffroy, Jean Philibert Damiron, Garnier, Jules Barthelemy Saint-Hilaire, F Ravaisson-Mollien, Charles de Rémusat, Jules Simon e Adolphe Franck–Jouffroy e Damiron che furono dapprima compagni poi studenti e infine discepoli. Jouffroy rimase fedele ai primi stimoli – quelli francesi e scozzesi – dell’insegnamento di Cousin. Cousin continuò a tenere letture per due anni e mezzo dopo il ritorno in cattedra. Simpatizzante per la Rivoluzione di Luglio, venne immediatamente riconosciuto dal nuovo governo come un amico della libertà nazionale. Scrivendo nel luglio del 1833, Cousin spiega la sua posizione filosofica e politica: “ ebbi il vantaggio di tenere unite per molti anni nel fronte contro di me sia la scuola sensista che quella teologica. Nel 1830 entrambe le scuole scesero in campo nell’arena della politica. Com’era naturale, la scuola sensista diede origine al partito demagogico, e la scuola teologica divenne, altrettanto naturalmente, una forma di assolutismo, salvo prendere in prestito di quando in quando la maschera del demagogo per meglio raggiungere i propri fini, così come in filosofia è grazie allo scetticismo che esso viene garantito per restaurare la teocrazia. D’altro canto, colui che si trovava a combattere ogni principio unico nella scienza era costretto a rifiutare ogni principio unico nella gestione dello stato, e a difendere il principio della rappresentanza del governo”. Il governo fu rapido a rendergli onore. Fu indotto dal governo del quale il suo amico Guizot era capo, a divenire membro del concilio per l’istruzione pubblica e consigliere di Stato, e nel 1932 fu nominato Pari di Francia. Smise di tenere lezioni, ma conservò il titolo di professore di filosofia. Alla fine, accettò la carica di ministro della pubblica istruzione nel 1840 sotto il governo Thiers. Fu inoltre direttore della Scuola Normale, virtualmente rettore dell’università, a partire dal 1840, un membro dell’Istituto (Accademia delle scienza morali e politiche). La sua personalità e la sua posizione ufficiale in questo periodo, gli garantirono un grande potere all’interno dell’università e nei provvedimenti in materia d’educazione nel paese. Infatti, durante i diciassette anni e mezzo di regno di Luigi Filippo, Cousin decise e modellò le tendenze filosofiche ed anche letterarie delle classi colte francesi. L’opera più importante che portò a termine in questo periodo fu l’organizzazione dell’istruzione primaria. Fu agli sforzi di Cousin che la Francia dovette i suoi progressi, per quanto riguarda l’educazione elementare, tra il 1830 e il 1848. La Prussia anzitutto e la Sassonia avevano stabilito il modello nazionale da seguire, e la Francia fu guidata verso il raggiungimento di questa meta da Cousin. Dimentico della calamità nazionale e del personale torto (abbaglio?), Cousin guardava alla Prussia come se essa rappresentasse l’applicazione di un esemplare sistema di educazione nazionale; era convinto che “riportare l’educazione prussiana in Francia avrebbe permesso un più nobile ( sebbene incruento) trionfo rispetto ai trofei di Austerlitz e Jena”. Nell’estate del 1831, su incarico del governo, visitò Francoforte e la Sassonia, e trascorse qualche tempo a Berlino. Il risultato del viaggio fu una serie di rapporti al ministero, in seguito pubblicati sotto il nome di Rapport sur l’état de l’instruction publique dans quelques pays de l’Allemagne et particulièrement in Prusse (da mettere a confronto con De l’instruction publique en Hollands, 1837). I suoi giudizi furono prontamente accettati al suo ritorno in Francia, e poco dopo grazie alla sua influenza, venne approvata una legge per l’istruzione elementare (vedere i suoi Exposés des motifs et projet de loi sur I’instruction primaire, présentes a la chambre des deputes, seance du 2 janvier 1837). Nelle parole dell’Edinburgh Review(luglio 1833), questi documenti “segnano un’ epoca nell’evoluzione dell’educazione nazionale, e sono direttamente riconducibili a risultati importanti, non soltanto per la Francia ma per l’Europa”. Il resoconto fu tradotto in inglese da Mrs Sarah Austin nel 1834. la traduzione venne più volte ristampata negli Stati uniti. Le ‘del New Jersey e del Massachusetts lo distribuivano nelle scuole a spese dello stato. Cousin nota che, tra tutti i riconoscimenti letterari che ricevette, “Nessuno mi ha commosso di più che il titolo di membro straniero dell’Istituto Americano per l’Educazione”. Alle menti illuminate di Guizot e di Thiers sotto il re-cittadino e allo zelo e all’abilità di Cousin nell’opera di organizzazione, la Francia deve il meglio del suo sistema educativo elementare – un aspetto dell’interesse nazionale che era stato trascurato durante la Rivoluzione, l’Impero e la Restaurazione. Durante i primi due anni del regno di Luigi Filippo venne fatto per l’educazione più di quanto fosse stato intrapreso nel corso dell’intera storia della Francia. A difesa degli studi universitari egli si fece coraggiosamente avanti nella Camera dei pari nel 1844, contro il partito clericale da un lato e contro il partito del “livellamento” (levelling), detto Partito “filisteo” dall’altro. I suoi discorsi in questa occasione vennero pubblicati nel trattato Defense de l’université et de la philosophie (1844 e 1845). Questo periodo di vita pubblica dal 1830 al 1848 Cousin lo trascorse, per quanto riguarda la ricerca filosofica, revisionando la sua filosofia precedente, maturandone alcuni aspetti in vista di pubblicazioni o ristampe e compiendo alcune ricerche a proposito del periodo sofistico della filosofia. Nel 1835 apparve De la metaphysique d’Aristote, seguito da un saggio di traduzione dei due primi tomi. Nel 1836, Cours de philosophie professé a la faculté des lettres pendant l’année 1818 e Oeuvres inedits à Abelard. Questo corso di filosofia apparve più tardi con il titolo Du vrai, du beau, et du bien. Dal 1825 al 1840 il Cours de I’histoire de la philosophic, nel 1829 il Manuel de I’histoire de la philosophic de Tennemann, tradotto dal tedesco. Nel 1840-41 abbiamo il Cours d’histoire de la philosophic morale au XVIII’ siècle (5 vols.). nel 1841 fu pubblicata la sua edizione delle Oeuvres philosophiques de Maine-de-Biran; nel 1842, le Lessons de philosophie sur Kant (traduzione inglese di AG Henderson, 1854) e, nello stesso anno, Des pensées de Pascal. I Nouveaux fragments furono raccolti insieme e ripubblicati nel 1847. Più tardi, nel 1859, apparve Petri Abaelardi opera. Durante questo periodo Cousin sembra essersi rivolto con fresco interesse a quegli studi letterari abbandonati a favore della speculazione sotto l’influenza di Laromiguière e di Royer-Collard. A questo rinnovato interesse dobbiamo gli studi su uomini e donne di riguardo del XVII secolo. Come risultati del lavoro in questa direzione, abbiamo, accanto al Des pensées de Pascal, 1842, Audes sur les femmes et la societé du XVIIe siècle, del 1853. Ha redatto anche brevi ritratti di Jacqueline Pascal (1844), Madame de Longueville (1853), il marchese de Sable (1854), la duchessa de Chevreuse (1856), Madame de Hautefort (1856). Quando il regno di Luigi Filippo giunse al termine, per l’opposizione del suo stesso governo, con Guizot al Cousin che non condivideva le posizioni di Guizot sulla nuova legge elettorale e sulla politica dei martrimoni con la casata di Spagna, concesse la sua simpatia a Cavaignac e al governo provvisorio. Pubblicò un pamphlet intitolato Giustizia e carità, il cui senso illustrava la moderazione delle sue opinioni politiche. Era, infatti, marcatamente anti-socialista. Ma da questo periodo si ritirò quasi del tutto dalla vita pubblica, e cessò di esercitare la sua personale influenza come aveva fatto negli anni precedenti. Dopo il colpo di stato del 2 dicembre, venne privato della sua posizione di membro permanente del Consilio superiore dell’istruzione pubblica. Si tenne a distanza da Napoleone e dall’Impero. Un decreto del 1852 lo collocava con Guizot e Villemain nella schiera dei professori onorari. Le sue simpatie andavano apparentemente alla monarchia, con alcune garanzie costituzionali. Nel 1853, parlando dei problemi politici della filosofia spirituale che aveva insegnato durante la sua vita, Cousin dice: “Conduce la società umana alla vera repubblica, quel sogno di tutte le anime generose, che nel nostro tempo può solo essere realizzato in Europa e solo dalla monarchia costituzionale”. Durante gli ultimi anni della sua vita, risiedeva in un alloggio alla Sorbona, dove viveva semplicemente e senza ostentazione. L’elemento più notevole del suo appartamento era la sua nobile biblioteca, l’amata collezione di una vita intera. Morì a Cannes il 13 di gennaio del 1867, nel suo sessantacinquesimo anno d’età. Di fronte alla Sorbona, sotto le stanze di lettura della facoltà di Lettere, una lapide riporta un estratto delle sue volontà, in cui Cousin lascia in eredità la sua nobile e beneamata biblioteca alle aule della sua attività professionale e dei suoi trionfi. Si possono individuare tre punti caratteristici della filosofia di Cousin. Si tratta del metodo, dei suoi risultati e dell’applicazione del metodo e dei suoi risultati alla storia – in particolare alla storia della filosofia. Si è soliti definire la sua filosofia “eclettismo”. In realtà essa è eclettica soltanto in un senso secondario e subordinato. Ogni forma di eclettismo che non sia destinata ad autocondannarsi o a divenire inefficace implica infatti alla sua base un sistema di dottrina, un criterio di verità. Altrimenti, come Cousin stesso, nota, scade ad un semplice e cieco sincretismo. E Cousin vide e proclamò a partire dal primo periodo del suo insegnamento filosofico la necessità di un sistema su cui basare il proprio eclettismo. Questa è davvero avanzata come illustrazione o conferma della verità del suo sistema – come prova che i fatti della storia corrispondono alle analisi della coscienza. Questi tre elementi – il metodo, i risultati e la filosofia della storia – sono strettamente connessi tra loro; sono sviluppi che si succedono in una sequenza naturale. Diventano in pratica psicologia, ontologia ed eclettismo nella storia. Prima di tutto, come metodo. Su nessun altro punto Cousin ha insistito tanto come sull’importanza del metodo in filosofia. Quello che egli adotta, e di cui proclama con forza la necessità, è il consueto metodo di osservazione, analisi e induzione. Cousin guarda al metodo del XVIII secolo – il metodo che Descartes intraprese ed abbandonò, che Locke e Condillac applicarono, sebbene in maniera imperfetta, e che Reid e Kant impiegarono con maggiore, sebbene non ancora completo, successo. Cousin insiste nell’affermare che questo è il vero metodo della filosofia applicato alla coscienza, in cui non appaiono che i fatti dell’esperienza. Ma la condizione corretta per l’applicazione del metodo è che esso non ometta attraverso il pregiudizio del sistema, un singolo fatto della coscienza. Se l’autorità della coscienza è valida in un caso, essa deve esserlo sempre. Se non è degna di fede in un caso, allora non si può fare affidamento su di essa in nessuno. I precedenti sistemi hanno sbagliato nel non presentare i fatti della coscienza. Il metodo d’osservazione applicato alla coscienza ci dà la scienza della psicologia. Questa è la sola e corretta base dell’ontologia e della metafisica – la scienza dell’essere – e della filosofia della storia. All’osservazione della coscienza Cousin aggiunge l’induzione come complemento del suo metodo, grazie al quale egli afferma che conclusioni/risultati quali la realtà sono rese necessarie dai dati della coscienza, e regolate/i da certe leggi che si trovano all’interno della coscienza, cioè quelle della ragione. Grazie a questo metodo di osservazione ed induzione così spiegato, la sua filosofia risulta caratterizzata con tratti molto netti, da un lato dalla costruzione deduttiva di nozioni di un sistema assoluto, come quelli rappresentati da Schelling o Hegel, che Cousin considera come basati semplicemente su ipotesi ed astrazione ottenute in maniera illegittima; dall’altro, dal lato di Kant, e in un certo senso, da quello di Sir W. Hamilton, che, nella visione di Cousin, sono limitati alla psicologia e alla semplice conoscenza relativa o fenomenica nello scetticismo nella misura in cui sono coinvolte le grandi realtà dell’ontologia. Ciò che Cousin trova da un punto di vista psicologico nella coscienza individuale, lo trova anche spontaneamente espresso nel senso comune o nell’esperienza universale dell’umanità. Infatti, secondo lui la filosofia ha la funzione di classificare e spiegare le convinzioni e le credenze universali. Ma il senso comune non viene da lui considerato come filosofia, e neanche come lo strumento della filosofia. Esso è semplicemente il materiale sul quale opera il metodo filosofico, ed in armonia con quale devono essere trovati i risultati finali. I tre grandi esiti dell’osservazione psicologica sono: sensibilità, attività o libertà e ragione. Questi tre elementi si differenziano per i caratteri, ma non sono separati nella coscienza. Gli elementi della ragione sono ugualmente necessari e la ragione non è meno indipendente dalla volontà che la sensibilità. I fatti volontari da soli sono impressi negli occhi della coscienza con i caratteri dell’imputabilità e della personalità. La volontà considerata da sola è l’Io. L’io è il cento della sfera intellettuale senza la quale la coscienza è impossibile. Ci troviamo in un mondo strano, tra due ordini di fenomeni che non ci appartengono, che apprendiamo soltanto a partire dalla condizione di considerarci distinti da essi. Inoltre, apprendiamo grazie ad una luce che non viene da noi stessi. Tutta la luce proviene dalla ragione, ed è la ragione che conosce se stessa e la sensibilità che la avvolge, e la volontà che essa obbliga ma non vincola. La coscienza, quindi, è costituita da questi tre elementi inseparabili che si integrano tra loro. La ragione è la base immediata della conoscenza e della coscienza stessa. C’è una peculiarità nella dottrina di Cousin dell’attività o libertà e nella sua dottrina della ragione, che entra profondamente nel suo sistema. Questo elemento è la spontaneità della volontà e della ragione. Questo è il cuore di ciò che c’è di nuovo [errore di battitura nel testo inglese, non si riesce a risalire al termine corretto] nella sua dottrina della conoscenza e dell’essere. Libertà è un termine generico che indica una causa o l’essere dotato di autoattività. Questa è infatti l’ultima causa di se stessa e del proprio sviluppo. La volontà è libera, sebbene sia preceduta dalla capacità di deliberare e dalla determinazione, ad esempio nella riflessione, dal momento che noi siamo sempre consci che anche dopo la determinazione siamo liberi di volere o non volere qualcosa. Ma c’è un tipo primario di atto di volontà che non ha come sua condizione la riflessione, che è completamente libero e spontaneo. Dobbiamo aver voluto,infatti, prima di tutto spontaneamente, altrimenti non potremmo sapere prima della nostra volontà riflessiva, che noi potremmo volere ed agire. La volontà spontanea è libera come quella riflessiva, ma è l’atto che, tra i due, viene prima. Questa visione della libertà del volere è l’unica che si accordi con gli elementi dell’umanità. Questa spiegazione esclude la volontà riflessiva e spiega l’entusiasmo del poeta e dell’artista nell’atto della creazione; spiega anche le azioni comuni degli esseri umani, che sono compiute come una regola spontanea e non dopo una delibera scaturita dalla riflessione. Ma è nella sua dottrina della ragione che si trova il principio peculiare della filosofia di Cousin. La ragione che ci è data dall’osservazione psicologica, la ragione della nostra coscienza, è impersonale nella sua natura. Non la creiamo; la sua caratteristica è esattamente opposta all’individualità; è universale e necessaria. Il riconoscimento dei principi dell’universale e del necessario è il punto essenziale della psicologia. Deve essere posto in prima posizione ed enfatizzato che questi principi esistono e sono impersonali ed assoluti. Il numero di questi principi, la loro numerazione e classificazione, è un punto importante, ma è secondario rispetto al riconoscimento della loro vera natura. Questo era il punto sul quale Kant cadde in errore nella sua analisi, e questa è la verità fondamentale che Cousin crede di aver restituito all’integrità della filosofia grazie al metodo dell’osservazione della coscienza. E come fa ad essere stabilita questa impersonalità o assolutezza della coscienza? La risposta è, in sostanza, che Kant sbagliò nel porre per prima la necessità come criterio di quelle leggi. Ciò le condusse entro la sfera della riflessione, e diede come loro garanzia l’impossibilità di pensarle rovesciate (?) e condusse a considerarle come interamente relative all’intelligenza umana, limitate alla sfera del fenomeno, incapaci di rivelarci la realtà sostanziale necessaria, tuttavia soggettiva. Ma questa prova della necessità è del tutto secondaria e queste leggi non ci sono pertanto garantite. Esse ci sono date, ciascuna e tutte, alla nostra coscienza, in un atto di spontanea appercezione o apprensione, immediatamente, all’istante, in una sfera al di sopra della conoscenza riflessiva, tuttavia ancora all’interno del campo d’azione della ragione. E “tutta la soggettività con tutta la riflessione sfocia nella spontaneità dell’appercezione. La ragione diventa soggettiva in relazione all’io libero e capace di volere. Ma in se stessa è impersonale, non appartiene o a questo o a quell’io non umano; non appartiene neanche all’umanità. Potremmo dire in verità che la natura e l’umanità appartengono ad essa, perché senza le sue leggi entrambe perirebbero”. Ma qual è il numero di queste leggi? Kant, revisionando l’opera di Aristotele in tempi più recenti ha fornito una lista completa delle leggi del pensiero, ma è questa classificazione è arbitraria e può essere legittimamente ridotta. Secondo Cousin, non ci sono che due leggi primarie del pensiero, quella della causalità e quella della sostanza. Da queste procedono naturalmente tutte le altre. Nell’ordine della natura, quella della sostanza è la prima legge e quella della causalità la seconda. Nell’ordine dell’acquisizione della conoscenza umana, la causalità precede la sostanza, o piuttosto in entrambe è presente ciascuna legge, ed esse sono contemporanee all’interno della coscienza. Questi principi della ragione, causa e sostanza, dati quindi psicologicamente, ci permettono di oltrepassare i limiti del relativo e del soggettivo per attingere la realtà assoluta – ci rendono in grado, in breve, di passare dalla psicologia, o scienza della conoscenza, all’ontologia, o scienza dell’essere, queste leggi sono inestricabilmente mescolate all’interno della coscienza con i dati della volontà e della sensazione, con l’attività libera e con l’azione necessaria [nel senso di inevitabile] e l’impressione; esse ci guidano nell’elevarci ad un essere personale, una causa per sé libera e ad una realtà impersonale, un non-io-natura, il mondo della forza che giace fuori di noi. Come riconduco a me stesso l’atto dell’attenzione e della volontà, così non posso fare a meno di far dipendere la sensazione da qualche causa, necessariamente altra che me stesso, cioè da una causa esterna, la cui esistenza è certa per me come la mia stessa esistenza, dal momento che il fenomeno che me la suggerisce è certo come il fenomeno che ha suggerito la mia realtà, ed entrambe sono date l’una nell’altra. Per questo e possibile raggiungere raggiungo un mondo oggettivo ed impersonale di forze che corrisponde alla varietà delle mie sensazioni. La relazione di queste forze o cause tra loro è l’ordine della coscienza. Ma queste due forze, l’io e il non-io, si limitano reciprocamente. Dal momento che la ragione ha appreso questi due fenomeni , attenzione e sensazione simultaneamente, ci conduce a concepire due tipi di assoluto distinti, cause, correlative e reciprocamente limitate, alle quali esse sono correlate. Così dalla nozione di questa limitazione, troviamo che è impossibile non concepire sotto la stessa guida una causa suprema, assoluta e infinita, essa stessa la prima ed ultima causa di tutto. Questo sta all’io e al non-io come questi stanno ai loro propri effetti. Questa causa è autosufficiente, ed è sufficiente per la ragione. Questa è Dio. Esso deve essere concepito entro la nozione di causa, messa in relazione all’umanità e al mondo. È sostanza assoluta soltanto nella misura in cui è causa assoluta, la sua essenza consiste precisamente nel suo potere creativo. Perciò egli crea, e crea secondo necessità. La teodicea di Cousin lo esponeva, come era abbastanza ovvio che fosse, all’accusa di panteismo. Egli la respinge, e la sua risposta potrebbe essere riassunta come segue. Per panteismo si intende propriamente l’elevazione al rango di divinità della legge dei fenomeni, il Dio dell’universo. Ma io distinguo le due cause finite dell’io e del non-io l’una dall’altra ed entrambe dalla causa infinita. Non si tratta di semplici modificazione di questa causa o proprietà, come nel caso di Spinoza – esse sono forze che hanno il loro potere o la loro forza d’azione in se stesse, e questo è sufficiente per la nostra idea di una realtà indipendente finita. Io sostengo questo, e sostengo la relazione di queste forze come effetti rispetto all’ultima causa suprema. Il Dio che io difendo non è né una divinità panteistica né l’unità assoluta dei filosofi di Elea, un essere separato da ogni possibilità di relazione o pluralità, una mera astrazione metafisica. La divinità di cui io asserisco l’esistenza ha la facoltà di creare, è necessariamente creatore. La divinità di Spinoza e degli Eleati è mera sostanza, non una causa in nessun senso. Come per la necessità per la quale Dio esiste nell’agire o nel creare, questa è la più alta forma di libertà, è la libertà della spontaneità, attività senza deliberazione. La sua azione non è il risultato di una lotta tra passione e virtù. Egli è illimitatamente libero, la spontaneità più pura nell’uomo non è che l’ombra della libertà di Dio. Egli agisce liberamente ma non arbitrariamente, e con la consapevolezza di essere in grado di compiere la scelta opposta. Non può decidere o volere come noi. La sua azione spontanea esclude al contempo gli sforzi e le miserie della volontà e l’operazione meccanica della necessità. Gli elementi riscontrati nella coscienza possono anche essere ritrovati nella storia dell’umanità e nella storia della filosofia. Nelle natura esteriore si danno espansioni e contrazioni che corrispondono alla spontaneità e alla riflessione. La natura esterna ancora in contrasto con l’umanità esprime la spontaneità; l’umanità esprime la riflessione. Nella storia dell’uomo l’Est rappresenta lo stadio spontaneo; il mondo Pagano e Cristiano rappresenta lo stadio della riflessione. Questo [concetto] venne in seguito modificato, espanso ed espresso con maggiore pienezza dicendo che l’umanità nel suo sviluppo universale ha attraversato tre momenti fondamentali. In principio, nello stadio della spontaneità, in cui la riflessione non si è ancora sviluppata e l’arte è imperfetta, l’uomo ha pensato soltanto all’immensità che lo circonda. È preoccupato dall’infinito. In seguito, nello stadio della riflessione, la mente è diventata oggetto a se stessa, oggetto cioè della propria riflessione. Essa perciò conosce se stessa esplicitamente o attraverso la riflessione. La sua propria individualità è ora il solo o comunque il supremo elemento. Questo è il momento del finito. Nella terza fase, giunge un’epoca in cui l’io è subordinato. La mente realizza l’esistenza di un altro potere nell’universo. Il finito e l’infinito diventano due reali termini di correlazione nel rapporto di causa ed effetto. Questo è il terzo e più elevato stadio di sviluppo, la relazione del finito e dell’infinito. Poiché la filosofia non è altro che la più elevata espressione dell’umanità, questi tre momenti saranno rappresentati nella sua storia. L’Oriente rappresenta l’infinito, la Grecia l’epoca del finito o della riflessione, l’era moderna lo stadio della relazione o correlazione di infinito e finito. Nell’ambito della teologia, l’idea filosofica dominante di ciascuna fase si traduce rispettivamente in panteismo, politeismo, deismo. In politica abbiamo analoghe corrispondenze con la monarchia, la democrazia e il costituzionalismo. Eclettismo perciò indica l’applicazione del metodo psicologico alla storia della filosofia. Confrontando i vari sistemi coordinati come il sensismo, l’idealismo, lo scetticismo, il misticismo con i fatti della coscienza, si raggiunge la conclusione che “ ogni sistema esprime un ordine di fenomeni ed idee, che è in verità molto reale, ma che non è il solo nella coscienza, e che allo stesso tempo mantiene un posto quasi esclusivo all’interno del sistema. Da ciò segue che ogni sistema non è falso, bensì incompleto, e che riunendo tutti i sistemi incompleti, dovremmo ottenere una filosofia completa, adeguata alla totalità della coscienza.” La filosofia, così perfezionata, non sarebbe un mero aggregato di sistemi, così come si potrebbe stolidamente supporre, ma un’integrazione della verità insita in ogni sistema dopo che ogni elemento falso o incompleto è stato eliminato. Così si configura il sistema a grandi linee. La posizione storica del sistema è da rintracciare nelle sue relazioni con Kant, Schelling e Hegel. Con Cousin l’assoluto come fondamento dell’essere è colto positivamente dall’intelligenza e rende intelligibile tutto il resto. Non è, come per Kant, solo una certa necessità ipotetica o regolativa.
MAINE DE BIRAN
VITA E OPERE
Nato a Grateloup vicino a Bergerac (Dordogne, Francia), il 29 novembre, 1766 e morto a Parigi, il 16 luglio del 1824, François-Pierre-Gonthier Maine de Biran ha studiato a Périgueux, ha fatto parte dell’esercito, ma dopo alcuni anni si è dimesso ed è entrato in politica. Nell’aprile del 1797 fa parte del Consiglio dei “Cinq Cents”; tuttavia, poiché ha subito l’ostilità del Direttorio per le sue simpatie monarchiche, si ritira a Grateloup, dove si dedica alla filosofia. La sua costituzione era fragile e sensibile e la sua inclinazione filosofica già si era manifestata tramite le sue osservazioni sull’influenza della condizione fisica sulla morale. Come ideologo vinse il premio al l’Istituto con il suo saggio Sull’abitudine (1802); ma il suo Decomposizione del pensiero (1805) mostra che egli sta deviando dalla teoria di quella scuola e in La percezione immediata (1807) e Rapporti del fisico e della morale dell’uomo (1811), è un antagonista della filosofia di XVIII secolo. Allora egli rientrò nell’arena politica e fu eletto al Parlamento in 1812, 1815 e 1820. Nell’ultima fase della sua vita, la sua tendenza al misticismo lo ha riportato gradualmente verso un Cristianesimo pratico. Tre fasi contrassegnano lo sviluppo della sua filosofia. Fino a 1804, una fase denominata “filosofia della sensazione”, in cui era un seguace del sensismo del Condillac, che presto ha abbandonato per un sistema basato su un’analisi della riflessione interna. Nella seconda fase – la filosofia della volontà – 1804-18, per evitare il materialismo ed il fatalismo, ha abbracciato la dottrina dell’immediata appercezione, che indicava che l’uomo conosce se stesso e le cose esteriori dalla resistenza del suo sforzo. Riflettendo, l’uomo rileva lo sforzo volontario che differenzia il suo interno dalla sua esperienza esterna, imparando così a distinguersi fra l’ego ed il non-ego. Nella terza fase – la filosofia della religione – dopo il 1818, scopriamo che De Biran sostiene una psicologia mistica intuitiva. All’uomo sono date due condizioni di vita: la rappresentazione (comune agli animali) e la volontà (volontà, sensazione e percezione); ma Mainde de Biran ne aggiunge una terza: l’amore o durata dell’unione con Dio, in cui la durata della tolleranza divina assorbe la rappresentazione e la volontà. Maine de Biran è ritenuto da Cousin come il metafisico francese più grande dopo Malebrahche. Il suo genio non è stato riconosciuto completamente fin dopo alla sua morte, poiché il saggio Sull’abitudine (Parigi, 1803) fu l’unico libro che è stato pubblicato sotto il suo nome durante il corso della sua vita; ma la sua reputazione è stata stabilita saldamente sulla pubblicazione dei suoi scritti, in parte da Cousin (Aperture filosofiche di Maine de Biran, Parigi, 1834-41) e in parte da Naville (Aperture inedite di Maine de Biran, Parigi, 1859).
IL PENSIERO
Per François Pierre Maine de Biran la riflessione interiore – su cui deve basarsi l’autentica filosofia – conduce ad una visione spiritualistica. Con ciò egli dichiara di porsi nella tradizione di pensiero che va da Montaigne a Pascal e a Malebranche. È vero che la sensibilità umana è “passiva”, ma è pur vero che l’esperienza interiore testimonia una “libera attività”, indipendente dai condizionamenti della sensazione e della stessa realtà esterna. Questa libera attività anzi ha un primato di valore; nel senso che essa, in modo autonomo, e secondo un criterio permanente di perfettibilità dei propri prodotti, traduce le sensazioni, molteplici e instabili, in conoscenza e in azione. Essa dunque è la condizione assoluta dell’attività teoretica e dell’attività pratica dell’uomo. Tale attività è la caratteristica della coscienza. Ma che cos’è la coscienza? L’autoriflessione ce la indica come il nostro “senso intimo”; cioè il “sentimento di esistenza individuale”, o anche il sentimento dell’identità di sé con sé del soggetto conoscente. Sul piano, dunque, del discorso teoretico, essa rappresenta non solo la condizione di ogni conoscenza, ma essa stessa una prima la piú semplice e insieme la piú certa – forma di conoscenza; cioè la conoscenza del proprio io come unitario, stabile, permanente nella sua identità; conoscenza del proprio io che non si lascia travolgere e trasformare dalla molteplicità e varietà delle sensazioni, ma che è il centro in cui queste acquistano valore conoscitivo. Sul piano, poi, del discorso pratico, la coscienza testimonia all’io che vuole ed agisce di essere “forza” e “causa”, unico principio di ogni atto di libera volontà e unica origine di tutti i suoi prodotti. C’è infine un terzo piano su cui va inoltre condotto il discorso sulla coscienza: quello religioso, quello della fede. Il “senso intimo” rappresenta la fonte delle certezze religiose, e soprattutto di quella che “esiste un Essere ordinatore di tutte le cose“, cioè Dio. E infatti nella coscienza, attraverso l’esperienza della preghiera e della meditazione, che Dio si manifesta all’uomo essa è pertanto il “luogo” di una “rivelazione originaria di Dio” che non solo non contraddice, ma integra e potenzia quel]a di cui la Chiesa è depositaria e custode. L’uomo dunque ha tre vite distinte: quella organica, quella cosciente e quella religiosa; la prima è in funzione della seconda, ma questa non si riduce – come voleva Condillac – alla prima, né dipende totalmente da essa; inoltre la seconda è in funzione della terza, ma anche in questo caso la terza non può ridursi o esaurirsi nella seconda. Di qui de Biran trae alcune conclusioni, come ad esempio quella che la libertà che si esperisce nella vita cosciente non costituisce il grado massimo di libertà dell’uomo; infatti solo nella vita religiosa la libertà è compiuta, in quanto l’uomo è completamente sottratto alle influenze delle passioni. Sul piano formale il discorso filosofico di de Biran approda a un esito religioso; in realtà la prospettiva religiosa ne costituisce il presupposto logico e la motivazione. Esso risponde allo scopo di garantire razionalmente l’autorità della Chiesa il cui messaggio, per il filosofo, trova fondamento psicologico nella rivelazione interiore di Dio all’individuo; esso è conformato all’obiettivo di difendere la continuità della presenza della Chiesa nella tradizione storica. Ma c’è di piú; la difesa del ruolo della Chiesa è contestuale a quella delle istituzioni socio-politiche esistenti; de Biran infatti tinge d’ottimismo l’evoluzione di quelle istituzioni, garantendone religiosamente l’autorevolezza e l’autorità. Come l’individuo – egli dice infatti – tende all’assoluto, cosí anche l’umanità nel suo complesso; le istituzioni sociali e politiche pertanto sono in cammino verso forme sempre piú perfette; il destino dell’individuo e quello dell’umanità associata si compiranno quando i “valori assoluti” diventeranno norma sia dell’esistenza singola che della convivenza civile.
ALLE ORIGINI DELLO SPIRITUALISMO FRANCESE
Maine de Biran può sicuramente essere considerato uno dei padri fondatori dello spiritualismo francese: egli fonda una nuova concezione della coscienza su base non metafisica, ma meramente psicologica, dandone una fondazione più scientifica che non filosofica; egli si colloca come propaggine estrema della corrente dell’ideologie, dello studio delle idee – intese come prodotto della mente – nella loro correlazione col corpo. Maine de Biran asserisce che dobbiamo partire da un “fatto primitivo” – che può esser posto a fondamento della scienza – che non sia un fantasioso principio astratto (quale era l’Io di Fichte), ma un fatto: ricollegandosi al “fatto”, egli – che pure del positivismo fu acerrimo nemico – si accosta alle tesi e alla terminologia positivistiche. Il fatto originario in questione è il “senso interno” (detto anche “sentimento della mia esistenza“), con un fin troppo evidente richiamo al cogito cartesiano (letto però in chiave scientifica). Tale originario sentimento della mia esistenza è dato dal fatto che mi sento opporre una resistenza da qualcosa di a me esterno: è cioè dato dalla coscienza di uno sforzo, il sentirmi come attività lottante contro la passività dell’esterno che mi si oppone e mi fa resistenza (e tra questi oggetti esterni a me opponentisi c’è il mio stesso corpo, che lotta contro il mio sforzo interno). Riconoscere al soggetto l’attività (ovvero la spontaneità) come sua essenza equivale a riconoscere che egli è libero, sottratto da una catena causale i cui singoli anelli sono insieme attività (causano) e passività (sono effetti di altre cause): la causalità necessaria, allora, si deve arrestare un attimo prima che si entri nell’interiorità del soggetto. “Porre in discussione la libertà significa mettere in dubbio il sentimento dell’esistenza dell’io, che da essa non si differenzia […] La libertà, o l’idea della libertà, considerata nella sua fonte reale, non è altro che il sentimento della nostra attività e del nostro potere di agire e di produrre lo sforzo costitutivo dell’io“: nel soggetto impera un’energia prorompente all’esterno e scontrantesi con esso; libertà è, appunto, sentire la nostra attività interna, lo sforzo costitutivo dell’io. Sebbene nel mondo esterno regni il determinismo, sussiste un ambito che da esso non è minimamente sfiorato: tale è l’ambito della coscienza, regno della spontaneità. Questo modello è ripreso e corretto dallo spiritualismo: caratteristica precipua è la distinzione e la separazione dei piani, per cui coscienza e realtà materiale sono due sfere eterogenee e quindi incompatibili, senza che una sia la versione nobilitata dell’altra. Nello spiritualismo, tuttavia, il discorso si fa più complesso: la coscienza è caratterizzata da spontaneità e, per ciò, è libera e sottratta alla causalità; ma poi lo spiritualismo tende a fare della coscienza la realtà fondamentale, rispetto a cui la non-coscienza (ossia la natura) è realtà subordinata e derivata, quasi come se fosse una coscienza addormentata e oggettivata, che ha perso lo smalto delle sue prerogative. Si giunge per tal via ad un monismo camuffato, per cui l’unica realtà è la coscienza, e la natura – eccanicisticamente intesa da Cartesio, da Kant e da Maine de Biran – è coscienza sviluppatasi in maniera più grossolana. Ciò significa che, in qualche modo, l’intera realtà è spontanea, anche se non manifestantesi nella forma umana della libertà: sicchè lo spiritualismo può affermare la libertà in forma generalizzata, tale per cui essa è estendibile all’intera realtà, poiché anche la natura è spontanea e attiva, capace di produrre il nuovo: in tal senso, l’effetto non può mai essere inteso come mero risultato meccanico della causa.
JOHN HERSCHEL
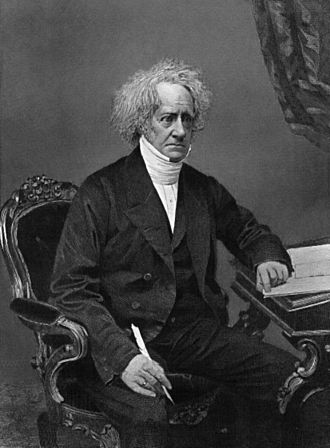
“Grazie alle scoperte di Copernico, Keplero e Galilei gli errori della filosofia aristotelica sono stati efficacemente capovolti, facendo ricorso semplicemente ai fatti della natura; restava da spiegare però, sulla base di principi ampi e generali, come e perchè Aristotele si sbagliasse; si dovevano ancora mettere in evidenza le peculiari debolezze del suo metodo di filosofare, per sostituirle con un metodo più forte e migliore. Questo è l’importante compito svolto da Francis Bacon”.
A cura di Guido Marenco
L’importanza di John W. F. Herschel (1792 – 1871) nella storia della filosofia rischia per diversi motivi di venire misconosciuta. In realtà egli fu il primo a tentare di mostrare in modo organico quanto fosse inadeguato e parziale il modello metodologico elaborato da Francis Bacon, centrato sulla sola induzione, e fu anche il primo a proporre una distinzione tra contesto della scoperta e contesto della giustificazione nei percorsi che conducono alla scoperta delle leggi ed alla successiva formulazione delle teorie. Fu anche, se non il primo, certamente tra i primi a distinguere in modo chiaro e sensato tra legge di natura e teoria generale, intendendo per quest’ultima non una visione ideologica e sistematica del mondo alla maniere della filosofia della natura di Schelling, ma un piano di precisa concordanza tra le leggi fisiche e, anche tra queste e quelle chimiche e addirittura biologiche. Inoltre, avendo egli assegnato un ruolo importante alla creazione di ipotesi, fu anche il primo a parlare di falsificazione delle teorie, ovvero della necessità da parte dello scienziato e del ricercatore, di mettere in campo tutte le possibili obiezioni e registrare meticolosamente tutti i fatti che avrebbero potuto smentire una data teoria. Il primo passo di Herschel fu quello di comprendere che molte importanti scoperte scientifiche non si erano sviluppate allo schema induttivo elaborato da Bacon. Ciò non equivaleva al voler negare la validità dell’impostazione, ma solo evidenziare la sua parzialità; infatti Herschel aveva scritto: «grazie alle scoperte di Copernico, Keplero e Galilei gli errori della filosofia aristotelica sono stati efficacemente capovolti, facendo ricorso semplicemente ai fatti della natura; restava da spiegare però, sulla base di principi ampi e generali, come e perchè Aristotele si sbagliasse; si dovevano ancora mettere in evidenza le peculiari debolezze del suo metodo di filosofare, per sostituirle con un metodo più forte e migliore. Questo è l’importante compito svolto da Francis Bacon» (da Preliminary Discourse on the Study of Natural Philosophy, 1830). Questo approccio di Herschel è facilmente spiegabile guardando alla sua formazione ed ai furori matematici degli anni giovanili trascorsi a Cambridge. Era nato nel 1792 e suo padre era il celebre astronomo William Herschel. Molto precocemente prese a frequentare il matematico (ed economista) Charles Babbage e gli ambienti dell’Analytical Society, un circolo fondato dallo stesso Babbage nel quale si discuteva animatamente di algebra, fisica e filosofia in termini del tutto anticonvenzionali. Un problema era dato dal fatto che la cultura matematica inglese era pressapoco ferma ai tempi di Newton, se ne rispettava perfino religiosamente la simbologia, mentre dal continente, in particolare dalla Francia, continuavano a piovere Memoirs che mostravano l’avanzamento negli studi. Una forte influenza era esercitata da Laplace in campo fisico, ma i politecnici francesi sembravano in generale capaci di innovare fortemente tutti gli indirizzi di ricerca nel campo delle matematiche. Una singolare eccezione in questo campo era costituita da Robert Woodhouse (1773 – 1827), fellow al Caius College di Cambridge. In particolare, Woodhouse aveva intrapreso una ricerca sui numeri immaginari, altrimenti detti “impossibili”, sostenendo che: «[…] se equazioni con segni e caratteri qualsiasi portano a giuste conclusioni, tali operazioni devono essere vere in virtù di un qualche principio […] – e aggiungeva – sebbene il simbolo radice quadrata di -1 sia al di là della potenza del calcolo aritmetico, le operazioni in cui esso è introdotto sono comprensibili e meritano quant’altro mai il nome di ragionamento. » Commenta in proposito Umberto Bottazzini: «un atteggiamento che portava Woodhouse a definire le dimostrazioni matematiche come “un metodo per tracciare una connessione tra certi principi ed una conclusione” mediante una catena di proposizioni intermedie, ognuna delle quali è trasformata nella successiva “cambiando la combinazione di segni che la rappresenta in un’altra equivalente ad essa» (da L’algebra simbolica e la scienza del tempo “puro” e delle forme – in Storia della scienza moderna e contemporanea – a cura di Paolo Rossi). Di fronte a questi ed altri stimoli, che portavano comunque a privilegiare, con Woodhouse, la dimensione algebrica e simbolica, Herschel, sotto l’influsso di Babbage prese radicalmente partito per la potenza del ragionamento delle operazioni logiche fondate sul simbolismo. Nel 1813 usciva un lavoro intitolato Memorie della Società Analitica che Babbage avrebbe voluto intitolare “I principi del puro d-ism in opposizione alla dot-age dell’università”. Per capire il gioco di parole: dot era riferito a “punti” di Newton, mentre dotage significa rimbambimento. Herschel, prima di abbandonare il campo delle ricerche algebriche per coltivare la vecchia passione del padre, l’astronomia, diede notevoli contributi. Nella citata Memorie curata da Babbage scrisse una parte centrata sul problema dell’integrazione delle equazioni differenziali. Più tardi riprese l’argomento con un’opera intitolata Considerazioni su diversi punti di analisi. Questi studi, apparentemente fini a se stessi, trovarono uno sviluppo nel lavoro di George Boole (1815 – 1864), prima in senso strettamente matematico, poi in senso più estesamente logico. Nel 1830 Herschel pubblicò Preliminary Discourse on the Study of Natural Philosophy (Discorso preliminare sullo studio della filosofia naturale), la sua opera cardinale. Era giunto a formulare i concetti fondamentali della sua visione della filosofia della scienza attraverso una riflessione sugli sviluppi di molte discipline, non ultime la fisica, l’astronomia, la chimica e la geologia. Come vedremo, io credo che Herschel debba una buona parte del suo concetto di teoria scientifica a Laplace, ma gli importanti contributi di cui si parlava all’inizio sono indubbiamente originali. Dal 1834 al 1838 risiedette in Sud Africa per studiare il cielo dell’emisfero australe. Rientrato in Inghilterra, scrisse diversi lavori su argomenti di astronomia, in particolare uno studio sulle stelle doppie e sulle nebulose, si interessò di birifrangenza dei cristalli, di fotochimica e persino di fotografia.
Il metodo scientifico secondo Herschel
Certamente il più importante contributo di Herschel alla filosofia della scienza fu la distinzione tra contesto della scoperta e contesto della giustificazione. Per contesto della scoperta si intende il modo in cui si perviene a formulare una legge, od anche una teoria più generale. Per contesto della giustificazione si intende quale procedura mettiamo in campo per cercare conferme e smentite alla teoria stessa. In questo quadro non si da ancora, o già, un problema di realismo. Herschel non si pose la domanda se esiste un mondo là fuori, e se lo scopo della scienza sia descriverlo ed interpretarlo in rapporto con esso o, paradossalmente, indipendentemente da esso. Il mondo esiste, ed allo scienziato tocca solo avere una certa cura e meticolosità nel suddividere i fenomeni complessi in parti semplici e nel porre grande attenzione a quei punti cruciali che possono fornire la spiegazione dei fenomeni stessi. Indubbiamente Herschel dovette qualcosa anche anche al metodo analitico propugnato da Descartes. «Il principale esempio che viene offerto da Herschel riguardo alla riduzione di un fenomeno complesso nei suoi aspetti rilevanti è l’analisi del suono: esso viene considerato come vibrazione di una sorgente, trasmissione del moto vibratorio attraverso un mezzo, ricezione da parte dell’orecchio e produzione di una sensazione». A rigore, per Herschel, non fa molta differenza che lo scienziato segua una via induttiva, od uno schema deduttivo, oppure azzardi congetture. Ogni problema specifico richiede un metodo particolare, ed è certamente vero che se ci poniamo domande ardite aventi per oggetto questioni sulle quali non disponiamo di dati sufficienti, l’ipotesi non può che essere l’unico dato di partenza. L’aspetto decisivo è che ogni metodo sappia estrarre i punti rilevanti di fenomeni complessi, e che tutti i ragionamenti muovano da questi punti, conducano alle leggi di natura ed, infine, consentano ancora di salire alla formulazione di teorie generali o attraverso induzione, o attraverso nuove ipotesi. Tra il semplice dato e la teoria generale esisteva per Herschel un passaggio intermedio di grande importanza: la legge di natura. Per avere idea di cosa fossero per Herschel le leggi di natura occorre guardare agli esempi che tirò in ballo. Avere carattere di legge di natura significa definire il contesto nel quale i fenomeni soddisfano le condizioni limite che li descrivono. La legge della caduta dei gravi di Galilei, ad esempio, vale solo per il movimento nel vuoto, mentre la legge di Boyle vale solo per le trasformazioni a temperatura costante. E’ molto importante per Herschel analizzare il percorso metodologico: rispetto alla legge di Boyle si può dire che lo scienziato giunse alla scoperta stuadiando le variazioni del volume di un gas a seconda della sua pressione. La generalizzazione fu costruita su risultati sperimentali, seguendo una via induttiva. Al contrario, una delle leggi di C. Huygens sulla propagazione della luce non sembrava affatto il risultato di un procedimento induttivo. Ma è anche vero che alla base degli studi di cristallografia si potevano trovare le osservazioni di Keplero sulla forma e la struttura dei cristalli; queste avevano portato una relazione di similitudine tra cristalli e geometria dei solidi. Dunque, prima dell’ipotesi avanzata da Huygens c’era stato un grosso lavoro di analisi preliminare condotto da altri, secondo uno schema induttivo. In sostanza, Herschel sembrò sopravvalutare la cosiddetta creatività del genio scientifico nella formulazione delle ipotesi, senza prestare la necessaria attenzione al fatto che le ipotesi stesse non nascono dal nulla, o dalla totale ignoranza, ma si generano su un terreno dove altri hanno seminato con le loro osservazioni. Con ciò nulla si vuole togliere al fatto indiscutibile che la semplice induzione manca spesso e volentieri di genio, od anche di talento e solo in determinati casi riesce a portare oltre il livello delle ipotesi minime o insignificanti. Non è una grande conquista scientifica la constatazione che tutti i corvi sono neri, salvo smentita. Certo ha un relativo interesse, invece, la constatazione che il camaleonte è un animale solitario, un single naturale che fugge la socializzazione e vive nascosto e mimetizzato, come se conoscesse uno dei precetti fondamentali della filosofia di Epicuro! Ovviamente la scoperta delle leggi di natura costituisce soltanto la prima fase del lavoro scientifico. Per Herschel era importante risalire, ancora attraverso la duplice possibilità di schema induttivo e salto ipotetico, a vere e proprie teorie generali in grado di integrare tra loro le diverse leggi particolari. Anche qui, per capire cosa fosse per Herschel una teoria bisogna guardare ad un esempio storico, ovvero la teoria dell’elettromagnetismo formulata da André-Marie Ampère negli anni venti dell’Ottocento. Il problema “Ampère” è complesso sotto diversi punti di vista, non ultimo il fatto che proprio lo stesso Ampère, smentendo in un certo senso, ante litteram, proprio Herschel e la sua insistenza sul ruolo dell’ipotesi, aveva affermato la necessità di seguire Newton, senza mai fare ipotesi “sulla natura delle forze che producono i fenomeni”, e semplicemente dedurre il valore matematico di queste forze, derivandolo da misurazioni precise e leggi basate unicamente sull’esperienza. In realtà, se si guarda bene a come Ampère fu costretto a contestare le posizioni di Coulomb (che negava vi fosse una qualsiasi relazione tra elettricità e fluidi magnetici), si comprende che Herschel aveva ragione: Ampère aveva formulato un’ardita ipotesi generale che, tuttavia, non era suffragata da dati sperimentali certi. Semplicemente era una ipotesi alternativa e “rivale” a quella di Coulomb, con l’ambizione di diventare una teoria generale dell’elettromagnetismo.
La concezione della teoria e la procedura di falsificazione
Herschel considerò la teoria come un insieme coerente di leggi della natura in grado di descrivere la complessità dei fenomeni relativamente ad un campo dato, ad esempio quello che oggi definiamo come oggetto degli studi di fisica. Indubbiamente la teoria nasce da un’ipotesi, la quale segue l’osservazione di certi fatti, ma non nasce spontaneamente in chiunque. Tra le stesse persone che rilevano gli stessi dati, solo alcune sono poi in grado di formulare congetture e supposizioni sensate (per dirla con Galileo) e solo pochissime, sono in grado di collocarle in un insieme coerente, compatibile con le leggi di natura già scoperte. Come già evidenziato, questo approccio di Herschel risentiva dell’influenza esercitata da Pierre -Simon de Laplace (1746-1827), il quale, nell’Exposition du Système du Monde aveva descritto l’atteggiamento ottimale nei confronti dell’attività scientifica. Essa si fondava sulla “possibilità di interpretare i fenomeni, osservabili in natura, alla stregua di conseguenze matematiche di un ristretto gruppo di leggi. Di qui discendeva a suo avviso, il ruolo centrale della matematica e dell’astronomia. La matematica consentiva infatti di enunciare i problemi mediante apparati formali rigorosi e l’astronomia era un modello per l’impresa scientifica in quanto le leggi del moto erano controllabili con particolare precisione negli spazi celesti.” ( E. Bellone – L’esposizione del sistema mondo – in Storia della scienza moderna e contemporanea – a cura di Paolo Rossi) Per Laplace: « Se l’uomo si fosse limitato a raccogliere dei fatti, le scienze non sarebbero che una sterile nomenclatura, e mai avrebbe conosciuto le grandi leggi della natura.» (Exposition, cap. 11 – pp. 436) Come si vede, con Laplace si era abbastanza vicini a negare che il mondo si offrisse spontaneamente alla conoscenza, come un libro sempre aperto sulla pagina giusta. Era la teoria, ed in senso kantiano, lo schema intellettuale dell’io a priori, logico e non psicologico, a dover interpretare la struttura fisica della realtà. Herschel assegnò dunque un ruolo centrale alla teoria ed avvisò che non c’è teoria che non si fondi su ipotesi. Per questo ne derivò che ogni teoria doveva essere in accordo, non solo con le leggi, ma avrebbe dovuto sopportare tutta una serie di controlli rigorosi ed esperimenti volti a negarne la validità. Con Herschel si passò dunque dal semplice elogio del dubbio, ad un’inedita formulazione di quale metodo occorra adottare per superare tutti i dubbi. Esso consisteva nella falsificazione delle teorie stesse.
JOSIAH ROYCE

Filosofo statunitense (Glass Valley, California, 1855-Cambridge, Massachusetts, 1916), Josiah Royce studiò alle università di California e John Hopkins e fu allievo di W. James, quindi si recò in Germania, dove si perfezionò con Lotze. Insegnò a Harvard. Centrale nell’idealismo di Royce è la ridiscussione dei rapporti tra idea e realtà. Royce distingue tra un significato esterno di idea (il riferimento a una realtà altra di cui essa è appunto idea) e uno interno (il fine che ci si propone formulando l’idea stessa): l’unico rapporto concepibile tra idea e realtà è l’assimilazione della realtà esterna dell’idea all’intenzione che ne costituisce il significato interno; l’idea non ha così una realtà, ma tende a essa nel realizzarsi, si determina precisando il proprio significato e fine eliminando le possibilità marginali. Ma tale realizzazione può effettuarsi solo nell’ambito di una coscienza totale, in cui ogni coscienza individuale sia integrata. Royce concepisce la totalità assoluta come compatibile con le sotto-totalità rappresentate dalle coscienze finite, utilizzando il concetto di numero come sistema autorappresentativo (un tutto le cui parti sono a loro volta totalità in corrispondenza con esso) sviluppato da Cantor e Dedekind. É così possibile eliminare l’aporia in cui cade il finito secondo Bradley. Nell’ultima fase del suo pensiero Royce riaffronta il problema dei rapporti fra finito e assoluto concependo un processo di unificazione dei singoli soggetti, nell’interpretazione da essi data del mondo come sistema di segni, e che conduce alla costituzione di una comunità cui il singolo deve una fedeltà esplicantesi nella realizzazione del proprio compito. Scritti principali: The Religious Aspect of Philosophy (1885; L’aspetto religioso della filosofia), The World and the Individual (1900-01; Il mondo e l’individuo), The Philosophy of Loyalty (1908; La filosofia della fedeltà), W. James and Other Essays (1911; W. James e altri saggi), The Sources of Religious Insight (1912; Le fonti dell’intuizione religiosa), The Problem of Christianity (1913; Il problema del cristianesimo). Josiah Royce è il maggior esponente del neo-idealismo americano. Egli concepisce anzitutto l’idealismo come quell'”analisi che consiste semplicemente nel mettere in luce che il mondo della conoscenza, checché esso contenga, è materiato della stessa sostanza di cui son fatte le idee”, cioè nel mostrare che tutto il reale “non è per ognuno di noi che un sistema di idee”. Consideriamo, egli dice, “il nostro cosí reale mondo dei sensi, pieno di luce, di calore, di suono”; la sua “solidità”, la sua “esteriorità”, ce lo fanno apparire, a prima vista, come “ostinato”, “semplicemente rigido”, “irriducibile” alla volontà dell’uomo. Eppure noi sappiamo che possiamo in qualche misura modificarlo. Ciò significa forse ch’esso, nonostante l’apparenza, sia sostanzialmente duttile all’azione dell’uomo? No, esso ci sembra rimanere pur sempre in qualche modo irriducibile: “La materia, ad esempio, è irriducibile quando ci sta contro in dure muraglie”; e che dire della irriducibilità delle “menti”, come ad esempio di quella di una fanciulla riluttante all’amore? Dunque tutto il mondo di cui abbiamo esperienza, appare non dipendere da noi; appare avere una sua “realtà” non conferita da noi. Ma si consideri meglio. Soprattutto il mondo sensibile, quello delle cose. Nel rapporto che noi istituiamo con esso, è esso cosí “oggettivo”, cosí indipendente dalle nostre “idee”? È veramente cosí “reale” da non poter essere in alcun modo “ideale”? No; non c’è dubbio che colori, sapori, suoni del “reale” sono “ideali”. Si prenda ad esempio una sinfonia; certo le onde sonore nell’aria hanno una loro realtà; ma il loro significato sta nella nostra percezione della musica; la sinfonia non è una proprietà delle onde sonore, né degli strumenti musicali. Pertanto il reale è sí “reale”, ma anche in qualche modo “ideale”.
Il mondo reale non è in sé indipendente dagli occhi, dalla lingua, dagli orecchi, dal tatto di qualcuno, né colorato né sapido, né freddo né caldo, né luminoso né oscuro, né sonoro né silenzioso. Tutte queste qualità appartengono alle nostre idee, senza che per ciò siano meno fatti veri, pur essendo sin qui fatti ideali.
(Lo spirito della filosofia moderna)
E non sono ideali anche altri caratteri del reale, come ad esempio la forma, la grandezza, il movimento? È possibile che il reale sia conosciuto secondo la forma, la grandezza, il movimento, senza quelle “grandi idee formali” del soggetto pensante che sono lo spazio e il tempo? Certo, possiamo ammettere pure una grandezza o un movimento “reale”; ma il significato di grandezza o movimento di una cosa è “ideale” per me che conosco. E che cosa dire delle altre qualità delle cose? Ad esempio della bellezza. Contempliamo un bel quadro; la sua bellezza è, certo, soprattutto “sua”; in tal senso la bellezza è “reale”; ma, infine, quel quadro non è bello “per noi”? Anche della bellezza del quadro bisogna dire che è sí “reale”, ma soprattutto “ideale”. Ma fermiamoci per un attimo a riflettere sul fatto che la bellezza del quadro è “sua”. Si vedrà meglio che anche la bellezza “reale” è, in sostanza, oggettivamente “ideale”. E si potrà ricavare quindi che tutti i caratteri oggettivi del reale (qualità, forma, grandezza, ecc.) sono in se stessi ideali. Che significa che la bellezza del quadro è “sua”? Significa che il quadro “incorpora” quella bellezza ch’era un’idea nella mente del suo autore; idea che questi voleva trasmettere al contemplatore. Dunque anche la bellezza propria del quadro è un fatto ideale. Pertanto:
In quanto il mondo dei sensi è bello, è maestoso, è sublime, questa bellezza e questa elevatezza esistono soltanto per l’osservatore che apprezza. Se esse esistono fuori di lui, esistono soltanto per qualche altra mente, ovvero come pensiero e fine, incorporato, di qualche universale anima della natura… Qui dunque vi è almeno tanto del mondo esterno che è ideale quanto precisamente la moneta o il gioiello, o la banconota, o la polizza, hanno il loro valore non solo nella loro presenza fisica, ma nell’idea che simboleggiano per la mente dello spettatore o per il pensiero relativamente universale del mondo commerciale.
(Lo spirito della filosofia moderna)
Dunque la “realtà” degli oggetti che ci attorniano sta comunque nella loro “idealità”; essi incorporano un’idea attribuita loro da una mente universale, idea che li rende significativi per noi che li percepiamo. Ecco perché il mondo reale è “ideale” e tuttavia “irriducibile” al nostro pensiero e al nostro arbitrio, tanto da apparirci totalmente estraneo a qualunque pensiero, eterogeneo rispetto al pensiero.
Fin qui si è dunque acquisito che ho delle esperienze che sembro obbligato ad avere (di una cosa “dobbiamo” vedere i colori, sentire il suono, ecc.); queste esperienze ci presentano un ordine che sembra oggettivo; la natura di quest’ordine tuttavia è essenzialmente ideale; dunque devo supporre che ci sia una mente universale che dispone “idealmente” la realtà. Ma esiste questa mente? Per rispondere a tale quesito bisogna che si approfondisca il discorso sulla “idealità” dell’ordine oggettivo delle cose. Nell’esperienza immediata noi abbiamo “fede” nell’esistenza di un mondo oggettivo da cui deriviamo l’esperienza stessa. Abbiamo fede che vi sia realmente qualcosa “fuor di noi” che corrisponda a ciò che avviene “in noi”. Ma si tratta solo di fede? È fede, ma ben fondata. “Deve” esistere qualcosa fuor di noi, altrimenti non ne avremmo esperienza. Se allora alla nostra esperienza corrisponde una realtà, affinché essa corrisponda alle mie idee bisogna ch’essa sia strutturata come un “sistema di idee”; tale sistema tuttavia è comunque “esteriore” alla mia mente; ma ciò significa solo che non l’ho prodotto io; allora se è esteriore alla mia mente, e se è un sistema di idee, esso non può essere esteriore a tutte le menti; dunque esiste una mente universale per la quale quel sistema non è esteriore.
Che cosa può, in definitiva, cosí bene accordarsi con un’idea come un’altra idea? A che potranno le cose che passano nella mia mente conformarsi, se non è con un’altra mente? Se, quanto piú la mia mente aumenta in chiarezza intellettuale, tanto piú s’avvicina alla natura della realtà, allora certamente la realtà a cui la mia mente cosí rassomiglia dev’essere in se stessa mentale.
Dopo tutto, se io dicessi che questo mondo, che esiste esternamente alla mia mente e ad ogni altra mente umana, esiste in e per una mente tipica e universale, il cui sistema di idee costituisce il mondo; se io dicessi ciò, forse che questo priverebbe di realtà il mondo che mi circonda, o non piuttosto conserverebbe e assicurerebbe la realtà e la conoscibilità del mio mondo d’esperienza? Voi conoscete in realtà il vostro mondo come un sistema di idee circa le cose, tale che di momento in momento riscontrate che questo sistema vi è imposto dall’esperienza. Anche la materia la conoscete appunto come una massa di idee coerenti che non potete fare a meno di avere. Lo spazio e il tempo quali li pensate, sono certamente vostre idee. Ora, che c’è di piú naturale che il dire che, se ciò sta cosí, il mondo reale fuori di noi dev’essere in sé un sistema di idee di qualcuno? Se ciò è, allora voi potete comprendere che cosa la sua esistenza significhi. Se ciò non è, allora, poiché tutto quello che di essa voi potete conoscere è ideale, il mondo reale deve essere completamente inconoscibile, una nuda x.
(Lo spirito della filosofia moderna)
Cosí Royce è giunto ad ammettere una Coscienza universale che racchiude in sé, in forma piena, ciò che l’individuo umano cerca di conoscere. Essa è la sede dell’essere e della verità. In essa sono comprese tutte le menti finite. Ma mentre queste soggiacciono alla legge del tempo, la Coscienza universale è fuori del tempo. In tal senso questa Coscienza è Dio. Dio non trascendente, ma immanente nel tutto. Dio che, nella sua eternità intemporalità assolutezza e perfezione, non esclude la storia, come non esclude l’ignoranza, l’errore, lo sforzo delle menti finite; questi elementi caratterizzano infatti la vita degli individui umani che in Lui sono “compresi”. E anzi, il fatto che questi siano compresi in Lui, dà all’uomo la fiducia che al problema ci sarà pur sempre una soluzione, che allo sforzo corrisponderà pur sempre il conseguimento di un obiettivo. E quando l’uomo agisce moralmente realizza nella sua finitezza consapevole la pienezza di Dio: non “annulla” la sua finitezza. L’uomo è per natura finito e infinito. Infatti il rapporto uomo-Dio è, secondo Royce, come quello che esiste, nella teoria dei numeri di Cantor e Dedekind, tra parte e tutto: la parte è uguale al tutto. Come il numero è un “sistema autorappresentativo”, cioè un sistema in cui ogni parte rappresenta il tutto, cosí Dio. Dio infatti è una realtà che contiene in sé le infinite menti umane in modo che ognuna rappresenta la totalità del contenente. In tal senso Dio è infinito, ma infinito è anche ogni singolo spirito umano; e tale infinità non nullifica la finitezza e la molteplicità dei singoli. Quanto all’universo, esso è l’insieme di “segni reali”; per l’uomo esso è l'”interpretazione” di quei segni; proprio tale interpretazione rende gli uomini una “comunità spirituale” di natura universale e divina. In e per questa comunità l’individuo conosce il vero e pratica il bene; vero e bene che non sono quindi accessibili all’individuo in quanto tale, ma in quanto membro di quella comunità che dà la sua “interpretazione” dei “segni reali”. L’idea di una tale comunità è ciò che rende fecondo il cristianesimo, che appunto indica nell’amore proprio la “fedeltà” dell’individuo alla comunità, e, insieme, il criterio per valutare fini compiti e azioni.
GIAN DOMENICO ROMAGNOSI

A cura di G. Tortora, S. Stringari e D. Quaglioni
Gian Domenico Romagnosi (1761-1835) è personalità di primo piano nella giurisprudenza italiana fra Sette e Ottocento. La sua opera, nel rinnovamento del pensiero giuridico europeo che s’intreccia con la Rivoluzione francese e con l’avvento della codificazione napoleonica, è strettamente legata alla fondazione di una nuova scienza del diritto pubblico e in particolare del diritto penale e del diritto amministrativo. Si può dire che la sua dottrina è una delle manifestazioni più chiare dello spirito scientifico settecentesco, rivolto ad affermare una fondamentale unità di metodo per le scienze morali (tra le quali il diritto continua ad occupare un posto di primo piano) e per le scienze della natura. Non è un caso che il celebre esperimento sul galvanismo, intorno al quale Sandro Stringari ha di recente portato nuova luce, si compia a Rovereto, nell’ambiente intellettuale raccolto attorno all’Accademia Roveretana degli Agiati, cioè in una società di letterati che a partire dagli anni ’50 del Settecento amano dibattere con la stessa intensità questioni di diritto, filosofia, lingua e letteratura così come di scienze fisiche, matematiche e naturali. Spirito enciclopedista, Romagnosi deve al suo decennio a Trento e nel Tirolo italiano le occasioni per la maturazione del suo abito intellettuale e della sua opera di investigatore dei fenomeni naturali, di giurista e di pensatore politico. Romagnosi, che si era addottorato a Parma, giunse a Trento nel 1791 per occupare l’ufficio di pretore, allora di durata annuale e non immediatamente rinnovabile, a norma di statuto (aveva già inoltrato domanda al magistrato consolare l’anno precedente, ma allora gli fu preferito il modenese Valdrighi). Il suo mandato non fu esente da contrasti con l’ultimo vescovo-principe di Trento, il conte Pietro Vigilio Thun; questi tuttavia, all’uscita dall’ufficio di pretore, gli concesse il titolo di consigliere aulico d’onore. Romagnosi restò perciò a Trento ed esercitò la professione di consulente legale, benché, in quanto forestiero, gli fosse precluso l’esercizio dell’avvocatura. Dopo l’entrata dei francesi a Trento, nel 1796, e con il successivo passaggio della città sotto il consiglio amministrativo austriaco, Romagnosi si trovò esposto al sospetto di attività filo-rivoluzionarie e tra il 1798 e il 1800 fu formalmente accusato di alto tradimento e imprigionato, venendo poi però assolto. Infine nel 1801, con la terza occupazione francese della città, egli divenne segretario del consiglio superiore presieduto dal giurista Carlo Antonio Pilati. Romagnosi lasciò quindi Trento per dedicarsi all’insegnamento universitario e ad un’intensa attività pubblicistica, certamente tra le più significative nei primi anni della restaurazione.
I suoi primi scritti politico-giuridici, dedicati ai concetti di uguaglianza e di libertà, risalgono appunto agli inizi del decennio trentino, così come la sua Genesi del diritto penale, del 1791, in cui si può già vedere la tendenza ad impostare la sua dottrina “more geometrico” (oggi diremmo con metodo razionale-sistematico), metodo che avrebbe trovato poi una compiuta espressione nella Introduzione allo studio del diritto pubblico universale (1805). La sua “civile filosofia”, cioè la sua teoria generale del diritto pubblico, fa di lui uno dei più importanti e riconosciuti teorici giuristi dell’età moderna. ![]() Gian Domenico Romagnosi è noto principalmente per i suoi studi giuridici e politico-sociali. Pochi sanno invece che fu protagonista, nel 1802, di un esperimento di fisica che avrebbe potuto influenzare in maniera profonda lo sviluppo della scienza, anticipando di parecchi anni la scoperta dell’elettro-magnetismo. Romagnosi era stato attratto dagli studi sperimentali fin dagli anni giovanili quando era studente del collegio Alberoni di Piacenza. Ma fu durante il soggiorno trentino che concepì l’idea di un esperimento rivoluzionario per l’epoca: l’esperimento puntava a dimostrare che una corrente elettrica produce la deviazione dell’ago magnetico. L’elettro-magnetismo è una delle scoperte scientifiche più importanti degli ultimi due secoli, punto di partenza dello sviluppo delle tecnologie più avanzate che utilizziamo quotidianamente, inclusi il computer e i più sofisticati sistemi di telecomunicazione. Alla base dell’elettro-magnetismo c’è il fatto fondamentale che i fenomeni elettrici e magnetici non sono indipendenti e separati uno dall’altro, ma sono invece intrinsecamente accoppiati. Questo è, ad esempio, il principio base della propagazione della luce. Prima del 1820, anno ufficiale della scoperta dell’elettro-magnetismo per opera del fisico danese Oersted, il mondo scientifico ignorava l’esistenza di questa connessione. È quindi straordinario il fatto che Romagnosi, ben 18 anni prima e solo 2 anni dopo l’invenzione della pila di Volta, abbia avuto l’idea di dimostrare il legame tra i fenomeni elettrici e magnetici. Romagnosi realizzò l’esperimento a Trento nel maggio 1802 e pubblicò i suoi risultati sui giornali di Trento e Rovereto. Cercò anche di far conoscere il suo lavoro a livello internazionale, inviando copia del suo articolo all’Accademia delle Scienze di Parigi, dove Napoleone Bonaparte aveva istituito un premio prestigioso per le ricerche sui fenomeni elettrici. Purtroppo la comunità scientifica non prestò molta attenzione al lavoro di Romagnosi. Nel 1830 Oersted scrisse sull’Enciclopedia di Edinburgo che “la conoscenza dei lavori di Romagnosi avrebbe anticipato la scoperta dell’elettro-magnetismo di 18 anni”. Questo significativo riconoscimento dell’importanza dell’intuizione di Romagnosi non spiega però perché il suo lavoro rimase nell’ombra per quasi vent’anni. Recentemente sono stati trovati ulteriori documenti che fanno parzialmente luce su quel periodo di storia, in particolare un articolo pubblicato sulla “Gazzetta di Rovereto” e la documentazione relativa alla partecipazione al concorso di Parigi.
Gian Domenico Romagnosi è noto principalmente per i suoi studi giuridici e politico-sociali. Pochi sanno invece che fu protagonista, nel 1802, di un esperimento di fisica che avrebbe potuto influenzare in maniera profonda lo sviluppo della scienza, anticipando di parecchi anni la scoperta dell’elettro-magnetismo. Romagnosi era stato attratto dagli studi sperimentali fin dagli anni giovanili quando era studente del collegio Alberoni di Piacenza. Ma fu durante il soggiorno trentino che concepì l’idea di un esperimento rivoluzionario per l’epoca: l’esperimento puntava a dimostrare che una corrente elettrica produce la deviazione dell’ago magnetico. L’elettro-magnetismo è una delle scoperte scientifiche più importanti degli ultimi due secoli, punto di partenza dello sviluppo delle tecnologie più avanzate che utilizziamo quotidianamente, inclusi il computer e i più sofisticati sistemi di telecomunicazione. Alla base dell’elettro-magnetismo c’è il fatto fondamentale che i fenomeni elettrici e magnetici non sono indipendenti e separati uno dall’altro, ma sono invece intrinsecamente accoppiati. Questo è, ad esempio, il principio base della propagazione della luce. Prima del 1820, anno ufficiale della scoperta dell’elettro-magnetismo per opera del fisico danese Oersted, il mondo scientifico ignorava l’esistenza di questa connessione. È quindi straordinario il fatto che Romagnosi, ben 18 anni prima e solo 2 anni dopo l’invenzione della pila di Volta, abbia avuto l’idea di dimostrare il legame tra i fenomeni elettrici e magnetici. Romagnosi realizzò l’esperimento a Trento nel maggio 1802 e pubblicò i suoi risultati sui giornali di Trento e Rovereto. Cercò anche di far conoscere il suo lavoro a livello internazionale, inviando copia del suo articolo all’Accademia delle Scienze di Parigi, dove Napoleone Bonaparte aveva istituito un premio prestigioso per le ricerche sui fenomeni elettrici. Purtroppo la comunità scientifica non prestò molta attenzione al lavoro di Romagnosi. Nel 1830 Oersted scrisse sull’Enciclopedia di Edinburgo che “la conoscenza dei lavori di Romagnosi avrebbe anticipato la scoperta dell’elettro-magnetismo di 18 anni”. Questo significativo riconoscimento dell’importanza dell’intuizione di Romagnosi non spiega però perché il suo lavoro rimase nell’ombra per quasi vent’anni. Recentemente sono stati trovati ulteriori documenti che fanno parzialmente luce su quel periodo di storia, in particolare un articolo pubblicato sulla “Gazzetta di Rovereto” e la documentazione relativa alla partecipazione al concorso di Parigi.
Figura eclettica di pensatore, Romagnosi fu sempre strenuo sostenitore dei principi fondamentali di libertà. È un onore per la comunità trentina annoverarlo tra i suoi cittadini illustri e per la nostra Università farne simbolo di impegno intellettuale e riferimento per le nuove generazioni di ricercatori. ![]()
IL PENSIERO FILOSOFICO
La revisione della gnoseologia “illuministica” ebbe luogo, in Giandomenico Romagnosi (1761-1835), sotto lo stimolo immediato dei temi, ormai circolanti anche in Italia, dell'”ideologia”.
L’Italia, infatti, è, in questo periodo, sotto l’influenza della cultura filosofica francese, sollecitata ugualmente dai temi del “movimento tradizionalista e spiritualista”, che si ripresentano quasi in modo fedele agli originali pure nelle speculazioni dei maggiori pensatori italiani della stessa corrente (anche se posti in un nuovo e diverso contesto sistematico), e dal “movimento degli ideologi”, che appunto si fece presente soprattutto nell’Italia settentrionale.
Di Romagnosi, allievo nella prima giovinezza del Collegio Alberoni di Piacenza, in cui l’insegnamento filosofico era condotto sui temi del sensismo, poi professore nelle Università di Pavia e di Parma, sono da ricordare le opere giuridiche Genesi del diritto penale (1791), Introduzione allo studio del diritto pubblico universale (1805), e quelle politico-filosofiche Della costituzione di una monarchia nazionale rappresentativa (1815), Che cos’è la mente sana? (1827), Della suprema economia dell’umano sapere in relazione alla mente sana (1828), Vedute fondamentali sull’arte logica (1832) e Giurisprudenza teorica ossia Istituzioni di civile filosofia (pubblicata postuma nel 1839). È indiscutibile, sostiene il Romagnosi, che la materia di ogni conoscenza proviene dai sensi. Ma è pur vero che la sensazione, per sé, non è ancora conoscenza. Questa ha luogo quando interviene l’intelletto che ordina le sensazioni secondo rapporti fondamentali suoi propri. Pertanto ha torto in qualche misura il sensismo quando riduce la conoscenza sensibile alla semplice “registrazione” della sensazione; e in qualche modo ha ragione il razionalismo quando sostiene che l’intelletto è attivo dando alle sensazioni delle forme che esse non contengono in sé. Dunque la conoscenza nasce dalla “compotenza”, cioè dal concorso di senso e intelletto, o, com’egli dice, di “senso esterno” e “senso logico”. Infatti le sensazioni divengono significative quando vengono ordinate secondo i concetti logici di ente, unità, forma, numero, successione e permanenza, uniformità e discrepanza, ecc. Questi concetti, che Romagnosi definisce “logie”, sono “emissioni intime”; nell’atto conoscitivo essi non derivano dall’esterno, ma provengono dall’interno stesso dell’anima, in quanto sono modi propri con cui l’anima dà “segnature razionali” alle “segnature positive”, cioè alle impressioni sensoriali.
Come Kant egli avverte che questi concetti non sono idee innate; esse non danno conoscenza “a priori”, cioè a prescindere dalle impressioni sensibili, ma solo in concorso con l’esperienza. Dunque, non esiste altra conoscenza che quella “a posteriori”, quella il cui contenuto è empirico. Tuttavia la conoscenza empirica non è oggettiva, non è conoscenza della realtà. Indiscutibilmente ha ragione Condillac: i sensi esterni non ci danno conoscenza delle cose, ma di ciò che percepiamo delle cose, dei fenomeni delle cose. Insomma conosciamo le rappresentazioni soggettive che noi stessi ci formiamo delle cose: i “sensi” offrono la materia della rappresentazione e il “senso logico” la ordina secondo quelle relazioni, secondo quelle forme d’organizzazione che lo stesso soggetto conoscente possiede. Fuori del soggetto non si va né si può andare.
Ma per quanto sottolinei l’affinità della sua posizione con Condillac, per tanto Romagnosi cerca di dissimulare l’evidente consonanza delle sue tesi con quelle di Kant.
A Kant obietta che le forme “a priori” non sono “trascendentali”; non sono connaturate al pensiero; esse hanno una genesi nell’anima. Pur non essendo frutto d’esperienza, sono i risultati di un processo induttivo graduale che il pensiero ha operato sull’esperienza empirica. Sono “a priori”, insomma, rispetto alle sensazioni attuali, ma hanno origine e radici pur sempre nell’esperienza passata.
Inoltre egli sottolinea pure che la conoscenza di cui parla è “fenomenica”, ma non in senso kantiano. È vero, egli sostiene, i fenomeni non sono riproduzioni fedeli del reale. Tuttavia da questa costatazione Kant ha concluso erroneamente che del reale non si ha alcuna conoscenza; erroneamente perché cosí la conoscenza non è altro che arbitraria creazione dell’intelletto; e quindi l’opera kantiana di dissipare lo scetticismo è naufragata. Se però i fenomeni non sono copie del reale, essi tuttavia sono pur sempre “segni” naturali; sicché le rappresentazioni sono i corrispondenti mentali delle cose e dei loro modi di essere, e non “figmenti nostri”.
Vale la pena ricordare, comunque, che Romagnosi, ingegno acuto, non esaurí i suoi interessi nel lavoro filosofico, come s’è visto dai titoli delle sue pubblicazioni. Egli si dedicò pure allo studio della vita sociale, in tutte le sue componenti (giuridiche, politiche, economiche, morali, storiche) e nelle sue leggi di sviluppo. In questo studio egli considerò l’uomo, evidentemente, non nella sua individualità, ma neppure nella sua astratta universalità; questi due modi di discorrere dell’uomo sono scientificamente sterili. Bisogna considerarlo invece nei modi e nelle forme concrete della sua esistenza storica, nei modi e nelle forme in cui egli concretamente pensa e agisce; il che significa anche che l’uomo non può essere studiato scientificamente senza che lo si relazioni al contesto sociale e al contesto storico in cui egli è di fatto inserito. Solo in tal modo lo studio della storia dell’uomo si rivela come lo studio della storia del suo “incivilimento” progressivo.
Il pensiero di Romagnosi fu largamente contestato dai metafisici spiritualisti, e specialmente dal Rosmini, che, evidentemente, non poteva accettare il soggettivismo conoscitivo, ossia la dichiarata impossibilità che la mente conosca il reale in sé, cosí com’è. Ma la “reazione metafisica” non riuscí a dissolvere l’eco prodotta dalle posizioni di Romagnosi, che anzi trovarono convinto accoglimento e adeguato sviluppo nel pensiero dei suoi discepoli. Soprattutto promosse l’inventiva dei suoi seguaci il suo appello a considerare l’uomo nel suo contesto sociale, cosa che costituiva la prima testimonianza della breccia aperta dai positivisti europei sugli intellettuali italiani d’impostazione, per cosí dire, laica.
E specialmente il Cattaneo accolse il suo invito a considerare le “segnature positive” l’unica materia di conoscenza, e, soprattutto, a studiare la stona dell'”incivilimento” umano a partire dai “fatti” empiricamente rilevabili. Col che ebbe inizio il vero filone “positivistico” nella filosofia italiana dell’Ottocento; o, si può anche dire, con ciò la riflessione critica sul sensismo illuministico sboccò nella concezione positivistica della realtà e della storia.
Col Ferrari, poi, si ebbe la teorizzazione della necessità di uno “spirito positivo” come condizione indispensabile per la creazione di una nuova, moderna società.
VINCENZO CUOCO

VITA E OPERE
Vincenzo Cuoco nacque a Civitacampomarano (Campobasso) nel 1770; la sua famiglia, di estrazione borghese, lo avviò agli studi di giurisprudenza che non completò mai, sentendosi invece più incline alla filosofia e alla letteratura che coltivò assiduamente. Tra i suoi interessi ebbero un ruolo particolare lo studio della storia e della cultura delle antiche popolazioni italiche; gli autori che più influenzarono la sua riflessione storica furono Machiavelli e Vico. Nel 1799 prese parte alla Rivoluzione napoletana ricoprendo incarichi di rilievo all’interno del regime giacobino. Per questo motivo, al ritorno dei Borboni, fu condannato alla confisca dei beni, a pochi mesi di prigionia e a venti anni di esilio. Imbarcatosi per Marsiglia, trascorse lunghi periodi successivamente a Milano e a Parigi: durante l’esilio iniziò a scrivere il Saggio storico sulla rivoluzione napoletana del 1799, la sua opera di maggior rilievo. Nel saggio, Cuoco imputa il fallimento dell’azione rivoluzionaria all’incauta applicazione dei modelli rivoluzionari giacobini alla realtà del meridione italiano, profondamente diversa da quella francese. L’opera venne terminata e pubblicata a Milano nel 1801, prima in forma anonima e poi a suo nome (1806). I primi anni dell’Ottocento lo videro impegnato in un’intensa attività pubblicistica presso il Giornale Italiano, cui riuscì a dare una nuova fisionomia economica, e nella stesura di numerose opere di vario genere rimaste però tutte incompiute. Unica eccezione i due volumi del Platone in Italia (inizialmente pubblicato in tre volumi), romanzo storico-epistolare che finse di tradurre dal greco. Il testo è incentrato sulla celebrazione dell’antica “Italia pitagorica” come luogo mitico di saggezza e si inserisce così nella polemica del “primato degli italiani” che animava la cultura del primo Ottocento, proclamando la supremazia culturale dell’Italia rispetto alla Francia. In seguito alla mutata condizione politica, Cuoco tornò a Napoli continuando ad occuparsi di pubblicistica (Monitore delle Sicilie) e ricoprendo incarichi politici sotto Gioacchino Murat, di cui fu uno dei più validi collaboratori. La restaurazione del 1815 e il conseguente ritorno allo status quo ante minarono irreversibilmente il suo fragile sistema nervoso, portandolo alla follia. Morì a Napoli nel 1823.
IL PENSIERO
Nel Settecento gl’intellettuali italiani si aprirono generosamente all’influsso delle idee illuministiche francesi (utilizzandole peraltro anche in modo autonomo e creativo) e a quello degli ideali della Rivoluzione del 1789. Ma con la fine dell’avventura napoleonica andarono maturando anche in Italia fermenti di critica contro l’astrattezza dei discorsi dei filosofi illuministi, e contro quella degli ideali rivoluzionari che troppo ingenuamente si erano ritenuti trasportabili nella nostra penisola.
In questo clima visse Vincenzo Cuoco, che, nei Frammenti di lettere a V. Russo e nel Saggio storico sulla rivoluzione napoletana del 1799, affermò che nessuna rivoluzione può essere imposta, né con “la forza delle baionette”, né ad opera di “un’assemblea di filosofi”; e sostenne che ogni popolo deve avere una sua propria costituzione adeguata alle sue caratteristiche, alla sua cultura e alla sua storia. E’ assurdo illudersi (e questo fu l’errore fatale dei Rivoluzionari francesi) che vi siano valori universalmente validi e universalmente applicabili a prescindere dalle particolari realtà storiche e sociali: tale è l’errore commesso dall’illuminismo, che pecca di astrattezza nella misura in cui pretende di universalizzare e di assolutizzare ogni cosa. Ogni realtà ha le sue condizioni e le sue peculiarità, sicchè non è detto che, quanto risulta ottimo a Parigi, tale risulti anche a Napoli. Troviamo, pertanto, in Cuoco, i germi del nascente Romanticismo, con la sua attenzione per le realtà particolari, di contro all’Illuminismo ormai tramontante. A proposito del fallimento della rivoluzione napoletana, egli annotava:
“Le idee della rivoluzione di Napoli avrebbero potuto essere popolari, ove si avesse voluto trarle dal fondo istesso della nazione. Tratte da una costituzione straniera, erano lontanissime dalla nostra; fondate sopra massime troppo astratte, erano lontanissime da’ sensi, e, quel ch’è piú, si aggiungevano ad esse, come leggi, tutti gli usi, tutt’i capricci e talora tutt’i difetti di un altro popolo, lontanissimi dai nostri difetti, da’ nostri capricci, dagli usi nostri…
Se mai la repubblica si fosse fondata da noi medesimi, se la costituzione, diretta dalle idee eterne della giustizia, si fosse fondata sui bisogni e sugli usi del popolo; se un’autorità che il popolo credeva legittima e nazionale, invece di parlargli un astruso linguaggio che esso non intendeva, gli avesse procurato dei beni reali, e liberato lo avesse da que’ mali che soffriva… forse… chi sa?… noi non piangeremmo ora sui miseri avanzi di una patria desolata e degna di una sorte migliore… La nostra rivoluzione, essendo una rivoluzione passiva, l’unico mezzo di condurla a buon fine era quello di guadagnare l’opinione del popolo. Ma le vedute de’ patrioti e quelle del popolo non erano le stesse: essi avevano diverse idee, diversi costumi e finanche due lingue diverse”.
(Saggio storico sulla rivoluzione napoletana del 1799)
Sul piano piú strettamente filosofico la reazione antilluministica, piuttosto che stimolare la creazione di nuove originali visioni del mondo, si trasformò, anzitutto, in esigenza di recupero della tradizione culturale italiana, con lo scopo pedagogico di formare le coscienze intorno ai valori costanti della civiltà italica. Infatti nell’Ottocento l’impegno politico degl’intellettuali si focalizzò sul disegno di liberazione del Lombardo-Veneto dalla dominazione austriaca e, quindi, sul progetto di costruzione di un unico stato italiano a dimensione nazionale. Sicché la riscoperta e la diffusione della tradizione storico-culturale mirava a fondare una “coscienza della nazionalità italiana” che sola poteva essere il presupposto logico di quel progetto; infatti era giudizio diffuso che sussisteva di fatto, e da tempi antichi, un’unità spirituale che la divisione politica in una molteplicità di stati, anche se secolare, non aveva mai spezzato.
SAGGIO STORICO
SULLA
RIVOLUZIONE DI NAPOLI
SECONDA EDIZIONE
CON AGGIUNTE DELL’AUTORE
1806
Caedo cur vestram rempublicam tantam perdidistis tam cito?
POMPONIO ATTICO, presso CICERONE, De senectute.
PREFAZIONE
ALLA SECONDA EDIZIONE
Quando questo Saggio fu pubblicato per la prima volta, i giudizi pronunziati sul medesimo furon molti e diversi, siccome suole inevitabilmente avvenire ad ogni libro, del quale l’autore ha professata imparzialitá, ma non sono imparziali i lettori. Il tempo però ed il maggior numero han resa giustizia, non al mio ingegno né alla mia dottrina (ché né quello né questa abbondavano nel mio libro), ma alla imparzialitá ed alla sinceritá colla quale io avea in esso narrati avvenimenti che per me non eran stati al certo indifferenti.
Della prima edizione da lungo tempo non rimaneva piú un esemplare; e, ad onta delle molte richieste che ne avea, io avrei ancora differita per qualche altro tempo la seconda, se alcuni, che han tentato ristamparla senza il mio assentimento, non mi avessero costretto ad accelerarla.
Dopo la prima edizione, ho raccolti i giudizi che il pubblico ha pronunziati, ed ho cercato, per quanto era in me, di usarne per rendere il mio libro quanto piú si potesse migliore.
Alcuni avrebbero desiderato un numero maggiore di fatti. Ed in veritá io non nego che nella prima edizione alcuni fatti ho omessi, perché li ignorava; altri ho taciuti, perché ho creduto prudente il tacerli; altri ho trasandati, perché li reputava poco importanti; altri finalmente ho appena accennati. Ho composto il mio libro senza aver altra guida che la mia memoria: era impossibile saper tutti gl’infiniti accidenti di una rivoluzione, e tutti rammentarli. Molti de’ medesimi ho saputi posteriormente, e, di essi, i piú importanti ho aggiunti a quelli che giá avea narrati. Ad onta però di tutte le aggiunzioni fatte, io ben mi avveggo che coloro, i quali desideravano maggior numero di fatti nella prima edizione, ne desidereranno ancora in questa seconda. Ma il mio disegno non è stato mai quello di scriver la storia della rivoluzione di Napoli, molto meno una leggenda. Gli avvenimenti di una rivoluzione sono infiniti di numero; e come no, se in una rivoluzione agiscono contemporaneamente infiniti uomini? Ma, per questa stessa ragione, è impossibile che tra tanti avvenimenti non vi sieno molti poco importanti e molti altri che si rassomiglian tra loro. I primi li ho trascurati, i secondi li ho riuniti sotto le rispettive loro classi. Piú che delle persone, mi sono occupato delle cose e delle idee. Ciò è dispiaciuto a molti, che forse desideravano esser nominati; è piaciuto a moltissimi, che amavano di non esserlo. I nomi nella storia servon piú alla vanitá di chi è nominato che all’istruzione di chi legge. Quanti pochi sono gli uomini che han saputo vincere e dominare le cose? Il massimo numero è servo delle medesime; è tale, quale i tempi, le idee, i costumi, gli accidenti voglion che sia: quando avete ben descritti questi, a che giova nominar gli uomini? Io sono fermamente convinto che, se la maggior parte delle storie si scrivesse in modo di sostituire ai nomi propri delle lettere dell’alfabeto, l’istruzione, che se ne ritrarrebbe, sarebbe la medesima. Finalmente, nella considerazione e nella narrazione degli avvenimenti, mi sono piú occupato degli effetti e delle cagioni delle cose che di que’ piccioli accidenti che non sono né effetti né cagioni di nulla, e che piaccion tanto al lettore ozioso sol perché gli forniscono il modo di poter usare di quel tempo che non saprebbe impiegare a riflettere.
Dopo tali osservazioni, ognun vede che i fatti che mi rimanevano ad aggiugnere eran in minor numero di quello che si crede. Ragionando con molti di coloro i quali avrebbero desiderati piú fatti, spesso mi sono avveduto che ciò che essi desideravano nel mio libro giá vi era: ma essi desideravano nomi, dettagli, ripetizioni; e queste non vi dovean essere. Per qual ragione distrarrò io l’attenzione del lettore tra un numero infinito d’inezie e lo distoglierò da quello ch’io reputo vero scopo di ogni istoria, dalla osservazione del corso che hanno, non gli uomini, che brillano un momento solo, ma le idee e le cose, che sono eterne? Si dirá che il mio libro non merita il nome di “storia”; ed io risponderò che non mi sono giammai proposto di scriverne. Ma è forse indispensabile che un libro, perché sia utile, sia una storia?
Una censura mi fu fatta, appena uscí alla luce il primo volume. Siccome essa nasceva da un equivoco, credei mio dovere dileguarlo; e lo feci con quell’avvertimento che, nella prima edizione, leggesi al principio del secondo volume, e che ora inserisco qui:
Tutte le volte che in quest’opera si parla di “nome”, di “opinione”, di “grado”, s’intende sempre di quel grado, di quella opinione, di quel nome che influiscono sul popolo, che è il grande, il solo agente delle rivoluzioni e delle controrivoluzioni.
Taluni, per non aver fatta questa riflessione, hanno creduto che, quando nel primo tomo, pagina 34, io parlo di coloro che furono perseguitati dall’inquisizione di Stato, e li chiamo “giovinetti senza nome, senza grado, senza fortuna”, abbia voluto dichiararli persone di niun merito, quasi della feccia del popolo, che desideravano una rivoluzione per far una fortuna.
Questo era contrario a tutto il resto dell’opera, in cui mille volte si ripete che in Napoli eran repubblicani tutti coloro che avevano beni e fortuna; che niuna nazione conta tanti che bramassero una riforma per solo amor della patria; che in Napoli la repubblica è caduta quasi per soverchia virtú de’ repubblicani… Nell’istesso luogo si dice che i lumi della filosofia erano sparsi in Napoli piú che altrove, e che i saggi travagliavano a diffonderli, sperando che un giorno non rimarrebbero inutili.
I primi repubblicani furono tutti delle migliori famiglie della capitale e delle province: molti nobili, tutti gentiluomini, ricchi e pieni di lumi; cosicché l’eccesso istesso de’ lumi, che superava l’esperienza dell’etá, faceva lor credere facile ciò che realmente era impossibile per lo stato in cui il popolaccio si ritrovava. Essi desideravano il bene, ma non potevano produrre senza il popolo una rivoluzione; e questo appunto è quello che rende inescusabile la tirannica persecuzione destata contro di loro.
Chi legge con attenzione vede chiaramente che questo appunto ivi si vuol dire. Io altro non ho fatto che riferire quello che allora disse in difesa de’ repubblicani il rispettabile presidente del Consiglio, Cito; e Cito era molto lontano dall’ignorare le persone o dal volerle offendere.
Sarebbe stoltezza dire che le famiglie Carafa, Riari, Serra, Colonna, Pignatelli… fossero povere; ma, per produrre una rivoluzione nello stato in cui allora era il popolo napoletano, si richiedevano almeno trenta milioni di ducati, e questa somma si può dir, senza far loro alcun torto, che essi non l’aveano. La ricchezza è relativa all’oggetto a cui taluno tende: un uomo che abbia trecentomila scudi di rendita è un ricchissimo privato, ma sarebbe un miserabile sovrano.
Si può occupare nella societá un grado eminentissimo, e non essere intanto atto a produrre una rivoluzione. Il presidente del Consiglio occupava la prima magistratura del Regno, e non potea farlo: ad un reggente di Vicaria, molto inferiore ad un presidente, ad un eletto del popolo, moltissimo inferiore al reggente, era molto piú facile sommovere il popolo.
Lo stesso si dice del nome. Chi può dire che le famiglie Serra, Colonna, Pignatelli… fossero famiglie oscure? Che Pagano, Cirillo, Conforti fossero uomini senza nome?… Ma essi aveano un nome tra i saggi, i quali a produr la rivoluzione sono inutili, e non ne aveano tra il popolo, che era necessario, ed a cui intanto erano ignoti per esser troppo superiori. Paggio, capo de’ lazzaroni del Mercato, è un uomo dispregevole per tutti i versi; ma intanto Paggio, e non Pagano, era l’uomo del popolo, il quale bestemmia sempre tutto ciò che ignora.
Credo superfluo poi avvertire che i giudizi del popolo non sono i miei; ma è necessario ricordare che, in un’opera destinata alla veritá ed all’istruzione, è necessario riferire tanto i giudizi miei quanto quelli del popolo. Ciascuno sará al suo luogo: è necessario saperli distinguere e riconoscere; e perciò è necessario aver la pazienza di leggere l’opera intera, e non giudicarne da tratti separati.
Questo Saggio è stato tradotto in tedesco. Son molto grato al signor Kellert, il quale, senza che ne conoscesse l’autore credette il libro degno degli studi suoi: piú grato gli sono, perché lo ha tradotto in modo da farlo apparir degno dell’approvazione de’ letterati di Germania; de’ favorevoli giudizi de’ quali io andrei superbo, se non sapessi che si debbono in grandissima parte ai nuovi pregi che al mio libro ha saputo dare l’elegante traduttore. Pure, tra gli elogi che il libro ha ottenuti, non è mancata qualche censura, ed una, tra le altre, scritta collo stile di un cavalier errante che unisce la ragione alla spada, leggesi nel giornale del signor Archenholz, intitolato: La Minerva. L’articolo è sottoscritto dal signor Dietrikstein, che io non conosco, ma che ho ragion di credere essere al tempo istesso valentissimo scrittore e guerriero, poiché si mostra pronto egualmente a sostener contro di me colla penna e colla spada che il signor barone di Mack sia un eccellente condottiero di armata, ad onta che nel mio libro io avessi tentato di far credere il contrario. In veritá, io dichiaro che valuto pochissimo i talenti militari del generale Mack. Quando io scriveva il mio Saggio, avea presenti al mio pensiero la campagna di Napoli e la seconda campagna delle Fiandre, ambedue dirette da Mack: vedeva nell’una e nell’altra gli stessi rovesci e le stesse cagioni di rovesci; e credei poter ragionevolmente conchiudere che la colpa fosse del generale. Ciò che è effetto di sola fortuna non si ripete con tanta simiglianza due volte. Quando poi pervenne in Milano l’articolo del signor Dietrikstein, era giá aperta l’ultima campagna. L’amico, che mi comunicò l’articolo, avrebbe desiderato che io avessi fatta qualche risposta. Ma, due giorni appresso, il cannone della piazza annunziò la vittoria di Ulma, ed io rimandai all’amico l’articolo, e vi scrissi a’ piè della pagina: “La risposta è fatta”.
Questo mio libro non deve esser considerato come una storia, ma bensí come una raccolta di osservazioni sulla storia. Gli avvenimenti posteriori han dimostrato che io ho osservato con imparzialitá e non senza qualche acume. Gran parte delle cose che io avea previste si sono avverate; l’esperimento delle cose posteriori ha confermati i giudizi che avea pronunziati sulle antecedenti. Mentre quasi tutta l’Europa teneva Mack in conto di gran generale, io solo, io il primo, ho vendicato l’onor della mia nazione, ed ho asserito che le disgrazie da lui sofferte nelle sue campagne non eran tanto effetto di fortuna quanto d’ignoranza. Fin dal 1800 io ho indicato il vizio fondamentale che vi era in tutte le leghe che si concertavano contro la Francia, e pel quale tutt’i tentativi de’ collegati dovean sempre avere un esito infelice, ad onta di tutte le vittorie che avessero potuto ottenere; e tutto ciò perché le vittorie consumano le forze al pari o poco meno delle disfatte, e le forze si perdono inutilmente se son prive di consiglio, né vi è consiglio ove o non vi è scopo o lo scopo è tale che non possa ottenersi.
Desidero che chiunque legge questo libro paragoni gli avvenimenti de’ quali nel medesimo si parla a quelli che sono succeduti alla sua pubblicazione. Troverá che spesso il giudizio da me pronunziato sopra quelli è stata una predizione di questi, e che l’esperienza posteriore ha confermate le antecedenti mie osservazioni. Il gabinetto di Napoli ha continuato negli stessi errori: sempre lo stesso incerto oscillar nella condotta, la stessa alternativa di speranze e di timore, e quella sempre temeraria, questo sempre precipitoso; moltissima fiducia negli aiuti stranieri, nessuna fiducia e perciò nessuna cura delle forze proprie; non mai un’operazione ben concertata; nella prima lega, il trattato di Tolentino e la spedizione di Tolone conchiuso e fatta fuori di ogni ragione e di ogni opportunitá; nella seconda, l’invasione dello Stato pontificio fatta prima che l’Austria pensasse a mover le sue armate, le operazioni del picciolo corpo che Damas comandava in Arezzo incominciate quando le forze austriache non esistevano piú; nella terza finalmente, un trattato segnato colla Francia, mentre forse non era necessario poiché si pensava di infrangerlo; i russi e gl’inglesi chiamati quando giá la somma delle cose era stata decisa in Austerlitz; l’inutile macchia di traditore, e l’inopportunitá del tradimento, e l’obbrobrio di vedere un re che comanda a sette milioni di uomini divenire, per colpa de’ suoi ministri, quasi il fattore degl’inglesi e cedere il comando delle sue proprie truppe entro il suo proprio regno ad un generale russo. Ricercate le cagioni di tutti questi avvenimenti, e trovate esser sempre le stesse: un ministro che traeva gran parte del suo potere dall’Inghilterra, ove avea messe in serbo le sue ricchezze; l’ignoranza delle forze della propria nazione, la nessuna cura di migliorare la di lei sorte, di ridestare negli animi degli abitanti l’amor della patria, della milizia e della gloria; lo stato di violenza che naturalmente dovea sorgere da quella specie di lotta, che era inevitabile tra un popolo naturalmente pieno di energia ed un ministro straniero che volea tenerlo nella miseria e nell’oppressione; la diffidenza che questo stesso ministro avea ispirata nell’animo de’ sovrani contro la sua nazione; tutto insomma quello che io avea predetto, dicendo che la condotta di quel gabinetto avrebbe finalmente perduto un’altra volta, ed irreparabilmente, il Regno.
Avrei potuto aggiugnere alla storia della rivoluzione anche quella degli avvenimenti posteriori fino ai nostri giorni. Riserbo questa occupazione a’ tempi ne’ quali avrò piú ozio e maggior facilitá di istruirmene io stesso, ritornato che sarò nella mia patria. Ne formerò un altro volume dello stesso sesto, carta e caratteri del presente. Intanto nulla ho voluto cangiare al libro che avea pubblicato nel 1800. Quando io componeva quel libro, il gran Napoleone era appena ritornato dall’Egitto; quando si stampava, egli avea appena prese le redini delle cose, appena avea incominciata la magnanima impresa di ricomporre le idee e gli ordini della Francia e dell’Europa. Ma io ho il vanto di aver desiderate non poche di quelle grandi cose che egli posteriormente ha fatte; ed, in tempi ne’ quali tutt’i princípi erano esagerati, ho il vanto di aver raccomandata, per quanto era in me, quella moderazione che è compagna inseparabile della sapienza e della giustizia, e che si può dire la massima direttrice di tutte le operazioni che ha fatte l’uomo grandissimo. Egli ha verificato l’adagio greco per cui si dice che gl’iddii han data una forza infinita alle mezze proporzionali, cioè alle idee di moderazione, di ordine, di giustizia. Le stesse lettere, che io avea scritte al mio amico Russo sul progetto di costituzione composto dall’illustre e sventurato Pagano, sebbene oggi superflue, pure le ho conservate e come un monumento di storia e come una dimostrazione che tutti quegli ordini che allora credevansi costituzionali non eran che anarchici. La Francia non ha incominciato ad aver ordine, l’Italia non ha incominciato ad aver vita, se non dopo Napoleone; e, tra li tanti benefíci che egli all’Italia ha fatti, non è l’ultimo certamente quello di aver donato a Milano Eugenio ed alla mia patria Giuseppe.
Lettera dell’autore a N.Q.
Quando io incominciai ad occuparmi della storia della rivoluzione di Napoli, non ebbi altro scopo che quello di raddolcire l’ozio e la noia dell’emigrazione. È dolce cosa rammentar nel porto le tempeste passate. Io avea ottenuto il mio intento; né avrei pensato ad altro, se tu e gli altri amici, ai quali io lessi il manoscritto, non aveste creduto che esso potesse esser utile a qualche altro oggetto.
Come va il mondo! Il re di Napoli dichiara la guerra ai francesi ed è vinto; i francesi conquistano il di lui regno e poi l’abbandonano; il re ritorna e dichiara delitto capitale l’aver amata la patria mentre non apparteneva piú a lui. Tutto ciò è avvenuto senza che io vi avessi avuto la minima parte, senza che neanche lo avessi potuto prevedere: ma tutto ciò ha fatto sí che io sia stato esiliato, che sia venuto in Milano, dove, per certo, seguendo il corso ordinario della mia vita, non era destinato a venire, e che quivi, per non aver altro che fare, sia diventato autore. “Tutto è concatenato nel mondo”, diceva Panglos: possa tutto esserlo per lo meglio!
In altri tempi non avrei permesso certamente che l’opera mia vedesse la luce. Fino a ier l’altro, invece di princípi, non abbiamo avuto che l’esaltazione de’ princípi; cercavamo la libertá e non avevamo che sètte. Uomini, non tanto amici della libertá quanto nemici dell’ordine inventavano una parola per fondare una setta, e si proclamavan capi di una setta per aver diritto di distruggere chiunque seguisse una setta diversa. Quegli uomini, ai quali l’Europa rimprovererá eternamente la morte di Vergniaud, di Condorcet, di Lavoisier e di Bailly; quegli uomini, che riunirono entro lo stesso tempio alle ceneri di Rousseau e di Voltaire quelle di Marat e ricusarono di raccogliervi quelle di Montesquieu, non erano certamente gli uomini da’ quali l’Europa sperar poteva la sua felicitá.
Un nuovo ordine di cose ci promette maggiori e piú durevoli beni. Ma credi tu che l’oscuro autore di un libro possa mai produrre la felicitá umana? In qualunque ordine di cose, le idee del vero rimangono sempre sterili o generan solo qualche inutile desiderio negli animi degli uomini dabbene, se accolte e protette non vengano da coloro ai quali è affidato il freno delle cose mortali.
Se io potessi parlare a colui a cui questo nuovo ordine si deve, gli direi che l’obblio ed il disprezzo appunto di tali idee fece sí che la nuova sorte, che la sua mano e la sua mente avean data all’Italia, quasi divenisse per costei, nella di lui lontananza, sorte di desolazione, di ruina e di morte, se egli stesso non ritornava a salvarla.
– Un uomo – gli direi, – che ha liberata due volte l’Italia, che ha fatto conoscere all’Egitto il nome francese e che, ritornando, quasi sulle ali de’ venti, simile alla folgore, ha dissipati, dispersi, atterriti coloro che eransi uniti a perdere quello Stato che egli avea creato ed illustrato colle sue vittorie, molto ha fatto per la sua gloria; ma molto altro ancora può e deve fare per il bene dell’umanitá. Dopo aver infrante le catene all’Italia, ti rimane ancora a renderle la libertá cara e sicura, onde né per negligenza perda né per forza le sia rapito il tuo dono. Che se la mia patria, come piccolissima parte di quel grande insieme di cui si occupano i tuoi pensieri, è destino che debba pur servire all’ordine generale delle cose, e se è scritto ne’ fati di non poter avere tutti quei beni che essa spera, abbia almeno per te alleviamento a quei tanti mali onde ora è oppressa! Tu vedi, sotto il piú dolce cielo e nel piú fertile suolo dell’Europa, la giustizia divenuta istrumento dell’ambizione di un ministro scellerato, il dritto delle genti conculcato, il nome francese vilipeso, un’orribile carneficina d’innocenti ch’espiano colla morte e tra tormenti le colpe non loro; e, nel momento istesso in cui ti parlo, diecimila gemono ancora ed invocano, se non un liberatore, almeno un intercessore potente.
Un grande uomo dell’antichitá che tu eguagli per cuore e vinci per mente, uno che, come te, prima vinse i nemici della patria e poscia riordinò quella patria per la quale avea vinto, Gerone di Siracusa, per prezzo della vittoria riportata sopra i cartaginesi, impose loro l’obbligo di non ammazzare piú i propri figli. Egli allora stipulò per lo genere umano.
Se tu ti contenti della sola gloria di conquistatore, mille altri troverai, i quali han fatto, al pari di te, tacere la terra al loro cospetto; ma, se a questa gloria vorrai aggiungere anche quella di fondatore di saggi governi e di ordinatore di popoli, allora l’umanitá riconoscente ti assegnerá, nella memoria de’ posteri, un luogo nel quale avrai pochissimi rivali o nessuno.
L’adulazione rammenta ai potenti quelle virtú de’ loro maggiori, che essi non sanno piú imitare; la filosofia rammenta ai grandi uomini le virtú proprie, perché proseguano sempre piú costanti nella magnanima loro impresa…
NB. Ogni volta che si parlerá di moneta di Napoli, il conto s’intenda sempre in ducati: ogni ducato corrisponde a quattro lire di Francia.
I
INTRODUZIONE
Io imprendo a scriver la storia di una rivoluzione che dovea formare la felicitá di una nazione, e che intanto ha prodotta la sua ruina(1). Si vedrá in meno di un anno un gran regno rovesciato, mentre minacciava conquistar tutta l’Italia; un’armata di ottantamila uomini battuta, dissipata, distrutta da un pugno di soldati; un re debole, consigliato da ministri vili, abbandonare i suoi Stati senza verun pericolo; la libertá nascere e stabilirsi quando meno si sperava; il fato istesso combattere per la buona causa, e gli errori degli uomini distruggere l’opera del fato e far risorgere dal seno della libertá un nuovo dispotismo e piú feroce.
Le grandi rivoluzioni politiche occupano nella storia dell’uomo quel luogo istesso che tengono i fenomeni straordinari nella storia della natura. Per molti secoli le generazioni si succedono tranquillamente come i giorni dell’anno: esse non hanno che i nomi diversi, e chi ne conosce una le conosce tutte. Un avvenimento straordinario sembra dar loro una nuova vita; nuovi oggetti si presentano ai nostri sguardi; ed in mezzo a quel disordine generale, che sembra voler distruggere una nazione, si scoprono il suo carattere, i suoi costumi e le leggi di quell’ordine, del quale prima si vedevano solamente gli effetti.
Ma una catastrofe fisica è, per l’ordinario, piú esattamente osservata e piú veracemente descritta di una catastrofe politica. La mente, in osservar questa, segue sempre i moti irresistibili del cuore; e degli avvenimenti che piú interessano il genere umano, invece di aversene la storia, non se ne ha per lo piú che l’elogio o la satira. Troppo vicini ai fatti de’ quali vogliam fare il racconto, noi siamo oppressi dal loro numero istesso; non ne vediamo l’insieme; ne ignoriamo le cagioni e gli effetti; non possiamo distinguere gli utili dagl’inutili, i frivoli dagl’importanti, finché il tempo non li abbia separati l’uno dall’altro, e, facendo cader nell’obblio ciò che non merita di esser conservato, trasmetta alla posteritá solo ciò che è degno della memoria ed utile all’istruzione di tutt’i secoli.
La posteritá, che ci deve giudicare, scriverá la nostra storia. Ma, siccome a noi spetta di prepararle il materiale de’ fatti, cosí sia permesso di prevenirne il giudizio. Senza pretendere di scriver la storia della rivoluzione di Napoli, mi sia permesso trattenermi un momento sopra alcuni avvenimenti che in essa mi sembrano piú importanti, ed indicare ciò che ne’ medesimi vi sia da lodare, ciò che vi sia da biasimare. La posteritá, esente da passioni, non è sempre libera da pregiudizi in favor di colui che rimane ultimo vincitore; e le nostre azioni potrebbero esser calunniate sol perché sono state infelici.
Dichiaro che non sono addetto ad alcun partito, a meno che la ragione e l’umanitá non ne abbiano uno. Narro le vicende della mia patria; racconto avvenimenti che io stesso ho veduto e de’ quali sono stato io stesso un giorno non ultima parte; scrivo pei miei concittadini, che non debbo, che non posso, che non voglio ingannare. Coloro i quali, colle piú pure intenzioni e col piú ardente zelo per la buona causa, per mancanza di lumi o di coraggio l’han fatta rovinare; coloro i quali o son morti gloriosamente o gemono tuttavia vittime del buon partito oppresso, mi debbono perdonare se nemmen per amicizia offendo quella veritá che deve esser sempre cara a chiunque ama la patria, e debbono esser lieti se, non avendo potuto giovare ai posteri colle loro operazioni, possano almeno esser utili cogli esempi de’ loro errori e delle sventure loro.
Di qualunque partito io mi sia, di qualunque partito sia il lettore, sempre gioverá osservare come i falsi consigli, i capricci del momento, l’ambizione de’ privati, la debolezza de’ magistrati, l’ignoranza de’ propri doveri e della propria nazione, sieno egualmente funesti alle repubbliche ed ai regni; ed i nostri posteri dagli esempi nostri vedranno che qualunque forza senza saviezza non fa che distrugger se stessa, e che non vi è vera saviezza senza quella virtú che tutto consacra al bene universale.
II
STATO DELL’EUROPA DOPO IL 1793
Ma, prima di trattar della nostra rivoluzione, convien risalire un poco piú alto e trattenersi un momento sugli avvenimenti che la precedettero; veder qual era lo stato della nazione, quali cagioni la involsero nella guerra, quali mali soffriva, quali beni sperava: cosí il lettore sará in istato di meglio conoscere le sue cause e giudicar piú sanamente de’ suoi effetti.
La Francia, fin dal 1789, avea fatta la piú gran rivoluzione di cui ci parli la storia. Non vi era esempio di rivoluzione, che, volendo tutto riformare, avea tutto distrutto. Le altre aveano combattuto e vinto un pregiudizio con un altro pregiudizio, un’opinione con un’altra opinione, un costume con un altro costume: questa avea nel tempo istesso attaccato e rovesciato l’altare, il trono, i diritti e le proprietá delle famiglie, e finanche i nomi che nove secoli avean resi rispettabili agli occhi de’ popoli.
La rivoluzione francese, sebbene prevista da alcuni pochi saggi, ai quali il volgo non suole prestar fede, scoppiò improvvisa e sbalordí tutta l’Europa. Tutti gli altri sovrani, parte per parentela che li univa a Luigi decimosesto, parte per proprio interesse, temettero un esempio che potea divenir contagioso.
Si credette facile impresa estinguere un incendio nascente. Si sperò molto sui torbidi interni che agitavano la Francia, non tornando in mente ad alcuno che all’avvicinar dell’inimico esterno l’orgoglio nazionale avrebbe riuniti tutt’i partiti divisi. Si sperò molto nella decadenza delle arti e del commercio, nella mancanza assoluta di tutto, in cui era caduta la Francia; si sperò a buon conto vincerla per miseria e per fame, senza ricordarsi che il periglio rende gli entusiasti guerrieri, e la fame rende i guerrieri eroi. Una guerra esterna, mossa con eguale ingiustizia ed imprudenza, assodò una rivoluzione, che, senza di essa, sarebbe degenerata in guerra civile.
L’Inghilterra meditava conquiste immense e vantaggi infiniti nel suo commercio sulla ruina di una nazione che sola allora era la sua rivale. La corte di Londra, piú che ogni altra corte di Europa, temer dovea il contagio delle nuove opinioni, che si potean dire quasi nate nel seno dell’Inghilterra; e, per renderle odiose al popolo inglese, mezzo migliore non ritrovò che risvegliare l’antica rivalitá nazionale, onde farle odiare, se non come irragionevoli, almen come francesi. Pitt vedeva che gli abitanti della Gran Brettagna, e specialmente gl’irlandesi e scozzesi, eran disposti a fare altrettanto: la rivoluzione sarebbe scoppiata in Inghilterra, se gl’inglesi quasi non avessero sdegnato d’imitare i francesi(2).
L’Inghilterra, sebbene non fosse stata la prima a dichiarar la guerra, fu però la prima a soffiare il fuoco della discordia. L’Austria seguí l’invito della sua antica e naturale alleata. Le corti di Europa non conoscevano le repubbliche. Dalla perdita inevitabile della Francia speravano un guadagno sicuro. La Prussia l’avea giá ottenuto nel congresso di Pilnitz colla divisione della Polonia. L’Inghilterra e la Prussia mossero lo statolder, il quale volea distrarre con una guerra esterna gli animi non troppo tranquilli de’ batavi, resi da poco suoi sudditi, ed amava veder distrutti coloro che potevan essere un giorno non deboli protettori de’ medesimi.
La Prussia e l’Austria strascinarono i piccoli principi dell’impero, i quali, piú che dalla perdita di pochi, incerti, inutili dritti, che la rivoluzione di Francia avea lor tolti in Alsazia ed in Lorena, erano mossi dall’oro degl’inglesi, ai quali da lungo tempo erano avvezzi a vendere il sangue de’ propri sudditi. Il re di Sardegna seguí le vie di sua antica politica, ed avvezzo ad ingrandirsi tra le dissensioni della Francia e dell’Austria, alle quali vendeva alternativamente i suoi soccorsi, tenne sulle prime il partito della lega, che gli parve il piú forte. Finalmente anche la Spagna seguí l’impulso generale; e la guerra fu risoluta.
Si aprí la campagna con grandissime vittorie degli alleati; ma ben presto furono seguite dai piú terribili rovesci. I francesi seppero distaccar la Prussia dalla lega; la quale, ottenuta la sua porzione di Polonia, comprese che, tra due potenze di prim’ordine che si laceravano e distruggevano a vicenda, suo meglio era quello di rimaner neutrale.
La corte di Spagna s’ingelosí ben presto dell’Inghilterra, che sola voleva ritrar profitto dalla guerra comune. La condotta degl’inglesi in Tolone fece scoppiare il malumore che da lungo tempo covava nel suo seno, e Carlo quarto non volle piú impiegar le sue forze ad accrescere una nazione che egli dovea temere piú della francese. Mentre i suoi eserciti erano battuti per terra, le sue flotte rimanevano inoperose per mare; mentre i francesi guadagnavano in Europa, egli avrebbe potuto aver un compenso in America e dar fine cosí alla guerra con una vicendevole restituzione, senza quelle perdite che fu costretto a soffrire per ottenere la pace. Il desiderio de’ francesi era appunto quello che molti lor dichiarassero la guerra e niuno la facesse con tutte le sue forze; cosí ogni nuovo nemico dava ai francesi una nuova vittoria, e quella lega, che dovea abbassarli, serviva ad ingrandirli.
La guerra era ormai divenuta, come nell’antica Roma, indispensabile alla Francia, tra perché teneva luogo di tutte le arti e di tutto il commercio, che prima formavano la sussistenza del popolo, tra perché un governo quasi sempre fazioso la considerava come un mezzo di occupare e distrarre gli animi troppo attivi degli abitanti ed allontanare i torbidi che soglion fermentar nella pace. Quindi si sviluppò quel sistema di democratizzazione universale, di cui i politici si servivan per interesse, a cui i filosofi applaudivano per soverchia buona fede; sistema che alla forza delle armi riunisce quella dell’opinione, che suol produrre, e talora ha prodotti, quegl’imperi che tanto somigliano ad una monarchia universale.
III
STATO D’ITALIA FINO ALLA PACE DI CAMPOFORMIO
In breve tempo li francesi si videro vincitori e padroni delle Fiandre, dell’Olanda, della Savoia e di tutto l’immenso tratto ch’è lungo la sinistra sponda del Reno. Non ebbero però in Italia sí rapidi successi; e le loro armate stettero tre anni a’ piedi delle Alpi, che non potettero superare, e che forse non avrebbero superate giammai, se il genio di Bonaparte non avesse chiamata anche in questi luoghi la vittoria.
Quando l’impresa d’Italia fu affidata a Bonaparte, era quasi che disperata. Egli si trovò alla testa di un’armata alla quale mancava tutto, ma che era uscita dalla Francia nel momento del suo maggiore entusiasmo e che era da tre anni avvezza ai disagi ed alle fatiche; si trovò alla testa di coraggiosi avventurieri, risoluti di vincere o morire. Egli avea tutti i talenti, e quello specialmente di farsi amare dai soldati, senza del quale ogni altro talento non val nulla.
Se le campagne di Bonaparte in Italia si vogliono paragonare a quelle che i romani fecero in paesi stranieri, si potranno dir simili solo a quelle colle quali conquistarono la Macedonia. Scipione ebbe a combattere un grandissimo capitano che non avea nazione; molti altri non ebbero a fronte né generali né nazioni guerriere: solo nella Macedonia i romani trovarono potenza bene ordinata, nazione agguerrita ed audace per freschi trionfi, e generali i quali, se non aveano il genio, sapevano almeno la pratica dell’arte. Bonaparte cangiò la tattica, cangiò la pratica dell’arte; e le pesanti evoluzioni de’ tedeschi divennero inutili come le falangi de’ macedoni in faccia ai romani. Supera le Alpi e piomba nel Piemonte. Costringe il re di Sardegna, stanco forsi da una guerra di cinque anni, privato di buona porzione de’ suoi domini, abbandonato dagli austriaci, ridotti a difendere il loro paese, a sottoscrivere un armistizio, forse necessario, ma al certo non onorevole, ed a cedere a titolo di deposito fino alla pace quelle piazze che ancora potea e che difender dovea fino alla morte. Dopo ciò, la campagna non fu che una serie continua di vittorie.
L’Italia era divisa in tanti piccoli Stati, i quali però, riuniti, pur potevano opporre qualche resistenza. Bonaparte fu sí destro da dividere i loro interessi. Questa è la sorte, dice Machiavelli, di quelle nazioni le quali han giá guadagnata la riputazione delle armi: ciascuno brama la loro amicizia, ciascuno procura distornare una guerra che teme. Cosí i romani han combattuto sempre i loro nemici ad uno ad uno e li han vinti tutti. Il papa tentò di stringere una lega italica. Concorrevano volentieri a questa alleanza le corti di Napoli e di Sardegna, la prima delle quali s’incaricò d’invitarvi anche la repubblica veneta. Ma i “savi” di questa repubblica alle proposizioni del residente napolitano risposero che nel senato veneto era giá quasi un secolo che non parlavasi di alleanza, che si sarebbe proposta inutilmente; ma che, se mai la lega fosse stata stretta tra gli altri principi, non era difficile che la repubblica vi accedesse. Ma, quando il gabinetto di Vienna ebbe cognizione di tali trattative, vi si oppose acremente e mostrò con parole e con fatti che piú della rivoluzione francese temeva l’unione italiana!
Allora si vide quanto lo stato politico degl’italiani fosse infelice, non solo perché divisi in tanti piccoli Stati (ché pure la divisione non sarebbe stata il piú grave de’ mali), ma perché da duecento anni o conquistati o, quel che è peggio, protetti dagli stranieri, all’ombra del sistema generale di Europa, senza aver guerra tra loro, senza temerne dagli esteri, tra la servitú e la protezione, avean perduto ogni amor di patria ed ogni virtú militare. Noi, in questi ultimi tempi, non solo non abbiam potuto rinnovar gli esempi antichi de’ nostri avi antichissimi, i quali, riuniti, conquistarono tanta parte dell’universo, ma neanche quei meno illustri dei tempi a noi piú vicini, quando, divisi tra noi, ma indipendenti da tutto il rimanente dell’Europa, eravamo italiani, liberi ed armati.
Gli austriaci, rimasti soli, non poterono sostener l’impeto nemico: tutta la Lombardia fu invasa, Mantova cadde, ed essi furono respinti fino al Tirolo. Bonaparte era giá poco lontano da Vienna, l’Europa aspettava da momento a momento azioni piú strepitose; quando si vide la Francia condiscendere ad una pace, colla quale essa acquistava il possesso della sinistra sponda del Reno e dell’importante piazza di Magonza, e l’Austria riconosceva l’indipendenza della repubblica cisalpina, in compenso della quale le si davano i domíni della repubblica veneta. Questa, col risolversi troppo tardi alla guerra, altro non avea fatto che dare ai piú potenti un plausibile motivo di accelerare la sua ruina.
Per qual forza di destino avrebbe potuto sussistere un governo, il quale da due secoli avea distrutta ogni virtú ed ogni valor militare, che avea ristretto tutto lo Stato nella sola capitale, e poscia avea concentrata la capitale in poche famiglie, le quali, sentendosi deboli a tanto impero, non altra massima aveano che la gelosia, non altra sicurezza che la debolezza de’ sudditi e, piú che ogni nemico esterno, temer doveano la virtú de’ propri sudditi? Non so che avverrá dell’Italia; ma il compimento della profezia del segretario fiorentino, la distruzione di quella vecchia imbecille oligarchia veneta, sará sempre per l’Italia un gran bene. Ed io che, tra i beni che posson ricevere i popoli, il primo luogo do a quelli della mente, cioè al giudicar retto, onde vien poi l’oprar virtuoso e nobile; io credo esser giá sommo vantaggio il veder tolto l’antico errore per cui i gentiluomini veneziani godevan nelle menti del volgo fama di sapienti reggitori di Stato.
Il trattato di Campoformio era vantaggioso a tutt’e due le potenze contraenti. L’Austria, sopra tutto, vi avea guadagnato massimo; e, se rimaneva ancora qualche altro oggetto a determinarsi, era facile prevedere che a spese de’ piú piccoli principi di Germania essa avrebbe guadagnato anche dippiú. Ma era facile egualmente prevedere che l’Inghilterra, avendo sola tra gli alleati colla guerra guadagnato e dovendo sola restituire, esser dovea lontana dai pensieri di pace.
Il governo che allora avea la Francia, checché molti credessero, avea, almen per poco, rinunciato al progetto di democratizzazione universale, il quale, al modo come l’aveano i francesi immaginato, era solo eseguibile in un momento di entusiasmo. I romani mostravan di rendere ai popoli gli ordini che essi bramavano, ma non avevan la smania di portar dappertutto gli ordini di Roma. Quindi i romani conservarono meglio e piú lungamente l’apparenza di liberatori de’ popoli. Ma il governo francese riteneva tuttavia il primiero linguaggio per vendere a piú caro prezzo le sue promesse e le sue minacce: eravi sempre una contraddizione tra i proclami de’ generali e le negoziazioni de’ ministri, tra le parole date ai popoli e quelle date ai re; e, tra queste continue contraddizioni, si faceva, ora coi popoli ora coi re, un traffico continuo di speranze e di timori.
Giá da questo ognuno prevedeva che il trattato di Campoformio avea sol per poco sospesa la democratizzazione di tutta l’Italia. Il re di Sardegna non era che il ministro della repubblica francese in Torino; il duca di Toscana ed il papa non erano nulla. Berthier finalmente occupò Roma; la distruzione di un vecchio governo teocratico non costò che il volerla; tale è lo stato dell’Italia, che chiunque vuole o salvarla o occuparla deve riunirla, e non si può riunire senza cangiare il governo di Roma. L’indifferenza colla quale l’Italia riguardò tale avvenimento mostrò bene qual progresso le nuove opinioni avean fatto negli animi degl’italiani.
IV
NAPOLI – REGINA
Rimaneva il regno di Napoli; e forse, almen per quel tempo, i francesi non aveano né interesse né forza né volontá di attaccarlo. Ma la parentela coi sovrani di Francia, l’influenza preponderante del gabinetto inglese, il carattere della regina, tutto contribuiva a fomentare nella corte di Napoli l’odio che fin da principio, piú caldo che ogni altra corte di Europa, avea spiegato contro la rivoluzione francese. La regina, nel viaggio che avea fatto per la Germania e per l’Italia in occasione del matrimonio delle sue figlie, era stata la prima motrice di quella lega che poi si vide scoppiare contro la Francia. La forza costrinse la corte di Napoli a sottoscrivere una neutralitá, quando Latouche venne con una squadra in faccia alla stessa capitale. Forse allora temette piú di quel che dovea: se avesse prolungate per due altri giorni le trattative, la stagione ed i venti avrebbero fatta vendetta di una flotta che troppo imprudentemente si era avventurata entro un golfo pericoloso in una stagione pericolosissima.
La presa di Tolone fece rompere di nuovo la neutralitá. Al pari delle altre corti, quella di Napoli inviò delle truppe a sostenere una sciagurata impresa piú mercantile che guerriera, la quale, nel modo in cui fu immaginata e diretta, potea esser utile solo agl’inglesi. Nella primavera seguente inviò due brigate di cavalleria nella Cisalpina in soccorso dell’imperatore: esse si condussero molto bene. Ma le vittorie di Bonaparte in Italia fecero ricadere la corte ne’ suoi timori, e si affrettò a conchiudere una pace nel tempo appunto in cui l’imperatore avea maggior bisogno de’ suoi aiuti; nel tempo in cui, non presa ancora Mantova, non distrutte ancora tutte le forze imperiali in Italia, poteva, facendo avanzar le sue truppe, produrre un potente e forse pericoloso diversivo. Il governo francese ad una corte che non sapeva far la guerra seppe vendere quella pace, che esso avrebbe dovuto e che forse era pronto a comprare.
Perché si ebbe tanta paura della flotta di Latouche? Perché si credeva che in Napoli vi fossero cinquantamila pronti a prender l’armi in di lui favore. Non vi era nessuno, nessuno… Qual fu nella trattativa di questa pace il grande oggetto del quale si occupò la corte di Napoli? La liberazione di circa duecento scolaretti, che teneva arrestati nelle sue fortezze. Che non si fece, che non si pagò per far sí che il Direttorio non insistesse, come allora era di moda, per la liberazione de’ “rei di opinione”? La regina non approvava quella pace, e forse avea ragione; ma credette aver ottenuto molto, avendo ottenuto il diritto di poter incrudelire inutilmente contro pochi giovinetti che conveniva disprezzare… Non si perdano mai di vista questi fatti. La corte di Napoli non sapeva né che temere né che sperare: come si poteva pretendere che agisse saviamente?
La corte di Napoli era la corte delle irresoluzioni, della viltá ed, in conseguenza, delle perfidie. La regina ed il re eran concordi solo nell’odiare i francesi; ma l’odio del re era indolente, quello della regina attivissimo: il primo si sarebbe contentato di tenerli lontani, la seconda volea vederli distrutti. Ne’ momenti di pericolo, il re ascoltava i suoi timori e, piú de’ timori, la sua indolenza; al primo favore di fortuna, al primo raggio di nuove e liete speranze, per cagione della stessa indolenza, abbandonava di nuovo gli affari alla regina.
Acton fomentava nel re un’indolenza che accresceva l’imperio suo e della regina; e questa, per desiderio di comandare, non si avvedeva che Acton turbava tutte le cose e spingeva ad inevitabile rovina il re, il Regno e lei stessa. La regina era ambiziosa; ma l’ambizione è un vizio o una virtú, secondo le vie che sceglie, secondo il bene o il male che produce. Ella venne la prima volta da Germania col disegno d’invadere il trono, né si ristette finché, per mezzo degl’intrighi e dell’ascendente che una colta educazione le dava sull’animo del marito, non giunse a cangiar tutt’i rapporti interni ed esterni dello Stato.
Il marchese Tanucci previde le funeste conseguenze del genio novatore della giovine regina, e volle opporvisi fin da quel momento in cui pretese di aver entrata e voto nel Consiglio di Stato. Era questa una novitá inudita nel regno di Napoli, e molto piú nella famiglia di Borbone, ma la regina vinse e giurò vendicarsi di Tanucci: né la sua etá, né il suo merito, né li suoi lunghi e fedeli servizi poterono salvar questo vecchio amico di Carlo terzo ed aio, per cosí dire, di suo figlio dalla umiliazione e dalla disgrazia.
Sotto un re, debole inimico ed infedele amico, tutti compresero non esservi da temere, non da sperare, se non dalla regina; e tutti furono a lei venduti. Ella creò anche al di fuori nuovi sostegni all’impero.
Tutti gl’interessi politici univano il regno di Napoli a quello di Francia e di Spagna, e questi legami potevano formar la felicitá della nazione coi vantaggi del commercio e della pace. Ma gl’interessi della nazione poteano bene essere quelli del re, non mai però quelli della regina: ella volea nuovi rapporti politici, che la sostenessero, se bisognasse, contro il re e, se fosse possibile, anche contro la nazione. Noi diventammo ligi dell’Austria, potenza lontana, dalla quale la nazione nostra nulla potea sperare e tutto dovea temere; potenza, la quale, involta in continue guerre, ci strascinava ogni momento a prender parte negl’interessi altrui, senza poter mai sperare di veder difesi li nostri. La preponderanza che l’Austria andava acquistando sulle nostre coste offese la Spagna; ma la regina, lungi dal temere il suo sdegno, lo fomentò, lo spinse agli estremi, onde togliere al re ogni via di ravvedimento.
I ministri del re doveano esser i favoriti della regina; ma questa sacrificava sempre i suoi favoriti ai disegni suoi. L’ultimo è stato il piú fortunato di tutti, non perché avesse piú merito, ma perché avea piú audacia degli altri, li quali non combattevano con lui ad armi eguali, perché non si permettevano tutto ciò ch’egli ardiva fare. Conservavano ancora costoro qualche vecchio sentimento di giustizia, di amicizia, di pubblico bene: come contrastare con uno che tutto sacrificava alla distruzione de’ suoi nemici ed al favore della sua sovrana?(3).
Giovanni Acton venne dalla Toscana, cioè da uno Stato che non avea marina, a crearne una in Napoli. Avea due titoli, oltre un terzo che gli attribuisce la fama, a meritare il favore della regina: era, tra’ ministri del re, il solo straniero e seppe prima degli altri comprendere che in Napoli la regina era tutto ed il re era un nulla. Giunse nel tempo in cui ardevano piú che mai i disgusti colla corte di Spagna. Sambuca, che allora era primo ministro, prese il partito spagnuolo: fu male accorto e vile; perdette la grazia della regina e poco dipoi, come era inevitabile, anche quella del re. Si vide per poco suo successore Caracciolo: ma costui, rotto dagli anni e per natura portato all’indolenza, in una corte ove non si voleva il bene né si soffriva il vero, non fu che l’ombra di un gran nome e serví, senza saperlo o almeno senza curarlo, a far risplendere Acton, che la regina voleva esaltare, ma che ancora non poteva vincere la riputazione de’ piú vecchi. La morte di Caracciolo diede luogo finalmente ai suoi disegni: Acton fu posto alla testa degli affari, il vecchio De Marco confinato ai minuti dettagli di casa reale, tutti gli altri ministri non furono che creature di Acton. La sola parte d’ingegno, che Acton veramente possedeva, era quella di conoscer gli uomini. Non vi era alcuno che meglio di lui sapesse definire il carattere morale de’ suoi favoriti. Riputava Castelcicala vile e crudele nella sua viltá; Vanni entusiasta, ambizioso e crudele per furore quanto lo era Castelcicala per riflessione; Simonetti e Corradini ambedue uomini dabbene, ma il primo indolente, il secondo pedante, ed incapaci ambedue di opporsi a lui. Si serví di Castelcicala fin da che era ministro in Londra.
V
STATO DEL REGNO – AVVILIMENTO DELLA NAZIONE
Acton e la regina quasi congiurarono insieme per perdere il Regno. La regina spiegò il piú alto disprezzo per tutto ciò ch’era nazionale. Si voleva un genio? Dovea darcisi dall’Arno. Si voleva un uomo dabbene? Dovea venirci dall’Istro. Ci vedemmo inondati da una folla di stranieri, i quali occuparono tutte le cariche, assorbirono tutte le rendite senz’avere verun talento e verun costume, insultarono coloro ai quali rapivano la sussistenza. Il merito nazionale fu obbliato, fu depresso e poté credersi felice quando non fu perseguitato(4).
Quel nobile sentimento di orgoglio, che solo ispira le grandi azioni, facendocene credere capaci; quel sentimento, che solo ispira lo spirito pubblico e l’amor della patria; quel sentimento, che in altri tempi ci fece esser grandi e che oggi fa grandi tante altre nazioni di Europa, delle quali fummo un tempo e maestri e signori, era interamente estinto presso di noi. Noi diventammo a vicenda or francesi or tedeschi ora inglesi; noi non eravamo piú nulla. Tante volte e sí altamente per venti anni ci era ripetuto che noi non valevamo nulla, che quasi si era giunto a farcelo credere.
La nazione napoletana sviluppò prima una frivola mania per le mode degli esteri. Questo produceva un male al nostro commercio ed alle nostre manifatture: in Napoli un sartore non sapeva cucire un abito, se il disegno non fosse venuto da Londra o da Parigi. Dall’imitazione delle vesti si passò a quella del costume e delle maniere, indi all’imitazione delle lingue: si apprendeva il francese e l’inglese, mentre era piú vergognoso il non sapere l’italiano(5). L’imitazione delle lingue portò seco finalmente quella delle opinioni. La mania per le nazioni estere prima avvilisce, indi ammiserisce, finalmente ruina una nazione, spegnendo in lei ogni amore per le cose sue. La regina fu la prima ad aprir la porta a quelle novitá, che ella stessa poi con tanto furore ha perseguitate. Una nazione, che troppo ammira le cose straniere, alle cagioni di rivoluzione che porta seco il corso politico di ogni popolo aggiunge anche quelle degli altri popoli. Quanti tra noi erano democratici solo perché lo erano i francesi? Sopra cento teste voi dovete contare, in ogni nazione, cinquanta donne e quarantotto uomini piú frivoli delle donne: essi non ragionano in altro modo che in questo: – In… si pettina meglio, si veste meglio, si cucina meglio, si parla meglio: la prova n’è che noi ci pettiniamo, mangiamo, ci vestiamo com’essi fanno. Come è possibile che quella nazione non pensi e non operi meglio di noi?(6).
VI
INQUISIZIONE DI STATO
I nostri affetti, preso che abbiano un corso, piú non si arrestano. L’odio segue il disprezzo, e dietro l’odio vengono il sospetto ed il timore. La regina, che non amava la nazione, temeva di esserne odiata; e questo affetto, sebbene penoso, ha bisogno, al pari di ogni altro, di essere fomentato. Chiunque le parlò male della nazione fu da lei ben accolto.
Le novitá delle opinioni politiche accrebbero i suoi sospetti e diedero nuovi mezzi ai cortigiani per guadagnare il suo cuore. Acton non mancò di servirsene per perder Medici e qualche altro illustre suo rivale. Quindi si sciolse il freno e si portò la desolazione nel seno di tutte le famiglie.
Un esempio. I nostri giovinetti in quegli anni aveano per moda di far delle corse a cavallo per Chiaia ed ai Bagnuoli. Si dette a credere ad Acton, o piuttosto Acton volle dar a credere alla corte, che essi volessero rinnovare le corse olimpiche. Qual rapporto tra le corse de’ nostri giovani napolitani e quelle de’ greci? E, quando anche quelle fossero state un’imitazione di queste, qual male? qual pericolo? Acton intanto incaricò la polizia di vegliare su queste corse, come se si fosse trattato della marcia di venti squadroni nemici che piombassero sulla capitale.
Alcuni giovani entusiasti, ripieni la testa delle nuove teorie, leggevano ne’ fogli periodici gli avvenimenti della rivoluzione francese e ne parlavano tra di loro o, ciocché val molto meno, ne parlavano alle loro innamorate ad ai loro parrucchieri. Essi non aveano altro delitto che questo, né giovani senza grado, senza fortuna, senza opinione potevano tentarne altro. Fu eretto un tribunale di sangue col nome di “Giunta di Stato” per giudicarli, come se avessero giá ucciso il re e rovesciata la costituzione.
Pochi magistrati, tra coloro che componevano la Giunta, amanti veracemente del re e della patria, vedendo che il primo, il vero, il solo delitto di Stato era quello di seminar diffidenze tra il sovrano e la nazione, ardirono prendere la difesa dell’innocenza e proporre al re che la pena de’ rei di Stato mal si applicava a pochi giovani inesperti, i quali non di altro delitto eran rei che di aver parlato di ciò che era meglio tacere, di aver approvato ciò che era meglio esaminare; delitto di giovani, i quali si sarebbero corretti coll’etá e coll’esperienza, che avrebbe smentite le brillanti ma fallaci teorie onde erano le loro menti invasate. I mali di opinione si guariscono col disprezzo e coll’obblio: il popolo non intenderá, non seguirá mai i filosofi. Ma, se voi perseguitate le opinioni, allora esse diventano sentimenti; il sentimento produce l’entusiasmo; l’entusiasmo si comunica; vi inimicate chi soffre la persecuzione, vi inimicate chi la teme, vi inimicate anche l’uomo indifferente che la condanna; e finalmente l’opinione perseguitata diventa generale e trionfa.
Ma, ove si tratta di delitto di Stato, le piú evidenti ragioni rimangono inefficaci. Imperciocché di rado un tal delitto esiste, e di rado avviene che un uomo attenti con atto non equivoco alla costituzione o al sovrano di una nazione: il piú delle volte si tratta di parole che vaglion meno delle minacce, o di pensieri che vagliono anche meno delle parole. Tali cose vagliono quanto le fa valere il timore di chi regna(7). Guai a chi ha ascoltato una volta le voci del timore! Quanto piú ha temuto, piú dovrá temere. Molto temeva la regina di Napoli, ed Acton voleva che temesse di piú. Le frequenti impressioni di sospetti e di timori, che aveva sofferte, avevano quasi alterato il di lei fisico e turbata interamente la serie e l’associazione delle sue idee. Persone degne di fede mi narrano che non senza pericolo di dispiacerle taluno le attestava la fedeltá de’ sudditi suoi.
Si volle del sangue, e se n’ebbe. Furono condannati a morte tre infelici, tra’ quali il virtuoso Emmanuele de Deo, a cui si fece offrire la vita purché rivelasse i suoi complici, e che in faccia all’istessa morte seppe preferirla all’infamia.
Ecco un esempio di ciò che possa e che produca il timore negli animi, una volta turbati. Nel giorno dell’esecuzione della sentenza si presero quelle precauzioni che altre volte si erano trascurate e che anche allora erano superflue. Si temeva che il popolo volesse salvare tre sciagurati, che appena conosceva; si temeva una sedizione di circa cinquantamila rivoluzionari, che per lo meno si diceva dover esser in Napoli. Intanto, le truppe che quasi assediavano la cittá, gli ordini minaccevoli del governo, tutto allarmava la fantasia del popolo; qualunque moto piú leggiero, che in altri tempi sarebbe stato indifferente, doveva turbarlo; temeva i sollevatori, temeva gli ordini del governo, temeva tutto; ed il minimo timore dovea produrre, come difatti produsse, in una gran massa di popolo un’agitazione tumultuosa. Cosí i sospetti del governo rendono piú sospettoso il popolo. Da quell’epoca il popolo napolitano, che prima quasi si conteneva da se stesso senza veruna polizia, fu piú difficile a maneggiarsi; tutte le pubbliche feste furono fatte con maggiori precauzioni, ma non furono perciò piú tranquille.
Si sciolse la prima Giunta. Si sperava poter respirare finalmente da tanti orrori; ma, pochi mesi dopo, si vide in campo una nuova congiura ed una Giunta piú terribile della prima. Si vollero allontanati tutti que’ magistrati che conservavano ancora qualche sentimento di giustizia e di umanitá. Si mostrò di volere i scellerati, ed i scellerati corsero in folla. Castelcicala, Vanni, Guidobaldi si misero alla loro testa. La nazione fu assediata da un numero infinito di spie e di delatori, che contavano i passi, registravano le parole, notavano il colore del volto, osservavano finanche i sospiri. Non vi fu piú sicurezza. Gli odii privati trovarono una strada sicura per ottener la vendetta, e coloro che non avevano nemici furono oppressi dagli amici loro medesimi, che la sete dell’oro e l’ambizione aveva venduti ad Acton ed a Vanni. Che si può difatti conservare di buono in una nazione, dove chi regna non dá le ricchezze, le cariche, gli onori se non ai delatori? dove, se si presenta un uomo onesto a chiedere il premio delle sue fatiche o delle sue virtú, gli si risponde che “si faccia prima del merito”? Per “farsi del merito” s’intendeva divenir delatore, cioè formar la ruina almeno di dieci persone oneste. Questo merito aveano tanti, i nomi de’ quali la giusta vendetta della posteritá non deve permettere che cadano nell’obblio. La regina, indispettita contro un sentimento di virtú che la massima parte della nazione ancora conservava, diceva pubblicamente che “ella sarebbe un giorno giunta a distruggere quell’antico pregiudizio per cui si reputava infame il mestiere di delatore”. Tutte queste e molte altre simili cose si narravano: forse, siccome sempre suole avvenire, in picciola parte vere, pel maggior numero false e finte per odio. Ma queste cose, o vere o false che sieno, sono sempre dannose quando e si dicono da molti e da molti si credono, perché rendono piú audaci gli scellerati e piú timidi i buoni. Che se esse son false, meritano doppiamente la pubblica esecrazione que’ ministri i quali colla loro condotta dánno occasione a dirle e ragione a crederle. Per cagioni intanto di queste voci, una parte della nazione si armò contro l’altra; non vi furono piú che spie ed uomini onesti, e chi era onesto era in conseguenza un “giacobino”. Vanni avea detto mille volte alla regina che il Regno era pieno di giacobini: Vanni volle apparir veridico, e colla sua condotta li creò.
Tutt’i castelli, tutte le carceri furono ripiene d’infelici. Si gittarono in orribili prigioni, privi di luce e di tutto ciò ch’era necessario alla vita, e vi languirono per anni, senza poter ottenere né la loro assoluzione né la loro condanna, senza neanche poter sapere la cagione della loro disgrazia. Quasi tutti, dopo quattro anni, uscirono liberi, come innocenti; e sarebbero usciti tutti, se non si fossero loro tolti i legittimi mezzi di difesa. Vanni, che era allor il direttor supremo di tali affari, non si curava piú di chi era giá in carcere; non pensava che a carcerarne degli altri: ardí dire che “almeno dovevano arrestarsene ventimila”. Se il fratello, se il figlio, se il padre, se la moglie di qualche infelice ricorreva a costui per sollecitare la decisione della di lui sorte, un tal atto di umanitá si ascriveva a delitto. Se si ricorreva al re e che il re qualche volta ne chiedeva conto a Vanni, ciò anche era inutile, perché per Vanni rispondeva la regina, la quale credeva che Vanni operasse bene. Vanni diceva sempre che vi erano altre fila della congiura da scoprire, altri rei da arrestare; e la regina tutto approvava, perché temeva sempre altri rei ed altre congiure.
Vanni, il quale meglio di ogni altro sapeva con quali arti si era ordita un’inquisizione, diretta piú a fomentare i timori della regina che a calmarli, tremava ogni volta che gli si parlava di esame e di sentenza. Ei volea trovare il reo, e temea che si fosse ricercata la veritá(8).
Sembrerá a molti inverisimile tutto ciò che io narro di Vanni. E difatti il carattere morale di quell’uomo era singolare. Egli riuniva un’estrema ambizione ad una crudeltá estrema e, per colmo delle sciagure dell’umanitá, era un entusiasta. Ogni affare che gli si addossava era grandissimo; ma egli voleva sempre apparir piú grande di tutti gli affari. Uomini tali sono sempre funesti, perché, non potendo o non sapendo soddisfare l’ambizione loro con azioni veramente grandi, si sforzano di fare apparir tali tutte quelle che possono e che sanno fare, e le corrompono.
Vanni incominciò ad acquistar fama di giudice integro e severissimo colla condotta che tenne col principe di Tarsia, il quale era stato per qualche anno direttore della fabbrica di seterie che il re avea stabilita in San Leucio. Il primo errore forse lo commise il re, affidando tale impresa al principe di Tarsia anziché ad un fabbricante; il secondo lo fu di Tarsia, il quale, non essendo fabbricante, non dovea accettar tale commissione. Ne avvenne quello che ne dovea avvenire. Tarsia era un onestissimo cavaliere, cioè un onestissimo spensierato, incapace di malversare un soldo, ma incapace al tempo istesso d’impedir che gli altri malversassero. Si trovò ne’ conti una mancanza di circa cinquantamila scudi. Fu data a Vanni la commissione di liquidare i conti. Non eravi affare piú semplice, perché Tarsia era un uomo che poteva e voleva pagare. Pure Vanni prolungò l’affare non so per quanti anni: cadde il trono, e l’affare di Tarsia ancora pendeva indeciso; ed intanto non eravi genere di vessazioni e d’insulti ai quali non sottoponesse la famiglia di Tarsia, perché, dicesi, tale era l’intenzione di Acton. Gli uomini di buon senso, alcuni dicevano: – Che imbecille! – altri: – Che impostore! – Ma nella corte si faceva dire: – Che giudice integro! Con quanto zelo, con quanta fermezza affronta il principe di Tarsia, un grande di Spagna, un grande officiale del palazzo! – Come se l’ingiustizia che si commette contro i grandi non possa derivar dalle stesse cagioni ed essere egualmente vile che quella che si commette contro i piccioli.
Si avea bisogno d’un inquisitor di Stato, e si scelse Vanni per la ragione istessa per la quale non si avrebbe dovuto scegliere. La prima volta che Vanni entrò nell’assemblea de’ magistrati che dovean giudicare, si mostrò tutto affannato, cogli occhi mezzo stralunati, e, raccomandando ai giudici la giustizia, soggiunse: – Son due mesi da che io non dormo, vedendo i pericoli che ha corsi il mio re. – “Il mio re”: questo era il modo col quale egli usava chiamarlo dopo che gli fu affidata l’inquisizione di Stato. – Il vostro re! – gli disse un giorno il presidente del Consiglio, Cito, uomo rispettabile e per la carica e per cento anni di vita irreprensibile – il vostro re! Che volete intender mai con questa parola, che, sotto apparenza di zelo, nasconde tanta superbia? E perché non dite “il nostro re”? Egli è re di tutti noi, e tutti l’amiamo egualmente. – Queste poche parole bastano per far giudicare di due uomini; ma, in un governo debole, colui che pronunzia piú alto “il mio re” suole vincere chi si contenta di dire “il nostro re”.
Lo sguardo di Vanni era sempre riconcentrato in se stesso; il colore del volto pallido-cinereo, come suole essere il colore degli uomini atroci; il suo passo irregolare e quasi a salti, il passo insomma della tigre: tutte le sue azioni tendevano a sbalordire ed atterrire gli altri; tutt’i suoi affetti atterrivano e sbalordivano lui stesso. Non ha potuto abitar di piú di un anno in una stessa casa, ed in ogni casa abitava al modo che narrasi de’ signorotti di Fera e di Agrigento. Ecco l’uomo che dovea salvare il Regno!
Ma la macchina di quattro anni dovea finalmente sciogliersi. Gl’interessati fremevano; gli uomini di buon senso ridevano di una nuova specie di delitto di Stato che in quattro anni d’inquisizione non si era ancora scoperto; nel popolaccio istesso andava raffreddandosi quel caldo che nei primi tempi avea mostrato contro i rei, e quasi incominciava a sentir pietá di tanti infelici, i quali non vedendo condannati, incominciava a credere innocenti. Acton, che da principio era stato il principal autore dell’inquisizione, dopo averne usato quanto bastava ai suoi disegni, vedendola innoltrar piú di quel che conveniva e non volendo e non potendo arrestarla, avea ceduto il suo luogo a Castelcicala. Costui, il piú vile degli uomini, avea bisogno, per guadagnare il favore della regina, di quel mezzo che Acton avea adoperato solo per atterrare i suoi rivali, ed in conseguenza dovea spingerne l’abuso piú oltre, e lo spinse. Fece di tutto perché la cabala non si scoprisse: giunse ad imputare a delitto la religiositá di coloro che diedero il voto per la veritá; giunse a minacciare un castigo agli avvocati da lui stesso destinati, perché difendevano i rei con zelo. Ma la nazione era oppressa e non corrotta, e, se diede grandi esempi di pazienza, ne diede anche moltissimi, ed egualmente splendidi, di virtú. Nulla potette smuovere la costanza de’ giudici e lo zelo degli avvocati. Quando si vide la veritá trionfare, ed uscir liberi quei che si volevano morti, Castelcicala, per giustificarsi agli occhi del pubblico e del re, il quale finalmente si era occupato di un tal affare, immolò Vanni, e tutta la colpa ricadde sopra costui.
Vanni avea accusati al re tutti i giudici, il presidente del Consiglio Mazzocchi, Ferreri, Chinigò, gli uomini forse i piú rispettabili che Napoli avesse e per dottrina e per integritá e per attaccamento al proprio sovrano; e un momento forse si dubitò se dovessero esser puniti questi tali o Vanni. Se Vanni rimaneva vincitore, avrebbe compíta l’opera della perdita del Regno e della rovina del trono. Per buona sorte era giunto all’estremo, e rovinò se stesso per aver voluto troppo. Ma, prima che ciò avvenisse, di quanti altri uomini utili avrebbe privato lo Stato, e quanti fedeli servitori avrebbe tolti al re? Quando anche il rovescio del trono di Napoli non fosse avvenuto per effetto della guerra, Vanni sarebbe bastato solo a cagionarlo, e lo avrebbe fatto.
Vanni fu deposto ed esiliato dalla capitale: si tentò di raddolcire in segreto il suo esilio, ma invano. L’anima ambiziosa di Vanni cadde in un furore melanconico, il quale finalmente lo spinse a darsi da se stesso una morte, che, per soddisfazione della giustizia e per bene dell’umanitá, avrebbe meritato da altra mano e molto tempo prima. La sua morte precedette di poco l’entrata de’ francesi in Napoli. Egli li temea, avea chiesta alla corte un asilo in Sicilia, e gli era stato negato. Prima di uccidersi scrisse un biglietto, in cui diceva: “L’ingratitudine di una corte perfida, l’avvicinamento di un nemico terribile, la mancanza di asilo mi han determinato a togliermi una vita che ormai mi è di peso. Non s’incolpi nessuno della mia morte; ed il mio esempio serva a render saggi gli altri inquisitori di Stato”. Ma gli altri inquisitori di Stato risero della sua morte, ne rise Castelcicala; e l’inquisizione continuò collo stesso furore, finché i francesi non furono a Capua.
VII
CAGIONI ED EFFETTI DELLA PERSECUZIONE
Io mi arresto; la mia mente inorridisce alla memoria di tanti orrori. Ma donde mai è nato tanto furore negli animi de’ sovrani d’Europa contro la rivoluzione francese? Molte altre nazioni aveano cangiata forma di governo; non vi è quasi secolo che non conti un cangiamento: ma né quei cangiamenti aveano mai interessati altri che le corti direttamente offese, né aveano prodotto nelle altre nazioni alcun sospetto ed alcuna persecuzione. Pochi anni prima, i saggi americani avean fatta una rivoluzione poco diversa dalla francese, e la corte di Napoli vi avea pubblicamente applaudito: nessuno avea temuto allora che i napolitani volessero imitare i rivoluzionari della Virginia. Il pericolo de’ sovrani è forse cresciuto in proporzione de’ loro timori?
I francesi illusero loro stessi sulla natura della loro rivoluzione, e credettero effetto della filosofia quello che era effetto delle circostanze politiche nelle quali trovavasi la loro nazione.
Quella Francia, che ci si presentava come un modello di governo monarchico, era una monarchia che conteneva piú abusi, piú contraddizioni: la rivoluzione non aspettava che una causa occasionale per iscoppiare. Grandi cause occasionali furono la debolezza del re, l’alterigia, or prepotente or debole anch’essa, della regina e di Artois, l’ambizione dello scellerato ed inetto Orléans, il debito delle finanze, Necker, l’Assemblea de’ notabili e, molto piú, gli Stati generali. Ma, prima che queste cagioni esistessero, eravi giá antica infinita materia di rivoluzione accumulata da molti secoli: la Francia riposava sopra una cenere fallace, che copriva un incendio devastatore.
Tra tanti che hanno scritta la storia della rivoluzione francese, è credibile che niuno ci abbia esposte le cagioni di tale avvenimento, ricercandole, non giá ne’ fatti degli uomini, i quali possono modificare solo le apparenze, ma nel corso eterno delle cose istesse, in quel corso che solo ne determina la natura? La leggenda delle mosse popolari, degli eccidi, delle ruine, delle varie opinioni, de’ vari partiti, forma la storia di tutte le rivoluzioni, e non giá di quella di Francia, perché nulla ci dice di quello per cui la rivoluzione di Francia differisce da tutte le altre. Nessuno ci ha descritto una monarchia assoluta, creata da Richelieu e rinforzata da Luigi decimoquarto in un momento; una monarchia surta, al pari di tutte le altre di Europa, dall’anarchia feudale, senza però averla distrutta, talché, mentre tutti gli altri sovrani si erano elevati proteggendo i popoli contro i baroni, quello di Francia avea nel tempo istesso nemici ed i feudatari, ivi piú potenti che altrove, ed il popolo ancora oppresso; le tante diverse costituzioni che ogni provincia avea; la guerra sorda ma continua tra i diversi ceti del regno; una nobiltá singolare, la quale, senza esser meno oppressiva di quella delle altre nazioni, era piú numerosa, ed a cui apparteneva chiunque voleva, talché ogni uomo, appena che fosse ricco, diventava nobile, ed il popolo perdea cosí financo la ricchezza; un clero, che si credeva essere indipendente dal papa e che non credeva dipendere dal re, onde era in continua lotta e col re e col papa; i gradi militari di privativa de’ nobili, i civili venali ed ereditari, in modo che all’uomo non nobile e non ricco nulla rimaneva a sperare; le dispute che tutti questi contrasti facevano nascere; la smania di scrivere, che indi nasceva e che era divenuta in Francia un mezzo di sussistenza per coloro i quali non ne avevano altro, e che erano moltissimi; la discussione delle opinioni a cui le dispute davan luogo ed il pericolo che dalle stesse opinioni nasceva, poiché su di esse eran fondati gl’interessi reali de’ ceti; quindi la massima persecuzione e la massima intolleranza per parte del clero e della corte, nell’atto che si predicava la massima tolleranza dai filosofi; quindi la massima contraddizione tra il governo e le leggi, tra le leggi e le idee, tra le idee e li costumi, tra una parte della nazione ed un’altra; contraddizione che dovea produrre l’urto vicendevole di tutte le parti, uno stato di violenza nella nazione intera, ed in séguito o il languore della distruzione o lo scoppio di una rivoluzione. Questa sarebbe stata la storia degna di Polibio(9).
La Francia avea nel tempo istesso infiniti abusi da riformare. Quanto maggiore è il numero degli abusi, tanto piú astratti debbono essere i princípi della riforma ai quali si deve rimontare, come quelli che debbono comprendere maggior numero di idee speciali. I francesi furono costretti a dedurre i princípi loro dalla piú astrusa metafisica, e caddero nell’errore nel qual cadono per l’ordinario gli uomini che seguono idee soverchiamente astratte, che è quello di confonder le proprie idee colle leggi della natura. Tutto ciò che avean fatto o volean fare credettero esser dovere e diritto di tutti gli uomini.
Chi paragona la Dichiarazione de’ diritti dell’uomo fatta in America a quella fatta in Francia, troverá che la prima parla ai sensi, la seconda vuol parlare alla ragione: la francese è la formola algebraica dell’americana. Forse quell’altra Dichiarazione che avea progettata Lafayette era molto migliore.
Idee tanto astratte portano seco loro due inconvenienti: sono piú facili ad eludersi dai scellerati, sono piú facili ad adattarsi a tutt’i capricci de’ potenti; i turbolenti e faziosi vi trovano sempre di che sostenere le loro pretensioni le piú strane, e gli uomini dabbene non ne ricevono veruna protezione. Chi guarda il corso della rivoluzione francese ne sará convinto.
I sovrani credettero, come i francesi, che la loro rivoluzione fosse un affare di opinione, un’opera di ragione, e la perseguitarono. Ignorarono le cagioni vere della rivoluzione francese e ne temettero gli effetti per quello stesso motivo per il quale non avrebbero dovuto temerli. Quando e dove mai la ragione ha avuto una setta? Quanto piú astratte sono le idee della riforma, quanto piú rimote dalla fantasia e da’ sensi, tanto meno sono atte a muovere un popolo. Non l’abbiamo noi veduto in Italia, in Francia istessa? Nel modo in cui i francesi aveano esposti i santi princípi dell’umanitá, tanto era sperabile che gli altri popoli si rivoluzionassero, quanto sarebbe credibile che le nostre pitture di ruote di carozze si perfezionino per i princípi di prospettiva dimostrati col calcolo differenziale ed integrale.
Se il re di Napoli avesse conosciuto lo stato della sua nazione, avrebbe capito che non mai avrebbe essa né potuto né voluto imitar gli esempi della Francia. La rivoluzione di Francia s’intendeva da pochi, da pochissimi si approvava, quasi nessuno la desiderava; e, se vi era taluno che la desiderasse, la desiderava invano, perché una rivoluzione non si può fare senza il popolo, ed il popolo non si move per raziocinio, ma per bisogno. I bisogni della nazione napolitana eran diversi da quelli della francese: i raziocini de’ rivoluzionari eran divenuti tanto astrusi e tanto furenti, che non li potea piú comprendere. Questo pel popolo. Per quella classe poi che era superiore al popolo, io credo, e fermamente credo, che il maggior numero de’ medesimi non avrebbe mai approvate le teorie dei rivoluzionari di Francia. La scuola delle scienze morali e politiche italiane seguiva altri princípi. Chiunque avea ripiena la sua mente delle idee di Machiavelli, di Gravina, di Vico, non poteva né prestar fede alle promesse né applaudire alle operazioni de’ rivoluzionari di Francia, tostoché abbandonarono le idee della monarchia costituzionale. Allo stesso modo la scuola antica di Francia, quella per esempio di Montesquieu, non avrebbe applaudito mai alla rivoluzione. Essa rassomigliava all’italiana, perché ambedue rassomigliavan molto alla greca e latina.
In una rivoluzione è necessitá distinguere le operazioni dalle massime. Quelle sono figlie delle circostanze, le quali non sono mai simili presso due popoli; queste sono sempre piú diverse di quelle, perché il numero delle idee è sempre molto maggiore di quello delle operazioni ed, in conseguenza, piú facile la diversitá, piú difficile la rassomiglianza. Non vi è popolo il quale non conti nella sua storia molte rivoluzioni: quando se ne paragonano le operazioni, esse si trovan somiglianti: paragonate le idee e le massime, si trovano sempre diversissime.
Chiunque vede una rivoluzione in uno Stato vicino deve temere o delle operazioni o delle idee. I mezzi per opporsi alle operazioni sono tutti militari: qualunque sieno le idee che due popoli seguono, vincerá quello che saprá meglio far la guerra; e quello la fará meglio, che avrá migliori ordini, piú amor di patria, piú valore e piú disciplina. Il mezzo per opporsi al contagio delle idee (lo dirò io?) non è che un solo: lasciarle conoscere e discutere quanto piú sia possibile. La discussione fará nascere le idee contrarie: è effetto dell’amor proprio: due uomini sono sempre piú concordi al principio della discussione che alla fine. Nate una volta queste massime contrarie, prenderanno il carattere di massime nazionali; accresceranno l’amor della patria, perché quelle nazioni piú ne hanno che piú differiscono dalle altre: accresceranno l’odio contro le nazioni straniere, la fiducia nelle proprie forze, l’energia nazionale; non solamente si eviterá il contagio delle opinioni, ma si riparerá anche alla forza delle operazioni. Mi si dice che il marchese del Gallo, quando ebbe letto l’elenco di coloro che trovavansi arrestati per cospiratori, ridendone al pari di tutti i buoni, propose al re di mandarli viaggiando. – Se son giacobini – egli diceva, – mandateli in Francia: ne ritorneranno realisti.- Questo consiglio è pieno di ragione e di buon senso, e fa onore al cuore ed alla mente del marchese del Gallo. Vince una rivoluzione colui che meno la teme. I sovrani colla persecuzione fanno diventar sentimenti le idee, ed i sentimenti si cangiano in sètte: il loro timore li tradisce, e cadono talora vittime delle stesse loro precauzioni eccessive. Si proibirono in Napoli tutti i fogli periodici: si voleva che il popolo non avesse neanche novella de’ francesi. Cosí un oggetto, che, osservato da vicino, avrebbe destato pietá o riso, fu come il fascio di sarmenti di Esopo, che dall’alto mare sembrava un vascello. Un’indomabile curiositá ne spinge a voler conoscere ciò che ci si nasconde, e l’uomo suppone sempre piú belle e piú buone quelle cose che sono coperte da un velo.
Ma io immagino talora, invece de’ nostri re, nelle crisi attuali dell’Europa, Filippo di Macedonia. La Grecia a’ di lui tempi era divisa tra i spartani ed ateniesi, i quali facevano la guerra per opinioni di governo ed uniti ai filosofi, che in quell’epoca discutevano le costituzioni greche, come appunto oggi li nostri filosofi discutono le nostre, stancavano i greci con guerre sanguinose e con cavillose dottrine. Cosí sempre suole avvenire: tra le varie rivoluzioni si obbliano le antiche idee, si perdono i costumi e, ridotte una volta le cose a tale stato, gli intriganti, tra’ quali i potenti tengono il primo luogo, guadagnano sempre, perché alla fine i popoli si riducono a seguir quelli che loro offrono maggiori beni sul momento; e cosí il massimo amore della libertá, producendo l’esaltazione de’ princípi, ne accelera la distruzione e rimena una piú dura servitú. Filippo con tali mezzi acquistò l’impero della Grecia.
È una disgrazia pel genere umano quando la guerra porta seco il cambiamento o della forma di governo o della religione: allora perde il suo oggetto vero, che è la difesa di una nazione, ed ai mali della guerra esterna si aggiungono i mali anche piú terribili dell’interna. Allora lo spirito di partito rende la persecuzione necessaria, e la persecuzione fomenta nuovo spirito di partito; allora sono que’ tempi crudeli anche nella pace. L’alta Italia ci ha rinnovati gli stessi esempi di Sparta ed Atene, quando le sue repubbliche, invece di restringersi a difender la loro costituzione, sotto il nome or di guelfi or di ghibellini, vollero riformare l’altrui; e gli stessi errori ebbero nell’Italia gli stessi effetti. Scala, Visconti, Baglioni, ecc., rinnovarono gli esempi di Filippo.
Tali epoche politiche sono meno contrarie di quello che si crede ai sovrani che sanno regnare. Ma in tali epoche vince sempre il piú umano, ed io oso dire il piú giusto. Oggi i repubblicani sono piú generosi e perdonano ai realisti; i re con una stolta crudeltá non dánno veruna tregua ai repubblicani: questo fará sí che essi avranno in breve freddi amici ed accaniti nemici. Quando l’armata del pretendente scese in Inghilterra, faceva impiccare tutt’i prigionieri di Hannover; Giorgio liberava tutt’i prigionieri del pretendente: questo solo fatto, dice molto bene Voltaire, basta a far decidere della giustizia de’ due partiti, pronosticare la loro sorte futura(10).
VIII
AMMINISTRAZIONE
Mentre da una parte con tali arti si avviliva e si opprimeva la nazione, dall’altra si ammiseriva col disordine in tutt’i rami di amministrazione pubblica. La nazione napolitana dalla venuta di Carlo terzo incominciava a respirare dai mali incredibili che per due secoli di governo viceregnale avea sofferti. Fu abbassata l’autoritá de’ baroni, che prima non lasciava agli abitanti né proprietá reale né personale. Si resero certe le imposizioni ordinarie con un nuovo catasto, il quale, se non era il migliore che si potesse avere, era però il migliore che fino a quel tempo si fosse avuto, e si abolí l’uso delle imposizioni straordinarie che, sotto il nome di “donativi”, avean tolte somme immense alla nazione, passate senza ritorno nella Spagna(11). Libera la nazione dalle oppressioni de’ baroni, dalle avanie del fisco, dalla perenne estrazione di denaro, incominciò a sviluppare la sua attivitá: si vide risorgere l’agricoltura, animarsi il commercio; la sussistenza divenne piú agiata, i spiriti piú colti, gli animi piú dolci. L’esserci noi separati dalla Spagna, e l’essersi la Spagna tolta alla famiglia di Austria e data a quella di Borbone, ed il patto di famiglia avean reso alla nostra nazione quella pace di cui avevamo bisogno per ristorarci dai mali sofferti; e la neutralitá, che ci fu permessa di serbare nell’ultima guerra tra la Spagna, la Francia e l’Inghilterra per le colonie americane, prodotto avea nella nostra nazione un aumento considerabile di ricchezze. In cinquant’anni avevamo fatti progressi rapidissimi, e vi era ragione di sperare di doverne fare anche di piú.
La nostra nazione passava, per cosí dire, dalla fanciullezza alla sua gioventú. Ma questo stato di adolescenza politica è appunto lo stato piú pericoloso e quello da cui piú facilmente si ricade nel languore e nella desolazione. Le nazioni escono dalla barbarie accrescendo le loro forze e rendendo cosí la sussistenza sicura: non passano alla coltura se non accrescendo i loro bisogni. Ma i bisogni si sviluppano piú rapidamente delle forze, tra perché essi dipendono dalle sole nostre idee, tra perché le altre nazioni, senza comunicarci le loro forze, ci comunicano volontieri le idee, i loro costumi, gli ordini ed i vizi loro, il che per noi diventa sorgente di nuovi bisogni; e, se allora, crescendo questi, non si pensa anche ad accrescer le nostre forze, noi non avremo mai quell’equilibrio di forze e di bisogni, nel che solo consiste la sanitá degl’individui e la prosperitá delle nazioni: i passi che faremo verso la coltura non faranno che renderci servi degli stranieri, ed una coltura precoce e sterile diventerá per noi piú nociva della barbarie. Uno Stato che non fa tutto ciò che può fare è ammalato. Tale era lo stato di tutta l’Italia; e questo stato era piú pericoloso per Napoli, perché piú risorse avea dalla natura e piú estesa era la sfera della sua attivitá.
Ma il governo di Napoli avea perduto gran parte delle sue forze, sopprimendo lo sviluppo delle facoltá individuali coll’avvilimento dello spirito pubblico: tutto rimaneva a fare al governo, ed il governo non sapea far nulla, né potea far tutto.
Le nazioni ancora barbare amano di essere sgravate dai tributi, perché non hanno desidèri superflui; le nazioni colte si contentano di pagar molto, purché quest’aumento di tributo accresca la forza e migliori la sussistenza nazionale. Il segreto di una buona amministrazione è di far crescere la riproduzione in proporzione dell’esazione: non è tanto la somma de’ tributi, quanto l’uso de’ medesimi per rapporto alla nazione, quello che determina lo stato delle sue finanze(12).
Un governo savio ed attivo avrebbe corretti gli antichi abusi di amministrazione, avrebbe sviluppata l’energia nazionale, ci avrebbe esentati dai vettigali che pagavamo agli esteri per le loro manifatture, avrebbe protette le nostre arti, migliorate le nostre produzioni, esteso il nostro commercio: il governo sarebbe divenuto piú ricco e piú potente, e la nazione piú felice. Questo era appunto quello che la nazione bramava(13). L’epoca in cui giunse Acton era l’epoca degli utili progetti: qual “progettista” egli si spacciò e qual “progettista” fu accolto; ma i suoi progetti, ineseguibili o non eseguiti o eseguiti male, divennero cagioni di nuove ruine, perché cagioni di nuove inutili spese.
Acton ci voleva dare una marina. La natura avea formata la nazione per la marina, ma non aveva formato Acton per la nazione. La marina dovea prima di tutto proteggere quel commercio che allora avevamo, il quale, essendo di derrate e quasi tutte privative del Regno, o poca o niuna gelosia dar potea alle altre nazioni, le quali per lo piú un commercio aveano di manifatture. I nostri nemici erano i barbareschi, contro i quali non valeva tanto la marina grande quanto la piccola marina corsara, che Acton distrusse(14). La marina armata dovea crescere in proporzione della marina mercantile e del commercio, senza di cui la marina guerriera è inutile e non si può sostenere. Acton, invece di estendere il nostro commercio, lo restrinse coi suoi errori diplomatici, col suo genio dispotico, colla sua mala fede, colla viltá con cui sposò gl’interessi degli stranieri in pregiudizio de’ nostri. Acton non conosceva né la nazione né le cose. Voleva la marina, ed intanto non avevamo porti, senza de’ quali non vi è marina: non seppe nemmeno riattare quei di Baia e di Brindisi, che la natura istessa avea formati, che un tempo erano stati celebri e che poteano divenirlo di nuovo con piccolissima spesa, se, invece di seguire il piano delle creature di Acton, si, fosse seguíto il piano dei romani, che era quello della natura.
La marina, come Acton l’avea immaginata, era un gigante coi piedi di creta. Era troppo piccola per farci del bene, troppo grande per farci del male: eccitava la rivalitá delle grandi potenze, senza darci la forza necessaria, non dico per vincere, ma almeno per poter resistere. Senza marina, saremmo rimasti in una pace profonda: con una marina grande, avremmo potuto vincere; ma, con una marina piccola, dovevamo, o presto o tardi, siccome poi è avvenuto, esser trascinati nel vortice delle grandi potenze, soffrendo tutt’i mali della guerra, senza poter mai sperare i vantaggi della vittoria.
Lo stesso piano Acton seguí nella riforma delle truppe di terra. Carlo terzo ne avea fissato il numero a circa trentamila uomini; ma, come sempre suole avvenire nei piccoli Stati, i quali godono lunghissima pace, gli ordini di guerra si erano rilasciati, e di truppe effettive non esistevano piú di quindicimila uomini. Noi mancavamo assolutamente di artiglieria. Questa fu organizzata in modo da non lasciarci nulla da invidiare agli esteri. Ma il numero delle altre truppe fu accresciuto solo in apparenza, per ricoprire un’alta malversazione ed una profusione la quale non avea né leggi né limiti. Acton piú degli altri ministri vi si era prestato; e questa non fu l’ultima delle ragioni per cui meritò tanta protezione sí potente e sí lunga.
Dalla morte di Iaci(15) incominciarono le riforme di abiti e di tattica. Veniva ogni anno dalla Spagna, dalla Francia, dalla Germania, dalla Svizzera un nuovo generale, il quale ora rialzava di due pollici il cappello, ora raccorciava di due dita l’uniforme, ora… Il soldato fremeva, vedendosi sottoposto a tante novitá, che un anno dopo sapeva doversi dichiarare inutili(16).
Questi generali conducevan sempre seco loro degli stranieri, i quali occupavano i primi gradi della truppa. Gli altri erano accordati agli allievi del collegio militare, dove la gioventú era invero bene istruita nelle cognizioni militari, ma non acquistava certamente né quel coraggio né quella sofferenza delle fatiche, che si acquista solo coll’etá e coi lunghi servigi. Il genio e le cognizioni debbono formare i generali: ma il coraggio e l’amor della fatica formano gli uffiziali. Il gran principio: che in tempo di pace l’anzianitá debba esser la norma delle promozioni, non era confacente al genio di Acton, il quale, quando non avesse avuto il dispotismo nel cuore, l’avea nella testa. Si videro vecchi capitani, abbandonati alla loro miseria, dover ubbidire a giovanetti inesperti e deboli, i quali non sapevano altro che la teoria, ed a molti altri (poiché, tolta una volta la norma sensibile del giusto, si apre il campo al favore ed all’intrigo), i quali non sapevano neanche la teoria, ma che, a forza di danaro, di spionaggio e di qualche titolo anche piú infame dello spionaggio, erano stati elevati a quel grado. I gradi, che non si potevano occupare da costoro, rimasero vuoti, e si videro de’ reggimenti interi mancare della metá degli officiali, mentre coloro che dovevan esser promossi domandavano invano il premio delle loro fatiche. Acton rispondeva a costoro che “aspettassero la pubblicazione del loro piano”; piano ammirabile, che costò ad Acton venti anni di meditazione e che, senza esser mai stato pubblicato, ha disorganizzata la truppa, disgustata la nazione, dissipato l’erario dello Stato!
Tutto nel regno di Napoli era malversazione o progetti chimerici piú nocivi della malversazione; ed intanto ciò che era necessario non si faceva. Noi avevamo bisogno di strade: il marchese della Sambuca ne vide la necessitá, fu posta una imposizione di circa trecentomila ducati all’anno: l’opera fu incominciata, se ne fecero taluni spezzoni; ma poco di poi l’opera fu sospesa e la contribuzione convertita ad un altro uso. Province intere chiesero il permesso di costruirsi le strade a loro spese, promettendo intanto di continuare a pagare alla corte, sebbene giá convertita ad altro uso, l’imposizione che era addetta alle strade; promettendo pagarla per sempre, ancorché, quando s’impose, si fosse promesso di dover finire colla costruzione delle strade. Si crederebbe che questo progetto fosse stato rifiutato? Si può immaginare nazione piú ragionevole e piú buona e ministero piú stolidamente scellerato? Vi erano nel regno di Napoli alcuni errori nelle massime ed alcuni vizi nell’organizzazione, i quali impedivano i progressi della pubblica felicitá. Avean data origine ai medesimi altri tempi ed altre circostanze: le circostanze e i tempi eransi cangiati, ma gli errori ed i vizi sussistevano ancora.
Simile a tutt’i governi i quali hanno un impero superiore alle proprie forze, il governo di Spagna, ne’ tempi della dinastia austriaca, avea procurato di distruggere ciò che non poteva conservare. Si era estinto ogni valor militare. A contenere una nobiltá generosa e potente, il primo de’ viceré spagnuoli, Pietro di Toledo, credette opportuno invilupparla tra i lacci di una giurisprudenza cavillosa la quale, nel tempo istesso che offriva facili ed abbondanti ricchezze a coloro che non ne avevano, spogliava quegli che ne abbondavano e moltiplicava oltre il dovere una classe di persone pericolose in ogni Stato, perché potevano divenir ricche senza esser industriose o, ciò che val lo stesso, senza che la loro industria producesse nulla. Tutti gli affari del Regno si discussero nel fòro, e nel fòro si disputò sopra tutti gli affari. Derivaron da ciò molti mali. Tutto ciò che non era materia di disputa forense fu trascurato: agricoltura, arti, commercio, scienze utili, tutto ciò fu considerato piuttosto come oggetto di sterile o voluttuosa curiositá che come studi utili alla prosperitá pubblica e privata. Si è letto per qualche secolo sulla porta delle nostre scuole un distico latino, nel quale la goffaggine dello stile eguagliava la stoltezza del pensiero, e che diceva: “Galeno dá le ricchezze, Giustiniano dá gli onori; tutti gli altri non dánno che paglia”. E, se mai taluno, ad onta della mancanza di istruzione, concepiva qualche idea di pubblica utilitá, non poteva eseguirla senza prima soggettarsi ad un esame, il quale, perché fatto innanzi a giudici e con tutte le formole giudiziarie, diventava litigio. Si voleva fare un ponte? si dovea litigare. Si voleva fare una strada? si dovea litigare. Ciascuno del popolo ha in Napoli il diritto di opporsi al bene che voi volete fare.
Carlo terzo fece grandissimi beni al Regno: egli riordinò l’amministrazione della giustizia, tolse gli abusi della giurisdizione ecclesiastica, frenò quelli della feudale, protesse le arti e l’industria; e piú bene avrebbe fatto, se il suo regno fosse stato piú lungo e se molti de’ ministri, che lo servivano, non avessero ancora seguite in gran parte le massime dell’antica politica spagnuola. Tanucci, per esempio, il di lui amico, quello tra’ suoi ministri a cui piú deve il Regno, errava credendo che il regno di Napoli non dovesse esser mai un regno militare. È nota la risposta che egli soleva dare a chiunque gli parlava di guerra: – Principoni, armate e cannoni; principini, ville e casini. – La sua massima era falsa, perché né il re di Napoli poteva chiamarsi “principino”, né i principini sono dispensati della cura della propria difesa. Tanucci, piú diplomatico che militare, confidava piú ne’ trattati che nella propria forza; ignorava che la sola forza è quella che fa ottener vantaggiosi trattati; ignorava la forza del Regno che amministrava ed, invece di un’esistenza propria e sicura, gliene dava una dipendente dall’arbitrio altrui ed incerta.
Continuò Tanucci a confondere il potere amministrativo ed il giudiziario, ed il fòro continuò ad esser il centro di tutti gli affari. Il potere giudiziario tende, per sua intrinseca natura, a conservar le cose nello stato nel quale si trovano; l’amministrativo tende a sempre cangiarle, perché tende sempre a migliorarle: il primo pronunzia sempre sentenze irrevocabili; il secondo non fa che tentativi, i quali si possono e talora si debbono cangiare ogni giorno. Se questi due poteri, per loro natura tanto diversi, li riunite, corrompete l’uno e l’altro.
Tutto in Napoli si dovea fare dai giudici e per vie giudiziarie; e da questo ne veniva che tutte le operazioni amministrative eran lente e riuscivan male. Il governo era tanto lontano dalle vere idee di amministrazione, che i vari oggetti della medesima o non erano affidati a nessuno o erano commessi agli stessi giudici; quindi l’utile amministrazione o non avea chi la promovesse o era promossa languidissimamente da coloro che avean tante altre cose da fare.
L’altro difetto, che vi era nell’organizzazione del governo di Napoli, era la mancanza di un centro comune, al quale, come tanti raggi, andassero a finir tutti i rami dell’amministrazione. Questo centro avrebbe dovuto essere il Consiglio di Stato. Ma Consiglio di Stato in Napoli non vi era se non di nome. Ciascun ministro era indipendente. I regolamenti generali, i quali avrebbero dovuto essere il risultato della deliberazione comune di tutt’i ministri, ciascun ministro li faceva da sé: in conseguenza, ciascun ministro li faceva a suo modo; i regolamenti di un ministro eran contrari a quelli di un altro, perché la principal cura di ogni ministro era sempre quella di usurpar quanto piú poteva l’autoritá de’ suoi colleghi e distruggere le operazioni del suo antecessore. Cosí non vi era nelle operazioni del governo né unitá né costanza: il ministro della guerra distruggeva ciò che faceva il ministro delle finanze, e quello delle finanze distruggeva ciò che faceva il ministro della guerra. Tra tanti ministri eravi sempre (e questo era inevitabile) uno piú innanzi di tutti gli altri nel favor del sovrano, e questo ministro era quegli che dava, come suol dirsi, il “tono” ed il “carattere” a tutti gli affari; tono e carattere che un momento di poi cangiava, perché cangiava il favore. Né valeva, ad assicurar la durata di un regolamento o di una legge, la ragionevolezza della medesima. Vi fu mai legge piú giusta di quella che obbligava i giudici a ragionar le loro sentenze, onde esse fossero veramente sentenze e non capricci? Tanucci avea imposta questa obbligazione ai giudici: Simonetti ne li sciolse. Si può credere che Simonetti pensasse di buona fede che i giudici non fossero obbligati a ragionare e ad ubbidire alla legge? Simonetti dunque tradí la sua propria coscienza, tradí il re, perché la legge, che egli abolí, non era opera sua, ma bensí di Tanucci.
Gli esempi di simili cose sarebbero infiniti di numero, ma io mi son limitato a questo solo, perché, siccome esso urta evidentemente il senso comune, basta a dimostrare che i difetti di organizzazione de’ quali parliamo erano spinti tanto innanzi, da non rispettar piú neanche il senso comune. Si aggiunga a ciò che tutt’i ministri erano ministri di giustizia, imperciocché l’amministrazione della giustizia non era ordinata in modo che seguisse la natura delle cose o delle azioni, ma seguiva ancora, come avveniva presso i barbari del Settentrione, nostri antenati, la natura delle persone: la giustizia era diversa pel militare, pel prete, per l’uomo che possedeva una greggia, per l’uomo che non ne possedeva, ecc. ecc. Si eran moltiplicate in Napoli le corti giudicatrici piú che non furono moltiplicati in Roma gl’iddii ai tempi di Cicerone, per cui questo grand’uomo si doleva di non potersi fare un passo senza timore di urtare qualche divinitá; e, nel contrasto continuo tra tanti tribunali, spesso era ben difficile sapere da qual di essi uno dovesse esser giudicato. Io ho degli esempi di “quistioni di tribunale”, le quali han durato diciotto anni.
Nuovi disordini, e maggiori. In una monarchia, quello che nella giurisprudenza romana chiamavasi “rescritto del principe” deve avere vigore di legge; ma i principi saggi fanno pochissimi rescritti e non mai per altro che per alcuni casi particolari, onde è che in tutte le monarchie trovasi, per legge quasi fondamentale dello Stato, stabilito che il rescritto non debba mai trasportarsi da un caso all’altro. Nel regno di Napoli i rescritti eransi moltiplicati all’infinito: ciascun ministro ne faceva, e ciascun ministro faceva rescritti invece di leggi. Come sempre suole avvenire, i rescritti eran l’opera de’ commessi, e vi è stato tra essi taluno il quale per molti anni è stato il vero, il solo legislatore di tutto il Regno.
Io mi trattengo molto sopra queste che sembran picciole cose, perché da esse dipendono le grandi. Cambiate le prime, ed imaginate che Tanucci avesse compresa tutta la potenza del Regno e vi avesse stabiliti ordini ed educazione militare; che il potere amministrativo fosse stato diviso dal giudiziario, e divenuto quello piú attivo, questo piú regolare; che tutte le parti dell’amministrazione avessero avuto un centro comune, un Consiglio permanente, alla testa del quale fosse stato il re; e che i ministri, non piú indipendenti l’uno dall’altro e tutti rivali, fossero stati costretti ad operare dietro un piano uniforme e costante; imaginate, insomma, che il re, invece di lasciar preponderare or questo or quell’altro ministro, avesse voluto esser veramente re; e tutto allora sarebbe cambiato. Imperciocché io son persuaso che, nello stato presente delle idee e de’ costumi dell’Europa, rarissimo e forse impossibile a trovarsi sia un re il quale non voglia il bene del suo regno: ma questo bene non si fa produrre, perché deve farsi dai ministri, i quali amano piú il posto che il regno e piú la persona propria che il posto. È necessitá dunque costringerveli colla forza degli ordini pubblici, il vero fine de’ quali, per chi intende, non è altro che garantire il re contro la negligenza e la mala volontá de’ ministri. Con picciolissime riforme voi producete un grandissimo bene, e tutte le riforme di uno Stato tendono ad un sol fine, cioè che il re sia veramente re. Ma, per questa ragione, a tali riforme i ministri si oppongono sempre; onde poi i mali diventano maggiori, ed inevitabili quelle grandissime crisi, per le quali spesso s’immolano dieci generazioni per rendere forse felice l’undecima. Veritá funesta e per i principi e per i popoli! Le rovine di quelli e di questi per l’ordinario sono l’effetto de’ ministri e di coloro che si millantano amici dei re(17).
IX
FINANZE
Chi paragona la somma de’ tributi che noi pagavamo con quella che pagavano le altre nazioni di Europa, crederá che noi non eravamo i piú oppressi. Chi paragona la somma delle imposizioni che noi pagavamo ai tempi di Carlo terzo con quella che poscia pagammo ai tempi di Ferdinando, vedrá forse che la differenza tra quella e questa non era grandissima. Ma intanto i bisogni della nazione eran cresciuti, erano cresciuti i bisogni della corte: quella veniva a pagare piú, perché in realtá avea meno superfluo; questa veniva ad esiger meno. Il poco che esigeva era malversato; non si pensava a restituire alla nazione ciocché da lei si prendeva; era facile il prevedere che tra poco le rendite non erano bastanti, ed il bisogno delle nuove imposizioni sarebbe stato tanto maggiore nella corte quanto maggiore sarebbe stata nel popolo l’impotenza di pagarle.
S’incominciò dal cangiare per specolazione taluni dazi indiretti, i quali sembravano gravosi (tali erano, per esempio, quelli sul tabacco e sulla manna), e furono commutati in dazi diretti, che rendevano quasi il doppio. S’impose un dazio sulla caccia, che fino a quell’epoca era stata libera; ma non si pensò a regolarla, perché il dazio interessava la corte ed il regolamento interessava la nazione. S’impose un dazio sull’estrazione de’ nostri generi, mentre se ne doveva imporre uno sull’introduzione de’ generi esteri. Si ricorse finanche alla risorsa della “crociata”, di cui non credo che vi possa essere risorsa piú vile, o che il governo creda o che non creda esser dell’onore della divinitá de’ cattolici che in taluni giorni dell’anno si mangino solo alcuni cattivi cibi che ci vendono gli eretici.
Si ricercarono per tutto il Regno i fondi che due, tre, quattro, dieci secoli prima erano stati posseduti dal fisco, e si aprí una persecuzione contro le cose non meno crudele di quella contro le persone. Finché questa persecuzione fu contro i soli feudatari ed ecclesiastici, fu tollerabile; ma gli agenti del fisco, dopo che ebbero assicurato il dominio, come essi dicevano, del re, annullarono spietatamente tutt’i contratti e, beffandosi di ogni buona fede, turbarono il povero colono, il quale fu costretto a ricomprarsi con una lite o col danaro quel terreno che era stato innaffiato dal sudore de’ suoi maggiori e che formar dovea l’unica sussistenza de’ figli suoi.
Forse un giorno non si crederá che il furore delle revindiche era giunto a segno che i cavalieri dell’ordine costantiniano, immaginando non so qual parentela tra Ferdinando quarto, gran maestro dell’ordine, e sant’Antonio abate, diedero a credere al re che tutt’i beni, i quali nel Regno fossero sotto l’invocazione di questo santo, si appartenessero a lui; ed egli, in ricompensa del consiglio e delle cure che mettevano i cavalieri in ricercare tali beni ovunque fossero, credette utile allo Stato, ed in conseguenza giusto, toglier tali beni a coloro che utilmente li coltivavano, e darli ad altri, i quali, essendo cavalieri costantiniani, avevano il diritto di vivere oziosi.
Le municipalitá presso di noi avevano molti fondi pubblici, che le stesse popolazioni amministravano, la rendita de’ quali serviva a pagare i pubblici pesi. Molti altri ve n’erano, sotto nome di “luoghi pii”, addetti alla pubblica beneficenza, fin da que’ tempi ne’ quali la sola religione, sotto nome di “caritá”, potea indurre gli uomini a far un’opera utile a’ loro simili ed il solo nome di un santo potea raffrenar gli europei ancora barbari dall’usurparli. Mille abusi ivi erano, e nell’oggetto e nell’amministrazione di tali fondi; ma essi intanto formavano parte della ricchezza nazionale, ed il privarne la nazione, senza che altronde avesse avuto niun accrescimento di arti e di commercio onde supplirvi, era lo stesso che impoverirla. Il tempo, che tutt’i mali riforma meglio dell’uomo, avrebbe corretto anche questo.
Una parte di questi fondi pubblici fu occupata dalla corte, e questo non fu il maggior male; l’altra, sotto pretesto di essere male amministrata dalle popolazioni, fu fatta amministrare dalla Camera de’ conti e da un tribunale chiamato “misto”, ma che, nella miscela de’ suoi subalterni, tutt’altro avea che gente onesta. L’amministrazione dalle mani delle comuni passò in quelle de’ commessi di questi tribunali, i quali continuarono a rubare impunemente, e tutto il vantaggio, che dalle nuove riforme si ritrasse, fu che si rubò da pochi, dove prima si rubava da molti; si rubò dagli oziosi, dove prima si rubava dagl’industriosi; il danaro fu dissipato tra i vizi ed il lusso della capitale, dove che prima s’impiegava nelle province; la nazione divenne piú povera, e lo Stato non divenne piú ricco.
Lo stesso era avvenuto per i fondi allodiali e gesuitici(18). Tutto nel regno di Napoli tendeva alla concentrazione di tutt’i rami di amministrazione in una sola mano. Ma questa mano, non potendo tutto fare da sé, dovea per necessitá servirsi di agenti non fedeli, e la nazione allora cade in quel deplorabile stato, in cui dagl’impieghi sperasi non tanto l’onore di servir la patria quanto il diritto di spogliarla. Allora la nazione è inondata da quelle “vespe” giudicatrici, che tanto ci fanno ridere sulle scene di Aristofane.
La nostra capitale incominciava ad essere affollata da quest’insetti, i quali, colla speranza di un miserabile impiego subalterno, trascurano ogni fatica: intanto i vizi ed i capricci crescono coll’ozio, ed, il miserabile soldo che hanno non crescendo in proporzione, sono costretti a tenere nell’esercizio del loro impiego una condotta la quale accresca la loro fortuna a spese della fortuna dello Stato e del costume della nazione. Io giudico della corruzione di un governo dal numero di coloro che domandano un impiego per vivere: l’onesto cittadino non dovrebbe pensare a servir la patria se non dopo di avere giá onde sussistere. Roma, nell’antica santitá de’ suoi costumi, non concedeva ad altri quest’onore. Cosí il disordine dell’amministrazione è la piú grande cagione di pubblica corruzione.
Sul principio il disordine nelle finanze attaccò i piú ricchi; ma, siccome la loro classe formava anche la classe degl’industriosi, e da questi il rimanente del popolo viveva, cosí il disordine attaccò l’anima dello Stato, e tra poco tutte le membra doveano risentirsene egualmente.
Nulla bastava alla corte di Napoli. Non bastò il danaro ritratto dallo spoglio delle Calabrie; si rimisero in uso i “donativi”; non passò anno senza che ve ne fosse uno. Finalmente neanche i “donativi” furono sufficienti, ed incominciaron le operazioni de’ banchi.
I banchi di Napoli erano depositi di danaro di privati, ai quali il governo non prestava altro che la sua protezione. Erano sette corpi morali, che tutti insieme possedevano circa tredici milioni di ducati ed ai quali la nazione ne avea affidati ventiquattro. Le loro carte godevano il massimo credito, tra perché ipotecate sopra fondi immensi, tra perché un corpo morale si crede superiore a quegli accidenti a cui talora va soggetto un privato, tra perché tenevano sempre i banchi il danaro di cui si dichiaravano per depositari e che non potevano convertire in altro uso. Fino al 1793 essi furono riputati sacri.
La regina pensò da banchi privati farli diventar banchi di corte. Il primo uso che ne fece fu di gravarli di qualche pensione in beneficio di qualche favorito; il secondo fu di costringerli a far degl’imprestiti a qualche altro favorito meno vile o piú intrigante; il terzo, di far contribuire grosse somme per i progetti di Acton, che si chiamavano “bisogni dello Stato”, quasi che il danaro dei banchi non fosse danaro di quegl’istessi privati ch’erano stati giá tassati. Indi incominciarono le operazioni segrete. Si fecero estrazioni immense di danaro: quando non vi fu piú danaro, si fecero fabbricar carte, onde venderle come danaro. Le carte circolanti giungevano a circa trentacinque milioni di ducati, de’ quali non esisteva un soldo.
Allora incominciò un agio fino a quel tempo ignoto alla nazione, e che in breve crebbe a segno di assorbire due terzi del valore della carta. La corte, lungi dal riparare al male allorché era sul nascere, l’accrebbe, continuando tutto giorno a metter fuori delle carte vuote e facendole convertire in contanti per mezzo de’ suoi agenti a qualunque agio ne venisse richiesto. Si vide lo stesso sovrano divenir agiotatore: se avesse voluto far fallire una nazione nemica, non potea fare altrimenti.
L’agio era tanto piú pesante quanto che non si trattava di biglietti di azione, non di biglietti di corte, la sorte de’ quali avesse interessati soli pochi renditieri; si trattava di attaccare in un colpo solo tutto il numerario e di rovesciar tutte le proprietá, tutto il commercio, tutta la circolazione di una nazione agricola, la quale di sua natura ha sempre la circolazione piú languida delle altre. La corte si scosse quando il male era irreparabile. Diede i suoi allodiali per ipoteca delle carte vuote; ma né que’ fondi potean ritrovare cosí facilmente compratori, né, venduti, riparato avrebbero alla mala fede. Conveniva persuadere al popolo che di carte vuote non se ne sarebbero piú fatte, cioè conveniva persuadere o che la corte non avrebbe avuto piú bisogno o che, avendo bisogno, non avrebbe adoperato l’espediente di far nuove carte. Lo stato delle cose avrebbe fatto temere il bisogno, la condotta della corte faceva dubitar della sua fede. Come fidarsi di una corte, la quale, avendo giá incominciata la vendita de’ beni ecclesiastici, invece di lacerar due milioni e mezzo di carte ritratte dalla vendita, li rimise di nuovo in circolazione? Cosí questa porzione di debito pubblico venne a duplicarsi, poiché rimasero a peso della nazione le carte e si alienò l’equivalente de’ fondi.
Non manca taluno, il quale ha creduto la vendita de’ beni ecclesiastici essere stata effetto, non giá di cura che si avesse di riempire il vuoto de’ banchi, ma bensí di timore che essi servissero di pretesto e di stimolo ad una rivoluzione. Quanto meno vi sará da guadagnare, dicevasi, tanto minore sará il numero di coloro che desiderano una rivoluzione. L’uomo che si dice autor di questo consiglio conosceva egli la rivoluzione, gli uomini, la sua patria?
X
Continuazione. – COMMERCIO
Il disordine de’ banchi, quindici anni prima, forse o non vi sarebbe stato o sarebbe stato piú tollerabile, perché la nazione avea allora un erario sufficiente a riempire il vuoto che ne’ banchi si faceva, o almeno a mantenervi sempre tanto danaro quanto era necessario per la circolazione. È una veritá riconosciuta da tutti, che ne’ pubblici depositi può mancare una porzione del contante senza che perciò la carta perda il suo credito; ma conviene che la circolazione sia in piena attivitá e che, mentre una parte della nazione restituisce le sue carte, un’altra depositi nuovi effetti. Ora, in Napoli da alcuni anni era cessata del tutto l’introduzione delle nuove specie, poiché estinta era ogni industria nazionale, e quei rapporti di commercio che soli ci eran rimasti colle altre nazioni erano tutti passivi. I tremuoti del 1783 e, piú de’ tremuoti, l’economia distruttiva della corte avean desolate le Calabrie; due delle piú fertili province eran divenute deserte. Il disseccamento delle paludi Pontine e la coltura che Pio sesto vi aveva introdotta ci avean tolto o almeno diminuito un ramo utilissimo di esportazione de’ nostri grani. Noi avevamo altre volte un commercio lucrosissimo colla Francia, e quello che sulla Francia guadagnavamo compensava ciò che perdevamo cogli inglesi, cogli olandesi e coi tedeschi. La rivoluzione di Francia, distruggendo le manifatture di Marsiglia e di Lione, fece decadere il nostro commercio d’olio e di sete. Conveniva dare maggiore attivitá alle nostre manifatture di seta ed istituir delle fabbriche di sapone: esse sarebbero divenute quasi privative per noi, ed avremmo ritratto almeno questo vantaggio dalla rivoluzione francese(19). Ma quest’oggetto non importava ad Acton. Conveniva serbare un’esatta neutralitá, la quale, ne’ primi anni della rivoluzione francese, avrebbe dato un immenso smercio de’ nostri grani. Ma Acton e la regina credevano poter far morire i francesi di fame. Intanto i francesi destarono i ragusei ed i levantini, dai quali ebbero il grano, e non morirono di fame: noi perdemmo allora tutto il lucro che potevamo ragionevolmente sperare, ed oggi ci troviamo di aver acquistati in questo ramo di commercio de’ concorrenti, tanto piú pericolosi in quanto che abitano un suolo egualmente fertile e sono piú poveri di noi. Ci si permise il solo commercio cogl’inglesi, poiché il commercio di Olanda era anche nelle mani dell’Inghilterra, cioè ci si permise quel solo commercio che ci si avrebbe dovuto vietare: anzi, siccome l’opinione della corte era venduta agl’inglesi, cosí l’opinione della nazione lo fu egualmente; e non mai le brillanti bagatelle del Tamigi hanno avuta tanta voga sul Sebeto, non mai noi siamo stati di tanto debitori agl’inglesi, quanto nel tempo appunto in cui meno potevamo pagare. Questo disquilibrio di commercio ha tolto in otto o nove anni alla nazione napolitana quasi dieci milioni di suo danaro effettivo, oltre tanto, e forse anche piú, che avrebbe dovuto e che avrebbe potuto guadagnare, se il vero interesse della nazione si fosse preferito al capriccio di chi la governava.
A tutti questi mali erasi aggiunto quello di una guerra immaginata e condotta in modo che distruggeva il Regno, senza poterci far sperare giammai né la vittoria né la pace. Si manteneva da quattro anni un esercito di sessantamila uomini ozioso nelle frontiere, ed il suo mantenimento costava quanto quello di qualunque esercito attivo in campagna. Per conservar, come si dicea, la pace del Regno, la quale si dovea fondar solo sulla buona fede del re, si richiesero nuovi soccorsi al popolo; e si ottennero. Si richiese non solo l’argento delle chiese, ma anche quello de’ privati, dando loro in prezzo delle carte che non avevano alcun valore; e si ottenne(20). S’impose una decima su tutti i fondi del Regno, la quale produceva quasi il quarto di tutti gli altri tributi che giá si pagavano. Ma tutte queste risorse, che non furono piccole, si dissiparono, si perdettero, passando per mani negligenti o infedeli.
Si spogliarono le campagne di cavalli, di muli, di bovi, che parte morirono per mancanza di cibo, parte si rivendettero da quegl’istessi che ne avean fatta la requisizione.
Si tolsero nella prima leva le migliori braccia all’agricoltura, allo Stato la piú utile gioventú, che, strappata dal seno delle loro famiglie, fu condotta a morire in San Germano, Sessa e Teano: l’aria pestilenziale di que’ luoghi e la mancanza di tutte le cose necessarie alla vita, in una sola estate, ne distrussero piú di trentamila. Una disfatta non ne avrebbe fatto perdere tanti.
Allora si vide quanto la nazione napolitana era ragionevole, amante della sua patria, ma nel tempo istesso nemica di opressioni e d’ingiustizie. Erano due anni da che si era ordinata una leva di sedicimila uomini, ma questa leva, commessa ad agenti venali, non era stata eseguita: la nazione vi aveva opposti tanti ostacoli, che pochissime popolazioni appena aveano inviato il contingente delle loro reclute. Gli abitanti delle province del regno di Napoli non amavano di fare il soldato mercenario, servo de’ capricci di un generale tedesco, che non conosce altra ordinanza che il suo bastone. La corte vide il male; la nuova leva fu commessa alle municipalitá o sia alle stesse popolazioni, ed i nuovi coscritti furon dichiarati “volontari”, da dover servire alla difesa della patria fino alla pace. Al nome di “patria”, al nome di “volontari”, tutti corsero, e si ebbe in pochissimi giorni quasi il doppio del numero ordinato colla leva. Ma questi stessi, un anno dopo, disgustati dai cattivi trattamenti della corte, e piú dalla sua mala fede, per la maggior parte disertarono. Essi erano volontari da servir fino alla pace; la pace si era conchiusa, ed essi chiesero il loro congedo. Un governo savio l’avrebbe volentieri accordato, sicuro di riaverli al nuovo bisogno; ma il governo di Napoli non conosceva il potere della buona fede e della giustizia: anziché esserne amato, credeva piú sicuro esser temuto dai suoi popoli, e ne fu odiato. Tanti disertori, per evitare il rigore delle persecuzioni, si dispersero per le campagne: il Regno fu pieno di ladri e le frontiere rimasero prive di soldati.
I cortigiani diedero torto ai soldati, perché volevano adular la corte(21); gli esteri diedero torto ai soldati, perché volevano avvilir la nazione; e molti tra’ nostri, che pure hanno fama di pensatori, diedero torto ai soldati, perché non conoscevano la nazione ed adulavano gli esteri. Questi piccoli tratti caratterizzano le nazioni, gli uomini che le governano e quelli che le giudicano.
XI
GUERRA
Tale era lo stato del Regno sul cadere dell’estate del 1798, quando la vittoria di Nelson ne’ mari di Alessandria(22), lo scarso numero della truppa francese in Italia, le promesse venali di qualche francese, la nuova alleanza colla Russia e, piú di tutto, gl’intrighi del gabinetto inglese, fecero credere al re di Napoli esser venuto il momento opportuno a ristabilire le cose d’Italia.
Da una parte, la repubblica romana, teatro delle prime operazioni militari, piú che di uno Stato, presentava l’apparenza di un deserto, i pochi uomini abitatori del quale, invece di opporsi all’invasore, dovean ricevere chiunque loro portasse del pane. Dall’altra, l’imperatore di Germania rivolgeva di nuovo pensieri di guerra: né egli né il Direttorio volevan piú la pace; e si osservava che, mentre i plenipotenziari delle due potenze stavano inutilmente in Rastadt, i francesi occupavano la Svizzera ed i russi marciavano verso il Reno.
Il re di Napoli, per completare il suo esercito, ordinò una leva di quarantamila uomini, la quale fu eseguita in tutto il Regno in un giorno solo. In tal modo sulle frontiere, al cader di ottobre, trovaronsi riuniti circa settantamila uomini.
Mancava a queste truppe un generale, e, credendosi che non si potesse trovare in Napoli, si chiese alla Germania. Mack giunse come un genio tutelare del Regno.
Il piano della guerra era che il re di Napoli avrebbe fatto avanzar le sue truppe nel tempo stesso che l’imperatore avrebbe aperta la campagna dalla sua parte. Il duca di Toscana ed il re di Sardegna doveano avere anch’essi parte nell’operazione, ed a tale oggetto facevano delle leve segrete ne’ loro Stati; e si erano inviati dalla corte di Napoli settemila uomini sotto il comando del general Naselli, il quale occupò Livorno ed a tempo opportuno doveva, insieme colle truppe toscane, marciar sopra Bologna e riunirsi alla grande armata. Si era creduto necessario, sotto apparenza di difesa, occupare militarmente la Toscana, perché quel governo era, tra tutti i governi italiani, il piú sinceramente alieno dai pensieri di guerra; e questo avea reso il ministero toscano tanto odioso al governo di Napoli, che poco mancò che non si vedessero dei corpi di truppa spedirsi da Napoli in Livorno a solo fine di obbligare il granduca a deporre Manfredini. In tal modo i francesi, circondati ed attaccati in tutti i punti, dovevano sloggiar dall’Italia.
Ma l’imperatore intanto non si movea, tra perché forse opportuna non era ancora la stagione, tra perché aspettava i russi che non erano giunti ancora. Il Consiglio di Vienna avea risoluto di non aprir la campagna prima del mese di aprile. Non si sa come, si ottennero lettere piú autorevoli delle risoluzioni del Consiglio, le quali permettevano all’esercito napolitano di muoversi prima; e queste lettere erano state chieste ed ottenute con tanta segretezza, che il ministero istesso di Vienna non le seppe se non nello stesso giorno nel quale seppe e la marcia delle truppe e la disfatta. Amarissimi rimproveri ne ebbe chi allora risedeva in Vienna per la corte di Napoli. Il ministro Thugut diceva che questa corte avea tradita la causa di tutta l’Europa e che meritava di esser abbandonata al suo destino. La protezione dell’imperatore Paolo primo, presso il quale principal mediatrice fu la granduchessa Elena Paolowna, allora arciduchessa palatina, salvò la corte dagli effetti di questa minaccia. L’ambasciatore napolitano si giustificò, mostrando ordini in faccia ai quali quelli del Consiglio dovean tacere. Ma rimase e rimarrá sempre incerto e disputabile perché mai, contro gli stessi propri interessi, da Napoli si chiedevano e da Vienna si davano ordini segreti, contrari al piano pubblicamente risoluto, da tutti accettato, da tutti riconosciuto per piú vantaggioso. Intendevasi, con ciò, ingannar l’inimico o se stesso?
È probabile che la corte di Napoli ardesse di soverchia impazienza di discacciar i francesi dall’Italia. È probabile ancora che tanta impazienza non nascesse da solo odio, ma anche da desiderio di trarre da una vittoria, la quale credevasi sicura, un profitto, che forse l’Austria non avrebbe volentieri conceduto, ma, trovandolo giá preso, lo
NIETZSCHE

BREVE INTRODUZIONE
Ho imparato ad andare: da quel momento mi lascio correre. Ho imparato a volare: da quel momento non voglio più essere urtato per smuovermi. Adesso sono lieve, adesso io volo, adesso vedo al di sotto di me, adesso é un dio a danzare, se io danzo.
Federico Nietzsche é una delle grandi figure del destino della storia dello spirito occidentale, un uomo che costringe alle estreme decisioni, un terribile punto interrogativo sul cammino lungo il quale era andato fino ad allora l’uomo europeo, cammino determinato dalla eredità dell’antichità e di duemila anni di cristianesimo. Nietzsche rappresenta la spietata ed acuta negazione del passato, il rifiuto di tutte le tradizioni, l’appello ad una svolta radicale. Nietzsche è il filosofo che mette in dubbio tutta la storia della filosofia occidentale, che cerca, dopo venticinque secoli di interpretazione metafisica dell’essere, un nuovo principio. Egli sovverte i valori occidentali ed è volto verso il futuro; ha un programma, un ideale, che è quello della “grande salute”. All’inizio della sua riflessione, Nietzsche fu influenzato da Schopenhauer, per il quale la vita è crudele e cieca irrazionalità, è dolore e distruzione. Ma egli non si ferma non si ferma al pessimismo di Schopenhauer: il sentimento tragico della vita è accettazione della vita stessa, è una esaltante adesione a tutti gli aspetti dell’esistenza, anche a quelli più terribili, poiché tutto fa parte dell’immensa marea della vita. Ne La nascita della tragedia (1872), Nietzsche vede nel mondo greco la stagione spiritualmente più alta e ricca dell’umanità. La civiltà greca era infatti nutrita da un vigoroso senso tragico, che è per Nietzsche l’autentico modo di rapportarsi alla vita: è accettazione di essa, coraggio davanti al Fato. L’uomo greco vedeva dappertutto l’aspetto orribile e assurdo dell’esistenza: ma egli seppe, nell’arte, trasfigurando l’orribile e l’assurdo in immagini ideali, rendere accettabile la vita. La grande tragedia greca è la forma suprema di arte, in quanto in essa si compongono gli impulsi vitali creativi (spirito dionisiaco), e la moderazione, l’equilibrio, la razionalità (spirito apollineo). Dalle Considerazioni inattuali (1873-74) in poi, Nietzsche inizia la sua critica ad ogni manifestazione culturale. La coscienza e il linguaggio si sono sviluppati dal bisogno di comunicare, comandare, difendersi. La scienza non è che il proseguimento della costruzione concettuale iniziata nel linguaggio; anch’essa è solo capace di ricondurre utilitaristicamente il mondo ad unità, creando l’immagine di un universo “regolare e rigido”, e si limita perciò a descrivere la superficie delle cose. Essa vuole parlare il linguaggio dei fatti, ma il fatto è sempre stupido, non parla da sé ma ha bisogno di qualcuno che lo interpreti. Dunque la scienza non è mai pura, né oggettiva perché non esiste conoscenza senza presupposti, e che non sia uno strumento in mano a qualche forza. Si pratica la scienza, insomma, per desiderio di sicurezza, per fuggire fantasmi e paure, per sete di possesso e di dominio. In quanto poi alla storia (cfr. la seconda delle Considerazioni inattuali intitolata Sull’utilità e il danno della storia per la vita), essa serve all’uomo perché ha bisogno di avere dei maestri ideali. Ma se la storia dice di poter servire alla vita, non può però pretendere di essere una scienza oggettiva; d’altra parte, se vuole essere una scienza, essa diventa una sorta di statica conclusione e di inutile bilancio di vite. In più, la società moderna tende a trasformare le cose in eventi, che obbediscono ad una legge inesorabile ed estranea all’uomo. L’individuo non è altro che uno spettatore di un processo, la Storia, che lo supera e lo travolge. Gli scritti successivi (Umano, troppo umano,1878-80; Aurora, 1881; La gaia scienza,1882), aprono la fase “neoilluministica” di Nietzsche. Egli vuole deliberatamente mettere tutto in discussione: romanticismo, idealismo, positivismo, socialismo, evoluzionismo, cristianesimo, metafisiche e dogmatismi vari. Tutte le realtà che sono state presentate come nobili, vere, spirituali sono in realtà “umane, troppo umane”. Sono costruzioni che esprimono solo gli istinti, appetiti, passioni e interessi più intimi dell’uomo. Nietzsche rifiuta così ogni tipo di metafisica e di religione, ed attacca lo stesso concetto di verità: secondo Nietzsche si sono chiamate verità gli errori utili, quelli che sono indispensabili all’uomo per poter vivere, giacché non sopporta il vivere senza un senso. La volontà di verità ha la sua radice proprio nel bisogno di stabilità, nella paura di instabilità. Ma non esiste nessuna verità se non all’interno di una interpretazione ed in riferimento ad una particolare prospettiva. In altre parole, non vi sono verità evidenti se non all’interno di categorie storicamente instaurate dagli uomini. Per quanto riguarda la religione, Nietzsche definisce il cristianesimo come “platonismo per il popolo”, nel senso che afferma due realtà, di cui quella che non si vede è la più importante. Non solo: il cristianesimo oppone i valori del cielo a quelli della terra. Così esso è la religione dei deboli, dei vinti. L’ateismo, appare quindi a Nietzsche come l’unica alternativa per liberare l’uomo. Esso è in lui qualcosa di ovvio: “Sono troppo curioso, troppo incredulo, troppo insolente per accontentarmi di una risposta così grossolana. Dio è una risposta grossolana, un’indelicatezza verso noi pensatori; anzi, addirittura, non è altro che un grossolano divieto contro di noi: non dovete pensare” (cfr. Ecce homo). Ne La gaia scienza Nietzsche sostiene che l’uomo ha ucciso Dio. “Dio è morto e noi l’abbiamo ucciso” ( fr. 125). La civiltà occidentale ha ucciso Dio a poco a poco, ma, uccidendo, ha perso ogni punto di riferimento. Dicendo che “Dio è morto!” Nietzsche vuol indicare insomma che sono morti gli ideali ed i valori del mondo occidentale. Dio è stato ucciso perché in Lui era sintetizzato tutto ciò che era contro la vita. Però, ora che Dio è morto, l’uomo non sa più che cosa fare: è privo di valori ed è quindi solo, sperduto “nel gran mare dell’essere”, senza punto d’appoggio. Non c’è che una alternativa: è l’uomo stesso che deve creare i valori. Ma quali? Prima di proporre una nuova tavola di valori, Nietzsche si dedica allo smantellamento della morale. In Al di là del bene e del male (1886) e nella Genealogia della morale (1887), egli risale all’origine dei comportamenti morali. La morale per Nietzsche è uno strumento di dominio: essa consiste nella costituzione di valori presentati come universali e auto-evidenti, ma in realtà astratti e repressivi. In nome di tali valori, alcuni uomini (i “buoni”) ne soggiogano altri (i forti). Vi sono infatti due tipi di morale: la morale dei sani, dei forti, che privilegia l’individualismo, la fierezza, l’amore per la vita; e vi è poi la morale degli schiavi, dei deboli, che è sociale e utilitaristica, che predica la democrazia e via dicendo. La morale degli schiavi è nata col cristianesimo ed è sorta per il risentimento verso la classe dei forti: infatti i mediocri non sanno elaborare nulla di proprio e di autonomo, la vera azione è loro negata, ed allora trovano il compenso in una vendetta immaginaria. Il disinteresse, l’abnegazione, il sacrificio di sé sono il frutto del risentimento dell’uomo debole verso la vita. I deboli, che non sanno vivere, hanno fatto diventare valore la negazione della vita; è questa la vendetta dei deboli contro i forti. La morale tende così ad indebolire l’uomo. L’essere umano desiderava soddisfare le proprie pulsioni, realizzarsi in questo mondo. La morale lo ha invece spinto a credere in una specie di anti-mondo, lo ha portato ad allontanarsi dalla sua natura originaria, che è terrestre. Ma la natura si è vendicata e gli istinti si sono rifugiati all’interno dell’uomo. Nietzsche ha anticipato qui Freud: ha scoperto la resistenza degli istinti e delle pulsioni, la impossibilità di annullarli con la forza della coscienza e della morale. Ed ha scoperto che, se non sono liberati per vie naturali, essi possono esercitare un’azione ancora più perversa. L’uomo appare così a Nietzsche come un “animale malato”. Orbene, per liberare l’uomo da questo nichilismo (nella sua storia l’Occidente ha progressivamente negato i valori vitali), Nietzsche propone una trasvalutazione di tutti i valori, una nuova tavola di valori che realizzino l’ideale della “grande salute”. Per poterla attuare, egli ha elaborato i concetti di volontà di potenza, superuomo ed eterno ritorno. In Così parlò Zarathustra (1883-85), Nietzsche mette in bocca a Zarathustra la dottrina della “morte di Dio”, che è l’inizio della liberazione da tutti gli idoli metafisici. L’uomo vivrà felice e libero quando si sarà liberato da tutti i legami, anche da quelli stessi di “uomo” e “umanità”. “L’uomo deve essere superato” affinché arrivi il Superuomo o Oltreuomo. Il superuomo sarà un essere libero, che agirà per realizzare se stesso. E’ un essere che ama la vita, che non si vergogna dei propri sensi e vuole la gioia e la felicità. E’ un essere “fedele alla terra”, alla propria natura corporea e materiale, ai propri istinti e bisogni. La “fedeltà alla terra” è fedeltà alla vita e al vivere con pienezza, è esaltazione della salute e sanità del corpo, è altresì affermazione di una volontà creatrice che istituisce valori nuovi (ecco il vero significato della volontà di potenza). Non più “tu devi”, ma “io voglio”. Il superuomo è inoltre un essere socievole, rappresentato da Zarathustra che balla. Egli ha abbandonato ogni fede, ogni desiderio di certezza, per reggersi “sulle corde leggere di tutte le possibilità”. La sua massima è: “Diventa ciò che sei”. La libertà del superuomo è una ricchezza di possibilità diverse, da qui appunto la rinuncia ad ogni certezza assoluta e da qui anche la profondità tipica del superuomo, l’impossibilità di definire e giudicare la vita interiore, dalla quale non si attinge altro che la maschera (“Tutto ciò che è profondo, ama mascherarsi”). Il superuomo è il filosofo dell’avvenire; è un uomo senza patria né mèta per poter insegnare ad amare la ricchezza e la transitorietà del mondo. Con la sua “diversità di sguardo”, egli cerca di rendere più degno il pensiero della vita, di dare al mondo un altro valore, un’altra verità: la verità non è qualcosa da riconoscere ma da creare. Con la libertà che nasce dall’abbandono delle vecchie illusioni e certezze, egli osa “spostare le pietre di confine” e aprire alla ricerca nuovi orizzonti. La volontà di potenza, come abbiamo già accennato, è la volontà di creare sempre, incessantemente, dei valori nuovi, cioè creare il senso della terra; quindi tutte le cose dipendono dalla volontà, dalla mia volontà. E’ questo può introdurci al terzo concetto, quello dell’eterno ritorno dell’uguale. Nietzsche vuole polemizzare così contro lo storicismo e l’evoluzionismo e, d’altra parte, rifiuta la riduzione della realtà a meri eventi effimeri, senza valore. Per Nietzsche, tutto quanto accade, è già accaduto, e tornerà ad accadere. Nulla avviene a caso; e quando avviene, avviene per sempre, non si dissolve, ritorna eternamente. Questa dottrina – dice Nietzsche – è una condanna solo per gli uomini mediocri, poiché per essi torneranno sempre frustrazioni e sconfitte. Ma per il superuomo, invece, l’eterno ritorno indica che in ogni momento si può cominciare una nuova vita. Per questo esso richiede un impegno assoluto: il superuomo è consapevole che ogni suo atto si inserisce in una realtà eterna. L’eterno ritorno è anche il sì che il mondo dice a se stesso, è l’autoaccettazione del mondo, la volontà cosmica di riaffermarsi e di essere se stesso: dall’eternità il mondo accetta se stesso e quindi si ripete. L’eterno ritorno è così una verità terribile. Bisogna però fare di più che “sopportare” un simile pensiero : bisogna amarlo, bisogna promettere noi stessi all’”anello degli anelli”! La formula per la grandezza dell’uomo è dunque l’amor fati, non volere nulla di diverso da quello che è, non solo sopportare quello che è necessario, ma amarlo appassionatamente e quindi volerlo. Questo amore libera l’uomo dalla schiavitù del passato, giacché per lui tutto quello che è stato si trasforma in “ciò che io volevo che fosse”. Il presente, in quanto momento della decisione, ha la capacità di far ritornare il passato riassumendolo nell’atto della decisione. E’ quindi proprio nella decisione che il tempo si crea come tale, dividendosi in passato, presente e futuro.
Riassunto generale
“Un filosofo: un filosofo è un uomo che costantemente vive, vede, sente, intuisce, spera, sogna cose straordinarie; che viene colpito dai suoi propri pensieri come se venissero dall’esterno, da sopra e da sotto, come dalla sua specie di avvenimenti e di fulmini; che forse è lui stesso un temporale gravido di nuovi fulmini; un uomo fatale, intorno al quale sempre rimbomba e rumoreggia e si spalancano abissi e aleggia un’aria sinistra. Un filosofo: ahimè, un essere che spesso fugge da se stesso, ha paura di se stesso – ma che è troppo curioso per non ‘tornare a se stesso’ ogni volta” (Al di là del bene e del male, § 292).
Nietzsche e Freud sono accomunati dall’aver smantellato in profondità, seppur con differenti modalità, le certezze del mondo ottocentesco e della sua fiducia razionalistica, già peraltro fatte scricchiolare da Schopenhauer e da Kierkegaard. Il bersaglio a cui indirizzano le loro critiche è costituito tanto dal panlogismo hegeliano quanto dal masterialismo marxiano e dallo scientismo positivistico, filosofie che hanno in comune una fiducia esasperata nel progresso. Ed è a partire da queste critiche che Freud e Nietzsche, così diversi tra loro, mettono in discussione i punti apparentemente più stabili della civiltà occidentale. I due pensatori, poi, sono tra loro accostabili perchè non possono essere considerati filosofi nel senso classico del termine: Freud è prima di tutto un medico e Nietzsche nasce come filologo, tant’è che esordisce come docente di filologia classica, anche se interpreta tale disciplina non come strumento per ricostruire fedelmente il passato, ma come una maniera per scavare nel significato più intimo della civiltà occidentale e per poter così metterne in evidenza gli aspetti più oscuri e stridenti; dietro la maschera di Nietzsche filologo è evidente come si nasconda già il Nietzsche filosofo che interpreterà l’Occidente. Nel suo lavoro di filologo, spesso e volentieri egli non rispetta le norme di “serietà” proprie della disciplina, ma si lascia trasportare dalla ricerca del significato profondo che ad essi soggiace e per coglierlo compie salti argomentativi che il più delle volte si rivelano spericolati. In altri termini, Nietzsche non vuole studiare l’antichità esclusivamente per conoscerla nella sua essenza più intima, ma, viceversa, intende piuttosto impossessarsi di conoscenze che gli permettano di farsi profeta di una traformazione della civiltà attuale: e proprio in questo risiede l’ “inattualità” del pensiero nietzscheano (come recita il titolo delle celebri Considerazioni inattuali ), nel trovarsi fuori posto nel suo tempo, nell’essere o troppo indietro o troppo avanti rispetto ai tempi correnti. Egli infatti scava nel mondo greco per farsi profeta di quelle trasformazioni che investiranno, prima o poi, la società del suo tempo e facendo ciò si trova perennemente proiettato o nel passato o nel futuro. E Nietzsche è in piena sintonia con l’idea marxiana di una filosofia di trasformazione, per cui interpretare il mondo, senza mutarlo, è insufficiente e, nel proporre questo modo di pensare, egli rompe brutalmente una lunga tradizione, risalente ad Aristotele, la quale voleva la filosofia come sapere fine a se stesso. Il sapere per il sapere, di ispirazione aristotelica, a Nietzsche non interessa, come del resto non gli interessa la pura e semplice ricostruzione filologica della realtà: queste operazioni, infatti, risultano del tutto subordinate, e dunque di secondaria importanza, rispetto al problema della vita. Sulla base di queste considerazioni, Nietzsche si innesta su un filone di pensiero che possiamo tranquillamente definire vitalistico , volto all’esaltazione della vita e dell’irrazionalismo che la contraddistingue; nella 2° delle Considerazioni inattuali , il cui titolo recita “Sull’utilità e il danno della storia per la vita”, Nietzsche non si domanda, come invece facevano i suoi contemporanei, se la storia sia o non sia una scienza e come la si debba impostare per far sì che essa ricostruisca fedelmente il passato; al contrario, gli interessa se la storia sia utile o dannosa per la vita: tutta la storia della filosofia precedente a Nietzsche aveva concentrato la propria indagine sulla ricerca del vero, senza mai osar mettere per davvero in forse il concetto di verità; ora, Nietzsche è del parere che il concetto di verità sia uno di quei concetti su cui si è costruita nel corso della storia la civiltà occidentale ed egli si propone di sostituirlo, dopo averlo dimostrato assurdo, con quello di utilità: la vera filosofia non deve più domandarsi cosa è vero, ma cosa è utile per la vita. Ne consegue che il criterio per giudicare un sapere non consisterà più nel domandarsi se esso sia veritiero, ma se serve o no alla vita, ovvero se è in grado di stimolare le forze vitali dell’uomo. Nietzsche prende le distanze dalla tradizione anche per il modo di scrivere: al periodare ampio e architettonicamente strutturato, egli preferisce l’ aforisma , caratterizzato dalla forma concisa, essenziale e folgorante di punti cruciali, attraverso stringate argomentazioni e rapide illuminazioni: inoltre l’aforisma, che Nietzsche mutua da Eraclito, è tipico delle filosofie non-sistematiche e ben risponde all’esigenza della filosofia nietzscheana di operare come un martello che distrugge le verità e che saggia le campane per vedere se suonano bene (fuor di metafora: gli aspetti della civiltà occidentale), o se debbano essere abbattute. Ecco perchè l’opera del pensatore tedesco si configura come un’opera di smontaggio degli elementi occidentali per sondarne la legittimità con i colpi martellanti dell’aforisma. Egli si avvale di questo stilema narrativo in quasi tutte le sue opere, fatta eccezione per La nascita della tragedia e per le Considerazioni inattuali , dove invece prevale la forma accademica del saggio, ossia la trattazione di un tema che procede gradualmente passo dopo passo, poichè l’argomento trattato lo costringe a percorrere quella strada (anche se fortissima è la partecipazione emotiva del filosofo); un’altra illustre eccezione è rappresentata dal capolavoro di Nietzsche, Così parlò Zarathustra : ciò a cui maggiormente si avvicina sono le Sacre Scritture e non a caso il protagonista stesso (Zarathustra) è un profeta o, meglio, per usare un’espressione tipicamente nietzscheana, è un “Anticristo”, ovvero predica un modo di vita diametralmente opposto a quello delineato da Cristo. Proprio come nei Vangeli, si racconta la vita del profeta inframmezzata da parabole e scintillante di metafore. E’ bene spendere qualche parola anche sulla vita di Nietzsche, naufragata nella pazzia: al di là dei molteplici eventi che l’hanno segnata, è molto importante il fatto che essa si sia tragicamente conclusa, dopo una lunga depressione, in una follia che ha portato il filosofo alla morte, dopo il crollo avvenuto nella sua città prediletta, Torino. E c’è chi ha voluto scorgere in alcuni aspetti sconcertanti della filosofia nietzscheana la prova lampante che la sua mente fosse già malata, leggendo la sua follia come un effetto della sifilide contratta in passato. Vi è poi stato chi ha sostenuto che la follia fu causata dalla filosofia stessa elaborata dal pensatore: e in effetti certi aspetti di essa tendono a sfuggire ad ogni logica umana, a schizzare via da ogni forma di comprensibilità; in certi punti il pensiero si smarrisce letteralmente e questo avvitamento estremo della filosofia lo avrebbe portato alla follia. Detto questo, passiamo ad esaminare la prima opera importante composta da Nietzsche: si tratta de La nascita della tragedia , del 1871. L’impostazione è, apparentemente, di stampo filologico, in quanto si cerca di risalire alle origini della tragedia fiorita in età greca, ma, come si evince fin dalle prime pagine, le tesi strettamente filologiche sono affiancate da profonde considerazioni filosofiche; ed è curioso notare come questo modo argomentativo abbia fatto molto presa, a tal punto che in molti (tra cui Heidegger), da allora, cercheranno, sulla scia di Nietzsche, di studiare dai tempi più remoti la società occidentale per poterla sanare. Nell’opera e, più in generale, nell’intera filosofia nietzscheana, aleggia l’idea che la crisi che sta vivendo la civiltà occidentale sia un qualcosa di molto remoto, risalente ai tempi del mondo greco, nell’idagine del quale Nietzsche apporta ragguardevoli novità. In primo luogo, egli stravolge la tradizione nella misura in cui non guarda alla civiltà greca come vivamente ottimistica, come invece si era soliti fare in virtù della tradizione invalsa dal Rinascimento in poi; al contrario, vuole indagarne gli aspetti ombrosi, il pessimismo di fondo che serpeggia in quel mondo e che nessuno era stato davvero in grado di cogliere. In quest’indagine, Nietzsche prende spunto da Schopenhauer, della cui filosofia si dichiara momentaneamente depositario: e legge appunto la nascita della tragedia come manifestazione di questo pessimismo latente che pervade il mondo greco; in particolare, egli adduce come esempi del pessimismo imperante all’epoca le lamentazioni sull’esistenza, i numerosi paragoni instaurati tra le stirpi umane e le foglie e, soprattutto, ricorda la vicenda di un sovrano che, imbattutosi in un satiro dei boschi detentore della verità sull’esistenza umana, dopo averlo a lungo rincorso, lo costringe ad enunciare tale verità: il bene assoluto per l’uomo è non nascere e, se è nato, morire al più presto. L’altra grande novità (strettamente connessa alla prima) che Nietzsche introduce nel suo metodo filologico risiede nell’aver scorto il momento culminante dell’età greca non nella società dei tempi di Platone e Pericle, bensì nella civiltà arcaica, ancora venata dal pessimismo; infatti, l’ottimismo è subentrato a partire dai grandi sistemi filosofici di Platone e Aristotele. E la tragedia, nella prospettiva nietzscheana, costituisce il momento in cui la civiltà greca arriva al massimo grado e, contemporaneamente, si avvia al suo tramonto: l’intera civiltà greca (e, indirettamente, quella occidentale) appare agli occhi di Nietzsche governata da due princìpi che egli identifica, rispettivamente, con il dio Apollo e con il dio Dioniso . Essi simboleggiano due atteggiamenti antitetici che connotano il mondo dei Greci: da un lato, Dioniso è l’orgiastico dio della natura selvaggia e incarna il disordine, le forze irrazionali e istintive dell’uomo; dall’altro lato, Apollo è il dio solare, emblema dell’equilibrio, dell’armonia, della razionalità e dell’ordine. Ed è come se il mondo greco, nella sua classicità, avesse privilegiato l’atteggiamento apollineo, dandosi una veste razionale: ma Nietzsche mette in risalto l’aspetto dionisiaco, attribuendogli anche un peso maggiore rispetto a quello apollineo. Prima che nascesse la tragedia, egli nota, vi è stato un alternarsi dei due atteggiamenti, per cui ora prevaleva la prospettiva caotica del dionisiaco, ora quella composta dell’apollineo: e se in alcune civiltà orientali (Nietzsche ha soprattutto in mente certi culti orgiastici in cui il dionisiaco si manifesta in modo sfrenato) lo spirito dionisiaco emerge incontrastato da quello apollineo e perciò risulta particolarmente violento, nel mondo greco, invece, il dionisiaco genera anche l’apollineo, quasi come una barriera di difesa all’impeto dirompente dello spirito dionisiaco. Soffermando la propria attenzione sul mondo greco, Nietzsche cita espressamente il tempio dorico arcaico che, con la sua assoluta perfezione geometrica, rappresenta proprio l’ergersi dell’ordine apollineo in opposizione al caos dilagante del dionisiaco. Ed è evidente come la novità della lettura nietzscheana della civiltà greca consista non tanto nell’aver sostenuto che, in fin dei conti, la cultura greca non è poi così ordinata come sempre la si è immaginata, quanto piuttosto nell’aver evidenziato il fatto che l’ordine che, qua e là, la colora è una pura e semplice manifestazione derivata dal caos di fondo, una barriera volta a limitare i danni dell’eccessivo disordine. A differenza dell’interpretazione che del mondo greco aveva dato qualche decennio prima Hegel, ad avviso del quale, in fin dei conti, i Greci erano un popolo ottimista e composto per inclinazione naturale, Nietzsche mette in luce come i Greci abbiano insistito in modo esasperato sull’ordine perchè avevano un senso particolarmente acuto della tragicità dell’esistenza umana, cosicchè dionisiaco e apollineo, inizialmente presentati come due poli antitetici, si rivelano ora come due facce della medesima medaglia, in quanto l’apollineo nasce come reazione alla tragicità dionisiaca della vita. E, sotto questo profilo, la tragedia greca costituisce il vertice raggiunto dal mondo arcaico, in quanto in essa è cristallizzato un perfetto e armonico equilibrio tra lo spirito dionisiaco e quello apollineo : sulla scena, infatti, vengono rappresentati avvenimenti terribili che però risultano piacevoli agli spettatori (già Aristotele aveva riflettuto su questo paradosso); l’interpretazione che ne dà Nietzsche è in piena sintonia con il suo ragionamento: di fronte alla tragicità degli eventi messi in scena, si prova piacere perchè si esprime sì l’impeto dionisiaco, ma è ” Dioniso che parla per bocca di Apollo “, ovvero gli elementi tragici dell’esistenza messi in scena vengono sapientemente sublimati dall’essere tradotti in un linguaggio artistico, come se Apollo desse forma ai contenuti di Dioniso. E la tesi nietzscheana, che campeggia nell’opera, secondo la quale la tragedia deriverebbe da antichi riti dionisiaci è ancor oggi per lo più accettata: “tragedia”, infatti, sta a significare “canto del capro” e il capro era appunto un animale sacro a Dioniso; al coro di uomini vestiti come capri in onore del dio, si è sempre più contrapposta la figura di Dioniso e da ciò si è, gradualmente, sviluppata la tragedia vera e propria. Come abbiam detto, in quest’opera Nietzsche professa la propria ascendenza schopenhaueriana e ben lo si evince dal prevalere, nella sua lettura del mondo greco, dell’aspetto drammatico e caotico dell’esistenza e della forza irrazionale, quasi demoniaca, che la permea a tal punto che la razionalità altro non è se non una mera apparenza. Tuttavia, nella seconda edizione dell’opera, Nietzsche pone una prefazione in cui dichiara di non essere più schopenhaueriano e che anzi, già quando aveva scritto La nascita della tragedia si era solo illuso di esserlo. E in effetti le differenze tra i due pensatori sono parecchie: seppur accomunati dal privilegiamento per l’irrazionalità e dal pessimismo, i due filosofi appaiono incommensurabilmente distanti nella loro concezione della vita; essa è per Nietzsche il valore centrale intorno al quale costruire la filosofia, mentre invece per Schopenhauer, attraverso quel tortuoso processo che, culminando con la “noluntas”, porta allo spegnimento della vita stessa, essa non ha alcun valore, ed è anzi la fonte della sofferenza umana. Nietzsche, che pure all’epoca de La nascita della tragedia si riteneva schopenhaueriano nella misura in cui prospettava la caoticità dell’esistenza, non giungeva affatto a scorgere l’unico rimedio possibile all’infelicità dell’esistere nell’annullamento della vita stessa: in altri termini, se per Schopenhauer, dopo essersi accorti che la vita è tragica, non resta che uscirne al più presto, per Nietzsche, viceversa, la si deve vivere fino in fondo, accettandola in ogni sua sfumatura (in Così parlò Zarathustra egli dice, con un’espressione che ben sintetizza la sua filosofia, ” bisogna avere un caos dentro di sè per generare una stella danzante “). Da tutto ciò si evince come per Nietzsche la vita sia il valore supremo e che dunque la tragicità che la connota non sia un motivo sufficiente per sottrarsi ad essa : il che è brillantemente simbolizzato dal coro tragico che si identifica a tutti gli effetti con la caoticità di Dioniso; Apollo stesso, del resto, non viene dipinto a tinte negative, ma è anzi inteso come un filtro che permette di vedere la tragicità esistenziale senza essere accecati dal fulgore che essa emana. Ciò non toglie, tuttavia, che l’apollineo, per rimanere positivo, non debba perdere il suo contatto con il dionisiaco (da cui è generato): il problema sorge nel momento in cui Apollo non è più portavoce di Dioniso, ma parla con voce propria, diventando così autonomo. E il crollo della cultura greca, verificatosi agli occhi di Nietzsche nel V secolo a.C., è legato proprio a questo: i due personaggi che ne sono vessilliferi sono Euripide , tragediografo dell’epoca, e Socrate , modello tipico di spettatore di tali tragedie. Infatti, con la produzione euripidea, il tragico sfuma e cede il passo alla razionalità, i personaggi in scena ragionano con una dialettica spietata e la tragedia perde i suoi connotati tragici tendendo sempre più a diventare ottimistica e razionale. Socrate, dal canto suo, è il primo grande simbolo della grande razionalità filosofica della Grecia e il suo allievo, Platone, non fa che portare alle stelle questa tendenza: da quel momento fino all’epoca in cui vive Nietzsche, la civiltà occidentale è sempre più andata, in modo irresistibile, verso una marcata compostezza ordinata e razionale, con il conseguente sganciamento dell’apollineo dal dionisiaco e la fine dell’equilibrio tra i due. Ma a Nietzsche non interessa il passato in quanto tale, ma la vita e il suo trascorrere incessante nel presente: ed è per questo che proietta la sua indagine sulla meravigliosa epoca dei Greci, per cercare il senso e l’origine profonda di quella crisi che alimenta l’epoca in cui Nietzsche vive; e il filosofo, come abbiam visto, rinviene le radici di tale crisi nel prevalere schiacciante dell’apollineo sul dionisiaco. E in questa fase del suo percorso filosofico, Nietzsche, oltrechè schopenhaueriano, si professa wagneriano, scorgendo nella figura di Wagner la possibilità di una rinascita della tragedia greca, intesa come antidoto al prevalere imperante dell’apollineo. Questo atteggiamento è presente anche nella II delle Considerazioni inattuali (1873-74), dal titolo Sull’utilità e il danno della storia per la vita : che la riflessione di Nietzsche sia “inattuale” e che egli sia, se inquadrato nella sua epoca, un pesce fuor d’acqua è evidente già solo dal titolo di questa Considerazione, titolo che peraltro costituisce la chiave di lettura di tutto il suo pensiero: a Nietzsche non interessa affatto se la storia dica il vero o se vada adottato un metodo storico piuttosto che un altro; semplicemente si domanda se la storia sia utile o dannosa per la vita, protagonista indiscussa della sua filosofia a partire da La nascita della tragedia (anche se in tale opera finiva per identificarsi con la volontà schopenhaueriana). Dalla lettura della II Considerazione, emerge come per Nietzsche la storiografia, che di per sè non è da respingersi, in quegli anni abbia assunto un’eccessiva importanza a tal punto da poter divenire dannosa, poichè fa sì che ci si senta inibiti nella vita perchè posseduti dalla malsana idea che tutto ciò che si poteva fare sia già stato compiuto nel corso della storia umana. Per poter agire nella vita è necessario un margine di oblìo e di ignoranza, e pertanto la storiografia va bene solo se presa a piccole dosi. Nello specifico, poi, egli individua tre diversi tipi di storiografia : quella “critica” ha un approccio critico con il passato e, dunque, si pone (sulla scia dell’Illuminismo) in forma correttiva rispetto ad esso; quella “monumentale”, invece, esamina e celebra le azioni del passato e, infine, quella “antiquaria”, come suggerisce il nome, nutre un culto, di stampo museale, del passato in quanto tale. Ciascuna di queste tre tipologie, a patto che non venga oltremodo esasperata quantitativamente e non si trascurino le altre, è utile: la critica e l’esaltazione delle gesta del passato, infatti, sono uno stimolo per agire in modo migliore e, in modo analogo, perfino il radicamento museale nel passato può essere una buona premessa per agire meglio (pensiamo a Manzoni, che nell’Adelchi mette in scena vicende del passato radicate nella cultura italiana per aizzare il popolo ai moti risorgimentali). Ciò non toglie, tuttavia, che non si debba esagerare: perchè se è vero che i tre tipi di storiografia possono, per le ragioni poc’anzi esposte, essere utili alla vita, è anche vero che, se si eccede, possono rivelarsi dannose. Se si critica eccessivamente il passato, infatti, ci si limita a lamentale di come le cose non debbano andare e se si esaltano troppo le imprese degli antichi ci si blocca in un’assurda idolatria. Ed è per questa ambiguità per cui la storia, nelle sue tre sottodivisioni, è in perenne bilico tra l’essere utile e l’essere dannosa per la vita, che Nietzsche attribuisce tale titolo alla seconda Considerazione. E, proprio come fa Freud, egli propone sempre anche degli antidoti: se ne La nascita della tragedia aveva proposto l’opera wagneriana come possibile ritorno all’equilibrio tra apollineo e dionisiaco, ora, invece, sostiene che per far fronte al rischio che la storia possa danneggiare la vita si deve ricorrere all’arte e alla religione. L’arte, infatti, pressochè costante nell’opera nietzscheana, può costituire un’efficace cura per dar spazio alla creatività dell’uomo e al suo istinto creativo, anche se, è bene notare, il pensatore tedesco cambia, a poco a poco, il suo atteggiamento. Se ne La nascita della tragedia e nelle Considerazioni inattuali ravvisa nell’arte un potente antidoto contro l’apollineo che mortifica la vita, man mano che matura, Nietzsche è sempre meno convinto che essa possa salvare e arriva a sostenere che si deve vivere la vita come un’opera d’arte (tesi che sarà particolarmente cara a D’Annunzio), ovvero si deve condurre la propria esistenza artisticamente, diventando creatori di valori e di certezze da contrapporre a quelli tradizionali. Forse più complessa è la questione per quel che riguarda la religione: pare infatti piuttosto strano che Nietzsche, accanito sostenitore che ” Dio è morto ” e autore de L’Anticristo , possa rintracciare nella religione un rimedio. Tuttavia, è bene precisare, Nietzsche non era banalmente un “ateo” dispregiatore della religione: come non gli interessa se la storia sia vera o falsa, ma se sia utile o dannosa per la vita, così la religione gli sta a cuore nella misura in cui essa può promuovere la creatività umana: e se arriverà a condannare le religioni dei suoi tempi, lo farà quasi esclusivamente perchè esse uccidono la vitalità, non perchè sono menzognere; e, in questa fase del suo pensiero, non può fare a meno di constatare che nell’epoca d’oro della tragedia (quella di Sofocle e, soprattutto, di Eschilo) la religione era un patrimonio lussurreggiante di miti e di immagini da vivere in prima persona con i riti e con le feste, cosicchè essa non ammazzava, ma anzi era una sorgente di vitalità umana. Da queste riflessioni si capisce come per Nietzsche la religione e l’arte siano antistoriche e “inattuali”: esse, cioè, si collocano al di là della pericolosità dell’incantesimo di quella storia che, se eccessiva, fiacca la vita. Una buona parte del lavoro filosofico di Nietzsche nella sua maturità è dedicato alla ricostruzione della ” genealogia della morale ” (come recita il titolo di un suo scritto datato 1887): se nella prima fase della sua indagine, il pensatore tedesco aveva individuato nell’arte la via di salvezza per la civiltà occidentale, da un certo momento in poi egli abbandona tale strada e scorge l’unico antidoto possibile nella scienza e per questo motivo questa nuova stagione del suo pensiero è stata spesso definita “illuministica”, tant’è vero che molti dei suoi scritti maturati all’epoca sono dedicati ai più prestigiosi pensatori dell’età della ragione, tra cui spicca Voltaire (dedicatario di Umano, troppo umano ). Apparentemente può stupire questa fedele adesione alla scienza di un pensatore che privilegia l’irrazionale e, soprattutto, il vitalismo: ma l’atteggiamento che egli assume è radicalmente diverso rispetto a quello positivistico, fiducioso che nel dato di fatto risiedesse la verità; più precisamente, la valutazione positiva che Nietzsche riserva alla scienza può essere spiegata facendo riferimento ad un altro testo, del 1881, intitolato ” La gaia scienza “: il pensatore tedesco apprezza la scienza non in base ad un criterio di verità, ma piuttosto perchè capace di liberare l’uomo, proprio come, anni prima, aveva valutato positivamente la religione per la sua capacità di far emergere la capacità creativa. Ed è per questo che egli abbraccia la scienza nella misura in cui in essa scorge una capacità liberatoria, senza contrapporla perchè più “vera” (come invece facevano i Positivisti) alle nebbie della metafisica: un pò come aveva fatto per la storia, egli si domanda ora non se la scienza sia vera o falsa, ma se sia utile o dannosa per la vita. E la valutazione che ne dà è inequivocabilmente positiva: la tecnologia stessa appare ai suoi occhi come un elemento liberatorio e non è un caso che egli, in questo periodo, concentri la sua attenzione su molti studi variegati, anche di natura scientifica. Ciò che più affascina Nietzsche della scienza e del suo essere utile per la vita è il fatto che essa indaghi sull’origine delle cose ed è per questo che la sua attenzione è rivolta precipuamente alla chimica e alla paleontologia, finalizzate (anche se una nel tempo, l’altra no) alla ricerca dell’origine degli elementi costitutivi della realtà. In sostanza, conclude Nietzsche, queste due scienze hanno un atteggiamento “genealogico” e si propone di operare anch’egli, in ambito filosofico, con questo metodo di costruzione dell’origine passando per lo smontaggio; tuttavia, se la chimica e la paleontologia studiano, in senso lato, la natura, Nietzsche vuole invece proiettare la propria indagine sulla morale, anche se con le stesse modalità delle altre due discipline: ed è per questo motivo che il suo famoso scritto che ne scaturisce si intitola Genealogia della morale . Più che distruggere la morale, come più volte gli è stato rinfacciato, Nietzsche la “decostruisce”, come ha acutamente messo in evidenza Vattimo, ovvero la costruisce all’incontrario: come la chimica “smonta” le sostanze complesse per ravvisare i singoli elementi che le costituiscono, così egli si propone di agire nei confronti della morale; ed è, a tal proposito, significativo il titolo di un’opera del 1878, intitolata ” Umano, troppo umano ” , che mette in risalto come dallo smontaggio della morale se ne ottenga una demitizzazione della morale stessa. In altri termini, la morale ha tradizionalmente poggiato su realtà sovrasensibili (il mondo delle idee di Platone ne è la più fulgida espressione), quasi come se nella storia i valori umani fossero stati tramutati in divini; questo atteggiamento paradossale, nato con Socrate e proseguito con Platone, ha accompagnato la civiltà occidentale per tutto il suo sviluppo, senza mai venir meno. Il cristianesimo stesso altro non è, a dire di Nietzsche, che un “platonismo popolare” che, con una precettistica meno raffinata di quella platonica, ha fatto slittare la discrepanza tra mondo fisico e mondo metafisico da un piano ontologico ad uno temporale, cosicchè la trascendenza non si colloca più al di sopra, ma dopo, dal momento che la si raggiunge solo con la morte. Perfino la democrazia e il socialismo sono il frutto di quest’atteggiamento di divinizzazione della morale e ciò che intende mettere in luce Nietzsche in Umano, troppo umano è come quei valori ipostatizzati, quasi trasformati in sostanze divine, in realtà sono umani, fin troppo umani: ” dove voi vedete le cose ideali, io vedo cose umane, ahi troppo umane “. Ma più che venir rifiutati, questi valori “ideali” sono smontati, quasi denudati, ossia messi in luce nella loro vera origine e quindi nella loro vera natura, attraverso un’operazione filosofica accostabile a quella di un martello che saggia ogni cosa. E, nel concreto, dimostrando nella sua indagine sulla genealogia della morale che essa non ha un’origine sovrasensibile e divina, ma anzi, fin troppo terrena, egli intende dire, ad esempio, che le regole morali che serpeggiano nella nostra civiltà sono regole di convivenza civile per regolare il comportamento degli individui, e non leggi enigmaticamente emanate da dio. E perchè nasce la morale? L’uomo, osserva Nietzsche, ha per natura il bisogno di dominare la realtà che lo circonda e tale esigenza si estrinseca in primo luogo come dominio intellettuale (la paura del buio, ad esempio, nasce dal fatto che non riusciamo a dominare concettualmente l’ambiente in cui ci si trova) e, per fare ciò, l’uomo sente la necessità impellente di imporsi delle regole comportamentali e conoscitive che lo difendano dalla realtà caotica e irrazionale in cui è immerso, proprio come, al tempo dei Greci, lo spirito apollineo era nato da quello dionisiaco. Ma il termine “morale” riveste in Nietzsche un significato più ampio di quello che, solitamente, le attribuiamo: a costituire la “morale” sarà la sfilza di regole che l’uomo si è imposto, ma anche i criteri per stabilire ciò che è vero e ciò che è falso, dato che la ricerca della verità e la necessità di comunicarla ai propri simili è esso stesso un valore morale, cosicchè anche il vero, oltre al bele, rientra nella vastità semantica del termine “morale”. Ma non basta: perfino la religione è una forma di morale, visto che in Dio sono cristallizati tutti i valori maturati nella storia dell’uomo ed è in quest’avventura di ricerca dell’origine umanissima della morale che Nietzsche ha modo di trattare della schiavitù: quelli che vengono generalmente riconosciuti come “il bene” e “il male” sono tali perchè l’han stabilito i “padroni”, afferma Nietzsche accostandosi in modo impressionante alle tesi che in quegli anni stava elaborando pure Marx; dopo di che, tuttavia, succede anche che nasca una morale dei servi, di coloro, cioè, che sono assoggettati in quanto deboli e che, con la loro morale, intendono negare la validità del diritto del più forte, proponendo, opposta ad essa, una ” morale del risentimento “. In questa prospettiva, che molto risente delle discussioni degli antichi Sofisti (cari a Nietzsche perchè demolitori della verità) sulla distinzione tra fusiV e nomoV , Nietzsche scaglia i suoi velenosi strali soprattutto contro Platone, che nella Repubblica aveva contestato a Trasimaco il diritto del più forte, contro il cristianesimo, strenuo propugnatore dell’uguaglianza degli uomini di fronte a Dio, contro la democrazia e contro il socialismo ( ” balorda incomprensione di quell’ ideale morale cristiano “); e dopo aver tuonato contro di essi, Nietzsche fa una scoperta sensazionale: la morale dei deboli può diventare morale della sopraffazione, poichè se essi si uniscono possono imporre i loro valori in modo coercitivo ma anche in modo “pacifico” e, in quest’ottica, l’ascetismo stesso, tanto caro a Schopenhauer, altro non è se non trasformare in valore l’incapacità di vivere la vita fino in fondo e voler costringere gli altri a cedere a tale valore. Perfino i martiri cristiani, sostiene Nietzsche, commettono una violenza, poichè col martirio è come se imponessero agli altri i loro valori. Con queste riflessioni Nietzsche demitizza la morale e da ciò deriva un atteggiamento di nichilismo , ovvero una filosofia del nulla che prorompe dal venir meno dei punti di riferimento della morale: e Nietzsche distingue tra “nichilismo passivo”, dipingendolo in negativo, e “nichilismo attivo”, esaltato invece come altamente positivo. Se con Platone era invalsa la convinzione che esistessero due mondi distinti, uno intellegibile e perfetto, l’altro fisico e lacunoso perchè pallida copia dell’altro (e il cristianesimo aveva esasperato questa mentalità), si è poi scoperta la falsità di tale apparato ideologico e morale, cosicchè il mondo fisico ha perso ancora più consistenza perchè, se ai tempi di Platone e della morale cristiana, era considerato imperfetto ma comunque copia di quello ideale, ora si trova smarrito e senza punti di riferimento assoluti: domina dunque il nichilismo passivo, che corrisponde a buona parte delle posizioni atee (ad esempio, gli atei che invidiano chi ha ancora il coraggio di credere). Con la fase del nichilismo passivo, il mondo ha perso consistenza rispetto al mondo di Platone perchè, se è vero che ha proclamato la falsità dei punti di riferimento assoluti (Dio, la morale, ecc), è altrettanto vero che non si è del tutto liberato da quel gravoso fardello e prova una sorta di rimpianto per quel mondo assoluto. Poi, però, nasce una nuova posizione: dopo aver dichiarato l’inesistenza del mondo dei valori assoluti, ci si accorge che di esso non c’è più bisogno (e forse non ce n’è mai stato), sicchè viene meno il rimpianto che caratterizzava il nichilismo passivo; il mondo sensibile resta l’unico e assume un valore assoluto, mai conosciuto in precedenza, poichè tutto il valore riconosciuto un tempo al mondo sovrasensibile si riversa ora su quello terreno e così, dal nichilismo passivo si passa a quello attivo, caratterizzato da un radicale immanentismo; il nuovo ateo, cioè, non rimpiange più il mondo dei valori, ma dice: “dio non c’è? Benissimo, allora dio sono io”, o, per usare le parole impiegate da Nietzsche in Così parlò Zarathustra , ” se esistessero gli dèi, come potrei sopportare di non essere dio! […] adesso é un dio a danzare, se io danzo “. E una volta che la scienza “gaia” (perchè liberatrice) perviene alla conoscenza e alla decostruzione della morale, la depotenzia fino a liberare l’uomo dalle tradizionali catene dei valori morali imposti dall’esterno e, per questo motivo, limitativi nei confronti della creatività umana; però, solo con il passaggio dal nichilismo passivo a quello attivo si attua effettivamente la liberazione dell’uomo e quella che Nietzsche definisce ” trasvalutazione dei valori “, cioè lo stravolgimento dei valori tradizionali: non si tratterà di eliminare il bene e il male, ma di trasmutarne il significato e questo atteggiamento volto a cambiare, non a distruggere, emerge bene dal titolo di un’opera del 1885-86 intitolata Al di là del bene e del male , da cui si evince facilmente come l’uomo, smontata la morale, sia tenuto a collocarsi al di là di quelli che la tradizione ha additato come “bene” e “male”, liberandosi in tal modo dei valori “divini” imposti dall’esterno e dannosi per la vita: questi vengono sostituiti da nuovi valori che l’uomo stesso si dà, trasformandosi così in un “creatore di valori”. Non si subiscono più in modo passivo i valori “divini”, ma si vivono in modo gioioso e gaio quelli nuovi, terreni a tutti gli effetti (l’opera di Nietzsche è pervasa da costanti inviti all’umanità a restare fedele alla terra). In base alle considerazioni fin’ora illustrate, Nietzsche può così arrivare ad affermare che ” Dio è morto “: in molti si son chiesti perchè non dica, molto più semplicemente, che non esiste, ma in realtà il suo atteggiamento è profondamente motivato dal suo stesso impianto filosofico. Infatti, ripercorrendo brevemente il suo percorso, egli ha indirizzato la sua ricerca sull’origine della morale attraverso l’impiego della scienza e ha scoperto che tutti quei valori morali, da sempre esaltati come divini, in verità hanno un’origine fin troppo umana, ma nella prospettiva nietzschena rientra nella tradizionale “morale” anche l’esigenza di distinguere il vero dal falso ed è a questo proposito che affiora un paradosso interessante nel suo pensiero, paradosso che qualche studioso ha voluto connettere alla follia nietzscheana: la ricerca condotta sulla genealogia della morale si basa anch’essa su quella spinta alla ricerca della verità che costituisce un punto cardinale della civiltà occidentale (e trova la sua massima espressione nella celebre espressione di Aristotele secondo cui l’uomo tende per natura alla verità); da tale indagine si scopriva che la verità non esiste e lo stesso valore morale che ci ha indotti a tale ricerca rivela la propria inconsistenza, quasi come se l’unica verità fosse l’inesistenza di una verità. E, poichè credere in Dio significa riporre tutti i valori morali (bontà, verità, ecc) in un solo ente, negarne l’esistenza vorrebbe dire, a sua volta, riproporre una verità e quindi ritirare in ballo l’esistenza di Dio, che è appunto la sintesi di tutti i valori morali (tra cui la verità): in altri termini, se Nietzsche avesse detto “Dio non esiste”, avrebbe riproposto una nuova verità (la non-esistenza di Dio) e si sarebbe trovato incastrato dalla sua affermazione, perchè laddove c’è una verità, là c’è anche Dio. Ecco perchè Nietzsche preferisce usare un’espressione più indiretta e sfumata, priva di implicazioni ontologiche: asserendo che Dio è morto, Nietzsche ci sta suggerendo che non ci serve più e da ciò emerge l’idea (fortissima in Così parlò Zarathustra ) del ” congedarsi da Dio “; certo, ci sono stati momenti in cui Dio ha avuto un senso e, del resto, Nietzsche esamina (nella Genealogia della morale )l’origine della morale senza scagliarsi contro di essa, ma anzi riconoscendo che, in determinati periodi storici, è stata necessaria e ha avuto un senso. Più nello specifico, è il progresso che ha reso sempre più possibile la vita senza l’arsenale divino e morale, fino ad arrivare al nichilismo attivo, in cui si smarrisce ogni rimpianto per tali valori; e un ruolo di primissimo piano è stato svolto dalla tecnologia: l’uomo, infatti, finchè non è stato in grado di dominare materialmente la realtà, ha sentito l’esigenza di imporsi su di essa almeno concettualmente con l’idea di Dio e della morale. Ma poi, grazie al progresso e alla tecnologia, egli ha esteso il proprio dominio materiale sulla realtà e la validità di concetti come “Dio” e “morale” si è sgretolata, a tal punto che ancora oggi le società più evolute sono quelle dotate di regole meno fisse. Non si tratta, pertanto, di distruggere brutalmente la morale e Dio, ma semplicemente di assumere nei loro confronti quell’ atteggiamento di congedo calmo e sereno che si attua nel momento in cui ci si accorge che quelle cose, un tempo indispensabili, ora non servono più e possiamo liberarcene in tutta tranquillità (l’idea di ” crepuscolo degli idoli “, come recita il titolo di un’altra opera, del 1888, rende bene l’idea di come i valori tradizionali non vengano violentemente distrutti, ma di come tramontino). L’odio nei confronti della morale e della religione, dice Nietzsche, può solo scaturire in seno al nichilismo passivo, quando cioè vengono ancora sentite forti e, in fondo, se ne sente ancora il bisogno: questo atteggiamento di transizione viene paragonato a quello del cane appena liberato che ha ancora sul collo il segno del collare. E dopo che la morale e la religione sono giunti al loro crepuscolo, l’uomo che si è congedato da esse è il superuomo : ” morti sono tutti gli dèi: ora vogliamo che il superuomo viva ” ( Così parlò Zarathustra ). Tuttavia, al termine superuomo, destinato a diventare un mito per le generazioni successive a Nietzsche e ad essere soggetto a clamorosi fraintendimenti, è preferibile usare quello di “oltreuomo”, come ha sottolineato Vattimo, proprio per distinguere la concezione nietzscheana dalle poco fedeli interpretazioni fascistoidi e dannunziane, anche se qualche spunto in tale direzione compare, qua e là, nelle stesse opere nietzscheane, soprattutto quando il folgorante profeta del superuomo si schiera contro le morali dei deboli; anche se, ad onor del vero, pur non approvando il socialismo come dottrina, in qualche aforisma guarda con simpatia al movimento operaio perchè, a differenza della sonnolenta borghesia, è animato da una forza particolarmente vitalistica capace di creare nuovi valori. Fondamentalmente, l’oltreuomo non è un essere superiore agli altri, ma la nuova figura che l’uomo dovrà assumere in futuro e Nietzsche se ne fa profeta soprattutto in Così parlò Zarathustra , un libro enigmatico ( “un libro per tutti e per nessuno” avverte il sottotitolo) che, come abbiamo accennato, si configura come una sorta di parodia del Vangelo in cui, oltre a capovolgere il testo sacro (viene propagandata una contro-religione), sceglie come protagonista quello Zarathustra, fondatore della religione persiana, che aveva contrapposto in modo nettissimo il bene al male. Nietzsche tramuta questo personaggio storico che aveva dato la codificazione più netta della morale in profeta di un’oltre-religione dell’essere al di là del bene e del male. Ma Nietzsche, per bocca di questo nuovo “profeta all’incontrario”, non vuole imporsi come fondatore di una nuova religione, poichè ciò non costituirebbe altro che una nuova divinizzazione di valori: ” non c’é nulla in me del fondatore di religioni: non voglio credenti, non parlo alle masse; ho paura che un giorno mi facciano santo ” ( Ecce homo ). L’unica cosa che Zarathustra insegna è di non accettare insegnamenti, ma di creare nuovi valori: egli profetizza la venuta del superuomo, ovvero dell’uomo del futuro ( ” Ancora non é esistito un superuomo. Io li ho visti tutti e due nudi, l’uomo più grande e il più meschino. Sono ancora troppo simili l’uno all’altro. In verità anche il più grande io l’ho trovato troppo umano! “) che si innesta nella civiltà postmoderna: vi sarà sì una fase provvisoria in cui esisteranno solo pochi oltreuomini in grado di cogliere come procede il futuro, ma ciò che li caratterizzerà sarà quel senso di “malattia” e di inattualità che ha accompagnato Nietzsche stesso per tutta la sua vita fino a culminare nella follia. Il superuomo sarà un essere libero, che agirà per realizzare se stesso. E’ un essere che ama la vita, che non si vergogna dei propri sensi e vuole la gioia e la felicità. E’ un essere “fedele alla terra”, alla propria natura corporea e materiale, ai propri istinti e bisogni. La “fedeltà alla terra” è fedeltà alla vita e al vivere con pienezza, è esaltazione della salute e sanità del corpo, è altresì affermazione di una volontà creatrice che istituisce valori nuovi (ecco il vero significato della volontà di potenza). Non più “tu devi”, ma “io voglio”. Soprattutto, l’oltreuomo trasvaluta tutti i valori e ne crea di nuovi, facendo della propria vita un’opera d’arte: e in Così parlò Zarathustra troviamo immagini ricorrenti , da cui traspare come l’oltreuomo sappia amare e trasmettere agli altri la gioia che deriva dalla propria piena realizzazione; il ridere e il danzare sono le sue prerogative peculiari: dopo aver smontato la verità, crolla inevitabilmente anche l’essere, giacchè la verità altro non è se non disvelamento dell’essere, e quando Nietzsche dice che ” l’essere manaca ” si avvicina soprattutto alle posizioni di Gorgia, il quale, dopo aver dimostrato che l’essere non è e che se anche fosse non sarebbe conoscibile e, se anche fosse conoscibile, comunque sarebbe incomunicabile, aveva dato una valutazione suprema dell’arte poichè, in assenza di una verità, l’artista non imita (come invece credeva Platone), ma crea e inganna; il discorso di Nietzsche è molto affine a quello gorgiano e, interpretando l’intera vita come un’opera d’arte, ciò che l’uomo crea diventa un valore assoluto e autonomo: in questa prospettiva, la risata e la danza incarnano la leggerezza dell’oltreuomo, il suo poggiare non sull’essere, ma sul vuoto simboleggiano il suo saper ” vivere in superficie “, quasi camminando sulle acque, proprio in virtù del venir meno di quella che Kant chiamava ” cosa in sè ” ed è proprio in questa prospettiva che uno dei più gravi pericoli è costituito dallo “spirito di gravità”. Costante è anche l’immagine del volo, che ben esprime la leggerezza: ” colui che un giorno insegnerà il volo agli uomini, avrà spostato tutte le pietre di confine; esse tutte voleranno in aria per lui, ed egli darà un nuovo nome alla terra, battezzandola ‘la leggera’. “; e Nietzsche può così affermare che ” l’uomo è un cavo teso fra la bestia e il superuomo […] é qualcosa che deve essere superato “, ma tale cavo è sospeso nel vuoto ed è perciò un passaggio arduo e rischioso (non a caso il funambolo presente in Così parlò Zarathustra perde l’equilibrio e cade). Sempre dalla lettura di Così parlò Zarathustra emergono altri concetti chiave della filosofia nietzschena, come ad esempio quello di “volontà di potenza” e di “eterno ritorno”. In particolare, la volontà di potenza (a cui Nietzsche dedica un’opera intitolata, appunto, La volontà di potenza ) è in un certo senso l’erede remoto della volontà schopenhaueriana: la stessa opera La nascita della tragedia era intrisa di concezioni schopenhaueriane e, soprattutto, l’elemento dionisiaco era quello in grado di cogliere la forza irrazionale che governa la realtà e che finiva per identificarsi con la volontà di Schopenhauer. Tuttavia, con la nozione di “volontà di potenza” Nietzsche si discosta dall’insegnamento del filosofo pessimista: come senz’altro si ricorderà, Schopenhauer insisteva vivamente sulla necessità di capovolgere la volontà in nolontà, quasi come se si dovesse sfuggire alla volontà stessa; ora, a partire da La nascita della tragedia , Nietzsche sostiene invece che si deve accettare fino in fondo la tragicità dell’esistenza e trovare una specie di gioia paradossale nel vivere il caos fino in fondo. In altri termini, se per Schopenhauer si deve sconfiggere la tragicità esistenziale rifiutandola, per Nietzsche la si deve vincere accettandola fino in fondo, in ogni sua sfumatura. E, con l’avvento del nichilismo, la mancanza di un senso assoluto finisce, secondo Nietzsche, per far assumere un senso assoluto proprio a quella realtà superficiale che è il mondo che ci circonda. E allora il concetto di volontà si colora di nuovi significati: in primo luogo, per Schopenhauer la volontà è l’unica cosa che esista veramente, come per Spinoza l’unica vera cosa esistente era la “Sostanza”; e per questo il discorso schopenhaueriano era metafisico a tutti gli effetti e per Nietzsche ogni discorso metafisico è del tutto inaccettabile, ovvero non si possono più fare affermazioni sulla struttura della realtà (come invece facevano Schopenhauer o Hegel) poichè, respinto il concetto di verità, ciò non ha più senso. L’oltreuomo si trova così nella situazione in cui non ci sono più l’essere nè i valori prestabiliti, e ad esistere sono solamente le interpretazioni del mondo e la nozione di interpetrazione (che fa di Nietzsche uno dei padri del pensiero ermeneutico) è originalissima: non si tratta di interpretare la verità sotto i diversi e legittimi, ma di per sè non sufficienti, punti di vista con cui si può guardare ad essa, bensì, ci sono solo interpretazioni del mondo ma non c’è più il mondo da interpretare, c’è solo più l’immagine del mondo: e Nietzsche può affermare che ” non esistono fatti, ma solo interpretazioni “. Non vi è una verità oggettiva da guardare sotto diversi profili, ma vi sono solo più i punti di vista: e se non c’è più il mondo ( ” l’essere manca “), cosa permette di dire che un’interpretazione è più valida di un’altra? Qui nuovamente emerge il concetto cardinale della filosofia nietzscheana: la vita; le interpretazioni, infatti, sono migliori o peggiori non perchè corrispondano di più o di meno ad una presunta verità, ma nella misura in cui sono più “potenti”, più convincenti, più capaci di muovere e di sostenere la vita (e questo spiega l’apprezzamento di Nietzsche per il movimento operaio). Venuto meno il mondo, esso è sostituito, potremmo dire, da un campo nel quale diversi centri di forza si confrontano tra di loro e tali centri di forza altro non sono se non le diverse interpretazioni di quel mondo che non c’è: ci saranno diverse immagini di valori, di interpretazione della realtà, e così via, e possono di volta in volta prevalere le une sulle altre proprio perchè manca la realtà con cui confrontarsi e l’unico criterio che permette ad un’interpretazione di trionfare sulle altre è basato sulla vitalità. Pertanto un’interpretazione che stimoli la vita tenderà a prevalere sulle altre e proprio in questo è racchiuso il concetto di volontà di potenza: è questo tentativo di affermare determinati valori a danno di altri, quasi il centro di un campo di forza, non una “cosa” (come invece era in Schopenhauer). Ma è bene notare come la volontà di potenza non sia volontà di esistere, poichè, propriamente, non c’è nulla che esista, ma è, invece, volontà di affermarsi (il martire cristiano non muore per esistere, ma per affermarsi); e questo ci permette di capire come, al di là di qualche sbavatura qua e là del pensiero nietzscheano, la volontà di potenza non si affermi mai in modo violento: viene seguita perchè dà un’interpretazione più forte della realtà, non perchè si impone con la violenza sui più deboli (come credevano i nazisti). E l’ultimo grande concetto presente in Così parlò Zarathustra è quello di eterno ritorno : tra i bislacchi personaggi che accomapgnano Zarathustra nella sua avventura, vi è anche un nano che espone tale dottrina, secondo cui tutto ritorna su se stesso e per cui tutto quanto accade ora è già accaduto un’infinità di volte nel passato e accadrà un’infinità di volte nel futuro. Nel formulare questa strana teoria, Nietzsche si basa anche su studi scientifici e, in particolare, sulla constatazione che meccanicisticamente le possibili composizioni della materia, per quanto numerose, si esauriscono e, dopo esserci state tutte, ritorna quella di partenza. Nella poliedricità caleidoscopica della filosofia nietzscheana, suona quasi banale questa teoria già esposta similmente dagli Stoici: tuttavia, gli animali che accompagnano Zarathustra, ad un certo punto, intonano una canzone il cui motivo è quello appunto dell’eterno ritorno, il cui significato profondo, però, non è banalmente quello del ritorno perpetuo delle medesime cose, ma è un significato recondito e profondo: tant’è che Zarathustra, in una narrazione in cui aleggia un clima onirico, racconta di aver avuto una visione e di aver visto un pastore che dormiva e a cui entra in bocca un serpente; Zarathustra cerca di aiutarlo ma, non riuscendoci, lo invita a mordere il serpente e così si salva e la vicenda si chiude con una risata liberatoria del pastore. Quale è il significato di ciò? Il serpente che si morde la coda simboleggia il tempo concepito come ciclico e che in un primo tempo può essere concepito come un qualcosa di soffocante, perchè l’idea che tutto ritorni è insostenibile poichè nessuno vorrebbe ripetere all’infinito la propria vita, proprio perchè la nostra vita non è così perfetta da poter aspirare ad essere desiderata per l’eternità. Il morso al serpente sta a significare che è vero che la dottrina dell’eterno ritorno può essere soffocante, ma solo per chi ha un’esperienza di vita non pienamente realizzata. L’oltreuomo, invece, che sa vivere in superficie e vivere pienamente la sua esistenza come un’opera d’arte, può per davvero desiderare di riviverla in eterno e tagliar la testa al serpente vuol dire spezzare il circolo del tempo che ritorna su se stesso e inserirsi in questo circolo ma se tutto torna su se stesso, si può obiettare, non c’è la possibilità di entrare in questo circolo; e questo è l’apparente paradosso della dottrina dell’eterno ritorno. E’ vero che non ci si può infilare nel circolo a nostro piacimento, ma tutto si spiega se, come ci rammenta Zarathustra, teniamo presente che le apparenze ingannano e la teoria dell’eterno ritorno è diversa da come sembra. Del resto, sarebbe assurdo che ora Nietzsche ci dicesse, prospettando i cicli dell’eterno ritorno, come procede il mondo: secondo la logica della volontà di potenza, egli vuole proporci un’interpretazione particolarmente forte del mondo, non una verità, ma un’immagine del mondo che valga la pena di essere vissuta; in altri termini, ci sta dicendo che se ci mettiamo nella prospettiva dell’oltreuomo e se quindi sappiamo vivere pienamente la vita, varrà la pena anche decidere di vivere come se la vita dovesse eternamente ritornare, momento per momento. Soltanto una vita pienamente vissuta si può desiderare che ritorni in eterno, ma solamente un qualcosa concepito come eternamente ritornante assume un valore assoluto tale da poter vivere pienamente la vita: nella dottrina del tempo lineare, ogni istante distrugge quello precedente, ogni cosa è travolta da quella che viene dopo e quindi se accetto tale dottrina non posso vivere pienamente, perchè so che ogni istante sarà distrutto da quello successivo; nella dottrina dell’eterno ritorno, invece, posso vivere la vita fino in fondo perchè ogni cosa che faccio ha un valore assoluto, poichè si sfugge tempo lineare per cui ogni cosa che si fa viene mangiata (e quindi privata di significato) da quella successiva (il mito di “Cronos”, ovvero il tempo, che divora i propri figli). Se l’eterno ritorno viene considerato non come dottrina metafisica, ma come interpretazione, allora il paradosso per cui si entra nel circolo si dilegua: posso decidere di vivere come se ci fosse l’eterno ritorno, desiderando con ardore di rivivere ogni singolo istante della vita per l’eternità ( amor fati ), quasi come se al “no” alla vita di Schopenhauer si sostituisse un “sì” eterno ad essa: ” la mia formula per la grandezza dell’uomo é amor fati: che cioè non si vuole nulla diverso da quello che é, non nel futuro, non nel passato, non per tutta l’eternità ” ( Ecce Homo ). E così, la fase precedente al nichilismo, quella cioè dei valori morali e di Dio, simboleggia l’eternità, mentre quella del nichilismo passivo, privo di valori assoluti, è il tempo lineare che tutto travolge e nulla ha senso; l’ultima fase, quella del nichilismo attivo, è il divenire continuo che assume valore assoluto e tutto ciò è quanto accade nella dottrina dell’eterno ritorno, la quale fa assumere dignità di assoluto al divenire, tutto fluisce ma in modo circolare. E così si capisce la vicenda del pastore: soffocato in principio dall’interpretazione banalizzante dell’eterno ritorno, riesce ad entrare nel circolo dell’eterno ritorno e col riso esprime la sua piena felicità.
CRONOLOGIA DELLA VITA DI NIETZSCHE
L'uomo é qualcosa che deve essere superato. (Così parlò Zarathustra)
1844
Il 15 ottobre nasce a Röken , non lontano da Lipsia , Friedrich Wilhelm Nietzsche , primogenito del pastore Karl Ludwig , a sua volta figlio di un pastore , e di Franziska Oehler , figlia anche lei di un pastore : è il giorno del compleanno del re , che il padre ammira molto , tanto da chiamare il figlio con gli stessi nomi . Il padre era stato precettore alla corte di Altenburg . Oltre ai genitori vivono in casa la nonna paterna , la sorella del padre Rosalie e una sorellastra di lui , Friederike.
1846
Il 10 luglio nasce la sorella di Nietzsche , Elisabeth.
1848
Nasce il fratello di Nietzsche , Joseph , che morirà due anni dopo . I moti del 1848 sconvolgono il padre , fervente monarchico , che alla fine di agosto si ammala (affezioni al sistema nervoso e al cervello).
1849
Il 30 luglio muore il padre in seguito ad un progressivo aggravamento dei disturbi avvertiti l'anno precedente.
1850
La madre si trasferisce a Naumburg con i due figli ; la decisione di trasferirsi a Naumburg fu presa dalla nonna paterna , che aveva in quella cittadina molti parenti . Anche le due zie si trasferiscono nella stessa casa . Nietzsche intorno a Pasqua comincia a frequentare la locale scuola . Amicizia con i coetanei Wilhelm Pinder e Gustav Krug .
1851
Insieme a Pinder e Krug entra nella scuola privata del candidato Weber , dove si insegna religione , latino e greco . In casa Krug prova le prime emozioni musicali . La madre gli regala un pianoforte . Gli viene impartita un' educazione musicale .
1856
Scrive poesie e compone musica . Muore la nonna materna . Trasferimento in un' altra casa , senza la zia Rosalie.
1858
La famiglia si trasferisce per la seconda voltain un' altra casa di Naumburg . In ottobre entra nella scuola di Pforta . Continua a comporre musica , sopratutto sacra e a scrivere poesie . Vari progetti letterari .
1859
Inizio dell' amicizia con Paul Deussen . carl von Gersdorff arriva a Pforta
1864
Conclude gli studi ginnasiali a Pforta . Dopo le vacanze estive viene immatricolato come studente di teologia a Bonn . Diventa membro del seminario di storia dell' arte e dell' associazione accademica Gustav-Adolf . Aderisce con Deussen alla Burschensheft "Franconia". Tra le altre segue le lezioni di filologia classica di Ritschl .
1865
Alla fine di gennaio decide di non comporre più musica . In maggio decide di trasferirsi a Lipsia per studiare filologia classica . Intanto anche Ritschl, per porre fine alla polemica con Otto Jahn , decide di trasferirsi a Lipsia . Si accentuano in Nietzsche alcuni disturbi che si erano manifestati già negli anni della scuola : catarro e reumatismi . Soffre di forti dolori al capo e di nausea . Dopo il trasferimento a Lipsia viene curato da due medici per sifilide . Continua gli studi su Teognide . Legge Schopenhauer .
1866
Tiene conferenze su Teognide e Suida . Inizia gli studi su Diogene e Laerzio . Stringe amicizia con Erwin Rohde . Lo studio su Teognide esce sul "Rheinisches Museum", XXII nuova serie . In gennaio tiene una conferenza sulla tradizione degli scritti aristotelici . Studia Omero e Democrito . Legge Kant (forse però solo attraverso l'esposizione di Kuno Fischer ). Il 9 ottobre comincia il servizio militare nel reparto a cavallo di un reggimento di artiglieria di stanza a Naumburg.
1868
Scrive varie recensioni di opere di filologia classica . Progetta una dissertazione , sul problema del rapporto tra Omero e Esiodo . Vorrebbe laurearsi in filosofia con una tesi su Kant . Legge la critica del giudizio di Kant e la storia del materialismo di di Lange. In marzo si ferisce gravemente al petto cadendo da cavallo . Alla metà di ottobre può lasciare il servizio militare e tornare a Lipsia . La sera dell' 8 novembre in casa dell' orientalista Hermann Brockhaus incontra per la prima volta Richard Wagner .
1869
Ottiene la cattedra di lingua e letteratura greca presso l' Università di Basilea , grazie all' appoggio di Ritschl e di Usener . In aprile raggiunge Basilea . Il 28 maggio tiene la profusione sul tema : Omero e la filologia classica . Si reca spesso , d' ora in poi , a Tribschen , dove vivono Richard e Cosima Wagner . L' Università di Lipsia gli ha intanto confermato il dottorato sulla base degli studi da lui pubblicatisul "Rheinisches Museum", compreso quello sulle fonti di Diogene Laerzio . Con grande rispetto entra in rapporto con Jakob Burckhardt .Rinuncia alla cittadinanza prussiana senza tuttavia chiedere quella svizzera .
1870
Tra gennaio e febbraio tiene due conferenze , una sul dramma musicale greco , l' altra su Socrate e la tragedia . Queste due conferenze , insieme allo scritto sulla visione dionistica del mondo , non pubblicato , costituiscono il primo nucleo del libro sulla nascita della tragedia . Conosce Franz Overbeck , di cui diventa vicino di casa . Il 9 aprile viene nominato professore ordinario . In giugno Rohde si reca a Berlino per visitare Nietzsche . In agosto in occasione della guerra franco-prussiana , Nietzsche chiede un congedo per arruolarsi come infermiere volontario . Viene però colpito dalla difterite e da dissenteria ; in settembre viene rimpatriato su un treno di feriti . Dopo un periodo di convalescenza a Naumburg , il 21 ottobre riparte per Basilea . Durante il secondo giorno di viaggio ha delle frequenti crisi di vomito .
1871
Pubblica il Certamen quod dicitur Homeri et Hesiondi e gli indici della nuova serie del "Rheinisches Museum fur Philologie" (1842-1869) . Nei mesi di gennaio e febbraio porta a termine la prima stesura della nascita della tragedia : l' editore Engelmann di Lipsia la rifiuta . In ottobre il manoscritto è accettato dall' editore di Wagner , Fritzsch . Il 29 dicembre il libro è pronto per essere messo in vendita . In gennaio Nietzsche aveva chiesto la cattedra di filosofia lasciata libera da Gustav Teichmuller . La domanda non viene accolta . Nietzsche aveva anche proposto Rohde come proprio successore . Tra luglio e agosto tenta ancora di far ottenere all' amico una cattedra a Zurigo : anche questo tentativo fallisce . Viene introdotto in casa Bachofen.
1872
Esce La nascita della tragedia dallo spirito della musica . Wagner esprime in una lettera a Nietzsche il suo entusiasmo per il libro . Il 16 gennaio tiene la prima delle 5 conferenze Sul futuro delle nostre istituzioni educative ; l' ultima risale al 23 marzo . In maggio , Ulrich von Wilamowitz-Moellendorf , che l' anno precedente aveva fatto con grande rispetto visita a Nietzsche , pubblica un opuscolo contro di lui . Wagner e Rohde prendono le difese di Nietzsche . Alla fine di luglio , riceve una visita di Deussen . Il 31 agosto incontra Malwida von Meysenburg , fervente wagneriana e sostenitrice dei moti del '48 . Nietzsche vorrebbe lasciare l' insegnamento universitario per dedicarsi interamente alla propaganda wagneriana . In maggio si era recato a Bayreuth , dove i Wagner si erano trasferiti per edificare il tempio della musica wagneriana , ma inaspettatamente non vi si reca durante le vacanze natalizie . Scrive il testo Su verità e menzogna in senso extranormale e progetta Il libro del filosofo .
1873
Esce , di nuovo presso l' editore Fritzsch di Lipsia , la prima delle Considerazioni inattuali , quella su David Strauss . Scrive La filosofia nell' epoca tragica dei Greci , senza concluderne la stesura ; questo scritto doveva rientrare in un' opera più ampia sui presocratici . Progetta una seconda Inattuale , con il titolo Il filosofo come medico della cultura . Dalla biblioteca universitaria di Basilea prende in prestito numerose opere di fisica e chimica . A partire da quest' anno , si accentuano tutte le sue sofferenze fisiche , soprattutto emicranie e vomito .
1874
Escono la seconda edizione della Nascita della tragedia e la seconda e la terza delle Inattuali , quella Sull' utilità e il danno degli studi storici per la vita e quella su Schopenhawer come educatore . In aprile compose l'inno dell'amicizia per pianoforte a quattro mani . Fa dei progetti di matrimonio . In settembre , Rohde passa due settimane a Basilea . Entra in un rapporto più stretto con Paul Rèe , che già nel ì73 aveva seguito il corso di Nietzsche sui presocratici . Trascorre le vacanze natalizie a Naumburg , dove i suoi amici Krug e Pinder gli presentano le loro mogli.
1875
Abbandona il progetto di scrivere una quarta Inattuale su noi filologi; decide invece di pubblicare come quarta Inattuale Richard Wagner a Bayreuth , che in un primo momento gli era sembrata non pubblicabile . Per tuto l' anno i suoi appunti hanno come tema la religione . Gli viene fatto dono , da parte di due suoi allievi (uno è Adolf Baumgartner , con la madre del quale Nietzsche ha stretto l' anno precedente una fruttuosa amicizia : Marie Baumgartner ha tradotto in in francese la terza Inattuale) , degli appunti relativi alle lezioni di Burckhardt sulla storia della cultura greca . Legge con interesse gli studi sulla storia della chiesa antica di Overbeck e le Considerazioni psicologiche di Rèe . In ottobre gli rende visita Gersdorff. All' inizio dell' semestre invernale , arriva a Basilea , per seguire le lezioni di Nietzsche e di Overbeck , il giovane musicista Heinrich Koselitz , più noto con lo pseudonimo di Peter Gast : diventerà uno dei discepoli più fedeli.
1876
Prima dell' inizio del festival Bayreuth , previsto per agosto , esce la quarta Inattuale , Richard wagner a Bayreuth , presso l'editore Schmeitzner di Chemnitz . Il 23 luglio Nietzsche arriva a Bayreuth dove rimane fino al 27 agosto ; riparte cioè prima della conclusione del festival . Le sue condizioni di salute sono intanto peggiorate . In settembre deve curarsi gli occhi con l' atropina . Prima dell' estate ha dovuto ridurre l'attività didattica ; a partire dal mese di ottobre ottiene un anno di congedo per motivi di salute . Parte con paulRèe per l' Italia . A Ginevra si unisce a loro Albert Brenner , un allievo di Nietzsche . Il 22 ottobre a arrivano a Genova , da dove si imbarcano per Napoli . Il 27 ottobre sono a Sorrento , ospiti di Malwida von Meysenburg , nella Villa Rubinacci , da lei presa in affitto . La sera stessa Nietzsche rende visita ai Wagner , anch' essi a Sorrento . Prima della sua partenza , Overbeck si era sposato e Rohde aveva annunciato il suo fidanzamento . In giugno e luglio aveva dettato a Peter Gast degli aforismi per una ulteriore Inattuale : questi aforismi confluiranno in Umano , troppo umano . Muore Ritschl .
1877
Marie Baumgartner ha tradotto in francese anche la quarta Inattuale , che esce presso Schmeitzner . Serate di lettura a Sorrento : Tucidide , il Vangelo di Matteo , Voltaire , Diderot , Michelet , Ranke , Storia dei papi . Verso la metà di maggio arriva a Ragaz , per cure termali ; Overbeck gli fa visita ; Nietzsche gli parla della sua intenzione di abbandonare definitivamente la cattedra . Alla metà di giugno raggiunge Rosenlauibad , percorrendo l' ultimo tratto di strada a piedi , tra l' 11 e il 17 giugno . A Rosenlauibad legge , tra l' altro , il libro di Rée sull' origine dei sentimenti morali . Ancora progetti matrimoniali ( se necessario sposerebbe anche una donna presa dalla strada ) . In agosto Rohde si sposa . Il primo settembre lascia Rosenlauibad per tornare a Basilea e riprendere l' attività universitaria . Il 2 settembre comincia a dettare a Peter Gast il testo di Umano , troppo umano , che già il 3 dicembre viene offerto all' editore Schmeitzner , che dovrà tenerlo segreto fino al maggio dell' anno successivo . Riceve l' ultima lettera di Cosima Wagner .
1878
La rottura con Wagner é ormai definitiva . In gennaio Nietzsche regala le partiture con dedica donategli da Wagner . In maggio esce la prima parte di Umano , troppo umano . In agosto compare sui " Bayreuther Blatter " un velato attacco di Wagner contro Nietzsche . Alla fine di dicembre il manoscritto della seconda parte di Umano , troppo umano é pronto .
1879
Le condizioni di salute di Nietzsche peggiorano . Spesso non é in grado di tenere le sue lezioni universitarie . A partire dal 19 marzo cessa interamente la sua attività didattica . Si reca a Ginevra per essere sottoposto a delle cure . In maggio chiede ed ottiene di essere collocato a riposo . Trascorre le settimane successive a Wiesen e a St. Moritz . In settembre raggiunge Naumburg . E' intanto uscita la seconda parte di Umano , troppo umano . Un libro per spiriti liberi . In appendice : Opinioni e sentenze diverse . Durante l' estate a St. Moritz dà vita a Il viandante e la sua ombra .
1880
Esce , sempre presso Schmeitzner Il viandante e la sua ombra . E' probabile che già in gennaio abbia cominciato a prendere i primi appunti per Aurora . Tra le letture di questo periodo particolarmente numerose ed assidue quelle riguardanti il problema morale ; legge anche il libro di Overbeck , pubblicato nel '73 , Sulla cristianità della nostra attuale teologia . Il 10 Febbraio lascia Naumburg diretto a Riva del Garda dove lo raggiunge pochi giorni dopo Peter Gast . Il 15 marzo raggiungono entrambi Venezia . Paul Rèe aiuta finanziariamente Peter Gast con grande discrezione . Luglio e agosto a Marienbad . Quando apprende che Schmeitzner si occupa di pubblicazioni antisemite , manifesta tutta la sua indignazione . All' inizio di settembre ritorna a Naumburg , che lascia quasi subito per recarsi a Heidelberg e poi a Basilea , per incontrare gli Overbeck . In ottobre si reca a Locarno , quindi a Stresa . A partire dall' 8 novembre si stabilisce a Genova , con l' intenzione di vivere nella più completa solitudine .
1881
Il manoscritto di Aurora dopo essere stato decifrato e riscritto da Peter Gast , come del resto è accaduto per le altre opere di Nietzsche , viene inviato a Schmeitzner per la stampa . Il libro esce nei primi giorni di luglio . Progetta un soggiorno a Tunisi insieme a Gersdorff . In maggio lascia Genova diretto a Vicenza , dove lo attende Peter Gast . Insieme proseguono per Recoaro : durante questo soggiorno viene coniato per Koselitz lo pseudonimo di Peter Gast . All' inizio di luglio raggiunge per la prima volta Sils-Maria dove tornerà ogni estate . Durante un' escursione ha l' idea dell' eterno ritorno . Il 1° ottobre ritorna a Genova . La salute è sempre pessima ,anche la vista subisce un peggioramento . Il 27 novembre assiste per la prima volta alla Carmen di Bizet : ne è entusiasta.
1882
All' inizio dell' anno lavora ad una prosecuzione di Aurora . Alla fine di gennaio spedisce a Peter Gast le prime tre parti . L' opera , compresa la la quarta parte , uscirà alla fine di agosto con il titolo La gaia scienza , sempre presso Schmeitzner . In febbraio Paul Rèe visita Nietzsche a Genova , portandogli una macchina da scrivere . Alla fine di marzo , a bordo di un mercantile a vela va a Messina , dove rimane fino al 20 aprile . La stesura degli Idilli di Messina precede però di alcuni giorni questo viaggio . Questi idilli , le uniche poesie pubblicate da Nietzsche al di fuori di un' opera aforistica , vengono pubblicati nel numero di maggio della "Internationale Monatsschrift" pp. 269-75 . Su invito di Malwida von Meysenbug e di Paul Rèe , Nietzsche , proveniente da Messina , arriva a Roma il 24 aprile . A Roma conosce in casa Meysenbug Lou von Salomè , che vorrebbe sposare . Incarica Rèe di portare la sua proposta a Lou . Lou parte con la madre per il lago d' Orta dove Nietzsche e Rèe le raggiungono pochi giorni dopo . Lunga passeggiata di Lou e Nietzsche sul "monte sacro" . Grande irritazione di Rèe per la loro lunga assenza . I tre avevano in precedenza progettato di trascorrere insieme un periodo di studio a Vienna o a Parigi . Tra l' 8 e il 13 maggio Nietzsche visita Overbeck a Basilea . In seguito raggiunge a Lucerna Rèe e Lou . Il 16 maggio Nietzsche torna a Naumburg , mentre Rèe e Lou si recano a Stibbe , nella Prussia orientale , presso la madre di Rèe . Nietzsche che ha svelato le sue intenzioni alla sorella affitta una casa a Tautenburg , per trascorrervi un periodo di tempo con Lou e la sorella . Nella casa di Tautenburg Lou resta dal 7 al 26 agosto . Il 27 agosto Nietzsche si reca a Naumberg e in seguito a Lipsia , dove incontrerà per l' ultima volta Rèe e Lou . Il 18 novembre riparte per Genova . In seguito si trasferisce a Portofino , a Santa Margherita e poi , dal 3 dicembre a Rapallo . La prima parte di Così parlò Zarathustra risale a questo periodo.
1883
Fino a febbraio resta a Rapallo , dove gli arriva la notizia della morte di Wagner , Alla fine di febbraio si trasferisce nuovamente a Genova . Mentre esce la prima parte di Zarathustra , Nietzsche scrive la seconda , che uscirà ancora nel corso dell' anno , e prepara la terza . Frequenti litigi e riconciliazioni con la sorella , che rivede in Giugno a Roma in casa di Malwida von Meysenbug . Trascorse l' estate a Sils-Maria . In settembre torna a Naumburg , quindi decide di trascorrere l' inverno a Nizza .
1884
Il 18 gennaio conclude la stersura della terza parte di Zarathustra , che uscirà in aprile . Nuovi litigi con la sorella , a causa del suo fidanzamento con Bernhard Forster , un antisemita e un wagneriano . In febbraio da Nizza scrive a Peter Gast che la musica è la cosa migliore e che mai come in quel momento vorrebbe essere musicista . Conversazioni con il dottor Joseph Paneth di Vienna , uno zoologo interessato alla filosofia e un amico di Freud . Il 20 aprile lascia Nizza diretto a Venezia , dove lo attende Peter Gast . Rompe i rapporti anche con la madre . Dalla metà di luglio alla fine di settembre soggiorna a Sils-Maria . Tra il 26 e il 28 agosto gli fa visita Heinrich von Stein , di cui riporta un' ottima impressione . Come già in altri momenti , ritorna l' idea della vita monacale, di un ordine filosofico (con Lou e Rèe) . La madre e la sorella gli propongono un incontro a Naumburg per una riconciliazione . Nietzsche dapprima rifiuta , poi propone un incontro a metà strada , a Zurigo . Dalla fine di settembre alla fine di ottobre è a Zurigo , dove avviene la riconciliazione con la sorella . Il 4 ottobre scrive alla madre in tono benevolo . Incontra Gottfried Keller . Trascorre il mese di novembre a Mentone , quindi ritorna a Nizza . Il progetto per la quarta parte dello Zarathustra risale alla metà di novembre.
1885
Non trovando un editore disposto a pubblicare Zarathustra IV , Nietzsche chiede a Gersdorff un aiuto finanziario per farlo stampare privatamente . Il 9 aprile lascia Nizza e raggiunge Peter Gast a Venezia . All' inizio di maggio le prime copie di Zarathustra IV sono inviate a Overbeck : l' editore dell' edizione privata è Naumanndi Lipsia . Il 22 maggio , la sorella si sposa con il dott. Forster , che ha intenzione di fondare una colonia tedesca sulle basi dei principi razzial . Nietzsche non è presente alle nozze . Il 7 giugno arriva a Sils-Maria , dove resterà fino alla metà di settembre . In seguito resta fino al 1° Novembre a Naumburg , poi raggiunge Monaco , quindi Firenze . L' 11 novembre è nuovamente a Nizza .
1886
Per la pubblicazione di Al di là del bene e del male deve nuovamente ricorrere all' edizione privata , presso Naumann ; le prime copie sono pronte all'inizio di agosto . Dopo il fallimento dell' Editore Schmeitzner le opere di Nietzsche pubblicate presso di lui vengono trasferite presso l' editore Fritzsch , che ripubblica , con nuove prefazioni di Nietzsche : I due volumi di Umano , troppo umano . Fritzsch ripubblica anche La nascita della tragedia . Ovvero : grecità e pessimismo , di cui Nietzsche premette un tentativo di autocritica . BurcKhardt scrive a Nietzsche che Al di là del bene e del male si spinge troppo lontano rispetto alla sua vecchia testa . Durante l' estate a Sils-Maria, progetta un' opera in quattro volumi sulla volontà di potenza e un' altra sull' eterno ritorno . Intanto , in febbraio , la sorella e il marito sono partiti per il Paraguay . Tra maggio e giugno , Nietzsche lasciata Nizza é a Naumburg e a Lipsia , dove assiste alle lezioni di Rohde , che da aprile é diventato professore . Dopo il soggiorno estivo in Engadina , trascorre una parte del mese di ottobre a Ruta Ligure , poi ritorna a Nizza . Prepara le prefazioni per le nuove edizioni di Aurora e della Gaia scienza .
1887
In giugno escono le nuove edizioni di Aurora e della Gaia scienza ( quest' ultima comprende ora un quinto libro e un' appendice costituita dalle Canzoni del principe Vogelfrei ) , presso Fritzsch . Anche lo Zarathustra viene ripubblicato presso lo stesso editore : questa edizione comprende soltanto le prime tre parti . Il 3 aprile Nietzsche lascia Nizza diretto diretto a Cannobio , sul Lago Maggiore . Trascorre poi una settimana a Zurigo , fino al 6 maggio , quindi raggiunge Chur , dove resta fino all' 8 giugno . A Chur apprende del fidanzamento di Lou con il dottor Andreas ; grande depressione . Rompe l' amicizia con Rohde per il giudizio irrispettoso da lui espresso circa H. Taine , con il quale Nietzsche aveva avuto nell' autunno precedente un intenso scambio epistolare . A partire dal 12 giugno è a Sils-Maria , dove scrive la Genealogia della morale , che esce presso Neumann in novembre ; le spese sono di nuovo a carico di Nietzsche . Dopo aver trascorso alcune settimane a Venezia , il 22 ottobre ritorna a Nizza . Riceve la prima lettera da Georg Brandes , professore dell' università di Copenhagen , che l' anno seguente terrà un corso su Nietzsche . Tra le pubblicazioni di quest' anno bisogna ricordare anche una composizione musicale , l' inno alla vita , per coro misto e orchestra (la melodia risale al 73/74 , mentre le parole sono quelle di una strofa della poesia preghiera alla vita di Lou von Salomè) : anche in questo caso l' editore è Fritzsch .
1888
Nietzsche resta a Nizza fino al 2 aprile , quindi raggiunge Torino , di cui riporta un' ottima impressione . A Nizza lavora all' opera sulla "svalutazione di tutti i lavori" ossia a quella che diventerà L' anticristo . A Torino lavora al caso Wagner , che il 17 luglio invia a Neumann per la stampa . Il 5 giugno ha intanto lasciato Torino per recarsi a Sils-Maria , dove resta fino al 20 settembre . Trascorre poi l' ultima parte dell' anno nuovamente a Torino . A Sils-Maria lavora al libro sulla volontà di potenza e scrive il Crepuscolo degli idoli . A Torino scrive Ecce homo , concluso il 4 novembre e spedito a Neumann , e Nietzsche contra Wagner , spedito a a Neumann il 15 dicembre . Intanto è uscito il caso Wagner ed è stata portata a termine la stampa di tutte le altre opere di Nietzsche scritte durante questo anno , compresa Ditirambi di Dioniso .
1889
Il 3 gennaio Nietzsche da gravi segni di squilibrio mentale ; nei giorni successivi scrive lettere esaltate ad amici e a personaggi pubblici . Burckhardt riceve una di queste lettere e , allarmato , avverte Overbeck , che l' 8 gennaio è a Torino ; con lui Nietzsche ritorna a Basilea , dove viene ricoverato in una clinica per malattie nervose . "La diagnosi è paralisi progressiva" . Il 17 gennaio la madre accorsa a Basilea , riporta a casa il figlio nella clinica universitaria per malattie nervose di Jena : con lei ci sono due infermieri . Presso l' editore Neumann escono intanto il Crepuscolo degli idoli , Nietzsche contra Wagner , Ecce homo . Di quest' ultima opera Overbeck aveva consigliato a Peter Gast di rimandare temporaneamente la pubblicazione . Nei primi giorni di giugno , a causa del fallimento finanziario della progettata impresa coloniale in Paraguay , il marito della sorella di Nietzsche si toglie la vita . In novembre compare Julius Langbehn , uno studioso di storia dell' arte che offre la sua collaborazione : accompagna Nietzsche nelle sue passeggiate fuori dalla clinica e parla con lui . La reazione di Nietzsche è , dopo tre settimane , negativa . Dopo il febbraio dell' anno seguente , Langbehn , che avrebbe voluto ottenere la tutela di Nietzsche , scompare dalla scena .
1890
Il 24 marzo Nietzsche può lasciare la clinica e abitare con la madre a Jena . Il 13 maggio madre e figlio lasciano Jena e tornano Naumburg : è quasi una fuga . Il 16 dicembre la sorella rientra dal Paraguay.
1891-97
Le condizioni di Nietzsche peggiorano rapidamente : nel '92 non è più in grado di riconoscere nessuno degli amici che gli fanno visita , sovente ha degli eccessi d' ira , tanto che Peter Gast teme per l' incolumità della madre . Nel '93 subentra una paralisi della spina dorsale , che gli impedisce di uscire per le passeggiate che fino ad allora la madre gli aveva fatto fare; in casa deve servirsi di una sedia a rotelle . A partire dal '94 Nietzsche che non parla più , spesso urla mentre il volto esprime grande serenità . Il 20 aprile 1897 , all' età di 71 anni , muore la madre di Nietzsche . La sorella porta il malato a Weimar presso di se . Ma chi si occupa materialmente del malato è Alwine Freytatag , da anni al servizio della madre . Intanto nel '92 , l' editore Fritzsch cede i diritti delle opere di Nietzsche a Neumann e Peter Gast comincia a curare un' edizione delle opere : in autunno esce lo Zarathustra , che per la prima volta comprende tutte le sue quattro parti . In seguito escono le Considerazioni inattuali , compreso il capitolo ecce homo ad esse relativo . Nel '93 escono umano , troppo umano , Al dì là del bene e del male e genealogia della morale. All ' inizio del '94 la sorella di Nietzsche blocca l' edizione di Peter Gast e fonda il Nietzsche-Archiv che si occuperà d' ora in poi dell' edizione completa.
1900
Verso mezzogiorno di sabato 25 agosto Nietzsche muore.
LA NASCITA DELLA TRAGEDIA
Nel 1871 Federico Nietzsche pubblica la sua memorabile opera La nascita della tragedia. In essa il grande pensatore tedesco introduce per la prima volta la distinzione tra apollineo e dionisiaco: la prima delle due categorie, caratteristica del sogno, si traduce in immagini di serena compostezza e trova la sua manifestazione più compiuta nelle arti figurative; l’altra, propria dell’ebbrezza, attiene alle pulsioni sotterranee dell’inconscio e si esprime nella musica. Il classicismo tradizionale aveva privilegiato solo la componente apollinea dello spirito greco, ma dietro l’enigmatico sorriso del Dio solare (Apollo) si cela il volto mutevole del suo fratello notturno, il nume delle orge e dei misteri: nella tragedia in virtù di un miracolo metafisico della “volontà” ellenica, compaiono in ultimo accoppiati l’uno nell’altro, e in questo accoppiamento generale si generano l’opera d’arte, altrettanto dionisiaca che apollinea, che é la tragedia attica. L’intuizione nietzscheana, pur espressa nello stile immaginoso e folgorante del profeta del superuomo, ha non solo il merito di aver gettato le basi per i successivi approfondimenti del problema, ma soprattutto quello di aver colto il carattere di coincidentia oppositorum, di sintesi dialettica dei contrari, che é il fulcro stesso del dramma greco, elemento questo che troverà riscontri precisi in molte delle teorie elaborate più tardi.Tra i libri pubblicati da Nietzsche, se escludiamo gli scritti filologici, questo è l’unico dedicato ai Greci. Nessun altro libro di Nietzsche ha alle spalle una preparazione così lunga e faticosa. Per dieci anni il giovane studioso vive tra i suoi libri, accetta la tradizione della filologia, ammonisce i suoi amici a reprimere la fantasia, a rispettare il metodo, a controllare le ipotesi. Poi scrive questo libro, dove tutto è contraddetto. In esso Nietzsche propone una nuova visione della classicità, non quella della cultura europea che riflette la civiltà greca della decadenza, quando la sua forza creativa si è estinta, ma l’originario spirito greco, fatto di due elementi: un elemento dionisiaco oscuro, irrazionale, indefinito e ambiguo, che avverte la caoticità dell’essere, la vitalità, la spontaneità, l’ebbrezza e che si esprime con la musica e la danza, un elemento apollineo, luminoso, ben definito, che produce un mondo di forme limpide e definite e che si esprime con la scultura e le arti figurative. Nella grande tragedia greca (Eschilo e Sofocle) si compongono i due impulsi: la musica vi rappresenta il dionisiaco, la vicenda dell’eroe la definitezza apollinea. Noi siamo circondati dallo spettacolo, tutto oggi è spettacolo, non soltanto il teatro, il cinema, la televisione. Oggi anche gli uomini d’azione guardano, più che non agiscano. Perciò si rimane atterriti , quando viene qualcuno a rivelare che cosa fu la tragedia greca. D’un tratto ci si accorge che quello non era soltanto un vedere, che quello spettacolo era l’essenza del mondo, contagiante, soverchiante gli oggetti che crediamo reali. Quindi la sensazione moderna “questo è soltanto uno spettacolo” è l’inverso dell’emozione della tragedia greca che faceva dire “questa è soltanto la verità quotidiana”. L’uomo di oggi va a teatro per rilassarsi, per scaricarsi dal peso di tutti i giorni, perchè ha bisogno di qualcosa che sia soltanto spettacolo. Lo spettatore della tragedia greca veniva e “conosceva” qualcosa di più sulla natura della vita perchè veniva contagiato dall’interno, investito da una contemplazione, cioè da una conoscenza, che già esisteva prima di lui, che saliva dall’orchestra e suscitava la sua contemplazione, si confondeva con essa. E se la via dello spettacolo fosse la via della conoscenza, della liberazione, della vita insomma? Tale è la domanda posta da La nascita della tragedia. Già Euripide tende ad eliminare dalla tragedia l’elemento dionisiaco, col predominio del raziocinio; poi Socrate e Platone sono “gli strumenti di dissoluzione greca, gli pseudogreci, gli antigreci”. Socrate fu ostile alla vita, volendo dominare e soffocare l’istintività spontanea in nome della ragione. Un brano dall’opera “La nascita della tragedia” : Apollineo e dionisiaco. Questi nomi li prendiamo in prestito dai greci, i quali rendono percepibili all’intelligenza le profonde dottrine della loro visione estetica non già per il mezzo di concetti astratti, ma con raffigurazioni chiare ed incisive della mitologia. Alle loro due divinità che simboleggiavano l’arte, Apollo e Dioniso, si riallaccia la nostra teoria, che nel mondo greco esiste un contrasto, enorme per l’origine e i fini, fra l’arte plastica, cioè l’apollinea, e l’arte non plastica della musica, cioè la dionisiaca; questi due istinti così diversi camminano uno accanto all’altro, per lo più in aperto dissidio, stimolandosi reciprocamente a sempre nuove e più gagliarde reazioni per perpetuare in sé incessantemente la lotta di quel contrasto, su cui la comune parola di “arte” getta un ponte che è solo apparente: finchè in ultimo, riuniti insieme da un miracolo metafisico prodotto dalla “volontà” ellenica, essi appaiono finalmente in coppia e generano in quest’accoppiamento l’opera d’arte della tragedia attica, che è tanto dionisiaca quanto apollinea. Uno degli aspetti dell’insuperabile fascino di quest’opera consiste proprio, probabilmente, nella peculiare mescolanza di filologia e filosofia, in una misura e con risultati che non trovano precedenti nella grande filologia-filosofia romantica. La Nascita della tragedia é insieme una reinterpretazione della Grecità, una rivoluzione filosofica ed estetica, una critica della cultura presente e un programma di rinnovamento di essa. Il Greco conobbe e sentì i terrori e le atrocità dell’esistenza: per poter comunque vivere, egli dovette porre davanti a tutto ciò la splendida nascita sognata degli dei olimpici. L’enorme diffidenza verso le forze titaniche della natura […] fu dai Greci ogni volta superata, o comunque nascosta e sottratta alla vista, mediante quel mondo artistico intermedio degli dei olimpici. Proprio gli dei olimpici sono il mezzo con cui i greci sopportano l’esistenza, della quale hanno visto la caducità, la vicenda dolorosa di vita e morte, soffrendone in modo profondo a causa della loro esasperata sensibilità; gli dei olimpici giustificano la vita umana vivendola essi stessi, perchè la vivono in una luce senza ombre e fuori dall’angoscioso incombere della morte. La portata liberatoria delle figure degli dei olimpici si esercita solo se essi rimangono in un rapporto profondo con il dionisiaco, cioè con il mondo del caos al quale pure devono aiutarci a sfuggire. Il rapporto fra apollineo e dionisiaco é innanzitutto un rapporto fra forze all’interno dell’uomo singolo, che all’inizio dell’opera Nietzsche paragona agli stati del sogno (l’apollineo) e dell’ebbrezza (il dionisiaco); e che funziona nello sviluppo della civiltà come la dualità dei sessi nella conservazione della specie. Tutta la cultura umana é frutto del gioco dialettico di questi due impulsi. Sul piano della specifica teoria dell’arte, la dualità permette di leggere le varie fasi dell’arte greca in relazione alla lotta tra impulso dionisiaco e apollineo, lotta che si dispiega anche come conflitto tra popoli diversi, nel succedersi di invasioni e assestamenti che caratterizza la storia della Grecia arcaica. Così l’arte dorica si dispiega solo come risultato di una resistenza dell’apollineo agli assalti, che sono anche veri e propri attacchi di popoli invasori, del dionisiaco, dei culti orgiastici di origine barbarica. Nella lotta dei due princìpi avversi, la storia greca antica si suddivide in 4 grandi periodi artistici ; dall’età del bronzo, con le sue titanomachie e la sua aspra filosofia popolare, si sviluppò, sotto il dominio dell’istinto di bellezza apollinea, il mondo omerico; questa magnificenza “ingenua” venne di nuovo inghiottita dal fiume irrompente del dionisiaco, e di fronte a questa nuova potenza l’apollineo si elevò alla rigida maestà dell’arte dorica e della visione dorica del mondo. Al predominio dell’uno o dell’altro impulso si legano poi le diverse arti: se la musica é arte prevalentemente dionisiaca, la scultura e l’architettura sono apollinee, e così l’epopea. Ed é la tragedia attica che si prospetta come la più perfetta ed equilibrata sintesi tra i due impulsi: secondo Nietzsche essa nasce dal coro dei Satiri, ossia la processione sacra in cui i partecipanti si trasformano in finti esseri naturali. Questo mondo non é più un mondo di fantasia, situato arbitrariamente fra cielo e terra; bensì un mondo di realtà e credibilità pari a quella che possedeva, per il Greco religioso, l’Olimpo con tutti i suoi abitatori. Ma la tragedia greca va intesa, secondo Nietzsche, come coro dionisiaco che sempre di nuovo si scarica in un mondo apollineo di immagini. Ma il profeta del superuomo indaga anche perchè la tragedia ad un certo punto sia morta e giunge alla nota conclusione che l’autore di questo suicidio é stato Euripide, che ha portato lo spettatore sulla scena: ha trasformato il mito tragico in un susseguirsi di vicende razionalmente concatenate e comprensibili, di stampo sostanzialmente realistico. E se Euripide trasforma in senso realistico e razionale il mito tragico, lo fa per soddisfare le esigenza di un determinato spettatore, Socrate, il quale inaugura nella mentalità greca una visione razionale del mondo e delle vicende umane, secondo la quale al giusto non può accadere nulla di male, nè nella vita terrena nè nell’aldilà. E la stessa introduzione euripidea del prologo, con il quale spiega fin da principio l’azione, toglie alla tragedia ogni tensione epica e eccitante incertezza. E visto che tutto deve andare razionalmente, si intende anche la necessità del deus ex machina. Se c’é una struttura razionale dell’universo, come crede Socrate, allora il tragico perde il suo significato, non ha più senso. Nietzsche arriva a criticare il carattere unilaterale e riduttivo della cultura tedesca del suo tempo, in cui predomina l’uomo teoretico alla Socrate. Questi corrisponde al mondo della scienza e della divisione tecnica dei compiti; esso é caratterizzato dalla fiducia nella possibilità di correggere il mondo per mezzo del sapere, in una vita guidata dalla sola scienza. Il prototipo e il capostipite di tale modello culturale é proprio Socrate, che inaugura il metodo di comprensione della realtà mediante concetti. Con ciò l’arte stessa viene subordinata al concetto e si stempera nella visione delle forme apollinee, di cui non si coglie la radice profonda nel dolore e nella durezza della vita. Nietzsche vede la possibilità di una ripresa dello spirito tragico, andato perduto per colpa di Euripide e Socrate, una ripresa intesa come sapienza che si volge con immobile sguardo all’immagine totale del mondo, cercando di cogliere in essa l’eterna sofferenza come sofferenza propria. Si tratta di andare oltre i limiti della cultura teoretica, incapace di poter scrutare, sulla base della causalità, l’intima essenza delle cose e di superare lo spirito critico-storico della cultura presente,che si riduce a raccattare elementi disgregati dietro la spinta di una eccessiva brama di sapere, e riannodare il legame tra vita e mito. In questa fase del suo pensiero, Nietzsche risulta particolarmente influenzato dalla metafisica di Schopenhauer, con la distinzione tra mondo della rappresentazione e mondo della volontà, sia dal dramma musicale wagneriano, che intende essere opera d’arte totale , con la fusione di musica , mito, azione, testo poetico e plasticità scenica. si Riportiamo qui sotto un passo in cui Nietzsche parla della visione dionisiaca del mondo:
I
I Greci, che esprimono e al tempo stesso nascondono la dottrina segreta della loro visione del mondo nei loro dèi, hanno stabilito come duplice fonte della loro arte due divinità Apollo e.Dioniso. Questi nomi rappresentano nel dominio dell’arte dei contrari stilistici, che incedono l’uno accanto all’altro quasi sempre in lotta tra loro, e appaiono fusi una volta soltanto, quando culmina la «volontà» ellenica, nell’opera d’arte della tragedia attica. In due stati, difatti, l’uomo raggiunge il sentimento estatico dell’esistenza, nel sogno e nell’ebbrezza. La bella illusione del mondo del sogno dove ogni uomo è artista pieno, è madre di ogni arte figurativa e altresì come vedremo, di una metà importante della poesia. Noi godiamo in una comprensione immediata della figura, tutte le forme ci parlano; non vi è nulla di indifferente e di non necessario. Nella vita suprema di questa realtà di sogno traluce ancora tuttavia il nostro sentimento della sua illusorietà solo quando cessa questo sentimento, si presentano gli effetti patologici, in cui il sogno non ristora più e cessa la forza naturale risanatrice di quello stato. Entro tale limite non sono tuttavia soltanto le immagini piacevoli e benigne a essere da noi ricercate con quella perspicacia universale in noi stessi: anche ciò che è serio, triste, torbido, oscuro viene contemplato con la stessa gioia, senonché anche qui il velo dell’illusione si muove svolazzando e non può nascondere totalmente le forme fondamentali della realtà. così mentre il sogno è il giuoco del singolo uomo con il reale, l’arte dello scultore (in senso ampio) è il giuoco con il sogno. La statua come blocco di marmo è qualcosa di assai reale, ma la realtà della statua in quanto figura di sogno è la persona vivente del dio. Sintanto che la statua rimane di fronte agli occhi dell’artista come immagine fantastica, egli giuoca ancora con il reale: se traduce questa immagine nel marmo egli giuoca con il sogno. Orbene, in quale senso Apollo poteva essere considerato come il dio dell’arte? Solo in quanto è il dio delle rappresentazioni di sogno. Egli è in tutto e per tutto il «risplendente» nella sua radice più profonda è il dio del sole e della luce, che si manifesta nel fulgore. La «bellezza» è il suo elemento: a lui si accompagna la gioventù eterna. Ma anche la bella illusione del mondo del sogno è il suo dominio: la verità superiore, la perfezione, di questi stati in antitesi alla realtà diurna lacunosamente comprensibile, lo innalzano a dio vaticinante, ma altrettanto sicuramente a dio artistico. Il dio della bella illusione dev’essere al tempo stesso il dio della conoscenza vera. Quel tenue confine, peraltro, che l’immagine di sogno non può oltrepassare, se non vuol agire patologicamente là dove la parvenza non soltanto illude ma inganna, non può mancare nell’essenza di Apollo: quella delimitazione piena di misura, quella libertà dai moti più selvaggi, quella saggezza e quiete del dio plastico. Il suo occhio dev’essere «solarmente» calmo: su di esso, anche quando si adira e guarda di malumore, sta la consacrazione della bella parvenza. L’arte dionisiaca per contro si fonda sul giuoco con l’ebbrezza, con il rapimento. Sono soprattutto due forze, che portano l’ingenuo uomo naturale all’oblio di sé nell’ebbrezza, ossia l’impulso primaverile e la bevanda narcotico. I loro effetti sono simboleggiati nella figura di Dioniso. In entrambi gli stati viene spezzato il principium individuationis, l’elemento soggettivo svanisce completamente di fronte alla violenza prorompente dell’elemento generalmente umano, anzi universalmente naturale. Le feste di Dioniso non solo stringono il legame tra uomo e uomo, ma riconciliano anche uomo e natura. Spontaneamente la terra offre i suoi doni e gli animali più feroci si avvicinano pacificamente: il carro di Dioniso, incoronato di fiori, è tirato da pantere e da tigri. Tutte le divisioni di casta, stabilite tra gli uomini dalla necessità e dall’arbitrio, scompaiono: lo schiavo è uomo libero, il nobile e l’uomo di basse origini si riuniscono nei medesimi cori bacchici. Il vangelo dell’ «armonia universale» si aggira da un luogo a un altro in schiere sempre più numerose: cantando e danzando, l’uomo si manifesta come membro di una comunità superiore e più ideale; ha disimparato a camminare e a parlare. C’è di più egli si sente preda di un incantesimo ed è realmente diventato qualcosa di differente. Come gli animali parlano e la terra dà latte e miele, così anche risuona da lui qualcosa di soprannaturale. Egli sente se stesso come dio, e quello che altrimenti viveva solo nella sua immaginazione, ora egli lo sente in se stesso. Che cosa sono ora per lui i ritratti e le statue? L’uomo non è più artista: è diventato opera d’arte, si aggira ora in estasi e in alto, così come in sogno vide aggirarsi gli dèi. Si rivela qui il potere artistico della natura, non più quello di un solo uomo: un’argilla più nobile, un marmo più prezioso vengono qui plasmati e sgrossati, ossia l’uomo. Quest’uomo formato dall’artista Dioniso sta rispetto alla natura nello stesso rapporto in cui la statua sta rispetto all’artista apollineo. Se dunque l’ebbrezza è il giuoco della natura con l’uomo, la creazione dell’artista dionisiaco è allora il giuoco con l’ebbrezza. Questo stato, se non lo si è sperimentato personalmente, lo si può intendere solo simbolicamente: è qualcosa di simile a quando si sogna e al tempo stesso si avverte che il sogno è appunto un sogno. Il seguace di Dioniso deve così trovarsi nell’ebbrezza e al tempo stesso stare fuori di sé come un osservatore in agguato. La maestria artistica dionisiaca non si rivela in un’alternanza di assennatezza e di ebbrezza, bensì nella loro consistenza. Questa consistenza caratterizza il punto culminante della grecità: in origine soltanto Apollo è il dio ellenico dell’arte, e fu la sua potenza ad ammansire Dioniso che veniva all’assalto dall’Asia, al punto che fra essi poté sorgere la più bella lega fraterna. Qui si può comprendere con la massima facilità l’incredibile idealismo della natura ellenica: un culto naturale, che presso gli Asiatici significava lo scatenamento più rozzo degli istinti inferiori, una vita animalesca pansessuale, che per un determinato tempo spezzava tutti i vincoli sociali, diventò presso di loro una festa di redenzione del mondo, un giorno di trasfigurazione. Tutti gli impulsi sublimi del loro essere si manifestarono in questa idealizzazione dell’orgia. Mai tuttavia la grecità aveva corso un pericolo più grande che all’approssimarsi tempestoso del nuovo dio. D’altro canto, mai la sapienza di Apollo delfico si mostrò in una luce più bella. Dapprima Apollo, ricalcitrante, avvolse il possente avversario con la più sottile delle reti, cosicché quest’ultimo quasi non si accorse di andare in giro come prigioniero a metà. Quando la classe sacerdotale di Delfi ebbe indovinato il profondo influsso del nuovo culto sui processi rigenerativi della società e lo ebbe favorito in conformità ai suoi fini politico-religiosi, quando l’artista apollineo ebbe imparato con avveduta moderazione dall’arte rivoluzionaria dei culti bacchici, quando infine il dominio annuale nell’ordinamento delfico del culto fu spartito tra Apollo e Dioniso, allora entrambi gli dèi uscirono, si può dire, come vincitori dalla loro gara: una conciliazione sul campo di battaglia. Se si vuol vedere con piena chiarezza, con quale violenza l’elemento apollineo sottomise l’aspetto irrazionalmente soprannaturale di Dioniso, si pensi al fàto che nel periodo antico della musica; il génos dithyrambikón era al tempo stesso l’esykhastikón. Quanto più possentemente poi crebbe lo spirito artistico apollineo, tanto più liberamente si sviluppò il dio fratello Dioniso: nello stesso tempo in cui lo spirito apollineo giunse a una visione piena, per così dire immobile della bellezza, nell’epoca di Fidia, Dioniso interpretò nella tragedia gli enigmi e i terrori del mondo, ed espresse nella musica tragica il più intimo pensiero della natura, la trama della «volontà» entro e al di sopra di tutte le apparenze. Se la musica è anche arte apollinea, allora a rigore è soltanto il ritmo a sviluppare la sua forza figurativa, per la rappresentazione di stati apollinei: la musica di Apollo è architettura in suoni, precisamente in suoni appena accennati, quali appartengono alla cetra. Viene cautamente tenuto lontano proprio l’elemento che costituisce il carattere della musica dionisiaca, anzi della musica in generale, ossia la forza sconvolgente del suono e il mondo assolutamente incomparabile dell’armonia. Per quest’ultima il Greco aveva la più fine sensibilità come dobbiamo desumere dalla rigorosa caratterizzazione delle tonalità anche se il bisogno di un’armonia realizzata, realmente risonante, era presso di loro assai minore che nel mondo moderno. Nella successione armonica, -e già nella sua semplificazione la cosiddetta melodia- la «volontà» si manifesta in modo del tutto immediato, senza essere entrata precedentemente in una apparenza. Ogni individuo può servire come simbolo, per così dire come caso singolo per una regola generale. Viceversa poi l’artista dionisiaco renderà immediatamente comprensibile l’essenza di ciò che appare: egli domina anzi sul caos della volontà che non ha ancora acquistato una figura, e da ciò in ogni momento creativo può produrre un mondo nuovo, ma altresì quello antico, noto come apparenza. In quest’ultimo senso egli è un musicista tragico. Nell’ebbrezza dionisiaca, nell’infuriare tumultuoso di tutte le tonalità dell’anima a causa dell’eccitazione narcotico oppure nello scatenamento degli impulsi primaverili, la natura si manifesta nella sua forza suprema: essa lega di nuovo assieme i singoli esseri e fa che si sentano unificati; a questo modo il principium individuationis appare come un permanente stato di debolezza della volontà. Quanto più la volontà è intristita, tanto più tutto si frantuma nella singolarità, quanto più egoisticamente l’individuo si sviluppa, tanto più debole è l’organismo cui esso serve. In quegli stati si manifesta come un carattere sentimentale della natura, un «sospiro della creatura» per quello che ha perduto. Dal sommo della gioia risuona il grido del terrore, lo struggente lamento per una perdita irreparabile. La natura rigogliosa celebra i suoi Saturnali e al tempo stesso i suoi riti funebri. Gli affetti dei suoi sacerdoti sono mescolati nel modo più mirabile, i dolori suscitano piacere, il giubilo strappa al petto accenti strazianti. Il dio, o lysios, ha liberato ogni cosa da se stessa, ha trasformato tutto. Il canto e la mimica di masse così eccitate, in cui la natura si presentava come voce e come movimento, era qualcosa di assolutamente nuovo e inaudito per il mondo greco-omerico; c’era qualcosa di orientale che anzitutto esso, con la sua enorme forza ritmica e figurativa, doveva dominare, e del resto dominò nello stesso tempo in cui dominò lo stile dei templi egiziani. Fu il popolo apollineo a incatenare con la bellezza quell’istinto strapotente: esso ha sottoposto al giogo gli elementi più pericolosi della natura, le sue bestie più feroci. Si ammira al massimo la potenza idealistica della grecità quando si confronta la sua spiritualizzazione delle feste di Dioniso con quello che è sorto presso altri popoli dalla stessa origine. Feste simili sono antichissime e rintracciabili ovunque: le più famose si ritrovano a Babilonia, sotto il nome di Sacee. Qui, in feste che duravano cinque giorni, ogni vincolo statale e sociale veniva spezzato; il nucleo di esse peraltro stava nella sfrenatezza sessuale, nell’annientamento di ogni legame familiare attraverso una illimitata dissolutezza. L’antitesi a ciò è offerta dal quadro delle feste greche di Dioniso, che Euripide traccia nelle Baccanti; da questo quadro spira la stessa leggiadria, la stessa ebbrezza musicale di trasfigurazione, che Scopa e Prassitele hanno tradotto in scultura. Un messaggero racconta di essere salito con le greggi, nella calura meridiana, sulle cime dei monti: è il momento giusto e il luogo giusto, per vedere ciò che mai si vede; ora Pan dorme, ora il cielo è lo sfondo immoto di un fulgore, ora il giorno fiorisce. Su un prato montano il messaggero scorge tre cori di donne, distese qua e là sul terreno e piene di contegno; molte donne sono appoggiate a tronchi di abete. Tutte sonnecchiano. All’improvviso la madre di Penteo comincia a esultare, il sonno è scacciato, tutte saltano su un modello di nobili costumi – le giovani fanciulle e le donne sciolgono i capelli sulle spalle; la pelle di capriolo viene riordinata se nel sonno i nastri e i fiocchi si sono sciolti. Ci si cinge con serpenti, che familiarmente lambiscono le gote; alcune donne prendono in braccio lupacchiotti e giovani caprioli, e li allattano. Tutte si adornano con corone d’edera e fiori di convolvolo; un colpo di tirso sulle rocce e l’acqua sgorga fuori; un colpo con il bastone sul terreno e sale uno zampillo di vino. Dolce miele gocciola dai rami quando qualcuno tocca il terreno solo con la punta delle dita, salta fuori latte bianco come neve. È tutto un mondo incantato, la natura celebra la sua festa di riconciliazione con l’uomo. Il mito dice che Apollo ha di nuovo ricomposto Dioniso sbranato. Tale è l’immagine di Dioniso rigenerato da Apollo, salvato dalla sua lacerazione asiatica. II Nella perfezione in cui già ci si presentano in Omero, gli dèi greci non possono certo intendersi come prodotti della necessità e del bisogno: tali esseri sicuramente non sono stati inventati da un animo scosso dall’angoscia. Non è per ritrarsi dalla vita, che una geniale fantasia ha proiettato nel vuoto le loro immagini. Attraverso queste parla una religione della vita, non già una religione del dovere o dell’ascetismo o della spiritualità Tutte queste figure esprimono il trionfo dell’esistenza, un rigoglioso sentimento di vita accompagna il loro culto. Esse non pretendono: in loro è divinizzare ciò che sussiste, sia esso buono o cattivo. Confrontata alla serietà alla santità e al rigore di altre religioni, la religione greca corre il pericolo di essere sottovalutata come un divertimento fantastico – nel caso in cui non ci si rappresenti un tratto di profondissima sapienza, spesso disconosciuto, mediante cui quella realtà epicurea degli dèi d’improvviso appare come una creazione dell’incomparabile popolo di artisti, e quasi come la sua suprema creazione. È la filosofia del popolo, quella svelata ai mortali dall’incatenato dio silvano: «La cosa migliore è di non esistere, e la migliore dopo questa è di morire presto». È questa stessa filosofia che costituisce lo sfondo di quel mondo di dèi. Il Greco conosceva i terrori e le atrocità dell’esistenza, ma li velò per potere vivere: una croce nascosta tra le rose, secondo il simbolo di Goethe. Quel fulgente mondo olimpico ha affermato il suo dominio soltanto perché l’oscuro governo dellamoîra, che determina per Achille la morte precoce e per Edipo le nozze orrende, doveva venir nascosto attraverso le risplendenti figure di Zeus, di Apollo, di Hermes eccetera. Se qualcuno avesse tolto di mezzo l’illusione artistica di quel mondo intermedio, si sarebbe dovuto seguire la sapienza del dio silvano, del seguace dionisiaco. Fu tale stato di necessità onde il genio artistico di questo popolo ha creato tali dèi, Perciò una teodicea non fu mai un problema ellenico: ci si guardò dall’addossare agli dèi l’esistenza del mondo, e quindi la responsabilità per la sua configurazione. Anche gli dèi sono sottomessi all’anánke: questo è un riconoscimento della più rara sapienza. Vedere la propria esistenza – quale si presenta – in uno specchio trasfigurante, e difendersi con questo specchio dalla Medusa, ecco la strategia geniale della «volontà» ellenica, in generale per poter vivere. Come avrebbe infatti potuto sopportare altrimenti l’esistenza quel popolo infinitamente sensibile, così splendidamente recettivo al dolore, se tale esistenza non gli si fosse rivelata, avvolta da una gloria superiore, nei suoi dèi? Lo stesso impulso che trae alla vita l’arte, in quanto integrazione e compimento che inducono a continuare la vita, fece sorgere altresì il mondo olimpico, un mondo della bellezza, della quiete, del godimento. Sotto l’influsso di una tale religione, la vita viene intesa nel mondo omerico come qualcosa in sé desiderabile: la vita cioè nel chiaro splendore solare di tali dèi. Il dolore degli uomini omerici si riferisce alla dipartita da questa esistenza, soprattutto a una precoce dipartita: quando in genere si leva un lamento, questo risuona per «Achille dalla breve vita», per i rapidi mutamenti della stirpe umana, per la scomparsa dell’epoca eroica. Non è indegno dei più grandi eroi il desiderare ardentemente una lunga vita, sia pure come salariati. Mai la «volontà» si è espressa più apertamente che nella grecità il cui lamento è ancora un canto di lode per la volontà Perciò l’uomo moderno si strugge per quell’epoca in cui egli crede di avvertire la piena consonanza tra natura e uomo; perciò la grecità è la parola risolutiva per tutti coloro che vanno cercando fulgidi modelli per la loro cosciente affermazione della volontà, perciò infine è sorto dalle mani di sensuali scrittori il concetto di «serenità greca», cosicché in modo irriverente una vita dissoluta di fannulloni osa giustificarsi, anzi innalzarsi, con la parola «greco». In tutte queste rappresentazioni che da quanto è più nobile si sviano in quanto è più volgare, la grecità è intesa in modo troppo rozzo e semplice, e in un certo senso è stata raffigurata secondo l’immagine di nazioni non ambigue, per così dire unilaterali (per esempio i Romani). Tuttavia il bisogno di illusione artistica dovrebbe essere supposto altresì nella visione del mondo di un popolo che suole trasformare in oro tutto ciò che tocca. In questa visione del mondo noi troviamo del resto realmente, come già si è accennato, un’enorme illusione, la stessa illusione di cui la natura si serve così regolarmente per raggiungere i suoi scopi. Il vero scopo viene coperto da un’immagine illusoria: tendiamo le mani verso questa, e la natura raggiunge quello attraverso il nostro errore. Nei Greci la volontà volle intuire se stessa trasfigurata in opera d’arte: per glorificarsi, le sue creature dovettero sentire se stesse come degne di glorificazione, dovettero rivedere se stesse in una sfera superiore, sollevate per così dire in una sfera ideale, senza che questo mondo perfetto dell’intuizione agisse come imperativo o come rimprovero. Questa è la sfera della bellezza, dove essi contemplano le loro immagini in uno specchio, gli dèi olimpici. Con quest’arma la volontà ellenica lottò contro il talento, correlativo a quello artistico, del dolore e della sapienza del dolore. Da questa lotta e come monumento della vittoria di questa volontà è nata la tragedia. L’ebbrezza del dolore e il bel sogno hanno i loro differenti mondi divini: la prima penetra con l’onnipotenza del suo essere nei pensieri più intimi della natura, riconosce il terribile impulso all’esistenza e al tempo stesso la morte continua di tutto ciò che entra nell’esistenza; gli dèi che essa crea sono buoni e cattivi, rassomigliano al caso, incutono terrore con una sistematicità che si manifesta all’improvviso, sono spietati e privi di gusto per il bello. Essi sono parenti della verità e si avvicinano al concetto: raramente e difficilmente assumono una figura. Il contemplarli pietrifica: come si potrebbe vivere con loro? Ma non lo si deve: questa è la loro dottrina. Da questo mondo divino, se non lo si poteva velare totalmente come un segreto degno di punizione, si doveva distogliere lo sguardo mediante la splendente creazione di sogno – posta al suo fianco – del mondo olimpico: tanto più in alto perciò si infiammano i colori di quest’ultimo e tanto più sensuali diventano le sue figure, quanto più fortemente si fa valere la verità o il simbolo di essa. Mai però la lotta tra verità e bellezza fu più grande che durante l’invasione del culto di Dioniso: in esso la natura si svelava e parlava con terrificante chiarezza del suo segreto, ossia con il suono, di fronte al quale la seducente illusione quasi perdette il suo potere. Questa sorgente sgorgava in Asia, ma in Grecia dovette diventare fiume, poiché qui per la prima volta trovò ciò che in Asia non le era stato offerto, la più eccitabile sensibilità e recettività al dolore, accoppiate alla più sottile perspicacia e riflessione. Come poté Apollo salvare la grecità? Il nuovo venuto fu accolto nel mondo della bella illusione, nel mondo degli dèi olimpici: a lui furono sacrificati molti onori spettanti alle più ragguardevoli divinità per esempio a Zeus e ad Apollo. Non si sono mai fatti tanti complimenti con un forestiero; per di più era anche un forestiero terribile (hostis in ogni senso), abbastanza possente da demolire la casa che l’ospitava. In tutte le forme della vita cominciò una grande rivoluzione: ovunque penetrò Dioniso, anche nell’arte. La contemplazione, la bellezza e l’illusione circoscrivono la sfera dell’arte apollinea: si tratta del mondo trasfigurato dell’occhio, che crea artisticamente nel sogno, con le palpebre abbassate. Anche la poesia epica vuol condurci a questo stato di sogno: non dobbiamo veder nulla con gli occhi aperti e dobbiamo pascerci delle immagini interiori, alla cui produzione cerca di stimolarci il rapsodo con i suoi concetti. L’effetto delle arti figurative viene qui raggiunto attraverso una strada più lunga: mentre lo scultore ci conduce, con il suo marmo sgrossato, verso il dio vivente, da lui contemplato in sogno, in modo tale che la figura – la quale propriamente si presenta come télos – diventa chiara tanto per lo scultore quanto per lo spettatore, e il primo conduce il secondo a seguirlo nella contemplazione attraverso la figura mediatrice della statua, il poeta epico invece, che pure vede la stessa figura vivente e vuole anch’egli presentarla all’intuizione di altri, non pone tra sé e gli uomini alcuna statua, ma piuttosto racconta in che modo quella figura dimostra la propria vita con movimenti, suoni, parole e azioni, e ci costringe a ricondurre una grande quantità di effetti alla loro causa, obbligandoci a una composizione artistica. Egli ha raggiunto il suo scopo, quando vediamo chiaramente di fronte a noi la figura, o il gruppo, o l’immagine, ossia quando ci comunica quello stato di sogno in cui egli stesso ha anzitutto prodotto quelle rappresentazioni. La spinta a creare plasticamente, impressa dalla poesia epica, dimostra come la lirica sia assolutamente diversa dall’epica, poiché la prima non tende mai a formare immagini. L’elemento comune tra le due è soltanto qualcosa di materiale, la parola, e ancor più generalmente il concetto. Quando parliamo di poesia, non intendiamo una categoria che sia coordinata con l’arte figurativa e con la musica, ma intendiamo piuttosto un conglomerato di due mezzi artistici in sé totalmente diversi, l’uno dei quali indica una strada verso l’arte figurativa, e l’altro una strada verso la musica: entrambi sono però soltanto vie che conducono alla creazione artistica, e non già arti. In questo senso, naturalmente, anche la pittura e la scultura sono soltanto mezzi artistici: la vera arte è il poter creare immagini, non importa poi che si tratti di una creazione primitiva oppure indotta. Su questa qualità che è universalmente umana, si fonda l’importanza dell’arte per la cultura. L’artista – come colui che con strumenti artistici costringe all’arte – non può essere al tempo stesso l’organo assorbente della comunicazione artistica. Il culto figurativo della civiltà apollinea, sia che questa si manifestasse in un tempio, in una statua oppure nell’epos omerico, trovò uno scopo sublime nell’esigenza etica della misura, che corre parallela all’esigenza estetica della bellezza. La misura stabilita come esigenza è possibile solo nel caso in cui la misura, il limite siano considerati conoscibili. Per mantenere i propri limiti, li si deve conoscere: di qui l’esortazione apollinea gnôthi seautón.Ma il solo specchio in cui il Greco apollineo poteva vedere, cioè riconoscere se stesso, era il mondo degli dèi olimpici: qui peraltro egli riconosceva la sua essenza più peculiare, avvolta dalla bella illusione del sogno. La misura, sotto il cui giogo si moveva il nuovo mondo di dèi (di fronte al mondo abbattuto dei Titani), era quella della bellezza: il limite che il Greco doveva mantenere era quello della bella illusione. Il fine più intimo di una cultura rivolta all’illusione e alla misura può certo essere soltanto quello di velare la verità. L’instancabile indagatore al servizio della verità così come il tracotante Titano, viene richiamato con l’ammonizione del medén ágan. Con Prometeo viene mostrato alla grecità un esempio di come un eccessivo avanzamento della conoscenza umana agisca in modo ugualmente rovinoso per chi promuove tale avanzamento e per chi ne usufruisce. Chi con la sua sapienza vuol sostenersi di fronte al dio, deve, come dice Esiodo, métron ékhein sophíes. In un mondo così costruito e artificiosamente difeso penetrò allora il suono estatico della festa di Dioniso, dove tutto l’eccesso della natura in gioia, dolore e conoscenza si manifestò in uno stesso tempo. Tutto quello che sino allora valeva come limite e come determinazione di misura si dimostrò a quel punto una artificiosa illusione: l’ «eccesso» si svelò come verità. Per la prima volta il canto popolare demonicamente affascinante mugghiò in tutta l’ebrietà di un sentimento strapotente: che cosa significava in contrario il salmodiante artista di Apollo, con gli accordi timidamente accennati della sua kithára? Ciò che prima si era trapiantato entro una casta, nelle corporazioni poetico-musicali, e al tempo stesso era stato isolato da ogni partecipazione profana, ciò che doveva mantenersi, con la violenza del genio apollineo, al livello di una semplice architettonica, ossia l’elemento musicale, si spogliò ora di ogni costrizione: la ritmica, che prima si era mossa soltanto nella più semplice scansione, sciolse le sue membra nella danza baccantica: risonò la voce strumentale, non più spettralmente attenuata come prima, ma mille volte potenziata dalla massa e accompagnata dalle basse risonanze degli strumenti a fiato. E la cosa più misteriosa si realizzò: venne allora al mondo l’armonia, che nel suo movimento fa immediatamente comprendere la volontà della natura. In compagnia di Dioniso si fecero ormai udire cose che nel mondo apollineo stavano artificiosamente nascoste: tutto il fulgore degli dèi olimpici impallidì dinnanzi alla sapienza di Sileno. Un’arte che nella sua ebbrezza estatica diceva la verità, scacciò le Muse delle arti dell’illusione; nell’oblio di sé degli stati dionisiaci perì l’individuo con i suoi limiti e le sue misure: eminente un crepuscolo degli dèi. Qual era la mira della volontà, che pure in definitiva è unitaria, nel concedere un accesso, contro la propria creazione apollinea, agli elementi dionisiaci? Ciò riguardava una nuova e superiore mekhané dell’esistenza, ossia la nascita del pensiero tragico. III L’estasi dello stato dionisiaco, con il suo annientamento delle barriere e dei limiti abituali dell’esistenza, contiene nel suo perdurare un elemento letargico, in cui si immerge tutto ciò che è stato vissuto nel passato., Attraverso questo abisso dell’oblio si dividono così l’uno dall’altro il mondo della realtà quotidiana e quello della realtà dionisiaca. Ma non appena quella realtà quotidiana rientra di nuovo nella coscienza, viene sentita come tale con disgusto: il frutto di quelle esperienze è uno stato d’animo ascetico, negatore della volontà. Ciò che è dionisiaco viene contrapposto nel pensiero come un ordine superiore del mondo a un ordine volgare e dappoco: il Greco voleva una fuga assoluta da questo mondo della colpa e del destino. Difficilmente si dava pace con un mondo dopo la morte: la sua brama andava più in alto, al di là degli dèi; egli negava l’esistenza assieme al suo variopinto, luccicante rispecchiamento negli dèi. Nella consapevolezza del risveglio dall’ebbrezza, egli vede ovunque l’atrocità o l’assurdità dell’esistenza umana. Ciò gli dà la nausea. Ora egli comprende la sapienza del dio silvano. Qui viene raggiunto il confine più pericoloso che la volontà ellenica potesse permettersi con il suo principio fondamentale apollineo-ottimistico. Qui tale volontà agì subito con la sua naturale forza risanatrice, per far ripiegare nuovamente quello stato d’animo negatore: i suoi strumenti furono l’opera d’arte tragica e l’idea tragica. Non poteva assolutamente avere l’intenzione di mitigare, o addirittura di reprimere lo stato dionisiaco: una sottomissione diretta era impossibile, e quand’anche fosse stata possibile, era troppo pericolosa poiché quell’elemento, trattenuto nella sua effusione, si sarebbe aperto altrove una strada e sarebbe penetrato in tutte le arterie vitali. Si trattava anzitutto di trasformare quei pensieri di disgusto per l’atrocità e l’assurdità dell’esistenza in rappresentazioni con cui si potesse vivere: queste sono il sublime in quanto soggiogamento artistico dell’atroce, e il ridicolo in quanto scaricarsi artistico dal disgusto per l’assurdo. Questi due elementi intrecciati assieme vengono riuniti in un’opera d’arte che imita l’ebbrezza, che giuoca con l’ebbrezza. Il sublime e il ridicolo costituiscono un passo al di là del mondo della bella illusione, poiché in entrambi i concetti viene sentita una contraddizione. D’altro canto essi non coincidono affatto con la verità sono un velame della verità il quale è bensì più trasparente della bellezza, ma risulta pur sempre un velame. In questi concetti noi troviamo dunque un mondo intermedio tra bellezza e verità dove è possibile riunire Dioniso e Apollo. Questo mondo si rivela in un giocare con l’ebbrezza, non già nell’essere completamente assorbiti essa. Nell’attore noi riconosciamo l’uomo dionisiaco, il poeta, il cantore, il danzatore istintivo, in quanto però uomo dionisiaco rappresentato. L’attore cerca di raggiungere questo modello nella commozione della sublimità o anche in uno scoppio di risa: egli va oltre la bellezza e tuttavia non cerca la verità. Rimane sospeso a eguale distanza dalle due. Egli non tende alla bella parvenza, bensì all’illusione, non tende alla verità bensì alla verosimiglianza. (Simbolo, segno della verità. Dapprima l’attore non era naturalmente un isolato: doveva piuttosto venir presentata la massa dionisiaca, cioè il popolo. Di qui il coro ditirambico. Giocando con l’ebbrezza, l’attore stesso, come anche il coro circostante degli spettatori, doveva per così dire scaricarsi dell’ebbrezza. Dal punto di vista del mondo apollineo, la grecità era qualcosa che si doveva risanare ed espiare: Apollo, il vero dio della salute e dell’espiazione, salvò il Greco dall’estasi chiaroveggente e dal disgusto per l’esistenza, mediante l’opera d’arte del pensiero tragico e comico. Il nuovo mondo dell’arte, quello del sublime e del ridicolo, quello della «verosimiglianza», si fondava su un’intuizione degli dèi e del mondo differente dalla concezione anteriore della bella parvenza. La conoscenza degli orrori e dell’assurdità dell’esistenza, di un ordine turbato e di una sistematicità irrazionale, e in generale la conoscenza del più mostruoso dolore in tutta quanta la natura aveva svelato le figure – nascoste così ingegnosamente – della Moira e delle Erinni, di Medusa e di Gorgona: gli dèi olimpici correvano il massimo pericolo. Con l’opera d’arte tragica e comica essi furono salvati, venendo immersi a loro volta nel mare del sublime e del ridicolo: essi cessarono di essere soltanto «belli» e assorbirono per così dire in se stessi quell’antico ordinamento di dèi e la sua sublimità. Si separarono ormai in due gruppi (soltanto pochi rimasero sospesi in una posizione intermedia), da un lato come divinità sublimi e d’altro lato come divinità ridicole. Soprattutto Dioniso ricevette quella duplice natura. Due tipi di uomini, cioè Eschilo e Sofocle, mostrano nel modo migliore come oggi si potrebbe rivivere il periodo tragico della grecità. Al primo, come pensatore, il sublime si presenta soprattutto nella forma di una grandiosa giustizia. Per lui, uomo e dio stanno in una strettissima comunione soggettiva: la divinità la giustizia, la moralità e la felicità sono per lui intrecciate assieme in modo unitario. L’individuo, uomo o Titano, viene pesato su questa bilancia. Gli dèi sono ricostruiti in base a questa norma di giustizia. Così per esempio la credenza popolare in un demone che acceca e seduce alla colpa – un residuo di quel primordiale mondo divino, detronizzato dagli dèi olimpici – viene corretta, poiché questo demone viene trasformato in uno strumento nella mano di Zeus e della sua giusta punizione. Il pensiero altrettanto primordiale – e del pari estraneo agli dèi olimpici – della maledizione di una stirpe viene spogliato di tutta la sua crudezza, poiché per Eschilo l’individuo non è spinto al delitto da una necessità e chiunque può liberarsene. Mentre Eschilo trova il sublime nella superiorità della giustizia olimpica, Sofocle lo scopre invece – in modo sorprendente – nell’imperscrutabilità della giustizia olimpica. Su tutti i punti egli ricostituisce la prospettiva popolare. Il non meritare un destino orrendo sembrava a lui qualcosa di sublime e gli enigmi veramente insolubili dell’esistenza umana ispirarono la sua Musa tragica. La sofferenza trova in lui la sua trasfigurazione e viene concepita come qualcosa di santificante. Il distacco tra l’umano e il divino è incommensurabile; è quindi conveniente la più profonda sottomissione e rassegnazione. La vera virtù è la sophrosyne, propriamente una virtù negativa. L’umanità eroica è la più nobile umanità: priva di quella virtù il suo destino dimostra quell’abisso invalicabile. Non esiste la colpa, ma soltanto una mancanza di conoscenza sul valore dell’uomo e sui suoi limiti. Questo punto di vista è in ogni caso più profondo e più interiore di quello eschileo, si avvicina notevolmente alla verità dionisiaca e la esprime senza molti simboli: ciononostante, ritroviamo qui il principio etico di Apollo intrecciato con la visione dionisiaca del mondo. In Eschilo, il disgusto si risolve nel brivido sublime di fronte alla sapienza dell’ordine cosmico, che è difficilmente riconoscibile solo per la debolezza dell’uomo. In Sofocle, questo brivido è ancora più violento, poiché quella sapienza è del tutto insondabile. È questo lo schietto stato d’animo della devozione priva di lotta, mentre la devozione eschilea ha continuamente il compito di giustificare la giustizia divina e si trova perciò sempre di fronte a nuovi problemi. Il «confine dell’uomo», che Apollo comanda di cercare, è per Sofocle riconoscibile, ma è più stretto e più limitato di quello inteso nell’epoca predionisiaca di Apollo. Che l’uomo manchi della conoscenza di sé è il problema di Sofocle; che l’uomo manchi della conoscenza sugli dèi, è il problema di Eschilo. Devozione, mirabile maschera dell’istinto vitale! Abbandonarsi a un mondo perfetto di sogno, che fornirà la suprema saggezza morale! Fuggire di fronte alla verità per poterla adorare da lontano, nascosta nelle nubi! Conciliazione con la realtà poiché essa è enigmatica; avversione per chi decifra gli enigmi, perché noi non siamo dèi; gioioso inginocchiarsi nella polvere, beata quiete nell’infelicità, suprema alienazione di sé compiuta dall’uomo nella sua suprema espressione. Esaltazione e trasfigurazione dei mezzi di terrore e della terribilità dell’esistenza, intendendo tutto ciò come strumento per salvarci dall’esistenza; vita piena di gioia nel disprezzo della vita; trionfo della volontà nella sua negazione. Su questo piano conoscitivo esistono soltanto due vie, quella del santo e quella dell’artista tragico: ciò che li accomuna è il fatto che, nonostante la più chiara conoscenza della nullità dell’esistenza, essi possono tuttavia continuare a vivere, senza sentire una frattura nella loro intuizione del mondo. Il disgusto di continuare a vivere viene sentito come un mezzo per giungere alla creazione, tanto nel santo quanto nell’artista. Il terribile o l’assurdo è esaltante, poiché è terribile o assurdo solo apparentemente. La forza dionisiaca dell’incantesimo si conferma valida anche al culmine estremo di questa visione del mondo: tutto ciò che è reale si risolve in illusione, e dietro di esso si manifesta la natura unitaria della volontà avvolta completamente dalla gloria della sapienza e della verità da uno splendore accecante. L’illusione e la follia giungono al loro apice. Ora non sembrerà più incomprensibile che quella medesima volontà, la quale in quanto apollinea dava un ordinamento al mondo greco, accogliesse in sé l’altra sua forma di manifestazione, la volontà dionisiaca. La lotta fra le due forme in cui appare la volontà aveva uno scopo straordinario, quello cioè di creare una possibilità più alta di esistenza, e di giungere poi in questa a una glorificazione ancora superiore (attraverso l’arte). La forma di tale glorificazione non era più l’arte dell’illusione, bensì l’arte tragica: in quest’ultima peraltro viene completamente assorbita quell’arte dell’illusione. Apollo e Dioniso si sono riuniti. Allo stesso modo che nella vita apollinea è entrato l’elemento dionisiaco, e allo stesso modo che l’illusione si è consolidata qui come limite, così pure l’arte tragica dionisiaca non è più «verità». Quel canto e quella danza non sono più l’ebbrezza istintiva della natura: la massa corale eccitata dionisiacamente non è più la massa popolare colta inconsciamente dall’impulso primaverile. La verità viene. ora simboleggiata, si serve dell’illusione, può e deve quindi usare le arti dell’illusione. Già qui si rivela tuttavia una grande differenza rispetto all’arte precedente: ora i mezzi artistici dell’illusione sono chiamati in aiuto tutti assieme, e la statua cammina, gli apparati scenici dipinti si spostano, e con lo stesso sfondo scenico viene presentato di fronte agli occhi ora il palazzo e ora il tempio. Osserviamo così al tempo stesso una certa indifferenza verso l’illusione, che deve qui deporre le sue eterne pretese, le sue esigenze sovrane. L’illusione non viene più goduta come illusione, bensì come simbolo, come segno della verità. Di qui la fusione – in sé urtante – dei mezzi artistici. Il segno più evidente di questo disprezzo dell’illusione è la maschera. Lo spettatore si trova quindi di fronte all’esigenza dionisiaca, che tutto quanto gli si presenti come incantato, che egli veda sempre qualcosa di più del simbolo e che tutto il mondo visibile della scena e dell’orchestra sia il regno del miracolo. Ma dov’è la forza che può disporre il suo animo a credere nei miracoli, e per cui egli può vedere ogni cosa come dovuta a un incantesimo? Che cos’è che può vincere la forza dell’illusione, depotenziandola come simbolo? IV Ciò che noi chiamiamo «sentimento» risulta, secondo l’insegnamento di una filosofia che si muova sulle tracce di Schopenhauer, un complesso di rappresentazioni inconsce e di stati della volontà. Le tendenze della volontà si manifestano peraltro come piacere o dolore e in ciò rivelano unicamente una differenza quantitativa. Non vi sono diverse specie di piacere, bensì gradi differenti e un numero sterminato di rappresentazioni concomitanti. Con piacere, noi dobbiamo intendere il soddisfacimento di una volontà unica, e con dolore il suo non soddisfacimento. In qual modo, orbene, si comunica il sentimento? Parzialmente – ma assai parzialmente – esso può trasferirsi in pensieri, cioè in rappresentazioni coscienti. Ciò vale naturalmente solo per la parte delle rappresentazioni concomitanti. Anche su questo terreno del sentimento, d’altronde, rimane sempre un resto irriducibile. È unicamente del resto riducibile, che si occupa il linguaggio, e quindi il concetto: in base a ciò viene determinato il limite della «poesia» nella capacità di esprimere il sentimento. Le altre due specie di comunicazione sono completamente istintive, prive di coscienza, e tuttavia operanti conformemente a un fine. Si tratta del linguaggio dei gesti e di quello dei suoni. Il linguaggio dei gesti consiste in simboli universalmente comprensibili, e viene prodotto da movimenti riflessi. Questi simboli sono visibili: l’occhio che li vede trasmette senz’altro lo stato che ha prodotto il gesto e che è da questo simboleggiato. Chi vede, sente in sé per lo più – per simpatia – un’azione dei nervi sulle medesime parti del volto o sulle medesime membra, il cui movimento egli percepisce. Simbolo vuol significare qui un riflesso parziale e del tutto imperfetto, un segno allusivo, sulla cui comprensione ci si deve accordare: in questo caso tuttavia la comprensione universale è istintiva, cioè non dominata da una chiara coscienza. Che cosa simboleggia dunque il gesto, rispetto a quell’entità duplice che è il sentimento? Evidentemente la rappresentazione concomitante, poiché soltanto questa può essere accennata, in modo incompleto e parziale, dal gesto visibile: un’immagine può essere simboleggiata solo attraverso un’immagine. La pittura e la scultura presentano l’uomo mentre gestisce: esse cioè imitano il simbolo e hanno raggiunto il loro effetto quando noi comprendiamo il simbolo. La gioia di chi contempla consiste nella comprensione del simbolo, nonostante la sua apparenza. L’attore invece presenta il simbolo realmente, non soltanto per l’illusione: l’effetto esercitato su di noi peraltro non si fonda sulla comprensione di tale simbolo. Piuttosto, noi ci immergiamo nel sentimento simboleggiato, senza arrestarci alla gioia dell’illusione, alla bella parvenza. Così nel dramma la decorazione non suscita affatto la gioia dell’illusione: noi la intendiamo invece come simbolo e comprendiamo il reale che ne è accennato. Fantocci di cera e piante vere, accanto ad altre semplicemente dipinte, sono qui perfettamente ammissibili, per dimostrare che in questo caso noi ci rappresentiamo concretamente la realtà, non una illusione artificiosa. Il compito consiste qui nella verosimiglianza, non più nella bellezza. Ma che cos’è la bellezza? – «la rosa è bella» significa soltanto: la rosa ha una buona parvenza, ha qualcosa di piacevolmente luminoso. Con ciò non si dice nulla sulla sua essenza. Essa piace, in quanto parvenza suscita piacere: in altre parole, attraverso il suo apparire la volontà è soddisfatta, il piacere di esistere viene in tal modo accresciuto. Essa è – nella sua parvenza – un riflesso fedele della sua volontà o in forma equivalente: essa corrisponde, nella sua parvenza, alla determinazione della specie. Quanto più essa fa questo, tanto più è bella; se poi essa corrisponde nella sua essenza a quella determinazione, è allora «buona». «Un bel dipinto» significa soltanto: la rappresentazione che noi abbiamo di un dipinto è in questo caso realizzata; se invece noi chiamiamo «buono» un dipinto, designiamo allora la nostra rappresentazione di un dipinto come tale da corrispondere all’essenza del quadro. Per bel quadro, d’altronde, si intende per lo più un quadro che rappresenti qualcosa di bello: tale è il giudizio dei profani. Costoro gustano la bellezza del contenuto: ed è così che noi dobbiamo gustare le arti figurative nel dramma. Quest’ultimo tuttavia non può avere come compito di rappresentare soltanto cose belle: basta che un oggetto sembri vero. L’oggetto rappresentato deve essere colto in modo massimamente sensibile e vivo. Esso deve agire come verità: un’esigenza, questa, antitetica a quella fatta valere in ogni «opera della bella illusione». Peraltro, se il gesto simboleggia, rispetto al sentimento, le rappresentazioni concomitanti, con quale simbolo sarà mai comunicata la comprensione dei moti della volontà come tale? Quale è in questo caso la mediazione istintiva? La mediazione del suono. Per essere precisi, sono i differenti aspetti del piacere e del dolore – senza alcuna rappresentazione concomitante – che risultano simboleggiati dal suono. Tutto ciò che noi possiamo dire, per caratterizzare i diversi sentimenti di dolore, consiste in immagini di rappresentazioni chiarite attraverso il simbolismo del gesti. Ciò accade, per esempio, quando a proposito di un improvviso terrore noi parliamo di «mazzate, crampi, sussulti, punture, ferite, morsi, stimoli, del dolore. Con ciò sembra trovata l’espressione di certe «forme intermittenti» della volontà; in breve – nel simbolismo del linguaggio dei suoni – questa è una ritmica. La ricchezza delle gradazioni della volontà, la quantità mutevole della gioia e del dolore, sono da noi riconosciute nella dinamica del suono. Ma la vera essenza della volontà si nasconde, senza potersi esprimere con un’immagine, nell’armonia. La volontà e il suo simbolo – l’armonia – costituiscono assieme, in estrema analisi, la logica pura. Mentre la ritmica e la dinamica sono in certo modo ancora aspetti esteriori della volontà che si rivela in simboli e portano in sé ancora l’impronta dell’apparenza, l’armonia è invece il simbolo dell’essenza pura della volontà. Nella ritmica e nella dinamica, perciò la singola apparenza deve essere ancora caratterizzata come apparenza e da questo lato la musica può essere elaborata come arte dell’illusione. Il resto irriducibile, l’armonia, parla della volontà al di fuori e all’interno di tutte le forme dell’apparenza, e quindi non è semplicemente un simbolismo del sentimento, bensì un simbolismo del mondo. Nella sfera della volontà il concetto è del tutto impotente. Ora possiamo comprendere l’importanza del linguaggio dei gesti e dei suoni per l’opera d’arte dionisiaca. Nell’originario ditirambo primaverile del popolo l’uomo non vuole esprimersi come individuo, bensì come appartenente alla sua specie. Che egli cessi di essere un uomo individuale, viene espresso attraverso il simbolismo dell’occhio, il linguaggio dei gesti: egli infatti parla e gestisce – in verità con un linguaggio di gesti potenziato, ossia con i movimenti della danza – come satiro, come essere naturale in mezzo a esseri naturali. Attraverso il suono egli esprime peraltro i più intimi pensieri della natura: si rende qui immediatamente comprensibile non soltanto il genio della specie, come avviene con il gesto, bensì il genio dell’esistenza come tale, la volontà. Con il gesto egli rimane dunque entro i limiti della specie, ossia entro il mondo dell’apparenza mentre col suono egli dissolve per così dire il mondo dell’apparenza nella propria unità primordiale, e il mondo di Maja scompare di fronte al suo incantesimo. Ma quand’è che l’uomo naturale giunge al simbolismo del suono? Quand’è che il linguaggio dei gesti non è più sufficiente? Quand’è che il suono diventa musica? Soprattutto nei supremi stati di piacere e di dolore della volontà, quando la volontà tripudia oppure è mortalmente atterrita, in breve nell’ebbrezza del sentimento: nel grido. In confronto allo sguardo, quanto più potente e più immediato è il grido! Anche le commozioni meno violente della volontà hanno tuttavia il loro simbolismo sonoro. In generale, a ogni gesto corrisponde un suono, ma soltanto l’ebbrezza del sentimento riesce a potenziarlo in un puro accordo sonoro. «La fusione più intima e più frequente di un certo simbolismo del gestire con il suono viene chiamata linguaggio. Quando si parla, con il suono e la sua cadenza, la forza e il ritmo della sua risonanza, viene simboleggiata l’essenza della cosa, e con il movimento della bocca viene simboleggiata la rappresentazione concomitante, l’immagine, l’apparenza dell’essenza. I simboli possono e debbono essere di molte specie: essi tuttavia si accrescono istintivamente, con una grande e saggia regolarità. Un simbolo contrassegnato è un concetto, e poiché quando si conserva qualcosa nella memoria il suono svanisce completamente, nel concetto si conserva allora solamente il simbolo della rappresentazione concomitante. Ciò che si può designare e distinguere, lo si «concepisce». Nel potenziarsi del sentimento, l’essenza della parola si rivela più chiaramente e più sensibilmente attraverso il simbolo del suono: perciò la parola risuona allora maggiormente. Il recitativo è per così dire un ritorno alla natura: il simbolo, che si ottunde con l’uso, ritrova in tal caso la sua forza originaria. Con la successione delle parole, cioè con una catena di simboli, deve venir rappresentato simbolicamente qualcosa di nuovo e di più grande: in questa elevazione a potenza, diventano nuovamente necessarie la ritmica, la dinamica e l’armonia. Questa cerchia più ampia domina ora quella più ristretta della parola singola: si rende necessaria una scelta delle parole, una nuova disposizione di esse, e comincia la poesia. Il recitativo di una frase non consiste in una successione ordinata dei suoni delle parole: una parola ha infatti unicamente un suono del tutto relativo, poiché la sua essenza, il suo contenuto rappresentato dal simbolo, è differente a seconda della sua posizione. In altri termini, in base all’unità superiore della frase e dell’essenza da essa simboleggiata, il simbolo individuale della parola viene determinato continuamente in modo nuovo. Una catena di concetti costituisce un pensiero: quest’ultimo è dunque l’unità superiore delle rappresentazioni concomitanti. L’essenza della cosa non può essere raggiunta dal pensiero: che peraltro esso agisca su di noi come motivo, come stimolo della volontà si può spiegare per il fatto che il pensiero è già divenuto al tempo stesso un simbolo contrassegnato che accenna a un’apparenza della volontà ossia a un moto e a una manifestazione della volontà. Il pensiero, tuttavia, se è pronunciato – cioè attraverso il simbolismo del suono – agisce in modo incomparabilmente più forte e più diretto. Se cantato, esso raggiunge il culmine del suo effetto, quando il melos costituisce il simbolo comprensibile della sua volontà: se tale non è il caso, la successione dei suoni agisce su di noi, e la successione delle parole, ossia il pensiero, ci rimane lontano e indifferente. Ora, secondo che la parola debba agire prevalentemente come simbolo della rappresentazione concomitante, oppure come simbolo del moto originario della volontà, secondo cioè che debbano venir simboleggiate immagini oppure sentimenti, si distingueranno due vie della poesia, quella epica e quella lirica. La prima porta all’arte figurativa e la seconda alla musica: il diletto per l’apparenza domina la poesia epica, mentre nella lirica si rivela la volontà. La prima si libera dalla musica, e la seconda rimane sua alleata. Nel ditirambo dionisiaco, peraltro, l’esaltato seguace di Dioniso viene stimolato a potenziare massimamente tutte le sue facoltà simboliche: qualcosa di mai sentito – l’annientamento dell’individuazione, l’unificazione nel genio della specie, anzi della natura – tende a manifestarsi. Ora l’essenza della natura vuole esprimersi: è necessario un nuovo mondo di simboli, e le rappresentazioni concomitanti si trasformano in simboli attraverso le immagini di un potenziato essere umano. Tali rappresentazioni si manifestano con la massima energia fisica attraverso l’intero simbolismo del corpo, attraverso i movimenti della danza. Anche il mondo della volontà desidera peraltro un’inaudita espressione simbolica, e le potenze dell’armonia, della dinamica, della ritmica si accrescono d’un tratto tumultuosamente. Altresì la poesia, che si trovava distribuita in due mondi, raggiunge ora una nuova sfera, ottenendo al tempo stesso la sensibilità dell’immagine, come nell’epos, e l’ebbrezza e sentimento nel suono, come nella lirica. Per cogliere l’intero scatenarsi di tutte queste forze simboliche, bisogna raggiungere quella stessa esaltazione dell’essere, la quale le ha create: il seguace ditirambico di Dioniso viene compreso soltanto dal suo simile. Perciò tutto questo nuovo mondo artistico si agita nella sua affascinante e sconosciuta magnificenza, sostenendo terribili lotte, entro la grecità apollinea.
CONSIDERAZIONI INATTUALI L’uomo é difficile da scoprire, ed egli é per se stesso la più difficile delle scoperte. Con lo sguardo rivolto alla Grecia antica, Nietzsche si sente alieno al mondo moderno, erede dell’ottimismo socratico, e intraprende una battaglia contro il presente e la sua mancanza di vera cultura, scrivendo le “Considerazioni inattuali”: esse sono inattuali poichè enunciano tesi contrastanti con i valori dominanti e operano per costruire un nuovo futuro, anzichè per avere successo nell’immediato e conquistare l’attualità.Le “Considerazioni inattuali” sono quattro volumi che nascono come opere di transizione e di formazione, in cui la mancanza di uno stile autonomo, inconfondibile, si sente. Nel secondo, più interessante, dal titolo Sull’utilità e il danno della storia per la vita tratta del sapere storico, Nietzsche sostiene che i fatti in sé sono stupidi: occorre l’interpretazione. Sono le teorie ad essere intelligenti. Il senso della storia è spesso nemico della vita, perchè ci rende schiavi del passato, passivi. Ne consegue una sfiducia nella propria capacità creativa, e il formarsi di una pura erudizione da enciclopedie ambulanti, che annulla la personalità: “nessuno osa più esporre se stesso, ma ciascuno prende la maschera di uomo colto, di dotto, di poeta”. Si diventa così “uomini che non vedono quello che anche un bambino vede”. In particolare riconosce che: la storia archeologica si ferma al mediocre, si attarda ad ammirare il passato, anche nei suoi aspetti mediocri e meschini, per giustificare la presente mediocrità la storia monumentale cerca nel passato esempi e modelli positivi, che mancano nel presente, onde poter guardare al futuro con sicurezza che ciò che è stato possibile in passato lo sarà ancora solo la storia critica è davvero positiva, in quanto non si limita a favorire l’imitazione del passato, anche eroico, ma lo vuole superare. Nietzsche non nega la storia, ma la vuole subordinata alla vita.. […] Ma che la vita abbia bisogno del servizio della storia, deve essere compreso altrettanto chiaramente quanto la proposizione che sarà più tardi da dimostrare – secondo cui un eccesso di storia danneggia l’essere vivente. In tre riguardi al vivente occorre la storia: essa gli occorre in quanto è attivo e ha aspirazioni, in quanto preserva e venera, in quanto soffre e ha bisogno di liberazione. A questi tre rapporti corrispondono tre specie di storia, in quanto sia permesso distinguere una specie di storia monumentale, una specie antiquaria e una specie critica. […] La storia occorre innanzitutto all’attivo e al potente, a colui che combatte una grande battaglia, che ha bisogno di modelli, maestri e consolatori, e che non può trovarli fra i suoi compagni e nel presente. […] L’uomo invidia l’animale, che subito dimentica […] l’animale vive in modo non storico, poichè si risolve nel presente […] l’uomo invece resiste sotto il grande e sempre più grande carico del passato: questo lo schiaccia a terra e lo piega da parte. Per ogni agire ci vuole oblìo: come per la vita di ogni essere organico ci vuole non solo luce, ma anche oscurità. La serenità, la buona coscienza, la lieta azione, la fiducia nel futuro dipendono […] dal fatto che si sappia tanto bene dimenticare al tempo giusto, quanto ricordare al tempo giusto… Così dice Nietzsche a proposito delle “Considerazioni inattuali” nella propria autobiografia, “Ecce homo”: “Sono scritti sostanzialmente polemici. Dimostrano che io non ero un sognatore, che mi fa piacere anche di sguainare la spade; forse anche che ho il polso pericolosamente sciolto. Il primo assalto (1873) fu diretto contro la cultura tedesca che già allora consideravo con un disprezzo senza limiti. Senza senso, senza sostanza, senza scopo: una semplice opinione pubblica. […] La seconda considerazione inattuale (1874) mette in luce ciò che vi é di pericoloso, ciò che corrode e avvelena la vita nel nostro modo di coltivare la scienza: la vita, malata a causa di questo congegno, di questo meccanismo privo di personalità, a causa dell’impersonalità del lavoratore e della falsa economia nella divisione del lavoro. Il fine: la cultura, va perduto; il mezzo: il movimento scientifico moderno, ne é barbarizzato. […] Nella terza e nella quarta Considerazione inattuale, come indici di un concetto superiore di cultura, del ristabilimento del concetto di cultura, sono opposti due casi di egoismo, di educazione di se stessi, due tipi per eccellenza fuori dal loro tempo, pieni di sovrano disprezzo per tutto ciò che intorno a loro si chiamava impero, cultura, cristianesimo, Bismarck, successo; dico Schopenhauer e Wagner, oppure, con una parola sola, Nietzsche.” E nelle Considerazioni inattuali uno dei temi portanti é quello riguardante la storia; ora per Nietzsche “non esistono fatti, ma solo interpretazioni”, vale a dire che ogni fatto che ci viene tramandato o semplicemente raccontato non é mai il fatto in sè, ma é sempre un’interpretazione da parte di chi ce lo racconta. La cultura moderna appare a Nietzsche soprattutto in preda ad una “ipertrofia” del sapere storico: la malattia storica . Alla descrizione e alla cura di questa nociva malattia, Nietzsche tenta di provvedere con la seconda delle “Considerazioni inattuali”, intitolata “Sull’utilità e sul danno della storia per la vita”. Essa é inattuale perchè smaschera gli elementi potenzialmente dannosi contenuti in ciò che per l’epoca presente rappresenta un vanto: la formazione e la conoscenza storica. Il criterio per formulare questa valutazione é dato dalla vita: la storia favorisce e incrementa oppure blocca e atrofizza la vita e l’azione? L’ oblio per Nietzsche é necessario alla vita: per poter vivere nel presente, bisogna poter dimenticare il passato, che altrimenti ci sovrasterebbe e paralizzerebbe. Questo non significa che la storia, fondata sulla memoria del passato, sia inevitabilmente sempre perniciosa: la cosa importante é ricordare nel momento giusto e nella misura adeguata. La storia deve quindi essere posta al servizio della vita, non viceversa: il tema della vita e del suo primato su qualsiasi altra cosa é il filo che lega l’intera produzione nietzscheana. Per valutare il carattere positivo o negativo della storia occorre assumere come criterio di riferimento e di misura la vita, ma per comprendere il posto da assegnare alla storia nella vita, senza che ciò si tramuti in un danno per la vita stessa, occorre partire da un chiarimento del rapporto che intercorre tra vita e oblio. La vita, come accennavamo, può fiorire solo grazie all’oblio, perchè é questo che permette di immergersi totalmente nella vita, nell’immediatezza del presente: se non c’é oblio la vita diventa impossibile perchè rimane paralizzata dal passato. La storia invece é memoria: essa dovrà, dunque, entrare a far parte della vita solo nella misura in cui incrementerà e favorirà la vita stessa; al di là di questo, essa genererà solo un blocco e un’atrofizzazione della vita. Nietzsche distingue tre tipi di storia, ognuno dei quali é necessario per il vivente, ma può anche svolgere una funzione negativa nei confronti della vita. E Nietzsche distingue tra 3 forme di storia: la storia archeologica si ferma al mediocre, si attarda ad ammirare il passato, anche nei suoi aspetti mediocri e meschini, per giustificare la presente mediocrità; la storia monumentale cerca nel passato esempi e modelli positivi, che mancano nel presente, onde poter guardare al futuro con sicurezza che ciò che è stato possibile in passato lo sarà ancora; solo la storia critica è davvero positiva, in quanto non si limita ad favorire l’imitazione del passato, anche eroico, ma lo vuole superare: essa trascina il passato davanti al tribunale, lo giudica e lo condanna. Il tema storico, nelle Considerazioni inattuali, é davvero forte e sentito, e Nietzsche arriva a dire, come in parte già accennato all’inizio: ” l’uomo invidia l’animale, che subito dimentica [..] l’animale vive in modo non storico, poiché si risolve nel presente [..] l’uomo invece resiste sotto il grande e sempre più grande carico del passato: questo lo schiaccia a terra e lo piega da parte. Per ogni agire ci vuole oblìo: come per la vita di ogni essere organico ci vuole non solo luce, ma anche oscurità. La serenità, la buona coscienza, la lieta azione la fiducia nel futuro dipendono [..] dal fatto che si sappia tanto bene dimenticare al tempo giusto, quanto ricordare al tempo giusto. ” Ma analizziamo più in profondità le 4 considerazioni inattuali che costituiscono il testo: Ecco, subito, venirci incontro nella prima considerazione Davide Strauss, confessore, scrittore, filisteo della coltura, razionalista, senza fede, senza passione, adiposo di ottimismo, incapace di comprendere la nuova spiritualità, rappresentante perfetto della indifferenza, non originale, diffidente, avaro, soddisfatto, attaccato a irti squallori di schemi logici, non vivente l’attualità della vita. L’autore di Vom alten und neuen Glauben è antipatico come ogni omiciattolo che vuole riuscirci troppo simpatico. Nietzsche nella Prima Inattuale condanna la scienza e la storia. La realtà, Egli scrive, è dramma. E lo viene provando con la vita che fin d’ora (1873) si manifesta ardua. La Seconda Inattuale è pungente di ostilità, in nome della natura, contro il sapere storico. La Grecia presocratica e la coltura tragica, di cui Nietzsche è l’apostolo nella Germania del secolo decimonono, riempiono di attualità questo scritto del ’73-’74 intorno all’utilità e al danno della storia per la vita. L’assoluto nietzscheano che squilla nell’Origine della Tragedia è non storico e soprastorico insieme. In questa Seconda Inattuale il problema storico è posto naturalisticamente come problema di utilità per la vita. Nietzsche odia i famuli alla Wagner goethiano. Di fronte alla storia Nietzsche afferma la vita. Vita è agire, vita è dimenticare. La vita è antistorica per Nietzsche. La creazione della vita da parte del genio forma il tessuto della Terza Inattuale. La coscienza etica si afferma in senso individualistico. L’individuo apporta l’eticità vivendo liberamente, in libertà geniale. L’avvento del genio giustifica di per sé stesso l’esistenza. Rammentiamoci del Prometeo incatenato di Eschilo e del Prometeo goethiano. L’individuo geniale è intuito da Nietzsche padrone e creatore della storia. Spinto dal turbine delle passioni ardenti, volatore sull’ala degl’istinti, volontario come una creazione dal nulla, agitantesi come quelle freie Mächle ohne Ethik che Nietzsche abbraccia religiosamente, Egli segue, unica norma, il comando della concreta realizzazione del proprio essere. Intorno all’uomo di genio il deserto: quale contatto tra l’unico e le sparute determinazioni dei valori degli sparuti uomini affaccendantisi? Artista, il genio è libero da ogni legge: l’arte è vita in senso religioso. L’estetica tragica è, sappiamo già, eroica. V’è un’antitesi granitica tra quanto afferma il genio, e la negazione filitea. Irrazionalissimo, filosofo, poeta, eroe della verità, risolutamente opposto alla freddezza neutra di neutri scienziati, ecco una splendida imagine di genio ribelle in “Arturo Schopenhauer”, che conosce e accetta la verità che atterrisce. Lo Schopenhauer della “Terza Inattuale” (“Schopenhauer educatore”) è tutto nietzscheano: è uno Schopenhauer ridotto al sistema nervoso della volontà che scatta negl’impulsi lucidi di Nietzsche. Schopenhauer educa Nietzsche creando la coscienza individuale. Educare vuol dire rivelare la personalità del discepolo. Autobiografica, questa Terza Inattuale ci chiarifica la potenza, veramente geniale, di Nietzsche che interpreta soggettivamente Schopenhauer, cercando in lui la soluzione di problemi propri. Contro l’educazione e la coltura contemporanee vibra Nietzsche i suoi attacchi violenti. Si può parlare di “alchimia psicologica”, a questo riguardo? Comunque, anche il Castiglioni nel suo lucido saggio ammette la giustezza nietzscheana della concezione etica del genio. Del quale si celebra, dionisiacamente, l’apoteosi nella Quarta Inattuale. L’eroe è glorificato in Riccardo Wagner a Bayreuth. Il mito wagneriano è ardente di ispirazione prometea. Wagner è chi afferma Dioniso. L’antitesi Dioniso-Apollo si riflette tragicamente anche in Wagner. L’irrazionale avvampa di ragione intima, misteriosa. Anche Wagner, come Prometeo, è plasmatore di uomini tragici che superano l’umanità.
UMANO, TROPPO UMANO
Dove voi vedete cose ideali, io vedo cose umane,ah! troppo umane…
Con “Umano, troppo umano. Un libro per spiriti liberi” (1878) Nietzsche prende le distanze sia da Schopenhauer, sia da Wagner e imbocca la via del rischiaramento logico-scientifico, inteso come “storia della genesi del pensiero”. Scritti in poco più di un anno, le Opinioni e sentenze diverse e Il viandante e la sua ombra ( riuniti nell’edizione del 1886 col titolo di Umano, troppo umano ) sono testimonianze, nell’attività di Nietzsche, di un ripiegamento su se stesso: é uno stato d’animo ciclico nella sua vita, anche se talora viene mascherato, come in questo caso. Le cose non lo sospingono e gli uomini l’hanno lasciato solo, cosicchè l’autore può interessarsi più di se stesso, come fa qui il viandante, costretto a parlare con la sua ombra. Discorrendo con sè, si parla più facilmente di sè. Questo fatto tuttavia non appare in primo piano, e il lettore si trova di fronte a concreti argomenti di storia, di arte, morale, com’era naturale, del resto, perchè nell’opera di Nietzsche questo risulta il periodo più imparziale, scientifico, obiettivo. Tale oggettività é però raggiunto paradossalmente, ossia attraverso una concentrazione e una speculazione interiore. Lo dice chiaramente egli stesso: Il mio modo di riportare le cose della storia consiste propriamente nel raccontare “esperienze” personali, prendendo a spunto epoche e uomini del passato. Non é qualcosa di organico-solo cose singole mi si sono chiarite, altre no. I nostri storici della letteratura sono noiosi, perchè si impongono di parlare e di giudicare di tutto, anche dove non hanno “vissuto”. La stessa critica del cristianesimo si muove con una compostezza contemplativa e riflessiva. Indagando la nascita delle rappresentazioni di questo mondo, Nietzsche propugna una “chimica delle idee dei sentimenti morali, religiosi ed estetici”, per mostrare che “anche in questo campo i colori più magnifici si ottengono da materiali molto bassi e persino spregiati” : per esempio il razionale dall’irrazionale, la logica dall’illogicità, il disinteresse dalla brama, l’altruismo dall’egoismo e la verità dagli errori. Egli inoltre si propone di sostituire al pathos del possesso di verità assolute “quel pathos, certo più mite e meno altisonante, della ricerca della verità”. Vista nel suo insieme, quest’opera di Nietzsche, la cui dedica a Voltaire testimonia la simpatia per l’illuminismo e la cultura filosofica francese, si presenta come un aggiornato discorso sul metodo. Tale metodo consiste nel saper rendere giustizia alla conoscenza disdegnando “tutto ciò che acceca e confonde il giudizio sulle cose” , per conoscerle invece “in modo puro” ponendole “nella luce migliore” ed esaminandole “con occhio attento”. Va poi data una spiegazione del titolo: Umano, troppo umano. Nietzsche si sforza di guardarsi intorno ma tutto ciò che vede é ancora troppo volgare, troppo legato all’uomo e ai suoi errori di sempre: non é ancora arrivato il superuomo e anche il migliore degli uomini é ancora troppo umano.La pubblicazione di “Umano, troppo umano” , dedicato a Voltaire, segna una vera e propria svolta nella filosofia di Nietzsche. Egli continua l’aspra polemica nei confronti della cultura del proprio tempo e delle esaltazioni del progresso storico, ma non scorge più nell’arte la via per uscire dalla decadenza, bensì nella scienza. Il pensatore tedesco ora guarda con interesse e simpatia, da una parte, all’illuminismo e alla tradizione dei moralisti francesi del Seicento e del Settecento e, dall’altra, alle scienze naturali. In questa fase la scienza é valutata in modo positivo da Nietzsche non tanto perchè in grado di pervenire a conoscenze oggettive, quanto come forma di atteggiamento metodico e, insieme, libero e spregiudicato di fronte ai valori correnti, ai presupposti, alle abitudini e alle regole imposte dalla società. Infatti, la scienza stessa ha la sua origine e la sua giustificazione nei bisogni della vita e i suoi risultati si sono storicamente trasformati in condizioni di vita, cosicchè la conoscenza si é imposta come un bisogno tra gli altri, essenziale per vivere e, in quanto tale, ha assunto un potere sempre più vasto nel mondo moderno. Ma questo potere crescente non dipende dal fatto che la scienza sia un sapere disinteressato, che abbia come scopo la “verità” e sia capace di carpirla. Intanto, é necessario osservare, a parere di Nietzsche, che anche l’ “errore” può essere utile alla vita e che la stessa promozione della scienza nell’età moderna é avvenuta grazie ad alcuni errori inconsapevoli. Alla scienza, infatti, sono stati erroneamente attribuiti il potere di cogliere la bontà e la sapienza divina che regge l’universo e la prerogativa di essere lo strumento fondamentale per realizzare la felicità umana. Sono questi errori che hanno fatto aumentare l’importanza della scienza nella vita moderna. In realtà, la rappresentazione del mondo, fornita dalle scienze, non coglie affatto le cose come sono in se stesse, in quanto non può andare oltre l’apparenza. Anche la scienza, infatti, ben lontana dall’essere disinteressata e pacifica e, quindi, in contrasto con i presunti istinti cattivi degli uomini, nasce dal bisogno vitale di avere certezze e rassicurazioni, per poter sopravvivere: é tale esigenza che ha fatto escogitare i princìpi erronei sui quali si fonda la scienza, come l’esistenza di legami causali tra cose ed eventi o la possibilità di numerare e di compiere astrazioni e generalizzazioni, al fine di cogliere presunte essenze stabilite delle cose. Ammettere che la scienza possa nascere da errori e finzioni pare in contrasto con i consueti giudizi di valore, eppure é possibile, secondo Nietzsche, che l’apparenza, l’illusione, l’interesse personale abbiano per la vita un valore superiore alla verità e al disinteresse, anzi é possibile che i due piani siano intrecciati, anzichè contrastanti. La filosofia e la scienza hanno la loro origine più profonda e recondita, più che nell’istinto di conoscenza, in un istinto vitale che si é servito della conoscenza come strumento per la vita stessa. Così dice Nietzsche in un celebre aforisma del testo: Prossimi alla follia. – La somma dei sentimenti, delle conoscenze, delle esperienze, l’onere complessivo della civiltà, insomma, è divenuto così grande che c’è un pericolo generalizzato di sovreccitazione della capacità nervosa e mentale, anzi, le glassi colte dei paesi europei sono ormai completamente nevrotiche e in quasi tutte le grandi famiglie c’è qualcuno prossimo alla follia. E’ vero che oggi si favorisce la salute in tutti i modi; ma fondamentalmente rimane la necessità di una riduzione di quella tensione del sentimento, di quello schiacciante onere della civiltà che, anche qualora dovesse venire pagato con gravi perdite, ci fa tuttavia fortemente sperare in un nuovo Rinascimento. L’intera opera é talvolta pervasa da un senso di ambiguità, con il quale il pensatore tedesco vuol dimostrare che ciò che é bene può anche essere male (e viceversa) : Pieno di riguardi. – Non voler offendere né danneggiare nessuno può essere segno di una mentalità equa, ma anche di una timorosa , egli afferma amaramente; oppure egli dice con un pizzico di ironia che l’ipocrita più raffinato. – Non parlare per niente di sé è un’ipocrisia molto raffinata. Ma anche in quest’opera sullo sfondo c’é l’idea tipicamente nietzscheana della volontà di potenza, secondo la quale ogni nostra azione ha come fine ultimo l’aumento del nostro potere: Bontà materna. – Certe madri hanno bisogno di figli felici onorati; altre di figli infelici: altrimenti la loro bontà materna non può manifestarsi. Ma non mancano le critiche rivolte ai bugiardi e agli ipocriti, contro cui Nietzsche si scaglia per tutto il corso della sua vita: Contro i visionari. – Il visionario nega la verità di fronte a se stesso, il bugiardo solo di fronte agli altri. Ed é poi evidente in un certo senso il biasimo mosso alla società moderna, con i suoi costumi e le sue mode:Musica d’oggi. – Questa musica modernissima, con i suoi polmoni forti e i nervi deboli, è la prima a spaventarsi di se stessa. Troppo e troppo poco. – Oggi gli uomini vivono troppe cose e riflettono troppo poco: hanno insieme fame e colica, e perciò diventano sempre più magri, per quanto mangino. Chi oggi dice: “Non mi è mai successo niente”, è uno sciocco. Dura é anche la critica ai deboli, a quelli che, secondo la morale cristiana, esercitano l’indulgenza e la pazienza : Non far valere il proprio diritto. – Esercitare il potere costa fatica e richiede coraggio. Perciò tanti non fanno valere il loro buon, buonissimo diritto, perché questo diritto è una specie di potere, e loro invece sono troppo pigri o troppo vigliacchi per esercitarlo. Indulgenza e pazienza vengono chiamate le virtù che mascherano questi difetti. Ma che cosa é, in buona fine, la chimica delle idee e dei sentimenti ? Ce lo spiega Nietzsche nell’apertura di “Umano, troppo umano”: “I problemi filosofici riprendono oggi in tutto e per tutto quasi la stessa forma interrogativa di duemila anni fa: come può qualcosa nascere dal suo opposto, per esempio il razionale dall’irrazionale, ciò che sente da ciò che é morto, la logica dall’illogicità, il contemplare disinteressato dal bramoso volere, il vivere per gli altri dall’egoismo, la verità dagli errori? La filosofia metafisica ha potuto finora superare questa difficoltà negando che l’una cosa nasce dall’altra e ammettendo per le cose stimate superiori un’origine miracolosa, che scaturirebbe immediatamente dal nocciolo e dall’essenza della ‘cosa in sè’. Invece la filosofia storica, che non é più affatto pensabile separata dalle scienze naturali, ed é il più recente di tutti i metodi filosofici, ha accertato in singoli casi (e questo sarà presumibilmente il suo risultato in tutti i casi), che quelle cose non sono opposte, tranne che nella consueta esagerazione della concezione popolare o metafisica, e che alla base di tale contrapposizione sta un errore di ragionamento: secondo la sua spiegazione, non esiste, a rigor di termini, nè un agire altruistico nè un contemplare pienamente disinteressato, entrambe le cose sono soltanto sublimazioni, in cui l’elemento base appare quasi volatilizzato e solo alla più sottile osservazione si rivela ancora esistente. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno e che allo stato presente delle singole scienze può esserci veramente dato, é una chimica delle idee e dei sentimenti morali, religiosi ed estetici, come pure di tutte quelle emozioni che sperimentiamo in noi stessi nel grande e piccolo commercio della cultura e della società, e perfino nella solitudine: ma che avverrebbe, se questa chimica concludesse col risultato che anche in questo campo i colori più magnifici si ottengono da materiali bassi e perfino spregiati? Avranno voglia, molti, di seguire tali indagini? L’umanità ama scacciare dalla mente i dubbi sull’origine e i princìpi: non si deve forse essere quasi disumanizzati per sentire in sè l’inclinazione opposta?” Ma in “Umano, troppo umano” Nietzsche tratta anche di politica, prevedendo con grande acutezza una ormai prossima democratizzazione dell’Europa; per quel che riguarda il socialismo, Nietzsche, suo acerrimo nemico, ravvisa in Platone l’archegeta di tale movimento; ma la parte più affascinante é quella conclusiva: l’opera si conclude infatti con quello che il pensatore tedesco definisce un “aureo motto”: “All’uomo sono state poste molte catene, affinchè egli disimpari a comportarsi come un animale; e veramente egli è divenuto più mite, spirituale, gioioso e assennato di tutti gli animali. Ma ora soffre ancora del fatto di aver portato per tanto tempo le catene, di aver mancato per tanto tempo di aria buona e di movimento libero; queste catene però sono, lo ripeterò sempre di nuovo, gli errori gravi e insieme sensati delle idee morali, religiose e metafisiche. Solo quando anche la malattia delle catene sarà superata, la prima grande meta sarà veramente raggiunta: la separazione dell’uomo dagli animali.- Ora noi siamo impegnati nel nostro lavoro di togliere le catene e ci è necessaria, in tale circostanza, la massima prudenza. La libertà dello spirito può essere data solo all’uomo nobilitato; a lui solo rende vicino l’alleggerimento della vita spargendo balsamo sulle sue ferite; egli per primo può dire di vivere per la gioia e per nessun altro scopo; e su ogni altra bocca il suo motto sarebbe pericoloso: pace intorno a me e un prender piacere a tutte le cose più vicine.- Con questo motto per singoli uomini, egli si circonda di un’antica, grande e toccante parola, che fu detta per tutti, e che si è fermata sopra l’umanità intera, come un motto e un simbolo, per cui è destinato a perire chiunque ne adorni troppo presto la propria bandiera,- per cui è perito il cristianesimo. Ancora, così sembra, non è tempo che a tutti gli uomini possa accadere come a quei pastori che videro rischiarato il cielo sopra di sé e udirono quella parola: ‘Pace in terra e agli uomini un prender piacere gli uni agli altri’.- Questo è ancora il tempo degli individui.” Vi é poi il celeberrimo dialogo tra il viandante e la sua ombra: é Nietzsce che dialoga con se stesso, per molti versi.
*
* *
L’ombra: Giacché è tanto tempo che non ti sento parlare, vorrei dartene un’occasione.
Il viandante: Parla – dove? e chi? è quasi come se sentissi parlare me stesso, solo con voce più debole della mia.
L’ombra (dopo una pausa): Non sei contento di avere un’occasione di parlare?
Il viandante: Per dio e per tutte le cose a cui non credo, è la mia ombra che parla: la sento, ma non ci credo.
L’ombra: Accettiamolo e non pensiamoci oltre, tra un’ora sarà tutto finito.
Il viandante: Pensai proprio così, quando in un bosco vicino a Pisa vidi prima due e poi cinque cammelli.
L’ombra: E’ bene che ambedue siamo ugualmente indulgenti verso di noi, se per una volta la nostra ragione tace: così anche nel nostro colloquio non ci adireremo e non metteremo subito le manette all’altro se la sua parola ci suonerà incomprensibile. Se proprio non si sa rispondere, basta già dire qualcosa: questa è l’equa condizione alla quale io mi intrattengo con qualcuno. In un dialogo un po’ lungo, anche il più savio diventa una volta pazzo e tre volte babbeo.
Il viandante: Le tue modeste pretese non sono lusinghiere per colui al quale le confessi.
L’ombra: Debbo dunque lusingare?
Il viandante: Pensavo che l’ombra dell’uomo fosse la sua vanità: ma questa non chiederebbe mai: “debbo dunque lusingare?”.
L’ombra: La vanità umana, se ben la conosco, non domanda neppure, come io ho già fatto due volte, se può parlare: parla sempre.
Il viandante: Solo adesso mi accorgo quanto sono scortese nei tuoi confronti, mia cara ombra: non ho ancor neppure fatto parola su quanto mi rallegra di ascoltarti, e non solo di vederti. Lo sai, io amo l’ombra come amo la luce. Perché esistano la bellezza del volto, la chiarezza del discorso, la bontà e fermezza del carattere, l’ombra è necessaria quanto la luce. Esse non sono avversarie: anzi si tengono amorevolmente per mano, e quando la luce scompare, l’ombra le scivola dietro.
L’ombra: E io odio quel che odi tu, la notte; amo gli uomini perché sono seguaci della luce, e mi allieta lo splendore che è nel loro occhio quando conoscono e scoprono, loro, gli infaticabili conoscitori e scopritori. Quell’ombra che tutte le cose mostrano quando su di esse cade il sole della conoscenza – io sono anche quell’ombra.
Il viandante: Credo di capirti, anche se ti sei espressa in modo un po’ umbratile. Ma avevi ragione: i buoni amici si dicono talvolta una parola oscura, come segno d’intesa, che dev’essere un enigma per ogni altra persona. E noi siamo buoni amici. Perciò basta con i preamboli! Centinaia di domande premono il mio animo, e il tempo in cui tu potrai rispondervi è forse troppo breve. Vediamo su che cosa incontrarci in fretta e pacificamente.
L’ombra: Ma le ombre sono più timide degli uomini: non dirai a nessuno come abbiamo parlato insieme!
Il viandante: Come abbiamo parlato insieme? Il cielo mi guardi da lunghi ed elaborati dialoghi scritti! Se Platone avesse avuto meno gusto a elaborare, i suoi lettori avrebbero più gusto a lui. Un dialogo che nella realtà delizia è, se trasformato in scrittura e letto, un quadro con prospettive del tutto false: tutto è troppo lungo o troppo corto. – Tuttavia potrò forse comunicarti su che cosa ci siamo accordati?
L’ombra: Questo mi basta; perché tutti vi riconosceranno solo le tue opinioni; nessuno si ricorderà dell’ombra.
Il viandante: Forse ti sbagli, amica! Sinora nelle mie opinioni si è vista più l’ombra che me.
L’ombra: Più ombra che luce? E’ possibile?
Il viandante: Sii seria, cara matta! La mia prima domanda esige subito serietà!
L’ombra: Di quel che hai detto, più di tutto mi è piaciuta una promessa: che volete ridiventare buoni vicini delle cose prossime. Questo tornerà a vantaggio anche di noi, povere ombre. Perché, ammettetelo, sinora ci avete calunniato anche troppo volentieri.
Il viandante: Calunniato? Ma perché non vi siete difese? Avevate pur vicine le nostre orecchie.
L’ombra: Ci sembrava appunto di esservi troppo vicine per poter parlare di noi stesse.
Il viandante: Delicato! Assai delicato! Ah, voi ombre siete “uomini migliori” di noi, me ne accorgo.
L’ombra: Eppure ci avete chiamato “importune” – noi, che almeno una cosa sappiamo fare – tacere e attendere – nessun inglese lo sa far meglio. £ vero, ci si trova molto, molto spesso al seguito dell’uomo, ma mai come sue schiave. Quando l’uomo fugge la luce, noi fuggiamo l’uomo: a tanto arriva la nostra libertà.
Il viandante: Ahimè, tanto più spesso è la luce a fuggir l’uomo e allora anche voi lo abbandonate.
L’ombra: Ti ho abbandonato spesso con dolore: a me, avida di sapere, tante cose dell’uomo sono rimaste oscure, perché non posso esser sempre intorno a lui. Pur di possedere una totale conoscenza dell’uomo, sarei volentieri la tua schiava.
Il viandante: Lo sai tu, lo so io, se tu da schiava non diventeresti improvvisamente padrona? Oppure se tu rimarresti schiava ma, disprezzando il tuo padrone, condurresti una vita di umiliazione, di disgusto? Accontentiamoci ambedue della libertà, così come è rimasta a te – a te e a me! Giacché la vista di un essere non libero amareggerebbe le mie gioie più grandi; le migliori cose mi ripugnerebbero, se qualcuno dovesse dividerle con me, – non voglio sapere di schiavi intorno a me. Per questo non amo il cane, il pigro e scodinzolante parassita, che è diventato “cane” solo come servo degli uomini, e di cui essi sogliono addirittura decantare la fedeltà al padrone e il fatto di seguirlo come la sua. –
L’ombra: Come la sua ombra, essi dicono. Forse anch’io oggi ti ho seguito per troppo tempo? E’ stato il giorno più lungo, ma ne siamo alla fine, abbi ancora un attimo di pazienza! Il prato è umido, ho i brividi.
Il viandante: Oh, è già tempo di separarsi? E ho dovuto alla fine farti ancora male, l’ho visto: sei diventata più scura.
L’ombra: Arrossivo, nel colore in cui posso farlo. Mi è venuto in mente che spesso sono stata ai tuoi piedi come un cane, e che tu allora –
Il viandante: E, in tutta fretta non potrei farti ancora
L’ombra: Nessuno, tranne quello che ebbe il “cane” filosofico davanti al grande Alessandro: togliti un poco dal sole, ho troppo freddo.
Il viandante: Che debbo fare?
L’ombra: Cammina sotto quei pini e guarda i monti: il sole tramonta.
Il viandante: Dove sei? Dove sei?
AURORA. PENSIERI SUI PREGIUDIZI MORALI
Con questo libro comincia la mia campagna contro la morale.
“Aurora” é l’opera con cui Nietzsche si avvia verso quella “guarigione”, che viene a coincidere con la sua perfetta maturità, ed é anche l’opera in cui diventa centrale la “passione della conoscenza”, a cui Nietzsche si abbandonerà fino all’ultimo. Lo stile aforistico raggiunge qui uno dei suoi apici: con le sue antenne ipersensibili Nietzsche si avvicina ai temi più vari: dal Cristianesimo ai valori morali moderni, dalla dècadence alla “cattiva coscienza” , dalla civiltà greca al romanticismo tedesco. E ce li presenta col gesto più fermo e insieme delicato, in un libro dove -egli stesso ci consiglia- si può “metter la testa dentro e sempre di nuovo fuori, senza trovare intorno a sè nulla di consueto”. L’opera fu composta nel 1881 e dimostra il desiderio di Nietzsche di scavare nei presupposti della morale, che vengono ricondotti principalmente alla pressione della paura e del conformismo sociale ( “spirito del gregge” ). D’altro canto in tutte le forme della morale, anche quelle del sacrificio e dell’ascetismo proprie del Cristianesimo, si cerca di soddisfare comunque il senso della potenza, che é il connotato di ogni agire umano. ” Con questo libro comincia la mia campagna contro la morale ” , dirà Nietzsche stesso, nell’anelito di conservare la vivezza delle intuizioni primitive. La ricerca dell’essenza della morale si sviluppa attraverso la critica di quelli che sono stati posti come i suoi fondamenti tradizionali: il dovere (Kant), l’utile (Spencer), la compassione (Shopenhauer). A sostituirli sembra intervenire il concetto di paura. Lo stretto condizionarsi reciproco degli uomini nella società (per cui il valore di un uomo risiede completamente nel giudizio che il prossimo si forma su di lui) anticipa il futuro concetto di “gregge” e costituisce il terreno da cui sorge il concetto stesso di morale; in contrapposizione a ciò va delineandosi ora, per la prima volta, il concetto di “individuo”, che sintetizza ciò che gli uomini intendono per immorale. La critica della società moderna si avvia a diventare argomento predominante. “Si corrompe nel modo più sicuro un giovane, se gli si insegna a stimare chi la pensa come lui più di chi la pensa diversamente”. La bruciante sentenza eraclitea, “ho indagato me stesso”, viene qui raccontata in un libro intero: meditando su di sè, Nietzsche vi ha trovato il mondo; su tutti gli oggetti che illustra, lui ha lasciato l’impronta di sè, del conoscitore. Il lettore più ingenuo potrebbe rimanere incantato dal bel apparato artistico messo in atto da Nietzsche con “Aurora”, pensando che in realtà non voglia comunicare nulla, ma é Nietzsche stesso ad esortare alla diffidenza, ad andare oltre il significato superficiale: “Non c’é cosa che artisti, poeti e scrittori temano di più di quell’occhio che vede la loro piccola frode… quell’occhio che chiede loro conto se vollero vendere poco per molto” (af. 223). In “Umano, troppo umano” il filosofo tedesco aveva presentato una scienza fatta di intuizioni, in “La gaia scienza” fornirà ancora una scienza, la cui indicazione é di identificarsi con la poesia, qui lui dà sempre una scienza, la cui indicazione é di identificarsi con la poesia, qui lui dà sempre una scienza, i cui contenuti sono più variegati e fluttuanti, non appartengono alla sfera politica e statale, raramente si concentrano su figure di filosofi o artisti. Ed é bene citare due esempi per quale nobilissimo alibi egli usi della parola scienza in Aurora: nell’af. 76, in cui si tratta della calunnia cristiana contro l’amore e la procreazione, troviamo scritto: “Infine questa diabolizzazione di Eros ha avuto un epilogo da commedia […] che fin nel bel mezzo della nostra epoca, la vicenda amorosa é divenuta l’unico reale interesse comune a tutti gli ambienti- in una esagerazione inconcepibile all’antichità, esagerazione cui seguirà più tardi, quando che sia, anche uno scoppio di ilarità”. Ecco un bell’esempio di scienza, intesa come pura intuizione, basata sulla pura esperienza immediata. E’ una valutazione del presente (1800) illuminata da un giudizio del passato (visione del mondo cristiana): ed é per questo che si può parlare di vera e propria intuizione storica, in cui Nietzsche apre una prospettiva nella storia, passata, presente e futura. Ma sarebbe riduttivo intendere l’intera scienza nietzscheana come “intuizione storica”! Nietzsche, nella prefazione, non esita a definire il suo libro come “pessimista fin nel cuore della morale, fino a trascendere la fiducia nella morale”, ritenendolo così una produzione tedesca a tutti gli effetti; egli non concorda, come già ci aveva dato modo di intendere nella “Nascita della tragedia”, nel trovare a tutto una spiegazione razionale e dice esplicitamente, a proposito: “Tutte le cose che vivono a lungo, s’impregnano a poco a poco di ragione, a tal punto che la loro provenienza dall’irrazionale diventa perciò improbabile”; e del resto “com’é venuta nel mondo la ragione?Com’é giusto che arrivasse, in un modo irrazionale, attraverso il caso.” Così Nietzsche può muover guerra al concetto di causalità ( con la quale si vedono solo le figure di cause ed effetti, senza però capire nulla di più profondo!) , a quello di finalità ( non abbiamo gli occhi al fine di vedere: é il caso che ce li ha donati!) e a quello di volontà (ridiamo di chi dice “voglio che esca il sole!” e allo stesso modo dovremmo ridere di chi dice di voler ogni altra cosa!). Gli stessi matrimoni sono dettati dal caso, spiega Nietzsche per dar la prova alla tribuna dei lettori che esso impera ovunque: “Se fossi un dio, e un dio benigno, i matrimoni degli uomini mi farebbero perdere la pazienza più di ogni altra cosa. Il fatto che un individuo possa arrivare ben lontano, ai suoi 70, anzi ai suoi 30 anni, fa stupire anche gli dei! Ma se poi si osserva come abbandoni il patrimonio e il retaggio delle sue lotte e delle sue vittorie, l’alloro della sua umanità, appendendolo al primo posto che trova, dove una femminuccia lo coglie; se si osserva quanto é valente nel conquistare e incapace nel conservare, anzi come non pensi affatto che potrebbe preparare una vita ancor più ricca di vittorie mediante la procreazione, si viene a perdere, come già si é detto, la pazienza, e si dice a se stessi: dall’umanità, a lungo andare, non può venir fuori nulla; i singoli vengono sprecati, e la causalità dei matrimoni rende impossibile ogni razionalità di un grande cammino dell’umanità- cessiamo di essere gli appassionati spettatori e giullari di questa commedia senza meta!” Ed é tipicamente un pregiudizio morale dei dotti il credere di sapere ogni cosa meglio nel presente che nel passato. Ma i pregiudizi cristiani sono altrettanto forti e arrivano a porre limiti alla conoscenza umana: “Chi vorrà ribellarsi alla deduzione cui amano giungere i credenti: la scienza non può essere vera perchè nega Dio. Di conseguenza essa non deriva da Dio; di conseguenza non é vera, poichè Dio é la verità? Non nell’inferenza, bensì nel presupposto sta l’errore: e se Dio appunto non fosse la verità, e questo appunto fosse provato? Se egli fosse la vanità, la bramosia del potere, l’impazienza, il terrore, l’estasiato ed inorridito delirio degli uomini?” (af. 93).E d’altronde la sottomissione ad una morale, spiega Nietzsche, é qualcosa non morale! Ed ecco che poi Nietzsche analizza la società tedesca e la sua morale: lo spirito tedesco é particolarmente incline ad ubbidire agli ordini impartiti, ma, al momento giusto, sa anche acquisire la sua autonomia e la sua creatività personale: i Tedeschi sono capaci di grandissime cose, ma é improbabili che le facciano secondo Nietzsche! Ed é per questo che insito in loro vi é qualcosa di superiore, che prima o poi dovrà manifestarsi. In tutta l’opera aleggia un clima particolare, si potrebbe dire desueto alle istanze di cui Nietzsche si fa portavoce: si ha la sensazione che il pensatore tedesco non voglia lasciar trapelare dove si rivolge la sua simpatia e dove la sua antipatia. Così si preoccupa persino di non offendere troppo il Cristianesimo, come fa invece nelle altre opere, riconoscendogli, qua e là, qualche pregio. Ma c’é un punto in cui Nietzsche cade in trappola, applicando con eccessiva disinvoltura questa tecnica del rovesciamento. Ed é quando, con stupefazione, lo ascoltiamo tessere un elogio della dialettica, la sua bestia nera di sempre: nell’af. 544 leggiamo infatti: “Lo vedo bene: i nostri giovinetti […] pretendono oggi dalla filosofia proprio il contrario di quel che ne ricevevano i Greci. Chi non sente il continuo tripudio che pervade ogni battuta e ogni replica in un dialogo platonico, il tripudio sulla nuova invenzione del pensiero razionale, che cosa comprende di Platone, che cosa dell’antica filosofia? Quando si praticava il gioco asciutto e rigoroso del concetto…”. Non si crede alle proprie orecchie , ma Nietzsche ribadisce: “Socrate fu colui che scoprì l’incantesimo […] della causa e dell’effetto, del fondamento e della conseguenza: e noi uomini moderni siamo così abituati alla necessità della logica e così educati ad essa, che essa rappresenta per la nostra lingua il sapore normale, necessariamente spiacevole agli ingordi e ai boriosi. Quel che si distacca da esso, li manda in solluchero…”. E in questo periodo Nietzsche é impegnatissimo nella vita politica, numerosissime sono le sue meditazioni su Napoleone e Paolo. Ma in Aurora questo non affiora e domina incontrastata la dichiarazione “dello Stato, il meno possibile!” (af. 179). Qui si teorizza la conoscenza come supremo valore della vita e nel far questo Nietzsche si sforza di debellare il valore contrapposto, l’azione. Dal momento che é sul metro della conoscenza che l’azione viene giudicata: “Tutte le azioni sono essenzialmente ignote” (af. 116). Ma la preminenza del conoscere sull’agire non é solo puramente speculativa, si tratta anche di una preminenza morale: “E così sarebbe forse l’impulso ad agire, nient’altro, in definitiva, che un fuggire a se stessi?” (af. 549). Splendido é poi il finale dell’opera, in cui Nietzsche arriva a paragonare gli ingegni superiori agli uccelli che spiccano il volo, che tanto più si innalzano e tanto più sembrano piccoli a quelli che non possono volare: evidente é il significato allegorico: chi si eleva al di sopra degli altri uomini, non viene compreso, viene anzi osteggiato, si cerca di tirarlo giù per riportarlo al pari dell’ “armento”. “Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare. Tutti questi arditi uccelli che spiccano il volo nella lontananza, nell’estrema lontananza, di sicuro, a un certo momento non potranno più andare oltre e si appollaieranno su un pennone o su un piccolo scoglio- e per di più grati di questo miserevole ricetto! Ma a chi sarebbe lecito trarne la conseguenza che non c’è più dinanzi a loro nessuna immensa, libera via, che sono volati tanto lontano quanto è possibile volare? Tutti i nostri grandi maestri e precursori hanno finito coll’arrestarsi; e non è il gesto più nobile e il più leggiadro atteggiamento, quello con cui la stanchezza si arresta: sarà così anche per me e per te! Ma che importa a me e a te! Altri uccelli voleranno oltre! Questo nostro sapere e questa nostra fiducia spiccano il volo con essi e si librano in alto, salgono a picco sul nostro capo e oltre la sua impotenza, lassù in alto, e di là guardano nella lontananza, vedono stormi d’uccelli molto più possenti di quanto siamo noi, i quali agogneranno quel che agognammo noi, in quella direzione dove tutto è ancora mare, mare, mare! E dove dunque vogliamo arrivare? Al di là del mare? Dove ci trascina questa possente avidità, che è più forte di qualsiasi altro desiderio? Perché proprio in quella direzione, laggiù dove sono fino ad oggi tramontati tutti i soli dell’umanità? Un giorno si dirà forse di noi che, volgendo la prua a occidente, anche noi speravamo di raggiungere l’India, ma che fu il nostro destino a naufragare nell’infinito? Oppure, fratelli miei? Oppure”
COSI’ PARLO’ ZARATHUSTRA
Fra i miei scritti sta a sè il mio Zarathustra. Con esso io ho fatto all’umanità il più grande regalo che le sia mai stato fatto.
L’ idea di Così parlò Zarathustra Balenò a Nietzsche come una folgorazione nell’ agosto del 1881 , in Engadina ( Svizzera ) , ” 6000 piedi al di là dell’ uomo e del tempo ” . Essa coincise con il rivelarsi dell’ ” eterno ritorno ” , una delle teorie più fortemente nietzschiane . Lo Zarathustra rielabora e ripresenta tutto ciò che Nietzsche era stato fino allora in una forma assolutamente nuova , e soprattutto in una forma incompatibile con i canoni della filosofia occidentale . ” Un libro per tutti e per nessuno ” é il sottotitolo di Così parlò Zarathustra : proprio perchè obbliga il pensiero a parlare immediatamente , fuori da ogni tecnicismo , in una forma poetica e profetica : tutti possono leggerlo , ma chi può capirne fino in fondo il significato ? Probabilmente nessuno . Non a caso ogni volta che si apre questo libro carico di enigmi , esso appare sorprendente e diverso , quasi se non si esaurisse mai il suo significato . Nietzsche era consapevole di questa ambiguità e di questa polisemia del suo libro , e in certo modo dell’ intera sua opera ; in una lettera del 1884 scriveva : ” Chissà quante generazioni dovranno trascorrere per produrre alcune persone che riescano a sentire dentro di sè ciò che ho fatto ! E anche allora mi terrorizza il pensiero di tutti coloro che , ingiustificatamente e del tutto impropriamente , si richiameranno alla mia autorità . Ma questo é il tormento di ogni grande maestro dell’ umanità : egli sa che , in date circostanze del tutto accidentali , può diventare con la stessa facilità una sventura o una benedizione per l’ umanità ” .Così parlò Zarathustra è l’opera che riassume il pensiero dell’ultima fase intellettuale di Nietzsche. L’opera è scritta secondo un modello che richiama lo stile del Nuovo Testamento e questa scelta di stesura in forma profetica ci fa intuire come Nietzsche , da questo periodo della sua vita in poi, si senta investito di un compito epocale, una convinzione di dover provocare un mutamento radicale di civiltà, mutamento concepito in solitudine e in un totale isolamento intellettuale. In questa opera Nietzsche prende congedo dal moralista e dallo psicologo e prende i toni di un profeta e di un lirico. Negli scritti successivi tale rottura va perduta, ed anche il respiro profetico. L’esame del contenuto porta comunque a scoprire una continuità di sviluppo: che Al di là del bene del male abbia i medesimi contenuti di Così parlò Zarathustra lo dice Nietzsche stesso; che un’uguale tematica sia già presente nella Gaia scienza è facilmente dimostrabile da un’analisi dell’opera e dei relativi frammenti postumi. Ma i contenuti non sono l’essenziale per Nietzsche: in quest’opera ciò che conta è il dettaglio, la singola visione, il tempo, il colore musicale, piuttosto che non i pensieri di fondo. Questo non inteso letterariamente (che sia essenziale la forma) ma filosoficamente. Piuttosto la forma è rivelatrice di un tentativo particolare di comunicazione, dove ciò che importa è anzitutto quello che vuol essere comunicato. Poesia e filosofia consistono in questo: rievocare, collegare (in un certo modo e in una certa forma) immagini, sentimenti e concetti preesistenti; e dove venga usato un linguaggio simbolico, alludere (attraverso una trasposizione immaginativa) a immagini, sentimenti e concetti già costituiti. Ma quando questi manchino, ossia quando ciò che è manifestato da un’espressione non sia esso stesso espressione, bensì una certa immediatezza di vita, fuori della rappresentazione e della coscienza, allora intervengono forme espressive analoghe a quelle di Così parlò Zarathustra. Questo libro sembra sorgere perciò dalla sfera delle espressioni primitive, ed è arduo classificarlo come opera filosofica. Una filosofia è di regola una manipolazione di concetti, i quali esprimono oggetti sensibili, mentre qui immagini e concetti non esprimono né concetti né cose concrete, sono simboli di qualcosa che non ha volto, sono espressioni nascenti. Così parlò Zarathustra è “un libro per tutti”, è stato un serio tentativo di portare la filosofia su un piano esoterico, strappandola al tecnicismo, all’isolamento di cerchie senza risonanza, alla derisione che viene riservata a un’arte pretenziosa fuori moda. E’ anche “un libro per nessuno”, una battaglia di vasta portata,: ma quello che sul fondo di essa vi è di remoto, nascosto, inaccessibile, intorbida la chiarezza della comunicazione. La melanconia di Zarathustra, i suoi lunghi silenzi, i sogni orrendi, l’ora senza voce, alludono di continuo ad una natura precocemente armata contro la vita, esposta al contagio pessimistico. Ma non c’è solo sensibilità, ma anche reattività, quella di un superuomo che declassa la ragione e afferma di nuovo la naturalità. Ma chi é Zarathustra , il folgorante profeta del superuomo , in fin dei conti ? Egli é il ” senzadio ” per eccellenza , il sostenitore della teoria del superuomo e dell’ eterno ritorno ; dopo essersi allontanato dalla sua città che aveva 30 anni e dopo averne passati 10 sui monti , in un luogo ameno e isolato , in compagnia di se stesso e dei suoi amici animali , all’ età di 40 anni sente il bisogno di tornare in mezzo agli uomini per metterli a conoscenza della teoria del superuomo , per insegnare loro ad apprezzare il mondo terreno per quello che é , senza vivere aspettando un presunto mondo ultraterreno che non può che non esserci : Giunto a trent’ anni , Zarathustra lasciò il suo paese e il lago del suo paese , e andò sui monti . Qui godette del suo spirito e della sua sua solitudine , nè per dieci anni se ne stancò . Alla fine si trasformò il suo cuore , – e un mattino egli si alzò insieme all’ aurora , si fece al cospetto del sole e così gli parlò : – “Astro possente ! Che sarebbe la tua felicità , se non avessi coloro ai quali tu risplendi ! Per dieci anni sei venuto quassù , alla mia caverna : sazio della tua luce e di questo cammino saresti divenuto , senza di me , la mia aquila , il mio serpente . Noi però ti abbiamo atteso ogni mattino e liberato dal tuo superfluo ; di ciò ti abbiamo benedetto . Ecco ! La mia saggezza mi ha saturato fino al disgusto ; come l’ ape che troppo miele ha raccolto, ho bisogno di mani che si protendano . Vorrei spartire i miei doni , finchè i saggi tra gli uomini tornassero a rallegrarsi della loro follia e i poveri della loro ricchezza . Perciò devo scendere a giù in basso : come tu fai la sera , quando vai dietro al mare e porti la luce al mondo infero , o ricchissimo fra gli astri ! Anch’ io devo al pari di te , tramontare , come dicono gli uomini , ai quali voglio discendere . Benedicimi , occhio pacato , scevro d’ invidia anche tu alla vista di una felicità troppo grande ! Benedici il calice , traboccante a far scorrere l’ acqua d’ oro , che ovunque porti il riflesso splendente della tua dolcezza ! Ecco ! Il calice vuol tornare vuoto , Zarathustra vuol tornare uomo”. Così cominciò il tramonto di Zarathustra . Zarathustra fa il suo arrivo in città e al vedere una folla non può resistere : ecco allora che pronuncia la teoria del superuomo ( oltreuomo ) , sostenendo che l’ uomo in sè non sia un punto di arrivo , ma di partenza per dare un qualcosa di più , il superuomo appunto ; questi afferma la vita accettandone la sofferenza, il dolore e le contraddizioni che l’accompagnano con gioioso (dionisiaco) amore per l’esistenza; è un creatore di valori ed è per questo privo di valori fissi e immutabili, al di là del bene e del male, artefice di una “morale autonoma ” . Ecco come Zarathustra arringa la folla : Giunto nella città vicina, sita presso le foreste, Zarathustra vi trovò radunata sul mercato una gran massa di popolo: era stata promessa infatti l’esibizione di un funambolo. E Zarathustra parlò così alla folla:Io vi insegno il superuomo. L’uomo è qualcosa che deve essere superato. Che avete fatto per superarlo? Tutti gli esseri hanno creato qualcosa al di sopra di sé: e voi volete essere il riflusso in questa grande marea e retrocedere alla bestia piuttosto che superare l’uomo? Che cos’è per l’uomo la scimmia? Un ghigno o una vergogna dolorosa. E questo appunto ha da essere l’uomo per il superuomo: un ghigno o una dolorosa vergogna. Avete percorso il cammino dal verme all’uomo, e molto in voi ha ancora del verme. In passato foste scimmie, e ancor oggi l’uomo è più scimmia di qualsiasi scimmia. E il più saggio tra voi non è altro che un’ibrida disarmonia di pianta e spettro. Voglio forse che diventiate uno spettro o una pianta? Ecco, io vi insegno il superuomo! Il superuomo è il senso della terra. Dica la vostra volontà: sia il superuomo il senso della terra! Vi scongiuro, fratelli rimanete fedeli alla terra e non credete a quelli che vi parlano di sovraterrene speranze! Lo sappiano o no: costoro esercitano il veneficio. Dispregiatori della vita essi sono, moribondi e avvelenati essi stessi, hanno stancato la terra: possano scomparire! Un tempo il sacrilegio contro Dio era il massimo sacrilegio, ma Dio è morto, e così sono morti anche tutti questi sacrileghi. Commettere il sacrilegio contro la terra, questa è oggi la cosa più orribile, e apprezzare le viscere dell’imperscrutabile più del senso della terra! In passato l’anima guardava al corpo con disprezzo: e questo disprezzo era allora la cosa più alta: essa voleva il corpo macilento, orrido, affamato. Pensava in tal modo, di poter sfuggire al corpo e alla terra. Ma questa anima era anch’essa macilenta, orrida e affamata: e crudeltà era la voluttà di questa anima! Ma anche voi, fratelli, ditemi: che cosa manifesta il vostro corpo dell’anima vostra? Non è forse la vostra anima indigenza e feccia e miserabile benessere? Davvero, un fiume immondo è l’uomo. Bisogna essere un mare per accogliere un fiume immondo, senza diventare impuri. Ecco, io vi insegno il superuomo: egli è il mare, nel quale si può inabissare il vostro grande disprezzo. Qual è la massima esperienza che possiate vivere? L’ora del grande disprezzo. L’ ora in cui vi prenda lo schifo per la vostra felicità e così pure per la vostra ragione e la vostra virtù . L’ ora in cui diciate : ” Che importa la mia felicità ? Essa é indigenza e feccia e un miserabile benessere . Ma la mia felicità dovrebbe giustificare persino l’ esistenza ! ” L’ ora in cui diciate : ” Che importa la mia ragione ! Forse che essa anela al sapere come il leone al suo cibo ? Essa é indigenza e feccia e un miserabile benessere ” . L’ ora in cui diciate : ” Che importa la mia virtù ! Finora non mi ha mai reso furioso . Come sono stanco del mio bene e del mio male ! Tutto ciò é indigenza e feccia e benessere miserabile ! ” . L’ ora in cui diciate : ” Che importa la mia giustizia ! Non mi vedo trasformato in brace ardente Ma il giusto é brace ardente ! ” . L’ ora in cui diciate : ” Che importa la mia compassione ! Non é forse la compassione la croce cui viene inchiodato chi ama gli uomini ? Ma la mia compassione non é crocefissione ” . Avete già parlato così ? Avete mai gridato così ? Ah , vi avessi già udito gridare così ! Non il vostro peccato – la vostra accontentabilità grida al cielo, la vostra parsimonia nel vostro peccato grida al cielo! Ma dov’è il fulmine che vi lambisca con la sua lingua! Dov’è la demenza che dovrebbe esservi inoculata? Ecco, io vi insegno il superuomo: egli è quel fulmine e quella demenza! – Zarathustra aveva detto queste parole, quando uno della folla gridò: “Abbiamo sentito parlare anche troppo di questo funambolo; è ora che ce lo facciate vedere!”. E la folla rise di Zarathustra. Ma il funambolo, credendo che ciò fosse detto per lui, si mise all’opera. Zarathustra invece guardò meravigliato la folla. Poi parlò così: L’uomo è un cavo teso tra la bestia e il superuomo, – un cavo al di sopra di un abisso. Un passaggio periglioso, un periglioso essere in cammino, un periglioso guardarsi indietro e un periglioso rabbrividire e fermarsi. La grandezza dell’uomo è di essere un ponte e non uno scopo: nell’uomo si può amare che egli sia una transizione e un tramonto. Io amo coloro che non sanno vivere se non tramontando, poiché essi sono una transizione. Io amo gli uomini del grande disprezzo, perché essi sono anche gli uomini della grande venerazione e frecce che anelano all’altra riva. Io amo coloro che non aspettano di trovare una ragione dietro le stelle per tramontare e offrirsi in sacrificio: bensì si sacrificano alla terra, perché un giorno la terra sia del superuomo.Io amo colui che vive per la conoscenza e vuole conoscere, affinché un giorno viva il superuomo. E così egli vuole il proprio tramonto. Io amo colui che lavora e inventa, per costruire la casa al superuomo, e gli prepara la terra, l’animale e la pianta: giacché così egli vuole il proprio tramonto. Io amo colui che ama la sua virtù: giacché virtù è volontà di tramontare e una freccia anelante. Io amo colui che non serba per sè una goccia di spirito , bensì vuol essere in tutto e per tutto lo spirito della sua virtù : in questo modo egli passa , come spirito , al di là del ponte . Io amo colui che della sua virtù fa un’ inclinazione e un destino funesto : così egli vuole vivere , e insieme non più vivere , per amore della sua virtù . Io amo colui che non vuole avere troppe virtù . Una virtù é più virtù di due , perchè essa é ancor più il cappio cui si annoda un destino funesto . Io amo colui l’ anima del quale si dissipa e non vuol essere ringraziato , nè dà qualcosa in cambio : giacchè egli dona sempre e non vuol conservare se stesso . Io amo colui che si vergogna quando il lancio dei dadi riesce in suo favore e si domanda : son forse un baro ? egli infatti vuole perire . Io amo colui che getta avanti alle proprie azioni parole auree e mantiene più di quanto prometta : egli infatti vuole il proprio tramonto . Io amo colui che giustifica gli uomini dell’ avvenire e redime quelli del passato : a causa degli uomini del presente egli infatti vuole perire . Io amo colui che castiga il suo dio perchè ama il suo dio : giacchè dovrà perire per l’ ira del suo dio . Io amo colui l’anima del quale trabocca da fargli dimenticare se stesso, e tutte le cose sono dentro di lui: tutte le cose divengono così il suo tramonto. Io amo colui che è di spirito libero e di libero cuore: il suo cervello, in tal modo, non è altro che le viscere del cuore, ma il suo cuore lo spinge a tramontare. Io amo tutti coloro che sono come gocce grevi, cadenti una a una dall’oscura nube incombente sugli uomini: essi preannunciano il fulmine e come messaggeri periscono. Ecco, io sono un messaggero del fulmine e una goccia greve cadente dalla nube: ma il fulmine si chiama superuomo. E’ particolarmente forte e carica di significati la definizione di uomo come cavo teso tra bestia e superuomo : spetta a ciascuno di noi scegliere la parte verso la quale ” forzare ” . Tuttavia la folla non apprezza le parole di Zarathustra , sentendosi incapace di dar vita al superuomo , e preferisce assistere allo spettacolo del funambolo , uno spettacolo che non mette in crisi le loro concezioni e non stravolge un mondo che a loro pareva consolidato , come invece fa Zarathustra . Ecco che il funambolo cammina sul filo teso tra due torri , un cavo teso proprio come é l’ uomo per Nietzsche ; improvvisamente però egli precipita e si schianta al suolo : é il destino dell’ uomo dai bassi ideali , che si ostina a seguire la tradizione del bene e del male , senza lasciarsi ammaestrare dagli insegnamenti di Zarathustra : una volta precipitato , egli é ancora in vita , ma gli resta poco prima di morire : Zarathustra gli si avvicina incuriosita ed egli fa le sue ultime riflessioni prima della morte , cercando di immaginare , secondo la tradizione religiosa , che cosa gli toccherà dopo la vita : sapevo da un pezzo che il diavolo mi avrebbe fatto lo sgambetto , egli dice a Zarathustra ; ma questi gli spiega che non c’ é nessun aldilà , nessun ” mondo dietro al mondo ” : Sul mio onore amico , rispose Zarathustra , le cose di cui parli non esistono : non c’ é il diavolo e nemmeno l’ inferno . La tua anima sarà morta ancor prima del corpo : ormai non hai più nulla da temere ! . Il funambolo , in fin di vita , accetta quanto Zarathustra gli dice e nell’ atto di esalare l’ anima cerca di protendere la sua mano verso quella di Zarathustra per ringraziarlo . Successivamente il saggio Zarathustra espone la grande teoria delle tre metamorfosi per diventare superuomini : attraverso le tre figure del cammello, leone, fanciullo Nietzsche riesce a spiegare il procedere umano verso la propria autoliberazione dagli idoli della superstizione e della colpa (religione e morale) verso l’innocenza dionisiaca del superuomo. Il cammello rappresenta l’uomo che teme e riverisce, che si piega davanti alla grandezza di Dio assumendo volontariamente su di sé i grandi tormenti del mondo. L’uomo poi diventa leone quando combatte contro la morale che gli è stata imposta riconoscendo il suo stato di alienazione precedente. Ma il leone possiede una “libertà da…” e non una “libertà di…” e allora per dare nuove leggi il leone deve diventare fanciullo, che rappresenta l’innocenza. I motti sono “tu devi” per il cammello, “io voglio” per il leone e “io sono” per il fanciullo . Leggiamo l’ intero passo in cui é descritto il processo : Tre metamorfosi io vi nomino dello spirito: come lo spirito diventa cammello, e il cammello leone, e infine il leone fanciullo. Molte cose pesanti vi sono per lo spirito, lo spirito forte e paziente nel quale abita la venerazione: la sua forza anela verso le cose pesanti, più difficili a portare. Che cosa è gravoso? domanda lo spirito paziente – e piega le ginocchia, come il cammello, e vuol essere ben caricato. Qual è la cosa più gravosa da portare, eroi? – così chiede lo spirito paziente, – affinché io la prenda su di me e possa rallegrarmi della mia robustezza. Non è forse questo: umiliarsi per far male alla propria alterigia? Far rilucere la propria follia per deridere la propria saggezza? Oppure è: separarsi dalla propria causa quando essa celebra la sua vittoria? Salire sulle cime dei monti per tentare il tentatore? Oppure è: nutrirsi delle ghiande e dell’erba della conoscenza e a causa della verità soffrire la fame dell’anima? Oppure è: essere ammalato e mandare a casa coloro che vogliono consolarti, e invece fare amicizia coi sordi, che mai odono ciò che tu vuoi? Oppure è: scendere nell’acqua sporca, purché sia l’acqua della verità, senza respingere rane fredde o caldi rospi? Oppure è: amare quelli che ci disprezzano e porgere la mano allo spettro quando ci vuol fare paura? Tutte queste cose, le più gravose da portare, lo spirito paziente prende su di sé: come il cammello che corre in fretta nel deserto sotto il suo carico, così corre anche lui nel suo deserto. Ma là dove il deserto è più solitario avviene la seconda metamorfosi: qui lo spirito diventa leone, egli vuol come preda la sua libertà ed essere signore nel proprio deserto. Qui cerca il suo ultimo signore: il nemico di lui e del suo ultimo dio vuol egli diventare, con il grande drago vuol egli combattere per la vittoria. Chi è il grande drago, che lo spirito non vuol più chiamare signore e dio? “Tu devi” si chiama il grande drago. Ma lo spirito del leone dice “io voglio”. “Tu devi” gli sbarra il cammino, un rettile dalle squame scintillanti come l’oro, e su ogni squama splende a lettere d’oro “tu devi!”. Valori millenari rilucono su queste squame e così parla il più possente dei draghi: “tutti i valori delle cose risplendono su di me”. “Tutti i valori sono già stati creati, e io sono ogni valore creato. In verità non ha da essere più alcun `Ìo voglio”!”. Così parla il drago. Fratelli, perché il leone è necessario allo spirito? Perché non basta la bestia da soma, che a tutto rinuncia ed è piena di venerazione? Creare valori nuovi – di ciò il leone non è ancora capace: ma crearsi la libertà per una nuova creazione – di questo è capace la potenza del leone. Crearsi la libertà e un no sacro anche verso il dovere: per questo, fratelli, è necessario il leone. Prendersi il diritto per valori nuovi – questo è il più terribile atto di prendere, per uno spirito paziente e venerante. In verità è un depredare per lui e il compito di una bestia da preda. Un tempo egli amava come la cosa più sacra il “tu devi”: ora è costretto a trovare illusione e arbitrio anche nelle cose più sacre, per predar via libertà dal suo amore: per questa rapina occorre il leone. Ma ditemi, fratelli che cosa sa fare il fanciullo, che neppure il leone era in grado di fare? perché il leone rapace deve anche diventare un fanciullo? Innocenza è il fanciullo e oblio, un nuovo inizio, un giuoco, una ruota ruotante da sola, un primo moto, un sacro dire di sì. Sì, per il giuoco della creazione, fratelli, occorre un sacro dire di sì: ora lo spirito vuole la sua volontà, il perduto per il mondo conquista per sé il suo mondo. Tre metamorfosi vi ho nominato dello spirito: come lo spirito divenne cammello, leone il cammello, e infine il leone fanciullo. Ma Zarathustra porta un insegnamento non coglibile da tutti, ma indirizzato a pochi, agli uomini superiori: “Ah fratelli, questo dio che creai era opera e follia umana, come tutti gli dei! Uomo era, e solo un povero frammento di uomo e di io: dalla mia cenere e dalla mia vampa venne a me, questo fantasma: E in verità non mi venne dall’aldilà! Ma che avvenne fratelli? Superai me stesso, me stesso sofferente, portai la mia cenere al monte, trovai per me una fiamma più limpida. Ed ecco! Il fantasma si allontanò da me! …Un nuovo orgoglio mi insegnò il mio io, e io lo insegno agli uomini: non nascondere più la testa nella sabbia delle cose celesti, ma portala libera e scoperta, una testa terrena che crea un senso alla terra….Malati e moribondi erano quelli che disprezzavano corpo e terra e inventarono il cielo e le redentrici gocce di sangue.”; il messaggio di fondo é sempre lo stesso, mantenersi fedeli alla terra senza credere in un “mondo dietro il mondo”. Dall’ esperienza cittadina Zarathustra arriva a capire che gli uomini non riescono a comprendere fino in fondo le sue teorie , lo ritengono ancora qualcosa di mezzo tra un pagliaccio e un cadavere . D’ altronde Zarathustra , in seguito , dirà per indurre gli uomini superiori a tenersi lontano dal ” volgo ” : Voi , uomini superiori , imparate questo da me : sul mercato nessuno crede a uomini superiori . E , se volete parlare lì , sia pure ! Ma la plebe dirà ammiccando : -Noi siamo tutti uguali- , l’ uomo é uomo ; davanti a Dio siamo tutti uguali ! >> . Davanti a Dio ! Ma questo Dio é morto . Davanti alla plebe , però , noi non vogliamo essere uguali . Uomini superiori , fuggite il mercato ! ; é evidente che il popolo non vorrà mai riconoscere l’ esistenza di uomini superiori ( superuomini ) , un pò perchè legato alla tradizione cristiana che vuole gli uomini tutti uguali a Dio , un pò perchè , come Nietzsche dirà in Umano , troppo umano si cerca l’ uguaglianza proprio perchè si ha timore di risultare inferiori nel confronto : si cerca cioè di tirare giù dal suo volo l’ uomo superiore , per riportarlo al livello degli altri uomini , a terra . Ecco allora che il principale nemico di Zarathustra diventa lo ” spirito di gravità ” , questa forza che attira ogni cosa verso terra , impedendo all’ uomo di elevarsi verso il cielo : Potrei credere solo a un dio che sapesse danzare . E quando ho visto il mio demonio , l’ ho sempre trovato serio , radicale , profondo , solenne : era lo spirito di gravità , grazie a lui tutte le cose cadono . Non con la collera , col riso si uccide . Orsù , uccidiamo lo spirito di gravità . Ho imparato ad andare : da quel momento mi lascio correre . Ho imparato a volare : da quel momento non voglio più essere urtato per smuovermi . Adesso sono lieve , adesso io volo , adesso vedo al di sotto di me , adesso é un dio a danzare , se io danzo . Nietzsche dichiara guerra allo spirito di gravità facendo dire a Zarathustra : Nutrito di cose innocenti , con poco , sempre pronto e impaziente di volare , di volar via , questa é la mia specie : come potrebbe non esservi qualcosa degli uccelli ! Tanto più che io sono nemico dello spirito di gravità , come lo sono gli uccelli : e ne sono nemico mortale , arcinemico , nemico da sempre ! […] Colui che un giorno insegnerà il volo agli uomini , avrà spostato tutte le pietre di confine ; esse tutte voleranno in aria per lui , ed egli darà un nuovo nome alla terra , battezzandola la leggera . Lo struzzo corre più veloce del più veloce dei cavalli , ma anche lui ficca ancora pesantemente la testa nella terra pesante : così pure l’ uomo , che ancora non sa volare . Pesante é per lui la terra e la vita ; e così vuole che sia lo spirito di gravità ! Ma chi vuol divenire leggero e un uccello , non può non amare se stesso : questo é il mio insegnamento . L’ uomo deve essere superato ripete incessantemente Zarathustra per tutta l’ opera , e il primo grande passo da fare per superarlo e lasciarsi alle spalle tutta la tradizione religiosa , più che mai quella cristiana col suo Dio nel quale é dichiarata inimicizia alla volontà di vivere ( l’ Anticristo ) , un Dio che limita la potenza umana ; il vero Dio diventa l’ uomo , anzi , il superuomo : I fichi cadono dagli alberi , essi sono buoni e dolci ; la loro rossa pelle si screpola , quando cadono . Io sono un vento del settentrione per fichi maturi . Così , simili a fichi , cadono a voi questi insegnamenti , amici miei : bevetene il succo , la loro dolce polpa ! Tutt’ intorno é autunno e cielo puro e pomeriggio . Guardate la pienezza intorno a noi ! Bello é guardare verso mari lontani , dalla sovrabbondanza .Un tempo nel guardare verso mari lontani si diceva Dio ; ora però io vi ho insegnato a dire : superuomo . Dio é una supposizione ; ma io voglio che il vostro supporre non si spinga oltre i confini della vostra volontà creatrice . Forse che potreste creare un dio ? Dunque non parlatemi di dèi ! Certo , voi potreste creare il superuomo . Forse non voi stessi , fratelli ! Ma potreste creare in voi i padri e gli antenati del superuomo : e questo sia il vostro creare migliore ! Dio é una supposizione : ma io voglio che il vostro supporre trovi i suoi confini entro ciò che é possibile pensare . Forse che potreste pensare un Dio ? Ma ciò significhi per voi volontà di verità : che tutto sia trasformato sì da poter essere pensato , visto e sentito dall’ uomo ! Voi dovete pensare fino in fondo i vostri sensi stessi ! E ciò che avete chiamato mondo , deve ancora essere da voi creato : esso deve diventare la vostra ragione , la vostra immagine , la vostra volontà , il vostro amore ! E in verità per la vostra beatitudine , o voi che conoscete ! E come vorreste sopportare la vita senza questa speranza , voi che conoscete ? Voi non dovreste essere generati nè nell’ incomprensibile nè nell’ irrazionale . Ma , affinchè vi apra tutto il mio cuore , amici : se vi fossero degli dèi , come potrei sopportare di non essere dio ! Dunque non vi sono dèi . Bene , ora ho tratto la conclusione ; ora però essa trae me : dio é una supposizione : ma chi potrebbe bere tutto il tormento di questa supposizione senza morire ? Deve essere tolta al creatore la sua fede e all’ aquila il suo librarsi in lontananze d’ aquila ? Dio é un pensiero che rende storte tutte le cose dritte e fa girare tutto quanto é fermo . Come ? Il tempo sarebbe abolito , e tutto ciò che é perituro sarebbe solo una menzogna ? Pensare queste cose é vortice e vertigine per gambe umane , e vomito per lo stomaco : davvero , abbandonarsi a simili ipotesi io lo chiamo avere il male del capogiro . Io lo chiamo cattivo e ostile all’ uomo tutto questo insegnare l’ Uno e il Pieno e l’ Immoto e il Satollo e l’ Imperituro . Ogni Imperituro non é che un simbolo ! E i poeti mentono troppo . Invece i migliori simboli debbono parlare del tempo e del divenire : una lode essi debbono essere e una giustificazione di tutto quanto é perituro ! Creare , questa é la grande redenzione dalla sofferenza , e il divenire lieve della vita . Ma perchè vi sia colui che crea é necessaria molta sofferenza e molta trasformazione . Sì , molto amaro morire dev’ essere nella vostra vita , o voi che create ! Solo così siete coloro che difendono e giustificano ogni cosa peritura . Per essere il figlio di nuovo generato , colui che crea non può non voler essere anche la partoriente e non volere i dolori della partoriente . Davvero , attraverso cento anime io ho camminato la mia via e attraverso cento culle e dolori del parto . Molte volte ho già preso congedo : io conosco gli ultimi istanti che spezzano il cuore . Ma così vuole la mia volontà creatrice , il mio destino . O , se debbo parlarvi più sinceramente : proprio un tal destino vuole la mia volontà . Tutto quanto é sensibile soffre in me ed é in ceppi : ma il mio volere viene sempre a me come mio liberatore e apportatore di gioia . Volere libera : questa é la vera dottrina della volontà e della libertà , così ve la insegna Zarathustra . Non più volere e non più valutare e non più creare ! Ah , rimanga sempre da me lontana questa grande stanchezza ! Anche nel conoscere io sento solo la mia volontà che gode di generare e di divenire ; e se nella mia conoscenza é innocenza , ciò accade perchè in essa é volontà di generare . Via da Dio e dagli dèi mi ha allettato questa volontà : che cosa mai resterebbe da creare , se gli dèi esistessero ! Ma la mia ardente volontà creatrice mi spinge sempre di nuovo verso l’ uomo ; così il martello viene spinto verso la pietra . Ah , uomini , nella pietra é addormentata un’ immagine , l’ immagine delle mie immagini ! Ah , che essa debba dormire nella pietra più dura e più informe ! E ora il mio martello infuria crudelmente contro la sua prigione . Dalla pietra un polverio di frammenti : che mi importa ? Io voglio compiere la mia opera : un’ ombra venne infatti a me , la più silenziosa e lieve di tutte le cose é venuta una volta da me ! La bellezza del superuomo venne a me come un’ ombra . Ah , fratelli ! Che mai possono importarmi ancora gli dèi ! . Un ateismo radicale , che nasce dalla teoria secondo la quale Dio sarebbe morto : con il decadimento di tutti i valori , religiosi e non , é decaduto anche Dio stesso :Dio é morto ; a causa della sua compassione per gli uomini é defunto Iddio . […] E’ già da molto tempo che gli antichi dèi finirono : e , invero , ebbero una buona e lieta fine da dèi ! Essi non trovarono la morte nel crepuscolo , questa é la menzogna che si dice ! Piuttosto : essi risero una volta da morire , fino a uccidere se stessi ! Questo accadde , quando la più empia delle frasi fu pronunciata da un dio stesso , questa : Vi é un solo dio ! Non avrai altro dio accanto a me ! Un vecchio dio barbuto e burbero , un dio geloso trascese a questo modo : e allora tutti gli dèi risero e barcollarono sui loro seggi e gridarono : Ma non é proprio questa la divinità , che vi siano dèi ma non un dio ? Chi ha orecchi intenda . Questo é un punto di partenza per il superuomo , il cui agire pare davvero illimitato ( neanche Dio può limitarlo , visto che é morto ) : Morti sono tutti gli dèi : ora vogliamo che il superuomo viva . D’ altronde l’ uomo ha sempre vissuto nel timore di Dio e di un altro mondo , arrivando così a svalutare quello in cui trascorre la sua vita : ecco allora che é arrivato a vivere tristemente , nel timore di peccare e di commettere torto a Dio : ma da quando vi sono uomini , l’ uomo ha gioito troppo poco : solo questo , fratelli , é il nostro peccato originale ! . Zarathustra , il senzadio , capisce che gli uomini comuni non fanno per lui , il loro carattere non si confa alle istanze della dottrina di cui si fa portavoce ; soprattutto gli uomini che parlano ancora di bene e male ( come se esistessero ! ) , quelli che sono per il ” volgo ” i buoni , che insegnano l’ uguaglianza : per Zarathustra essi sono tarantole : Ecco la tana della tarantola ! Vuoi vederla tu stesso ? Qui pende la sua ragnatela : toccala , che frema . Eccola venire docilmente : benvenuta , tarantola ! Nero sta sul tuo dorso il tuo triangolo e distintivo ; e io so anche che cosa si annida nella tua anima . Vendetta si annida nella tua anima : dove tu mordi , si forma una nera schianza ; con la vendetta il tuo veleno fa venire le vertigini all’ anima ! Così io parlo per similitudine a voi , che fate venire le vertigini alle anime , voi predicatori dell’ uguaglianza ! Tarantole siete voi per me , e in segreto smaniose di vendetta ! … così parla a me la giustizia : – gli uomini non sono uguali – E neppure devono diventarlo ! Che sarebbe il mio amore per il superuomo se io parlassi diversamente ? Per mille ponti e sentieri devono sospingersi verso il futuro , e tra loro deve essere posta sempre più guerra e diseguaglianza : così mi fa parlare il mio grande amore ! …Invero Zarathustra non é vento che ruoti vorticoso ; e se anche é un danzatore , non sarà mai un danzatore per morso di tarantola ! ; questi uomini sono tarantole che , come se in combutta con lo spirito di gravità , vogliono impedire al superuomo di emergere , di elevarsi al di sopra di tutto e di tutti , vogliono impedirgli di volare , ostinandosi a parlare di bene e di male , di uguaglianza e di solidarietà : Anche io ho imparato a fondo l’ arte di attendere , ma soltanto di attendere me stesso . E sopra ogni altra cosa ho imparato a stare e andare e camminare e saltare e arrampicarmi e danzare . Ma questa é la mia dottrina : chi vuole imparare un giorno a volare , deve prima di tutto imparare a stare e andare e camminare e arrampicarsi e danzare : il volo non si impara in volo ! Io ho imparato ad arrampicarmi con scale di corda fino a più di una finestra , a gamba lesta mi sono inerpicato su per alti alberi di nave : star seduto sugli alti alberi della nave della conoscenza , mi parve non piccola beatitudine , palpitare come le fiammelle su alti alberi di nave : una piccola luce , é vero , purtuttavia un grande conforto per naviganti e naufraghi sperduti ! Per vie di molte specie e in molti modi sono giunto alla mia verità ; non fu una sola scala , quella su cui salii per giungere alla vetta , dove il mio occhio dilaga nelle mie remote lontananze . E solo malvolentieri ho sempre chiesto le strade , ciò é sempre stato contrario al mio gusto ! Preferivo interrogare e tentare le strade da solo . Il mio cammino é sempre stato , in tutto e per tutto , un tentativo e un interrogativo ; in verità bisogna anche imparare a rispondere a questo interrogare ! Ma questo é il mio gusto : non un buon gusto , nè cattivo , bensì il mio gusto , di cui non mi vergogno più e che più non celo . << Questa insomma é la mia strada , dov' é la vostra ? >> , così rispondo a quelli che da me vogliono sapere la strada . Questa strada , infatti , non esiste ! ; ma quella di Zarathustra non é una semplice presa di posizione contro il volgo , che gli si é dimostrato nemico : lui ha provato a propugnare presso il popolo le sue teorie dell’ oltreuomo e della morte di Dio , ma esso non le ha accettate : Chi presso gli uomini tutto volesse comprendere , dovrebbe toccare tutto . Ma le mie mani sono troppo pulite per farlo . Già non sopporto di respirare il loro respiro ; ahimè , aver dovuto vivere così a lungo in mezzo al loro strepito e al loro alito cattivo ! Oh silenzio beato intorno a me ! Oh puri aromi ! Oh come questo silenzio attinge il suo puro respiro dalle profonde cavità del petto ! Oh , come sta in ascolto , questo silenzio beato ! Ma laggiù in basso , là tutti parlano e nessuno presta attenzione . Anche a divulgare la saggezza propria con squillo di campane : ai mercanti sul mercato basterà far tintinnare pochi soldi , per sovrastarne il suono ! Tutti parlano presso di loro , nessuno é più capace di intendere . Tutto va a finire nell’ acqua , nulla più in profonde sorgenti . Tutti parlano presso di loro , ma nulla riesce più e giunge alla fine . Tutti starnazzano , ma chi ha voglia di rimanere in silenzio sul suo nido a covar l’ uova ? Tutti presso di loro parlano , e tutto viene logorato a forza di parole . E ciò che ieri era troppo duro perfino per il tempo e per la sua zanna : oggi penzola rosicchiato a brandelli dal muso degli uomini d’ oggi . Tutti presso di loro parlano , e tutto viene messo in piazza . E ciò che un tempo si chiamò segreto e intimità di anime profonde , oggi viene strombazzato per le strade da ogni genere di schiamazzatori . O natura dell’ uomo , bizzarra natura ! Strepito per vicoli bui ! Or sei di nuovo dietro di me : il più grande dei miei pericoli é dietro di me ! Il più grande dei miei pericoli fu sempre quello di risparmiare gli altri e di averne compassione ; e ogni natura umana vuol essere risparmiata e sopportata . Con verità rattenute , con una mano folle e un cuore infatuato e ricco di piccole bugie compassionevoli : così ho sempre vissuto tra gli uomini . Ho seduto tra loro travestito , disposto a misconoscere me stesso , per poter sopportare loro , e ripetendo sempre a me stesso : folle , tu non conosci gli uomini ! Si disimpara a conoscere gli uomini , se si vive tra gli uomini : troppo in tutti gli uomini é solo facciata , a che servono tra loro occhi che mirano e che cercano nella lontananza ! E quando disconoscevano me : io , pazzo , proprio per questo avevo più riguardi per loro che per me : avvezzo alla durezza verso me stesso , e spesso vendicando su me stesso la mia clemenza . Punzecchiato da mosche velenose e scavato , come una pietra , da molte gocce di perfidia , così sedevo in mezzo a loro e per di più cercavo di convincermi : i piccoli non hanno colpa della loro piccolezza ! Specialmente quelli che si dicono buoni trovai che erano le più velenose delle mosche : essi punzecchiano in piena innocenza , essi mentono in perfetta innocenza : e come potrebbero essere giusti verso di me ! Chi vive in mezzo ai buoni , la compassione gli insegna a mentire . La compassione rende l’ aria intanfita in tutte le anime libere . La scempiaggine dei buoni , infatti , é senza fondo . Nascondere me stesso e la mia ricchezza , questo ho imparato laggiù in basso : perchè non ne trovai uno che non fosse povero di spirito . Questa fu la menzogna della mia compassione : tutti li conoscevo , per ognuno la mia vista e il mio olfatto mi dicevano che cosa per lui fosse spirito a sufficienza e che cosa troppo spirito ! I loro saggi legnosi io li chiamavo saggi e non di legno , così imparai a ingozzare le parole . Zarathustra ha provato con entusiasmo a far passare le sue teorie , ma ha capito che l’ uomo é difficile da scoprire , ed egli é per se stesso la più difficile delle scoperte . D’ altronde l’ idea di un uomo superiore agli altri , come detto , non può che trovare opposizione presso il popolo : non é facile il superuomo , il capire che come uomini non si é un fine ma solo un mezzo per il superuomo , un ponte : Vi sono vie e maniere di molte specie che portano al superamento : ma qui , vedi tu ! Solo un pagliaccio può pensare : << l' uomo può anche essere saltato d' un balzo >> . Supera te stesso anche nel tuo prossimo : e un diritto che puoi togliere in prede , non devi lasciartelo dare ! Ciò che tu fai , nessuno può rifartelo a sua volta . Vedi , non esiste remunerazione . Chi non é capace di comandare a se stesso , ha da obbedire . E vi sono certi che sanno comandare a se stessi , ma molto ci manca a che sappiano anche obbedire a se stessi ! . Zarathustra decide così di tenersi distante dal popolo e di allontanarsi dalla città a lui cara , ” Vacca Pezzata ” , per far ritorno sulla montagna alla sua caverna : tuttavia il suo permanere presso gli uomini non é stato vano ; certo , ha capito che essi preferiscono forzare dalla parte delle bestie piuttosto che verso quella del superuomo , si é accorto che un superuomo non c’ é ancora stato ( Ancora non é esistito un superuomo . Io li ho visti tutti e due nudi , l’ uomo più grande e il più meschino . Sono ancora troppo simili l’ uno all’ altro . In verità anche il più grande io l’ ho trovato troppo umano ! ) , ma tuttavia é arrivato a scoprire che in ogni uomo é insita la volontà di potenza , ogni azione é motivata dal cercare di aumentare il proprio potere : Ogni volta che ho trovato un essere vivente , ho anche trovato volontà di potenza ; e anche nella volontà di colui che serve ho trovato la volontà di essere padrone . Il debole é indotto dalla sua volontà a servire il forte , volendo egli dominare su ciò che é ancora più debole : a questo piacere , però , non sa rinunciare . E come il piccolo si dà al grande , per avere diletto e potenza sull’ ancora più piccolo : così anche ciò che é più grande dà se stesso e , per amore della potenza , mette a repentaglio la sua vita . Ma Zarathustra é il grande distruttore della morale classica, imposta dal razionalismo socratico: la più grande liberazione deve però riguardare l’idea cristiana della morte, idea strutturata secondo il modello cristiano – borghese di dominio. La paura della morte è la paura della sanzione finale dell’insensatezza dell’esistenza: Molti muoiono troppo tardi, e alcuni muoiono troppo presto. Suona ancora strano l’insegnamento: “muori al momento giusto!”. Muori al momento giusto: questo insegna Zarathustra. In verità, chi non vive al momento giusto, come potrebbe morire al momento giusto? Bisognerebbe che non fosse mai nato! Questo consiglio ai superflui. Zarathustra dunque ritorna sulla sua montagna arricchito di nuove esperienze , ha una conoscenza più profonda dell’ uomo di quanto non avesse prima . Ecco che Zarathustra matura la teoria dell’ eterno ritorno : Coraggio è la mazza più micidiale: il coraggio ammazza anche la compassione. Ma la compassione è l’abisso più fondo: quanto l’uomo affonda la sua vista nella vita, altrettanto l’affonda nel dolore. Coraggio è però la mazza più micidiale, coraggio che assalti: esso ammazza anche la morte, perché dice: “Questo fu la vita? Orsù! Da capo!”. Ma in queste parole sono molte squillanti fanfare. Chi ha orecchi, intenda. “Alt, nano! dissi. O io! O tu! Ma di noi due il più forte son io: tu non conosci il mio pensiero abissale! Questo – tu non potresti sopportarlo!”. Qui avvenne qualcosa che mi rese più leggero: il nano infatti mi saltò giù dalle spalle, incuriosito! Si accoccolò davanti a me, su di un sasso. Ma, proprio dove ci eravamo fermati, era una porta carraia. “Guarda questa porta carraia! Nano! continuai: essa ha due volti. Due sentieri convengono qui: nessuno li ha mai percorsi fino alla fine. Questa lunga via fino alla porta e all’indietro: dura un’eternità. E quella lunga via fuori della porta e in avanti – è un’altra eternità. Si contraddicono a vicenda, questi sentieri; sbattono la testa l’un contro l’altro: e qui, a questa porta carraia, essi convengono. In alto sta scritto il nome della porta: “attimo”. Ma, chi ne percorresse uno dei due sempre più avanti e sempre più lontano: credi tu, nano, che questi sentieri si contraddicano in eterno?”. “Tutte le cose diritte mentono, borbottò sprezzante il nano. Ogni verità è ricurva, il tempo stesso è un circolo”. “Tu, spirito di gravità! dissi io incollerito, non prendere la cosa troppo alla leggera! O ti lascio accovacciato dove ti trovi, sciancato – e sono io che ti ho portato in alto! Guarda, continuai, questo attimo! Da questa porta carraia che si chiama attimo, comincia all’indietro una via lunga, eterna: dietro di noi è un’eternità. Ognuna delle cose che possono camminare, non dovrà forse avere già percorso una volta questa via? Non dovrà ognuna delle cose che possono accadere, già essere accaduta, fatta, trascorsa una volta? E se tutto è già esistito: che pensi, o nano, di questo attimo? Non deve anche questa porta carraia esserci già stata? E tutte le cose non sono forse annodate saldamente l’una all’altra in modo tale che questo attimo trae dietro di sé tutte le cose avvenire? Dunque – anche se stesso? Infatti, ognuna delle cose che possono camminare: anche in questa lunga via al di fuori – deve camminare ancora una volta! E questo ragno che indugia strisciando al chiaro di luna e persino questo chiaro di luna e io e tu bisbiglianti a questa porta, di cose eterne bisbiglianti – non dobbiamo tutti esserci stati un’altra volta? e ritornare a camminare in quell’altra via al di fuori, davanti a noi, in questa lunga orrida via – non dobbiamo ritornare in eterno?”. ; ma il superuomo non può che apprezzare l’eternità, l’eterno ritorno, perché è un rinnovarsi continuo della sua volontà di potenza e del suo dominio sul mondo: un dominio che dovrà ritornare all’infinito, per l’eternità: ed è questo l’ “amor fati” che proclama Zarathustra, l’amore per l’eterno ritorno delle cose; egli continua a ripetere “ti amo eternità! una volta abbandonata definitivamente la città e il mercato , Zarathustra dialoga a riguardo della dottrina dell’ eterno ritorno con i suoi stessi animali , che , a differenza del volgo , lo ascoltano entusiasti , quasi come a dire che essi sono superiori perchè in fondo l’ uomo é il più crudele degli animali : ecco che io muoio e scompaio , diresti , e in un attimo sono un nulla . Le anime sono mortali come i corpi . Ma il nodo di cause , nel quale io sono intrecciato , torna di nuovo , esso mi creerà di nuovo ! Io stesso appartengo alle cause dell’ eterno ritorno . Io torno di nuovo , con questo sole , con questa terra , con quest’ aquila , con questo serpente , non a nuova vita o a vita migliore o a una vita simile : io torno eternamente a questa stessa identica vita . Zarathustra narra di una passeggiata su un impervio sentiero di montagna , in cui lo segue lo spirito di gravità , metà talpa , metà nano , metà storpio , il suo demonio e nemico capitale , il quale gli canta una sorta di ritornello che contiene una versione da nani dell’ eterno ritorno : O Zarathustra , sussurrava beffardamente sillabando le parole , tu , pietra filosofale ! Hai scagliato te stesso in alto , ma qualsiasi pietra scagliata deve cadere ! [ A un certo punto si trovano di fronte ad una porta carraia ] . << Guarda questa porta carraia ! Nano ! continuai : essa ha due volti . Due sentieri convengono qui : nessuno li ha mai percorsi fino alla fine . Questa lunga via fino alla porta e all' indietro : dura un' eternità . E quella lunga via fuori dalla porta e in avanti é un' altra eternità . Si contraddicono a vicenda , questi due sentieri ; sbattono la testa l' uno contro l' altro : e qui , a questa porta carraia , convengono . In alto sta scritto il nome della porta : attimo . Ma , chi ne percorresse uno dei due sempre più avanti e sempre più lontano : credi tu , nano , che questi sentieri si contraddicano in eterno ? >> . << Tutte le cose diritte mentono , borbottò sprezzante il nano . Ogni verità é ricurva , il tempo stesso é un circolo >> . Tu , spirito di gravità ! , dissi io incollerito , non prendere la cosa troppo alla leggera ! . Sulla sua montagna Zarathustra ritrova la pace: ma essa viene improvvisamente sconvolta da un grido d’aiuto lanciato dalla foresta: é l’umanità che ha bisogno di Zarathustra e dei seuoi insegnamenti. Ecco allora che il vecchio senzadio non esita a scendere dal monte e si lancia alla ricerca di chi ha emesso l’urlo per potergli prestare soccorso: si imbatte in un indovino già incontrato anni addietro e poi in una coppia di re: anch’essi, come Zarathustra, sono alla disperata ricerca di un uomo superiore, nauseati dalla volgare società comune. Con Zarathustra condividono l’ideale che l’uomo più elevato sulla terra deve anche essere il signore di tutti. Non vi é nel destino dell’uomo sventura più dura di quando i potenti della terra non sono anche i primi uomini. Proseguendo la sua ricerca, Zarathustra si imbatte in un ferito che, dopo l’incertezza iniziale, si rivela onorato di essere al cospetto del celebre senzadio: dopo averlo aiutato e rincuorato, Zarathustra, tipico eroe romantico che non trova pace, non demorde nella sua ricerca e incontra un mago che gli si rivolge con una sfilza di ritornelli magici e di filastrocche: anch’egli comunque nutre grande rispetto nei confronti del celebre vegliardo ed é pronto a seguire i suoi preziosi insegnamenti. Ma probabilmente il punto culminante nei vari incontri di Zarathustra é quello con il vecchio papa: il vecchio senzadio gli domanda se é vero, come si dice, che Dio é morto: il vecchio papa annuisce. Dio é morto per colpa degli uomini? No di certo: che colpe può avere l’uomo verso Dio? E’ Dio stesso che l’ha creato e deve risponderne! Se la colpa era dei nostri orecchi, perchè ci dette degli orecchi che lo udivano male? domanda Zarathustra con insistenza. Fu il buon gusto alla fine che portò l’uomo a dire: Basta con un Dio così!Meglio nessun Dio, meglio costruirsi il destino con le proprie mani, meglio essere un folle, meglio essere noi stessi Dio!. Dopo essersi in seguito imbattuto nell’uomo più brutto del mondo, nel mendicante volontario, e perfino nella sua stessa ombra, Zarathustra rincasa: alla fine egli invita nella sua caverna tutti i personaggi che ha incontrato ed essi accettano l’invito con gioia. A questo punto ciascuno di loro apprende finalmente che cosa significhi vivere, senza il timore di Dio o di forze soprannaturali e quello che sembra apprezzare maggiormente é l’uomo più brutto: Io sono per la prima volta felice di aver vissuto tutta quanta la mia vita. E l’attestare questo non mi basta ancora. Vale la pena di vivere sulla terra. Occorre imparare ad apprezzare il nostro mondo, senza speranze in una vita ultraterrena!
LA GAIA SCIENZA
Nessun vincitore crede al caso.
E’ qualcosa di nuovo, di piacevolmente nuovo rispetto alle opere precedenti. Nietzsche ha recuperato la salute ed esprime nel suo scritto una visione matura del mondo umano, un distacco composto. Il tema dominante dell’opera: “la sfera della conoscenza deve essere unita a quella della gioia”. Egli polemizza contro i filosofi che, da Platone in poi, hanno congiunto la conoscenza con la repressione degli istinti naturali, con l’astrazione dal mondo sensibile o addirittura con la condanna dell’esistenza. Vi é una radicale critica in generale del pensiero scientifico, cui viene rimproverato il tentativo di spiegare tutto col nesso di causa ed effetto. Questo tipo di spiegazione ci consente di descrivere meglio il divenire nella successione delle sue immagini, ma non ce lo fa comprendere nei suoi aspetti qualitativi e per di più frammenta il flusso dell’accadere in elementi isolati; ed ecco che possiamo spiegare il singolare titolo dell’opera: la scienza moderna, a parere di Nietzsche, come accennavamo é soltanto la forma più recente e nobile dell’ideale ascetico, essa ha ancora fiducia nelle verità come valore in sè, superiore ad ogni altro e, quindi, non é in grado di contrastare questo ideale. E’ tuttavia possibile quella che Nietzsche definisce gaia scienza , che si rivolge ai senzapatria, figli dell’avvenire e a disagio nel proprio tempo, amanti del pericolo e dell’avventura, avversi a ogni ideale, i quali non hanno intenzione di regredire ad alcun passato nè lavorare per il progresso, ossia per l’affermarsi dell’uguaglianza e della concordia tra gli uomini. Per raggiungere questo stato di gaiezza bisogna abbandonare la morale corrente, porsi liberi al di là del bene e del male e quindi staccarsi da parecchie cose, ma per far questo occorre acquisire una condizione di leggerezza: e Nietzsche paragona questo stato a quello della “danza”. La prima domanda che é bene porsi per costruire una gaia scienza é se i cosiddetti valori morali siano segno di impoverimento o di pienezza della vita. Ma é radicale anche la critica mossa alla religione: Avete sentito di quell’uomo folle che accese una lanterna alla chiara luce del mattino, corse al mercato e si mise a gridare incessantemente: “Cerco Dio! Cerco Dio!”? – E poiché proprio là si trovano raccolti molti di quelli che non credevano in Dio, suscitò grandi risa. “Si è forse perduto?” disse uno. “Si è smarrito come un bambino”? fece un altro. “Oppure sta ben nascosto? Ha paura di noi? Si è imbarcato? E’ emigrato?” gridavano e ridevano in una gran confusione. L’uomo folle balzò in mezzo a loro e li trapassò con i suoi sguardi: “Dove se n’è andato Dio?” gridò “ve lo voglio dire! L’abbiamo ucciso – voi e io! Siamo noi tutti i suoi assassini! Ma come abbiamo fatto? […] Dio è morto! Dio resta morto! E noi lo abbiamo ucciso. Si vede che anche la scienza riposa su una fede, che non esiste affatto una scienza “scevra di presupposti”. La domanda se sia necessaria la verità, non soltanto deve avere avuto già in precedenza risposta affermativa, ma deve averla avuta in grado tale da mettere quivi in evidenza il principio, la fede, la convinzione che “niente è più necessario della verità e che in rapporto a essa tutto il resto ha soltanto un valore di secondo piano”. Questa incondizionata volontà di verità, che cos’è dunque? […] Ebbene, si sarà compreso dove voglio arrivare, vale a dire che è pur sempre una fede metafisica quella su cui riposa la nostra fede nella scienza; che anche noi, uomini della conoscenza di oggi, noi atei e antimetafisici, continuiamo a prendere anche il nostro fuoco dall’incendio che una fede millenaria ha acceso, quella fede cristiana che era anche la fede di Platone, per cui Dio è la verità e la verità è divina… Ma come è possibile, se proprio questo diventa sempre più incredibile, se niente più si rivela divino salvo l’errore, la cecità, la menzogna, se Dio stesso si rivela come la nostra più lunga menzogna? Ed ecco che nell’agosto del 1881, in Engadina, “6000 piedi al di là dell’uomo e del tempo”, Nietzsche ebbe la folgorazione dell’eterno ritorno, il vero mistero filosofico della sua vita. Ed é di questo periodo l’elaborazione del testo che stiamo prendendo in esame, la “Gaia scienza”, libro che “rivela da cento segni la prossimità di qualcosa di incomparabile”. Qui lo stile di Nietzsche sembra raggiungere la sua perfezione: all’implacabile spirito indagatore, a cui già si dovevano “Umano, troppo umano” e “Aurora”, si associa ora quello spirito della danza che attendeva di presentarsi nella figura di Zarathustra, il quale diceva in continuazione “potrei credere solo in un Dio che sapesse danzare”. Così la scienza diventa gaia, e già nel titolo si offre il richiamo a “quella unità di cantore, cavaliere e spirito libero che differenzia quella meravigliosa e precoce civiltà dei Provenzali da tutte le civiltà equivoche”. E insieme ora si afferma definitivamente in Nietzsche quella “riabilitazione dell’apparenza” che segnerà l’ultima fase del suo pensiero. Tutte le tensioni laceranti che sfoceranno nella follia sono già presenti in queste pagine, ma ancora sovranamente dominate: e con quanta saggezza e con che spirito profetico egli prevedeva l’affermarsi del nichilismo, la perdita definitiva di tutti i valori tradizionali, primo fra tutti il Cristianesimo, cancro dell’universo! Sicchè per un lettore che voglia avvicinarsi all’opera di Nietzsche, il folgorante profeta del superuomo, forse questo é libro é il più consigliabile: muovendosi fra le sue pagine ripercorrerà quel labirinto che Nietzsche é stato. Il libro si avvia con la constatazione da parte del filosofo che tutti gli uomini in ultima istanza fanno quel che giova alla conservazione della specie umana, agendo mossi non tanto da un sentimento sublime, quanto piuttosto da un puro e semplice istinto. Molti hanno cercato e molti in futuro cercheranno di trovare un senso razionale alla vita, chiedendosi il perchè e provando a trovare una spiegazione. Ma la cosa più importante é imparare ad apprezzare la vita, senza mai perdere il senso della terra, annebbiati da eventuali vite ultraterrene! Ed ecco che Nietzsche constata amaramente che ai più manca la coscienza intellettuale, e che esigendola si finisce per essere in città popolose come deserti! E qui Nietzsche ne approfitta per riprendere la distinzione a lui cara tra nobile e volgare, asserendo comunque che fino ad oggi a permettere la conservazione della razza umana sono sempre state le persone più vigorose ecattive: e qui la mente del lettore può soffermarsi sulla figura del Duca Valentino, verso il quale in più occasioni Nietzsche dimostra simpatia. E l’errore della specie umana consiste proprio nell’aver voluto trovare un perchè ad ogni cosa, nel tentativo di razionalizzare tutto, facendo morire il senso del tragico presente fino ad Eschilo e a Sofocle, massimi esponenti della tragedia greca. E’ a partire da Euripide che si é avviato questo esasperato processo di razionalizzazione che ha portato in trionfo il dio Apollo, il solare dio della razionalità, a discapito di Dionisio, il notturno Dio dei festini e della tragedia. Ma in fin dei conti che spiegazione razionale vi potrà mai essere nel vivere? Che cosa significa vivere? Nietzsche prova a dare una sua spiegazione: Che significa vivere? Vivere-ecco quel che significa: respingere da sè senza tregua qualcosa che vuole morire; vivere- vuol dire essere crudeli e spietati contro tutto ciò che sta diventando debole e vecchio in noi. Vivere-vuol dire: essere senza pietà per i moribondi, i miserabili e i vecchi? Essere sempre di nuovo assassini? Eppure il vecchio Mosè ha detto: “Non uccidere!” Ma la grande e aspra polemica che Nietzsche muove nell’opera é indirizzata alla scienza, che facilmente conduce all’adorazione della verità oggettiva, rende l’uomo schiavo dell’oggettività esterna, e contrapposta alla vita. Ma in realtà non ci sono dati, fatti oggettivi (antipositivisticamente), ma solo interpretazioni:”Si vede che anche la scienza riposa su una fede, che non esiste affatto una scienza “scevra di presupposti”. La domanda se sia necessaria la verità, non soltanto deve avere avuto già in precedenza risposta affermativa, ma deve averla avuta in grado tale da mettere quivi in evidenza il principio, la fede, la convinzione che “niente è più necessario della verità e che in rapporto a essa tutto il resto ha soltanto un valore di secondo piano”. Questa incondizionata volontà di verità, che cos’è dunque? […] Ebbene, si sarà compreso dove voglio arrivare, vale a dire che è pur sempre una fede metafisica quella su cui riposa la nostra fede nella scienza; che anche noi, uomini della conoscenza di oggi, noi atei e antimetafisici, continuiamo a prendere anche il nostro fuoco dall’incendio che una fede millenaria ha acceso, quella fede cristiana che era anche la fede di Platone, per cui Dio è verità e la verità è divina… Ma come è possibile, se proprio questo diventa sempre plu incredibile, se niente più si rivela divino salvo I’errore, la cecità, la menzogna, se Dio stesso si rivela come la nostra più lunga menzogna?”(La gaia scienza, 344). E Nietzsche, ancora, denuncia lo schematismo degli scientisti, che non si accorgono della polimorfia del reale, pretendendo di ricondurlo a pochi princìpi meccanici. “Il vostro amore per la realtà, oh, é un antico, antichissimo “amore”!In ogni percezione, in ogni impressione sensibile c’é un frammento di questo vecchio amore […] Ecco laggiù una montagna! Ecco una nuvola! Ma che cosa é poi reale? Tirate via da tutto questo, voi sobri, il fantasma e l’insieme degli ingredienti umani! […] Per noi non ci sono realtà- e nemmeno per voi sobri-e non siamo affatto così lontani gli uni dagli altri come pensate e forse la nostra buona volontà di tirarci fuori dall’ebbrezza é altrettanto rispettabile quanto la vostra convinzione d’essere del tutto incapaci d’ebbrezza”: qui prorompe tutto il nichilismo nietzscheiano, con un vigore straordinario: che senso ha parlare di realtà? Questa é la domanda che sta sullo sfondo di tutta la sua filosofia. Ma destinataria delle sue critiche non é solo la scienza, che Nietzsche definisce beffardamente gaia, ma la fede in Dio, più precisamente nel Dio cristiano, a suo avviso morto ucciso dagli uomini. Nietzsche é indubbiamente il più radicale ateo della storia della filosofia. Per lui infatti Dio in quanto tale si oppone all’uomo: deve morire, affinchè l’uomo viva: non c’é spazio per tutti e due! Nietzsche d’altronde si schiera contro gli atei volgari(i ridanciani) che non si rendono conto della posta in gioco, e credono che sia facile “sbarazzarsi” di Dio. Mentre si tratta di un’opera titanica, da far tremare le vene ai polsi: “Come abbiamo fatto questo? Come potemmo vuotare il mare, bevendolo fino all’ultima goccia? Chi ci dette la spugna per cancellare l’intero orizzonte? Che mai facemmo, a sciogliere questa terra dalla catena del suo sole? Dov’è che si muove ora? Dov’è che ci muoviamo noi? Via da tutti i soli? Non è il nostro un eterno precipitare? Con che acqua potremo lavarci? Quali riti espiatori, quali giochi sacri dovremo noi inventare? Non è troppo grande per noi la grandezza di questa azione?”(La Gaia scienza, n.125). La vera grande battaglia che Nietzsche porta avanti é contro Dio: credere in un Dio che punisce e in un mondo ultraterreno non fa altro che rimpicciolire l’uomo e fargli perdere il senso della terra! “Dopo che Buddha fu morto, si continuò per secoli ad additare la sua ombra in una caverna-un’immensa orribile ombra. Dio é morto: ma stando alla natura degli uomini, ci saranno forse ancora per millenni caverne nelle quali si additerà la sua ombra. E noi, noi dobbiamo vincere anche la sua ombra!”. Bisogna in primo luogo evitare di attribuire vita all’universo, come avevano fatto Platone e Giordano Bruno, ad esempio: esso non si nutre, non vegeta, non ha leggi, non ha neppure istinto di autoconservazione, che é caratteristica degli esseri viventi! Solo senza pregiudizi, solo senza timore verso un Dio che non c’é, l’uomo può trovare la sua serenità: “Il più grande avvenimento recente, che Dio é morto, che la fede nel Dio cristiano é divenuta inaccettabile, comincia già a gettare le sue prima ombre sull’Europa. A quei pochi almeno, i cui occhi, la cui diffidenza negli occhi é abbastanza forte e sottile per questo spettacolo, pare appunto che un qualche sole sia tramontato, che una qualche antica, profonda fiducia si sia capovolta in dubbio […] Perfino noi, per nascita divinatori d’enigmi, noi che siamo in attesa per così dire sulle montagne, piantati fra l’oggi e il domani, noi primogeniti e figli prematuri del secolo venturo, noi che già dovremmo scorgere le ombre che ben presto avvolgeranno l’Europa: com’é che perfino noi le guardiamo salire senza una vera partecipazione a questo ottenebramento, soprattutto senza preoccuparci e temere per noi stessi? […] In realtà, noi filosofi e spiriti liberi, alla notizia che il vecchio Dio é morto, ci sentiamo come illuminati dai raggi di una nuova aurora; il nostro cuore ne straripa di riconoscenza, di meraviglia, di presagio, d’attesa- finalmente l’orizzonte torna ad apparirci libero, anche ammettendo che non é sereno, finalmente possiamo di nuovo sciogliere le vele alle nostre navi, muovere incontro a ogni pericolo; ogni rischio dell’uomo della conoscenza é di nuovo permesso; il mare, il nostro mare, ci sta ancora aperto dinanzi, forse non vi é ancora mai stato un mare così aperto.” Ma che cosa é che ha portato l’uomo in passato all’errore di credere in un’entità superiore, in cui credere e di cui aver paura? Secondo Nietzsche a portare l’uomo alla fede é stata la mancanza di volontà, l’incapacità di comandare, il preferire essere comandati al comandare, dando così vita ad una vera e propria morale degli schiavi : “La fede é sempre tanto più ardentemente desiderata, tanto più urgentemente necessaria, laddove manca la volontà: la volontà infatti, come passione del comando, é il più decisivo segno di riconoscimento del dominio esercitato su se stessi e della forza.” Interessante risulta poi nel testo una sorta di “auto-intervista” di Nietzsche:
Ma che cosa sono alla fin fine le verità dell’uomo? Sono gli errori inconfutabili dell’uomo. Chi ha grandezza é crudele verso le sue virtù e le sue riflessioni di second’ordine. Con una grande meta si é superiori perfino alla giustizia, non solo alle proprie azioni e ai propri giudici.
Che cosa rende eroici? Muovere incontro al proprio supremo dolore e insieme alla propria suprema speranza.
In che cosa credi? In questo: che i pesi di tutte le cose devono essere nuovamente determinati.
Che cosa dice la tua coscienza? Devi diventare quello che sei.
Dove stanno i tuoi più grandi pericoli? Nella compassione.
Che cosa ami negli altri? Le mie speranze.
Chi chiami cattivo? Chi mita solamente a incutere vergogna.
Che cosa é per te la cosa più umana? Risparmiare vergogna a qualcuno.
Che cosa é il sigillo della raggiunta libertà? Non provare più vergogna davanti a se stessi.
* CURIOSITA’: a Torino, in centro, vi é un ristorante che si chiama “La gaia scienza”: pare che Nietzsche fosse solito pranzare lì durante i suoi soggiorni torinesi.
AL DI LA’ DEL BENE E DEL MALE
Scritto a Sils-Maria, a Nizza, nel 1885-86, l’Al di là fu stampato dal Naumann di Lipsia nel 1886. I 296 aforismi che lo compongono si aggruppano vastamente in 9 capitoli: I pregiudizi dei filosofi; Lo spirito libero; Lo spirito religioso; Massime e intermezzi; Storia naturale della morale; Noi altri sapienti; Le nostre virtú; Popoli e Patrie; Che cosa è nobile. Sono essi la glorificazione, come ogni opera nietzscheana, come lo Zarathustra specialmente, della vita quale istinto, interesse, volontà, energia. Al di là del Bene e del Male, si afferma la vita che opera per amore, ed è il nucleo per sé stesso della morale. Il libro, europeista e spirito-liberista, si scaglia nel suo prologo contro il platonismo creatore dello spirito e del bene in sé, contro il dommatismo serio e balordo incapace di conquistare la verità che è femmina…; e, di scatto, nel suo primo capitolo Nietzsche afferma che la verità dei metafisici si fonda su una credenza. Non v’è divinità occulta per Nietzsche, ma attività istintiva. Ecco la biologia nascondersi dietro la logica. Nietzsche vuole che un giudizio, vero o falso non conta, valga se accelera e conserva la vita, mantiene e sviluppa la specie. La menzogna è condizione vitale. Kant è un Tartufo, Spinoza è un ciarlatano. I filosofi che vantano piú la sottile freddezza razionalistica sono i crociati di un desiderio. L’acredine umoristica nietzscheana contro gli scienziati fa abbrividire, mentre dei filosofi Nietzsche dice, quasi senz’avvedersene, che ogni istinto brama il dominio; cosí aspira a filosofare… Nulla di impersonale in un filosofo. La filosofia è istinto tirannico che crea il mondo a propria imagine, è la piú intellettuale volontà di potenza: I veri filosofi sono coloro che comandano e legiferano: essi affermano “così deve essere!”, essi determinano in primo luogo il “dove” e l’”a che scopo” degli uomini e così facendo dispongono del lavoro preparatorio di tutti gli operai della filosofia, di tutti i soggiogatori del passato — essi protendono verso l’avvenire la loro mano creatrice e tutto quanto è ed è stato diventa per essi mezzo, strumento, martello. Il loro “conoscere” è creare, il loro creare è una legislazione, la loro volontà di verità è volontà di potenza. — Esistono oggi tali filosofi? Sono già esistiti tali filosofi? Non devono forse esistere tali filosofi? . Al positivismo che si destreggia nel suo baraccone di fiera, agitando gli stracci piú variopinti, Nietzsche contrappone lo scetticismo antirealista di ricercatori minuziosi della conoscenza: importa a Nietzsche l’andarsene. Ecco tutto. Contro i giudizi sintetici a priori kantiani e contro l’atomismo delle anime sferra Nietzsche i suoi attacchi. Egli è un violento del moto: nega alla fisiologia, dominata dall'”essere” di Spinoza, che l’istinto di conservazione sia il fondamentale. La vita è, ripete Egli con sempre maggiore intuizione di autoverità, anzitutto, volontà di potenza. Certo i darwinisti e antifinalisti contemporanei aveano ben da opporsi a simili audacie nietzscheane: la teoria della forza minima e, aggiunge il polemista ardente, della stupidità massima, sono le teorie fisiche in voga. Gli organi di senso non sono fenomeni, in senso idealistico. Nietzsche si dichiara avversario delle certezze immediate: l’io penso, l’io voglio, non hanno diritto di cittadinanza nel regno di questo autosaggiatore ispirato. Il venerabile io è spolverato con sparutezza compunta da Nietzsche e ridotto a galante e sopportabile piú che quisquilia. Nella volontà, in cui si drappeggia un pregiudizio popolare, Egli intuisce una molteplicità di sensazioni da scomporsi: sensazione del punto di partenza della volontà, del punto d’arrivo, del va e vieni, e, anche, sensazione muscolare. Subentra la riflessione: in ogni atto volitivo v’è un pensiero che lo dirige. È, in fine, e piú c’importa, esso atto una tendenza al comando. Un volontario comanda qualcosa a sé stesso. Nietzsche analizza acutamente il sentimento complesso di piacere prodotto dal trionfo sugli ostacoli: è il rallegramento del sovrano per l’eroismo del proprio popolo. Io significa effetto. Numerose anime lo costituiscono. La morale, dunque, è, per Nietzsche, la dottrina dei rapporti di potenza sotto i quali il fenomeno vita si svolge. Nietzsche indaga la ragione di parentela filosofica nella parentela linguistica degl’indiani, dei greci, dei germani. Anche qui un lampo di genio per una scienza futura. La volontà forte nella vita reale vince la volontà debole. Il determinismo è mitologia. Non esiste né causa, né successione, né finalità, né legge, né numero, né libertà, né scopo. Tutto è volontà di potenza. La psicologia, la scienza dei solitari e dei poeti, la scienza delle scienze, è studiata da Nietzsche come morfologia e come dottrina dell’evoluzione nella terribile e nuda volontà di potenza. Ma la tartuferia morale grida allo scandalo. Nel secondo capitolo dell’Al di là, Nietzsche raccomanda ai filosofi “cavalieri dalla triste figura” della verità, di esser prudenti, in nome dell’innocenza e della “neutralità sottile”, e di non istrioneggiare il martirio. Il sacrifizio alla Bruno o alla Spinoza è da commediante. Rifuggirsi in leggera e vibrante solitudine è necessario. D’altronde, l’indignazione induce alla menzogna. L’uomo superiore deve, invece, aprir l’orecchio dell’anima a tutte le lascive facezie dei satiri, a tutte le sfumature volgari dei cinici. Certo è privilegio di pochi simili forza temeraria che moltiplica all’infinito i rischi della vita. Questa lode può sperarsene? Nessuna: il grande e il raro – ha nome di follia. Lo spirito nobile, lungi dal sí e dal no, espressione del gusto peggiore, quello dell’assoluto, anela alle nuances che sono le caratteristiche dei sommi artisti, è incline al dubbio che insorge contro la giovinezza dell’entusiasmo, contro l’astrologia e l’alchimia moralistiche, per inebriarsi del carattere erroneo del mondo. Quale contraddizione essenziale tra il vero e il falso? Si tratta di prospettiva, di gioco di ombre, di valori illusori. Nietzsche aggiunge che non conviene nell’apparenza o nella rappresentazione di un Berkeley o di uno Schopenhauer. La realtà degl’istinti proclamata da Nietzsche è, sappiamo, lo sviluppo e la differenziazione d’una sola forma fondamentale di volontà, la volontà di potenza. Certo la dottrina nietzscheana è di forte agrume per chi argomenta sulla virtú e sulla felicità. Ma Stendhal scrive che per essere buon filosofo bisogna essere secco, chiaro, preciso, che bisogna essere buon banchiere. Non dimentichiamo poi che le cose profonde amano la maschera. I destini e le crisi degli spiriti rari e delicati eleggono vie discrete e secrete dove la stessa sottile confidenza dal passo leggero non può indugiarsi a cogliere fiori. Ecco rivelarsi il senso nietzscheano della solitudine filosofica: nel tormentoso saggio che lo spirito libero fa su sé stesso, scrive pascalianamente l’autore di Zarathustra, le persone piú care sono da allontanarsi, con la pietà, la scienza, la patria. E bisogna anche, scrive nietzscheanamente Nietzsche, non restare legato alle nostre virtú. S’illumina, vedete, nella creazione critica di questo periodo, la visione lirico-umoristica del profeta del fuoco. Il furore di Nietzsche sa anche carezzare qui: passano brividi sempre in quell’eroica anima gentile. Lo spasimo di Nietzsche si acuisce nell’esaltazione della durezza, della violenza, della schiavitú, del pericolo, dell’artificio, di tutto ciò che nell’uomo è belluino e serpentesco. Nel terzo capitolo, Lo spirito religioso, si pone il problema della fede quale è propria dei primi cristiani e di Pascal. In Pascal è suicidio della ragione. La fede cristiana è, originariamente, un sacrificio, nel senso di insulto a sé stesso, mutilazione di sé. La nobile luce di tolleranza di Roma antica esige la nuova espressione di assoluto, di tirannico, senza lieve ombra di scetticismo. La voluttà esuberante di penitenza, negazione del mondo, annientamento del volere, è sintomo di nevrosi religiosa. Nel santo, Nietzsche vede la successione immediata dei contrasti, o di aspetti morali contraddittori. Nietzsche, analizzando la passione per Dio, timida e ardente nella Guyon, aspra e irta in S. Agostino, accenna alla crisi sessuale. La Chiesa ha canonizzato la donna isterica. In fatto di santità, Nietzsche scrive che la sola volontà di potenza ha tratto uomini potentissimi a inchinarsi al santo, considerato come un enimma d’impero su sé stesso e di privazione volontaria. La morale di Nietzsche non comporta simile “mostro di negazione”. Il genio di questo filosofo è tutto per l’impeto affermatore, per l’eternità di quanto è stato ed è, per la grandezza grandiosa dello spettacolo di lotta universale. Se non che in lui l’istinto tragico non esclude il sorriso indulgente e profondo per la necessaria superficialità degli uomini. Il filosofo che abbraccia nella sua coscienza lo sviluppo completo dell’umanità può servirsi, comunque, delle religioni per la sua opera di educazione. Innegabilmente, bouddhismo e cristianesimo hanno insegnato ai minimi a elevarsi all’apparenza d’un ordine superiore e a restare soddisfatti della grama realtà. Ma guai a chi fa fini a sé stesse delle religioni! Queste pur nobili manifestazioni elevano a canone di vita la sofferenza e considerano la vita come una malattia. Cosí trionfa la sparuta miseria degli odierni europei. Entriamo ora più nel dettaglio. Va subito detto che “Al di là del bene e del male” è anzitutto una sfida al cervello del lettore: tutti, anche senza saperlo, si sentono provocati. Il filosofo, che sente di non essersi ancora pienamente realizzato come tale, vuole affermarsi anche sul terreno teoretico, mira a legiferare sui principi dell’esistenza. Nietzsche intrappola il lettore con una domanda: “Che cos’è aristocratico?”. E per contro “Che cos’è volgare?”. Insiste sul tema della maschera. Esaminando l’agire degli aristocratici, si scopre che esso esprime prima di ogni altra cosa il loro istinto del distacco, e lo manifesta con una molteplicità di maschere, che vengono fraintese dai volgari come gli unici, veri volti. I libri, le opere. le filosofie – se dietro c’è un aristocratico – sono soltanto maschere. Lui stesso dichiara che conta solo indicare la propria natura, che non interessa il bisogno di nobiltà: ” Chi è aristocratico non sente il bisogno di esserlo, chi ne sente il bisogno non lo è”. Vagabondando tra le molte morali, più raffinate e più rozze, che hanno dominato fino a oggi o dominano ancora sulla terra, ho rinvenuto certi tratti caratteristici, periodicamente ricorrenti e collegati tra loro: cosicchè mi si sono finalmente rivelati due tipi fondamentali e ne è balzata fuori una radicale differenza. Esiste una morale dei signori e una morale degli schiavi. […] Lo schiavo non vede di buon occhio le virtù dei potenti: è scettico e diffidente, ha la raffinatezza della diffidenza per tutto quanto di “buono” venga tenuto in onore in mezzo a costoro, vorrebbe persuadersi che tra quelli la stessa felicità non è genuina. All’opposto vengono messe in evidenza e inondate di luce le qualità che servono ad alleviare l’esistenza ai sofferenti: sono in questo caso la pietà, la mano compiacente e soccorrevole, il calore del cuore, la pazienza, l’operosità, l’umiltà, la gentilezza ad essere poste in onore. […] La morale degli schiavi è essenzialmente morale utilitaria. I genitori rendono involontariamente il figlio simile a loro – questo lo chiamano “educazione” -, nessuna madre, nel profondo del suo cuore, dubita di aver partorito a se stessa una proprietà, partorendo un figlio, nessun padre si nega il diritto di sottometterlo alle sue idee e ai suoi criteri di valore. Un tempo addirittura al padre pareva giusto disporre a suo piacimento della vita e della morte del figlio appena nato (come tra gli antichi germani). […] Poco per volta mi si è chiarito che cosa è stata fino a oggi ogni grande filosofia: cioè la confessione del suo ideatore, una specie di mémoires involontari e inavvertiti… Di conseguenza non credo che il padre della filosofia sia un “istinto della conoscenza”, ma che qui, come ovunque, un altro istinto si sia servito della conoscenza (e della falsa conoscenza!) come strumento. Ma chi consideri gli istinti fondamentali dell’uomo per chi vedere in che misura essi possano aver avuto un ruolo di geni ispiratori (o demoni, o coboldi), troverà che tutti gli istinti hanno già praticato la filosofia, e che ciascuno di essi vorrebbe fin troppo volentieri presentarsi come lo scopo finale dell’esistenza e signore legittimo di tutti gli altri istinti. Ciascun istinto infatti aspira al dominio: e come tale cerca di fare filosofia. […] Un filosofo: un filosofo è un uomo che costantemente vive, vede, sente, intuisce, spera, sogna cose straordinarie; che viene colpito dai suoi propri pensieri come se venissero dall’esterno, da sopra e da sotto, come dalla sua specie di avvenimenti e di fulmini; che forse è lui stesso un temporale gravido di nuovi fulmini; un uomo fatale, intorno al quale sempre rimbomba e rumoreggia e si spalancano abissi e aleggia un’aria sinistra. Un filosofo: ahimè, un essere che spesso fugge da se stesso, ha paura di se stesso – ma che è troppo curioso per non “tornare a s estesso” ogni volta. […] Ma i veri filosofi sono coloro che comandano e legiferano: essi affermano “così deve essere!”, essi determinano in primo luogo il “dove” e l'”a che scopo” degli uomini e così facendo dispongono del lavoro preparatorio di tutti gli operai della filosofia, di tutti i soggiogatori del passato – essi protendono verso l’avvenire la loro mano creatrice e tutto quanto è ed è stato diventa per essi mezzo, strumento, martello. Il loro “conoscere” è creare, il loro creare è una legislazione, la loro volontà di verità è volontà di potenza. – Esistono oggi tali filosofi? Sono già esistiti tali filosofi? Non devono forse esistere tali filosofi?.”Al di là del bene e del male” è un libro di riflessioni e aforismi che ha come motivo conduttore la ridefinizione dei concetti di “aristocraticità” e “volgarità”. Questo binomio tematico, che in D’Annunzio assumerà toni esaltati di puro edonismo estetico e letterario, comporta in realtà, da parte di Nietzsche, una consapevole provocazione nei confronti del “senso comune”: l’aristocratico non è colui che è “diverso dagli altri” – il “migliore” nel senso letterale ed etimologico della parola -, ma l’individuo, chiunque esso sia, che è disposto ad accettare la consapevolezza della profonda natura “animale” o “naturale” dell’uomo. L'”animale umano” non è dunque un essere inferiore a cui si contrappongono i “superuomini” aristocratici, ma è l’uomo reale, nelle sue naturali determinazioni, le stesse che l’indole “aristocratica” fa proprie con un atto di libero pensiero. Si pongono pertanto due possibilità: subire supinamente questa condizione, adattandosi a una vita alienata, da “animale d’armento”, salvo poi negarla facendo ricorso a costruzioni metafisiche e valori che servono solo a mascherare ipocritamente la propria debolezza (e tali sono per Nietzsche le ideologie politiche di massa e il cristianesimo stesso); oppure prenderne atto con un gesto di volontà, trasformando questa consapevolezza in una forma di superiorità morale nei confronti dell’ipocrisia corrente. Solo questa coraggiosa accettazione della propria vera natura rende libero il filosofo nei confronti della massa. La superiorità dell'”aristocratico” non è comunque nella liberazione edonistica degli istinti (il “piacere” dannunziano), bensì nell’accettazione del dolore, nella capacità di vivere positivamente la sofferenza senza fuggire da essa: “La profonda sofferenza rende nobili; essa divide”. Fortissima e dagli aspri toni é la condanna nietzschiana alla democrazia presente nel testo: “Diciamo subito ancora una volta quel che già abbiamo detto cento volte: giacché oggi non sono ben disposti gli orecchi a intendere certe verità, le nostre verità! Ci è già abbastanza noto quanto suoni offensivo annoverare, senza fronzoli e non metaforicamente, l’uomo in genere tra gli animali; e ci verrà quasi considerata una colpa l’aver costantemente usato, proprio in riferimento agli uomini delle “idee moderne”, le espressioni “armento”, “istinti dell’armento” e simili. Che importa! Non possiamo fare altrimenti: sta proprio in questo, infatti, la nostra nuova conoscenza. Abbiamo riscontrato che l’Europa ha raggiunto l’unanimità in tutti i suoi principali giudizi morali, senza escludere quei paesi in cui domina l’influsso europeo: si sa, evidentemente, in Europa quel che Socrate riteneva di non sapere e ciò che quel vecchio famoso serpente aveva un tempo promesso di insegnare – si “sa” oggi che cos’è bene e male. Deve allora aver suoni aspri e tutt’altro che gradevoli agli orecchi la nostra ogn’ or rinnovata insistenza nel dire che è l’istinto dell’uomo animale d’armento quel che in lui crede di saperne abbastanza a questo proposito, celebra se stesso con la lode e il biasimo e chiama se stesso buono: come tale, questo istinto è arrivato a farsi strada, a predominare e a signoreggiare sugli altri e guadagna sempre più terreno in armonia a quel crescente processo di convergenza e di assimilazione fisiologica di cui esso è un sintomo. La morale è oggi in Europa una morale da armento – dunque, stando a come intendiamo noi le cose – nient’altro che un solo tipo di morale umana, accanto, avanti, e dopo la quale molte altre, soprattutto morali superiori, sono o dovrebbero essere possibili. Contro una tale “possibilità”, contro un tale “dovrebbe”, questa morale però si difende con tutte le sue forze: essa si affanna a dire con ostinazione implacabile “io sono la morale in sé e non v’è altra morale se non questa!” – anzi, sostenuta da una religione che appagava le più sublimi concupiscenze delle bestie da mandria, lusingandole, si è giunti al punto che persino nelle istituzioni politiche e sociali troviamo una espressione sempre maggiormente evidente di questa morale: il movimento democratico costituisce l’eredità di quello cristiano. Leggendo che La morale è oggi in Europa una morale da armento, non dobbiamo ridurre questo enunciato a un puro e semplice gesto di disprezzo nei confronti delle masse, ma inserirlo nella giusta cornice scientifica d tipo illuminista che connota il pensiero di Nietzsche in questa fase del suo percorso filosofico: per Nietzsche la “moralità” non è una qualità spirituale di carattere superiore infusa da un Ente di natura divina, bensì è una proprietà dell’essere vivente simile a tutte le altre, comprese quelle biologiche. Ecco un altro passo tratto da “Al di à del bene e del male” che può chiarire il significato di questo pensiero: “3. Dopo avere, abbastanza a lungo, letto i filosofi tra le righe e riveduto loro le bucce, mi sono detto: occorre ancora considerare la maggior parte del pensiero cosciente tra le attività dell’istinto, e anche laddove si tratta del pensiero filosofico; occorre, a questo punto, trasformare il proprio modo di vedere, come si è fatto per quanto riguarda l’ereditarietà e l'”innatismo”. Come l’atto della nascita non può essere preso in considerazione nel processo e nel progresso dell’ereditarietà, così l'”esser cosciente” non può essere contrapposto, in una qualche maniera decisiva, all’istinto, – il pensiero cosciente di un filosofo è per lo più segretamente diretto dai suoi istinti e costretto in determinati binari. Anche dietro ogni logica e la sua apparente sovranità di movimento stanno apprezzamenti di valore, o per esprimermi più chiaramente, esigenze fisiologiche di una determinata specie di vita.” Nietzsche, come al solito, muove un’accesa polemica nei confronti di Socrate, accusato di falsità e di ipocrisia (so di non sapere, egli diceva per mettere in difficoltà l’avversario), biasimato per aver introdotto il concetto di “uomo virtuoso”, facendo così, insieme ad Euripide, morire il senso del tragico razionalizzando ogni cosa: in questo passo di Al di là del bene e del male, il riferimento è alla teoria dialettica di Socrate, fatta propria da Platone, secondo cui la vera conoscenza – soprattutto la vera conoscenza del bene – non è nel possesso di una comune opinione, nella supina ripetizione di ciò che tutti pensano, ma nella ricerca “filosofica”, o “noetica”, di una verità nascosta dietro l’apparenza del mondo sensibile. Una costante dell’intera opera di Nietzsche, poi, é l’attacco al cristianesimo, che troverà la sua massima espressione nell’Anticristo: in Al di là del bene e del male, vi é una condanna totale e senza mezzi termini dell’esperienza “storica” del Cristianesimo, vale a dire della sua trasformazione in istituzione politica e culturale. Per tutta l’opera Nietzsche teorizza la somiglianza strutturale e ideologica tra il cristianesimo come “sistema di valori” e qualsiasi altra forma di ideologia sociale che abbia come scopo la liberazione dell’uomo dalla sofferenza. La sofferenza, il dolore, per il nostro filosofo non è eliminabile da un’esistenza che voglia essere autenticamente libera. Nella Volontà di potenza, Nietzsche, nemico accanito del Socialismo, del Comunismo e della democrazia, simpatizzante per l’aristocrazia, definirà il Socialismo come una balorda interpretazione dell’ideale cristiano. Resta ora da chiarire il titolo dell’opera, Al di là del bene e del male: esso é riferito al superuomo, tutto assorbito dalla vita terrena, ateo, senza inutili speranze ultraterrene, creatore di valori, rinnegatore dei valori tradizionali: egli é appunto al di là del bene e del male comunemente detti, ossia é su “un altro pianeta”, ha un’altra scala di valori da lui stesso impostata e riconosciuta. In Al di là del bene e del male é evidente la precisa consapevolezza che Nietzsche ha del significato e dell’importanza dell’interpretazione nella decifrazione della realtà e del suo senso. Pensare di poter esprimere direttamente la “verità” è ingenuità o malafede; occorre operare anche in filosofia come opera la vita nella sua immediatezza: celandosi dietro una maschera. Egli stesso scrisse, a questo proposito: “Tutto ciò che è profondo ama la maschera; le cose più profonde hanno per l’immagine e l’allegoria perfino dell’odio. (…) Ogni spirito profondo ha bisogno di una maschera: e più ancora, intorno a ogni spirito profondo cresce continuamente una maschera, grazie alla costantemente falsa, cioè superficiale interpretazione di ogni parola, di ogni passo, di ogni segno di vita che egli dà.” La maschera è dunque un mezzo ambiguo, dietro il quale da un lato la verità ama nascondersi per salvaguardare la propria profondità; ma che dall’altro noi utilizziamo per non vedere la realtà, per sfuggire da essa. “Nel terzo saggio di questo libro ho presentato un modello di quel che in un caso del genere intendo per “interpretazione” – a questo saggio è fatto precedere un aforisma ed esso stesso ne rappresenta il commento. Indubbiamente, per esercitare in tal modo la lettura come arte, è necessaria soprattutto una cosa, che oggidì è stata disimparata proprio nel modo più assoluto – ed è per questo che per giungere alla “leggibilità” dei miei libri occorre ancora del tempo – una cosa per cui si deve essere quasi vacche e in ogni caso non “uomini moderni”: il ruminare…”. La modernità a cui si riferisce Nietzsche è la nostra modernità delle macchine, della velocità ad ogni costo. Una modernità che non lascia più spazio all’attenzione e alla profondità, che fa, appunto, della velocità una maschera per nascondere la propria angoscia ed impotenza. Ruminare, quindi, nel senso di lasciarsi tempo, di ripensare a lungo su ciò che si è letto, di non voler cogliere “subito tutto”, di essere, cioè, il contrario di un uomo moderno. Da: Al di là del bene e del male, afor. 38: “Dopo avere, abbastanza a lungo, letto i filosofi tra le righe e riveduto le loro bucce, mi sono detto: occorre anche considerare la maggior parte del pensiero cosciente tra le attività dell’istinto, e anche laddove si tratta del pensiero filosofico; occorre, a questo punto, trasformare il proprio modo di vedere, come si è fatto per quanto riguarda l’ereditarietà e l'”innatismo”. Come l’atto della nascita non può essere preso in considerazione nel processo e nel progresso dell’ereditarietà, cosl l'”esser cosciente” non può essere contrapposto, in una qualche maniera decisiva, all’istintivo – il pensiero cosciente di un filosofo è per lo più segretamente diretto dai suoi istinti e costretto in determinati binari. Anche dietro ogni logica e la sua apparente sovranità di movimento stanno apprezzamenti di valore, o per esprimermi più chiaramente, esigenze fisiologiche di una determinata specie di vita. Per esempio, che il determinato abbia più valore dell’indeterminato, che l’apparenza sia meno valida della “verità”: simili apprezzamenti, con tutta la loro importanza regolativa per noi, potrebbero, pur tuttavia, essere soltanto apprezzamenti pregiudiziali, una determinata specie di “niaiserie”, come può essere appunto necessaria per la conservazione di esseri quali noi siamo. Supposto, cioè, che non sia proprio l’uomo la “misura delle cose”…”. Alla radice della filosofia e della morale – dice in sostanza Nietzsche in questo aforisma – c’è l’istinto di conservazione e di accrescimento della vita. Dietro ogni grande teoria filosofica, ogni ideale morale o misticismo religioso, c’è la volontà di vivere, concepita come una forza naturale sempre uguale a se stessa. “Comunque sia da concepire questo “fondo”, resta in ogni caso che, nella demitizzazione, esso si oppone al mito come il vero al falso, è il criterio di verità in base a cui la favola si rivela favola. Ora, uno dei miti, anzi il mito che Nietzsche si è applicato con più calore a distruggere, è proprio la credenza nella verità. “Anzitutto, scuotere la credenza nella verità”. Non in qualche verità determinata, ma nella verità come tale.” G. Vattimo, citato, p. 136. Leggiamo ora l’aforisma 16: “Continuano ancora ad esistere ingenui osservatori di sé, i quali credono che vi siano “certezze immediate”, per esempio “io penso”, o, come era la superstizione di Schopenhauer, “io voglio”: come se qui il conoscere potesse afferrare puro e nudo il suo oggetto, quale “cosa in sé”, e non potesse aver luogo una falsificazione né da parte del soggetto, né da parte dell’oggetto.” … se il “soggetto” della conoscenza, colui che conosce, può falsificare i dati della sua conoscenza sovrapponendovi le proprie “verità” prefabbricate e le proprie teorie morali; così anche l'”oggetto”, la cosa che si vuole conoscere, si nasconde dietro un’apparenza, una serie di maschere, che caratterizza tutto ciò che è vivo: la vita ama nascondersi per difendersi… “Ma non mi stancherò di ripetere che “certezza immediata”, così come “assoluta conoscenza” e “cosa in sé”, comportano una “contradictio in adjecto”: ci si dovrebbe pure sbarazzare, una buona volta, della seduzione delle parole! Creda pure fin che vuole il volgo, che conoscere sia un conoscere esaustivo; il filosofo deve dirsi: se scompongo il processo che si esprime nella proposizione “io penso”, ho una serie di asserzioni temerarie, la giustificazione delle quali mi è difficile, forse impossibile, – come per esempio, che sia io a pensare, che debba esistere un qualcosa, in generale, che pensi, che pensare sia un’attività e l’effetto di un essere che è pensato come causa, che esista un “io”, infine, che sia già assodato che cos’è caratterizzabile in termini di pensiero, – che io sappia che cos’è pensare. Se io, infatti, non mi fossi già ben deciso al riguardo, su quale base potrei giudicare che quanto appunto mi sta accadendo non sia forse un “volere” o un “sentire”? Ebbene, quell'”io penso” presuppone il confronto del mio stato attuale con altri stati che io conosco a me attinenti, al fine di stabilire che cosa esso sia: a causa di questo rinvio a un diverso “sapere”, esso non ha per me, in nessun caso, un’immediata certezza.” Malgrado la sua critica nei confronti del linguaggio filosofico tradizionale, in questo caso Nietzsche “ricade” nel meccanismo della confutazione logica: egli asserisce, infatti, che la “certezza” cartesiana circa il fondamento primario dell'”io penso” – al di sotto dell’io, della coscienza, non c’è nulla poiché è il pensare che costituisce il fondamento di ogni certezza – è contraddetta dall’esistenza, accanto al “pensare”, di altri stati della coscienza quali il “volere” e il “sentire”. In base a quale principio assoluto possiamo dunque stabilire che prima viene il pensare e poi tutto il resto? In base, sostiene Nietzsche, a una semplice nostra decisione in tal senso. Ma proprio Nietzsche ci ha insegnato che una decisione non crea una verità. ” – Al posto di quella “certezza immediata”, alla quale il popolo, nel caso in questione, può credere, il filosofo si ritrova in tal modo nelle mani una serie di problemi della metafisica, vere e proprie questioni di coscienza dell’intelletto, che così si formulano: “Donde prendo il concetto del pensare? Perché credo a causa ed effetto? Che cosa mi dà il diritto di parlare d’un io e perfino d’un io come causa, e infine ancora d’un io come causa dei pensieri?”. Chi, richiamandosi a una specie d’intuizione della conoscenza, si sentisse così fiducioso da rispondere, come fa colui che dice: “Io penso e so che questo almeno è vero, reale, certo” -troverebbe oggi pronti in un filosofo un sorriso e due punti interrogativi: “Signor mio, gli farebbe forse capire il filosofo, è improbabile che lei non si sbagli: ma perché poi verità a tutti i costi?.” Per comprendere il significato di quest’ultima frase, leggiamo questi altri due brevi aforismi tratti da La volontà di potenza: “Contro il valore di ciò che rimane eternamente uguale (vedi l’ingenuità di Spinoza, come pure di Cartesio) c’è il valore di ciò che è più breve e transeunte, il seducente scintillio dorato sul ventre del serpente vita”. “Non “conoscere” ma schematizzare, – imporre al caos tutta la regolarità e tutte le forme sufficienti al nostro bisogno pratico”. Dunque la verità a tutti i costi è un bisogno pratico di sopravvivenza dell’uomo; solo di quell’uomo, però, che teme, per debolezza, la forza vitale del “divenire”, del caotico cambiamento che caratterizza la vita. Il seguente aforisma (n. 289), sempre tratto da Al di là del bene e del male, è stato giudicato “una delle pagine più belle che Nietzsche abbia mai scritto”. In esso emerge con forza quel concetto di profondità insondabile del “vero” che ha connotato gran parte del pensiero del Novecento: “Negli scritti di un eremita si ode ancor sempre qualcosa coma la eco del deserto, qualcosa dei bisbigli e del timido guardarsi attorno della solitudine…” Malgrado l’apparenza, anzi, proprio “dietro di essa”, deserto e solitudine nascondono ancora qualcosa; l’eremita ascolta proprio questo “qualcosa”. “… dalle sue più forti parole, dal suo stesso grido affiora ancora una nuova e più pericolosa specie di silenzio, di tacita segretezza. Chi di anno in anno, ogni giorno e ogni notte, è stato in un intimo contrasto e colloquio con l’anima sua, chi nella sua caverna – può essere un labirinto, ma anche una miniera d’oro – è divenuto un orso antidiluviano o un disseppellitore o un custode di tesori e un drago…” Il “nuovo” filosofo che Nietzsche intende essere non è colui che dà chiarezza, ma colui che scava nella profondità senza paura di sporcarsi; nella profondità dell’esistenza infatti si trova l’oscurità (che la nostra “coscienza” ritiene fangosa) di una condizione vitale elementare di cui è stolto avere paura, perché in essa si cela il tesoro della vita. Il filosofo, come il drago della mitologia sassone, è il custode del tesoro celato nel cuore della terra. “… finisce per ricevere, persino nelle sue idee, un tono di luce crepuscolare, un profumo tanto d’abisso che di muffa, qualcosa di incomunicabile e di ripugnante che investe con un soffio gelido chiunque gli passi accanto. L’eremita non crede che un filosofo – posto che un filosofo sia sempre stato, prima di tutto, un eremita – abbia mai espresso in libri le sue intime ed estreme opinioni: non si scrivono forse libri al preciso scopo di nascondere quel che si custodisce dentro di sé? – dubiterà, anzi, che un filosofo possa avere in generale “estreme e intime” opinioni, pensando invece che ci sia in lui, dietro ogni caverna, una caverna ancor più profonda – un mondo più vasto, più strano, più ricco al di sopra d’una superficie, un abisso sotto ogni fondo, sotto ogni “fondazione”. Ogni filosofia è filosofia di proscenio – questo è un giudizio da eremita: “V’è qualcosa di arbitrario nel fatto che costui si sia arrestato qui, abbia rivolto lo sguardo indietro e intorno a sé, non abbia, qui, scavato più profondamente e abbia messo in disparte la vanga – c’è pure qualcosa di sospetto in tutto ciò”. Ogni filosofia nasconde anche una filosofia; ogni opinione è anche un nascondimento, ogni parola anche una maschera.”
GENEALOGIA DELLA MORALE
Composta da Nietzsche nell’estate del 1887 e pubblicata agli inizi dell’inverno di quello stesso anno, la “Genealogia della morale” nacque come scritto polemico , presentandosi all’insegna di una consapevole provocazione. Alcune delle più controverse teorie sociali di Nietzsche, come per esempio la contrapposizione fra morale dei signori e morale del gregge, vengono ampiamente esposte e argomentate in questo libro. Ma ogni riferimento sociale rimarrebbe opaco se non lo si connettesse al suo presupposto “metafisico”: l’indagine sull’ “origine dei nostri pregiudizi morali” presuppone l’interrogativo sull’ “origine del male”, a cui Nietzsche dichiara di essersi dedicato sin dal suo “primo gioco d’infanzia letterario”: “a quel tempo, ebbene, com’é logico, resi l’onore a Dio e feci di lui il padre del male”. Nietzsche sapeva benissimo che questo suo scritto sarebbe suonato “urtante all’orecchio”. Ma sapeva anche che, nella sua epoca come nella nostra, questo é inevitabile per ogni ricerca che metta radicalmente in questione la bontà dei buoni sentimenti e si offra quale amaro antidoto alle perorazioni di coloro che “a quel che pretendono non danno il nome di rivalsa, bensì di ‘trionfo della giustizia'”. In quanto tale, con tutte le sue contraddizioni e dolorose tensioni, la “Genealogia della morale” rimane un saggio prezioso. La “Genealogia della morale”, come accennato, fu concepita e presentata da Nietzsche come un’integrazione e un chiarimento rispetto alle tesi enunciate in “Al di là del bene e del male”, pubblicato l’anno precedente. E’ lo scritto con il quale Nietzsche conclude il periodo della sua battaglia contro la morale occidentale e cristiana, iniziata con “Umano, troppo umano”. Rispetto ai primi scritti di questo periodo, costruiti come raccolte di aforismi, la Genealogia della morale presenta una maggiore sistematicità e un andamento più argomentativo. Essa risulta infatti articolata in tre dissertazioni, ciascuna con un proprio titolo, e, precisamente: 1 ) buono e malvagio, buono e cattivo; 2 ) colpa, cattiva coscienza e simili; 3 ) che significano gli ideali ascetici? Il primo effetto prodotto dalla cattiva coscienza consiste nell’interpretare in chiave morale i propri istinti animali e, quindi, come cattivi, ossia costituenti di per sè una colpa, in quanto sarebbero contrastanti con la volontà di Dio. Il positivo viene così interamente spostato fuori di sè e della propria natura e riconosciuto solo i Dio, mentre tutto ciò che é umano, compresi se stessi e la propria natura, diventa il negativo. Tra questi due poli si instaura una distanza incolmabile, sulla quale si fondano le nozioni di inferno e di pena eterna. Alla radice di queste operazioni Nietzsche vede una volontà inconsapevole di crudeltà, che raggiunge il suo apice proprio quando é rivolta contro se stessi: qui si radica la “volontà di pensarsi castigato” eternamente, senza mai poter scontare interamente e definitivamente da sè la colpa, con la conseguenza che l’esistenza e l’uomo stesso vengono spogliati di ogni valore, per identificare il valore stesso con Dio. E strettamente connesso a queste argomentazioni é l’ascetismo, che si basa sul presupposto di concepire l’uomo come un essere imperfetto e incompleto, mancante di qualcosa. Ciò significa che l’uomo non ha in se stesso la giustificazione della propria esistenza, ma deve cercarla altrove, fuori di sè e soltanto fuori di sè: nella negazione di se stesso può trovare un significato per la propria vita. L’ascetismo agli occhi di Nietzsche presenta solo un aspetto positivo: l’aver dato un senso alla sofferenza, che é un dato ineliminabile, ma che appare assurdo e privo di senso a colui che soffre. Come intuibile, con la “Genealogia della morale” Nietzsche si impegna con una nuova profondità a rovesciare tutti gli apprezzamenti di valore già dati nella tradizione europea. In particolare, la morale platonico-cristiana, con i suoi valori di compassione, umiltà, rassegnazione e uguaglianza appiattita sul livello dei più deboli e rinunciatari, viene stigmatizzata come “morale degli schiavi” , che dicono un “no” secco alla vita, e del risentimento contro le virtù praticate positivamente dagli aristocratici (magnanimità, coraggio, capacità di eccedere e di donare). In quest’ opera c’è poi un riavvicinamento a Schopenauer. Infatti nella prefazione egli dice: “…il mio grande maestro Schopenhauer”. La parentela del nuovo principio filosofico della “volontà di potenza” con il principio schopenhaueriano della “volontà di vivere” è evidente e indiscutibile (e lo dice Nietzsche stesso). La prima si presenta anzi come una variante della seconda. In entrambi i casi si tratta di una sostanza irrazionale, che è in noi. La differenza rispetto a questa sostanza si riduce al fatto che Schopenhauer la rifiuta e vuole negarla, Nietzsche invece l’accetta e vuole affermarla. In quest’opera cominciano a delinearsi gli argomenti e le tesi contro la scienza. […] Mentre ogni morale aristocratica nasce da una trionfale affermazione di sé, la morale degli schiavi oppone sin dal principio un no a ciò che non fa parte di essa, a ciò che è differente da sé ed è il suo non-io; e tale è il suo atto creatore. Questo capovolgimento del colpo d’occhio valutativo, questo punto di vista che si ispira necessariamente all’esterno invece di fondarsi su se stesso, appartiene in proprio al risentimento. Della “Genealogia della morale” ce ne parla Nietzsche stesso in “Ecce homo”, la sua autobiografia: “Le tre dissertazioni di cui é composta questa genealogia sono forse, per quel che riguarda l’espressione, le intenzioni e l’arte della sorpresa, ciò che di più inquietante é stato scritto finora. Dioniso é, si sa, anche il dio dell’oscurità. Tutte le volte, un principio che si deve indurre in errore, freddo, scientifico, perfino ironico, messo in rilievo con intenzione, tirato in lungo con intenzione. A poco a poco l’agitazione cresce: guizzano singoli lampi; da lontano, delle verità molto spiacevoli si fanno sentire con un cupo brontolìo; finchè da ultimo si arriva ad un tempo feroce in cui ogni cosa incalza con una formidabile tensione. In chiusura, tutte le volte, fra denotazioni spaventose appare tra dense nubi una nuova verità. La verità della prima dissertazione é la psicologia del cristianesimo: l’origine del cristianesimo dallo spirito del risentimento e non, come si crede generalmente, dallo spirito; per sua natura, un movimento di reazione, la grande sollevazione contro il dominio di valori nobili. La seconda dissertazione dà la psicologia della coscienza: la quale non é, come generalmente si crede, la voce di dio nell’uomo, ma é l’istinto della crudeltà che, poichè non gli é più possibile di sfogarsi all’esterno, si rivolta indentro. La crudeltà é mostrata qui per la prima volta come uno dei più antichi e più necessari fondamenti della civiltà. La terza dissertazione risolve il problema donde venga l’immensa potenza dell’ideale ascetico, dell’ideale del prete, sebbene esso sia l’ideale dannoso per eccellenza, un’aspirazione alla fine, un ideale di decadenza. Risposta: non perchè, come generalmente si crede, dio agisca dietro il sacerdote, ma ‘faute e mieux’, perchè finora fu l’unico ideale, perchè non ha avuto concorrenti. Poichè l’uomo preferisce di volere il Nulla piuttosto che non volere nulla… Soprattutto, mancava un controideale, fino a Zarathustra. Sono stato compreso? Tre importanti studi preparatori d’uno psicologo, per un’inversione di tutti i valori. Questo libro contiene la prima psicologia del prete”. Nella “Genealogia della morale” Nietzsche ne approfitta per trattare un tema che riprenderà poi nell’Anticristo: il tema, come accennavamo, del senso di colpa, del doversi ad ogni costo sentire colpevoli di fronte ad un Dio creatore della morale: “Si sarà già intuito che i criteri di valutazione dei sacerdoti possono facilmente separarsi da quelli cavalleresco – aristocratici, fino a diventare il loro opposto. I giudizi di valore cavalleresco – aristocratici presuppongono una prestanza fisica, una salute florida, ricca, debordante e insieme tutto ciò che ne condiziona il mantenimento, guerra, avventura, caccia, danza, tornei, insomma tutto quello che comporta una vita attiva, forte, libera, serena. I criteri di valutazione sacerdotali hanno altri presupposti. ..C’è qualcosa di malsano in queste aristocrazie sacerdotali e nelle abitudini che le dominano, aliene all’azione, parte sentimentalmente esplosive e parte malinconicamente assopite, qualcosa la cui conseguenza pare essere quella nevrastenia e quella cagionevolezza intestinale che sembra inevitabilmente endemica tra i sacerdoti di ogni tempo… I sacerdoti sono, come è noto, i nemici più crudeli. E per quale ragione poi? Perché sono i più impotenti. L’impotenza genera in loro un odio che arriva a diventare mostruoso e sinistro, spiritualissimo e tossico al massimo grado. Nella storia universale coloro che più degli altri sono stati capaci di odio, e di genialità nell’odio, sono sempre stati i preti – a paragone della genialità della vendetta sacerdotale, ogni altra dote intellettuale può appena essere presa in considerazione. ..gli Ebrei, quel popolo sacerdotale che non ritenne di aver ricevuto la dovuta soddisfazione dai propri nemici e sopraffattori, se non dopo averne radicalmente ribaltato i valori, cioè solo grazie ad un atto della più spirituale vendetta. Sono stati gli Ebrei che hanno osato ribaltare e mantenere, stringendo i denti dell’odio più abissale (l’odio dell’impotenza), l’equazione aristocratica di valore buono = aristocratico in “i miserabili solo sono i buoni, i poveri, gli impotenti, i sofferenti, gli indigenti, i malati, i brutti sono gli unici ad essere pii, beati in Dio, solo a loro è concessa la beatitudine – là dove voi, al contrario – voi, nobili e potenti, voi sarete per l’eternità i malvagi, i crudeli, i corrotti, gli insaziabili, gli empi, e sarete anche per l’eternità infelici, dannati e maledetti” (Genealogia della morale, 8). Il Dio originario degli Ebrei è la naturale espressione della potenza del popolo ebraico ed è pertanto concepito antropomorficamente come padre e come re, potente e vendicativo. Ma nel tempo questa potenza viene meno e a man mano che Dio appare sempre meno reale, anche il concetto di Dio subisce un processo di moralizzazione e di purificazione: viene introdotta l’idea di peccato, colpa, aldilà che trasforma la sua decadenza, la sua morte sulla croce, in un nuovo dio, il Dio dei cristiani. In questo modo la sconfitta storica di Gesù, la sua morte sulla croce, è spacciata per una vittoria e il progetto storico del cristianesimo è una gigantesca mistificazione per cui i più nichilisti, i più impotenti diventano i padroni del mondo in nome di una entità inesistente che loro stessi gestiscono e amministrano. Ciò avviene inculcando agli uomini un perverso sistema di divieti, di giudizi e di scale di valori assolutamente arbitrari con lo scopo di spegnere i essi tutte le reattività, indebolirlo, renderlo simile a loro reprimendo le pulsioni naturali. L’uomo, spinto a soffocare i propri impulsi e a vergognarsene, trova il suo sfogo nel mondo interiore dove trovano spazio angoscia e inquietudine. L’uomo, che crede di essere arrivato sul gradino più alto dell’evoluzione, è destinato a diventare sempre più malato, come sempre più malata è la sua produzione artistica e letteraria, piena com’è di lacrimevoli retoriche su pentimenti, rimorsi, problemi di coscienza e problemi esistenziali. La morale ha riempito l’uomo di mostri interiori e lo ha trasformato in una povera bestia acculturata. Chiunque pensi che il disprezzo di Nietzsche per la morale, per il cristianesimo, per la cultura, sia un elogio alla violenza, dimostra di non avere capito nulla. Nietzsche non è il filosofo del potere, ma il filosofo del divenire, ed è per questo che accanto al cristianesimo combatte il socialismo, l’anarchismo, il femminismo e il concetto stesso di ideologia. Ogni ideologia nasce da uno stato di malessere e di “risentimento”, al pari del cristianesimo. L’idea ebraica e cristiana del libro che cambia la vita è ereditata dal socialismo in cui gli intellettuali prendono il posto dei preti ed è ereditata dal femminismo in cui le donne prendono il posto dei preti e degli intellettuali e così via. Le ideologie sono teorie sempre confutabili che hanno in comune il fatto di proporre libri programmatici, precetti, ideali nella cui genericità e universalità nessuno si riconosce. Queste considerazioni permettono a Nietzsche di interpretare il processo storico e filosofico dell’età moderna in modo profondamente originale. Il movimento che da Lutero e dalla Riforma protestante porta a Leibniz, a Kant, alla filosofia tedesca, assume qui un significato regressivo: la rivolta del mondo tedesco contro Roma è la rivincita della teologia e della morale nei confronti di quel sano scetticismo veramente progressivo e creativo del Rinascimenti italiano. L’importanza fondamentale dell’ Italia e della sua cultura consiste nel fatto che in questo paese si è tentato di uccidere Dio prima che in qualsiasi altro luogo, proprio nel Rinascimento, quando si è riconosciuto il carattere temporale e politico dei condizionamenti metafisici.
IL CASO WAGNER
Dopo la Genealogia della Morale, s’inizia un periodo vivacemente polemico e genialmente paradossale in cui Nietzsche si fa il legislatore della propria profezia. La nudità psicologica si fa piú incisiva; la forma stilistica del pensiero nietzscheano diventa piú cruda e precisamente superba. Chi annuncia l’era tragica dell’Europa è compreso di una strana febbre di chiarezza e di orgoglio. Il celebre Caso Wagner, compiuto a Sils-Maria nel luglio del 1888, e apparso nelle librerie di Torino nel settembre dello scorso anno, riesce a far parlare le gazzette cosí squallidamente mute prima per Nietzsche, per il carattere pamphletaire di quest’opera del terribile specialista, per dirla alla Berthelot. Wagner è per Nietzsche artista moderno per eccellenza, senza natura, senza coltura, senza istinto. Ma Wagner ha saputo, con acutissima perspicacia, scoprire i bisogni, le necessità interiori, dell’anima de’ suoi tempi. Wagner è un ciarlatano che ha suonato insieme tutte le campane: la brutalità, l’idiozia, l’artificio sono le sue armi. Il retore dell’arte massiccia, africanamente fantasioso, preziosamente orientale, informe, scompositore dello stile, col suo coraggio ha saputo teorizzare i propri difetti. Wagner, narcotizzatore misterioso, sbigottisce come un sogno cupo, come un incubo, le anime malate. Gli istinti nichilisti, la fatica, la morte sono glorificati dal Maestro che ha reso musicalmente l’antipotenza e l’antivolontà. Wagner è il decadente per eccellenza, quello che Nietzsche, nella “Volontà di potenza” definirà “un grande punto interrogativo del nostro secolo”. La musica secondo Nietzsche é stata privata del suo carattere affermativo e trasfiguratore del mondo per diventare una vera e propria musica di decadenza e non più il flauto di Dioniso: in essa non é più insita una volontà di vivere che si estrinseca in ogni istante, bensì predominano i temi cupi di chi rifiuta la vita. Ed ecco che tutto “Il caso Wagner” non é altro che un enorme “problema musicale”, come lo definisce Nietzsche stesso in “Ecce homo”: e Nietzsche si proclama pronto a muover guerra contro Wagner, il suo grande amico del passato, schierando i campo i “pezzi più grossi della mia artiglieria”. Nietzsche era particolarmente affascinato dalla musica in quanto forma artistica, per di più tipicamente dionisiaca ed egli arriva più volte a sostenere che l’arte sia più importante della verità (anche perchè, in fin dei conti, che cosa é la verità?). Il grande pensatore tedesco dice di disprezzare in Wagner l’eccessivo spirito religioso e l’antisemitismo sfrenato: e qui abbiamo la conferma decisiva dell’errata interpretazione nazista del pensiero nietzscheano che, indebitamente, lo ha sempre fatto passare per antisemita. Ma la critica aspra e polemica mossa al musicista tedesco non trova le sue radici in complessi edifici argomentativi, quanto piuttosto nel mettere in luce i danni arrecati da Wagner alla cultura tedesca: sì, perchè “Wagner non é un sillogismo, ma una malattia” che se non trattata con la giusta terapia può infettare l’intero mondo tedesco ed europeo. Ed ecco allora che troviamo Nietzsche nei panni di medico indaffarato a trovare un rimedio a questa malattia di nome “Wagner”. Wagner secondo Nietzsche ha tutte le istanze dell’uomo moderno: il sovreccitamento e l’esaltazione, la pomposità delle rappresentazioni, il teatro rivolto alle masse, all’ ‘armento’. E strettamente congiunto alla decadenza wagneriana é l’idealismo stesso che caratteristica il musicista tedesco, il cercare in modo esasperato la redenzione dell’uomo (anche dalla donna!), la conoscenza. Wagner é poi imbevuto del pessimismo di Schopenhauer, da cui Nietzsche si é saggiamente distaccato. E poi non mancano le critiche all’ideale wagneriano secondo il quale la musica non sarebbe un punto di arrivo, ma solo un mezzo per arrivare oltre, a qualcosa di superiore: Nietzsche non può accettare questo, da grande estimatore dell’arte quale egli é: non vi é un “oltre la musica”, non vi é una verità recondita cui l’uomo può accedere tramite le leggiadre sinfonie musicali: tutta la verità é insita nella musica stessa, massima espressione artistica di tipo dionisiaco. Certo, Wagner si può ammirare: è un seduttore in grande stile, convince gli incerti senza condurli alla consapevolezza di ciò che viene fatto loro credere, occulta il più nero oscurantismo nei luminosi involucri dell’ “ideale”. I giovani con Wagner diventano imbecilli, cioè “idealisti”; in questo senso Parsifal è un capolavoro. Dunque, l’adesione a Wagner deve far sì che la vita riesca in singoli individui, in singoli esemplari e non realizzi la felicità dei più, della maggior parte delle persone. Il “dramma di sè” deve essere “ritrovamento di sè”. Occorre prendere potere su se stessi che significa anche prendere potere sui nostri “pro” e sui nostri “contro”. Leggi ancora: “aver potere sul bene e sul male”. Questo ci libera dall’obbligo di solidarizzare con gli altri i quali invece ostacolano proprio la formazione del super uomo. Nel 1854 Wagner si avvicina a Schopenhauer concependo il mito non solo come passato inverato dalla storia, ma come il presente che spiega il passato imperniando il dramma sull’azione negativa della volontà, poi supera Schopenhauer affermando la possibilità di un’ azione redentrice. Rielaborando le antiche leggende dell’ “Edda”, del “Niebelungenlied”, Wagner infonde nei personaggi uno spirito universale sì che l’angoscia degli dei antichi, le passioni dei nani e dei giganti, l’anima degli eroi si identificano con le nostre angosce, con le nostre passioni, con i nostri stessi ideali Due le idee madri in Wagner: l’idea di una caduta originale e quella di una redenzione. Il male entra nel mondo per una colpa, un fallo e fatalmente allarga il proprio influsso venefico fino a dominare tutti gli esseri viventi e persino gli stessi dei. La caduta da uno stato di innocenza e la coscienza della colpa spingono i personaggi wagneriani al bisogno di un riscatto: siamo alla vigilia dell’idea della redenzione. E poiché nessuno può essere nello stesso tempo colpevole e redentore, ecco allora profilarsi l’eroe redentore: l’uomo puro tra i puri potrà essere l’eroe degno della missione e riportare l’umanità alla purezza, perdonando e obliando la “caduta”. Niente di più lontano da Nietzsche; il filosofo rifiuta decisamente l’equivalenza pena = colpa. E’ vero che la sofferenza conferisce distinzione, virtù, valore e nobiltà, ma l’ascesi di Nietzsche ha un’altra direzione; ciò che è terribile è la mancanza di senso del dolore, è la sua gratuità che suscita ribellione. Occorre dunque trovarne una interpretazione. Poiché il senso del dolore ha varie interpretazioni, trovare il “senso in sé ” è cosa che non esiste. E’ compito rimesso a ciascuno di noi trovare l’interpretazione del nostro dolore personale. Solo così avrà “senso” per ciascuno di noi e ne renderà possibile l’accettazione. Dunque il dolore può assumere più forme perché di per sé non ha valore, ma riceve il valore di “riflesso”, il valore che ogni uomo dà al proprio dolore. La sofferenza non deriva da colpa, c’è e basta; è la lotta titanica con il dolore che ci porta a rinascere alla vita. Morale, religione, metafisica sono solo giustificazioni. Il dolore ha senso nel preciso momento in cui io gliene do uno. Dice Nietzsche: “davanti al tiranno (dolore) io sono senza colpa”. Profonde divergenze ideologiche e filosofiche allontanano quindi Nietzsche da Wagner, per quanto Nietzsche abbia indubbiamente sentito il fascino della musica wagneriana, e non solo. Già nel 1854 Nietzsche aveva composto al ginnasio alcuni brani musicali; nel 1860 aveva fondato l’associazione musicale e letteraria “Germania” per la quale il filosofo scriverà saggi, poesie, composizioni musicali. Dopo l’allontanamento da Wagner, Nietzsche farà l’elogio della Carmen di Bizet, dimostrando di amare un altro tipo di musica. Anche Wagner era stato grande ammiratore di Nietzsche fervente entusiasta allorché nel 1872 era uscita “la nascita della tragedia dallo spirito della musica”. Persino Cosima Wagner riceve con gratitudine gli omaggi e le dediche letterarie e musicali che le indirizzò il filosofo. Ma già nel luglio 1876, quando esce la quarta “inattuale”: “Richard Wagner a Bayreuth”, il filosofo avverte il suo congedo da Wagner. Intanto le condizioni di salute di Nietzsche si aggravano sempre più e allorchè esce nel 1878 “umano, troppo umano”, Cosima e Richard Wagner si chiudono in un silenzio ostile. Di lì a poco Wagner non esisterà più per Nietzsche se non nelle opere e nei brani che lo riguardano. Solo nel 1889, in piena crisi psichica e ormai prossimo al manicomio, Nietzsche ricorderà il nome Wagner, scrivendo a Cosima un biglietto “Arianna, io ti amo”, paragonando Cosima ad Arianna. Si concluse erroneamente per un infelice amore di Nietzsche per Cosima Wagner; in realtà niente mostra tracce di un autentico amore ad eccezione di quel sentimento che legò Nietzsche al Lou Salomè, sua discepola e compagna dalla quale fu poi abbandonato.
IL CREPUSCOLO DEGLI IDOLI
Ovvero come si filosofa col martello
Il “Crepuscolo degli idoli” appartiene a quei mesi brucianti del 1888 che videro l’ultima fioritura degli scritti di Nietzsche. In questo libretto leggero, sinuoso, acuminato, Nietzsche sembra cercare una pausa di temibile “ozio”, un respiro all’interno della laboriosa formazione della sua grande opera incompiuta: la “Trasvalutazione”. E’ un gioco guerresco, teatrale, che vuole aggirare, auscultare e rovesciare tutti quegli idoli che accompagnano la nostra storia. Il Nietzsche che qui racchiude in una abbagliante parabola la millenaria vicenda attraverso la quale “il mondo vero divenne favola” é lo stesso che, superata la soglia iniziatica nella sua critica della décadence, ne annuncia la conclusione paradossale: che l’unica critica adeguata della décadence é quella che ci obbliga ad “andare avanti, voglio dire un passo dopo l’altro più in là nella décadence”. Nietzsche stesso scrive a proposito del “Crepuscolo degli idoli” in “Ecce homo”, la sua autobiografia: “Questo scritto, che non arriva a 150 pagine, sereno e fatale nell’intonazione- un demone che ride- scritto in così pochi giorni che io esito a dirne il numero, é fra i libri, una vera eccezione: non c’é nulla di più sostanzioso, di più indipendente, di più rivoluzionario: di più cattivo. Se ci si vuole fare rapidamente un’idea del modo in cui erano capovolte tutte le cose, prima di me, si cominci da questo scritto. Ciò che sulla copertina é chiamato idolo é semplicemente quello che finora si é chiamato verità. Crepuscolo degli idoli; in lingua povera: la vecchia verità si avvicina alla sua fine… Non c’é realtà, non c’é idealità che non sia toccata in questo libro (toccata: che prudente eufemismo!). Non solo gli idoli eterni, ma anche i più recenti e, conseguentemente, i più caduchi: le idee moderne, ad esempio. Un gran vento soffia tra gli alberi e dappertutto cadono a terra dei frutti: delle verità. Vi é in esso la soverchia abbondanza di un autunno troppo ricco: si inciampa tra le verità, se ne schiaccia anche qualcuna: ce ne sono troppe… Ma ciò che si finisce per avere in mano non sono più cose problematiche, sono cose precise”. Nietzsche arriva anche a definire quest’opera come la somma di tutte le sue principali eterodossie filosofiche; non gli idoli dell’epoca, ma gli ideali, gli idoli eterni vengono qui ausculati e sfiorati col martello come con un diapason. Sicchè il martello con cui Nietzsche filosofeggia sembra piuttosto il martelletto di un mineralogo che un rozzo strumento distruttore; é anzi un diapason grazie al quale gli idoli eterni, gli ideali, emettono quel sordo rumore che tradisce viscere enfiate. Già in “Umano, troppo umano” Nietzsche aveva potuto pronunciarsi contro gli ideali, suoi eterni nemici: “Dove voi vedete cose ideali, io vedo cose umane,ah! troppo umane… “. Il “Crepuscolo degli idoli” rappresenta una “fisiologizzazione” del pensiero del filosofo tedesco, che ha al suo centro il concetto di décadence. La decadenza nella filosofia (da Socrate), nella religione e nella morale (cristianesimo), nella politica (democrazia e socialismo) nell’arte e nella letteratura é condizionata fisiologicamente. Ciò vuol dire che essa é espressione del decadere della vita. Il pessimismo non é un problema, ma solo un sintomo, il nome giusto per esso é nichilismo, ma il nichilismo a sua volta non é la causa ma la logica stessa della décadence. Sotto i nomi più rispettati e venerati, i valori nichilistici, i valori del declino della vita, si sono imposti e dominano la modernità. E il processo di decadenza non può nè deve essere arrestato, checchè ne pensino i vari filosofi e i preti. L’umanità, sotto il grande peccato originale della ragione, l’immortale irrazionalità, che ha fondato la morale, é giunta alle forme attuali della decadenza. Nietzsche non ha da contrapporre alcun antidoto, intende solo descrivere la decadenza, andarne a caccia, farla vedere dietro ogni idolo, ogni ideale. La sua é solo una diagnosi, non vi é un solo imperativo volto al miglioramento. Un’infinita scala di individui, di infinite volontà di potenza, ciascuna con la loro prospettiva, ciascuna separata e in tensione con tutte le altre; questa sembra essere la visione finale. Dopo l’annullamento del dualismo “mondo vero-mondo apparente” tutte le prospettive di tutte le volontà di potenza non sono nè vere nè false: sono però reali, e restituite all’innocenza del divenire. E sul finire del “Crepuscolo degli idoli” troviamo anche la concezione dell’eterno ritorno e dell’amor fati, tipiche della filosofia nietzscheana, espresse come “fede di Dioniso”: “Io, l’ultimo discepolo del filosofo Dioniso, io il maestro dell’eterno ritorno…”. E poi vi é la celebre sintesi dell’argomento del Crepuscolo degli idoli: “La volontà di sistema é una mancanza di onestà”. Non un sistema della volontà di potenza, ma la negazione e il superamento della volontà di potenza nel pensiero dell’eterno ritorno dell’identico é il significato filosofico del Crepuscolo degli idoli. Nella prefazione, Nietzsche esordisce sostenendo amaramente che “vi sono nel mondo più idoli che realtà”, e sono proprio questi idoli, ossia questi ideali, che hanno fatto imboccare al mondo la strada della décadence, dalla quale non si può tornare indietro; certo, il pensatore tedesco sa che non tutti comprenderanno le sue teorie e preferiranno aggrapparsi agli idoli, senza staccarsene per nulla al mondo: e così Nietzsche può dire: “Uomini postumi- ,come me, ad esempio- vengono compresi peggio di quelli attuali, ma ascoltati meglio. Più esattamente: noi non siamo mai compresi- di qui la nostra autorità…” (af. 15). Nietzsche dichiara così guerra a tutti gli ideali, una guerra che lo vede combattere da solo contro tutti quanti gli uomini, che non riescono a capirlo; e così egli si avvia a smascherare uno dei più gradi creatori di ideali: Socrate, con cui ha esordio la grande decadenza. Il suo errore consisterebbe nell’aver introdotto l’ideale della virtù e della dialettica e se i suoi precetti furono accolti dagli Ateniesi, fu solo perchè egli “affascinava: sembrava essere un medico, un salvatore”. Il ragionamento socratico viene da Nietzsche così riassunto: “Ragione = virtù = felicità significa solamente che si deve imitare Socrate e stabilire in permanenza contro gli oscuri appetiti una luce diurna, la luce diurna della ragione”: Nietzsche riprende qui il tema caratteristico della “Nascita della tragedia”, secondo il quale Socrate introducendo a tutti i costi la razionalità avrebbe ucciso il senso del tragico, il dionisiaco. Nietzsche non può che disapprovare Socrate anche per il fatto che egli volle morire, andando contro la morte con animo tranquillo: l’intera sua vita non fu altro che un “no” alla vita, in attesa di una vita ultraterrena. Ma i velenosi strali di Nietzsche sono indirizzati a molti altri filosofi dell’antichità e l’unico a salvarsi é Eraclito, da cui Nietzsche stesso riprende lo stile aforismatico e con cui ha in comune il profondo senso aristocratico: “Eraclito avrà ragione in eterno ad affermare che l’essere é una vuota finzione. il mondo ‘apparente’ é l’unico mondo: il ‘vero mondo’ é solo un’aggiunta mendace”. E poi, come al solito, Nietzsche muove aspre critiche al Cristianesimo sostenendo che, un pò come per Socrate, “attaccare le passioni alla radice significa attaccare alla radice la vita: la prassi della Chiesa é ostile alla vita”. Dopo di che il pensatore tedesco procede mettendo in luce “4 grandi errori” commessi dall’uomo nel corso della storia, 4 idoli da lui innalzati e venerati: il primo errore consiste nello scambiare la causa con l’effetto, il secondo consiste invece nella falsa causalità, il terzo nell’immaginare cause che in realtà non esistono, e il quarto nella convinzione del libero arbitrio. Dopo aver mosso qualche critica alla presente società tedesca, Nietzsche passa ad esaminare i concetti di bello e brutto, sottolineando come nella realtà non vi siano un bello e un brutto in sè, come aveva sostenuto Platone: “Nel bello l’uomo pone se stesso come misura della perfezione; […] l’uomo in fondo si rispecchia nelle cose, considera bello tutto ciò che gli rimanda la sua immagine; […] l’uomo ha umanizzato: ecco tutto”. Le considerazioni nietzscheane poi volgono alla politica ed egli attacca gli anarchici, quei riottosi che rifiutano ogni autorità e incitano gli altri a comportarsi come loro, nella convinzione che ognuno debba essere responsabile del fatto che loro se la passano male… essi sono perennemente in collera e sono un “no” netto alla vita; da qui il pensatore tedesco prende lo spunto per muovere una critica alle rivoluzioni che muovono dal principio secondo il quale “se io sono una canaglia, dovresti esserlo anche tu”. L’anarchico, il socialista e il cristiano sono tutte forme di decadenza, di insozzatori del mondo. Nel mare magnum delle critiche, Nietzsche non rinuncia però a elogiare anche qualche personaggio del passato: per esempio, egli nutre simpatia per Tucidide e Machiavelli, affini “per l’assoluta volontà di non crearsi delle mistificazioni e di vedere la ragione nella realtà- non nella ragione e meno ancora nella morale”: essi hanno rifiutato ogni ideale, mettendo perfino in discussione l’idea di bene e di male. Riportiamo qui qualche aforisma del Crepuscolo degli idoli:
– Per vivere soli bisogna essere o un animale o un dio, dice Aristotele. Manca il terzo caso: bisogna essere l’uno e l’altro, un filosofo.
– E che? l’uomo è soltanto un errore di Dio? Oppure Dio è soltanto un errore dell’uomo?
– Diffido di tutti i sistematici e li evito. La volonta’ di sistema è una mancanza di onesta’.
– Chi non sa’ porre la propria volonta’ nelle cose, vi pone almeno un senso: crede, cioè, che in esse esista gia’ una volonta’
– Che non si commettano vilta’ verso le proprie azioni! Che non le si pianti poi in asso! Il rimorso è sconveniente.
– “Ogni verita’ è semplice”. Non è questa una doppia menzogna?
– E che? tu cerchi? vorresti decuplicarti, centuplicarti? cerchi seguaci? Cerca zeri!
– “Spirito tedesco”: da diciott’anni una contradictio in adjecto.
– Quando la donna ha virtù virili, c’è da scappare: e se non ha alcuna virtù virile, è lei stessa a scappare.
– Il verme calpestato si rattrappisce. E questo è intelligente. Diminuisce infatti la probabilita’ di venir calpestato un’altra volta. Nel linguaggio della morale: umiltà.
– Erano gradini per me, li ho saliti; a tal fine ho dovuto oltrepassarli. Ma quelli credevano che volessi riposarmi su di loro…
Come il “mondo vero” finì per diventare favola
Il mondo vero, irraggiungibile per il saggio, il pio, il virtuoso – egli vive in quel mondo, egli è quel mondo.
(La più antica forma dell’idea, relativamente intelligente, semplice, convincente. Parafrasi della proposizione “Io, Platone, sono la verità”.)
Il mondo vero, irraggiungibile per ora, ma promesso al saggio, al pio, al virtuoso (“al peccatore che fa penitenza”).
(Progresso dell’idea: diventa più sottile, più insidiosa, meno comprensibile – diventa donna, diventa cristiana…)
Il mondo vero, irraggiungibile, indimostrabile, impromettibile, ma già in quanto pensato una consolazione, un dovere, un imperativo.
(Il vecchio sole, in fondo, ma attraverso la nebbia e scetticismo; l’idea divenuta sublime, pallida, nordica, konigsberghese.)
Il mondo vero – irraggiungibile? Comunque non raggiunto. E, in quanto non raggiunto, anche sconosciuto. Dunque neppure consolante, liberatorio, vincolante: a che potrebbe vincolarci qualcosa di sconosciuto?
(Grigio mattino. Primo sbadiglio della ragione. Canto del gallo del positivismo.)
Il “mondo vero” – un’idea che non serve più a niente, che non vincola nemmeno più – un’idea divenuta inutile, superflua, dunque un’idea confutata: eliminiamola!
(Giorno chiaro; prima colazione; ritorno del bon sens e della serenità; rossore di vergogna di Platone; baccano indiavolato di tutti gli spiriti liberi.)
Il mondo vero lo abbiamo eliminato: quale mondo è rimasto? Quello apparente forse?… Ma no! Col mondo vero abbiamo eliminato anche quello apparente!
(Mezzogiorno; momento dell’ombra più corta; fine dell’errore più lungo; culmine dell’umanità; INCIPIT ZARATHUSTRA.)
L’ ANTICRISTO
Ciò che ci divide non è il fatto che noi non troviamo nessun Dio, né nella storia, né nella natura, né dietro la natura, – ma che quello che è stato adorato come Dio noi non lo troviamo affatto “divino”, ma al contrario pietoso, assurdo, dannoso, non solo perché è un errore, ma perché è un crimine contro la vita…
L’Anticristo é il testo con cui Nietzsche si scaglia apertamente contro il Cristianesimo, colpevole di rendere e mantenere ignoranti le persone e di aver causato nella storia milioni di vittime. All’ Anticristo spetta la funzione di chiudere i conti con il Cristianesimo, oggetto sempre più ossessivo delle analisi e degli attacchi dell’ultimo Nietzsche. Il tono é ultimativo, da manifesto, preludio a un’azione che doveva essere un attacco radicale a tutta la nostra civiltà. Ma, al tempo stesso, Nietzsche si mostra qui ancora una volta di una sottigliezza psicologica prodigiosa, come dimostrano le parole bellissime, e profondamente amiche sulla figura di Cristo. Mentre la condanna del Cristianesimo e della morale convogliano in sè quella, più generale, contro tutte le forze nemiche della vita e capaci di camuffarsi dietro le potenze della religione e della cultura. Contro di esse Nietzsche scende definitivamente in guerra, giungendo a siglare, alla fine, la sua “legge contro il Cristianesimo” col nome terribile dell’Anticristo, in quanto “trasvalutatore di tutti i valori” . E’ un libro che si conviene ai pochissimi, dice Nietzsche stesso nella prefazione: forse di questi non ne vive ancora uno. Nietzsche era profondamente convinto che il cristianesimo fosse nato e fosse morto anche se la sua agonia é durata 2000 anni, quando i discepoli di Gesù non hanno perdonato i suoi nemici. L’argomentazione di questa tesi, prende le mosse dalla convinzione che per il cristianesimo: “E’ in sè completamente indifferente il fatto che una cosa sia vera o no, ma é estremamente importante, invece, fino a che punto sia creduta. Così ad esempio, se é insita una felicità nei credenti redenti dal peccato, come premesse di ciò, non é necessario che l’uomo sia peccatore, ma che si senta peccatore.” In questo modo il cristianesimo ha sostituito la verità con la fede che qualcosa sia vero. Anzi alla ricerca della verità ha posto un “divieto”, e ha sostituito questa, che é la più autentica delle virtù, con le virtù teologali: fede, speranza e carità, che sono 3 “accorgimenti” a cui il cristianesimo é ricorso per distogliere l’uomo dalla ricerca della verità, e poterlo così “signoreggiare, addomesticare, dominare”.
A che scopo i Greci? A che scopo i Romani?
L’intero lavoro del mondo antico per nulla: non trovo parole per esprimere il mio sentimento davanti a qualcosa di così mostruoso. – E in considerazione del fatto che il suo era lavoro preparatorio, che quella gettata con granitica presunzione era appunto solo l’infrastruttura di un lavoro millenario, l’intero senso del mondo antico fu vano!… A che scopo i Greci? A che scopo i Romani? – Tutte le premesse per una civiltà colta, tutti i metodi scientifici erano già là, si era già affermata la grande, l’incomparabile arte di ben leggere – questo presupposto per la tradizione della cultura, per l’unità della scienza; la scienza della natura, unita con la matematica e la meccanica, era sulla migliore delle strade – il senso dei fatti, l’ultimo e più prezioso di tutti i sensi, aveva le sue scuole, la sua tradizione vecchia ormai di secoli! Ci rendiamo conto di ciò? Tutto l’essenziale era trovato, per potersi accingere al lavoro: i metodi, si deve dirlo dieci volte, sono l’essenziale, anche la cosa più difficile, anche quella che ha più a lungo contro di sé abitudini e pigrizie. Ciò che noi oggi, con assoluto autodominio, – poiché noi tutti abbiamo ancora in qualche modo nel nostro sangue i cattivi istinti, quelli cristiani – ci siamo riconquistati, lo sguardo aperto alla realtà, la mano prudente, la pazienza e la serietà nelle più piccole cose, l’intera rettitudine della conoscenza – esisteva già! già più di duemila anni fa! E per di più il tatto e il gusto buono e fine!
Non come addestramento mentale! Non come educazione “tedesca”, con maniere da villani! Ma come corpo, come gesto, come istinto – in una parola, come realtà… Tutto invano Nel giro di una notte, nulla più che un ricordo! – Greci! Romani! La nobiltà dell’istinto, il gusto, la ricerca metodica, il genio dell’organizzazione e dell’amministrazione, la fede, la volontà d’avvenire umano, il grande sì a tutte le cose visibile nella forma di imperiimi romanum, visibile a tutti i sensi, lo stile grande non più solo arte, ma diventato realtà, verità, vita…
E non seppellito nel giro di una notte per un evento naturale! Non calpestato da Germani e altri plantigradi! Devastato invece da astuti, occulti, invisibili, anemici vampiri! Non vinto – solo dissanguato!… La nascosta sete di vendetta, l’invidia piccina diventa padrona! Tutto ciò che è miserevole, che soffre di sé, che è travagliato da cattivi sentimenti, l’intero mondo da ghetto dell’anima, d’un colpo portato in alto. – Non v’è che da leggere un qualsiasi agitatore cristiano, sant’Agostino per esempio, per capire, per fiutare che razza di immondi compari sono in tal modo venuti a galla. C’inganneremmo in tutto e per tutto se si presumesse nei capi del movimento cristiano un qualche difetto d’intelletto: sono avveduti, oh se sono avveduti fino alla santità, i signori Padri della Chiesa! Ciò che manca loro è ben altro. La natura li ha trascurati – essa dimenticò di donar loro una dote modesta di istinti rispettabili, decenti, puliti…
Detto in confidenza, questi non sono nemmeno dei maschi… Quando l’Islam disprezza il cristianesimo, ha mille volte ragione di farlo: l’Islam ha dei maschi per presupposto…
Purtroppo non è solo il discorso di uno psicopatico…
Presento un paio di saggi di ciò che questa gentucola si è messa in testa, di quello che ha messo in bocca al proprio maestro: semplici professioni di fede di “anime belle”.
“E se taluni non vi vogliono ricevere ne ascoltare, allontanatevi da loro e scuotete la polvere dai vostri piedi, per fare testimonianza contro di loro. Io vi dico: in verita Sodoma e Gomorra nel giudizio finale saranno trattate meno dura-mente di una simile citta” (Marco 6, 11). – Com’e evangelico!…
“E se taluno scandalizzerà uno dei piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina e fosse scagliato in mare” (Marco 9, 42). – Com’e evangelico!… “Se il tuo occhio ti dà scandalo, strappalo; e meglio per te entrare, con un occhio solo, nel regno di Dio, che avere due occhi ed essere gettato nel fuoco dell’inferno; dove il verme non muore e il fuoco non si spegne mai” (Marco 9, 47). – Non è precisamente all’occhio che si allude…
“In verità vi dico, qui ci sono alcuni che non gusteranno la morte prima di vedere il regno di Dio giungere con forza” (Marco 9, 1). – Si mente bene, leone…
“Chi mi vuol seguire, rinneghi se stesso e prenda la sua croce sopra di sé e mi segua. Perché…” (Nota di uno psicologo. La morale cristiana è confutata dai suoi perché: i suoi “motivi” confutano, – questo è cristiano), (Marco 8, 34).
“Non giudicate, affinché non siate giudicati. Con la misura con cui voi giudicherete, si farà giudizio di voi” (Matteo 7, 1). – Che concezione della giustizia, di un giudice “giusto”!…
“Se voi amate coloro che vi amano, quale ricompensa riceverete per questo! Non fanno lo stesso anche i pubblicani? E se vi comportate da amici coi vostri fratelli, che cosa fate di strano? Non fanno così anche i pubblicani?” (Matteo 5, 46). – Principio dell'”amore cristiano”: in fin dei conti vuol essere pagato bene…
“Ma se voi non perdonate agli uomini le loro colpe, anche vostro Padre non perdonerà a voi” (Matteo 6, 15). – Molto compromettente per il detto “padre”…
“Cercate in primo luogo il regno di Dio e la sua giustizia, e tutto il resto vi sara dato” (Matteo 6, 33). – Tutto ciò: cioè cibo, vestiario, tutto quanto e più necessario nella vita. Un errore, a dir poco… Subito dopo Dio appare in qualita di sarto, perlomeno in certi casi…
“Rallegratevi allora e saltate: perché ecco, il vostro premio in cielo e grande. Lo stesso fecero i vostri padri ai profeti” (Luca 6, 23). Branco di svergognati! Già si paragonano ai profeti… “Non sapete che voi siete il tempio di Dio, e che lo spirito di Dio abita in voi? Se taluno guasterà il tempio di Dio, Dio guasterà lui, poiché il tempio di Dio, che voi stessi siete, è santo” (Paolo, I Corinzi 3, 16). – Non si disprezzerà mai abbastanza roba del genere… “Non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? E se il mondo deve essere giudicato da voi, non siete voi idonei abbastanza a giudicare cose minori?” (Paolo, I Corinzi 6, 2). Purtroppo non è solo il discorso di uno psicopatico… Questo spaventoso impostore prosegue testualmente: “Non sapete, che noi giudicheremo gli angeli? Quanto piu dunque giudicheremo dei beni temporali!”…
“Non ha Dio cambiato in follia la saggezza di questo mondo? Poiché, non avendo il mondo con la sua saggezza riconosciuto Dio nella sua saggezza, e piaciuto a Dio di rendere beati, con una folle predicazione, coloro che credono in lui… Non sono eletti molti saggi secondo la carne, né molti potenti, ne molti nobili. Ma ciò che è folle agli occhi del mondo, fu eletto da Dio, per svergognare i saggi; e chi è debole agli occhi del mondo fu eletto da Dio per svergognare chi è forte. E chi agli occhi del mondo e ignobile e disprezzato fu eletto da Dio, e chi non è niente, per rendere niente chi è qualche cosa. Affinché al suo cospetto nessuna came si vantasse” (Paolo, i Corinzi 1, 20 ss.). – Per intendere questo passo, testimonianza di primissimo ordine sulla psicologia di ogni morale da Ciandala, si legga la prima dissertazione nella mia Genealogia della Morale: in essa, per la prima volta, veniva messa in luce la contrapposizione tra una morale nobile e una morale da Ciandala nata sul risentimento e sulla sterile vendetta. Paolo fu il maggiore fra tutti gli apostoli della vendetta…
Per preti e dèi è finita quando l’uomo diventa scientifico
Abbiamo veramente capito la famosa storia che sta all’inizio della Bibbia, – a proposito della dannata paura di Dio di fronte alla scienza?
Non l’abbiamo capita. Questo libro di preti par excellence ha inizio, come si conviene, con la grande difficoltà interiore del prete: per lui c’è solamente un grande pericolo, di conseguenza per “Dio” c’è solamente un grande pericolo.
II vecchio Dio, tutto “spirito”, tutto sommo sacerdote, tutto perfezione, va a spasso nel suo giardino: solo che si annoia. Contro la noia lottano invano perfino gli dèi. Che cosa fa lui? Inventa l’uomo, l’uomo è divertente… Ma, guarda un po’, anche l’uomo s’annoia. La pietà di Dio per l’unica miseria che tutti i paradisi comportano, è sconfinata: tosto egli creò anche altri animali.
Primo passo falso di Dio: l’uomo non trovò divertenti gli animali – dominava su di loro, non voleva essere neppure “animale”. – Allora Dio creò la donna. E in effetti a quel punto con la noia fu finita, – ma anche con qualcos’altro! La donna fu il secondo passo falso di Dio. – “La femmina è per sua natura serpente: Eva” – ogni prete lo sa; “ogni malanno al mondo viene dalla femmina” – anche questo sa ogni prete. “Da essa viene quindi anche la scienza“…
Solo attraverso la donna l’uomo apprese ad assaggiare i frutti dell’albero della conoscenza. – Che cosa era successo? Il vecchio Dio fu preso da una dannata paura. L’uomo stesso era divenuto il suo più grande passo falso, egli si era creato un rivale, la scienza rende simili a Dio, – per preti e dèi è finita quando l’uomo diventa scientifico! – Morale: la scienza è il proibito in sé, – essa sola è proibita. La scienza è il primo peccato, il seme di tutti i peccati, il peccato originale. La morale è soltanto questo. – “Tu non devi conoscere“: – il resto consegue da ciò. – La dannata Paura non impedì a Dio di essere furbo. Come ci si difende dalla scienza? Per lungo tempo questo divenne il suo primo problema. Risposta: fuori l’uomo dal paradiso!
La felicità, l’ozio inducono a pensare – tutti i pensieri sono cattivi pensieri… L’uomo non deve pensare. – E il “prete in sé” inventa il bisogno, la morte, il pericolo mortale della gravidanza, ogni sorta di miseria, vecchiaia, fatica, la malattia soprattutto – nient’altro che strumenti della lotta contro la scienza! Il bisogno non consente all’uomo di pensare… E a onta di ciò, che orrore! L’opera della conoscenza s’innalza torreggiante, invadendo il ciclo, oscurando gli dèi – che fare? – II vecchio Dio inventa la guerra, divide i popoli, fa sì che gli uomini si annientino a vicenda ( – i preti hanno sempre avuto bisogno della guerra…). La guerra – grande guastafeste della scienza, tra l’altro! Incredibile! La conoscenza, l’emancipazione dal prete, avanza perfino a dispetto delle guerre. – E al vecchio Dio si presenta una decisione estrema: “l’uomo è divenuto scientifico, – non c’è altro da fare, bisogna annegarlo.”…
La psicologia del prete: il prete domina grazie all’invenzione del peccato
Mi avete capito. L’inizio della Bibbia contiene l’intera psicologia del prete. – II prete conosce solo un grande pericolo: la scienza – la sana nozione di causa ed effetto. Ma la scienza prospera totalmente solo in condizioni fortunate – bisogna aver tempo, bisogna avere spirito in eccedenza, per “conoscere”… “Dunque bisogna rendere l’uomo infelice” – questa, in ogni tempo, fu la logica del prete. – Già si indovina che cosa, innanzitutto, coerentemente a questa logica, è venuto con ciò al mondo: il “peccato”… È l’invenzione del concetto di colpa e punizione, dell’intero “ordine morale del mondo” a porsi contro la scienza – contro l’affrancamento dell’uomo dal prete… Non fuori, ma dentro di sé deve guardare l’uomo; non deve, come il discente, guardare con sagacia e prudenza nelle cose; non deve in generale guardare per nulla: deve soffrire… e deve soffrire in guisa tale da aver sempre bisogno del prete.
– Basta coi medici! Un salvatore ci vuole. – II concetto di colpa e di castigo, ivi compresa la dottrina della “grazia”, della “redenzione”, del “perdono” – menzogne da cima a fondo e senza alcuna realtà psicologica – sono inventate apposta per distruggere il senso di causalità dell’uomo: sono l’attentato contro il concetto di causa ed effetto! – E non un attentato col pugno, col coltello, con sincerità nell’odio e nell’amore! Ma partendo dagli istinti più vili, più subdoli, più bassi! Un attentato da preti! Un attentato da parassiti! Un vampirismo di livide sanguisughe del sottosuolo!… Quando le naturali conseguenze di un’azione non sono più “naturali”, ma vengono attribuite dal pensiero agli spettri concettuali della superstizione, a “Dio”, agli “spiriti”, alle “anime”, come conseguenze puramente “morali”, come premio, castigo, avvertimento, mezzi educativi, allora la premessa della conoscenza è distrutta – allora si è commesso il più grande crimine contro l’umanità. – Il peccato, ripeto, questa forma autolesionista, par excellence dell’uomo, è inventato per rendere scienza, cultura, ogni innalzamento e nobiltà dell’uomo, impossibili; il prete domina grazie all’invenzione del peccato.
Essa creò miserie per perpetuare se stessa…
Con ciò sono alla conclusione e pronuncio il mio giudizio. Condanno il cristianesimo, levo contro la Chiesa cristiana l’accusa più spaventosa che mai sia uscita dalla bocca di un accusatore. Essa è per me, la suprema tra tutte le corruttele immaginabili, essa ha avuto la volontà della estrema possibile corruttela. La Chiesa cristiana, con la sua depravazione, non lasciò nulla d’intatto, essa ha fatto d’ogni valore un non-valore, di ogni verità una menzogna, d’ogni rettitudine un’infamia dell’anima. Che osino parlarmi ancora delle sue benemerenze “umanitarie”!
Il sopprimere una qualsiasi miseria andava contro la sua più profonda utilità: essa visse di miserie, essa creò miserie per perpetuare se stessa… Il verme del peccato, per esempio: solo la Chiesa ha arricchito l’umanità con questa miseria! – L’eguaglianza delle anime davanti a Dio”, questa falsità, questo pretesto per le rancunes d’ogni anima vile, questo esplosivo concettuale, il quale alla fine si è fatto rivoluzione, idea moderna e principio di decadimento per l’intero ordine sociale – è dinamite cristiana… Benemerenze “umanitarie” del cristianesimo! Far crescere dalla humanitas un’autocontraddizione, un’arte dell’autolesionismo, una volontà di menzogna ad ogni costo, una avversione, un disprezzo per tutti i buoni e retti istinti! – Queste sarebbero le benedizioni del cristianesimo, per me!
– II parassitismo come unica prassi della Chiesa; che col suo ideale anemico di “santità” beve fino all’ultima goccia ogni sangue, ogni amore, ogni speranza di vivere: l’ai di là come volontà di negazione d’ogni realtà; la croce quale segno di riconoscimento per la più sotterranea congiura mai esistita – contro salute, bellezza, costituzione bennata, coraggio, spirito, bontà dell’anima, contro la vita medesima…
Questa eterna accusa al cristianesimo io voglio scrivere su tutti i muri ovunque siano muri – possiedo caratteri per far vedere anche i ciechi… Io chiamo il cristianesimo unica grande maledizione, unica grande intima perversione, unico grande istinto di vendetta, per il quale nessun mezzo è abbastanza velenoso, occulto, sotterraneo, piccino – io lo chiamo unico imperituro marchio d’abominio dell’umanità…
E noi computiamo il tempo a partire dal dies nefastus con cui questa calamità principiò – dal primo giorno del cristianesimo! -Perché non piuttosto dal suo ultimo! – Da oggi! – Trasvalutazione di tutti i valori!
LEGGE CONTRO IL CRISTIANESIMO
Data nel dì della salute, nel primo giorno dell’anno
uno (- il 30 settembre 1888 della falsa cronologia)
Guerra mortale contro il vizio:
il vizio è il Cristianesimo
Prima proposizione.
– Viziosa è ogni specie di contronatura. La più viziosa specie d’uomo è il prete; egli insegna la contronatura. Contro il prete non si hanno motivi, si ha la prigione.
Seconda proposizione.
– Partecipare ad un ufficio divino è un attentato alla pubblica moralità. Si deve essere più severi contro i protestanti che contro i cattolici, più severi contro i protestanti liberati che contro quelli di stretta osservanza. Il delittuoso dell’esser cristiani cresce vieppiù ci si avvicini alla scienza. Il criminale dei criminali è quindi il filosofo.
Terza proposizione.
– Il luogo esecrando in cui il cristianesimo ha covato le sue uova di basilisco sia distrutto pietra su pietra e sia il terrore di tutta la posterità quale luogo abominevole della terra. Su di esso si allevino serpenti velenosi.
Quarta proposizione.
– La predicazione della castità è istigazione pubblica alla contronatura. Ogni disprezzo della vita sessuale, ogni contaminazione della medesima mediante la nozione di “impurità” è vero e proprio peccato contro il sacro spirito della vita.
Quinta proposizione.
– Chi mangia alla stessa tavola di un prete sia proscritto: con ciò egli si scomunica dalla retta società. Il prete è il nostro Ciandala – lo si deve mettere al bando, affamare, menare in ogni specie di deserto.
Sesta proposizione.
Si chiami la storia “sacra” col nome che merita in quanto storia maledetta; le parole “Dio”, “salvatore”, “redentore”, “santo” siano usate come oltraggi, come epiteti da criminali.
Settima proposizione.
Il resto è conseguenza.
LA VOLONTA’ DI POTENZA
Saggio di una trasmutazione di tutti i valori
“La volontà di potenza” é un insieme di scritti nietzscheani raccolti (1901) dalla sorella Elisabeth e dal discepolo e copista Peter Gast, raccolti in modo arbitrario e condizionato dalle simpatie razziste e autoritarie. Tuttavia non é per questo che si può accusare eccessivamente la sorella-parafulmine, sostenendo che Nietzsche non avrebbe mai scritto un’opera così: essa, in linea di massima, rispecchia le idee del filosofo tedesco, se facciamo eccezione per alcune manomissioni di forte sapore nazista. “La volontà di potenza” può essere considerata come grande summa del pensiero nietzscheano: e le troviamo davvero tutte le sue teorie, dalla volontà di potenza (che dà il nome all’opera), all’eterno ritorno, al nichilismo, al binomio apollineo-dionisiaco, al superuomo. In realtà quest’opera corposa si suddivide in 4 libri:
| Libro 1 | Il nichilismo europeo |
| Libro 2 | Critica dei valori supremi finora riconosciuti |
| Libro 3 | Principio di una nuova posizione di valori. |
| Libro 4 | Disciplina e selezione |
La forma predominante é quella, tipicamente nietzscheana, dell’aforisma. Il primo libro si apre con la constatazione che “il nichilismo é davanti alla porta […] in una interpretazione determinata, in quella della morale cristiana sta il nichilismo” : é proprio il “tramonto del cristianesimo” che ha aperto la porta al nichilismo, ossia alla perdita di tutti i valori, perfino la nozione di bene e di male. Del resto non poteva perdurare oltre la morale cristiana, morale “che si volge contro il Dio cristiano (il senso della veracità, altamente sviluppato dal cristianesimo, prova nausea di fronte alla falsità e alla menzogna di tutte le interpretazioni cristiane del mondo e della storia)”. Ecco che ora viene a sostituirsi all’esecrabile morale cristiana la morale secondo la quale tutto é privo di senso, “tutte le interpretazioni del mondo sono false”. Il nichilismo, in altre parole, é la conseguenza dell’interpretazione dei valori dell’esistenza, finora ammessa. Nichilismo significa che “i valori supremi sono svalutati. Manca lo scopo. Manca la risposta alla domanda: dove?”. Ma Nietzsche non si limita a criticare il cristianesimo in tutto e per tutto e gli riconosce qualche merito, ad esempio l’aver per molto tempo fornito all’uomo un valore assoluto, o l’aver fatto apparire il male pieno di significato, o ancora l’aver impedito all’uomo di disprezzarsi come tale: “In summa: la morale fu il grande antidoto contro il nichilismo teorico e pratico“. Il nichilismo stesso, spiega Nietzsche, ha come premessa che non vi sia verità alcuna, che non esista una assoluta natura delle cose, quelle che Platone chiamava “cose in sè”: si é stati sempre portati a credere che esistessero dei valori (questo é bene, quest’altro no), ma il nichilismo porta a considerare gli uomini stessi come fissatori dei valori. “Il nichilista filosofo é persuaso che tutto ciò che accade é privo di senso e invano”: ma il nichilismo non é altro che un’espressione della decadenza che sta investendo il mondo, una decadenza che ha le sue pesanti conseguenze ( lo scetticismo, il libertinaggio dello spirito, la corruzione dei costume, i metodi di cura psicologici e morali). Ma dire che é espressione, non significa dire che ne é causa: esso é solo la “logica” della decadenza, i cui tipi principali sono la perdita della forza per reagire agli stimoli o lo scambiare la causa con l’effetto il sentire la vita come base del male. Tutti i supremi giudizi di valore finora ammessi sono riconducibili a “giudizi degli esauriti”: si chiamò Dio ciò che indebolisce e l'”uomo buono” é una forma di autodecadenza. Ma Nietzsche si oppone con vigore: “Io insegno a dir no a tutto ciò che rende debole; io insegno a dir sì a tutto ciò che rafforza, che accumula energia, che giustifica il sentimento della forza”: il suo é un volersi opporre ai deboli, agli stanchi di vivere, alle masse che seguono la morale cristiana e socialista (“l’istinto del gregge”). E contro il socialismo, che nell’Ottocento andava sempre più affermandosi, Nietzsche muove un’aspra polemica: ” che altro é se non una balorda incomprensione di quell’ ideale morale cristiano ? … ci saranno sempre troppi possidenti perchè il socialismo possa significare altro che un attacco di malattia ; e questi possidenti sono come un uomo di una fede : si deve possedere qualche cosa per essere qualche cosa . Ma questo é il più vecchio e il più sano di tutti gli istinti : io aggiungerei : si deve voler avere di più di quanto si ha , per diventare di più … Nella dottrina del socialismo si nasconde malvagiamente una volontà di negare la vita…“. E non é questo che vuole Nietzsche: nello Zarathustra, egli invitava a restare fedeli alla Terra, non facendosi ingannare da promesse ultraterrene, e anche qui in fondo é lo stesso: occorre amare la vita e la terra, proprio come farà il superuomo (quando ve ne sarà uno). Ed emerge l’aristocrazia di cui si fa portavoce il pensatore tedesco, a discapito delle masse democratiche e socialisteggianti: non é nella massa che vanno riposte le speranze, ma nei singoli! Il libro secondo de “La volontà di potenza” é dedicata alla critica dei valori supremi finora riconosciuti e si apre, come c’era da aspettarsi, con una critica alla religione, come svalutazione dell’uomo, impotente di fronte ad un ipotetico Dio: “Tutta la bellezza e la magnificenza che abbiamo prestato alle cose reali e immaginate , io voglio rivendicarla come proprietà e opera dell’ uomo : come la sua più bella apologia . L’ uomo come poeta, pensatore , Dio , amore , forza ; ammiriamo la sua regale generosità , con cui ha fatto doni alle cose per impoverire se stesso e sentirsi miserabile ! Finora il suo maggiore disinteresse fu questo , che egli ammirò e adorò e seppe nascondere a se stesso che egli stesso aveva creato ciò che ammirava.” La religione, secondo il filosofo tedesco, nasce per errore ed ignoranza dell’uomo: allo stesso modo in cui ancor oggi esso ritiene che la collera sia la causa del suo adirarsi o che lo spirito sia la causa del suo pensare, così in tempi lontanissimi, a un livello ancora più ingenuo, egli spiegò quei medesimi fenomeni con l’aiuto di entità divine. L’idea che ogni cosa sia causata da un Dio, non fa che sminuire l’uomo, che finisce per non essere la causa di nulla: la conseguenza é che l’uomo non ha osato attribuire a sè (come era giusto invece fare) ogni avvenimento; ne consegue che per Nietzsche la religione é “il parto mal riuscito di un dubbio sull’unità della persona […] per cui tutto ciò che nell’uomo é grande e forte fu concepito dall’uomo come sovraumano, come estraneo; […] la religione ha abbassato il concetto di uomo“. Ma l’invenzione della religione, e se ne accorge anche Marx, può avere anche un’altra funzione oltre a quella di spiegare fenomeni cui non si trova una risposta: é uno dei mezzi con cui “si può fare degli uomini ciò che si vuole: purchè si possegga un eccesso di forze creatrici e si possa imporre la propria volontà per lunghi periodi di tempo“: sì, perchè si deve avere la forza creatrice per inventare un Dio e la forza materiale per imporlo. Ma Nietzsche, pur aborrendo il Cristianesimo, non può non provare simpatia nella figura del Cristo, non tanto come “uomo della morale”, quanto piuttosto come uomo dal senso di giustizia: e del resto “La Chiesa é esattamente ciò contro cui Gesù predicò e contro cui insegnò ai suoi discepoli a combattere“. La vita esemplare non é quella sostenuta dal Cristianesimo: per Nietzsche, al contrario ( ed é bene aggiungere “al contrario”, visto e considerato l’atteggiamento cristiano nei secoli) “La vita esemplare consiste nell’amore e nell’umiltà; nella pienezza di cuore, che non esclude nemmeno l’infimo; nel rinunciare completamente al voler avere ragione, a difendersi, a vincere nel senso del trionfo personale; nel credere alla felicità quaggiù, sulla terra, nonostante la miseria, le avversità e la morte; nel riconciliarsi con il prossimo, nell’astenersi dalla collera e dal disprezzo; nel non volere ricompense; nel non legarsi a nessuno; nel non avere signori in senso spirituale e più che spirituale; in una vita molto fiera posta sotto il segno della volontà e di una vita povera e servizievole“. Il cristianesimo per Nietzsche é una “religione per masse volgari”, un cercare di equiparare tutti, un nascondere la superiorità di certi individui su altri dietro l’usbergo dell’uguaglianza nell’altra vita; l’ideale cristiano, poi, fa sempre presa sui “falliti”, coloro che non riescono ad affermarsi e han bisogno di protezione e di una beatitudine futura: “L’uomo superiore si distingue dall’inferiore per la sua intrepidezza e la sua sfida alla sventura; […] il cristianesimo con la sua prospettiva di beatitudine é un modo di pensare tipico di un genere di uomini sofferenti e impoveriti“. La conclusione cui giunge Nietzsche é che il cristianesimo vada abbattuto, ed egli é peraltro convinto (a ragion veduta) che nel secolo venturo (1900) esso si sgretolerà definitivamente. La seconda critica ai valori supremi é indirizzata alla morale (“per morale intendo un sistema di valutazioni che aderisce alle condizioni di vita di una creatura“): “La costante della storia europea dopo Socrate é il tentativo di ricondurre i valori morali a dominare tutti gli altri valori; e in modo tale che debbano essere guide e giudici non solo della vita, ma anche della conoscenza, delle arti, delle aspirazioni politiche e sociali; […] l’intera morale dell’Europa ha per base ciò che giova al gregge: […] quanto più una qualità del gregge appare pericolosa, tanto più sistematicamente ottiene considerazione“. Il problema che si pone Nietzsche é di farci capire che un bene e un male assoluti non ci sono, non sono quelli fissati da Dio (che é morto): egli é consapevole che non tutti possono capirlo e soprattutto non vogliono: il gregge (ossia le masse volgari) non potranno mai afferrare il messaggio nietzscheano: “La mia filosofia é orientata verso la gerarchia: non verso una morale individualistica. Il modo gregario di sentire deve regnare nel gregge, ma non fuori di esso.“. Ma che senso può avere dire ad uno, secondo i dettami della morale, “devi essere così” ? “Un uomo quale deve essere: questa frase ci suona tanto sciocca quanto quest’altra: un albero, quale deve essere”. Ma Nietzsche va contro la morale, la ribalta, in lui vi é una trasvalutazione di tutti i valori morali tradizionali: Oggi, quando ogni “l’uomo deve essere così e così” ci strappa una leggera ironia e teniamo per fermo che un uomo, a dispetto di tutto, diventa soltanto quello che é già, nelle cose della morale abbiamo appreso a capovolgere in modo curioso il rapporto di causa ed effetto“. Ma in fin dei conti cosa é nella morale che dà fastidio a Nietzsche? “La morale sostiene di sapere qualcosa, cioè che cosa sia buono o cattivo. Questo significa voler sapere a quale scopo l’uomo esista, conoscerne la meta, la destinazione.” Ma Nietzsche muove una critica non solo ai preti e agli uomini “buoni”, ma anche ai filosofi e alle loro superstizioni: il grande bersaglio di Nietzsche é Socrate, che ha introdotto il concetto di uomo virtuoso: ma per il pensatore tedesco un uomo già per il fatto di essere detto virtuoso, ossia di essere ricondotto ad uno “schema”, é inferiore! Anche Kant viene aspramente criticato, con la sua legge morale. Ne consegue che “I veri filosofi (dei Greci) sono quelli che precedono Socrate…” e le simpatie di Nietzsche si soffermano sulla figura dello scettico Pirrone di Elide. Pirrone era convinto, da buono scettico, dell’inesistenza di una verità assoluta: e l’errore dei filosofi sta proprio nell’aver creduto che ve ne fosse una: “Che cosa é verità? Inerzia,l’ipotesi che ci rende soddisfatti;il minimo dispendio di forza intellettuale“. Ecco allora che, smontata la morale tradizionale, nel terzo libro della “Volontà di potenza” Nietzsche si ingegna nel porre il principio di una nuova posizione di valori: avvia la sua riflessione sulla “volontà di potenza come conoscenza”, prendendo i considerazione i metodi finora usati dai filosofi; vi é una radicale critica all’ “io” di Cartesio e Kant: Nietzsche sembra abbracciare le posizioni di Hume, il quale intendeva l’io come “fascio di percezioni” : l’io non esiste, noi siamo solo il punto di incontro di percezioni, un punto di incontro in cui si estrinseca la volontà di potenza, di dominare sugli altri. E finalmente Nietzsche giunge ad una definizione di verità, o almeno, del criterio con cui raggiungerla: “Il criterio della verità si trova nell’aumento della sensazione di potenza“. Radicale é la critica al determinismo: “La necessità non é uno stato di fatto, ma un’interpretazione“. E Nietzsche sembra anche sostenere la tesi dell’inconoscibilità: “Conoscere é un riportare qualcosa a qualcos’altro: é per sua natura un regressus in infinitum. Ciò che si ferma é la pigrizia, la stanchezza“. Ed ecco che subentra in tutta la sua vitalità la volontà di potenza: Si deve trasformare la credenza “é così e così” nella volontà “deve diventare così e così”. E sull’interpretazione del mondo Nietzsche critica il meccanicismo di matrice cartesiana , rifiutando il concetto stesso di atomo. Ma c’é anche una aspra polemica nei confronti di Darwin, che si ritrova anche nel quarto e ultimo libro della Volontà di potenza, “Disciplina e selezione”: “L’uomo come specie non é in progresso. Si raggiungono bensì tipi superiori, ma non si conservano; […] l’uomo come specie non rappresenta un progresso in confronto con qualsiasi altro animale“. Tutto il 4° libro é dedicato appunto alla selezione e alla disciplina: al rapporto tra l’uomo forte e l’uomo debole, tra gli uomini superiori e le masse; sono passi in cui il linguaggio di Nietzsche assurge a toni altisonanti, forti ed intransigenti: “I diritti che un uomo si prende sono proporzionali ai doveri che si impone, ai compiti rispetto a cui si sente all’altezza. La maggioranza degli uomini non ha diritto all’esistenza, ma costituisce una disgrazia per gli uomini superiori; […] quando mancano gli uomini superiori, si rendono semidei o dei i grandi uomini del passato; […] la tirannia é un affare da uomini grandi: questi fanno fessi gli uomini dappoco. […] nel Teagete di Platone compare la frase: ognuno vorrebbe poter essere il signore di tutti gli uomini, e magari Dio. Questa mentalità deve tornare ad esistere.[…] La massima elevazione della consapevolezza della propria forza nell’uomo é ciò che crea il superuomo.“. E torna ancora una volta la contrapposizione tra ciò che é aristocratico e ciò che non lo é, contrapposizione particolarmente cara a Nietzsche. Nel libro quarto, “disciplina e selezione”, Nietzsche mette poi ancora una volta a confronto de due divinità, il Cristo dei Cristiani e il Dioniso dei Greci; lo scetticismo radicale che erode le fondamenta metafisiche e cristiane della cultura occidentale, a parere di Nietzsche, va portato fino in fondo, affinchè l’umanità sappia creare un “nuovo Dio” che Nietzsche indica in Dioniso, contrapposto non più ad Apollo, come nell’antica Grecia, ma al Crocefisso. Quindi un Dio della natura e della gioia di vivere, nei limiti che la natura concede, contro il Dio della trascendenza e della glorificazione della sofferenza che abita quel “mondo dietro il mondo” che Platone da un lato e il cristianesimo dall’altro hanno inaugurato: “I due tipi: Dioniso e il Crocifisso. Da stabilire: il tipico uomo religioso è una forma di dècadence (i grandi innovatori sono, tutti insieme e uno per uno, malati ed epilettici)? Così non lasciamo da parte un tipo dell’uomo religioso, il tipo pagano? Il culto pagano non è una forma di riconoscenza alla vita e di affermazione della vita? Il suo supremo rappresentante non dovrebbe essere un’apologia e una divinizzazione della vita? Un tipo di spirito ben riuscito e traboccante, estatico… Un tipo di spirito che accoglie in sé le contraddizioni e i problemi della vita, e li redime? Qui io pongo il Dioniso dei Greci: l’affermazione religiosa della vita, della vita intera, non negata né dimezzata; che l’atto sessuale susciti pensieri di profondità, di mistero, di rispetto, è tipico. Dioniso contro il Crocifisso: eccovi il contrasto. Non è una differenza nel martirio: piuttosto, il martirio ha un altro senso. In un caso, la vita stessa, la sua eterna fecondità e il suo ritornare determina il tormento, la distruzione, la volontà di annientamento… Nell’altro, la sofferenza, il Crocifisso come innocente, è un’obiezione contro questa vita, è la formula della sua condanna. E si capisce: il problema è quello del senso della sofferenza: o un senso cristiano o un senso tragico. Nel primo caso la sofferenza è la via che conduce ad un’esistenza beata; nel secondo, si ritiene che l’essere sia abbastanza beato da giustificare anche una sofferenza mostruosa. L’uomo tragico approva anche la sofferenza più aspra: è abbastanza forte, ricco, divinizzatore per farlo; il cristiano dice di no anche alla sorte più felice che ci sia sulla terra: ed è abbastanza debole, povero, diseredato per soffrire della vita in ogni sua forma… il Dio in croce è una maledizione scagliata sulla vita, un dito levato a comandare di liberarsene- Dioniso fatto a pezzi è una promessa di vita; la vita rinasce in eterno e ritornerà in patria, tornerà alla distruzione.” E nell’ultima parte, dulcis in fundo, il pensatore tedesco ci ripresenta l’eterno ritorno, centrale nella sua filosofia, il “cerchio dell’essere”. E per sopportare il pensiero di un eterno ed infinito ritorno é necessario essere liberi dalla morale, fare una trasmutazione di tutti i valori. “Io voglio insegnare il pensiero che dà a molti il diritto di sopprimersi-il grande pensiero che seleziona e disciplina“. E celebre per la sua forza espressiva é la chiusura del libro: “E sapete voi che cosa é per me il mondo? Devo mostrarvelo nel mio specchio? Questo mondo é un mostro di forza, senza principio, senza fine, una quantità di energia fissa e bronzea, che non diventa nè più piccola nè più grande, che non si consuma, ma solo si trasforma, che nella sua totalità é una grandezza invariabile […] Questo mio mondo dionisiaco che si crea eternamente, che distrugge eternamente se stesso, questo mondo misterioso di voluttà ancipiti, questo mio al di là del bene e del male, senza scopo, a meno che non ci sia uno scopo nella felicità del ciclo senza volontà, a meno che un anello non dimostri buona volontà verso di sè, per questo mondo volete un nome?Una soluzione per tutti i suoi enigmi? E una luce anche per voi, i più nascosti, i più forti, i più impavidi, o uomini della mezzanotte? Questo mondo é la volontà di potenza e nient’altro! E anche voi siete questa volontà di potenza e nient’altro!“
ECCE HOMO
come si diviene ciò che si é
“Ecce homo” é la grande biografia di Federico Nietzsche, il testo con cui egli si presenta una volta per tutte al suo popolo di lettori: nell’inoltrarsi dell’autunno del 1888, egli decide di dar vita in una sola settimana al libro conclusivo della sua opera, con cui fornisce una spiegazione anche degli altri testi. Ne parla agli amici, a Gast, a Overbeck come di un preludio alla grande opera della trasvalutazione di tutti i valori e annuncia con tono apocalittico che fra un paio di anni il mondo sarà in convulsioni. La previsione della crisi era esatta, sebbene il tempo ne fosse anticipato, poichè si può veramente dire che la crisi iniziata nel 1914 é la stessa che Nietzsche si attendeva. E in “Ecce homo” Nietzsche riprende tutte le sue teorie classiche, dall’eterno ritorno all’attacco al cristianesimo; ma quest’opera é un qualcosa di più che una semplice autobiografia, é più un’interpretazione della propria vita e della propria opera; la ragione dello scritto la enuncia Nietzsche stesso nelle sue lettere indirizzate agli amici: riteneva necessario di presentarsi e di precisare il suo essere prima di compiere l’atto della trasmutazione di tutti i valori. E così scrive appunto nella prefazione di “Ecce homo”: “Poichè prevedo che fra breve dovrò presentarmi all’umanità col più grave problema che le sia mai stato posto, mi pare indispensabile dire chi sono. […] Io non sono affatto un orco, un mostro di immoralità: sono il contrario di quella specie d’uomo che finora é stata onorata come virtuosa.[…] Sono un discepolo del filosofo Dioniso, preferirei essere un satiro piuttosto che un santo. […] L’ultima cosa che io mi sognerei di promettere sarebbe di migliorare l’umanità. Io non innalzo nuovi idoli; gli antichi forse potrebbero imparare da me che cosa significhi avere i piedi d’argilla. Rovesciare gli idoli- così io chiamo gli ideali- ecco il mio compito.[…] Chi sa respirare l’aria che circola nei miei scritti, sa che é l’aria delle grandi altezze, che é un’aria fine. […] La filosofia nel senso in cui finora l’ho interpretata e vissuta io, é libera vita tra i ghiacci, in alta montagna, é la ricerca di tutto ciò che vi é di strano e di enigmatico nell’esistenza, di tutto ciò che finora era inibito dalla morale” . E così si avvia la riflessione nietzscheana sulla propria esistenza, che talvolta si estende ad indagare sull’esistenza del genere umano in generale; e il resoconto della propria vita, viene da Nietzsche intrecciato abilmente alle opere, che sono quel che dureranno anche dopo la sua morte. Particolare amore e predilizione Nietzsche dimostra per lo Zarathustra, il suo libro sa sempre più venerato, in cui affiorano tutte le sue teorie: la critica della morale, del cristianesimo, l’eterno ritorno, il superuomo… un libro che, purtroppo, non sempre é stato compreso, e d’altronde il suo sottotitolo (“un libro per tutti e per nessuno”) lo lasciava intendere. Nietzsche con “Ecce homo” dimostra di nutrire grande amore nella vita e nella sua stessa personalità: e così per tutta l’opera egli proverà a spiegare al lettore “perchè sono tanto saggio”, “perchè sono tanto accorto” e “perchè scrivo così buoni libri”; la prima parte dell’opera é dedicata alla vita di Nietzsche, la vita movimentata, i numerosi soggiorni in Italia e, soprattutto a Torino, città di cui era come non mai entusiasta (“la migliore cucina é la piemontese!“, egli sostiene) ; dopo di che egli passa ad un’introspezione, cimentandosi nell’analizzare il suo carattere: “io sono per natura battagliero“, dice, e riassume in quattro proposizioni la sua tattica di guerra: 1) attaccare solo le cose vittoriose o aspettare finchè non diventino tali; 2) attaccare solo le cose in cui si é certi di non trovare compagni che supportino: occorre agire da soli; 3) non attaccare mai le persone, bensì servirsi di esse per rendere visibile qualche male comune, ma difficile a essere colto; 4) attaccare solo cose da cui é esclusa qualunque antipatia personale. Detto questo, Nietzsche spiega perchè é tanto accorto: lo é perchè non ha mai “riflettuto su problemi che non sono problemi“, non si é mai sprecato. Egli é “accorto” perchè ha smascherato Dio come supposizione dell’uomo, come “no” alla vita: ma Nietzsche ci tiene a specificare che il suo non é un ateismo “volgare”, ma é un istinto: “In me l’ateismo non é nè una conseguenza, nè tanto meno un fatto nuovo: esso esiste in me per istinto. Sono troppo curioso, troppo incredulo, troppo insolente per accontentarmi di una risposta così grossolana. Dio é una risposta grossolana, un’indelicatezza contro noi pensatori: anzi, addirittura, non é altro che un grossolano divieto contro di noi: non dovete pensare!“. Ma un altro grande problema che Nietzsche si pone in “Ecce homo” é quello del nutrimento e in questo frangente colma di elogi la cucina piemontese. Si tratta ora di rispondere alla domanda “perchè scrivo libri così buoni?”: il primo problema da affrontare, comunque, secondo Nietzsche, é se essi sono o non sono compresi: il pensatore tedesco deve constatare che essi non sono ancora compresi, ma un giorno lo saranno: “Sarei in aperta contraddizione con me stesso se mi aspettassi di trovare già oggi orecchie e mani disposte ad accogliere le mie verità: che oggi non mi si ascolti, che non si voglia prender nulla da me, mi sembra non solo naturale, ma anche giusto“. Ed é proprio per questo che Nietzsche si ritiene un ottimo scrittore, perchè non lo si comprende ancora, perchè parla alle razze future, perchè i suoi scritti, per quei pochi che sanno comprenderne il significato profondo, sanno portare ad alta quota. Ma la domanda ultima e nello stesso tempo più significativa che Nietzsche si pone é “perchè sono una fatalità?”; egli sostiene di conoscere il proprio destino: un giorno si riconnetterà il suo nome a qualcosa di terribile, di una crisi come non ce ne furono altre, del più tremendo urto di coscienza, d’una sentenza pronunciata contro tutto ciò che era stato creduto: ” Io non sono un uomo, sono dinamite“. Ma ciò di cui Nietzsche ha paura é di diventare un “santo”, di essere venerato come un fondatore di religioni: “Non c’é nulla in me del fondatore di religioni: non voglio credenti, non parlo alle masse; ho paura che un giorno mi facciano santo“; dice esplicitamente di preferire essere un buffone piuttosto che un santo: i santi hanno sempre mentito e nel futuro ci sarà un’enorme lotta tra la verità e la menzogna: “Ci saranno guerre come non ci sono mai state sulla terra. Soltanto a cominciare da me c’é al mondo una grande politica“. Ed é lui, l’uomo Nietzsche, ad aver scoperto la verità, ad essersi differenziato per aver smascherato il cristianesimo: “Il concetto di Dio fu trovato come antitesi a quello di vita, in esso fu riunito in una terribile unità tutto ciò che vi era di dannoso, di velenoso, di calunnioso, tutto l’odio mortale contro la vita. Il concetto dell’al di là, del vero mondo fu creato per disprezzare l’unico mondo che ci sia, per non conservare più alla nostra realtà terrena alcuno scopo, alcuna ragione, alcun compito! I concetti di anima, di spirito, e, infine, anche quello di anima immortale, furono inventati per insegnare a disprezzare il corpo, a renderlo malato- cioè santo- per opporre a tutte le cose che meritano di essere trattate con serietà nella vita“.
GLORIA E ETERNITA’
1
Da quanto tempo ormai
siedi sulla tua sventura?
Attento! tu mi covi ancora
un uovo,
un uovo di basilisco
dal tuo lungo rantolo.
Come – Zarathustra striscia lungo la montagna? –
Diffidente, ulcerato, cupo,
un lungo guatatore – ,
ma improvviso un lampo,
chiaro, terribile, uno schianto dall’abisso verso il cielo: – alla montagna stessa si scuotono
i visceri…
Dove odio e fulmine
divennero uno, una maledizione– ,
abita ora sulle montagne l’ira di Zarathustra,
una nube di tempesta che striscia per la sua via.
Si rimpiatti chi ha un’ultima coperta!
A letto voi delicati!
Ora rombano tuoni sulle volte,
ora trema quanto è muro e trave,
ora guizzano lampi e verità gialle di zolfo –
Zarathustra maledice…
2
Questa moneta,
con cui tutto il mondo paga,
gloria – ,
con i guanti tocco questa moneta,
con nausea la calpesto sotto di me.
Chi vuol essere pagato?
Chi si fa comprare…
Chi è in vendita acciuffa
con grasse mani questo clingclang della gloria per tutti!
– Li vuoi comprare?
Si fanno tutti comprare.
Ma offri molto!
fa’ tintinnare una grossa scarsella!
– se no li rafforzi,
se no rafforzi la loro virtù…
Sono tutti virtuosi.
Gloria e virtù – fanno rima
Finché vive
il mondo paga il blabla della virtù c
ol cracra della gloria -,
il mondo vive di questo chiasso…
Davanti a tutti i virtuosi
voglio essere
debitore della colpa,
chiamarmi colpevole di ogni grande colpa!
Davanti a tutte le bocche sonore della gloria
la mia ambizione mi vuole verme -,
fra questa gente mi garba
essere l’infimo…
Questa moneta, con cui
tutto il mondo paga,
gloria – ,
con i guanti tocco questa moneta,
con nausea la calpesto sotto di me.
3
Silenzio! –
Di grandi cose – io vedo grande! –
si deve tacere
o dire grande:
di’ grande, mia incantata saggezza!
Io vedo in alto –
là si rivoltano mari di luce:
o notte, o silenzio, o chiasso di quiete mortale!…
Io vedo un segno -,
dalla più lontana lontananza
cala lenta su di me una costellazione scintillante…
4
Supremo astro dell’essere!
Tavola di eterne figure!
Tu vieni a me? –
Ciò che nessuno ha scorto,
la tua muta bellezza –
come? non fugge davanti ai miei sguardi?
Stemma della necessità!
Tavola di eterne figure!
– ma tu già lo sai:
ciò che tutti odiano,
ciò che solo io amo,
che tu sei eterno!
che tu sei necessario!
Il mio amore si accende
in eterno solo della necessità.
Stemma della necessità!
Supremo astro dell’essere!
– mai raggiunto da desiderio, mai macchiato da no,
eterno sì dell’essere,
sono il tuo sì in eterno:
perché io ti amo, o eternità!
IL SUPERUOMO DI D’ANNUNZIO
Nietzsche è forse il miglior interprete della fine di un mondo e del bisogno di rinnovamento di tutta un’epoca: profeta insieme della decadenza e della rinascita, dà origine alle interpretazioni più discordi, che si tradurranno nelle influenze più diverse. Volta a volta materialista o antipositivista, esistenzialista o profeta del nazismo, il filosofo condivide tutte le ambiguità delle avanguardie intellettuali e artistiche borghesi del primo novecento e non a caso diverrà oggetto, in Italia, dell’interpretazione estetizzante di Gabriele D’Annunzio ]esercitando un indiscutibile fascino sui futuristi[. Nietzsche divenne così il filosofo della crisi, il fondatore d’un modo di pensare nuovo. Quanto alla sua idea del superuomo, inteso come il giusto trionfatore di una massa di deboli o schiavi, va senza dubbio corretta. Nietzsche non fu l’estensore d’un vangelo della violenza, ma intese porre le condizioni di sviluppo d’una civiltà e di un’idea dell’uomo radicalmente rinnovate. Nietzsche è uno scrittore asistematico e estremamente originale, la cui produzione si staglia solitaria nel panorama della storia della filosofia moderna e contemporanea. Le opere della maturità, in particolare, sono scritte con uno stile aforistico e poetico: lirismo, tono profetico e filosofia si mescolano in maniera inestricabile, rendendo spesso difficile e riduttiva l’interpretazione. Rimane costante nell’opera di Nietzsche un’ambiguità di fondo, un’ambiguità socio-politica che ha dato adito a contrastanti strumentalizzazioni politiche. Il filosofo, infatti, non specifica mai espressamente chi debba essere il soggetto della volontà di potenza: il superuomo. Molti critici hanno identificato il superuomo in una umanità vivente in modo libero e creativo, ma, molti altri lo hanno limitato ad un’élite che esercita la sua volontà di potenza non solo nei riguardi della caoticità del mondo, ma anche verso il prossimo. A ciò bisogna aggiungere il problema degli scritti postumi: la ricostruzione sistematica operata dalla sorella Elisabeth e da uno dei discepoli di Nietzsche, oltre a essere ideologicamente discutibile e largamente responsabile delle interpretazioni naziste del pensiero dei filosofo, va contro il suo rifiuto netto di ogni sistema filosofico e contro il fascino vivissimo per la forma del frammento e dell’aforisma. L’edizione critica di tutti gli scritti di Nietzsche, a cura di due italiani, G. Colli e M. Montinari, ha restituito, però, l’integrità dei frammenti secondo un ordine cronologico e ha dimostrato come “La volontà di potenza” pubblicata nel 1906 è un’opera profondamente manipolata e addomesticata. Gabriele D’Annunzio, nella sua fase superomistica, è profondamente influenzato dal pensiero di Nietzsche, tuttavia, molto spesso, banalizza e forza entro un proprio sistema di concezioni le idee del filosofo. Dà molto rilievo al rifiuto del conformismo borghese e dei principi egualitari, all’esaltazione dello spirito “dionisiaco”, al vitalismo pieno e libero dai limiti imposti dalla morale tradizionale, al rifiuto dell’etica della pietà, dell’altruismo, all’esaltazione dello spirito della lotta e dell’affermazione di sé. Rispetto al pensiero originale di Nietzsche queste idee assumono una più accentuata coloritura aristocratica, reazionaria e persino imperialistica. Le opere superomistiche di D’Annunzio sono tutte una denuncia dei limiti della realtà borghese del nuovo stato unitario, del trionfo dei princìpi democratici ed egualitari, del parlamentarismo e dello spirito affaristico e speculativo che contamina il senso della bellezza e il gusto dell’azione eroica. D’Annunzio arriva quindi a vagheggiare l’affermazione di una nuova aristocrazia che si elevi al di sopra della massa comune attraverso il culto del bello e la vita attiva ed eroica. Per D’Annunzio devono esister alcune élite che hanno il diritto di affermare se stesse, in sprezzo delle comuni leggi del bene e del male. Queste élite al di sopra della massa devono spingere per una nuova politica dello Stato italiano, una politica di dominio sul mondo, verso nuovi destini imperiali, come quelli dell’antica Roma. La figura dannunziana del superuomo è, comunque, uno sviluppo di quella precedente dell’esteta, la ingloba e le conferisce una funzione diversa, nuova. Il culto della bellezza è essenziale per l’elevazione della stirpe, ma l’estetismo non è più solo rifiuto sdegnoso della società, si trasforma nello strumento di una volontà di dominio sulla realtà. D’Annunzio non si limita più a vagheggiare la bellezza in una dimensione ideale, ma si impegna per imporre, attraverso il culto della bellezza, il dominio di un’élite violenta e raffinata sulla realtà borghese meschina e vile. D’Annunzio applica, in un modo tutto personale, le idee di Nietzsche alla situazione politica italiana. Ne parla per la prima volta in un articolo, La bestia elettiva, del ’92, e presenta il filosofo di Zarathustra come il modello del “rivoluzionario aristocratico”, come il maestro di un “uomo libero, più forte delle cose, convinto che la personalità superi in valore tutti gli attributi accessori”,”forza che si governa, libertà che si afferma”. Il suo è un fraintendimento, una volgarizzazione fastosa ma povera di vigore speculativo. Ciò che il D’Annunzio scopre in Nietzsche è una mitologia dell’istinto, un repertorio di gesti e di convinzioni che permettono al dandy di trasformarsi in superuomo e fanno presa immediatamente in un mondo di democrazia fragile e contrastata, soprattutto quando al cronista del “Mattino” e della “Tribuna” si sostituisce lo scrittore insidioso del Trionfo della Morte(“Noi tendiamo l’orecchio alla voce del magnanimo Zarathustra, o Cenobiarca, e preperiamo nell’arte con sicura fede l’avvento dell’Uebermensch, del Superuomo”) o quello, fra lirico e decadente, delle Vergini delle rocce, il nuovo romanzo del ’95, presentato dapprima sul “Convito”(“Il mondo è la rappresentazione della sensibilità e del pensiero di pochi uomini superiori, i quali lo hanno creato e quindi ampliato e ornato nel corso del tempo e andranno sempre più ampliandolo e ornandolo nel futuro. Il mondo, quale oggi appare, è un dono magnifico largito dai pochi ai molti, dai liberi agli schiavi: da coloro che pensano e sentono a coloro che debbono lavorare…”). Come dirà poi Gramsci, la piccola borghesia e i piccolo intellettuali sono particolarmente influezati da tali immagini romanzesche che sono il loro “oppio”, il loro “paradiso artificiale”. Non è ancora un’ideologia, ma è un’oratoria dell’attivismo verbale in cui fermenta la scontentezza dell’Italia borghese, il cruccio dell’avventura africana, il fastidio della mediocrità democratica e della burocrazia parlamentare, dall’esplosione dei Fasci siciliani al rovescio di Adua. Come sempre, il D’Annunzio avverte d’istinto questi stati d’animo confusi e li amplifica nei bassorilievi della sua eloquenza floreale, li traspone nello specchio del proprio personaggio e dei suoi gesti stravaganti o stupefacenti. Il primo romanzo in cui si inizia a delineare la figura del superuomo è il Trionfo della morte, dove non viene ancora proposta compiutamente la nuova figura mitica, ma c’è la ricerca ansiosa e frustrata di nuove soluzioni. Il romanzo ha una debole struttura narrativa ed è articolato in sei parti (“libri”). E’ incentrato sul rapporto contradditorio ed ambiguo di Giorgio Aurispa con l’amante Ippolita Sanzio, ma su questo tema di fondo si innestano e si sovrappongono altri motivi e argomenti: il ritorno del protagonista alla sua casa natale in Abruzzo è il pretesto per ampie descrizioni (nella seconda, terza e quarta parte) del paesaggio e del lavoro delle genti d’Abruzzo. Giorgio cerca di trovare l’equlibrio tra superomismo e misticismo, e aspira a realizzare una vita nuova (è il titolo del quarto libro). Per questo vive il rapporto con l’amante come limitazione, come ostacolo: per il suo fascino irresistibile, Ippolita Sanzio è sentita come la “nemica”, primigenia forza della natura che rende schiavo il maschio. Solo con la morte Giorgio si libererà da tale condizione: per questo si uccide con Ippolita, che stringe a sè, precipitandosi da uno scoglio. Giorgio Aurispa, il protagonista, l’eroe, è ancora un esteta simile ad Andrea Sperelli; Ippolita, la donna fatale consuma le sue forze e gli impedisce di attingere a pieno all’ideale superumano a cui aspira, portandolo alla morte. Sulla figura del superuomo si incentra anche Le Vergini delle Rocce. Qui però La complessità metafisica e ideologica del superuomo subisce una sostanziale semplificazione nella direzione di un superomismo a impronta esclusivamente estetica che s’intride di valenze politiche reazionarie. E’ qui riscontrabile l’esito di una lunga ricerca sul versante stilistico e formale, che nel momento stesso in cui agganciava le posizioni più innovative del Simbolismo europeo, si reimmetteva nel solco della tradizione trecentesca e rinascimentale, l’onnipresenza di Leonardo da Vinci nelle Vergini ne è il segno tangibile. Il nucleo drammatico del romanzo, fondato sull’aspirazione di Claudio Cantelmo a generare un figlio in cui si distillassero le mirifiche qualità di una illustre progenie e che sarebbe dovuto diventare il futuro re di Roma, appare del tutto gratuito e incapace di sostenere una dinamica narrativa di lungo respiro. In questo senso il romanzo esprime i limiti dell’interpretazione che D’Annunzio diede di Nietzsche. Dopo un decennio di interruzione, in cui scrive per il teatro e sviluppa le Laudi, D’Annunzio ritorna alla forma del romanzo scrivendo Forse che sì forse che no. Qui presenta un nuovo strumento di affermazione superomistica inedito e in linea con i tempi: l’aereo. Il protagonista Paolo Tarsis realizza la sua volontà eroica tramite le sue imprese di volo. Egli è senza dubbio la reincarnazione dei vari superuomini presenti ne IlTtrionfo della Morte o nelle Vergini delle rocce, ma a differenza di questi, non appartiene ad una nobile casata ma è un borghese estraneo agli influssi decadenti e dedito all’azione; affiancata a questo superuomo troviamo Isabella Inghirami, la prima figura femminile capace di contendere il primato all’egotismo del superuomo di turno. Tra i due personaggi c’è un rapporto di amore-passione che talvolta arriva fino alle degenerazioni dell’incesto e del masochismo. Questo romanzo rappresenta la piena adesione del D’Annunzio alla contemporaneità: è possibile infatti ritrovare personaggi che si muovono tra aeroplani, automobili, telefoni. Vi si ritrova un amore, quindi, per la macchina e la velocità. In Italia, nel frattempo, sotto la pressione di molti e potenti interessi l’onda dell’interventismo stava montando, e il D’Annunzio poteva essere l’uomo dell’ora, l’araldo dello sdegno nazionale. I discorsi, o meglio le orazioni, che lo scrittore tenne a Genova tra il 4 e il 7 maggio e poi a Roma dal 12 al 20, mostrarono che il calcolo era giusto, giacchè l’oratoria dannunziana conferiva uno stile alla passione politica di una gioventù borghese insoddisfatta, abbagliata dal grande fuoco rinnovatore della guerra nazionale. Mentre l’Italia scendeva in guerra trascinata dal radiosomaggismo, stava sorgendo anche una nuova oratoria, che non aveva bisogno dei fatti ma dell’immaginazione, e che attraverso la mistica di un capo carismatico comunicava a ciascuno la forza di una coerenza fittizia, la certezza di un rito collettivo. Nell’eloquenza dell’esteta, che si proclamava ora non più “un grido e un allarme” ma “un semplice compagno tra compagni”, prendeva forma lo stile moderno della propaganda, del discorso politico di massa non più rivolto ad un’élite ma ad una comunità di compagni di cui si condivide il destino nella magia degli slogan e delle parole d’ordine. Il primo ad esserne preso era lo stesso D’Annunzio, a cui questo contatto verbale con la folla rinnovava, ma ad un grado più alto, quel piacere di una pronunzia della parola tutta corporea, ” nella bocca sonante del dicitore”, che aveva invocato anni prima il poeta della Canzone di Garibaldi. Anche la parola, insomma, si faceva gesto, ebbrezza d’azione, istante assoluto da consumare in sé stesso, nella forza sensuale di una presenza aggressiva come in uno spettacolo di delirio o di entusiasmo rituali. Nonostante il suo “viso grinzoso di vecchietto richiamato” la guerra fece del D’Annunzio un eroe di nuovo giovane, per quanto non si possa negare, d’accordo con gli storici d’oggi, che egli rimase sempre un “avventuriero privilegiato”, estraneo agli orrori putridi e comuni della trincea, ma pronto, a sfidare la morte con la logica singolare del giocatore d’azzardo: come risulta chiarissimo dai suoi taccuini di combattente, sia che confessi che ” la vita non ha più pregio poichè non può rischiarla nel più temerario dei giochi” sia che si sorprenda a notare come ” tante immagini di voluttà accompagnino uno stato eroico” o lodi “l’amore del destino” in una “carne che domani può essere un pallido sacco d’acqua amara”. Alla fine della guerra il tenente colonnello D’Annunzio lasciava il fronte in un “misto di gioia e di scontento”, col sospetto per giunta che la vittoria potesse venire tradita e la vecchia politica riprendesse il suo corso come se l’evento della guerra non fosse stato il crepuscolo del mondo borghese e l’iniziio di una rivoluzione. Lo assillava soprattutto la questione della Dalmazia e dell’Adriatico, per la quale iniziò subito una nuova campagna di stampa contro le trattative diplomatiche in corso, assumendo ancora il ruolo di agitatore delle coscienze, di interprete della febbre nazionalistica nello scontro delle generazioni: nessuno meglio di lui, che era l’eroe della guerra poteva parlare alla massa dei reduci insoddisfatti, dei giovani che avevano combattuto e ora dovevano rassegnarsi al grigiore della vita comune declassati in un contesto sociale incerto e precario. Mentre c’era già chi salutava in lui “il solo Duce del popolo italiano e intrepido”, seguivano gli articoli della Pentecoste d’Italia, de Il comando passa al popolo, dell’Erma bifronte, e infine di Disobbedisco, di nuovo in aperto contrasto con il governo presieduto da Nitti. La situazione di Fiume, comunque, volgeva ormai al peggio a causa dei deliberati della Conferenza di Parigi, fra il tumulto crescenter dei nazionalisti e dell’ex socialista Benito Mussolini, il direttore del “Popolo d’Italia”. Il 12 settembre 1919 il poeta della guerra entrava a Fiume alla testa dei granatieri di Ronchi, che lo avevano voluto loro comandante, e di alcuni reparti dell’esercito regolare subito solidali, per affrettarne l’annessione all’Italia e per dare inizio, così, a un’avventura politica che durò quindici mesi e aprì la via, come riconoscono tutti gli storici, ad altre e più tragiche esperienze nel declino progressivo delle vecchie fedi democratiche. Il maggio radioso e l’avventura fiumana costituirono dei gravi precedenti di sminuimento del sistema democratico sulla cui falsa riga si arrivò in Italia e in Germania all’instaurazione di regimi totalitari, illiberali, reazionari e imperialistici. E ad incarnare perfettamente il superuomo é Ulisse: egli, anche se durato solo un attimo, cambia comunque la vita del poeta: egli non è come i suoi compagni, che pure gli sono cari, ma si sente spinto a confidare solo in se stesso e destinato a realizzare imprese eccezionali, come quell’Ulisse di cui ha meritato il simbolico sguardo. Ulisse diventa quindi non solo il simbolo del “superuomo” per D’Annunzio, ma anche l’esempio e l’incitamento di tutti gli uomini che, come il poeta, non si accontentano di una vita tranquilla ma vogliono affermare la loro volontà di potenza realizzando la dimensione eroica di se stessi. Dietro alle parole c’è però il vuoto più completo di pensiero, ma soprattutto di sentimento. E’ riscontrabile nel poeta il desiderio di imporsi, di agire e ciò sconfina in megalomania già riscontrabile nel poeta adolescente che negli anni maturi risente della nuova filosofia tedesca (superomismo). D’Annunzio, avendo rifiutato di porsi una problematica del vivere, si proiettò in una vita attiva e combattiva. Il suo vitalismo si rivelò in due sensi:
1. Come insofferenza di una vita comune e normale.
2. Come vagheggiamento della “bella morte eroica”.
Egli perciò insiste sui temi della grandezza, dell’orgoglio, dell’eroismo estetizzante. Determinò la svolta più importante del decadentismo, quella superomistica, a cui aderì dopo la (errata) interpretazione di Nietzsche. In D’Annunzio il superuomo trova la sua perfetta identificazione con l’artista. In lui non è tanto la vita a tenere dietro l’arte, ma l’arte a seguire le eccentricità della vita e questo costò al poeta un’accusa di superficialità. Il Superuomo per D’Annunzio, così come viene presentato nelle due opere Trionfo della Morte e Le Vergini delle Rocce, è un individuo proteso all’affermazione di sé, al di fuori di ogni remora di ordine morale e sociale. D’Annunzio applica concretamente alla realtà la teoria dell’idea pura di Superuomo e facendo ciò, ci permette di individuare alcune caratteristiche peculiari del “suo” Superuomo. I protagonisti delle opere sopracitate mostrano, infatti, il culto dell’energia dominatrice che si manifesta come forza, violenza, tesa all’affermazione della propria individualità. La loro è una concezione aristocratica del mondo che presuppone un conseguente disprezzo della massa, della plebe e del regime parlamentare che si basa su di essa. Giorgio Aurispa e Claudio Cantelmo ricercano la propria tradizione storica nella civiltà pagana, greco-romana e in quella rinascimentale. La sensualità caratterizza il Superuomo che ha alla base una sorta di furore sadico, di volontà di distruzione, di eccitazione violenta. Nel Superuomo d’annunziano si delinea una sproporzione tra gli obiettivi e le forze per raggiungerli, tra il desiderio e la realtà.
25 Agosto 2000: centenario della morte di Nietzsche
Cento anni fa, proprio il 25 agosto 2000, sei settimane prima del suo 50° compleanno, moriva Friedrich Nietzsche. Durante i precedenti due anni non aveva saputo nulla, sentito nulla, pensato nulla. Per quel che possiamo dire, non sapeva che la madre era morta nè che egli si trovava a Weimar. Non sapeva di essere famoso, nè che la sua fama poggiava sulla conferma di quasi tutto quello che aveva pensato. Quando morì, non sapeva di vivere da quasi 8 mesi nel XX secolo, della cui prossima storia aveva previsto tanto e con tanta chiarezza: il secolo del “sorgere del nichilismo” e del crollo del vecchio ordinamento mondiale; la “classica età della guerra” e della “politica su larga scala” che avrebbe tratto le ultime conclusioni della “morte di Dio” e della scomparsa di ogni sanzione per la morale; l’età in cui la democratizzazione dell’Europa centrale avrebbe offerto un “involontario campo di cultura alla tirannia” e in cui gli insegnamenti di Hegel ( “la marcia della storia” ) e di Darwin ( “la sopravvivenza dei più forti” ) sarebbero diventati realtà pratiche e avrebbero ridotto gli individui ad “animali o automi”. Il secolo in cui la volontà di potenza, non sublimata e non frenata dalle costrizioni che ancora si imponevano al XIX secolo, si sarebbe impadronita dovunque delle leve del potere, in cui “questo maledetto antisemitismo” avrebbe offerto l’occasione e il movente all’ultimo dei delitti nichilistici, e in cui la sua teoria che “un popolo dalla forte volontà di potenza, privato della soddisfazione esteriore, vorrà la propria distruzione piuttosto che non volere affatto” sarebbe stata dimostrata con terribile compiutezza dalla disperata e tremenda esperienza del Reich. L’amico e “discepolo” Peter Gast, che l’anno precedente, insieme a Elisabeth, sorella di Nietzsche aveva dato inizio alla terza edizione Omnia delle opere del filosofo, tenne l’orazione funebre nel cimitero parrocchiale di Röchen dove Nietzsche veniva sepolto accanto al padre, e, visibilmente commosso, ma anche rivelando quanto poco avesse capito del suo “Maestro”, chiuse il suo indirizzo con queste parole: “Pace alle tue ceneri! Santo sia il tuo nome a tutte le generazioni future!”. In Ecce homo Nietzsche aveva scritto: “Ho una terribile paura: che un giorno mi chiameranno santo”. Aveva previsto anche questo. Oggi, a un secolo dalla morte, di tutte le sue profezie vogliamo mettere a fuoco quella per cui Nietzsche é noto a tutti: l’annuncio della morte di Dio, del Dio cristiano naturalmente, per cui la morte di Dio significa la fine del cristianesimo come religione dell’Occidente. Nietzsche era profondamente convinto che il cristianesimo fosse nato e fosse morto anche se la sua agonia é durata 2000 anni, quando i discepoli di Gesù non hanno perdonato i suoi nemici. L’argomentazione di questa tesi (che troviamo nell’ Anticristo, opera scritto lo stesso anno, 1889, in cui Nietzsche cadde nella buia notte della follia), prende le mosse dalla convinzione che per il cristianesimo: “E’ in sè completamente indifferente il fatto che una cosa sia vera o no, ma é estremamente importante, invece, fino a che punto sia creduta. Così ad esempio, se é insita una felicità nei credenti redenti dal peccato, come premesse di ciò, non é necessario che l’uomo sia peccatore, ma che si senta peccatore.” In questo modo il cristianesimo ha sostituito la verità con la fede che qualcosa sia vero. Anzi alla ricerca della verità ha posto un “divieto”, e ha sostituito questa, che é la più autentica delle virtù, con le virtù teologali: fede, speranza e carità, che sono 3 “accorgimenti” a cui il cristianesimo é ricorso per distogliere l’uomo dalla ricerca della verità, e poterlo così “signoreggiare, addomesticare, dominare”. Fu così che il cristianesimo sostituì alla “lotta contro il dolore”, che ritroviamo in ogni religione della natura, “la lotta contro il peccato”, concepibile solo di fronte a una legge. Ma dov’é l’origine della legge se non nella casta sacerdotale che la promulga e riesce a imporla? All’inizio non c’era legge nella religione ebraica i cui tratti essenziali erano quelli tipici di ogni religione, dove sono codificati i precetti che regolano il rapporto originario dell’uomo con la natura: “Il culto divino era, nell’antichità ebraica, natura, era il vertice della vita, e chiarirne l’altezza e la profondità costituiva il suo significato autentico”. Poi, a seguito della cattività in Babilonia, questa religione andò incontro a un processo di “denaturalizzazione (denaturierung)” e il concetto di dio passò “nelle mani di agitatori sacerdotali” che ne fecero uno strumento di potere sui loro fedeli. Nel Deuteronomio, infatti, emerge la legge, e alle nozioni naturali di causa ed effetto subentrarono le nozioni antinaturali di premio e castigo che facevano riferimento non più “alle condizioni di vita e di sviluppo di un popolo, ma a quell’unica condizione che si oppone alla vita che é la nozione di peccato”. A questo punto i peccati, “che sono caratteristici appigli per l’esercizio del potere, diventano indispensabili. Il prete vive di peccati, per lui é necessario che si pecchi. Principio supremo: dio perdona chi fa penitenza- o più chiaramente chi si sottomette al prete”. Contro questa impostazione dell’ordine religioso muove la sua azione Gesù, che per Nietzsche non é il “Cristo della fede”, ma il “Gesù storico”, che i Vangeli presentano come il ribelle che si oppone “a tutto ciò che era ecclesiastico e teologico”, una sorta di “santo anarchico”, un “delinquente politico” condannato perciò a subire “per colpa sua” la condanna della croce. Alla “negazione della dottrina ecclesiastica ebraica” Gesù affianca l’annuncio della buona novella a cui mancano sia la nozione di colpa che quella di castigo; il peccato come segno di distanza tra l’uomo e Dio é eliminato, mentre la beatitudine, che scaturisce dall’innocenza infantile, diventa pratica di vita: “La vita di Gesù non é stata nient’altro che questa pratica di vita- anche la sua morte non fu altro. Egli sa che solo con la pratica di vita ci si poteva sentire divini, beati, evangelici, figli di dio in qualsiasi momento. Non la penitenza, non la preghiera per il perdono sono le vie che conducono a dio, soltanto la pratica evangelica porta a dio, essa appunto é dio. Ciò che fu liquidato con l’Evangelo fu l’ebraismo delle nozioni di peccato, remissione dei peccati, fede, redenzione mediante la fede”, l’intera dottrina ecclesiastica ebraica era negata nella buona novella”. Ma, prosegue Nietzsche: il Vangelo morì sulla croce. Ciò che da quel momento é chiamato buona novella o vangelo era già l’antitesi di quel che lui aveva vissuto: una cattiva novella un Dysangelium. Come é potuta accadere questa metamorfosi che trasformò la pratica di vita di Gesù in una nuova chiesa in tutto simile alla chiesa dell’ebraismo? Accadde, a parere di Nietzsche, ad opera dei discepoli di Gesù che “non perdonarono quella morte- il che sarebbe stato evangelico nel più alto senso; e al perdono subentrò il sentimento meno evangelico, la vendetta. Questa si tradusse nell’innalzare Gesù in una maniera aberrante, di distaccarlo da loro, proprio allo stesso modo con cui una volta gli ebrei, per vendicarsi dei loro nemici, avevano separato da sè il loro Dio e lo avevano portato in alto. Il Dio unico e il figlio unico di Dio: entrambi prodotti del risentimento”. L’artefice massimo di questa trasformazione del messaggio originario di Gesù fu Paolo: “Questo genio dell’odio che, nella visione dell’odio e nella spietata logica dell’odio ereditato dall’istinto sacerdotale ebraico, trasformò la buona novella nella peggiore fra tutte. Per questo falsificò la storia di Israele affinchè apparisse come la preistoria della sua azione: tutti i profeti hanno parlato del suo redentore. Poi la chiesa falsificò la storia dell’umanità facendone la preistoria del cristianesimo”. Come ogni sacerdote, Paolo aspirava alla potenza e, per ottenerla, si servì della menzogna: “Quel che lui stesso non credeva, gli idioti, tra cui egli gettò la sua dottrina, lo credettero; così riuscì a realizzare la tirannia dei sacerdoti, per formare delle mandrie: la fede nell’immortalità – vale a dire la dottrina del giudizio”. Oggi, alla luce della morte di Dio, scrive Nietzsche: é indecoroso essere cristiani; un teologo, un prete, il papa, non soltanto errano, ma mentono in ogni frase che proferiscono; anche il prete sa che Dio non esiste, che non c’é nessun peccatore, nessun redentore”, perciò, recita l’ultima parte dell’ Anticristo: “Sono giunto alla conclusione ed esprimo il mio giudizio . Io condanno il cristianesimo , levo contro la Chiesa cristiana la più tremenda di tutte le accuse che siano mai state sulla lingua di un accusatore. Essa é per me la massima di tutte le corruzioni immaginabili; essa ha avuto la volontà dell’ estrema corruzione possibile. La Chiesa cristiana non lasciò nulla di intatto nel suo pervertimento, essa ha fatto di ogni valore un disvalore, di ogni verità una menzogna, di ogni onestà un’ abiezione dell’ anima. Computiamo il tempo di quel dies nefastus con cui ebbe inizio questa fatalità – dal primo giorno del cristianesimo! E perchè non invece dal suo ultimo giorno? Trasvalutazione di tutti i valori”. Qui il riferimento di Nietzsche non é solo ai valori cristiani, ma anche ai valori metafisici che, inaugurati dal platonismo, per 2000 anni hanno dominato la cultura dell’Occidente. Lo scetticismo radicale che erode le fondamenta metafisiche e cristiane della cultura occidentale, a parere di Nietzsche, va portato fino in fondo, affinchè l’umanità sappia creare un “nuovo Dio” che Nietzsche indica in Dioniso, contrapposto non più ad Apollo, come nell’antica Grecia, ma al Crocefisso. Quindi un Dio della natura e della gioia di vivere, nei limiti che la natura concede, contro il Dio della trascendenza e della glorificazione della sofferenza che abita quel “mondo dietro il mondo” che Platone da un lato e il cristianesimo dall’altro hanno inaugurato. Ma “la menzogna bimillenaria”, come la chiama Nietzsche, é ormai alla fine. E la sua fine coinciderà con la fine di un tipo d’uomo, quello cresciuto sui valori cristiani, che attende di essere superato da un nuovo tipo d’uomo, capace di liberare tutte le possibili risorse umane finora trattenute sotto il giogo di chi aveva la pretesa di parlare in nome di Dio. Con questo messaggio si é chiusa la vita di Nietzsche e con essa la sua filosofia dell’avvenire con l’indicazione profetica della laicizzazione dell’Occidente che il XX secolo ha registrato come tratto tipico della sua fisionomia.
La Repubblica, venerdì 25 agosto 2000
NIETZSCHE E DON CHISCIOTTE
Indubbiamente Federico Nietzsche era affascinato dalla figura di Don Chisciotte. Per un pensatore che aveva dedicato un paragrafo della sua opera più importante, “Così parlò Zarathustra”, alla “libera morte”, il personaggio di Cervantes cui si “prosciugò talmente il cervello, che perse la ragione” non poteva non ispirargli simpatia. Sappiamo come Don Chisciotte morì: “Il mio intelletto è ora libero e chiaro senza le ombre caliginose dell’ignoranza, in cui l’aveva avvolto la continua e detestabile lettura dei libri di cavalleria. Io riconosco ora le stravaganze e i loro inganni, e mi duole soltanto d’essermene accorto troppo tardi, poiché non mi resta più tempo di compensare il mio fallo con la lettura d’altri libri che possano illuminarmi l’anima. (…)Vorrei morire in modo da far capire che la mia vita non è stata tanto cattiva da meritarmi la reputazione di pazzo: perché sebbene lo sia stato, non vorrei confermare questa verità con la mia morte” . E’ proprio questo “tipo” di morte che Nietzsche non accetta. Nietzsche amava Don Chisciotte e tendeva ad identificarsi con lui; egli criticava Cervantes per aver reso il suo eroe così ridicolo e non può esservi dubbio sulla paura di Nietzsche di essere non meno ridicolo, al punto tale che nello scritto “Ecce Homo” così si esprime:”…Ho una paura spaventosa che un giorno mi facciano santo: indovinerete perché io mi premunisca in tempo, con la pubblicazione di questo libro, contro tutte le sciocchezze che si potrebbero fare con me…Non voglio essere un santo, allora piuttosto un buffone…Forse sono un buffone….E ciononostante, anzi non ciononostante – perché non c’è mai stato sinora niente di più menzognero dei santi – la verità parla in me – Ma la mia verità è tremenda. Perché fino ad oggi si chiamava verità la menzogna. Trasvalutazione di tutti i valori: questa è la mia formula per l’atto con cui l’umanità prende la decisione suprema su se stessa, un atto che in me è diventato carne e genio. Vuole la mia sorte io debba essere il primo uomo decente, che sappia oppormi a una falsità che dura da millenni (….)Io vengo a contraddire, come mai si è contraddetto, e nondimeno sono l’opposto di uno spirito negatore. Io sono un lieto messaggero, quale mai si è visto, conosco compiti di un altezza tale che finora è mancato il concetto per definirli, solo a partire da me ci sono nuove speranze”. Successivamente Nietzsche annota:” Uno dei libri più dannosi è Don Chisciotte “(Schopenhauer als Erziecher 18749- e spiega in una nota successiva:” Cervantes avrebbe potuto combattere l’inquisizione, ma preferiva fare apparire ridicole le sue vittime, cioè gli eretici ed idealisti di tutti i tipi…”. L’attacco di Cervantes al romanzo cavalleresco divenne, osserva Nietzsche, la “più generale ironizzazione di tutte le aspirazioni più elevate” ed il libro deve perciò essere considerato un sintomo della “decadenza della cultura spagnola” e ” una disgrazia nazionale”(Der Wanderer und sein Schatten. Nella stessa nota Nietzsche protesta contro la conclusione del libro di Cervantes:” Egli non risparmia neanche al suo eroe la terribile illuminazione sulla sua condizione al termine della vita”. In un altro appunto Nietzsche fa di nuovo riferimento alla “terribile fine” di Don Chisciotte e così commenta:” L’ umanità è sempre minacciata da questa ignominiosa negazione di se stessi alla fine della propria lotta” (Die Morgenrote 1881). Rimane in Nietzsche un desiderio inespresso quindi, ossia quello di voler un’altra morte per Don Chisciotte. Quest’ultimo muore smentendo se stesso. Nietzsche rimane colpito da questa morte “insignificante”. La morte di Don Chisciotte non restituisce il preciso significato del vissuto -ante, al contrario rappresenta la negazione di se stessi, la morte del significato di una vita peculiare e la morte del significato di una “libera morte”. Don Chisciotte muore togliendosi la maschera che aveva indossato:” Rallegratevi con me, signori miei, perché io non sono più Don Chisciotte della Mancia, ma Alonso Chisciano, a cui gli esemplari costumi meritarono il nome di buono(…)Ormai mi sono odiose tutte le storie mondane della cavalleria errante”. Sembra quasi paradossalmente che il personaggio di Cervantes non muore di “libera morte” , “non muore al momento giusto” , muore come molti che “muoiono troppo tardi”. infatti Don Chisciotte va incontro alla morte smentendo se stesso, negando proprio le qualità e i caratteri della sua vita, che potevano in qualche modo essere sigillati con una morte diversa, con una “morte come adempimento”, la morte che per i vivi diventa stimolo e una promessa”. In tal modo Nietzsche sembra prendere le parti di Sancio, il quale sapendo che Don Chisciotte stava morendo disse:” Non muoia , signor padrone, non muoia. accetti il mio consiglio, e viva molti anni, perché la maggior pazzia che possa fare un uomo in questa vita è quella di lasciarsi morir così senza un motivo ,senza che nessuno lo ammazzi, sfinito dai dispiaceri e dall’avvilimento. Su, non faccia il pigro, si alzi da questo letto, e andiamocene in campagna vestiti da pastori come s’è fissato, e chi sa che dietro a qualche siepe non si trovi la signora Dulcinea disincantata, che sia una meraviglia a vedersi. Se Lei muore dal dispiacere d’essere vinto, la colpa la dia a me, dicendo che la scavalcarono perché io avevo sellato male Ronzinante…”. Ci piace pensare, a conclusione di questa breve noterella, a una superiore mistificazione romanzesca, che vuole la pazzia di Nietzsche suggellata dall’abbraccio a un cavallo, in una mattina del 3 gennaio 1889, in piazza Carlo Alberto a Torino e pensare che in qualche modo la vita e la morte di Nietzsche si possono volutamente confondere con quella di Don Chisciotte. Un ronzinante lega queste due figure, quando don Chisciotte scende da cavallo torna savio, quando Nietzsche abbraccia un cavallo afferma la sua pazzia. Ma è appunto solo una superiore mistificazione romanzesca.
Nietzsche e la matematica
Che cosa é verità?Inerzia;l’ipotesi che ci rende soddisfatti;il minimo dispendio di forza intellettuale.
Nietzsche muove diverse critiche alla matematica nel corso della sua vita, ognuna delle quali ha il suo argomento portante: in “Umano, troppo umano”, l’opera con cui il folgorante profeta del superuomo avvia una vera e propria chimica delle idee, egli scrive a proposito della matematica: ” certamente non sarebbe nata, se si fosse saputo fin da principio che in natura non esiste nè una linea esattamente retta, nè un vero cerchio, nè un’ assoluta misura di grandezza” . Per il pensatore tedesco la matematica indaga in modo certamente rigoroso, ma il suo campo d’azione é orientato in un mondo inesistente, puramente fittizio, dove si può parlare di “linee rette” o di “cerchi”: ora, nel nostro mondo terreno, quel mondo a cui Nietzsche invita a restare fedeli, non si troveranno mai una linea retta o un cerchio precisi; e così la matematica finisce per far presa su un mondo che non il nostro, sul mondo della “fantasia”: essa risulta essere troppo sganciata dalla realtà. Ed ecco allora che Nietzsche arriva alla conclusione che la matematica, la “scoperta delle leggi dei numeri”, derivi da un errore umano, dalla convinzione che esistano “rette precise” o “cose uguali”; e a proposito troviamo scritto, sempre in “Umano, troppo umano”: “La scoperta delle leggi dei numeri é stata fatta in base all’errore già in origine dominante che ci siano più cose uguali (ma in realtà non c’é niente di uguale), o che perlomeno ci siano cose (ma non ci sono ‘cose’). L’ammissione della molteplicità presuppone sempre già che ci sia qualcosa che si presenta come molteplice: ma proprio qui regna già l’errore, qui già fingiamo esseri e unità che non esistono. Le nostre sensazioni di spazio e di tempo sono false, giacchè, vagliate conseguentemente, conducono a contraddizioni logiche. In tutte le determinazioni scientifiche noi calcoliamo sempre inevitabilmente con alcune grandezze false: ma, poichè queste grandezze sono per lo meno costanti, come ad esempio la nostra sensazione dello spazio e del tempo, i risultati della scienza acquistano lo stesso perfetto rigore e sicurezza nella loro reciproca connessione; su di essi si può continuare a costruire- fino a quell’ultimo limite, dove le erronee premesse, quegli errori costanti, riescono in contraddizione con i risultati, come per esempio nella teoria atomica. Qui ci sentiamo ancor sempre costretti ad ammettere una ‘cosa’, o ‘substrato’ materiale che vien mosso, mentre l’intera procedurascientifica ha appunto perseguìto il compito di risolvere in movimento tutto ciò che si presenta come una cosa (che é materiale): anche qui noi distinguiamo ancora con la nostra sensazione ciò che muove e ciò che é mosso e non usciamo da questo circolo, perchè la fede nelle cose é fin dall’antichità connessa col nostro essere. Quando Kant dice che ‘l’intelletto non attinge le sue leggi dalla natura, ma le prescrive a questa’, ciò é pienamente vero riguardo al concetto di natura che noi siamo costretti a collegare con essa (natura = mondo come rappresentazione, cioè come errore), che é però il compendio di una moltitudine di errori dell’intelletto. Le leggi dei numeri sono totalmente inapplicabili: esse valgono solo nel mondo umano”. Nietzsche non intende certo mettere in discussione che 2 + 2 = 4, questo non gli interessa; vuol però far vedere come una formula matematica non ci dia alcuna conoscenza, bensì come essa si limiti a descriverci la procedura di un fatto. Nella “Volontà di potenza” egli scrive: “E’ illusione che conosciamo qualcosa quando abbiamo una formula matematica per ciò che avviene: abbiamo solamente indicato, descritto: nulla di più ! ”
NIETZSCHE FILOLOGO
“Ma nel tedesco egli odiava il puro mestierante, il filisteo”.
(F. Nietzsche, ottobre 1861)
Il periodo di Pforta
La scuola reale di Pforta – dove avevano studiato Novalis, Fichte, Friedrich Schlegel e dove Nietzsche compie gli studi superiori dal 1858 al 1864 – era un ginnasio-liceo a numero chiuso, di impostazione umanistica. In questa scuola, rinomata per la serietà dell’insegnamento, si studiava soprattutto l’antichità classica; qui, a differenza degli altri licei prussiani, in cui prevalevano ideali clericali e monarchici, si respirava l’atmosfera dell’ Ellade e di Roma: al centro dell’insegnamento stavano il greco e il latino, oltre che la lingua e la letteraura tedesca. Il modello ideale a cui ci si ispirava era il dotto, in particolare il filologo.
Negli anni di Pforta, Nietzsche è un allievo modello, negli autori greci e latini, acquista un’ eccellente competenza filologica. Coltiva inoltre una vasta gamma di interessi: si appassiona alla poesia tedesca classica e contemporanea, e sviluppa quelle doti musicali che lo accompagneranno per tutta la vita; alla musica si dedica intensamente, suonando e componendo. La scuola di Pforta incoraggiava la ricerca autonoma degli allievi, sollecitandoli a interessarsi ad argomenti di studio di loro scelta; probabilmente, anche la dissertazione in latino sul poeta arcaico Teognide di Megara, con cui Nietzsche conclude il corso liceale, rientra in questo ambito di ricerche. Lo studio di Teognide continua ad occuparlo negli anni dell’università; come nota Horst Althaus, una singolare affinità spirituale lo lega a questo poeta antico, che è uno scrittore di epigrammi e un ideologo dell’aristocrazia. (1)
Nell’estate del 1860, insieme agli amici d’infanzia Wilhelm Pinder e Gustav Krug, Nietzsche fonda l’associazione culturale “Germania”: ogni socio deve sottoporre al vaglio critico degli altri due un proprio lavoro, un saggio, una composizione musicale. Per Nietzsche è la prima tribuna da cui esprimere qualcosa di originale: l’associazione, che verrà sciolta tre anni dopo, ospiterà una lunga lista di contributi nietzscheani. Questi primi lavori – come afferma Althaus – sono solo tenaci esercizi linguistici di uno scolaro, che attestano più la passione che la sua maestria. Ma nel ’62 egli scrive per la sua “Germania” due saggi filosofici, Fato e storia e Libertà della volontà e fato, che alcuni critici considerano di singolare importanza: vi sarebbero enunciati temi destinati a produrre maturi frutti, come la critica della religione, l’eterno ritorno, la relatività della morale, l’amor fati. Tuttavia il giudizio su queste opere è controverso; ad esempio, Hans Wolff afferma che in esse Nietzsche mostra “confidenza con idee che costituiscono i fondamenti delle sue opere posteriori e perfino delle ultime” (2); invece Gianni Vattimo ne minimizza la portata: solo nel periodo degli studi universitari sarebbe possibile parlare della formazione di vere e proprie posizioni filosofiche (3).
E’ in questo clima culturale che matura la scelta filologica di Nietzsche, il quale, alla fine del periodo di Pforta, è deciso a fare della filologia la sua professione. Kurt Paul Janz (4) sostiene che a Pforta egli costruisce le basi eccezionalmente solide dell’amore e della conoscenza della classicità; impara a concentrare il suo spirito sul più scrupoloso lavoro scientifico, e comincia a leggere filologicamente gli autori latini e greci. La sua vocazione filologica è dunque essenzialmente l’effetto del genuino sentimento di amore per l’antichità. Ma, secondo Janz, in questa vocazione si nasconde un’ambiguità di fondo, un latente dissidio; mentre infatti, l’amore per l’antichità è immediato, vivo, e tale è destinato a rimanere, quello per la filologia è “spurio”: non è una inclinazione naturale, colma semplicemente una lacuna, si inserisce nel vuoto determinato dalla rinuncia a un progetto artistico-musicale (5).
Fin dall’inizio, la filologia non è per Nietzsche fine a se stessa, egli non si sente suo agio nei panni dell’erudito. Le motivazioni che sono alla base di tale scelta vanno cercate piuttosto nel desiderio di ricostruire la fisionomia della classicità, di farne rivivere le istanze etico-culturali in funzione del presente, per giudicarlo e rinnovarlo. La conoscenza del passato è dunque finalizzata a un progetto culturale più ampio. Un appunto della primavera del 1868, può essere indicato come il motto della sua attività di filologo: ” Non per il semplice fatto che sia accaduta si ha il diritto di fare ricerche su una cosa, ma perchè questo passato era migliore del presente e quindi funge da modello” (6).
In questo contesto, assai importante ci pare uno scritto degli ultimi anni di Pforta, un commento al primo coro dell’ Edipo re di Sofocle, dove Nietzsche già studia la tragedia, e individua nella musica l’origine del dramma greco. Il collegamento con la Nascita della tragedia è evidente; ma questo scritto è degno di interesse anche per un altro motivo. Hans Wolff sostiene che qui si fa sentire per la prima volta l’ influsso di Richard Wagner; Nietzsche, che già conoscerebbe gli scritti del Maestro, e in particolare Opera e dramma, “crede di vedere realizzato proprio nella tragedia classica quell’ideale di opera d’arte integrale a cui tende Wagner” (7). L’idea di concepire l’opera di Wagner come rinascita della tragedia greca risalerebbe dunque a quest’epoca.
L’anno di Bonn
Nel 1864 si iscrive all’università di Bonn per studiare filologia e teologia. L’università di Bonn, meta obbligata per gli ex-allievi di Pforta, godeva di un grande prestigio, soprattutto nel campo della filologia, che annoverava maestri rinomati come Friedrich Wilhelm Ritschl e Otto Jahn. A Bonn trascorre due semestri, poco produttivi per lo studio, senza frequentare regolarmente alcun corso. Anche per quanto riguarda il privato, non vive una stagione molto felice: partecipa ai divertimenti, alle occasioni mondane e artistiche di una città definita l’Atene renana, ma poi finisce per trovarsi in difficoltà finanziarie. Entra nell’ associazione studentesca “Franconia”, e, dopo un entusiasmo iniziale, se ne allontana, forse deluso dal “materialismo birraiolo” che vi dominava. Prende una sola decisone sicura, quella di abbandonare lo studio della teologia, intrapreso solo per compiacere la madre; più tardi, dirà che della teologia lo attirava unicamente il lato filologico.
Anche gli studi filologici sono fonte di incertezza, poichè comportano una scelta di campo, per così dire, fra Ritschl e Jahn: il primo, vicino alla scuola storico-critica, è conoscitore di Omero e della tragedia greca, e specialista di grammatica latina; il secondo è archeologo, musicista e storico della musica. Jahn è più vicino alla sensibilità del giovane studente che, tuttavia, dopo una iniziale presa di posizione per lui, effettua il definitivo passaggio alla filologia rigorosa con Ritschl. Ma non mancano le riserve, come ci attesta la corrispondenza di questo periodo: “Io tengo molto ad uno sviluppo autonomo – e guarda con quanta facilità si può venire influenzati da uomini come Ritschl, e trascinati addirittura su binari lontani dalla propria natura” (8). Così scrive all’amico Mushacke nell’agosto del ’65, un paio di mesi prima del suo trasferimento a Lipsia, dove ha deciso di proseguire gli studi. Per una strana combinazione, anche Ritschl, i cui rapporti con Jahn sono diventati particolarmente tesi, si trasferisce da Bonn a Lipsia. E anche questo fatto ci dimostra come la scelta di Nietzsche sia frutto più del caso che di una decisione consapevole (9).
In seguito, Nietzsche parlerà dell’anno di Bonn come di “un anno che per l’assenza di ogni progetto e di ogni scopo, e per la libertà da ogni proposito sul futuro, si presenta all’odierno mio modo di sentire quasi come un sogno..” (10)
Primi passi da filologo
A Lipsia, dove risiede fino alla primavera del ’69 – con l’interruzione del servizio militare, dall’autunno del 1867 all’autunno dell’anno seguente – Nietzsche trova l’ambiente adatto alle sue aspirazioni e la serenità necessaria per concentrarsi negli studi; qui avvengono le decisive esperienze spirituali: l’incontro con la filosofia di Schopenhauer e di Lange, la conoscenza personale di Wagner; qui matura, anche in virtù di queste esperienze, la sua identità filosofica. Lo studio, inoltre, non è incompatibile con una vita sociale e mondana ricca e appagante.
Nei primi anni di Lipsia, Nietzsche, sotto la guida di Ritschl, riprende gli studi filologici con fervore: in questo contesto scaturisce la sua “vena filologica” (11). Egli entra nella cerchia dei fedelissimi di Ritschl e comincia a studiare in più ristrette cerchie di studiosi intorno a lui: dapprima nell’ “Associazione Filologica”, costituita nel dicembre del ’65; poi, all’inizio del semestre invernale 1866-67, nella Societas philologica. Importante è la partecipazione all’ “Associazione”: Nietzsche vi tiene con successo alcune conferenze, i cui argomenti val la pena indicare, perchè ci mostrano i campi d’indagine verso i quali si indirizza la sua prima attività di studioso. La prima conferenza, del gennaio 1866, sull’ Ultima redazione della silloge teognidea, è un ampliamento del lavoro di congedo di Pforta; sarà poi rielaborata e pubblicata nel 1867 sul Rheinisches Museum fuer Philologie – la rivista diretta da Ritschl – con il titolo: Per la storia della silloge teognidea.
La seconda conferenza, tenuta nel giugno del 1866, verte sulla bizantina Suda, lessico tardo-bizantino del secolo X d. C., su cui Nietzsche si è imbattuto nel suo lavoro su Teognide. Lo studio delle fonti della filosofia antica è l’oggetto della terza conferenza del gennaio del 1867, che verte sui Pìnakes, i cataloghi tramandati delle opere di Aristotele. Ma agli studi filosofici si accosta anche attraverso Diogene Laerzio, scrittore greco del III secolo d. C., una delle fonti più importanti per conoscere le dottrine dei filosofi antichi, “il guardiano notturno della filosofia greca”, come lo definisce Nietzsche. Egli è indotto ad approfondire tale autore dal tema scelto dall’università nel 1866 (“De fontibus Diogeni Laertii) per un pubblico concorso, che vince; successivamente anche questo lavoro sarà pubblicato sul Rheinisches Museum.
Gli studi omerici costituiscono la base della quarta conferenza del luglio 1867, che ha per titolo: Sull’agone degli aedi nell’ Eubea. Il mitico ‘agone’ di Omero e Esiodo viene risolto da Nietzsche nella tesi, in contrasto con la concezione dominante, che la gara, lo spirito agonistico, siano un tratto caratteristico dei Greci, un elemento fondamentale della civiltà ellenica. Le questioni della tradizione omerica lo terranno impegnato anche in seguito, fino alla celebre prolusione del 1869, su Omero e la filologia classica. Anche nel filosofo maturo i sentimenti e i comportamenti ‘agonali’, giocano un ruolo di primo piano, e vengono contrapposti allo spirito di ‘debolezza’ del cristianesimo e della morale.
Una quinta conferenza, infine, sulle satire di Varrone e il cinico Menippo, viene tenuta il 6 novembre 1868.
Il rapporto con Ritschl, rafforzato anche mediante incontri e frequentazioni regolari, diviene presto coinvolgente anche sul piano personale. “Non puoi credere infatti con quanta forza ci incateni qui la significativa personalità di Ritschl e come sarà difficile, anzi insopportabile, separarci da lui.” Scrive nel gennaio 1866 (12).
In Ritschl Nietzsche trova il maestro ideale, un modello di alto profilo etico e culturale, la guida autorevole che sa indirizzarlo, sollecitarlo. D’altra parte, Ritschl, che ha individuato l’eccezionale talento dell’allievo, sa corrispondere appieno alle aspettative: non ne incoraggia la mera erudizione, ma la ricerca autonoma. Ciò che Nietzsche va cercando è infatti il metodo. “Mi divenne chiaro allora che l’esemplarità del metodo, della trattazione di un testo ecc., è il punto da cui parte l’effetto trasformatore. Perciò mi limitai a osservare come si insegna, come si trasmette il metodo di una scienza allo spirito dei giovani” (13). Una dottrina del metodo degli studi filologici in funzione di una meta educativa: è l’oggetto della lettera a Deussen dell’aprile 1867:
“Inoltre evito con la massima cura di cadere nello sfoggio di erudizione, che sia superfluo. Anche questo richiede non poco dominio di sè. Si tratta infatti di tagliare via proprio qualche superfluum che magari ti piace moltissimo. Una rigorosa presentazione della prova, esposta in modo facile e piacevole, evitando possibilmente tutta quella serietà opprimente e quello sfoggio pedantesco di citazioni così a buon mercato: e a questo che aspiro. La cosa più difficile, sempre, è riuscire a vedere come si collegano tra loro i punti fondamentali, trovare cioè la pianta della costruzione. [..] Ogni lavoro un po’ più importante, l’avrai notato anche tu, influisce sulla sfera etica. Lo sforzo di esporre in sintesi e in modo armonico un certo argomento, agisce come una pietra che cade sulla nostra vita spirituale: dal primo cerchio ristretto se ne formano altri più ampi” (14).
Grandi maestri
Ma Ritschl non è l’unico modello di riferimento per Nietzsche. Nei primi mesi di Lipsia avviene il famoso incontro con la filosofia di Schopenhauer, di cui Nietzsche legge il capolavoro, Il mondo come volontà e rappresentazione. Ma su questo punto occorre fare una precisazione. Va ridimensionata la vulgata di una ‘folgorazione’ di Nietzsche ‘sulla via di Lipsia’: lo stesso Nietzsche l’ha accreditata, descrivendo in una celebre pagina autobiografica, l’episodio della scoperta, presso un antiquario, del libro e della successiva lettura, quasi si trattasse di un appuntamento col destino (15). Certamente l’impatto con la filosofia di Schopenhauer è un’esperienza travolgente, tale da lasciare tracce profonde nel pensiero di Nietzsche. Ma ciò nonostante, il suo atteggiamento non è quello del credente; egli, al contrario, fin dall’inizio, è lettore attento e critico. I dubbi, i rilievi di Nietzsche si appuntano in particolare sul concetto di cosa in sè, che Schopenhauer ha mutuato da Kant; nella primavera del 1868 egli elabora uno scritto, intitolato Su Schopenhauer (16). La volontà schopenhaueriana, questa parola “dal conio grossolano”, scrive Nietzsche, “é generata soltanto grazie ad una intuizione poetica”; gli stessi predicati della volontà, ossia di qualcosa “che è per definizione impensabile, sono fin troppo determinati e tutti ricavati dall’antitesi con il mondo della rappresentazione: mentre tra la cosa in sè e il fenomeno neppure il concetto di antitesi ha senso” (17). In definitiva, affermando che la volontà viene determinata di sottobanco con predicati “presi in prestito dal mondo fenomenico” (18), Nietzsche colpisce al cuore il sistema di Schopenhauer. Vale la pena riflettere sul fatto che lo “schopenhauerismo” di Nietzsche ha alla sua base una così radicale confutazione del sistema. Ma le obiezioni teoretiche non sminuiscono, agli occhi di Nietzsche, il valore della personalità etica; Nietzsche non aderisce tanto ad una filosofia, quanto ad un filosofo. Nel medesimo scritto troviamo la seguente affermazione: “Per gli errori dei grandi uomini occorre avere rispetto perchè sono più fecondi delle verità dei piccoli” (19).
Come è stato per Ritschl, e come sarà per Wagner, gioca l’importanza del modello: Schopenhauer è lo spirito originale e indipendente che si erge sopra la meschinità del presente, il pensatore alieno da compromessi, consacrato alla verità: egli diverrà per Nietzsche, secondo la formulazione della terza Inattuale, l’educatore. “Il meglio che noi possediamo”, scrive all’amico Deussen, è “sentirsi tutt’uno con un grande spirito, riuscire a seguire il filo dei suoi pensieri in perfetto accordo, aver trovato una patria del pensiero, un luogo di rifugio per i momenti di sconforto..” (20)
Inoltre, il pessimismo schopenhaueriano offre a Nietzsche la medesima visione tragica della vita che è alla base della tragedia greca (21). In quest’ottica, Schopenhauer e l’amato mondo classico, filosofia e filologia, trovano un punto di incontro. Ma su un altro piano classicità e filosofia schopenahueriana si collegano, ed è là dove Nietzsche comincia a pensare a un nuovo modello di grecità, tale da superare la decadenza nella quale si è involuta la civiltà moderna.In un appunto della primavera-autunno 1868, è anticipato lo schema della Nascita della tragedia: “Schopenhauer è il filosofo di una ridestata classicità, di una grecità germanica. Schopenhauer è il filosofo di una Germania rigenerata” (22).
Anche l’atteggiamento di Nietzsche per Ritschl non è esente da rilievi critici. Egli osserva, ad esempio, che il maestro tendeva “a sopravvalutare la propria disciplina ed era quindi contrario a che i filologi si occupassero troppo intensamente di filosofia”; per contro, “cercava di far sì che i suoi allievi divenissero utili alla scienza il più presto possibile”, per cui sollecitava troppo precocemente “la vena produttiva di ciascuno” (23). A volte, lamenta che gli studi filologici non gli abbiano permesso di approfondire quegli scientifici; certo, non può condividere le riserve di Ritschl nei confronti della filosofia, soprattutto dopo che Schopenhauer ha risvegliato improvvisamente le energie filosofiche finora sopite. Perciò nel rapporto con Ritschl viene ad inserirsi un ostacolo nascosto, che determina una sorta di ‘doppiezza spirituale’, come la chiama Janz. Ciò non può non ripercuotersi sullo stesso lavoro filologico, come ci testimonia puntualmente l’epistolario. Nel marzo 1866, scrive all’amico Hermann Mushake che sta sprofondando “in quello stato di insensibilità ottusa” indotto dal suo lavoro “di taglialena filologico” (24) . Un mese dopo, riferendo all’amico Carl von Gersdorff del suo scritto su Teognide, afferma:
“Del resto non posso nemmeno negare che non riesco a capire perchè mai mi sono addossato questa preoccupazione, che mi allontana da me stesso (e inoltre da Schopenhauer, che spesso è la stessa cosa), che con le sue conseguenze mi espone al giudizio della gente e, se possibile, mi costringe addirittura a indossare la maschera di una erudizione che io non posseggo” (25).
Si tratta per il momento di frasi isolate, che riflettono umori sporadici, e si alternano a passi di tutt’altro tono; in questa fase filologia e filosofia procedono ancora parallelamente. Dall’epistolario emerge un Nietzsche sprofondato nel lavoro, che, mentre intensifica i riferimenti al filosofo di Danzica, si compiace per i progressi della società filologica. Egli sta vivendo la sua più felice e produttiva stagione di filologo. In una lettera del settembre 1866, indirizzata a Paul Deussen, parlando della filologia, afferma, ad esempio: “Questo è uno studio che costa qualche goccia di sudore, ma che compensa effettivamente ogni fatica. Questa sensazione, forte e corroborante, di avere un compito per la vita, si fa strada assai presto nell’anima del vero filologo” (26).
Verso la filosofia
Schopenhauer non esaurisce l’orizzonte filosofico di Nietzsche. Nei primi anni di Lipsia egli completa la conoscenza di vari autori: Friedrich Strauss, Hegel, Kant – approfondito attraverso la monografia di Kuno Fischer – Duehring. Ma l’opera di maggiore influenza – secondo Janz, addirittura superiore a quella dello stesso Schopenhauer – è la Storia del materialismo di Friedrich Albert Lange. Nietzsche la legge subito dopo la sua pubblicazione, nell’estate del 1866, e ne rimane fortemente colpito. “L’opera filosofica – scrive – più importante che sia apparsa negli ultimi decenni, della quale potrei scrivere un elogio di pagine e pagine. Kant, Schopenhauer e questo libro – tanto mi basta” (27).
Friedrich Lange, insieme a Kuno Fisher, è uno di quei pensatori che, prendendo le mosse da Kant, anticipano quella filosofia del neo-criticismo, le cui manifestazioni più significative sono la Scuola del Baden e la Scuola di Marburgo. Lange, scrittore della sinistra borghese, è una personalità indipendente e rigorosa. Dalla lezione kantiana egli sviluppa una concezione lontana da ogni dogmatismo, che spazia dalla filosofia antica, nella quale Democrito occupa un posto di rilievo, fino alle problematiche moderne, al darwinismo e alle correnti economiche e politiche. Lange, pur negando ogni validità conoscitiva alla metafisica, le riconosce una funzione edificante, consistente nel dare espressione a immagini e sistemi esaltanti: non è, quindi, scienza, bensì una forma d’arte per la quale Lange conia l’espressione di “libera poesia concettuale” (28).
La stessa lettura di Schopenhauer è influenzata da Lange. Negli appunti citati Su Schopenhauer, Nietzsche estende a Schopenhauer la critica che Lange rivolgeva a Kant, di essere, cioè, la cosa in sè, una categoria nascosta; e considera anche la filosofia schopenhaueriana un esempio di Begriffsdichtung. Alla base di questo concetto vi è la convinzione, mutuata sia da Schopenhauer che da Lange, che la realtà in sè sia alogica: ne deriva che la filosofia, a cui è preclusa l’essenza delle cose, non sia distinta dall’arte, e ad essa sia affidato un compito pratico, di elevazione. “Se la filosofia ha il compito di elevare – scrive a Gersdorff -, allora non conosco nemmeno un filosofo che elevi più del nostro Schopenhauer” (29). E a Deussen, nella primavera del ’68: “Il regno della metafisica, e con esso l’area della verità ‘assoluta’, è stato innegabilmente inserito in un’unica categoria insieme con la religione e la poesia” (30).
La filosofia speculativa è edificazione: è una concezione che si sedimenta nell’animo di Nietzsche, e che permane anche nel futuro filosofo. Per esempio, in Umano, troppo umano, il libro che apre la grande stagione delle opere aforistiche, dove pure egli effettua la “grande separazione” dai modelli che in precedenza venerava, come l’arte di Wagner e la filosofia di Schopenhauer. All’inizio, nel primo gruppo di aforismi, viene trattato il rapporto tra scienza e metafisica: la prima, che non si propone scopi consolatori, è volta unicamente alla conoscenza “qualunque cosa ne debba risultare” (aforisma 6); la seconda, al contrario, non tende alla verità, ma produce quelle concezioni per mezzo delle quali l’uomo “vive più felice” (aforisma 7). In particolare, all’aforisma 6, si dice:
“Nella filosofia poi, in quanto culmine dell’intera piramide del sapere, viene involontariamente sollevata la questione dell’utilità della conoscenza in genere, e ogni filosofia ha inconsciamente l’intento di ascriverle la più alta utilità. [..] E’ questo l’antagonismo fra i singoli campi scientifici e la filosofia. Quest’ultima vuole, come vuole l’arte, dare al vivere e all’agire la massima profondità e il massimo significato possibili” (31)
Ma Lange amplia le conoscenze di Nietzsche anche sugli inizi della filosofia greca, contribuisce ad affinare il suo sguardo su un mondo fino ad allora poco conosciuto. I filosofi presocratici erano trascurati dalla filosofia tradizionale, per la quale rappresentavano, come scrive Althaus, “una fase storica precivilizzata, pre-razionale, che Socrate e i suoi allievi avevano illuminato della loro luce” (32). Ora Nietzsche, sotto l’influenza di Lange, viene introdotto al materialismo di Democrito, che già aveva studiato da un punto di vista filologico. I lavori su Democrito, rielaborati in un’ottica filosofica, lo tengono occupato soprattutto nel periodo del servizio militare. “Per ora sono molto ottimista circa questo lavoro: – comunica a Rhode nel febbraio del ’68 – è andato acquistando uno sfondo filosofico, cosa che non ero mai riuscito a fare in nessuno dei miei lavori” (33).
In marzo, Nietzsche, che presta servizio come artigliere a cavallo, in seguito ad una brutta caduta, si procura uno strappo muscolare con complicazioni varie, ed è costretto ad un ozio forzato di parecchi mesi. Ne approfitta per dedicarsi con una maggiore concentrazione ai suoi lavori. “Lavoro, finchè c’è luce, di gran lena ai ‘philologica’ “, scrive a Rohde (34). Consegna a Ritschl il suo saggio sulla Lamentatio Danae di Simonide, che viene pubblicato sul Rheinisches Museum. Intanto progetta un viaggio a Parigi per l’anno successivo, e comincia a pensare alla tesi per il dottorato. Ne parla, a maggio, con l’amico Rohde: dapprima vuole scrivere una dissertazione di carattere filosofico, (“sul concetto di organico da Kant in poi”, ovvero “sulla teleologia”) (35) . Ma dopo un mese abbandona questo progetto, optando per una questione filologica più limitata: se i diversi padri, che gli storici della letteratura greca attribuiscono ai poeti, ai filosofi, agli oratori, siano fittizi o no. Nella lettera a Rohde, Nietzsche prefigura la sua situazione futura: la professione di filologo gli appare come la più certa, e ne esamina con distacco vantaggi e svantaggi. Dice di affrontare “senza speranze eccessive”, la carriera accademica, ma, nondimeno, questa può consentirgli “una posizione abbastanza indipendente dal punto di vista sia politico che sociale” e garantirgli “di dedicarsi con agio ai propri studi” (36).
Ma è proprio in questo periodo che si fa più evidente l ‘insofferenza di Nietzsche per i limiti che la filologia rigorosa impone e, in modo particolare, per l’ambiente accademico. Non è un atteggiamento improvviso; anche in precedenza, come si è visto, non mancavano i dubbi. Nella lettera dell’aprile 1867 a Gersdorff, le critiche diventano più specifiche; egli rimprovera ai filologi la visione angusta, l’incapacità di cogliere “quella esaltante visione complessiva dell’antichità”, dovuta al fatto che “essi si pongono troppo vicino al quadro e indagano su una macchiolina d’olio, invece di ammirare i tratti grandiosi e audaci dell’intero dipinto e, cosa ancora più importante, di goderne” (37).
Sono indicative di questo atteggiamento le lettere a Paul Deussen dell’estate-autunno 1868. In giugno, durante la malattia, scrive:
“Nella maggior parte dei filologi, si annida da qualche parte una certa stortura morale; ciò trova la sua spiegazione in parte addirittura sul piano fisico, in quanto essi vengono costretti a fare una vita contro natura, a rimpinzare il loro spirito con alimenti assurdi, a trascurare il loro sviluppo interiore a scapito della memoria e del giudizio. Persino la capacità, così bella, di entusiasmarsi è rarissima tra i filologi attuali: suoi squallidi surrogati sono la presunzione e la vanità” (38)
In settembre riprende l’argomento: “Credimi però: le qualità necessarie per produrre qualcosa di lodevole in campo filologico sono incredibilmente modeste e chiunque, purchè collocato al posto ‘giusto’, impara il suo mestiere.” Dopo qualche giorno ritorna sul medesimo motivo:
“Addirittura ho l’impressione che proprio le opere dei filologi meritino meno di tutte le altre ammirazione, riconoscimento di qualità geniali eccetera, [..] in sostanza, queste opere diligenti sono il prodotto di una mente assolutamente mediocre, una mente che ignora più alte e più valide sfere del pensiero o per lo meno, non riesce ad elaborarle con profitto, limitandosi a rovistarci dentro” (39).
A ottobre, all’amico che aveva definito la filologia come figlia della filosofia, risponde, rincarando la dose: “Se vuoi ch’io faccia della mitologia, allora la filologia mi appare come un aborto della dea filosofia, concepito con un idiota o un cretino” (40).
La situazione, a ben vedere, è paradossale: l’estraniazione Di Nietzsche dalla filologia sembra crescere proprio in proporzione ai suoi successi come filologo. Egli infatti, finito nell’ottobre 1868 il servizio militare, sta accrescendo il suo prestigio e consolidando la sua posizione di filologo: è collaboratore sia dei Jahrbuecher fuer Philologie, sia del Litterarisches Centralbatt, oltre che, naturalmente, del Rheinesches Museum. I suoi lavori gli procurano una certa fama, e attirano su di lui l’attenzione dell’Università di Basilea; nel gennaio del 1869, Nietzsche, ventiquattrenne non ancora laureato, è chiamato alla cattedra di lingue e letteratura greca in questa università. Grande è la gioia del neo professore straordinario, ma insieme all’entusiamo si fa strada la consapevolezza dell’ironia del “diavolo destino”. Il 16 gennaio scrive a Rohde: “Il fato si prende davvero gioco di noi: non più tradi della settimana scorsa volevo scriverti per proporti di studiare insieme chimica, e di gettare la filologia tra gli utensili domestici dei nostri progenitori, dove è il suo posto. Ora il diavolo ‘destino’ mi getta l’esca di una cattedra di filologia” (41).
L’ultimo periodo di Lipsia
Nietzsche cerca di superare il conflitto tra professione e vocazione in due modi contraddittori: da un lato, mediante un compromesso, che comporti una separazione, una netta distinzione dei ruoli. Come si è visto nella lettera a Rohde del maggio, ritiene che la professione accademica gli consenta l’indipendenza e la tranquillità necessarie per dedicarsi ai suoi interessi più veri. E che questo possa essere il motivo che lo porta ad abbandonare la dissertazione su Kant per il dottorato, lo si evince da una lettera di giugno a Deussen: “Scegli pure, per la tua formazione, i problemi più ardui e più belli; per una dissertazione invece l’angolino più modesto e più appartato, e niente di più. Pensi forse che, quando lavoro su Laertio e Suida, io mi trovi in uno stato d’animo così beato e perfetto come quando leggo, per esempio, il Faust o Schopenhauer?” (42)
Ma, dall’altro lato, egli mira anche ad un progetto culturale alto, in cui filologia e filosofia siano armonizzate; in questo secondo contesto, tuttavia, la filologia si trova subordinata ad una meta filosofica. Per comprendere meglio questo punto, leggiamo il seguente passo dalla lettera del febbraio ’68 a Rohde, in cui Nietzsche parla del suo lavoro su Democrito:
“I miei lavori prendono tutti una certa direzione e indicano tutti, come tanti pali del telegrafo, una meta dei miei studi, che ora non voglio più perdere di vista. Tale meta è una storia degli studi letterari nell’antichità e nell’epoca moderna. Per il momento non mi interessano molto i dettagli; quello che ora mi attrae è l’elemento universalmente umano, è vedere come nasce l’esigenza di un’indagine storico letteraria e come questa prenda forma tra le mani plasmatrici del filosofo” (43).
Come emerge anche dai frammenti di questo periodo (44), Nietzsche sta lavorando ad un’esposizione degli ‘studi di storia letteraria’, dalla quale il ruolo della filologia esce ridimensionato. Egli critica infatti l’ottica miope, la visione ristretta dei filologi, l’incapacità di pensare in grande. L’operazione è ispirata dalla concezione schopenhaueriana del genio, della forza esemplare delle grandi personalità. “L’uguale conosce l’uguale. E’ possibile mostrare come ogni grande concezione letteraria risalga ai grandi ingegni affini [..] Il grande canone dei classici è stato formato via via dai classici stessi” (45). Gli stessi concetti sono espressi nella lettera a Rohde del febbraio:
“Il fatto che tutti i concetti chiarificatori, nella storia letteraria, noi li abbiamo ricevuti da quei pochi uomini di genio che vivono nelle parole dei dotti; che tutti i lavori buoni e proficui, in questo campo, non sono stati altro che applicazioni pratiche di quelle idee tipiche; che in tal modo l’elemento creativo, nell’indagine letteraria, è proprio di coloro che personalmente non si dedicarono affatto, o si dedicarono limitatamente, a questo genere di studi; [..]: tutte queste considerazioni fortemente pessimistiche, che comportano un nuovo culto del genio, persistono nella mia mente e mi invogliano a fare una verifica storica alla luce delle medesime”. E conclude: “..ho l’impressione infatti che tu, leggendo queste righe, debba sentirci lo zampino di Schpenhauer” (46).
La filosofia di Schopenhauer è dunque alla base della crisi d’identità filologica di Nietzsche, ma non nel senso che la prima scalza semplicemente la seconda, bensì nel senso che Nietzsche è sollecitato dalla filosofia schopenhaueriana a ridefinire il ruolo e i compiti del lavoro filologico. Egli si trova in questa situazione di crisi, quando conosce personalmente Richard Wagner. L’incontro non modifica la traiettoria spirituale di Nietzsche, ma piuttosto la radicalizza, esasperando le tensioni e i conflitti. Mentre contribuisce ad aumentare l’insofferenza di Nietzsche verso la filologia ed i filologi, gli indica anche una direzione, una nuova finalità etico-culturale.
Nietzsche aveva sempre avuto nei confronti di Wagner un atteggiamento sostanzialmente critico, non privo di sentimenti contrastanti. “A grandi bellezze e virtutes, scrive all’amico Gersdorff nell’ottobre del 1866, fanno da contrappeso altrettanto grandi bruttezze e difetti” (47). Ma a partire dal suo ritorno a Lipsia, pur mantenendo delle riserve, comincia a manifestare una diversa disposizione. In ottobre, comunica a Rohde di aver letto i saggi di Jahn su Wagner, e, in contrasto con l’autore, ne ammira “l’energia inesauribile” e il “talento artistico multiforme”. E’ pur vero che lo considera come il “rappresentante di una forma moderna di dilettantismo”, ma poi afferma perentorio: “A me piace in Wagner ciò che mi piace in Schopenhauer: il soffio etico, il profumo faustiano, la croce, la morte, la tomba eccetera” (48)
Alla fine di ottobre ascolta il preludio del Tristano e l’ouverture dei Maestri Cantori, che lo riempie di entusiasmo; e proprio i Maestri Cantori diventano l’occasione per la conoscenza personale del Maestro. Wagner in quei giorni si trovava a Lipsia, ospite della sorella Ottilie; quando suona la canzone dei Maestri Cantori per la sorella e per l’amica di lei, la signora Ritschl, questa riferisce di averla già ascoltata da un giovane filologo, allievo del marito; Wagner allora manifesta il desiderio di conoscerlo. L’incontro, che avviene in casa della sorella l’ 8 di novembre, è descritto da Nietzsche il giorno immediatamente successivo, in una lunga e partecipata lettera a Rohde. Egli ripercorre minuziosamente i momenti di quella serata emozionante, costellata anche da piccoli incidenti (manca l’abito da sera, il sarto che non si fa vivo, la zuffa con il lavorante del sarto, ecc.), quasi presaghi dell’evento fatale.
Wagner appare subito a Nietzsche come il grand’uomo, “l’esemplificazione più viva di ciò che Schopenhauer chiama un genio” (49); e la musica di Wagner come un “mare di suoni schopenhaueriano” (50). L’ effetto più immediato è quello di far risaltare la meschinità dell’ambiente in cui Nietzsche vive:
“Ora che rivedo da vicino quella brulicante genia di filologi dei giorni nostri – scrive a Rodhe nel novembre – ; ora che mi tocca contemplare ogni giorno tutto questo affacendarsi da talpe, con le cavità mascellari rigonfie e lo sguardo cieco, contente di essersi accaparrate un verme, e indifferenti verso i veri, urgenti problemi della vita..” (51)
L’immagine grottesca della talpa, fa venire in mente il personaggio del “Coscienzioso dello spirito”, descritto nello Zarathustra, ossia dell’uomo di scienza parcellizzato, che ha dedicato la propria vita allo studio del cervello della sanguisuga, e vive immerso in una palude. Ma al di là degli elementi grotteschi, questi rilievi nei confronti dei filologi sono analoghi agli altri di questo periodo. Si è visto che la filosofia di Schopenhauer sia l’ispiratrice di quei rilievi; Schopenhauer si deve considerare anche l’artefice della ‘seduzione’ di Nietzsche, e non solo per il fatto che l’amicizia fra Nietzsche e Wagner nasce e si consolida sulla base del comune interesse per il filosofo di Danzica, ma anche e soprattutto perchè questa filosofia ha agito nel senso di una predisposizione. La dottrina della musica come la più sublime delle arti, la concezione del genio, una particolare sensibilità artistico-filosofica, si erano già sviluppate nell’animo di Nietzsche; la conoscenza di Wagner non fa che rafforzarle. Anche per quanto riguarda la filologia, lo ‘spirito della musica wagneriano’ opera nel solco già tracciato dalla filosofia di Schopenhauer: ne viene fuori una concezione che vuole unificare filologia, arte e filosofia, e che ora non è più professata nel privato di una corrispondenza o di un quaderno di appunti, ma apertamente dichiarata. Mi riferisco alla prolusione su Omero e la filologia classica, che egli pronuncia a Basilea il 28 maggio 1869, all’atto di assumere il nuovo ruolo di professore universitario.
Nella sua dissertazione, Nietzsche ripercorre per linee generali la questione omerica, per esaminare lo stato di salute della filologia, che, dilaniata tra spinte interne contrastanti, vive una acuta contraddizione tra arte e scienza. “La vita è degna di essere vissuta, dice l’arte, la più bella seduttrice; la vita è degna di essere conosciuta, dice la scienza” (52). Il rapporto vita – conoscenza ritornerà più volte nel corso dell’ elaborazione teorica; nelle prime opere, l’antitesi sarà risolta in favore dell’arte; in questo contesto, ragioni di opportunità impongono soluzioni conciliatorie e ottimistiche. La filologia può “colmare l’abisso” fra “antichità ideale” e “antichità reale”, ed arrivare a comprendere veramente lo spirito dell’antichità, a patto di avvalersi dell’ indispensabile “sostegno degli artisti e delle nature artistiche” (53). E la stessa questione omerica ci mostra appunto “come i filologi abbiano vissuto quasi un secolo intero insieme a poeti, pensatori e artisti” (54). Poi Nietzsche conclude la sua prolusione con queste parole:
“Anche a un filologo ben si addice di racchiudere il fine delle sue aspirazioni e la via che deve portarvi nella breve formula di una confessione di fede; e lo farò invertendo a questo modo una frase di Seneca: philosofia facta est quae philologia fuit. Con ciò si vuole dire che ogni attività filologica dev’essere racchiusa e circondata da una concezione filosofica del mondo..” (55).
In sostanza, Nietzsche indica i veri artefici di una riforma della filologia nel filosofo e nell’artista: un modo indiretto di riferirsi a Schopenhauer e a Wagner, di esaltarne la centralità.
Note
(1) Horst Althaus: Friedrich Nietzsche. Eine buergerliche Tragoedie, Muenchen 1985. Trad. it.: Nietzsche. Una tragedia borghese, Laterza, Roma-Bari 1994, p. 39.
(2) Hans M. Wolff: Friedrich Nietzsche. Der Weg zum Nichts, Bern 1956. Trad. it.: Friedrich Nietzsche. Una via verso il nulla, Il Mulino, Bologna 1975, p. 13.
(3) Gianni Vattimo: Friedrich Wilhelm Nietzsche, in: Grande Antologia Filosofica, Marzorati, Milano 1976, vol. XXV. Si veda in particolare il par. 1, Nietzsche filologo.
(4) Curt Paul Janz: Friedrich Nietzsche Biographie, Muenchen 1978; trad. it. Vita di Nietzsche, Laterza, Roma-Bari 1980. Dei tre volumi che compongono l’opera, si veda, in particolare, il primo (Il profeta della tragedia).
(5) C. P. Janz, op. cit., p. 104.
(6) F. Nietzsche: Appunti filosofici 1867-1869, Adelphi, Milano 1993, p. 131.
(7) H. Wolff: op. cit., p.22.
(8) F: Nietzsche: Epistolario, 1850-1869, Adelphi, vol. I, Milano 1976, lettera del 30 agosto 1865 a Hermann Mushacke, p. 379.
(9) Come sostiene Janz – op. cit., p.136 – Nietzsche non ‘seguì’ Ritschl, come è stato detto più volte, ma si decise per Lipsia in seguito alle sollecitazioni dell’amico Carl von Gersdorff, un mese prima della nomina di Ritschl.
(10) F. Nietzsche: Sull’avvenire delle nostre scuole, Adelphi, Milano 1992, I conferenza, pp. 14-15.
(11) F. Nietzsche: Epistolario, cit., lettera della prima metà del lugio 1867 a Hermann Mushacke, p. 525.
(12) Ivi., lettera del 15 gennaio 1866 a Edmund Oehler, p. 406. Lo stesso concetto è espresso, un anno dopo, all’amico Deussen: “Non puoi credere come mi sento strettamente legato a Ritschl, a tal punto che non posso né voglio staccarmene”. (Lettera del 4 aprile 1867, p. 509).
(13) F. Nietzsche: La mia vita, Adelphi, Milano 1955, p. 161.
(14) F. Nietzsche: Epistolario, cit., lettera del 4 aprile 1867 a Paul Deussen, pp. 510-11.
(15) Cfr. F. Nietzsche: La mia vita, cit., p. 163.
(16) F. Nietzsche: Appunti filosofici, cit., pp. 92-107.
(17) Ivi, p. 96.
(18) Ivi, p. 99.
(19) Ivi, p. 95.
(20) F. Nietzsche: Epistolario, cit., lettera dell’ottobre-novembre 1867 a Paul Deussen, pp.534-35.
(21) Un altro campo di indagine che occupa Nietzsche in questo periodo è rappresentato da Eschilo: anche questo fatto contribuisce ad accostare Nietzsche alla tragedia. Come nota Althaus, Eschilo è il più antico e il più oscuro dei tragediografi, colui che affonda le sue radici nel mondo pre-ellenico, “nel più primitivo e sanguinoso sostrato della ‘tragedia’ “. (H. Althaus, op. cit., p. 62).
(22) F. Nietzsche: Appunti filosofici, cit., p. 176.
(23) F. Nietzsche: La mia vita, cit., p. 170.
(24) F: Nietzsche: Epistolario, cit., lettera del 14 marzo 1866 a Hermann Mushacke, p. 416
(25) Ivi., lettera del 7 aprile 1866 a Carl von Gersdorff, p. 421. Su queste perplessità di Nietzsche sul proprio lavoro, cfr. anche la lettera dell’agosto 1866 a Gersdorff, cui confida, dopo aver terminato finalmente il Teognide: “Non ho mai scritto tanto di malavoglia”. (Ivi, p. 459).
(26) F. Nietzsche: Epistolario, cit., lettera del settembre 1866 a Paul Deussen, p. 466.
(27) Ivi., lettera del novembre 1866 a Hermann Mushake, pp. 488-89.
(28) “Freie Begriffsdichtung“; cfr. F. A. Lange: Geschichte des Materialismus, Iserlohn 1866, p. 545.
(29) F. Nietzsche: Epistolario, cit., lettera di fine agosto 1866 a Carl von Gersdorff, p.463.
(30) Ivi., lettera di fine aprile-primi di maggio 1868 a Paul Deussen, p. 575.
(31) F. Nietzsche, Umano, troppo umano, vol. primo, Adelphi, Milano 1982, pp. 18-19.
(32) H. Althaus, op. cit., p. 73.
(33) F. Nietzsche: Epistolario, cit., lettera dell’1-3 febbraio 1868 a Erwin Rohde, p. 554.
(34) Ivi, lettera del 6 giugno 1868 a Erwin Rohde, p. 596.
(35) Ivi, lettera del 3 o 4 maggio 1868 a Erwin Rohde, p. 581.
(36) Ivi, p. 583.
(37) Ivi, lettera del 6 aprile 1867 a Carl von Gersdorff, p. 515. Cfr. anche gli appunti di questo periodo. Scrive, ad esempio: “La maggior parte dei filologi sono oprai di fabbrica al servizio della scienza. Viene meno l’inclinazione ad abbracciare una totalità più ampia o a mettere al mondo nuovi punti di vista. I più lavorano invece con solerzia e persistenza a una piccola vite”. (Appunti filosofici, cit., p. 68).
(38) Ivi., lettera del 2 giugno 1868 a Paul Deussen, p. 590.
(39) Ivi, lettera del setttembre-ottobre 1868 a Paul Deussen, p. 627.
(40) Ivi, lettera della seconda metà dell’ottobre 1868 a Paul Deussen, p. 636.
(41) Ivi., lettera del 16 gennaio 1869 a Erwin Rohde, p. 667.
(42) Ivi, lettera del 22 giugno 1868 a Paul Deussen, p. 598.
(43) Ivi, lettera dell’ 1-3 febbraio 1868 a Erwin Rohde, p. 554.
(44) Cfr. ad es. il Quaderno PI 4a dell’autunno 1867 – primavera 1868, in Appunti filosofici, cit, pp. 66-72. Cfr. anche l’ Introduzione di Giuliano Campioni e Federico Gerratana.
(45) F. Nietzsche: Appunti filosofici, cit., p.70.
(46) F. Nietzsche: Epistolario, cit., lettera dell’1-3 febbraio 1868 a Erwin Rohde, pp. 554-55. Cfr. anche la lettera a Gersdorff del 16 febbraio 1868, p.562: “Come ti spiegherò un’altra volta, porrò a sfondo del tutto [‘un’esposizione degli studi letterari degli antichi’] alcune tesi marcatamente pessimistiche, cosicchè l’insieme risulterà fortemente pervaso di un’atmosfera schopenhaueriana”. Nonchè la lettera a Deussen del settembre 1868, pp.622-23: “Anche i nostri massimi talenti filologici, infatti, sono solo relativamente dei datori di lavoro: se ci si pone da un punto di vista più elevato, che consenta una prospettiva storica della cultura, si vede come anche queste menti in fondo non siano che operai, e precisamente al servizio di qualche semidio della filosofia (il più grande dei quali, in tutto l’ultimo millennio, è Schopenhauer)”.
(47) Ivi, lettera dell’11 ottobre 1866 a Carl von Gersdorff, p. 478.
(48) Ivi., lettera dell’8 ottobre 1868 a Erwin Rohde, p. 629.
(49) Ivi, lettera del 9 dicembre 1868 a Erwin Rohde, p.660.
(50) Ivi, pp.660-61.
(51) Ivi, lettera del 20 novembre 1868 a Erwin Rohde, p. 651.
(52) F. Nietzsche: Omero e la filologia classica, Adelphi, Milano 1993, p. 222.
(53) Ivi, p. 221.
(54) Ivi, p. 244.
(55) Ivi, p. 245.
PENSIERI DI NIETZSCHE SU VARI PERSONAGGI
OMERO
Il fatto più grande nella cultura greca rimane comunque questo, che Omero sia divenuto così per tempo panellenico. Tutta la libertà spirituale e umana che i Greci raggiunsero é da riportare a questo fatto. Nello stesso tempo però esso fu anche la tipica fatalità della cultura greca, perchè Omero appiattì, centralizzando, e dissolse i più seri istinti di indipendenza. Di tempo in tempo si elevò dal più profondo della natura greca la protesta contro Omero; ma egli rimase sempre vittorioso. Tutte le grandi potenze spirituali esercitano, oltre alla loro azione liberatrice, anche un’azione oppressiva; ma certo fa differenza che sia Omero o la Bibbia o la scienza a tiranneggiare gli uomini. (Umano, troppo umano; af. 262)
ERACLITO
Metto da parte, con sommo rispetto, il nome di Eraclito. Se il restante popolo dei filosofi rigettava la testimonianza dei sensi, perchè questi indicavano molteplicità e cambiamento, egli rifiutava la loro testimonianza perchè essi mostravano le cose come se avessero durata e unità. Anche Eraclito fece torto ai sensi. Essi non mentono nè nel modo che credevano gli Eleati, nè in quello che credeva lui- in generale essi non mentono. E’ soltanto quel che noi facciamo della loro testimonianza che introduce in essi la menzogna, per esempio la menzogna dell’unità, la menzogna della causalità, della sostanza, della durata… La “ragione” é la causa del nostro falsificare la testimonianza dei sensi. In quanto essi ci mostrano il divenire, lo scorrere, il cambiamento, non mentono… Ma Eraclito avrà ragione in eterno nell’affermare che l’essere é una vuota finzione. Il mondo “apparente” é l’unico mondo: il “vero mondo” é solo un’aggiunta mendace… (Crepuscolo degli idoli)
PARMENIDE
Parmenide ha detto: “non si pensa ciò che non é”- noi assumiamo la posizione diametralmente opposta e diciamo: “ciò che può venir pensato, deve sicuramente essere una finzione”. (La volontà di potenza, af. 539)
SOFISTI
I sofisti non sono altro che dei realisti: riformulano tutti i valori e le pratiche più comuni elevandole al grado di valori- hanno il coraggio, proprio di tutti gli spiriti forti, di conoscere la loro immoralità. Si crede forse che quelle piccole libere città greche, che volentieri si sarebbero divorate fra loro per rabbia e gelosia, fossero guidate da princìpi di filantropia e onestà? Si rimprovera forse a Tucidide quel discorso che egli fa pronunciare agli ambasciatori ateniesi inviati a Melo per trattarne la distruzione o la sottomissione? Parlare di virtù in mezzo a queste terribili tensioni era possibile solamente a dei perfetti Tartufi- o a gente che viveva appartata, a eremiti, a gente fuggita o uscita dalla realtà… Tutta gente che diceva di no per poter vivere. I sofisti erano greci: quando Socrate e Platone presero le parti della virtù e della giustizia, furono ebrei, o non so cos’altro. La tattica del Grote per difendere i sofisti é sbagliata: vuole elevarli al grado di uomini d’onore e di vessilliferi della morale- ma il loro onore fu quello di non imbrogliare nessuno con le grandi parole e le grandi virtù… (La volontà di potenza, af. 429)
SOCRATE
Per i suoi natali Socrate apparterrebbe al popolo minuto: Socrate era plebe. E’ noto, e lo si può vedere anche oggi, quanto egli fosse brutto. Ma la bruttezza, un’obiezione di per se stessa, é tra i Greci quasi una confutazione. E Socrate era poi veramente un greco? La bruttezza é abbastanza spesso l’espressione di uno sviluppo ibrido, ostacolato dall’incrocio. In altri casi, essa appare come un’involuzione nello sviluppo. Gli antropologi che si interessano di criminologia ci dicono che il delinquente tipico é brutto: monstrum in fronte, monstrum in animo. Ma il delinquente é un décadent. Era Socrate un delinquente tipico? Per lo meno a ciò non contraddice quel famoso giudizio fisionomico che aveva un suono così urtante per gli amici di Socrate. Uno straniero che si intendeva di facce, allorchè venne ad Atene, disse in faccia a Socrate che egli era un monstrum- che nascondeva in sè tutti i vizi e le bramosie peggiori. E Socrate si limitò a rispondere: “Lei mi conosce, signore!”. E’ un indice della décadence in Socrate non solo la confessata sregolatezza e anarchia degli istinti; precisamente a essa rinvia anche la superfetazione della logica e quella malvagità da rachitico che lo caratterizza. Non dimentichiamo nemmeno quelle allucinazioni acustiche che sono state interpretate in senso religioso, come il demone socratico. Tutto in lui é esagerato, buffo, caricatura, tutto é al tempo stesso occulto, pieno di secondi fini, sotterraneo. Cero di capire da quale idiosincrasia provenga quell’equazione socratica di ragione= virtù=felicità: la più stravagante equazione che sia mai esistita e che ha contro di sè, in particolare, tutti gli istinti dei più antichi Elleni. Con Socrate il gusto dei Greci degenera a favore della dialettica: che cosa avviene esattamente in questo momento? Innanzitutto viene sconfitto in tal modo un gusto aristocratico; con la dialettica la plebe rialza il capo. (Il crepuscolo degli idoli)
Questo brusco rovesciamento del gusto a favore della dialettica é un grande punto interrogativo. Che cosa accadde propriamente? Socrate, il plebeo che impose quel cambiamento, ottenne la vittoria sopra un gusto più nobile, il gusto di chi eccelle: la plebe giunse alla vittoria grazie alla dialettica. Prima di Socrate, tutta la buona società rifiutava le maniere della dialettica: si credeva che mettesse a nudo le anime; si metteva in guardia la gioventù contro di essa. Perchè questo sfoggio di motivi? A qual fine dimostrare? Contro gli altri, si possedeva l’autorità. Si comandava e basta. Inter pares, si possedeva la propria origine, che é pure un’autorità: e, come ultima risorsa, ci si intendeva! Non c’era posto per la dialettica. Anzi, si diffidava di un simile presentare in pubblico i propri argomenti. Tutto ciò che é dabbene non tiene pronti in mano i propri motivi. C’é qualcosa di sconveniente nel mostrare tutte le 5 dita. Ciò che si può dimostrare ha poco valore. Che la dialettica susciti diffidenza, che convinca poco, é del resto cosa risaputa per istinto dagli oratori di tutti i partiti. Nulla é più facile da cancellare che un effetto dialettico. La dialettica può essere soltanto una legittima difesa. Bisogna trovarsi in uno stato di necessità, avere il bisogno di estorcere un proprio diritto: prima, non si fa uso della dialettica. Perciò furono dialettici gli ebrei, lo fu Reineke Fuchs, lo fu Socrate. Si ha in mano uno strumento spietato. Si può tiranneggiare. Si denuda l’avversario, vincendolo. Si lascia che sia il suo sacrificio a dimostrare che non siamo degli idioti. Si rende l’avversario furioso e desolato, mentre noi restiamo freddi e trionfalmente ragionevoli- si snerva l’intelligenza dell’avversario. L’ironia del dialettico é una forma di vendetta plebea: la ferocia degli oppressi sta nelle fredde pugnalate del sillogismo. (La volontà di potenza, af. 431)
Missionari divini. Anche Socrate sente se stesso come missionario divino; ma in ciò si può ancora sentire una certa traccia di attica ironia e di gusto di scherzare, da cui quell’idea insopportabile e arrogante viene mitigata. Ne parla senza unzione: le sue immagini, del freno e del cavallo, sono semplici e non sacerdotali, e il vero compito religioso che egli si sente assegnato, di mettere il Dio alla prova in cento modi, per vedere se ha detto la verità, fa concludere a un atteggiamento ardito e libero, con cui qui il missionario si pone a fianco del suo Dio. Quel mettere alla prova il Dio é uno dei più sottili compromessi fra religiosità e libertà di spirito che siano mai stati ideati.- oggi non abbiamo più bisogno neanche di questo compromesso. (Aurora, af. 72)
Se tutto va bene, verrà il tempo in cui, per promuovere il proprio avanzamento morale e spirituale, si prenderanno in mano i “Memorabili” di Socrate a preferenza della Bibbia, e in cui Montaigne e Orazio saranno utilizzati come messaggeri e guide per la comprensione del più semplice e imperituro mediatore-saggio, Socrate. A lui riconducono le strade delle più diverse maniere filosofiche di vita, che sono in fondo le maniere di vita dei diversi temperamenti, stabiliti dalla ragione e dall’abitudine, e tutti quanti rivolti con la loro punta verso la gioia di vivere e di se stessi; dal che si potrebbe concludere che l’aspetto più peculiare di Socrate é stato un prendere parte a tuti i temperamenti.- Rispetto al fondatore del cristianesimo, Socrate ha in più la gioconda forma di serietà e quella saggezza piena di birbonate, che costituisce per l’uomo lo stato d’animo migliore. Inoltre aveva un intelletto più grande. (Aurora, af.86)
Socrate trovò la donna che gli occorreva – egli però non l’avrebbe certo cercata, se l’avesse conosciuta bene: così lontano anche l’eroismo di questo spirito libero non sarebbe andato. In realtà Santippe lo spinse sempre più verso la sua particolare professione, rendendogli casa e focolare inabitabili e inospitali: gli insegnò a vivere per le strade e dappertutto dove si poteva chiacchierare e oziare, facendo così di lui il più grande dialettico ambulante di Atene: il quale da ultimo dovette paragonare se stesso alle redini importune poste da un dio sul colle del bel cavallo Atene per non fargli aver pace. (Umano, troppo umano; af. 433)
PLATONE
Platone: un grande “Cagliostro”- si pensi a come lo giudicò Epicuro; a come lo giudicò Timone, l’amico di Pirrone. E’ forse fuori dubbio la probità di Platone? Ma noi sappiamo per lo meno che pretese di insegnare come una verità assoluta qualcosa che lui stesso non riteneva una verità, neppure condizionata: ossia l’esistenza particolare e l’immortalità personale delle anime. (La volontà di potenza, af. 428)
Consideriamo i filosofi della Grecia, ad esempio Platone. Separò gli istinti dalla polis, dalla lotta, dal valore militare, dall’arte e dalla bellezza, dai misteri, dalla fede nella tradizione e negli antenati… Fu il seduttore dei nobles, sedotto lui stesso dal roturier Socrate… Negò tutte le premesse del ‘greco eccellente’ di vecchio stampo, introdusse la dialettica nella pratica quotidiana, cospirò coi tiranni, predicò una politica dell’avvenire e diede l’esempio della più perfetta separazione degli istinti da ciò che é antico. E’ profondo e passionale in tutto ciò che é antiellenico… (La volontà di potenza, af. 435)
La filosofia di Platone ricorda gli anni medi della trentina, in cui una corrente fredda e una calda sogliono ribollire l’ una sull’ altra, sicchè si formano polvere e delicate nuvolette e, in circostanze favorevoli e sotto i raggi del sole, un incantevole arcobaleno. (Umano, troppo umano)
Per Platone, la cui sensualità e il cui fanatismo erano sovraeccitabili, il fascino del concetto diventò così grande che finì inavvertitamente per venerarlo e divinizzarlo come una forma ideale. Ubriacatura dialettica: coscienza di esercitare con essa un dominio su di sè- strumento della volontà di potenza. (La volontà di potenza, af. 431)
Due uomini tanto fondamentalmente diversi come Platone e Aristotele concordavano su ciò che costituisce la suprema felicità, non soltanto per loro e per gli esseri umani, ma anche in sè, perfino per gli dei delle estreme beatitudini: lo trovavano nel conoscere, nell’attività di un intelletto ben esercitato, che sa rinvenire e inventare. (Aurora, af. 550)
TUCIDIDE
Tucidide, immediatamente prima che la notte scenda su Atene (la peste e la rottura della tradizione), la fa brillare ancora una volta come uno sfolgorante tramonto, destinato a far dimenticare la brutta giornata che lo ha preceduto. (Umano, troppo umano; af. 474)
Il mio ristoro, la mia predilizione, la mia terapia contro ogni platonismo é stato, in ogni tempo, Tucidide. Tucidide, e forse il Principe di Machiavelli mi sono particolarmente affini per l’assoluta volontà di non crearsi delle mistificazioni e di vedere la ragione nella realtà- non nella “ragione” e meno che mai nella “morale”… Contro la deplorevole tendenza ad abbellire i Greci, a idealizzarli, che il giovane “educato sui classici” si porta nella vita come ricompensa del suo ammaestramento liceale, non vi é cura così drastica come Tucidide. Lo si deve rivoltare rigo per rigo e decifrare i suoi nascosti pensieri così esattamente come le sue parole- : esistono pochi pensatori così ricchi di segreti pensieri. In lui la cultura dei sofisti giunge alla sua compiuta espressione: questo movimento inestimabile in mezzo alla frode morale e ideale delle scuole socratiche dilaganti allora da ogni parte. La filosofia greca come dècadence dell’istinto greco: Tucidide come il grande compendio, l’ultima rivelazione di quella forte, severa, dura oggettività che era nell’istinto dei Greci più antichi. Il coraggio di fronte alla realtà distingue infine nature come Tucidide e Platone: Platone é un codardo di fronte alla realtà- conseguentemente si rifugia nell’ideale; Tucidide ha il dominio di sè- di conseguenza tiene sotto il suo dominio anche le cose… (Crepuscolo degli idoli)
EPICURO
Un giardino, fichi, piccoli formaggi e insieme tre o quattro buoni amici: fu questa la sontuosità di Epicuro. (Umano, troppo umano)
Epicuro ha vissuto in tutti i tempi, e vive ancora, sconosciuto a quelli che si dissero e si dicono epicurei, e senza fama presso i filosofi. Del resto egli stesso dimenticò il suo nome: fu il bagaglio più pesante che avesse mai gettato via. (Umano, troppo umano)
Sì, sono fiero di sentire il carattere di Epicuro in modo diverso, forse, da chiunque altro, e soprattutto di gustare in tutto ciò che di lui leggo e ascolto la gioia pomeridiana dell’antichità – vedo il suo occhio che guarda un vasto,albicante mare, oltre gli scogli delle coste su cui si posa il sole, mentre grandi e piccole fiere giuocano nella sua luce, sicure e placide come questa luce e quell’occhio stesso. Una tale gioia l’ha potuta inventare solo un uomo che ha perpetuamente sofferto, la gioia di un occhio davanti al quale il mare dell’esistenza si è quietato e che non si sazia più di guardare la sua superficie, e questo screziato, tenero, abbrividente velo di mare: non era mai esistita prima di allora una tale compostezza della voluttà. (La gaia scienza, af. 45)
La lotta contro la ‘fede antica’ intrapresa da Epicuro fu, in senso stretto, una lotta contro il cristianesimo preesistente- lotta contro il vecchio mondo intristito, moralizzato, inacidito da sentimenti di colpa, diventato decrepito e infermo. (La volontà di potenza, af. 438)
L’epicureo si sceglie la situazione, le persone e perfino gli avvenimenti che si armonizzano con la sua costituzione intellettuale estremamente eccitabile, egli rinuncia al resto, vale a dire al più, perchè sarebbe per lui un cibo troppo forte e pesante. (La gaia scienza, af.306)
Epicuro, l’acquietatore d’anime della tarda antichità, comprese meravigliosamente, come ancor oggi così raramente si comprende, che per tranquillizzare l’animo non é affatto necessario risolvere le ultime ed estreme questioni teoriche. Sicchè a coloro che erano tormentati dalla ‘paura degli dèi’, gli bastava dire:” se ci sono gli dèi, essi non si preoccupano di noi “,- invece di disputare sterilmente e da lontano sulla questione suprema, se ci siano in genere dèi. Questa posizione é molto più favorevole e forte: si danno all’altro alcuni passi di vantaggio, rendendolo così più pronto ad ascoltare e a ponderare. Ma non appena quegli si accinge a dimostrare il contrario,- che gli dèi si preoccupano di noi,- in quali errori e intrichi spinosi non dovrà cadere il misero, affatto da sè, senza astuzia da parte dell’interlocutore? Costui deve solo avere abbastanza umanità e finezza da nascondere la sua compassione per questo spettacolo. Da ultimo l’altro giunge alla nausea, l’argomento più forte contro quella proposizione, alla nausea per la sua stessa affermazione; si raffredda e va via con lo stesso stato d’animo che é anche dell’ateo puro: “cosa importa poi a me degli dèi? Che il diavolo se li porti!”.- In altri casi, specie quando un’ipotesi a metà fisica e a metà morale aveva offuscato l’animo, egli non confutava questa ipotesi, bensì ammetteva che poteva essere così, ma che per spiegare lo stesso fenomeno c’era ancora una seconda ipotesi; e che forse la cosa poteva stare ancora diversamente. Anche nel nostro tempo la pluralità delle ipotesi, per esempio sull’origine dei rimorsi della coscienza, basta per togliere dall’anima quell’ombra che così facilmente nasce dal ruminare un’ipotesi unica, la sola visibile, e pertanto cento volte sopravvalutata. – Chi dunque desidera largire conforto, a infelici, malfattori, ipocondriaci, morenti, si ricordi delle due espressioni tranquillizanti di Epicuro, che si possono applicare a moltissime questioni. Nella forma più semplice esse suonerebbero all’incirca: primo: posto che la cosa stia così, non ce ne importa niente; secondo: può essere così, ma può anche essere diversamente. (Il viandante e la sua ombra; af.8)
STOICI
Stoico. C’é una serenità nello stoico, quando si sente oppresso dal rituale che lui stesso ha prescritto al proprio tenore di vita; quivi egli gode se stesso come dominatore. (Aurora, af.251)
Lo stoico si esercita a trangugiare pietre e vermi, schegge di vetro e scorpioni e a essere insensibile alla nausea; il suo stomaco deve infine diventare indifferente a tutto ciò che vi travasa il caso dell’esistenza. (La gaia scienza, af.306)
PIRRONE
La stanchezza saggia: Pirrone. Vivere fra gli umili, umilmente. Nessuna fierezza. Vivere alla maniera comune; onorare e credere ciò che tutti credono. Stare in guardia di fronte a scienza e spirito e anche contro tutto ciò che gonfia… Con semplicità: indescrivibilmente paziente, noncurante, dolce; apaqeia , di più: prauths . Un buddista per la Grecia, cresciuto nel tumulto delle scuole: giunto tardi; stanco; la protesta dell’uomo stanco contro lo zelo dei dialettici; l’incredulità dell’uomo stanco nei confronti dell’importanza di tutte le cose. Ha visto Alessandro, ha visto i penitenti indiani. Su simili uomini tardivi e raffinati tutto ciò che é basso, povero, perfino idiota esercita una seduzione. Narcotizza: distende i nervi (Pascal). D’altra parte, in mezzo al tumulto e scambiati per gente qualunque, sentono un pò di calore: hanno bisogno di calore questi stanchi… Superare la contraddizione: nessuna lotta; nessuna volontà di distinguersi, negare gli istinti greci.(Pirrone viveva con una sorella che era levatrice). Travestire la saggezza, perchè cessi di renderci distinti; darle un manto di povertà e di cenci: fare i lavori più umili; andare al mercato a vendere maialetti… Dolcezza; serenità, indifferenza: nessuna virtù che esiga un contegno; farsi uguali agli altri anche nella virtù: ultima vittoria su di sè, ultima indifferenza. (La volontà di potenza, af. 437)
PAOLO
Cerca la potenza contro il giudaismo dominante, il suo movimento è troppo debole… trasvalutazione del concetto di ‘giudeo’: la ‘razza’ é messa da parte: ma ciò significò negare il fondamento. Il ‘martire’, il ‘fanatico’, il valore di ogni fede… Il cristianesimo é la forma degenerata del vecchio mondo al colmo dell’impotenza, dove vengono a galla gli strati sociali e i bisogni più malati e insani. Di conseguenza, altri istinti dovettero farsi avanti, per creare un’unità, una potenza che difende se stessa- insomma fu necessaria una specie di stato di emergenza come quello da cui gli ebrei ricevettero il loro istinto di autoconservazione… Sono, a questo punto, di incalcolabile importanza le persecuzioni dei cristiani- la comunanza nel pericolo, le conversioni di massa come unico mezzo per metter fine alle persecuzioni individuali (perciò Paolo fece l’uso più disinvolto del concetto di ‘persecuzione’). (La volontà di potenza, af. 173)
FRANCESCO D’ASSISI
Francesco d’Assisi: innamorato, popolare, poeta, combatte contro la gerarchia delle anime, a favore delle più umili. Nega la gerarchia delle anime: tutti uguali ‘di fronte a Dio’. L’ideale popolare: l’uomo buono, il disinteressato, il santo, il saggio, il giusto. O Marco Aurelio! (La volontà di potenza, af. 360)
LUTERO
Lutero, il grande benefattore. Quel che costituisce il più considerevole risultato dell’azione di Lutero sta nella diffidenza destata da lui nei riguardi dei santi e dell’intera vita contemplativa cristiana: soltanto da allora é divenuto di nuovo accessibile in Europa il cammino verso una vita contemplativa non cristiana, ed é stata posta una meta al disprezzo dell’attività mondana e dei laici. Lutero, che restava pur sempre il figlio gagliardo di un minatore, allorchè fu rinchiuso nel convento, e qui, in mancanza di altre profondità e “cavità”, cominciò a salire dentro se stesso e a trivellare orribili e oscuri cunicoli, finì per notare che una santa vita contemplativa gli sarebbe stata impossibile e che la sua innata “attività” nell’anima e nella carne lo avrebbe trascinato alla perdizione. Troppo a lungo tentò di trovare, a furia di macerazioni, la via della santità, ma finalmente prese la sua decisione e disse: “Non esiste alcuna reale vita contemplativa! Ci siamo fatti abbindolare! I santi non hanno avuto più valore di noi tutti”. Indubbiamente era questo un modo di aver ragione proprio da contadino,- ma per i Tedeschi di quel tempo era l’unico modo e quello giusto; li edificava assai leggere ora nel loro catechismo luterano: “Fuori dei 10 comandamenti non c’é opera alcuna che potrebbe piacere a Dio,- le magnificate opere religiose dei santi sono loro invenzioni”. (Aurora, af.88)
RAFFAELLO
Pittura e onestà. Raffaello, a cui importava molto della Chiesa (finchè era solvibile), ma poco, come ai migliori del suo tempo, degli oggetti della fede ecclesiastica, non seguì neanche di un passo l’esigente ed estatica religiosità di parecchi dei suoi committenti: egli conservò la sua onestà, anche in quel quadro d’eccezione, che era in origine destinato a uno stendardo di processione, nella Madonna Sistina. Qui egli volle per una volta dipingere una visione: ma una visione quale possono avere e avranno anche dei nobili giovani senza “fede”, la visione della futura sposa, di una donna intelligente, di animo nobile, silenziosa e molto bella, che porta in braccio il suo primogenito. Venerino pure qui i vecchi che sono avvezzi al pregare e all’adorare, come il venerabile vegliardo sulla sinistra, qualcosa di sovrumano: noi più giovani, così sembra gridarci Raffaello, vogliamo stare dalla parte della bella fanciulla sulla destra, che con il suo sguardo tentatore e tutt’altro che devoto dice a quelli che osservano il quadro: “Non é vero? Questa madre e il suo bambino- non é una vista piacevole e invitante?”. Questo volto e questo sguardo riflettono un raggio di gioia sui volti di coloro che li guardano; l’artista che inventò tutto ciò gode in tal modo di se stesso e aggiunge la propria gioia alla gioia dei destinatari dell’arte. – Riguardo all’ espressione “redentrice” sul viso di un bambino, Raffaello, l’onesto, che non voleva dipingere uno stato d’animo alla cui esistenza non credesse, abbindolò i suoi spettatori credenti in una garbata maniera; dipinse quel gioco di natura che non di rado accade, l’occhio dell’uomo nella testa del bambino, e precisamente l’occhio dell’uomo prode e misericordioso che vede uno stato di miseria. Per quest’occhio ci vuole una barba; che questa manchi e che due età diverse parlino qui da uno stesso volto, é il piacevole paradosso che i credenti si sono spiegati nel senso della loro fede nel miracolo: come anche l’artista poteva aspettarsi dalla loro arte di interpretare e di interpolare.
CELLINI
Il genio della civiltà si comporta come si comportò Cellini allorquando lavorava alla fusione del suo Perseo: la massa fluida minacciava di non bastare, ma essa doveva bastare: così egli vi gettò dentro piatti e stoviglie e quant’altro gli venne sottomano. E così anche quel genio getta dentro errori, vizi, speranze, chimere e altre cose di metallo tanto nobile che vile, perchè la statua dell’umanità deve venir fuori ed essere finita; cosa importa che qua e là si sia impiegato materiale più scadente? (Umano, troppo umano; af. 258)
SHAKESPEARE
La cosa più bella che io sappia dire in lode all’uomo Shakespeare é questa: egli ha creduto in Bruto, e non un granello di diffidenza ha gettato su questo tipo di virtù! A lui ha consacrato la sua migliore tragedia- la si continua sempre ancor oggi a chiamare con un falso nome-, a lui e al più terribile compendio dell’alta morale. Indipendenza dell’anima!- di questo si tratta! Nessun sacrificio può essere in questo caso troppo grande: ad essa bisogna saper sacrificare anche l’amico più diletto, fosse anche per giunta l’uomo più splendido, il vanto del mondo, il genio senza eguali- quando si ama, cioè, la libertà, come la libertà di anime grandi, e attraverso l’amico un pericolo minaccia questa libertà- in questo modo deve aver sentito Shakespeare! L’altezza alla quale innalza Cesare é il più squisito onore che potesse rendere a Bruto: soltanto così conferisce immensità di proporzioni al problema interiore di questo come al pari della forza spirituale che fu capace di tagliare questo nodo!- E fu realmente la libertà politica a spingere questo poeta a simpatizzare con Bruto- a condividerne la colpevolezza? Oppure la libertà politica fu solo un simbolo per qualcosa d’inesprimibile? Ci troviamo forse di fronte a un qualche oscuro evento, rimasto sconosciuto, e ad un’avventura dell’anima stessa del poeta, di cui egli solo per segni poteva parlare? Che cosa é tutta la melanconia di Amleto di fronte alla melanconia di Bruto!- E forse Shakespeare conosceva anche questa, come quella, per esperienza! Forse anche lui come Bruto aveva le sue ore fosche e il suo angelo malvagio!- Ma, comunque possano essersi configurate tali analogie e correlazioni segrete, Shakespeare si prosternò davanti all’intera figura e alla virtù di Bruto e si sentì indegno e lontano: nella tragedia ha inscritto la testimonianza di tutto questo. In essa per due volte ha introdotto un poeta e per due volte ha versato su di lui un tale impaziente ed estremo disprezzo che suona come un grido- come il grido di dispregio di se stesso. Bruto, Bruto stesso perde la pazienza quando appare il poeta, presuntuoso, patetico, importuno, come sono soliti esserlo i poeti, una persona che pare traboccare di possibilità di grandezza, anche di grandezza etica, e che tuttavia, nella filosofia dell’azione e della vita, raramente giunge sia pure alla comune onestà. ‘Lui conoscerà i tempi, ma io conosco le sue fisime- via da me quel pagliaccio coi sonagli!’ grida Bruto. Si riporti questo all’anima del poeta che lo scrisse. (La gaia scienza, af. 98)
Shakespeare come moralista. Shakespeare ha molto meditato sulle passioni e ha anche avuto, per il suo temperamento, assai facile accesso a molte di esse (i drammaturghi sono in genere uomini alquanto cattivi). Ma egli non sapeva, come Montaigne, parlare di esse, e pose invece le osservazioni sopra le passioni in bocca a personaggi appassionati: il che veramente é contro natura, ma rende i suoi drammi così densi di pensiero, da fare apparire vuoti tutti gli altri e da suscitare facilmente una generale avversione contro di loro. Le sentenze di Schiller (alla cui base stanno quasi sempre idee false o insignificanti) sono appunto sentenze da teatro e producono sempre come tali un effetto molto forte, mentre le sentenze di Shakespeare fanno onore al suo modello Montaigne e contengono in forma concisa pensieri serissimi, ma perciò troppo lontani e sottili agli occhi del pubblico dei teatri, cioè sono inefficaci. (Umano, troppo umano; af. 176)
CARTESIO
“Si pensa: di conseguenza c’é qualcosa che pensa”: così conclude l’argomentazione di Cartesio. Ma questo é un porre la nostra credenza nel concetto di sostanza come ‘vera a priori’. Dire che, se si pensa, deve esserci qualcosa ‘che pensi’ é semplicemente una formula della nostra abitudine grammaticale, che assegna a un’azione un autore. In breve, qui si enuncia già un postulato logico-metafisico- non si fa una semplice constatazione… Sulla via di Cartesio non si giunge a una certezza assoluta, ma solamente al fatto di una credenza molto forte. Se si riduce quella proposizione a quest’altra: “si pensa, di conseguenza ci sono pensieri”, si ha una semplice tautologia che non tocca precisamente ciò che é in questione, cioè la ‘realtà del pensiero’- ossia, in questa forma non si può rifiutare l’ ‘apparenza’ del pensiero. Ma ciò che Cartesio voleva é questo: che il pensiero non abbia soltanto una realtà apparente, ma una realtà in sè. (La volontà di potenza, af. 484)
DON GIOVANNI
Una favola. Il don Giovanni della conoscenza: non é stato ancora scoperto da nessun filosofo e da nessun poeta. Gli manca l’amore per le cose che conosce, ma nella caccia e negli intrighi della conoscenza- su su fino alle stelle più alte e lontane della conoscenza- é ingegnoso, formicolante di desiderio e ne gode, finchè non gli resta più nulla cui dar la caccia se non quel che nella conoscenza é assolutamente nocivo, come fa il bevitore, che finisce per darsi all’assenzio e all’acquavite. Così, alla fine, s’incapriccia dell’inferno- é l’ultima conoscenza, quella che lo seduce. Forse anch’essa lo delude, come ogni cosa quando é conosciuta! E allora dovrebbe starsene immobile per tutta l’eternità, inchiodato alla delusione, trasformato lui stesso nel convitato di pietra, con un desiderio di un’ultima cena della conoscenza che non gli toccherà mai più- poichè l’intero mondo delle cose non avrà più un boccone da offrire a questo affamato. (Aurora, af. 327)
HUME
Non abbiamo alcun ‘senso della causa efficiens’: qui ha ragione Hume, l’abitudine (ma non solo quella dell’individuo!) ci fa attendere che un certo accadimento, sovente osservato, segua a un altro, e basta! Ciò che ci dà una credenza nella causalità così straordinariamente stabile non é la grande consuetudine al succedersi degli eventi, ma la nostra incapacità di interpretare un evento vedendolo altrimenti che come prodotto da intenzioni. (La volontà di potenza, af. 550)
LESSING
Lessing ha una virtù schiettamente francese e come scrittore é stato in genere il più diligente nell’andare a scuola dai Francesi: sa bene ordinare ed esporre le sue cose in vetrina. Senza questa vera arte, i suoi pensieri, come pure i loro oggetti, sarebbero rimasti piuttosto in ombra, senza grave perdita per gli altri. Ma dalla sua arte hanno imparato molti (soprattutto le ultime generazioni di dotti tedeschi) e innumerevoli persone se ne sono allietate.- Certo quei discepoli non avrebbero avuto bisogno di imparare da lui, come così spesso é avvenuto, anche il suo tono e la sua maniera antipatica, in una mescolanza di litigiosità e probità.- Su Lessing lirico si é oggi unanimi: sul “drammaturgo” lo si sarà.
KANT
Kant, con la sua “ragione pratica”, col suo fanatismo morale, é completamente XVIII secolo: é ancoRA completamente fuori dal movimento storico; non ha occhi per la realtà del suo tempo, ad esempio per la Rivoluzione francese; non toccato dalla filosofia greca; fantastico nel concetto del dovere; sensista, con una recondita inclinazione al traviamento dogmatico. (La volontà di potenza, af. 95)
Kant: uno psicologo e un conoscitore degli uomini assai scarso; si sbagliava di grosso circa i grandi valori storici (Rivoluzione francese); fanatico morale à la Rousseau, con un acuto cristianesimo dei valori; completamente dogmatico, ma con un greve disgusto per questa sua inclinazione, fino a desiderare di dominarla; ma anche dello scetticismo si stancò subito; non fu sfiorato dal gusto per il cosmopolitismo, nè da quello per la bellezza dell’antichità… Fu un temporeggiatore e un intermediario, non ebbe nulla di originale. (La volontà di Potenza, af. 101)
La macchia del criticismo kantiano é gradatamente diventata visibile anche agli occhi più grossolani: Kant non aveva più alcun diritto a distinguere ‘fenomeno’ e ‘cosa in sè’ – si era negato il diritto di continuare a distinguere secondo questa vecchia consuetudine, poichè rifiutava come illecito l’inferire dal fenomeno una causa del fenomeno- in conformità con la sua concezione della causalità e della validità puramente intrafenomenica di tale concetto: un modo di concepire che, d’altra parte, anticipa quella distinzione, come se la ‘cosa in sè’ fosse non solo inferita, ma data. (La volontà di potenza, af. 553)
E ora non parlarmi dell’imperativo categorico, amico mio! Questa parola mi fa il solletico all’orecchio e non posso fare a meno di ridere nonostante la tua presenza tanto seria: mi vien fatto di pensare al vecchio Kant che a titolo di punizione per essersi sgraffinato la ‘cosa in sè’ – ridicolissima cosa pure questa! – fu accalappiato dall’imperativo categorico, e con quello in cuore rifece il cammino all’indietro smarrendosi in ‘Dio’, ‘anima’, ‘libertà’, ‘immortalità’, come una volpe che, smarritasi, ritorna nella sua gabbia- ed era stata la sua forza e accortezza a forzare questa gabbia! (La gaia scienza, af. 335)
L’istinto erroneo in tutto e per tutto, la contronatura come istinto, la dècadence tedesca come filosofia- questo é Kant!- (L’Anticristo, af. 11)
ROUSSEAU
Ma Rousseau dove voleva lui in verità tornare? Rousseau, questo primo uomo moderno, idealista e canaille in una sola persona; che ebbe bisogno della dignità morale per sopportare il suo stesso aspetto; malato di una sfrenata vanità e di un illimitato disprezzo di sè. Anche questa creatura malriuscita, che ha preso posto sulla soglia della nuova età, voleva il ritorno alla natura: dove, chiediamo ancora una volta, voleva tornare Rousseau? Odio Rousseau anche nella Rivoluzione: essa é l’espressione nella storia universale di quella doppia natura d’idealista e di canaille. La farsa sanguinosa in cui questa rivoluzione si sviluppò, la sua ‘immoralità’, m’importa poco: quel che odio é la rousseauiana moralità- le cosiddette verità della rivoluzione con le quali essa continua sempre a esercitare i suoi effetti e a conciliarsi tutto ciò che é piatto e mediocre. La dottrina dell’uguaglianza! (Crepuscolo degli idoli, af. 48)
Il corruttore é Rousseau: toglie le catene alla donna, che da allora in poi viene rappresentata in modo sempre più interessante- come sofferente. (La volontà di potenza, af. 94)
Rousseau: la regola fondata sul sentimento, la natura come fonte della giustizia; l’uomo si perfeziona nella misura in cui si avvicina alla natura. […] Ma Rousseau rimase plebeo, anche come homme de lettres, cosa inaudita: disprezzava spontaneamente tutto ciò che lui stesso non era. Ciò che vi é di morboso in Rousseau fu sommamente ammirato e imitato. […] La difesa della provvidenza da parte di Rousseau: aveva bisogno di Dio per poter scagliare la propria maledizione sulla società e sulla civiltà; ogni cosa doveva essere buona in sè, poichè Dio l’ha creata: solo l’uomo ha corrotto l’uomo. (La volontà di potenza, af. 100)
Contro Rousseau. Se é vero che la nostra civiltà ha in sè qualcosa di miserando, avete la scelta di giungere, con Rousseau, all’ulteriore conclusione che “della nostra cattiva moralità ha colpa questa miserabile civiltà”, oppure, contro Rousseau, ritornare alla conclusione che “della nostra miserabile civiltà ha colpa la nostra buona moralità”. I nostri fiacchi, svirilizzati, sociali concetti di bene e male, e l’enorme strapotere di questi sull’anima e sul corpo hanno finito per infiacchire tutte le anime e i corpi e per infrangere gli uomini indipendenti, autonomi, spregiudicati, le colonne di una robusta civiltà: dove ancor oggi si incontra la cattiva moralità, si vedono le ultime rovine di queste colonne. “Così s’opponga paradosso a paradosso! Impossibile che la verità possa essere da tutte e due le parti; e in genere é da una di queste due parti? Lo si accerti”. (Aurora, af.163)
VOLTAIRE
Basta leggere di tempo in tempo il Maometto di Voltaire per rappresentarsi con chiarezza alla mente che cosa una volta per tutte, con quella rottura della tradizione, sia andato perduto per la cultura europea. Voltaire fu l’ultimo dei grandi drammaturghi, l’ultimo che domasse con greca misura la sua anima molteplice, che era all’altezza anche delle più grandi tempeste tragiche; egli potè ciò che ancora nessun tedesco ha potuto, perchè la natura del francese é molto più affine a quella greca che non la natura del tedesco; come pure egli fu l’ultimo grande scrittore che, nella composizione del discorso in prosa, avesse orecchio greco, coscienziosità artistica greca e greca semplicità e grazia; anzi fu uno degli ultimi uomini che sapessero riunire in sè la più grande libertà di spirito e un modo di pensare assolutamente non rivoluzionario, senza essere incoerenti e pavidi. (Umano, troppo umano; af. 221)
NAPOLEONE
La Rivoluzione rese possibile Napoleone: così viene giustificata. Per un simile compenso si dovrebbe desiderare il crollo anarchico di tutta la nostra civiltà. Napoleone rese possibile il nazionalismo: questo é il suo limite. Il valore di un uomo (astraendo, come si deve, da moralità e immoralità: infatti, con questi concetti non si tocca ancora il valore di un uomo) non consiste nella sua utilità; perchè questo valore persisterebbe anche se non ci fosse nessuno a cui potesse tornare utile. E perchè precisamente l’uomo che sortì gli effetti più rovinosi non potrebbe essere il vertice dell’intero genere umano, così alto, così superiore che tutto rovina per invidia nei suoi confronti? (La volontà di potenza, af.877)
Si deve a Napoleone (e niente affatto alla Rivoluzione francese, che ha avuto di mira la ‘fraternità’ tra i popoli, nonchè universali, fioriti scambi di sentimenti) il fatto che ora possono succedersi un paio di secoli bellicosi di cui non esiste l’uguale nella storia, insomma il nostro avvenuto ingresso nell’età classica della guerra, della guerra dotta e al tempo stesso popolare nella più vasta scala (di mezzi, di attitudini, di disciplina), verso la quale tutti i secoli venturi, quasi fosse un frammento di perfezione- infatti il movimento nazionale da cui germoglia questa gloria guerriera é solo il contro-choc a Napoleone, e senza Napoleone non si sarebbe verificato. A costui dunque si potrà attribuire un giorno il fatto che in Europa l’uomo é divenuto ancora una volta signore del mercante filisteo; forse perfino della ‘donna’, che é stata blandita dal cristianesimo, dallo spirito stravagante del secolo XVIII e ancor più dalle ‘idee moderne’. Napoleone, che vedeva nelle idee moderne e proprio nella civilizzazione qualcosa come un nemico personale, ha confermato, con questa sua ostilità, di essere uno dei più grandi prosecutori del Rinascimento: egli ha nuovamente portato in luce un intero frammento dell’antica sostanza, quello decisivo forse, il frammento di granito. E chissà che questo frammento dell’antica sostanza non ridiventi finalmente dominatore del movimento nazionale e non debba farsi l’erede e il prosecutore di Napoleone in senso affermativo: Napoleone, il quale voleva, come é noto, un’Europa unita, perchè fosse signora della terra. (La gaia scienza, af. 362)
FICHTE
“La verità deve essere detta anche se il mondo dovesse andare in pezzi!”- così grida a piena voce il grande Fichte. Sì! Sì! Ma si dovrebbe anche possederla! Lui intende, però, che ognuno debba esprimere la propria opinione, anche se tutto dovesse essere messo sottosopra. Su questo si potrebbe ancora essere in disaccordo con lui. (Aurora, af. 353)
HEGEL
Il pensiero di Hegel non é molto lontano da quello di Goethe: si presti orecchio a ciò che Goethe dice di Spinoza. C’é una volontà di divinizzare il Tutto e la vita, per trovare quiete e felicità nella sua contemplazione e nella sua investigazione; Hegel vede la ragione dappertutto, davanti alla ragione é lecito sottomettersi e rassegnarsi.
Significato della filosofia tedesca (Hegel): escogitare un panteismo in cui il male, l’errore e la sofferenza non potessero venire avvertiti come argomenti contro la divinità. Di questa grandiosa iniziativa abusarono le potenze esistenti (Stato, ecc.), come se sancisse la razionalità del dominio di quelli che appunto dominavano.
GOETHE
In Goethe c’è una specie di fatalismo quasi gioioso e fiducioso, che non si rivolta, che non si stanca, che cerca di formare una totalità da se medesimo, persuaso che solo nella totalità tutto si redima e appaia buono e giustificato.
MILL
Contro John Stuart Mill. Io ho i orrore la sua volgarità, quella che dice: ‘ciò che é giusto per l’uno, è conveniente per l’altro; non fare ad altri ciò che non vuoi, ecc.’; che vuole fondare tutti i rapporti umani sulla reciprocità della prestazione, così che ogni azione appare come una specie di pagamento per un servizio reso. Qui la premessa é ignobile, nel senso peggiore del termine: qui viene presupposta per me e per te l’equivalenza delle nostre azioni, é semplicemente annullato il valore più personale di un’azione (ossia ciò che non può venire compensato o ripagato da nulla). La ‘reciprocità’ é estremamente volgare: proprio il fatto che ciò che io compio non possa, nè di diritto nè di fatto, essere compiuto da un altro, il fatto che non ci possa essere alcuna compensazione (fuorchè nella elettissima sfera dei ‘miei pari’, inter pares); il fatto che, in un senso più profondo, non si restituisca mai, perchè si é unici e si compiono solo azioni uniche- in questo fatto, in questa convinzione fondamentale consiste il motivo dell’isolamento aristocratico della moltitudine, perchè la moltitudine crede all”uguaglianza’ e quindi alla compensazione e alla ‘reciprocità’. (La volontà di potenza, af. 926)
“Siamo indulgenti con i grandi uomini da un occhio solo!” ha detto Stuart Mill: come se fosse necessario sollecitare indulgenza, laddove si é abituati a tributare loro fede e quasi adorazione! Io dico: siamo indulgenti verso chi ha due occhi, grande o piccolo che sia, perchè più in alto dell’indulgenza, così come noi siamo, certo non arriveremo. (Aurora, af. 51)
SCHOPENHAUER
Schopenhauer come cadenza finale (stato enteriore alla rivoluzione): compassione, sensualità, arte, debolezza della volontà, cattolicesimo dei desideri spirituali- questo ‘au fond’ é buon secolo XVIII. L’equivoco fondamentale sulla volontà in Schopenhauer (come se le brame, l’istinto, l’impulso fossero l’essenziale nella volontà) é tipico: svalutazione della volontà, fino a misconoscerla. Così pure l’odio contro il volere: tentativo di ravvisare nel non voler più, nell’ ‘essere un soggetto senza scopo nè intenzione’ ( nel ‘soggetto puro, privo di volontà’) qualcosa di superiore, anzi la cosa suprema, ciò che ha valore. Grande sintomo della stanchezza o della debolezza della volontà: perchè la volontà è precisamente ciò che tratta da padrona i desideri, prescrive loro il cammino e la misura… (La volontà di potenza, af. 84)
Schopenhauer appare come un tenace uomo morale che finisce per diventare un negatore del mondo al fine di mantenere la legittimità della sua valutazione morale. E da ultimo diventa ‘mistico’. Io stesso ho tentato una giustificazione estetica: come é possibile la bruttezza del mondo? (La volontà di potenza, af. 416)
Anche nel nostro secolo la metafisica di Schopenhauer ha dimostrato che anche adesso lo spirito scientifico non é ancora abbastanza forte; così l’intera concezione del mondo e il sentimento dell’uomo medievali e cristiani poterono ancora celebrare nella dottrina di Schopenhauer, nonostante la distruzione già da gran tempo raggiunta di tutti i dogmi cristiani, una resurrezione. Molta scienza echeggia nella sua dottrina, ma non essa la domina, bensì il vecchio e ben noto ‘bisogno metafisico’. Certo é uno dei massimi e affatto inestimabili vantaggi che traiamo da Schopenhauer il fatto che egli faccia temporaneamente indietreggiare il nostro sentimento verso antiche e possenti forme di contemplazione del mondo e degli uomini, a cui altrimenti nessun sentiero ci condurrebbe così facilmente. Il guadagno per la storia e per la giustizia é molto grande: io credo che oggi a nessuno potrebbe riuscire così facilmente, senza l’aiuto di v, di rendere giustizia al cristianesimo e ai suoi affini asiatici: cosa che é specialmente impossibile muovendo dal terreno del cristianesimo ancora esistente. (Umano, troppo umano; af. 25)
OFFENBACH
Musica francese con lo spirito di Voltaire, libero, petulante, con un piccolo ghigno sardonico, ma chiaro, ricco di spirito sino alla banalità (non si imbelletta) e senza la ‘mignardise’ di una sensualità morbosa o biondo-viennese. (La volontà di potenza, af. 833)
COMTE
La storia del metodo scientifico fu intesa da Auguste Comte quasi come se fosse la filosofia stessa. (La volontà di potenza, af. 467)
WAGNER
Richard Wagner, già per il suo valore per la Germania e la cultura tedesca, rimane un grande punto interrogativo, forse una sventura tedesca, in ogni caso un destino: ma che significa? Non é forse molto più che un semplice tedesco? Mi sembra persino che appartenga alla Germania meno che a ogni altro paese: qui nulla é pronto per lui, il suo tipo é completamente estraneo ai tedeschi, singolare, incompreso, incomprensibile. Ma ci si guarda bene dal confessarlo: si é troppo bonari, troppo quadrati, troppo tedeschi. ‘Credo quia absurdum est’ : così vuole, così volle anche in questo caso lo spirito tedesco- e frattanto crede tutto ciò che Wagner volle fosse creduto di lui. In tutti i tempi lo spirito tedesco in psycologicis mancò di finezza e di capacità di divinazione. Oggi, stando sotto la pressione del patriottismo e dell’autoammirazione, ingrassa a vista d’occhio e diventa sempre più rozzo; come potrebbe essere all’altezza del problema Wagner? (La volontà di potenza, af. 107)
SIGMUND FREUD

Se l’uomo distoglierà dall’aldilà le sue speranze e concentrerà sulla vita terrena tutte le forze rese così disponibili, riuscirà probabilmente a rendere la vita sopportabile per tutti e la civiltà non più oppressiva per alcuni.
BREVE INTRODUZIONE
Sigmund Freud, filosofo tedesco, oggi è noto essenzialmente per la psicanalisi. Ebreo, fu perseguitato dai nazisti, che bruciarono i suoi testi insieme a quelli di Albert Einstein . Morì nel 1939. Freud più che filosofo lo possiamo definire un medico psicanalista, che ha studiato i meccanismi della mente umana, dando una interpretazione scientifica del sesso e scoprendo e teorizzando “l’inconscio” (in passato intuito da Gorgia ed analizzato in parte da Galeno). L’inconscio è la parte irrazionale della psiche; per i cattolici e gli illuministi non esiste, perché per i primi esistono solo gli istinti e per i secondi esiste solo la ragione.
La psiche umana è divisa in tre parti : l’Esse, che è scaturita dall’ambiente sociale in cui si nasce o da una eredità genetica, l’Io, che è regolato dal rapporto che si ha con la realtà, il Super Io, la parte più nobile della nostra psiche che si plasma in base alla coscienza, ai modelli e agli ideali di una persona.
Freud lo possiamo definire sia positivista che antipositivista. E’ ottimista in quanto crede che l’uomo sia capace di sublimare gli istinti, quindi positivista, ma scopre l’inconscio o Esse, e quindi è antipositivista perché non ammette la sola ragione nei meccanismi psichici. Freud per arrivare a scoprire la psicanalisi lavorò tanti anni su dei malati, e dedusse che la differenze fra il malato ed il sano è un fatto di quantità di istinti, il sano riesce a mantenere l’equilibrio fra esse, io, e Super-io. La psicanalisi è essenzialmente un metodo di cura contro le nevrosi, il malato fa un compromesso con il medico, per poter essere guarito, questo deve assolutamente lasciarsi andare per sciogliere le resistenze dell’ Io e far emergere l’inconscio, questi sono in perenne lotta, solo con l’emergere dell’inconscio il malato può guarire. Il momento in cui il malato molla le forze mentali viene chiamato “transfert” , poi si ha la “rimozione” in cui l’Io del malato crolla e vengono esternati gli istinti nella “abreazione”. A questo punto la questione diviene molto delicata, lo psicanalista per poter procedere deve essere molto competente, non deve permettere che avvenga l’incrocio di sguardi con il paziente, questo potrebbe provocare lo stop dei processi di abreazione. In genere i malati più intelligenti guariscono prima, perché avviene prima in loro il fenomeno della “associazione libera”, ossia il malato si rende conto della sua malattia ed è più facile guarire. La psicanalisi rimane ancora oggi una pratica molto costosa che in poche si possono permettere. L’isteria, la nevrosi e in alcuni casi le paralisi sono conseguenza di un’attività psichica instabile. La migliore soluzione di una psicanalisi è la sublimazione, ovvero la trasformazione di istinti sessuali in qualcosa di produttivo (es: un uomo sublima i suoi istinti sessuali nello studio).
Alla psicanalisi, però vengono spesso associati fatti di cronaca incresciosi, infatti, in passato in America, vigeva una moda squallida, gli psicanalisti abusavano sessualmente dei loro pazienti, in quanto in cura il malato si affida totalmente allo psicanalista instaurando un rapporto di odio – amore, che alcune volte porta all’aggressione dello psicanalista. Molti uomini della politica, invece, si sono sottoposti alla psicanalisi per intenti utilitaristici, infatti, chi effettua la psicanalisi, impara a conoscere la sua psiche ed automaticamente è capace di capire i comportamenti di qualsiasi altra psiche, divenendo così quasi un’arte da sofisti. Tutto questo Freud lo escludeva, per lui la psicanalisi doveva essere semplicemente una cura.
Freud ha analizzato anche il sogno. Egli ha detto che nel sogno c’è un contenuto onirico, proprio del sogno, e un contenuto latente, generato dall’inconscio. L’Io nel sogno si allenta, ma non sproporzionatamente tanto da fare emergere l’esse, si accede all’inconscio, tendiamo a trasferire un oggetto su un altro corpo. Lo psicanalista ebreo, ha anche analizzato i vari stadi della sessualità, dividendoli in quattro fasi : la prima è quella orale, il bambino prova piacere ad allattare dal capezzolo della madre, la seconda è quella sadico-anale, il bambino prova piacere nell’escrezione delle proprie feci, la terza è quella fallica, in cui l’adolescente pratica autoerotismo (masturbazione), la quarta ed ultima fase è quella genitale, in cui l’uomo ha dei rapporti sessuali con il sesso opposto. Freud afferma che si è normali per convenzione, in queste fasi, afferma lo psicanalista, si possono avere parecchi traumi o complessi, come i complessi di Edipo ed Elettra; questi si fanno alla mitologia greca, Edipo uccise il padre per l’amore per la madre, al contrario fece Elettra. L’essere omosessuale è dovuto al fatto che nella fase fallica si pensa al proprio sesso. Il feticismo invece colpisce il bambino che non convincendosi che la donna è senza pene, vede peni da per tutto. Freud divide la psicologia in tre parti : dinamica, Thanatos ed Eros (libidine e natura inorganica), economica (piacere e dispiacere), topica (esse, io e Super-io). Karl Popper, filosofo liberale del novecento, affermerà che Freud per la scoperta dell’inconscio e quindi della debolezza umana sarà insieme a Darwin e Galileo, colui che ha umiliato l’uomo.
RIASSUNTO SU FREUD Freud e Nietzsche vengono solitamente accostati perchè entrambe, seppur in modi diversi, sul finire dell’Ottocento scardinano alcune certezze fondamentali della civiltà occidentale: se Nietzsche aveva “trasvalutato” tutti i valori fondamentali dell’Occidente, ora Freud distrugge la certezza dell’Io, sulla quale si è costruita la nostra civiltà e che, a seconda delle epoche storiche, è stata definita “Io”, “Spirito”, “Anima”, ecc. E non a caso l’intera filosofia moderna, dal Medioevo fino all’Ottocento aveva fatto perno sulla nozione di Io, dal cogito cartesiano all’ Io penso kantiano allo spirito hegeliano, e tale nozione era stata scoperta, molti secoli prima, da Socrate, dato che, prima di lui, l’anima restava un qualcosa di sfumato che non si identificava con la persona, tant’è che per gli Orfici essa era la parte divina presente in noi. Ed è proprio con Socrate che l’Io viene ad identificarsi con la coscienza, a tal punto che “Io” arriva a significare “ciò di cui ho coscienza” (pensiamo alla res cogitans di Cartesio) mentre, sempre gli Orfici, in direzione opposta a Socrate, avevano prospettato l’idea che quello che loro definivano “demone” si manifestasse nei momenti di minor coscienza (il sonno, lo svenimento, ecc). L’idea dell’identificazione Io/coscienza, affiorata con Socrate, è diventata uno dei pilastri della civiltà occidentale e solo in pochi hanno avuto l’ardire di metterla in discussione: tra questi, merita di essere ricordato Plotino, il quale aveva colto, per così dire, diversi livelli della coscienza, cosicchè, oltre al livello ordinario, vi era anche quello sovrarazionale, in grado di attingere l’Uno neoplatonico; dalla prospettiva plotiniana emerge, seppur timidamente, l’idea che la mente non si identifichi con l’Io e quest’idea è stata ripresa e perfezionata, nel Seicento, da Leibniz, il quale parlava espressamente di “piccole percezioni” e di “innatismo virtuale”, convinto che nella testa dell’uomo esistessero nozioni di cui non si ha coscienza, quasi come se la nostra mente contenesse qualcosa che va al di là della coscienza. Anche Hume, nell’età dell’illuminismo, smontando il concetto di sostanza, aveva finito per distruggere insieme ad esso anche quella particolarissima sostanza che siamo noi: in altri termini, il pensatore scozzese si era chiesto se, svuotata la mente dai contenuti della coscienza, sarebbe potuto rimanere qualcosa ed aveva argutamente risposto che l’Io, in fin dei conti, altro non era se non un fascio di percezioni ed era così giunto alla conclusione che non siamo altro all’infuori della somma delle nostre percezioni. Schopenhauer stesso leggeva l’Io come manifestazione particolarissima e superficiale di quella realtà unitaria e profonda che lui definiva “volontà”; tutti questi pensatori controcorrente, però, non sono bastati per impedire che si affermasse sempre più l’idea di un Io unitario, cosciente e razionale e che le passioni venissero considerate come elementi quasi estranei alla nostra vera personalità. Se Schopenhauer si era acutamente accorto che la vera natura dell’uomo, in realtà, non è la ragione, ma la sfera passionale (tant’è che la ragione, secondo Schopenhauer, è una specie di organo che la passione si conferisce per potersi realizzare), con Nietzsche ci troviamo di fronte ad una vera e propria ripresa dell’idea humeana. Anche se dal concetto di “volontà di potenza” sembra trasparire l’assoluta centralità dell’individuo, Nietzsche smonta radicalmente la nozione di sostanza ( ” l’essere manca ” afferma Zarathustra) e dal suo venir meno si sgretola pure quella particolarissima manifestazione di essa che siamo noi (l’Io) e Nietzsche avanza (in Umano, troppo umano ) l’inquietante quesito se sia vero che siamo noi a pensare le idee o, piuttosto, sono le idee che si pensano, che vanno e vengono, attratte da processi quasi chimici, senza che vi sia un Io. Il grande merito di Freud risiede nell’aver ricucito tutti questi duri colpi assestati alla nozione di Io e nell’aver dato la formulazione migliore di questo pensiero “controcorrente”. L’Io, nota Freud, non è che non ci sia, ma, semplicemente, è una realtà infinitamente più marginale di quel che si è creduto da Socrate in poi . E’ come se fossimo tutti, coscientemente o meno, cartesiani, poichè se vi sono cose di cui non abbiam coscienza è come se per noi non ci fossero; ma non è vero che la mente si identifica in tutto e per tutto con la coscienza; viceversa, la coscienza è una piccola porzione della mente , una porzione traballante per molti versi, e l’Io stesso è un punto di contatto tra cose ben più importanti. Ben emerge, da queste considerazioni, come per Freud la mente sia altra cosa rispetto all’Io o alla coscienza. La psiche è, invece, la mente nel suo complesso e in essa trova spazio l’Io (che Freud chiama anche “Ego”), il quale si configura come parte cosciente della psiche. Ed è molto curioso come Freud non sia, propriamente, un filosofo a pieno titolo, ma un medico che si interessa di psichiatria nel tentativo di curare alcune patologie precise ed è altrettanto curioso come, da buon medico di fine Ottocento, fosse convinto dei postulati del Positivismo materialista e ritenesse che per spiegare fatti psichici si dovesse ricorrere ad eventi materiali, come se ogni attività della mente fosse legata ad una parte del cervello. Man mano che Freud matura il suo pensiero, però, prende sempre più le distanze da queste idee, a tal punto che riterrà che un giorno, quando vi saranno gli strumenti adatti per farlo, sarà necessario individuare le cause materiali della patologia psichica, ma, poichè al momento non vi è disponibilità di tali strumenti, bisogna proiettare la propria indagine (ed è ciò che egli fa) su ciò che è indagabile, ovvero sui rapporti tra fatti psichici, trascurando quelli materiali. E’ come se Freud, da sempre considerato un anti-positivista, fosse in realtà un “positivista mancato”: ed egli comincia a praticare in una prima fase della sua attività, insieme ad altri medici, la tecnica dell’ipnosi per curare certe patologie, nella convinzione che tramite essa si possa regredire ad eventi del passato rimossi e, facendoli riemergere, si può capire l’origine di determinate “nevrosi” derivanti da conflitti interiori; si deve, cioè, far emergere ciò che è stato rimosso per poterlo così curare. E qualcosa di questa teoria originaria resterà sempre presente nel suo pensiero: in particolare, Freud sarà sempre convinto che le patologie psichiche abbiano origine in traumi e conflitti psichici irrisolti e tali conflitti vengono spesso rimossi , ossia tolti dallo stato di coscienza e riposti altrove: la diagnosi/terapia consiste nel farli riemergere e la diagnosi, pertanto, è anche la cura della malattia. Ma Freud, nel corso della sua maturazione, tende sempre più a concepire quelli che in origine chiamava “traumi reali” come “traumi virtuali”, cioè non effettivi: solo in rarissimi casi il trauma è legato ad un fatto della vita reale, mentre nella stragrande maggioranza dei casi avvengono all’interno della psiche umana e, in questa nuova prospettiva, Freud tende a respingere ora l’ipnosi, poichè ha la funzione di far crollare le barriere. Dato che con la rimozione certi eventi vengon fatti passare dalla coscienza alla non-coscienza, è evidente che non possano emergere attraverso una prassi razionale (visto che si trovano nascosti alla ragione) e l’ipnosi allora non serve più ad abbattere gli ostacoli aggirandoli (perchè è troppo “artificiale”), bensì si punterà sulla distruzione dei processi di rimozione, visto che essi hanno delle falle, ad esempio i sogni e i lapsus, quando cioè si dice una parola per un’altra (e per Freud la parola “scappata” inavvertitamente è quella che per davvero si voleva dire). Si deve pertanto badare a ciò che le persone dicono o fanno al di là della coscienza e, proprio come nel caso dei lapsus si pronuncia una parola anzichè un’altra, così è anche per i comportamenti: ci sono cose che facciamo senza rendercene conto (ad esempio, i tic) e scavando in essi si coglie la verità della natura umana. Tuttavia, ciò non implica che non tutte le azioni che compiamo inconsciamente abbiano un significato: ad esempio, non tutto ciò che è presente nei sogni ha un significato inconscio. Accettata l’idea di non poter spiegare e curare i disagi psichici attraverso pratiche materiali, Freud si propone di lavorare su un piano psicologico e il concetto fondamentale che emerge da questo nuovo lavoro è quello di rimozione : esso implica che determinate situazioni conflittuali che, proprio perchè tali, sono pesanti per la coscienza, vengano “rimosse”, senza però esser fatte sparire del tutto; vengono cioè nascoste e collocate in quel vastissimo serbatoio della psiche che freud chiama ” l’inconscio “. Esistono dunque cose che la nostra psiche tende a considerare da evitarsi a livello conscio e per questo motivo le rimuove, ma questa rimozione crea disagi che si manifestano in estrinsecazioni psichiche e psicosomatiche (Freud concentra la propria attenzione soprattutto sulla paralisi isterica) che scaturiscono appunto da conflitti psicologici irrisolti che, per poter essere curati, devono in qualche misura essere fatti emergere e dal fatto stesso di prenderne coscienza, magari dolorosamente, nasce anche la cura. Il problema è che, siccome la psiche ha riposto queste cose a livello di inconscio, è impensabile strapparle in modo coercitivo all’inconscio; si dovrà cercare piuttosto di aggirare le “barriere” che proteggono l’inconscio e, per poter fare ciò, vi sono svariati modi, in particolare tutte quelle situazioni in cui la coscienza è più tenue e gli aspetti irrazionali della mente sono in primo piano (i lapsus, i sogni, i tic, ecc); il lettino dello psicanalista rende bene l’idea, in quanto il paziente disteso su di esso parla spontaneamente abbassando le barriere dell’inconscio. Sempre in quest’ottica, Freud usò molto il meccanismo del transfert , ovvero l’innamoranto del paziente verso lo psicanalista: Freud si accorgeva, infatti, di come molte sue pazienti finissero per innamorarsi di lui (in quanto provavano un senso di necessità del suo aiuto e, in definitiva, della sua persona) e, in un primo tempo, pensò che questo imprevisto potesse interferire con la cura, ma poi notò come, invece, fosse d’aiuto, poichè tende a far crollare le barriere dell’inconscio e permette di entrare nelle profondità della psiche. Un altro sistema di cui si avvale Freud per penetrare nella mente è quello della libera associazione di idee , il quale consiste, essenzialmente, nel porre il paziente di fronte ad un’immagine o ad una parola e nell’invitarlo a dire tutto ciò che gli viene in mente. Ma il metodo più importante e più impiegato dallo psicologo austriaco è quello dell’ interpretazione dei sogni (a cui dedica il suo scritto forse più famoso): nel sogno sono presenti contenuti rimossi, ma la mente umana non è così ingenua da far affiorare nel sogno ciò che tiene nascosto durante la veglia e pertanto ciò che vediamo nei sogni non è, banalmente, ciò che è stato rimosso; bensì emergono contenuti rimossi ma in forma rielaborata e in un linguaggio che dice e nasconde contemporaneamente, in quanto dà contenuti ma li esprime in maniera enigmatica. Sarà pertanto sbagliato, nota Freud, dire che ho sognato di volare e che dunque voglio a tutti i costi volare; il lavoro che Freud si propone di fare è appunto quello di provare a decifrare le regole sintattiche del linguaggio dei sogni, distinguendo tra significato latente (cioè il vero significato, nascosto) e significato manifesto (quello apparente, così come ci appare nel sogno). Già Platone aveva a suo tempo notato come nei sogni spesso facciamo cose che nella realtà mai faremmo nè penseremmo di fare: così, dopo che il paziente avrà sognato di volare, si potrà dire che il significato manifesto era appunto di volare, ma quello latente era un altro; molto spesso, infatti, il sogno procede per immagini e, dunque, i contenuti vengono espressi attraverso simboli e oggetti (animali, cose, persone, ecc) di cui non si è in grado di spiegare il vero significato (che perciò resta “latente”). Tanto più che secondo un meccanismo di condensazione in un unico oggetto sono cristallizzati molteplici contenuti e significati. Ma non solo: attraverso il meccanismo di spostamento il contenuto si sposta e slitta su oggetti che non c’entrano nulla, per cui magari si sogna un gatto ma esso non ha nulla a che vedere con il contenuto. E’ curioso come Freud, partito da una questione terapeutica, si sposti sempre più, in modo graduale, verso una sistematizzazione del suo pensiero e venga elaborando un’interpretazione generale della psiche umana e così il suo discorso si allarga, da medico che era, verso l’antropologia. Ne nasce una metapsicologia , ossia una psicologia che da mero strumento per risolvere problemi diventa una teoria generale sull’uomo: e Freud scopre, in quest’ottica, la sessualità infantile , uno degli aspetti che maggiormente scandalizzarono la società del tempo. In particolare, egli sostiene la centralità della sessualità nella vita umana, mettendo in evidenza come le pulsioni che stanno alla base della vita siano sessuali e come dal sesso derivino perfino la civiltà e molte altre cose. E per poter conferire tale carattere fondativo alla sessualità, Freud si vede costretto a concepirla in un’accezione piuttosto ampia e arriva a proporre la tesi secondo cui la rimozione graduale della sessualità dalla società sia da attribuirsi al fatto che è sempre stata concepita in maniera troppo ristretta per poi inquadrarla in rigide regole che la attenuassero: non potendola eliminare, la si restringe all’ambito della sessualità volta alla procreazione nell’ambito matrimoniale, sicchè si arrivano a considerare moralmente inaccettabili forme di sessualità “diversa” (come quella non volta alla procreazione, quella omosessuale, quella extramatrimoniale) e per di più viene eliminato quel carattere di sessualità che in realtà molte cose hanno, tra cui i bambini. Il bambino, infatti, ha una sua sessualità e, in forma volutamente provocatoria, Freud lo definisce come un ” essere perverso poliformo “: quando si nasce, si ha una forma di sessualità a trecentosessanta gradi, una sessualità diversa da come la intende e ci impone di intenderla la civiltà di cui siamo figli: la sessualità, secondo Freud, coincide con la capacità di provare piacere col corpo attraverso funzioni che non siano strettamente fisiologiche e, pertanto, il bambino prova sì piacere nel prendere il latte materno perchè soddisfa la sua esigenza di cibo, ma è anche vero che prova piacere a succhiare il seno materno (e il ciucciotto nasce da questa considerazione), il che è una forma di sessualità. Il bambino dunque è “polimorfo” perchè in lui la limitazione della sessualità imposta dalla civiltà non c’è ancora e la sua sessualità non è ancora orientata ad una sola “zona erogena”; man mano che egli cresce, tuttavia, subisce l’influenza della società e finisce per identificare la sessualità solo con la zona erogena genitale; e quindi, oltre ad essere “polimorfo”, il bambino è anche “perverso” perchè in lui ci sono tutte quelle forme di sessualità che un pò alla volta vengon tagliate fuori dalla società in cui vive perchè le ritiene perverse. All’interno di queste fasi di maturazione del bambino, è molto importante il rapporto coi genitori e, soprattutto, col padre (l’attenzione di Freud è sempre riservata, per lo più, al sesso maschile): ed è a questo punto che Freud tratta del celebre complesso di Edipo ; man mano che la sua psicologia sfuma nell’antropologia, egli tende a stravolgere (un pò come aveva fatto Bruno col mito di Atteone) il significato dei miti classici. Più nel dettaglio, egli scorge nelle vicende di Edipo una trasposizione mitologica della vita del bambino: la madre costituisce per il bambino, proprio come per Edipo, il primo individuo con cui si rapporta e a cui rivolge la sua attenzione sessuale e, in questa prima fase, concepisce il padre come avversario e ne nasce una conflittualità per il possesso della madre; tale fase, però, sarà superata e si arriverà all’identificazione con il padre. La famiglia e, soprattutto, la figura del padre diventano per Freud la chiave di lettura di tutto: tutte le tappe che si percorrono nel processo di crescita sono necessarie, l’importante è non restare bloccati ad una tappa (magari quella del complesso di Edipo) senza superarla; se non la si supera, si ha la “regressione” e nascono disagi e patologie che la psicanalisi deve risolvere. Il presupposto del discorso è che, in assenza di riscontri fisiologici, la vita psichica deve essere interpretata sulla base di una forte pulsione interna che va scaricata, quasi come se esistesse un flusso di energia interiore che finchè non è scaricato fa star male; e, secondo Freud, tale energia interna è soprattutto una pulsione sessuale, che lui chiama libido . Il medico austriaco tende sempre più ad elaborare quella che lui stesso chiama “metapsicologia” e nell’ambito di questa elaborazione meritano di essere esaminati alcuni concetti centrali delle sue opere: un primo tentativo di spiegare il conflitto che travaglia la psiche umana risiede nell’osservare due princìpi opposti fra loro, che Freud chiama principio del piacere e principio di realtà . L’uomo, di per sè, tenderebbe sempre a soddisfare all’istante il piacere che prova, per poter così trovare una forma di equilibrio interno; e tuttavia a questo “principio del piacere”, per cui si sarebbe indotti a realizzare sempre e comunque il piacere, si oppone il “principio di realtà”, ovvero la consapevolezza delle richieste provenienti dall’ambiente circostante: se, infatti, tutte le pulsioni fossero immediatamente realizzate, non solo ciò sarebbe incompatibile con le regole della società, ma perfino con la semplice sopravvivenza fisica dell’individuo, e non a caso ciascuno di noi tende a reprimere parzialmente il principio di piacere in funzione del fatto che deve vivere. Secondo quest’interpretazione freudiana, l’uomo vive in una perenne tensione ineliminabile per cui nessuno dei due princìpi (di piacere e di realtà) può venir meno: le pulsioni devono essere scariocate ma tenendo conto della realtà circostante e da ciò sorge, gradualmente, un conflitto interiore, proprio come nei sogni emergevano cose rimosse dalla coscienza. Ed è curioso notare come questa distinzione tra i due princìpi rievochi fortemente quella nietzscheana tra apollineo e dionisiaco: come per Nietzsche, anche per Freud alla base dell’uomo vi sono pulsioni irrazionali e vitalistiche (ovvero dionisiache), che però vengono ridimensionate dall’apollineo, cioè dalle regole imposte dalla società e dalla razionalità. In alcune opere più mature, Freud dichiara apertamente di essere andato al di là del principio di piacere: si rende cioè conto che solo in apparenza il principio di realtà e quello di piacere sono tra loro opposti; se meglio analizzati, essi risultano anzi essere due facce della stessa medaglia, proprio come l’utile, se esaminato in profondità, non è in contrapposizione con il piacere, ma è anzi un modo per realizzarlo utilmente; così il principio di realtà altro non è se non una manifestazione del principio di piacere, più precisamente consiste nell’esprimere il piacere in forma mediata. E poi Freud si rende conto che contro questo principio bipolare che è il principio di piacere (comprendente, come abbiamo appena detto, anche quello di realtà) vi è un altro principio ad esso opposto e consiste in una tendenza all’autodistruzione. Ora Freud al principio vitale (piacere + realtà) contrappone quello di morte, sotto forma di autodistruzione e per esprimere il conflitto tra questi due princìpi riprende il binomio, tipicamente romantico, eroV kai qanatoV , “amore e morte”: paradossalmente, nell’uomo troviamo una tendenza vitalistica che si esprime nel principio di piacere ( eroV ) contrapposta a quella autodistruttrice ( qanatoV ) e Freud afferma che le pulsioni devono assolutamente essere scaricate e che il piacere consiste appunto nello scaricarle, ma aggiunge che se un relativo scaricamento di esse ridà l’equilibrio e coincide con l’ eroV , a volte vi è una tendenza esasperata ad uno scaricamento totale delle pulsioni e della vitalità: in ciò risiede qanatoV . Dove emerge questo secondo impulso che tende ad annullare la vita? Lo si scopre, dice Freud, soprattutto nell’aggressività verso l’esterno e verso se stessi e, ancora di più, nella coazione a ripetere , cioè nei tic con carattere fortemente ripetitivo: infatti, il fatto stesso che tendano a ripetersi all’infinito dà un senso di morte, perchè implica l’abolizione della creatività vitalistica e riduce la vita ad un meccanismo inanimato, quasi come se si provasse nostalgia per gli esseri privi di vita. Sempre nell’ambito della metapsicologia, Freud elabora due celebri teorie, dette della ” prima topica ” e della ” seconda topica “: il termine “topico” è desunto dal greco topoV , “luogo”, e Freud lo impiega perchè tende ora a leggere la psiche umana come se divisa in diverse regioni e regni, anche se, è bene ricordarlo, egli ha rinunciato all’interpretazione materialistica e pertanto per “luoghi” non si devono intendere letteralmente zone fisiche del cervello, ma piuttosto, metaforicamente, zone con caratteristiche diverse dalla cui interazione deriva il comportamento umano. Se Nietzsche aveva messo in dubbio, riprendendo le tesi humeane, la compattezza della nozione di Io, ora Freud con le “topiche” la sfalda del tutto: egli, infatti, suggerisce l’idea che non vi sia una personalità ben definita e dotata di svariate manifestazioni, ma, viceversa, propone l’ipotesi che vi siano “regni” separati di cui il nostro Io è solo un aspetto. Nella “prima topica” individua tre ambiti della psiche: 1) “conscio” è ciò di cui abbiamo effettivamente coscienza; 2) “preconscio” è quel serbatoio a cui il conscio attinge: se, ad esempio, sto parlando, le cose che dico ora consciamente, ieri erano già nella mia testa ma non stavo pensando ad esse e dunque erano a livello subconscio, bastava allungare la mano per prenderle; 3) “inconscio” è tutto ciò che è stato rimosso dalla coscienza, cosicchè si crea una barriera assai solida che impedisce l’accesso. Nella “seconda topica”, invece, che è di gran lunga più famosa, incontriamo tre elementi diversi: a) l’Io (o Ego) è la personalità cosciente, b) il Superio (o Superego) è la coscienza che si sovrappone alle decisioni dell’Io, c) l’Es (o Id) non è identificabile con la personalità individuale, ma è l’insieme delle pulsioni irrazionali e proprio per questo viene espresso con il pronome neutro “Es” (“Id” in latino). L’Io corrisponde alla dimensione conscia, a quelli che nella “prima topica” Freud aveva definito come “conscio” e “subconscio”; l’Es, invece, corrisponde all’inconscio della “prima topica” ed è, in sostanza, ciò che influenza pesantemente il comportamento. Ciò che però non trova un corrispettivo nella “prima topica” è il Superio, che, essenzialmente, si identifica con quella che solitamente definiamo voce della coscienza, quel senso del dovere che impone all’Io un comportamento che lui, di per sè, non adotterebbe, proprio come in Kant il dovere (Superio) impone di non fare ciò che l’Io vorrebbe fare. Il riferimento a Kant non è casuale: quando il pensatore tedesco parlava di imperativo categorico, diceva espressamente che si deve saper riconoscere ciò che effettivamente è un dovere proveniente dall’interno (magari aiutare gli altri), senza alcuna motivazione eteronoma. Kant però non era arrivato a ipotizzare, come invece fa Freud, che quella che solitamente consideriamo la voce della coscienza abbia anch’essa un’origine eteronoma o, per dirla con Nietzsche, umana, troppo umana; in altri termini, per Freud la voce della coscienza è l’insieme delle norme comportamentali che la società in cui viviamo ci impone di interiorizzare e di far diventare doveri morali; secoli prima, il sofista Crizia aveva sostenuto la teoria secondo cui la religione sarebbe stata inventata da un legislatore intelligente che, resosi conto che gli uomini si comportano bene solo se controllati, creò il concetto di Dio, una sorta di poliziotto che ci controlla tutti quanti ventiquattr’ore su ventiquattro. E anche quando respingiamo l’eventualità di un Dio, nota Freud, resta comunque la coscienza, che in fondo, come già aveva detto Hegel, è un Dio interiorizzato. Il bambino, dunque, nasce con tutte le pulsioni dell’Es che tenderebbero immediatamente a realizzarsi (per il principio del piacere): poi, però, la famiglia le limita vivamente e la prima autorità con cui il neonato entra in contrasto è la figura paterna, in quanto rappresenta un’autorità esterna che impone regole e che si pone come rivale nel possesso della donna (complesso di Edipo); tuttavia, questa autorità, originariamente intesa come nemica, tende a poco a poco ad essere interiorizzata a tal punto che il ragazzo finisce per identificarsi col padre; e quando poi l’individuo si allontana dalla famiglia per entrare a far parte della società, si imbatte in nuove autorità, cosicchè le leggi vengono rispettate perchè si teme la punizione che deriva dal trasgredirle e, soprattutto, perchè le si hanno interiorizzate come valori, si dimentica cioè che sono regole umane e le si concepiscono come valori assoluti dettati dalla voce della coscienza (il “dovere” di cui parlava Kant). In questa prospettiva, il Superio corrisponde un pò al principio di realtà, in quanto altro non è se non l’insieme delle regole imposte dall’esterno che vengono interiorizzate e diventano una parte di noi. Dopo aver detto che l’Es costituisce l’insieme delle pulsioni che stanno alla base dell’uomo e che il Superio è la cosiddetta voce della coscienza, non resta che chiedersi in che cosa consista l’Io: ad esso Freud riserva un destino alquanto disgraziato, poichè costituisce una sorta di terreno di confine tra l’Es e il Superio. A tal proposito, Freud cita esplicitamente la commedia “Arlecchino servitore di due padroni”, dove Arlecchino è l’Io e i due padrono sono, rispettivamente, l’Es e il Superio. L’Io/Arlecchino è tenuto a soddisfare la nostra essenza pulsionale e, nel contempo, a rispondere alle leggi dettate dal Superio, e ciò che prescrive il Superio è in netto contrasto con quanto prescritto dall’Es, visto che il primo tende a ingabbiare le pulsioni sessuali del secondo, e, in quest’ottica, il vestito a pezze ritagliate di Arlecchino simboleggia il fatto che l’Io è lacerato da questo conflitto. Nell’ultima fase del suo pensiero, Freud estende il suo discorso all’ analisi della civiltà umana e dei suoi costi : il Superio, egli nota, ha a che fare coi costi della società, in quanto placa gli impulsi senza lasciarli affiorare in superficie; sotto questo profilo, assume un’importanza sempre maggiore la nozione di sublimazione . Freud non rinuncia mai e poi mai alla centralità delle pulsioni all’interno della vita umana e fa notare come la civiltà sia sempre stata un tentativo di governarle, un tentativo che si è realizzato secondo due differenti modalità: da un lato, riduce a spazi e modi limitati l’espressione sessuale della libido, ma poi tutte le libido che non sono orientate in senso sessuale non spariscono, ma vengono piuttosto “sublimate”, ossia reindirizzate ad altri scopi creativi, come se evaporassero per poi ricondensarsi in un’altra maniera. Ed è così, come sublimazione delle pulsioni sessuali, che sono nate nella nostra civiltà la cultura, l’arte e il lavoro; dopo di che, Freud, riprendendo ed estendendo il concetto del complesso edipico, tratteggia l’origine dei totem e dà un’interpretazione dell’eucarestia cristiana: le società primitive si costruiscono sulla base di un parricidio originario con cui si elimina il padre ma, dopo aver compiuto tale gesto efferato, si prova rimpianto e, perciò, la figura paterna viene divinizzata attraverso il totem o, nel mondo cristiano, con l’eucarestia. Fatte queste considerazioni sulla religiosità delle diverse civiltà, Freud arriva esplicitamente ad affermare che la religione non ha futuro e che dovrà esaurirsi: molto significativo, a tal proposito, è il titolo di uno scritto del 1927, L’avvenire di un’illusione . In Il disagio della civiltà (1930) Freud afferma invece che la civiltà è un male inevitabile: è un male, perchè reprime e devia gli impulsi libidici e, proprio per questo motivo, l’intera società può essere considerata malata, anche se di una malattia generica: seppur non vi è sofferenza, regna ciononostante il disagio per il fatto che le pulsioni vengono repressivamente soffocate ma si continua lo stesso a sentire il bisogno della civiltà. Quest’idea di una società a disagio per un eccesso di apollineo rievoca fortemente il pensiero di Nietzsche, anche se per il profeta del Superuomo questo disagio è eliminabile nel momento in cui si giunge al nichilismo attivo; per Freud, invece, non ci si può in nessun caso liberare dal Superio e ne nasce una mesta prospettiva di accettazione di un male necessario. Nonostante queste considerazioni, Freud non è così pessimista come possa sembrare, in quanto, sebbene rifiuti la possibilità ammessa da Nietzsche di schizzare via dalla società, non rifiuta quella secondo cui è possibile migliorare la società ed è per questo che scorge nel movimento socialista non un modo per realizzare il paradiso in terra, ma per ridurre il disagio che opprime la nostra società; ancora una volta, Freud, nella convinzione che la società possa guarire un poco alla volta attraverso l’assunzione di medicine adeguate, rivela di essere forse più medico che filosofo.
L’EDIPO RE di SOFOCLE
1-116 Prologo
La tragedia inizia con l’apparizione di Edipo sorretto da una fanciulla, Antigone, sua figlia-sorella. In prossimità di Atene chiedono informazioni su dove si trovino ad un passante: questi li invita ad allontanarsi: il luogo è consacrato alle dee Eumenidi, dee terribili, dal cui nome Edipo è colpito. Apprende dallo stesso di essere a Colono, il cui re è l’ateniese Teseo. Già da qui si nota la stanchezza per la vita di Edipo, la sua voglia di porle fine. Il prologo anticipa il motivo conduttore della tragedia: il contrasto fra il crudo passato del protagonista e la quiete estrema, verso la quale tende e dalla quale finirà per essere assorbito.
117-253 Parodo
Qui troviamo un canto del coro: al sopraggiungere degli abitanti Edipo si era nascosto, quando si fa avanti, il coro prova un sentimento misto di pietà e di orrore. Dopo averlo invitato ad uscire dal sacro recinto, il coro vuol conoscere l’identità dello straniero, quando la scoprono gli intimano di allontanarsi, ma servirà l’intervento di Antigone per farlo restare.
254-667 Primo Episodio
Mentre tutti aspettano l’arrivo del re Teseo, la figlia di Edipo, Ismene, arriva da Tebe per avvertirlo dei disordini generati dai due figli maschi, entrambi ambivano al trono: il minore l’ha usurpato, ed il maggiore sta muovendo un esercito contro di lui. Ora entrambe le parti cercano Edipo, perché un oracolo ha predetto che la vittoria sarà destinata a chi lo avrà con sé, vivo o morto. Non è loro intenzione, però, riportarlo ai confini della patria, bensì lasciarlo ai margini di essa. Quindi Edipo, dopo aver maledetto i figli, viene aiutato e curato da due fanciulle. Il coro allora gli consiglia di offrire una libagione alle dee a cui è sacro il territorio. Sarà Ismene ad occuparsene. Interrogato dal coro sul suo passato, egli risponde che le sue presunte colpe si sono verificate per via della sorte. Al sopraggiunto Teseo egli chiede di poter essere seppellito in quel luogo stesso.
668-719 Primo Statismo
Qui il coro inneggia a Colono e a tutta la Grecia, ed Edipo ricorda la sua giovinezza.
720-1043 Secondo Episodio
Si presenta il figlio Creonte, che con una ipocrita proposta cerca di soccorrere il padre interessatamente, egli pensa che è in grado di costringerlo, sia lui che le sue figlie, a venire con sé, nonostante il rifiuto del padre. Gli strappa Antigone dalle braccia, e, nonostante le proteste del coro, usa la violenza anche sul padre. Accorso Teseo, lancia un esercito contro i rapitori. Mentre Edipo e Creonte discutono sull’uccisione del padre da parte del primo, Teseo trascina Creonte per liberare gli altri prigionieri. Prima della pace estrema egli deve ripercorrere con la memoria e le parole il suo cruento passato. Si sente immune da colpa, perchè tutto è dipeso dal volere degli dei.
1044-1095 Secondo Statismo
Il coro immagina di assistere al propizio scontro tra Teseo ed i tebani, ringraziando gli dei per questo.
1096-1210 Terzo Episodio
Quando Teseo riporta le figlie al padre, già l’altro figlio ottiene di parlare con lui.
1211-1248 Terzo Statismo
Il coro racconta che Edipo non è più perseguitato dagli dei e dal destino, è solo un vecchio. Si accorge quindi che lo stesso morire sarebbe un peccato: qui cita una frase di Sileno rivolto al Re Mida: “Meglio di ogni cosa è non essere nati, e dopo di ciò morire subito dopo la nascita”.
1249-1555 Quarto Episodio
Arriva ora Polinice, primo figlio di Edipo, che, diversamente dal fratello, chiede gentilmente aiuto al padre: qui si scatena l’ira di Edipo, il quale fa notare al figlio come sia ancora vivo per merito di Antigone e le sue sorelle, non di lui e del fratello: su questi ultimi cadrà la sua maledizione! Polinice rimane allora deluso, e non tenta alcuna replica. Mentre il coro lamenta la vicenda, si ode un tuono: segno che per Edipo si sono aperti i passaggi per l’aldilà, egli ordina di far accorrere Teseo, ed il coro si spaventa per quello che sta avvenendo. Quando Teseo arriva, Edipo si accinge a portarlo nel luogo della sua morte, e invita anche le figlie a venire. Dice a Teseo di cercare di mantenere tranquilla la sua città.
1556-1578 Quarto Statismo
Non resta che pregare gli dei dell’oltretomba, perchè concedano il lieve trapasso al morituro. La sua morte non è comune: è come una discesa dall’Ade.
1579-1779 Esodo
Teseo racconta al coro la scomparsa di Edipo: “Il vecchio si inoltrò nel bosco, e giunto alla sacra voragine compì i riti di purificazione. Poi prese commiato dalle figlie, e le fece allontanare, solo io restai ad apprendere le sue ultime parole: e poco dopo, voltandosi, essi mi videro come percosso da una vista arcana e tremenda – nessuno sa come sia morto Edipo, solo si sa che gli sono state risparmiati pianto e dolore”. Teseo conferma il desiderio di Edipo che nessuno si avvicini al suo sepolcro, e acconsente a quello di Antigone di poter andare a Tebe per tentare d’impedire lo scontro tra i due fratelli.
L’INTERPRETAZIONE DI FREUD E QUELLE SUCCESSIVE
La più famosa -seppur contestatissima- interpretazione dell’Edipo Re sofocleo si deve a Freud, che dalla tragedia fece derivare il nome del complesso maschile infantile per cui il bambino viene portato ad odiare il padre e ad attaccarsi morbosamente alla madre. Ciascuno di noi, in sostanza, vorrebbe da bambino sbarazzarsi del padre per poter possedere la madre, dalla quale è sessualmente attratto. Sul versante femminile, si ha il complesso di Elettra, ovvero la bambina vorrebbe sbarazzarsi della madre per possedere sessualmente il padre. Certo l’Edipo re assurse per Freud e per la psicoanalisi a paradigma del fenomeno psicologico, ma non solo, perché Freud stesso spiegò l’efficacia della tragedia in questo modo:
|
Il suo (di Edipo) destino ci commuove soltanto perché sarebbe potuto diventare anche il nostro, perché prima della nostra nascita l’oracolo ha decretato la medesima maledizione per noi e per lui. Forse a noi tutti era dato in sorte di rivolgere il nostro primo impulso sessuale alla madre, il primo odio e il primo desiderio di violenza contro il padre: i nostri sogni ce ne danno convinzione. (…) Davanti alla persona in cui si è adempiuto quel desiderio primordiale dell’infanzia indietreggiamo inorriditi, con tutta la forza della rimozione che questi desideri hanno subito da allora nel nostro intimo. Portando alla luce della sua analisi la colpa di Edipo, il poeta ci costringe a prendere conoscenza del nostro intimo, nel quale quegli impulsi, anche se repressi, sono pur sempre presenti. Sigmund Freud, da Interpretazione dei sogni, 1900 |
In parecchi testi, Freud riprende questa tesi e cita il mito di Edipo (la lezione XXI del ciclo di lezioni di Introduzione alla psicoanalisi, la lettera a Wilhelm Fliess del 15 ottobre 1897…). Scrive ancora Freud:
Se Edipo Re è in grado di scuotere l’uomo moderno come ha scosso i greci suoi contemporanei, ciò non può che significare che l’effetto della tragedia greca non è basato sul contrasto tra destino e volontà umana, ma sulla particolarità della materia sulla quale questo contrasto viene mostrato. Deve esistere nel nostro intimo una voce pronta a riconoscere nell’Edipo la forza coercitiva del destino, mentre soggetti come quello della Bisavola o di altre simili tragedie del destino ci fanno un’impressione di arbitrarietà, e non ci toccano. Ed effettivamente nella storia di Re Edipo è contenuto un tale motivo. Il suo destino ci scuote soltanto perché avrebbe potuto diventare anche il nostro, perché prima della nostra nascita l’oracolo ha pronunciato ai nostri riguardi la stessa maledizione. Forse è stato destinato a noi tutti di provare il primo impulso sessuale per nostra madre, il primo odio e il primo desiderio di violenza per nostro padre; i nostri sogni ce ne convincono. Re Edipo, che ha ucciso suo padre Laio e che ha sposato sua madre Giocasta, è soltanto l’adempimento di un desiderio della nostra infanzia. Ma a noi, più felici di lui, è stato possibile, a meno che non siamo diventati psiconevrotici, di staccare i nostri impulsi sessuali dalla nostra madre, e dimenticare la nostra invidia per nostro padre. Davanti a quel personaggio che è stato costretto a realizzare quel primordiale desiderio infantile, proviamo un orrore profondo, nutrito da tutta la forza della rimozione che da allora in poi hanno subito i nostri desideri. Il poeta, portando alla luce la colpa di Edipo, ci costringe a conoscere il nostro proprio intimo, dove, anche se repressi, questi impulsi pur tuttavia esistono. Il canto, con il quale il coro ci lascia:
…”Vedete, questo è Edipo, i cittadini tutti decantavano e invidiavano la sua felicità; ha risolto l’alto enigma ed era il primo in potenza, guardate in quali orribili flutti di sventura è precipitato!”
è un’ammonizione che colpisce noi stessi e il nostro orgoglio, noi che a parer nostro siamo diventati cosi saggi e così potenti, dall’epoca dell’infanzia in poi. Come Edipo, viviamo inconsapevoli dei desideri che offendono la morale, di quei desideri che ci sono stati imposti dalla natura; quando ci vengono svelati, probabilmente noi tutti vorremmo distogliere lo sguardo dalle scene dell’infanzia
A questo proposito bisogna ricordare quanto fosse importante per Freud e quanto lo sarà per la psicoanalisi (in particolar modo il filone junghiano) ricorrere al mito: un po’ come nella filosofia platonica, il mito diviene paradigma, exemplum, una via efficace per spiegare, più precisamente per far affiorare dall’inconscio ciò che abbiamo rimosso. L’importanza dell’arte per Freud sta anche in questo: egli stesso sostiene che “noi e lui [Freud e il poeta] attingiamo alle stesse fonti, lavoriamo sopra lo stesso soggetto, ciascuno di noi con metodo diverso”.
Riprendendo il discorso della critica freudiana, oltre il passo sovracitato egli inserisce una serie di versi, dalla tragedia stessi, sui quali fa poggiare trionfante la propria interpretazione:
| dall Edipo Re di Sofocle, vv.977-983 GIOCASTA: Ma perché sgomentarsi, se in balìa della fortuna sono i casi umani, che l’uomo non potrà mai preconoscere? E’ più saggio affidarsi alla ventura, come si può; né tu temere le nozze con tua madre. Non giacquero molti in sogno con la loro madre? E vivono sgomenti forse per i loro sogni? No, se vogliono condurre la vita senza troppi affanni. |
Freud nega l’interpretazione della tragedia secondo la quale la morale sta nell’accusa degli dei e del Fato, anzi nega che sia questa a causare l’effetto tragico. Piuttosto il successo della tragedia sta nel riconoscimento del lettore nell’Edipo, perché la tragedia stessa indica esplicitamente (nei versi sopra citati) che la leggenda è tratta da un primordiale materiale onirico.
La critica successiva ha negato l’interpretazione freudiana, un po’ troppo semplicistica, non sottile forse perché priva del materiale filologico e storico di cui necessitava. L’intuizione freudiana sta nell’aver percepito l’importanza della tragedia quale analisi dell’animo, del conflitto interiore di Edipo che cammina verso la verità, pronta ad accecarlo: quando l’ubriaco alla festa gli confida la sua vera identità, Edipo sente qualcosa insinuarsi nel profondo, pungergli qualcosa che aveva rimosso (vv.779-786). Inoltre nella affannata ricerca di Edipo, Freud vede un paragone col processo di analisi della psiche da lui stesso affrontato: Edipo solleva il velo che gli nasconde la verità, la sua identità parricida e incestuosa, come lo psicoanalista attraverso il dialogo “scopre” al di là della dimensione conscia, L’Edipo Re è la parabola di un uomo riconosciuto come uguale agli dei dal punto di vista degli uomini, ma pari a nulla, cieco, per gli dei (cfr. Vernant, Ambiguità e rovesciamento. Sulla struttura enigmatica dell’Edipo Re).
Chi nega il senso di colpa di Edipo è Jean Pierre Vernant stesso ( Edipo sans complexe è appunto il titolo di un suo saggio del 1979): dimostra quanto e come sia errata la prospettiva freudiana, poiché si propone in forma assiomatica e non scaturisce quale esito di una corretta e integrale analisi di tutti gli aspetti del testo. Come può un’opera letteraria che appartiene alla civiltà ateniese del V sec. a C. e che traspone essa stessa in maniera molto libera una leggenda tebana molto più antica, anteriore al regime della polis, confermare le osservazioni di un medico degli inizi del XX secolo sulla clientela di malati che frequentano il suo studio?: sono queste le parole di critica più diretta all’interpretazione freudiana, che – secondo Vernant – non è credibile anche perché non poggia su un lavoro minuzioso di analisi. Questo avviene perché Freud trascura la storicità del pubblico che fruisce dell’opera; egli procede nel senso opposto della psicologia storica, che prima ancora di analizzare contenuto, tema, lingua, si occupa del contesto in cui avviene la performance. Una volta analizzato il contesto storico dell’Atene del V sec. a C., rendendosi conto di come si trattasse di un ambiente politicamente e socialmente diverso, per esempio, dalla Siracusa del XX sec. d.C., dove in questi giorni la tragedia è ripresa, è possibile rendersi conto dell’intima reazione del pubblico. Vernant ammette come già la Poetica di Aristotele, seppur solo un secolo dopo, non sia in grado di interpretare la tragedia, che appartiene ormai ad un’epoca trascorsa, un’epoca in cui il sorgere del principio di responsabilità nel campo del diritto aveva posto il problema della misura in cui l’uomo fosse responsabile delle proprie azioni.
Una posizione intermedia è quella di Paduano, che nell’introduzione a Sofocle, Tragedie e Frammenti, in un microsaggio intitolato Sulla diversità, del 1982, sostiene che l’Edipo Re sia una struttura teatrale che non trascriva direttamente nè sia estranea al complesso di Edipo: anzi lo rappresenta attraverso un rovesciamento e uno spostamento. Se lo spostamento è quello dalla dialettica psichica tra conscio e coscienza alla dialettica sociale uomo-dio, il rovesciamento è quello che nella sovracitata dialettica psichica scambia tra di loro desiderio represso e repressione. Infatti Edipo desidera la normalità, ma la realtà si è già organizzata in forme opposte alla volontà del soggetto: l’evento tragico avviene prima dell’azione tragica. Da questo Paduano fa derivare l’uso, in Sofocle, di un’ironia tragica che si discosta dalla sua forma tradizionale. Infatti, se di solito l’ironia tragica, quale convergenza di due significati sullo stesso significante, viene usata per “prevedere” ciò che accadrà, qui non ha la stessa funzione: un’ironia tragica che troviamo anche in Euripide, quando (nell’”Elettra”) i due fratelli, prossimi al matricidio, appellano la madre “la generatrice” (thn tekousan). L’evento tragico è già stato, appunto, dunque l’ironia ha solo la funzione di confrontare l’immagine del DESIDERIO con quella della REALTA’. Dunque è come se due dimensioni si accostassero parallele: e così se nell’universo simulato Edipo possiede l’autorità, nell’universo reale le stesse valenze autoritarie trasformano il soggetto in oggetto. In entrambi i casi è fondamentale il rapporto con Laio: nella dimensione simulata esiste una filialità solo metaforica, quando per esempio Edipo dice del re “come se fosse mio padre”, e si identifica in lui con una serie di punti di contatto (il potere, i possibili figli, la moglie); finché nella dimensione reale la filialità diviene biologica.
Paduano rivaluta poi, in un certo senso, il tema della conoscenza: non è infatti importante come potrebbe sembrare la differenza tra sapere umano e oracolo divino, vista l’ambiguità di quest’ultimo. Anzi, la conoscenza, come il potere, rientra nei desideri di Edipo: l’intellettualismo di Edipo fa parte dell’insieme compatto dei suoi desideri autoritari e normativi, citando da Paduano stesso. Ma questa conoscenza, che pur uscirà sconfitta dalla rivelazione, è una forma di eroica tlhmosunh, di sopportazione: “Ahimè, sto per dire la cosa tremenda”, gli dice il pastore. Risponde Edipo: “E io per sentirla. Ma sentirla bisogna“.
Secondo Paduano il primo di molti Edipi non più senza complesso è quello di Seneca, dove il parricidio e l’incesto vengono assunti come ossessione non risolta. Il complesso esclude tuttavia l’aspetto libidinale e investe unicamente quello autopunitivo dell’angoscia. L’Edipo di Seneca è il primo Edipo freudiano, già vicinissimo alla verità.
Un’analisi interessante è quella di Fromm ne “Il linguaggio dimenticato”, dove il mito viene inteso come ribellione del figlio contro l’autorità del padre nella famiglia patriarcale (e la teoria trova supporto nelle altre due tragedie della trilogia, Edipo a Colono e Antigone, nelle quali ricorre il rapporto padre-figlio).
L’ultima interpretazione è quella dello psicologo Franco Maiullari, che nel suo ultimo saggio, L’interpretazione anamorfica dell’Edipo Re. Una nuova lettura della tragedia sofoclea, propone appunto una nuova lettura in chiave psicoanalitica secondo cui l’indagine di Edipo non sia rivolta alla ricerca di sapere ma alla ricerca di potere, e spinge l’accecamento di Edipo come mezzo per andare oltre i propri limiti, divenendo così potente come Tiresia. Viene inoltre evidenziata la funzione ambigua di Giocasta, la cui preoccupazione è quella di mantenere l’omertà sui fatti del palazzo. In “Il linguaggio dimenticato” (trad. it. di G. Brianzoni, Bompiani, Milano, 1962, pp. 188-193), scrive Fromm:
II mito di Edipo offre un eccellente esempio dell’applicazione del metodo freudiano e allo stesso tempo un’ottima occasione per considerare il problema sotto una prospettiva diversa, secondo la quale non i desideri sessuali, ma uno degli aspetti fondamentali delle relazioni tra varie persone, cioè l’atteggiamento verso le autorità, è considerato il tema centrale del mito. Ed è allo stesso tempo una illustrazione delle distorsioni e dei cambiamenti che i ricordi di forme sociali e di idee più antiche subiscono nella formazione del testo evidente del mito. […]Il concetto del complesso di Edipo, che Freud ha così efficacemente espresso, divenne una delle pietre angolari del suo sistema psicologico. Egli credeva che esso fosse la chiave per comprendere la storia e l’evoluzione della religione e della morale e che costituisse il meccanismo fondamentale dello sviluppo del bambino. Sosteneva inoltre che il complesso di Edipo è la causa dello sviluppo psicopatologico e il ” nocciolo della nevrosi “.
Freud si riferiva al mito di Edipo secondo la versione contenuta nell’Eco Re di Sofocle. La tragedia ci racconta che un oracolo aveva predetto a Laio, Re di Tebe, e a sua moglie Giocasta, che se essi avessero avuto un figlio, questi avrebbe ucciso il padre e sposato la propria madre. Quando nacque Edipo, Giocasta decise di sfuggire alla predizione dell’oracolo, uccidendo il neonato. Ella consegnò Edipo a un pastore, perché lo abbandonasse nei boschi con i piedi legati e lo lasciasse morire. Ma il pastore, mosso a pietà per il bambino, lo consegnò a un uomo che era a servizio del Re di Corinto, il quale a sua volta lo consegnò al padrone. Il Re adotta il bambino e il giovane principe cresce a Corinto senza sapere di non essere il vero figlio del Re di Corinto. Gli viene predetto dall’oracolo di Delfi che è suo destino uccidere il proprio padre e sposare la propria madre e decide quindi di evitare questa sorte non ritornando più dai suoi presunti genitori. Tornando a Delfi egli ha una violenta lite con un vecchio che viaggia su un carro, perde il controllo e uccide l’uomo e il suo servo senza sapere di aver ucciso suo padre, il Re di Tebe.
Le sue peregrinazioni lo conducono a Tebe. In questa città la Sfinge divora i giovinetti e le giovinette del luogo e non cesserà finché qualcuno non avrà trovato la soluzione dell’enigma che essa propone. L’enigma dice: ” Che cos’è che dapprima cammina su quattro, poi su due e infine su tre? ” La città di Tebe ha promesso che chiunque lo risolva e liberi la città dalla Sfinge sarà fatto Re e gli sarà data in sposa la vedova di Laio. Edipo tenta la sorte. Trova la soluzione all’enigma cioè l’uomo che da bambino cammina su quattro gambe, da adulto su due e da vecchio su tre (col bastone). La Sfinge si getta in mare urlando, Tebe è salvata dalla calamità, Edipo diviene Re e sposa Giocasta, sua madre.
Dopo che Edipo ha regnato felicemente per un certo tempo, la città viene decimata dalla peste che uccide molti cittadini. L’indovino Tiresia rivela che l’epidemia è la punizione del duplice delitto commesso da Edipo, parricidio e incesto. Edipo, dopo aver disperatamente tentato di ignorare la verità, si acceca quando è costretto a vederla e Giocasta si toglie la vita. La tragedia termina nel punto in cui Edipo ha pagato il fio di un delitto che ha commesso a sua insaputa, nonostante i suoi consapevoli sforzi per evitarlo.
È giustificata la conclusione di Freud secondo la quale questo mito conferma la sua teoria che inconsci impulsi incestuosi e il conseguente odio contro il padre-rivale sono riscontrabili in tutti i bambini di sesso maschile? Invero sembra di sì, per cui il complesso di Edipo a buon diritto porta questo nome. Tuttavia, se esaminiamo più da vicino questo mito, nascono questioni che fanno sorgere dei dubbi sull’esattezza di tale teoria. La domanda più logica è questa: se l’interpretazione freudiana fosse giusta, il mito avrebbe dovuto narrare che Edipo incontrò Giocasta senza sapere di essere suo figlio, si innamorò di lei e poi uccise suo padre, sempre inconsapevolmente. Ma nel mito non vi è indizio alcuno che Edipo sia attratto o si innamori di Giocasta. L’unica ragione che viene data del loro matrimonio è che esso comporta la successione al trono. Dovremmo forse credere che un mito, il cui tema è costituito da una relazione incestuosa fra madre e figlio, ometterebbe completamente l’elemento di attrazione fra i due? Questa obiezione diventa ancora più valida se si considera che la profezia del matrimonio con la madre è ricordata una sola volta da Nicola di Damasco, che secondo Cari Robert attinge a una fonte relativamente tarda.
Come possiamo concepire che Edipo, descritto come il coraggioso e saggio eroe che diviene il benefattore di Tebe, abbia commesso un delitto considerato orrendo agli occhi dei suoi contemporanei? A questa domanda si è talvolta risposto, facendo notare che per i greci il concetto stesso di tragedia stava nel fatto che il potente e forte venisse improvvisamente colpito da sciagura. Rimane da vedere se una tale risposta sia sufficiente o se ne esista un’altra più soddisfacente.
Questi problemi sorgono dall’analisi di Edipo Rè. Se consideriamo soltanto questa tragedia senza tenere conto delle altre due parti della trilogia, Edipo a Colono e Antigone, non è possibile dare una risposta definitiva. Ma siamo almeno in grado di formulare una ipotesi e cioè: che il mito può essere inteso come simbolo non dell’amore incestuoso fra madre e figlio, ma della ribellione del figlio contro l’autorità del padre nella famiglia patriarcale; che il matrimonio fra Edipo e Giocasta è soltanto un elemento secondario, soltanto uno dei simboli della vittoria del figlio che prende il posto di suo padre e con questo tutti i suoi privilegi.
La validità di questa ipotesi può essere verificata coll’esame del mito di Edipo nel suo complesso, specialmente nella versione di Sofocle contenuta nelle altre due parti della sua trilogia, Edipo a Colono e Antigone.
FRANZ BRENTANO

LA VITA
Franz Brentano fu un filosofo tedesco che tra i primi si interessò alla psicologia, invitando i ricercatori del tempo a concentrarsi non tanto sui contenuti della mente, ma sugli atti o processi mentali (da cui la corrente dell’intenzionalismo). Discendente da un’antica e nobile famiglia di origine italiana, Franz Brentano nacque a Marienberg sul Reno nel 1838. Studiò filosofia a Berlino, dove entrò in stretto contatto con Friedrich Adolf Trendelenburg, profondo studioso di Aristotele, e poi a Monaco e a Tubinga, laureandovisi nel 1862. Nel 1864 fu ordinato prete cattolico e nel 1866 divenne libero docente all’università di Würzburg. Quando, nel 1869, fu preannunciato il dogma dell’infallibilità del papa, la crisi vocazionale del filosofo, già in atto da diverso tempo, raggiunse il culmine. Brentano, assieme ad altri esponenti del cattolicesimo tedesco, si oppose strenuamente al nuovo dogma, fino a decidere di lasciare la veste talare nel 1872. Come logica conseguenza, nel 1873 anche la posizione universitaria di professore straordinario che aveva ottenuto come ecclesiastico a Würzburg, dovette essere abbandonata. Nel 1874 Brentano divenne però nuovamente professore a Vienna,. Era infatti un oratore particolarmente brillante, e le signore distinte di Vienna affollavano le sue lezioni; tra i suoi allievi vi furono le migliori personalità del tempo, quali il filosofo Edmund Husserl, il politico cecoslovacco Thomas Masaryk, lo scrittore Franz Kafka, lo psicologo Carl Stumpf, oltre al fondatore della psicoanalisi, Sigmund Freud. Dora Stockert Meynert lo descrisse come somigliante a un Cristo bizantino, dalla voce dolce, che costellava la sua eloquenza con gesti di grazia inimitabile, “figura di un profeta con lo spirtito di un uomo di mondo “. Brentano era dotato di un prodigioso talento linguistico, e oltre alla fama di erudito e di filosofo originale, egli era noto per la sua improvvisazione di elaborati giochi di parole. Egli creò un nuovo genere di indovinello chiamato dal- dal- dal che divenne popolarissimo nei salotti viennesi e fu molto imitato; altri indovinelli furono pubblicati in forma anonima. Non sparirono però dalla letteratura, né dalla scienza: infatti Freud li citò in una nota nel libro: Motto di spirito e la sua relazione con l’inconscio. Da figura eminente nella vita sociale viennese del tempo però, ancora una volta Brentano finì nella polvere. Nel 1880 infatti dovette di nuovo dimettersi: questa volta per motivi personali, continuando a tenere lezioni solo come libero docente. Quali erano questi motivi personali ? L’amore, naturalmente. Franz, nel 1880, aveva deciso di sposarsi con una donna cattolica, ma in Austria il matrimonio con un ex prete era proibito, per cui Brentano prese la cittadinanza sassone e si sposò a Lipsia. L’immediata conseguenza fu, come detto, la perdita della carica di professore ordinario a Vienna. La vita coniugale durò solo 14 anni: infatti nel 1894, Brentano restò vedovo. Lasciò Vienna e, dopo aver vissuto in varie città, si stabilì a Firenze nel 1896. La permanenza di Brentano a Firenze fu molto importante per lo sviluppo della filosofia e della psicologia italiana di inizio secolo. Brentano fu infatti in stretto contatto con Francesco De Santis ed ebbe una fitta corrispondenza con il filosofo pragmatista Giovanni Vailati, che aveva tenuto anche un’importante relazione sulla ” classifica degli stati di coscienza” proposta da Franz Brentano al IV congresso internazionale di psicologia a Parigi, nel 1900. Nel 1913 fu tradotta da Mario Puglisi la seconda parte della Psicologia dal punto di vista empirico ( l’opera principale di Brentano) con il titolo La classifica delle attività psichiche. Oltre a numerose opere di filosofia, Brentano si interessò moltissimo alla psicologia, in particolare approfondì le teorie psicologiche del De anima di Aristotele. Nel 1897, a quasi sessant’anni, si sposò per la seconda volta con una donna viennese, suscitando i commenti pungenti di molti suoi colleghi. Nel 1915, a causa dello scoppio della guerra, si trasferì a Zurigo dove morì nel 1917. Nella storia della psicologia si ricordano di Brentano lo studio dei processi mentali, o atti. Egli chiamò questa visione delle cose, “obiettività immanente”. Nei fenomeni fisici, sosteneva, vi è una direzione della mente verso un oggetto, come quando osserviamo qualcosa. L’oggetto che vediamo è ‘inesistente’ fino a che non si compie l’atto di ‘guardarlo’. Le sue idee divennero punto di partenza per moltissimi filosofi e psicologi del tempo.
OPERE PRINCIPALI
Le principali opere di Brentano sono: Psicologia dal punto di vista empirico (1874), L’origine della conoscenza morale (1889), Il futuro della filosofia (1893), Le quattro fasi della filosofia e il suo momento presente (1895), Ricerche sulla psicologia dei sensi (1907), e – dedicate ad Aristotele – Sui molti significati dell’esistente in Aristotele (1862), La psicologia di Aristotele (1867), Il creazionismo di Aristotele (1882), Aristotele e la sua visione del mondo (1911), La dottrina di Aristotele sull’origine dello spirito umano (1911).
IL PENSIERO
Franz Brentano (Marienberg, Austria, 1838 – Zurigo 1917) fu un grande psicologo e filosofo; prete cattolico, si allontanò poi dalla Chiesa; fu docente all’Università di Vienna, ma fu costretto a lasciare l’incarico per motivi di salute. Si stabilì a Firenze e negli ultimi anni in Svizzera, a Zurigo, dove terminò la sua esistenza. Secondo Brentano, alla base dei fenomeni psichici c’è l’intenzionalità, termine che traduce l’intentio del filosofo tardoscolastico Guglielmo da Ockham. L’intenzionalità indica la tensione verso l’oggetto, sempre reale, cui si riferiscono i fatti mentali, che Brentano riduce a tre tipi: rappresentazioni, giudizi e sentimenti. La teoria dell’intenzionalità è molto importante perché, grazie alla mediazione del fenomenologo Husserl e dell’empirista Russell, troverà grande sviluppo nella filosofia della mente e nella scienza cognitiva novecentesca, specialmente dalla fine degli anni Sessanta, quando si sviluppò l’intelligenza artificiale e cominciò a farsi strada un modello di intenzionalità differente. Molto inciderà (con la mediazione di Husserl) sulla formazione filosofica dello stesso Heidegger. Esaminiamo ora più nello specifico il pensiero di Brentano e la nozione che ne sta al cuore: l’intenzionalità. Per Ockham gli universali non sono puri suoni, ma segni naturali prodotti nell’anima delle cose stesse di cui essi sono segno, cosicché l’universale è segno nel modo in cui il fumo è segno del fuoco o il lamento è segno di dolore o di malattia. Esso ha una natura intenzionale, nel senso che “tende verso” (in latino intendit) l’oggetto di cui è segno: in ciò sta per Ockham l’intentio, per cui il termine universale “uomo” è segno non di una presunta entità universale uomo o umanità, bensì di Socrate, di Platone e dei singoli individui umani. Secondo Brentano, l’intenzionalità è il carattere specifico dei fenomeni psichici in quanto si riferiscono tutti ad un oggetto immanente. Sulle diverse forme di intenzionalità, egli fonda la classificazione dei fenomeni psichici. La rappresentazione, il giudizio e il sentimento – che sono per l’appunto le tre classi fondamentali di tali fenomeni – si distinguono tra loro per la natura dell’atto intenzionale che li costituisce. Nella rappresentazione, l’oggetto è semplicemente presente, nel giudizio viene affermato o negato, nel sentimento viene amato oppure odiato. Tutti questi atti si riferiscono ad un “oggetto immanente” e sono dunque intenzionali. Ma la loro intenzionalità – ossia il loro riferimento all’oggetto – è diverso per ciascuno di essi. L’oggetto dell’atto intenzionale è immanente in quanto cade nell’ambito dell’atto stesso, cioè nell’ambito della stessa esperienza psichica. In un primo tempo (nella Psicologia dal punto di vista empirico), Brentano ritenne dunque che l’oggetto dell’intenzionalità potesse essere indifferentemente reale o irreale: a questa fase del suo pensiero si riallacciano Husserl e Meinong. In seguito su questo punto il suo parere mutò. Nella Classificazione dei fenomeni psichici (1911), Brentano afferma che l’oggetto dell’intenzionalità è sempre un oggetto reale e che il riferimento ad un oggetto irreale è sempre un riferimento indiretto, ossia fatto per il tramite di un soggetto che affermi o neghi l’oggetto stesso. Il riferimento all’oggetto è soltanto la relazione primaria dello spirito, che poi ha nello stesso atto una relazione secondaria con se stesso. Ciò comporta che nell’unica attività psichica vi sia una molteplicità di relazioni ed una molteplicità di oggetti. Per Brentano il compito della filosofia è l’analisi dei fenomeni psichici in quanto modo efficace per mostrare e spiegare la verità e la falsità del conoscere. Tuttavia egli si differenzia in modo decisivo dagli psicologi, in particolare da Wundt e da Fechner, che annettevano una importanza esclusiva allo studio dei fenomeni fisici e dunque fondavano la loro scienza psicologica unicamente sull’osservazione e l’esperimento.
Brentano distingue tra fenomeni psichici e fenomeni fisici ed afferma che oltre ad una psicologia fisiologica, esiste una psicologia descrittiva o “psicognosia”, intesa soprattutto come disciplina filosofica. I fenomeni psichici, o atti psichici, si differenziano da quelli fisici per il fatto che sono “intenzionali”, cioè diretti ad uno scopo consapevole. Ogni atto volto a rappresentare, a giudicare, esprimente attrazione o repulsione emotiva, è caratterizzato dal fatto che nello stesso mentale del soggetto è presente l’oggetto, ricordato od intuito. Questa autonomia della sfera psichica da quella fisica, che non dovrebbe tuttavia portare ad una netta separazione, ebbe sicuramente una profonda influenza su Sigmund Freud, che seguì le lezioni di Brentano. Contrariamente a quanto potrebbe apparire da questa rivendicazione di autonomia degli elementi psichici e mentali, Brentano non fu un idealista, ma fu anzi fortemente critico nei confronti delle posizioni speculative dell’idealismo tedesco.
Iniziò la sua attività filosofica muovendo dalle posizioni di Trendelenburg, e quindi da un rinnovato interesse per la filosofia di Aristotele, e su questa base si orientò per un lavoro di rifondazione della filosofia come scienza rigorosa, fondata sull’analisi dell’esperienza e sullo studio del linguaggio con il quale la descriviamo. Brentano è in questo senso ed a buon diritto da considerarsi come un precursore della fenomenologia di Husserl e della psicoanalisi di Freud.
BRANI ANTOLOGICI
Sull’accusa di psicologismo
In questa lettura Brentano afferma di non proporre teorie psicologistiche e respinge le accuse che a questo proposito gli vengono rivolte. Egli conclude ricordando che però la conoscenza è un giudizio e che come tale essa appartiene inevitabilmente al campo psichico.
La mia teoria della conoscenza è stata accusata di psicologismo, una parola venuta in uso recentemente, a udir la quale qualche pio filosofo, come qualche cattolico ortodosso al nome “modernismo”, si fa il segno della croce, come se questo nome contenesse Satana in persona. Per discolparmi di una cosí grave accusa, devo domandare che cosa poi s’intende propriamente con questo, perché a ogni momento si ha sempre pronto quel nome, a mo’ di spauracchio, anche dove si tratta di cose assai diverse. Quando per avere una spiegazione pregai personalmente Husserl e alcuni che seguono fedelmente le sue vedute, mi si disse che con ciò s’intende una teoria la quale combatte la validità universale della conoscenza, una teoria secondo la quale altri esseri, che non siano uomini, possono avere conoscenze che sono addirittura opposte alle nostre. Intesa in questo senso, non solo non sono psicologista, ma sempre ho rigettato e combattuto, nella maniera piú decisa, un tale assurdo soggettivismo. Però sento rispondere che tuttavia sono psicologista e abolisco l’unità della verità per tutti, poiché questa consiste soltanto in quanto al vero giudizio corrisponde qualcosa fuori dello spirito, qualcosa che è una e la stessa per tutti coloro che giudicano. Ma nei giudizi negativi e in quelli che indicano qualcosa come possibile, impossibile, passata o futura, questa qual cosa non può essere un reale, e con ciò, non ammettendo io come qualcosa che sia insieme a reali anche certi non reali, come non essere, possibilità, impossibilità, esser passato, esser nel futuro e simili, abolirei qui secondo loro l’unità della verità per tutti. Rispondo che se anche da quella negazione seguisse l’abolizione della validità universale della conoscenza, tuttavia non va bene di screditarmi come psicologista, giacché io stesso non traggo queste conseguenze. Si potrebbe forse dire soltanto che io pongo proposizioni che, nelle loro conseguenze, devono condurre allo psicologismo. Ma neanche questo è giusto, infatti anche senza premettere tali non reali, perché non dovrebbe essere evidente che due giudizi, dei quali uno afferma in un certo modo ciò che l’altro nega nello stesso modo, non possono essere giusti, tanto se vengono dati da due diverse persone, quanto se li dà una stessa persona? Perché nessuno dirà, spero, che se anche esiste quel non reale, la percezione di questo e il suo confronto col nostro giudizio precedono per farci riconoscere, nell’armonia dell’una con l’altra, e nella loro disarmonia, la verità o falsità dei nostri giudizi. Sono sempre invece percezioni di reali, immediatamente evidenti, e negazioni di composizioni, in cui esse sono entrate nelle nostre rappresentazioni, che ci offrono l’ultimo sostegno nella critica dei propri e degli altrui pensieri. Tanto, in breve, per difendermi da false e odiose dicerie, le quali non credo che possano provenire dalla bocca di antichi discepoli. Ma, se cosí fosse, devono apparire come un segno di estrema debolezza di memoria. Però vi è anche una terza ipotesi. Si conosce ciò che avviene, e che, negli uomini, inavvertitamente, i concetti si spostano, e che essi stessi poi, in seguito alle equivocazioni che ne sono scaturite, non sanno bene che cosa dicono. Cosí qualcuno, che sarà cascato in tale debolezza umana, mi chiama psicologista. E infatti non solo il soggettivista, ma anche colui che crede che la psicologia ha da dire qualcosa nella teoria della conoscenza e nella logica viene confuso nel psicologismo. Ma per quanto io condanni il soggettivismo, tanto poco mi lascio deviare da ciò alla sconoscenza di quella verità, secondo me cosí decisamente stabilita, che mi sembrerebbe paradossale, anzi assurdo, se qualcuno negasse che la conoscenza è un giudizio, o negasse che il giudizio appartiene al campo psichico. E si può dire perciò che se anche altri esseri fuori di noi partecipano alla conoscenza, essi dovranno partecipare a quella che cade anche nel campo dei fenomeni psichici umani, e soltanto qui sono accessibili direttamente all’indagine nostra. [F. Brentano, La classificazione delle attività psichiche]
Sulle attività psichiche
Per Brentano le principali attività psichiche sono riconducibili a tre tipi: la rappresentazione, il giudizio e la relazione affettiva.
Per dir subito la nostra opinione, siamo anche d’avviso che, rispetto alla diversa maniera del loro riferirsi all’oggetto immanente, devono distinguersi tre classi principali di attività psichiche. Ma queste tre specie non sono le stesse di quelle che ordinariamente si pongono e, in mancanza di espressioni piú precise, chiamiamo la prima “rappresentazione”, la seconda “giudizio” e la terza “relazione effettiva”, “interesse” o “amore”. Nessuna di queste denominazioni è di tal sorta che non possa venire malintesa, anzi ciascuna di esse è frequentemente adoperata in un senso piú stretto. Ma la nostra lingua non ci offre migliori espressioni che corrispondano meglio a quei concetti. E sebbene sia malagevole adoperare espressioni che hanno un significato impreciso, come termini per una classificazione cosí importante, e ancor piú di adoperarli forse in un senso insolitamente piú generale, tuttavia, nel nostro caso, mi sembra meglio questo che introdurre delle denominazioni del tutto nuove e sconosciute. Ci siamo già spiegati anche prima su ciò che chiamiamo rappresentazione. Noi parliamo di un rappresentarci quando ci appare qualcosa. Se vediamo qualche cosa ci rappresentiamo un colore, se udiamo qualche cosa ci rappresentiamo un suono, se fantastichiamo intorno a qualche cosa ci rappresentiamo un fantasma. Per mezzo della generalità con cui adoperiamo la parola, potremmo dire impossibile che l’attività psichica si riferisca in qualche modo a qualche cosa che non sia rappresentata. Se ascolto e comprendo un nome mi rappresento ciò che esso significa, e, in generale, è questo lo scopo dei nomi, richiamare rappresentazioni.
Per giudizio intendiamo, in conformità col comune uso filosofico, un accettare (come vero) e respingere (come falso). Ma abbiamo già veduto che un tale accettare e rifiutare avviene anche lí dove molti non adoperano l’espressione giudizio, come per esempio nella percezione di atti psichici e nel ricordo. E naturalmente noi non esiteremo a subordinare anche questi casi alla classe del giudizio. Per la terza classe principale, i di cui fenomeni chiamiamo relazioni affettive, fenomeni di interesse, o fenomeni di amore, manca maggiormente una espressione propria, precisa. Questa classe deve secondo noi, comprendere tutti i fenomeni psichici che non sono contenuti nelle due prime classi. Ma per emozione si comprendono comunemente solo affetti che si associano a una notevole eccitazione fisica. Ognuno indicherà come emozione dell’animo l’ira, la paura, il forte desiderio, ma, nella generalità di cui adoperiamo la parola, essa invece deve essere anche deve essere anche applicata a ogni decisione e a ogni intenzione. [F. Brentano, La classificazione delle attività psichiche]
CHATEAUBRIAND

Chateaubriand, nato a Saint-Malo nel 1768, è diventato uno dei più celebri scrittori della letteratura francese. Discendente di una nobile famiglia bretone, venne avviato fin da giovane alla carriera militare e, a Parigi, fu testimone dei primi eventi rivoluzionari. Sono fermenti sociali che lo vedono inizialmente partecipare in modo distaccato e scettico, in osservanza del già pronunciato conservatorismo che lo scrittore ostentava. Nel 1791 compie un viaggio nel Nordamerica, utile per aprirgli la mente e stimolarlo ad un confronto fertile tra altre culture, altri luoghi e la madrepatria. Tornato in Francia, comincia ad assumere un atteggiamento decisamente più attivo nei confronti della politica, tanto da unirsi alle forze controrivoluzionarie, in difesa dello status quo e della dell’organizzazione monarchica della società. Ma la Rivoluzione Francese è un evento inarrestabile che tutto trascina, un moto della storia violento e febbrile, facente leva delle ondate progressiste scatenate dai difensori della ragione e del progresso sociale. I conservatori come lui si ritrovano quindi ben presto in cattive acque. Lo scrittore è quindi costretto a riparare in Inghilterra, dove visse in pratica da esule per ben sette anni (dal 1793 al 1800). Il ritiro londinese è foriero di nuove ispirazioni e di alacre lavoro letterario. Nel 1797 pubblica il “Saggio storico sulle rivoluzioni”, intriso malgrado tutto dello spirito illuminista che permeava il settecento (non a caso si pone l’accento sulla storia), ma non senza tracce di un’inquietudine religiosa che poco tempo dopo, nei giorni della crisi spirituale seguita alla morte della madre e della sorella, lo condusse a riabbracciare la perduta fede dell’infanzia. L’opera successiva “Il genio del cristianesimo”, iniziata nell’ultimo anno d’esilio e completata dopo il ritorno a Parigi, riflette il proposito di Chauteaubriand di porre il talento letterario al servizio della fede cristiana, difendendola dagli attacchi del voltairianesimo e illustrandone le bellezze poetiche e morali. Partecipano di tale disegno più letterario che filosofico i due brevi romanzi che Chateaubriand incluse nell’opera “Atala”, che narra la vicenda d’amore di due indiani della Louisiana con l’intento di mostrare le armonie della religione con le scene della natura e le passioni del cuore umano, e “Renè”, che attraverso il racconto velatamente autobiografico dei giovani anni del protagonista condanna le passioni indeterminate e le sterili fantasticherie che hanno condotto Renè a un’esistenza di tedio e di solitudine. “Il genio del cristianesimo” ottenne il plauso dell’opinione francese che ritornava in quegli anni alla fede tradizionale dopo la bufera rivoluzionaria, mentre nei tratti del melanconico Renè amarono riconoscersi le prime generazioni romantiche. A dimostrare la superiorità del “meraviglioso cristiano” sul “meraviglioso pagano” Chateaubriand scrisse quindi l’epopea in prosa “I martiri” (1809), dopo essersi recato in Grecia e in Terra Santa per meglio documentarsi sui luoghi della narrazione, ambientata al tempo delle persecuzioni di Diocleziano. Le note e impressioni di viaggio, raccolte nell’ “Itinerario da Parigi a Gernsalemme”, riuscirono uno scritto vivace e non aggravato da intenti epici e apologetici; esso prendeva re mosse, del resto, da una fitta tradizione di relazioni letterarie sull’Oriente. Ricche di suggestioni esotiche e primitivistiche sono anche tre opere composte anni prima: “Le avventure dell’ultima Abencerage”, “I Natchez” (pubblicate entrambe nel 1826), e il “Viaggio in America” pubblicato l’anno dopo. Nominato pari di Francia dopo il ritorno del Barboni, Chateaubriand prese parte attiva alla vita politica della Restaurazione, ricoprendo anche importanti incarichi diplomatici e di governo, ma si dimise dalla camera nel 1830, con l’avvento della monarchia di Luglio. Ritiratosi a vita privata, si dedicò all’elaborazione delle “Memorie d’oltretomba” (composte negli ultimi anni di vita), appassionata rievocazione della sua vita nel quadro d’una tormentata epoca storica. Nell’operosa maturità, confortata dall’amicizia di Mme Recamier, attese anche a minori opere storiche e a una “Vita di Rancé” dove Chauteabriand, tracciando la vita di un religioso del Seicento, ritrova la propria immagine, le proprie illusioni e amarezze. Dotato di una penna elegante e fortemente suggestiva, guidata da un senso molto forte dell’idea di bellezza, Chauteabriand esercitò una forte influenza sulla letteratura dell’Ottocento, annunciando tendenze e motivi destinati a grande fortuna nel secolo romantico. Si spense a Parigi il 4 luglio 1848.
Fu Napoleone in persona a ordinare che venisse recensita positivamente l’opera “Genio del cristianesimo”, pubblicata da François-René de Chateaubriand esattamente il 14 aprile 1802 o, come si diceva allora in ossequio ai dettami della moda rivoluzionaria, il 24 germinale dell’anno X. Per la verità l’autore, che era nato a Saint-Malo nel 1768 e che morirà a Parigi nel 1848, dopo un’iniziale adesione alle idee illuministiche, si era spostato su posizioni decisamente controrivoluzionarie, facendo coincidere tale spostamento con la conversione al cattolicesimo, di cui il Genio è la testimonianza più viva e interessante. Chateaubriand, che con Louis de Bonald e Joseph de Maistre è considerato uno dei maitre à penser della controrivoluzione filosofica francese, ritenne che i fatti del 1789 e tutti i mali che ne erano seguiti fossero la diretta conseguenza delle dottrine elaborate nel XVIII secolo dai Voltaire e dai Diderot, i quali non avevano esitato a porre al centro delle loro riflessioni e delle loro polemiche il rifiuto e la condanna della fede religiosa, in particolare di quella cristiana, di cui avevano criticato e persino ridicolizzato i dogmi e le verità principali. Dunque, per Chateaubriand la sconfessione delle tesi rivoluzionarie e la difesa del cristianesimo sono due facce della stessa medaglia, il compito che gli si impone è allora quello di dimostrare che il messaggio di Gesù Cristo non soltanto non ha prodotto gli effetti negativi denunciati dagli illuministi ma, al contrario, è stato il più potente alleato della cecità occidentale e del progresso della cultura: «Non si trattava – si legge a questo riguardo nel Genio del cristianesimo – di riconciliare con la religione i sofisti, bensì la gente da essi traviata. L’avevano ingannata col dire che il cristianesimo era un culto nato in seno alla barbarie, assurdo nei dogmi, ridicolo nelle sue cerimonie, nemico delle arti e delle lettere, della ragione e della bellezza; un culto che aveva continuamente versato il sangue, incatenato gli uomini e ritardato la felicità e i lumi del genere umano; si doveva dimostrare che, al contrario di tutte le religioni mai esistite, la religione cristiana è la più poetica, la più umana, la più favorevole alla libertà, alle arti, alle lettere; che il mondo moderno le deve tutto, dall’agricoltura alle scienze astratte; dagli ospizi per gli infelici fino ai templi costruiti da Michelangelo e decorati da Raffaello». Gettandosi in un dibattito antico e, come è noto, ancor oggi di grande attualità, Chateaubriand manifesta la certezza che la civiltà cristiana sia superiore a tutte le altre. E per suffragare questa tesi fa appello a motivi estetici e sentimentali piuttosto che ad argomentazioni strettamente razionali e logiche: egli – è stato detto – «non spiega, non ragiona, ma contempla e ammira». E ammirando, si convince che niente è più sublime della religione cristiana, a proposito della quale, sempre nel Genio, afferma: «Si doveva dimostrare come niente sia più divino della sua morale, niente più bello e solenne dei suoi dogmi, della sua dottrina e del suo culto; occorreva dire come essa favorisca il genio, purifichi il gusto, sviluppi le passioni virtuose, dia vigore al pensiero, offra nobili forme allo scrittore e perfetti stampi agli artisti; che non bisogna vergognarsi di credere con Newton e Bossuet, Pascal e Racine». A questo punto, agli occhi di Chateaubriand, è evidente che coloro che hanno pensato di poter fare a meno del cristianesimo avrebbero condotto l’uomo e la società allo sfacelo, perché esso rappresenta quella tradizione aurea fuori o contro la quale non è possibile edificare niente di buono: «E’ qualcosa di generalmente riconosciuto – si legge ancora nel Genio del cristianesimo – che l’Europa deve alla Santa Sede la propria civiltà, una parte delle sue leggi migliori e quasi tutte le sue scienze e le sue arti». «Avvocato poetico» del cattolicesimo, come lo definì Sainte-Beuve, e fors’anche «cristiano dilettante», secondo il giudizio che ne dette Pierre Moreau, Chateaubriand non appare teologo e filosofo capace di speculazioni profonde; la sua stessa religiosità risulta a volte vaga e troppo legata alle emozioni e condizionata dai sentimenti. Tuttavia, questo intellettuale dalla vita inquieta – ebbe una carriera politico-diplomatica contrastata ancorché di buon successo, e celebre resta il suo fascino di grande amatore – fu capace di riattirare sulla Chiesa il favore e la simpatia della gente e degli stessi uomini di cultura, dopo l’ubriacatura anticristiana che aveva stordito per lungo tempo la Francia e che era figlia di quel materialismo rivoluzionario che egli definì «il patibolo sostituito alla legge e obbedito in nome dell’umanità».
WILLIAM HAMILTON
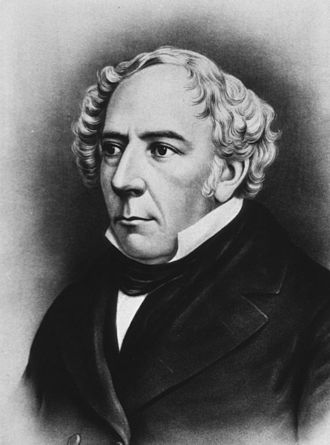
A cura di Daniele Lo Giudice
William Hamilton nacque a Glasgow, in Scozia, l’8 marzo 1788 e morì ad Edimburgo il 6 maggio 1856. Nel 1836 divenne professore di logica e metafisica all’università di Edimburgo. La sua importanza di filosofo è strettamente legata alle Lezioni di Logica ed alle Lezioni di metafisica. Nelle prime Hamilton introdusse la quantificazione del predicato. Secondo questo principio, nelle proposizioni si deve indicare la quantità, ovvero il numero, non solo del soggetto, ma anche del predicato. Ad esempio, risulta indubbiamente più preciso affermare che Pietro, Giacomo e Giovanni furono alcuni apostoli, piuttosto che affermare genericamente che furono apostoli. Nelle Lezioni di metafisica, Hamilton effettuò una ripresa della teoria psicologica della scuola scozzese del senso comune: com’è noto, i filosofi della Scuola Scozzese (primo fra tutti Thomas Reid), ai dubbi humeani e cartesiani, rispondevano dicendo che a garantirci l’esistenza del mondo esterno e la validità della conoscenza è il senso comune, ovvero il sentimento in base al quale ciascuno crede all’esistenza delle cose esterne e del proprio io. Tuttavia, Hamilton introduce una variante alla dottrina del senso comune: infatti – egli nota – la percezione immediata non ci fa conoscere la cosa com’è in se stessa. In proposito, egli scrive:
“La teoria della percezione immediata non implica che noi percepiamo la realtà materiale assolutamente ed in se stessa, cioè fuori dalle relazioni con i nostri organi e le nostre facoltà; al contrario, l’oggetto totale e reale della percezione è l’oggetto esterno in relazione ai nostri sensi e alla nostra facoltà conoscitiva. Ma per quanto relativo a noi l’oggetto non è rappresentazione, non è una modificazione dell’io. Esso è il non-io – il non-io modificato e relativo, forse, ma pur sempre non-io”. (Lectures on Metaphysics, I, 1870, p. 129)
I motivi della scuola scozzese vengono dunque da Hamilton coniugati con il trascendentalismo kantiano, poiché se è vero che la conoscenza è data dalla percezione immediata, è però anche vero che l’oggetto percettivo non è la cosa come è in se stessa, bensì come è modificata dalla sua relazione con i nostri organi conoscitivi. Ne segue allora che, kantianamente, la cosa in sé, l’Assoluto da cui la conoscenza sensibile deriva, resta del tutto in conoscibile. Di esso si può affermare l’esistenza soltanto con un atto di fede. Alla luce di queste considerazioni, è evidente che Hamilton, nello sviluppare una teoria della percezione del mondo esterno sulla base del senso comune, veniva in realtà ad affermare esattamente il contrario; mentre i filosofi come Reid avevano detto che noi percepiamo immediatamente l’oggetto così com’è, Hamilton diceva che l’esistenza di un oggetto non è conoscibile nella sua assolutezza, ma solo in modi speciali, strettamente legati a quelle che sono le nostre facoltà di percezione e valutazione. Inoltre, le determinazioni che riusciamo ad attuare circa gli oggetti sono il risultato di una modificazione delle nostre stesse facoltà. In altre parole: anche Hamilton conviene nel dire che la nostra conoscenza è sempre relativa e che l’intuizione può anche sbagliare cogliendo un determinato oggetto in una particolare situazione, ad esempio un uomo irato o addolorato in una situazione nella quale egli risulti alterato. Anche Hamilton si pronunciò quindi contro la dottrina della conoscibilità dell’Assoluto, teorizzata da Schelling e da Cousin, anche se in accordo con essi, accetta l’idea che l’Assoluto esista, affermando altresì che la prova della sua esistenza starebbe nella credenza. Il ragionamento di Hamilton fu, grosso modo, questo: poichè noi non possiamo cogliere l’infinito, cioè l’Assoluto, con una percezione sensibile, noi possiamo intuirlo o pensarlo, ma pensandolo, lo condizioniamo, mentre l’Assoluto è, per sua stessa definizione, incondizionato. Di fronte a questo paradosso della ragione, Hamilton, disse che “l’Assoluto non è concepibile che come negazione della concepibilità“. Tuttavia, “poichè la sfera della nostra credenza è molto più estesa della sfera della nostra conoscenza“, quando neghiamo che si possa conoscere, siamo ben lontani dal dire e dal pensare che non vi si debba credere. Asserendo che credere è legittimo, Hamilton, ritornò, di fatto, ai principi della scuola scozzese. È solo nella credenza (da Hamilton intesa come fede), infatti, che si attua quel processo per il quale l’infinito/Assoluto rivela se stesso all’uomo. In sintesi: Hamilton fu scettico circa le possibilità della percezione e della ragione, da un lato, ma dall’altro fu anche un dogmatico della fede, cioè un filosofo che negava alla ricerca filosofica qualsiasi possibilità di arrivare all’Assoluto e quindi a Dio, nei termini propri della Rivelazione ricevuta dalla religione. In altre parole, egli seguì una tradizione che risaliva a Duns Scoto e a Guglielmo di Ockham. Contro Hamilton polemizzò aspramente John Stuart Mill, autore di uno scritto Esame della filosofia di Sir William Hamilton (1865): in quest’opera, il cui cuore è la riflessione sulla conoscenza, Mill va sostenendo che ogni nostra conoscenza è una conoscenza di idee, le quali non hanno alcun rapporto con una realtà estrinseca alla sfera della rappresentazione, a differenza di quel che asseriva Hamilton: l’intero processo conoscitivo si risolve allora per Mill nell’associazione di idee.
NEWMAN

A cura di Giuseppe Tortora
Lo spiritualismo e la filosofia dell’azione furono correnti filosofiche tipicamente francesi, ma tra i loro principali ispiratori dev’essere sicuramente annoverato l’inglese John Henry Newman (1801-1890). Egli infatti, originariamente anglicano, divenuto poi cardinale della chiesa cattolica, nel Saggio sullo sviluppo della dottrina cristiana (1845) sostenne che una dottrina, una teoria, un enunciato, sia di natura etica o politica o religiosa, mostra la sua effettiva vitalità quando penetra nella moltitudine degli uomini, e non solo viene accettato o anche tradotto in termini concettuali chiari e distinti, ma diviene un «principio attivo»; e attivo non solo nel senso che genera nell’uomo una nuova contemplazione o una rimeditazione, ma soprattutto nel senso che si traduce in azioni, in iniziative di applicazione. È qui che si nota come l’azione assuma un ruolo assolutamente capitale. In tal senso, secondo Newman, si può affermare senza incertezze che il cristianesimo è stato sempre vitale, privilegiando l’azione rispetto alla contemplazione. Ma quali sono le ragioni per le quali alcune, e solo alcune, teorie vengono attuate «in pratica», acquistano «vitalità»? A tale domanda Newman tenta di rispondere nel suo Saggio di una grammatica dell’assenso (1870): egli rileva che le proposizioni possono avere la forma della domanda, che esprime un dubbio, o della conclusione, che esprime un processo di inferenza, o della asserzione, che esprime un atto di assenso. Rispetto all’inferenza (cioè al ragionamento), in cui la conclusione è «condizionata» dalle premesse da cui si parte, l’assenso è sempre «incondizionato»; e rispetto al dubbio, l’assenso esprime «certezza»; certezza che, nota Newman, non significa infallibilità, perché essa sussiste anche quando ci s’inganna; certezza, dunque, che è un atto di fede consapevole e deliberato. L’assenso poi può essere nozionale (professione, opinione, presunzione, ecc) se è dato alle nozioni; o reale, se è attribuito a cose. L’assenso nozionale è piú debole di quello reale, perché solo questo ha la capacità di sollecitare affetti, sentimenti, passioni, può coinvolgere la volontà, può generare azioni. In campo religioso – che è quello che piú direttamente interessa a Newman – non è l’assenso nozionale, ma quello reale, che dà vitalità ad una dottrina, anche se questo secondo non sussiste senza il primo (mentre invece è possibile il contrario, che il primo sussista senza il secondo). Tuttavia vale in generale, per Newman, che solo quando una dottrina muove l’aspetto affettivo, pratico, dell’uomo, essa si sviluppa nel corso del tempo e diventa forza storica. Distinguendo tra l’assenso nozionale (che è di tipo intellettuale e si configura come adesione teoretica ad una proposizione assertiva) e l’assenso reale (dato invece dalla volontà e tale da investire la sfera pratica dell’agire), Newman non esita minimamente a riconoscere la netta superiorità del secondo, dando così il via ad una filosofia che troverà in Ollé-Laprune il suo diretto continuatore.
LOTZE

A cura di Alessandro Sangalli
Rudolf Hermann Lotze nacque il 21 maggio 1817 e morì il 1° luglio del 1881. Come filosofo, tentò di conciliare i concetti della scienza meccanicista con i princìpi dell’idealismo romantico. Studente sia di medicina che di filosofia a Lipsia, dove in seguito tenne lezioni su entrambe le materie, diventò professore nel 1842. Nel 1844 successe a Johann Friedrich Herbart come professore a Gottinga e nel 1881 si unì alla facoltà di Berlino. Le sue opere principali sono: Metafisica (1841); Allegemeine Pathologie und Therapeutik als mechanische Naturwissenschaften (1842); Logica (1843); Fisiologia (1851); Psicologia medica (1852); Microcosmo, 3 voll. (1856-1864); Sistema di Filosofia: Logica (1874); Metafisica (1879). Il suo pensiero rappresenta una decisa reazione al panteismo idealistico di Hegel, che sembrava sacrificare l’individualità e la varietà dell’esistenza ad un formale ed astratto schema di sviluppo dialettico. Lotze definì la sua posizione filosofica come un idealismo teleologico, e considerava l’etica il punto di partenza della metafisica. Mentre da una parte rinforzava la visione meccanica della natura, dall’altra cercava di mostrare come il meccanicismo – la relazione causa/effetto – fosse in realtà incomprensibile, se non come la realizzazione di un mondo di idee morali. Così ogni catena causale diventa allo stesso tempo una catena teleologica. Lotze riuscì ad elaborare questa conciliazione tra una visione meccanicista con una teleologica combinando le monadi del pensiero di Leibniz con la sostanza infinita di Spinoza: in quest’ultima trovano infatti il proprio fondamento le cose individuali (monadi), ed inoltre, attraverso la sua unità che tutto comprende, diventa possibile l’interrelazione.Tenendo insieme la monadologia leibniziana e il panteismo di Spinosa, Lotze cerca di tenere coniugare monismo e pluralismo, meccanicismo e teleologia, realismo e idealismo, panteismo e teismo. Lotze riconosce valore alle istanze dell’idealismo etico-religioso di Fichte e le applica ad una sobria e scientifica interpretazione dei fenomeni naturali. In Lotze convivono una ferma convinzione dell’universale validità delle leggi scientifiche e la consapevolezza della necessità della metafisica. Egli insiste sul fatto che la filosofia debba avere le sue radici nelle scienze naturali, poiché gli esseri umani sono soggetti alla medesime leggi fisiche che governano gli oggetti inanimati: si schiera perciò contro qualsiasi tentativo di dedurre la realtà da meri principi astratti. “La conoscenza – sostiene – è il risultato dell’osservazione e dell’esperimento, non di uno sviluppo logico-dialettico”. L’obiettivo della metafisica è perciò quello di analizzare e sistematizzare i concetti prodotti dalla scienza. Secondo Lotze la natura è sì governata da leggi meccaniche, ma il sistema della natura è un insieme di mezzi indirizzati verso un fine fissato da Dio. Egli considera tutte le cose come immanenti in Dio; ciò che gli scienziati vedono come una causalità meccanica è semplicemente l’espressione dell’attività divina. Le cosiddette leggi naturali sono nient’altro che azione divina: sono i modi dell’operare di Dio. Lotze rileva come l’uomo non possa trovare nessun appagamento etico-religioso nell’universo meccanizzato della scienza. La materia organica e quella inorganica si differenziano nell’organizzazione delle loro parti: la forza materiale conferisce movimento e direzione a queste parti separate. La concezione meccanica dell’universo, che considera anche il corpo umano come una macchina, non lascia quindi spazio alle idee e ai proponimenti dell’uomo. Il meccanicismo, secondo Lotze, risulta inadeguato per spiegare la vita. Sensazioni, percezioni e leggi del pensiero sono funzioni del Soggetto, dell’Io. La Realtà, le cose considerate per se stesse, devono avere la capacità di operare e subire effetti, pur rimanendo le stesse in ogni mutamento. La Realtà è da noi conosciuta soltanto attraverso quel principio di unità autodeterminante che è l’anima. Un’anima che è distinta dal corpo: essa è infatti la capacità della mente di combinare la molteplicità dei fenomeni nell’unità di un’esperienza cosciente. Lotze afferma perciò che l’universo fisico deve essere interpretato in termini mentali, cioè per come è conosciuto da noi. La materia è attiva e vitale, ma la vita mentale è superiore: essa riesce infatti ad illuminare le grossolane forme materiali. Benché il mondo fenomenico non sia privo di significato, lo si deve tuttavia concepire come un mondo eticamente ordinato. Per quel che concerne la logica, Lotze sostiene che forme e leggi del pensiero hanno fondamento nella ricerca del bene: la realtà stessa ha fondamento nel bene. La relazione tra corpo (meccanicismo) e anima (teleologia) si configura come un’interazione, anche se resta umanamente impossibile spiegare come ciò accada. Il corpo, secondo Lotze, è un sistema di monadi, di forze spirituali, ma è l’anima, correlata al cervello, che lo domina. Per questa via, Lotze trasforma la teoria meccanicista in un sistema di realtà spirituali in relazione reciproca l’una con l’altra. La molteplicità del mondo necessita infatti il suo fondamento in una sostanza universale della quale tutti i fenomeni siano modi d’espressione. Il meccanicismo diventa perciò un’espressione dell’Assoluto, dell’Essere infinito. La filosofia di Lotze trapassa così in un panteismo idealista nel quale coesistono la sostanza di Spinoza e le monadi di Leibniz: l’anima umana conferisce una personalità alla sostanza universale e ne fa un essere assolutamente buono, un Dio-amore. Nel suo capolavoro – Microcosmo (1856-64) -, Lotze avanza l’idea che gli scienziati e i fisici abbiano ragione a ritenere che l’universo sia costituito da atomi, ma gli atomi sono entità coscienti, senzienti, e si influenzano l’un l’altro in maniera causale, in prevedibile accordo con le leggi naturali. Questi atomi, o monadi, possono essere considerati meccanicamente dal di fuori, ma internamente sono espressioni di una volontà. Tutta la natura, che è meccanicismo direzionato da un fine, è espressione del volere creativo di Dio. Inoltre, sempre in quest’opera, Lotze sostiene che sia la mente a rendere unico l’uomo: infatti, sebbene sia soggetto come gli altri animali al processo evolutivo e alla lotta per l’esistenza, la sua storia non può essere interamente compresa in meri termini meccanicisti. L’uomo, che è in se stesso un’unità, porta l’Unità all’esistenza utilizzando idee e ideali: le unità, in natura, sono prodotti mentali. Sicchè è incontestabile che la natura si muove secondo leggi necessarie ed immutabili; ma bisogna aggiungere che tale ordinamento meccanico è espressione di una saggezza superiore, ed ha uno scopo complessivo che è quello della realizzazione del bene. Anzi quanto piú si approfondisce la perfezione del meccanismo naturale, tanto piú si fa chiaro il principio superiore di razionalità inerente alla realtà. E infatti, la scoperta che il processo di evoluzione della natura culmina nell’uomo, nella sua vita spirituale, è la testimonianza che tutta la realtà, cosiddetta «materiale», è nella sua sostanza «spirituale», e che l’affermazione dello spirito è il fine stesso del processo naturale. Inoltre la regolarità del processo mostra che Dio è la condizione di ogni evento fisico e di ogni legge meccanica. All’uomo cosí resta aperta la via alla speranza e alla gioia dell’esistenza, come pure la possibilità dell’azione morale e la certezza della fede.
HEINRICH HEINE

A cura di Stefano Paduano
“L’annientamento della fede nel cielo ha una importanza non soltanto morale, ma anche politica: le masse non sopportano piú con cristiana pazienza la loro miseria terrena, e aspirano ardentemente a una beatitudine sulla terra. Il comunismo è una conseguenza naturale di questa mutata visione del mondo, e si estende per tutta la Germania. Una manifestazione altrettanto naturale è che i proletari, nella loro lotta contro lo stato di cose esistente, abbiano come guide gli spiriti piú avanzati, i filosofi della grande scuola; questi trapassano dalla dottrina all’azione, scopo ultimo di ogni pensare” (Lettere sulla Germania, 1844).
CENNI BIOGRAFICI
Heinrich Heine (1797-1856), poeta tedesco di origini ebraiche, fu anche un importante filosofo collocato nelle file della Sinistra hegeliana. I suoi versi hanno ispirato molti compositori come Mendelssohn, Schubert, e Schumann. Heinrich Heine visse in un epoca di grandi cambiamenti sociali e politici: la Rivoluzione Francese (1789-99) e le guerre napoleoniche influenzeranno profondamente il suo pensiero. Heine morì a Parigi, dove è vissuto dal 1831 come una delle figure centrali sulla scena letteraria. Tra le famosi poesie di Heine ricordiamo ‘Die Lorelei’, adattata musicalmente da Silcher nel 1837 e ripresa da F. Liszt. E’ diventata una delle più note canzoni tedesche.
Io non so che voglia dire
che son triste, così triste.
Un racconto d’altri tempi
nella mia memoria insiste.
Fresca è l’aria e l’ombra cala,
scorre il Reno quetamente;
sopra il monte raggia il sole
declinando all’occidente.
La bellissima fanciulla
sta lassù, mostra il tesoro
dei suoi splendidi gioielli,
liscia i suoi capelli d’oro.
mentre il pettine maneggia,
canta, e il canto ha una malia
strana e forte che si effonde
con la dolce melodia.
Soffre e piange il barcaiolo,
e non sa che mal l’opprima,
più non vede scogli e rive,
fissi gli occhi ha su la cima.
Alla fine l’onda inghiotte
barcaiolo e barca…Ed ahi!
Questo ha fatto col suo canto
la fanciulla Lorelei.
Harry Heine nacque a Düsseldorf nel 1797 da una stimata famiglia di commercianti e banchieri ebrei. Intraprese malvolentieri una carriera per diventare un borghese. Le alterne vicende della dominazione francese nella sua città risvegliarono in lui precoci tendenze francofile e una profonda antipatia per la Prussia. Sog giornò a Bonn (1817) iniziando gli studi di diritto filosofia e letteratura; qui a Bonn seguì le lezioni di August W. Schlegel . Nel 1821 passò l’università di Berlin, dove frequentò tra gli altri Hegel, Schleiermacher e Chamisso. Nel 1825 si converte alla religione evangelica e assume il nome di Heinrich: in quello stesso anno si laurea in giurisprudenza a Gottinga. Fa viaggi in Inghilterra, ciò che risveglia i suoi interessi politici, e in Italia. La critica sempre più radicale della società tedesca spinse Heine a trasferirsi come giornalista nella più libera Francia, dove frequentò la comunità di tedeschi qui immigrati, come Humboldt , Lasalle, Wagner; ma anche gli intellettuali francesi come Balzac, Hugo, Sand. Entrò anche in contatto con i sansimonisti. Scrisse corrispondenze per varie riviste tedesche, ma anche resoconti in francese sulla situazione tedesca. Nel 1835 la censura proibì la circolazione dei suoi libri in Germania. Solo con l’aiuto del governo francese, datogli nonostante le critiche rivolte a Luigi Filippo, Heine potè far fronte alle difficoltà economiche causategli dal divieto. Gli ultimi anni furono segnati dalle sofferenze atroci provocate da una atrofia muscolare progressiva, che lo costrinse a letto per quasi otto anni. Morì a Paris nel 1856. Già prima del soggiorno a Bonn (1817) aveva iniziato a scrivere le prime liriche d’amore. Le sue prime liriche pubblicate nel 1822, mostrano l’influsso di Byron e di Fouqué , ma anche caratteri d’originalità, con il loro rifarsi allo stile delle ballate popolari e nell’ironico rifiuto di ogni illusione. L’Intermezzo lirico (Lyrisches Intermezzo, 1823) possiede una spiccata vena melodica. Con i due primi volumi dei racconti lirici Impressioni di viaggio (Reisebilder, 1826-1831) mise le basi della sua fama letteraria: sul filo di un presunto diario di viaggio che si richiama agli esempi di Sterne e di Jean Paul , le “Impressioni” trattano diversi temi fantastici e morali.
Nel Libro dei canti (Buch der Lieder, 1827) riunì le liriche dei periodi precedenti. Frutto del breve viaggio in Italia è il terzo volume delle Impressioni di viaggio (1829), e i racconti delle Notte fiorentine (Florentinische Nächte, 1836). Al periodo francese, e frutto dei contatti con i sansimonisti, risalgono la sua Storia della religione e della filosofia in Germania (Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland, 1835), e la Scuola romanticista (Romantische Schule, 1833-1836). Gli scritti di questo periodo, in cui prevale la tematica politica, sono raccolti nei quattro volumi del Salon (1834-1840). Qui si trovano anche i frammenti di romanzo Dalle memorie del signor von Schnabelewopski (Aus den Memorien des Herrn von Schnabelewopski), e Il rabbi di Bacharach (Der Rabbi von Bacharach) sulla persecuzione degli ebrei nel medioevo. In H.Heine su L.Bö rne (H. Heine über L.Bö rne, 1840) Heine diede una aggressiva giustificazione delle proprie idee in risposta alle critiche dei connazionali. Nel poema Atta Troll : ein sommernachtstraum (1843) attaccò con dura ironia avversari letterati e politici. Dopo una breve visita a Hamburg nacque la satira in versi Germania una fiaba d’inverno (Deutschland ein Winter märchen, 1844), una delle più importanti opere della letteratura politica tedesca, in cui è evidente l’influsso dell’amicizia Parisna di Heine con il giovane Karl Marx.
IL PENSIERO
Le atroci sofferenze della malattia sono descritte nelle poesie del Romancero (1851), e nelle raccolte del 1853-1854, in cui prevale una profonda serietà etica e religiosa. Gli Scritti vari (Vermischte Schriften, 1854) sono dissertazioni su giudaismo e cristianesimo, liberalismo e comunismo, costituiscono la summa e la conclusione della sua attività politica e letteraria.
Tu sei come un fiore
così soave, bella e pura
io ti guardo e la malinconia
s’insinua nel mio suore.
Mi sento come se
dovessi porti le mani sul capo,
pregando che Dio ti conservi
pura, bella e soave.
(da ‘Du Bist Wie eine Blume’, composta per Therese Heine)
Come poeta Heine fece il suo debutto con Gedichte (Poesie) nel 1821. Nella raccolta includette una delle sue più famose poesie, Zwei Grenadiere, che rispecchia la passione di Heine per Napoleone. Heine si infatua delle cugine Amalie e Therese che lo ispirano a scrivere alcune poesie d’amore. Buch der Lieder (1927) fu la prima esauriente raccolta di versi. Questi primi lavori mostrano l’influenza della poesia folcloristica, ma grazie al suo ironico tocco Henrie si separa dalla corrente principale romantica. I viaggi estivi di Henri producerono le basi per i suoi quattro volumi Reisebilder (1826-31), una sintesi autobiografica, critica sociale e dibattito letterario.
Heine visitò l’Inghilterra nel 1827, ma la formalità del comportamento e il materialismo borghese spaventarono il poeta che ritornò amareggiato in Germania. Nel terzo volume di Reisebilder (Die Bäder von Lucca), Heine satireggia il poeta August von Platen, che lo aveva attaccato per via delle sue origini ebree. Questo fatto danneggiò la reputazione di Heine, che nel 1831 si recò a Parigi come giornalista, per scrivere articoli di giornale sullo sviluppo della democrazia e del capitalismo in Francia. Nel 1834 si innamorò di Crecence Eugénie Mirat (‘Mathilde’ nelle sue poesie), una commessa ignorante, con la quale si sposerà sette anni dopo. Mathilde sarà una sperperatrice ma durante la lunga malattia durata otto anni di Heine lei lo accudirà teneramente e fedelmente. Heine scrivette numerose poesie su Mathilde, ma non saranno certo le migliori della sua produzione.
A Parigi, Heine fece cronache sulla cultura e gli affari politici francesi, scrisse libri sui suoi viaggi e lavori sulla letteratura e filosofia tedesca. A quel tempo, Parigi era la culla europea delle nuove idee: Victor Hugo ha appena pubblicato Notre Dame de Paris, appaiono le prime novelle di Balzac e George Sand, Delacroix e Delaroche erano al centro dei saloni d’arte. Le opinioni di Heine infastidiscono la censura tedesca, e lui non avrà altra scelta che diventare un profeta in Germania. Alla fine del 1835, la Dieta Federale Tedesca provò a mettere al bando in tutta la nazione ogni suo lavoro. Presto Heine si trovò ad essere circondato dalla polizia segreta, e il suo esilio divenne forzato. Il poeta una volta dichiarò: “quando gli eroi se ne vanno, subentrano i clown”.
Dopo una visita alla sua casa natale, Heine, disprezzando i censori tedeschi, pubblicò un lungo verso satirico, Deutchland: ein Wintermaerchen (1844), un attacco durissimo ai circoli reazionari. Nello stesso anno (il 1844), i tessitori slesiani protestarono violentemente contro le intollerabili condizioni lavorative e Heine si schierò con loro nella sua poesia:
“Condannati dalla patria, falso nome, / Dove non cresce nulla a parte disgrazia e vergogna, / Dove i fiori sono schiacciati prima di sbocciare, /Dove il verme è destato dalla putrefazione e dalla muffa – Noi tessiamo, noi tessiamo”.
Friedrich Engels tradurrà la poesia in inglese, che diventò successivamente una delle poesie più studiate nei paesi comunisti. Anche Karl Marx lesse con entusiasmo le poesie di Heine, intrattenendo con lui una fitta corrispondenza epistolare. Lo zio di Heine morì nel 1844 lasciandogli una piccola pensioncina. Dopo il 1844 Heine patì crisi finanziarie e un peggioramento della sua salute. Secondo alcune ipotesi, egli soffriva di una sclerosi laterale amiotrofica. Dal 1848 fino alla sua morte Heine rimase paralizzato, ma scrisse una delle sue più raffinate raccolte di versi, Romanzero (1851). Engels lo vide e scrisse:”… Heine è alla fine. Nel quattordici giorni che mi sono intrattenuto da lui, se n’è stato nel letto e ha patito una crisi di nervi”.
Durante l’ultimo anno, Heine si interessò al sensualismo sia cristiano che pagano. La sua ultima relazione amorosa fu con Camilla Selden, un’australiana che lui chiamò ‘Mouche’. Le poesie dedicate a Camilla contengono alcuni dei suoi migliori versi. Heine morì a Parigi nel 17 Febbraio del 1856. Anche dopo la sua morte, i suoi scritti destarono controversie in Germania, influenzando il giovane Rilke, Wilhelm Busch e Frank Wedekind, e altri aspiranti poeti. La stessa proposta di erigere una statua in suo onore destò proteste. Vista la discendenza ebraica di Heine, i nazisti insistettero nel bollarlo come ‘autore sconosciuto’, negandogli ogni valore poetico.
La poetica di Heine prende le mosse dai versi romantici, volti soprattutto alla tagliente satira politica: ma lui non credeva che le sue parole avrebbero cambiato qualcosa: “Non puoi scaccuare i topi coi sillogismi / Essi scavalcano facilmente i tuoi sofismi più raffinati”. Ebbe una relazione di amore-odio con il romanticismo tedesco, anche se i suoi versi sono tra i migliori esempi di poesia. Dopo la Rivoluzione del 1830, Heine si era trasferito a Parigi, componendo nel 1834 il suo scritto filosoficamente più rilevante: Sulla storia della religione e della filosofia in Germania. In quest’opera, egli va sostenendo che la Germania ha già compiuto la rivoluzione filosofica e spirituale, della quale Hegel aveva concluso “il grande ciclo”. Si trattava ora per la Germania di attuare anche la rivoluzione politica, forti delle altre due. La stessa religione cristiana ha smorzato ma non distrutto la “brutale smania di combattere dei Tedeschi”: ciò, secondo Heine, sarebbe risultato ben evidente nel giorno in cui il “talismano addomesticatore” della croce cristiana – ormai fradicio – fosse andato in pezzi.
BRANI ANTOLOGICI
Heine stabilisce un parallelo fra la rivoluzione filosofica in Germania e la rivoluzione politica in Francia: il criticismo kantiano, l’idealismo di Fichte e la filosofia della natura di Schelling hanno sviluppato in Germania una grande forza rivoluzionaria che è in attesa soltanto del momento di potersi scatenare.
“La nostra rivoluzione filosofica è terminata. Hegel ha chiuso il suo grande ciclo. […] La filosofia tedesca è una cosa importante, che interessa tutto il genere umano, e solo i nipoti che verranno potranno decidere se siamo da biasimare o da lodare per il fatto che abbiamo elaborato prima la nostra filosofia e poi la nostra rivoluzione. A me sembra che un popolo metodico, come siamo noi, dovesse cominciare con la riforma, potesse in seguito occuparsi di filosofia e, solo dopo averla portata alla perfezione, procedere alla rivoluzione politica. Io trovo del tutto ragionevole quest’ordine. Le teste, che la filosofia ha adoperato per meditare, queste poi la rivoluzione può abbatterle per i propri fini. Ma la filosofia non avrebbe mai potuto adoperare le teste che sarebbero state abbattute dalla rivoluzione, nel caso che la avesse preceduta. Ma non siate inquieti, repubblicani tedeschi: la rivoluzione tedesca non sarà né piú dolce né piú mite perché l’ha preceduta la critica kantiana, l’idealismo trascendentale di Fichte e la filosofia della natura. Attraverso queste dottrine si sono sviluppate le forze rivoluzionarie che attendono solo il giorno in cui potranno scatenarsi e riempire il mondo di orrore e di ammirazione. Si vedranno dei kantiani che, anche nel mondo dei fenomeni, non vorranno saperne della pietà e che, spietatamente, con la spada e con la scure, sconvolgeranno il terreno della nostra vita europea, per estirpare anche le ultime radici del passato. Verranno sulla scena dei fichtiani armati che, nel fanatismo della loro volontà, non potranno essere frenati né dalla paura né dall’interesse personale, giacché essi vivono nello spirito e combattono la materia come i primi cristiani che non potettero essere piegati né dalle torture né dai piaceri della carne; anzi, siffatti idealisti trascendentali sarebbero, in un rivolgimento sociale, ancora piú tenaci dei primi cristiani, poiché, mentre questi subivano il martirio terreno per giungere alla beatitudine celeste, l’idealista trascendentale considera lo stesso martirio come una vana parvenza ed è irraggiungibile nella trincea del proprio pensiero. Ma piú terribili di tutti sarebbero ancora i filosofi della natura che attivamente interverrebbero in una rivoluzione tedesca e si identificherebbero con la stessa opera di distruzione. E invero, se la mano del kantiano percuote fortemente e sicuramente, per il fatto che il suo cuore non è mosso da nessuna riverenza tradizionale; se il fichtiano coraggiosamente affronta ogni pericolo, per il fatto che per lui non ne esiste nella realtà nessuno; il filosofo della natura sarà terribile per il fatto che si mette in relazione con le potenze originarie della natura, può evocare le forze demoniache del panteismo alto-germanico, che risvegliano in lui la bellicosità che troviamo negli antichi tedeschi, i quali non combattono né per distruggere né per vincere, ma semplicemente per combattere. Il cristianesimo – e questo è il suo merito piú bello – ha addolcito un poco la brutale bellicosità germanica; tuttavia non ha potuto distruggerla, e, quando una volta il talismano lenitore, la croce, si rompe, allora si scatena nuovamente la ferocia degli antichi guerrieri, la folle furia bellicosa, della quale i poeti nordici cantano e dicono tante cose. Quel talismano è tarlato e verrà il giorno in cui andrà miseramente in frantumi”. (Sulla storia della religione e della filosofia in Germania, libro III)
EDUARD BERNSTEIN

“Chi oggi applica la teoria materialistica della storia ha l’obbligo di applicarla nella sua forma piú sviluppata e non in quella primitiva; ha l’obbligo, cioè, di tener pienamente conto, oltre che dello sviluppo e dell’influsso delle forze produttive e dei rapporti di produzione, anche delle concezioni morali e giuridiche, delle tradizioni storiche e religiose di ciascuna epoca, degli influssi dei fattori geografici e di tutti gli altri fattori naturali, di cui del resto fa parte anche la natura dell’uomo stesso e delle sue attitudini spirituali. E ciò va tenuto presente in particolar modo quando non si tratta piú semplicemente di esplorare le epoche storiche passate, ma di progettare gli sviluppi futuri, quando cioè la concezione materialistica della storia deve servire come strumento di orientamento per il futuro”.
Eduard Bernstein (6/1/ 1850 – 18/12/1932) fu uno dei massimi esponenti del socialismo della Seconda Internazionale. Fin dal 1872, egli è iscritto al Partito Socialdemocratico: collabora direttamente con Marx ed Engels (il quale lo sceglierà come esecutore testamentario) ed è diverse volte deputato al Reichstag. Tra il 1896 e il 1903, egli è al centro del dibattito marxista per via della sua ardita proposta di revisione radicale del marxismo in direzione riformistica e anticlassista. Nel 1896, Bernstein pubblica sulla rivista Die neue Zeit una ricca serie di articoli sui Problemi del socialismo: nel 1899, egli raccoglie questi articoli in un saggio a cui dà il titolo di I presupposti del socialismo e i compiti della socialdemocrazia. Tutti questi scritti, al di là delle tante differenze che li caratterizzano, hanno come comun denominatore l’esame critico del concetto marxiano di rivoluzione: la tesi bernsteiniana è che la nozione marxiana di rivoluzione sarebbe del tutto infondata sul piano filosofico, economico e sociologico. Crolla in questo modo la dicotomia, interna alla Socialdemocrazia tedesca, tra l’enunciazione di una teoria rivoluzionaria e la pratica di marca riformistica. Quello che, secondo le sue stesse parole, Bernstein si propone di fare non è un revisionismo antimarxista, ma piuttosto un revisionismo nel marxismo, che ne corregga le storture: tali storture, del resto, erano – nota Bernstein – già stati ampiamente condannati da Marx ed Engels, nemici di tutti “gli edifici utopistici costruiti in base a princìpi astratti” e di tutte le teorie sganciate dalla prassi. Per questa ragione, Bernstein deride quei marxisti che dei principi del marxismo fanno una specie di “rivelazione divina”, tale da rimanere immutata per sempre. Viceversa, come avevano insegnato Marx ed Engels, il marxismo è il prodotto della pratica concreta del movimento operaio e, in quanto tale, è soggetto ai sempre nuovi mutamenti richiesti dal mutare della situazione storica. Se letto in trasparenza, il revisionismo di Bernstein tende a liquidare il marxismo più che a revisionarlo: infatti ne mette in discussione i principi cardinali come la lotta di classe, l’idea di rivoluzione, il materialismo storico. Si trattava di una vera e propria eresia all’interno del marxismo, come rilevarono i più autorevoli esponenti della Seconda Internazionale, da Kautsky a Plechanov, dalla Luxemburg a Lenin. Il vero punto di partenza della riflessione di Bernstein è il rifiuto del carattere scientifico del socialismo, inteso più come un’esigenza morale che come una teoria scientifica della società. È sì vero che la teoria marxiana del valore e quella della produzione sono il frutto di un’accurata analisi scientifica della società: ma ciò non di meno il socialismo è innanzitutto un ideale etico, è l’espressione di quel che gli uomini desiderano (giustizia, eguaglianza, fine dello sfruttamento, ecc) e che ancora manca. È proprio in questa enfatizzazione del momento etico che Bernstein può recuperare alcuni elementi del pensiero di Kant, che si stava allora diffondendo presso la Socialdemocrazia tedesca: la volontà morale, infatti, gioca un ruolo decisivo nel determinare i fini del socialismo e, di conseguenza, nega che esso sia il prodotto di un processo necessario e scientificamente prevedibile. Bernstein arriva addirittura ad accostare il socialismo alle idee della Critica della ragion pura kantiana: al pari di esse, che non hanno contenuto, anche il socialismo è un ideale da raggiungere ma che di fatto non sarà mai raggiunto; bisogna sforzarsi il più possibile di tendere ad esso, alla luce del fatto che “l’obiettivo è niente, il movimento è tutto”. Ecco perché Bernstein rivelò tanta avversione verso la dialettica hegeliana, arrivando a sostenere che “quel che Marx ed Engels hanno prodotto di grande, l’hanno prodotto non grazie alla dialettica hegeliana, ma malgrado essa”. Altrettanto avverso egli fu nei confronti dell’evoluzionismo deterministico propugnato da Kautsky: il socialismo è una possibilità dipendente dalla volontà umana e alimentata dal cuore delle masse operaie, con la conseguenza che sbaglia Kautsky a credere che esso sia l’esito necessario della crisi finale del capitalismo. La più recente storia del capitalismo, secondo Bernstein, ha del resto dimostrato la falsità di molte proposizioni marxiste: ad esempio, la progressiva concentrazione delle imprese industriali non ha portato a una conseguente concentrazione del capitale, ma anzi è aumentato il numero dei possidenti grazie al diffondersi delle società per azioni. La stessa previsione marxiana della scomparsa dei ceti medi si è dimostrata falsa: essi, anziché estinguersi, oggi proliferano più che mai; le stesse medie imprese crescono di numero ogni giorno che passa. Da queste considerazioni, Bernstein trae la conseguenza che si debba buttare a mare l’idea marxista della graduale polarizzazione della società in due classi antagoniste (possessori e proletari), destinate a una guerra sociale culminante nella rivoluzione. Ciò anche alla luce del fatto che si è rivelata falsa anche la previsione marxiana di un crescente impoverimento della classe operaia, anch’esso inteso come origine dell’acuirsi degli scontri di classe. Ma la previsione di Marx che più si è rivelata falsa è quella del crollo del capitalismo: lo svilupparsi dei trust, dei monopoli e delle alleanze tra le imprese permette oggi al capitalismo, se non di azzerarne la crisi, almeno di ridurne la portata. Per tutte queste ragioni, Bernstein difende il rifiuto delle concezioni rivoluzionarie del socialismo, in nome di un graduale riformismo attraverso il quale la società capitalistica potrà consentire lo sviluppo al proprio interno del socialismo. Per questa via, la maturazione di rapporti socialisti di produzione avverrebbe lentamente e senza salti, in un lungo periodo di sviluppo, analogamente a come i rapporti capitalistici di produzione si sono formati gradualmente a partire dalla società feudale. In questa prospettiva, lo Stato deve controllare l’economia garantendone una funzione via via sempre più sociale. In opposizione all’autoisolamento della Socialdemocrazia propugnato dalle frange estremiste, Bernstein propone la collaborazione con i settori progressisti della borghesia e prospetta addirittura l’idea di una trasformazione della Socialdemocrazia in un raggruppamento democratico: queste proposte si inquadrano del resto perfettamente nella convinzione bernsteiniana secondo cui il socialismo sarebbe l’erede legittimo del liberalismo borghese, a tal punto che “non esiste idea liberale che non appartenga anche al patrimonio ideale del socialismo”. A queste tesi rispose Kautsky con uno scritto significativamente intitolato Bernstein e il programma socialdemocratico. Un’autocritica (1899): sostenendo la teoria del socialismo come esito necessario della crisi capitalistica, Kautsky rigetta tutte le proposte di Bernstein, mostrandone l’infondatezza. È vero che il ceto medio e le piccole imprese non sono scomparse, ma – nota Kautsky – è anche vero che su di esse è sempre maggiore il controllo esercitato dal grande capitale, il quale impedisce ai ceti medi un’autonoma espressione politica. La tesi dell’impoverimento assoluto del proletariato è secondo Kautsky un’assurdità inventata da Bernstein e sconosciuta a Marx, il quale s’è limitato a parlare di impoverimento relativo alla crescente ricchezza capitalistica. Le tesi di Bernstein saranno condannate nel 1903 nel Congresso di Dresda, ma ciò non impedirà la loro diffusione.
KARL KAUTSKY

“La società capitalistica ha chiuso bottega; la sua dissoluzione è ormai solo questione di tempo; l’inarrestabile sviluppo economico porta alla bancarotta del modo di produzione capitalistico con necessità di legge naturale. La creazione di una nuova forma di società al posto di quella attuale non è piú solo qualcosa di desiderabile ma è diventata inevitabile. E sempre piú numerose e piú potenti diventano le schiere dei lavoratori nullatenenti, per i quali il modo di produzione odierno è diventato insopportabile, che non hanno nulla da perdere dal suo crollo ma tutto da guadagnare, che devono introdurre una nuova forma di società corrispondente ai loro interessi se non vogliono soccombere del tutto – e con loro però anche l’intera società di cui formano la componente piú importante ” (Il programma di Erfurt).
Karl Kautsky è il principale esponente del pensiero marxiano negli anni della Seconda Internazionale. Grazie ai suoi numerosi scritti e alla sua rivista Die neue Zeit, la sua influenza sul pensiero socialista europeo è stata a tal punto decisiva che egli è stato ribattezzato “il papa rosso”. Della sua opera si è però ben presto creata un’immagine non del tutto vera, come di un interprete dogmatico del pensiero di Marx e di Engels, responsabile di una sua cristallizzazione entro una rigida precettistica non suscettibile ad alcun movimento. A questo proposito, è significativo il fatto che egli fu anche rinominato come “defensor fidei”. Kautsky si ribellò in ogni modo a questa poco gratificante immagine di mero difensore dell’ortodossia marxista nella sua intatta originarietà.
Kautsky nasce a Praga nel 1854: nel 1871, si iscrive all’Università di Vienna e abbraccia gli ideali del socialismo, anche sull’onda degli accadimenti politici (il ’71 è l’anno della Comune di Parigi). A farlo approdare sui lidi del marxismo è la lettura del Capitale di Marx e dell’Anti-Dühring di Engels. Nella particolare interpretazione che egli darà del marxismo giocherà un ruolo fondamentale il fascino subito dalle idee del darwinismo, che Kautsky aveva conosciuto soprattutto attraverso la figura di Ernst Haeckel. In questa prospettiva, negli anni Ottanta, egli va elaborando una concezione marxista in cui rientrano molti elementi darwiniani e al cui cuore stanno due tesi: in primo luogo, Kautsky enfatizza il carattere oggettivo e deterministico delle leggi dei mutamenti sociali, considerando la fine del capitalismo e l’avvento della società marxista come l’esito inevitabile della storia; in secondo luogo, egli intende il passaggio dal capitalismo al comunismo non come il frutto di una rivoluzione a mano armata e incentrata sulla violenza, ma piuttosto come il naturale esito di un’evoluzione graduale e necessaria. Sicché, per via della prima tesi, il marxismo di Kautsky è inconciliabile con la prospettiva revisionista invalsa con Eduard Bernstein; ma per via della seconda tesi, il marxismo kautskyano è inconciliabile con le posizioni della Sinistra rivoluzionaria (Lenin, Luxemburg). In virtù di questa medianità tra il revisionismo e la Sinistra rivoluzionaria, il marxismo di Kautsky si colloca in una posizione centrista. Ad essa, il pensatore di Praga perviene attraverso un’ardua operazione teoretica: la sostituzione dell’interpretazione dialettica di marca hegeliana (proposta da Marx e da Engels come chiave di lettura del movimento storico/sociale) con una lettura del socialismo in chiave di evoluzionismo sociale, sulla scia delle posizioni positivistiche all’epoca imperanti. Crollano in questo modo la forte soggettività riconosciuta (soprattutto da Marx) alla classe operaia quale agente della storia e il riconoscimento della rottura del processo rivoluzionario: l’accento è invece posto sull’oggettività e sulla gradualità dei processi. Per questa ragione, Kautsky si rivelò sempre avverso ad ogni sorta di spontaneismo volontaristico: da quello del sindacalismo rivoluzionario a quello della Luxemburg, fino a quello di Lenin. Secondo Kautsky, infatti, il crollo del capitalismo qualcosa di necessario e oggettivo: nell’attesa che esso si verifichi, il movimento operaio non ha altro da fare se non “organizzarsi e attendere”. Il momento della rivoluzione, che non dipende affatto per Kautsky dalla lotta operaia ma solo ed esclusivamente dal corso della storia, è dunque rinviato ad un futuro non meglio identificato: non occorre adoperarsi per far avvenire ciò che avverrà necessariamente, cosicché “poiché la rivoluzione non può essere fatta a nostro arbitrio, non possiamo dire assolutamente nulla circa il tempo,le condizioni e le forme in cui essa avverrà” (Catechismo rivoluzionario, 1893). In questa prospettiva, il solo compito che spetta al partito è di alimentare il “finalismo rivoluzionario”, che mai potrebbe sorgere dalla spontaneità della coscienza proletaria. Infatti gli operai,pur subendo quotidianamente lo sfruttamento e l’oppressione, da soli non saranno mai in grado di innalzarsi ad una visione complessiva dello sviluppo sociale e dunque non potrebbero mai agire in vista dell’attuazione del socialismo. A questa visione complessiva giungono invece gli intellettuali. Il compito del partito sarà appunto quello di sintetizzare queste due componenti: il proletariato sfruttato e l’intellettuale che spiega scientificamente le origini di tale sfruttamento e che così pone le basi per superarlo. In rottura col revisionismo di Bernstein, Kautsky nega che l’emancipazione operaia possa essere ridotta al solo orizzonte di una serie di graduali riforme migliorative del sistema sociale vigente: alla Socialdemocrazia spetta il compito di guida della rivoluzione sociale che abolisce la proprietà privata dei mezzi di produzione. Ciò non comporta però indifferenza verso le lotte sociali per le riforme condotte dal proletariato: con esse, la classe operaia matura la propria coscienza di classe, sviluppa l’organizzazione e la solidarietà, migliora (in caso di successo) le proprie condizioni, si prepara psicologicamente all’avvento della futura rivoluzione. La guida del partito, del resto, svolge il fondamentale compito di impedire l’integrazione del proletariato nella società capitalistica: le riforme, affinché non si convertano pericolosamente in un’integrazione e in uno scendere a patti con la borghesia, devono secondo Kautsky assumere la forma di un’imposizione al capitalismo da parte degli operai, i quali devono rivelarsi intransigenti e non disposti a ogni possibile intesa con le altre forze politiche. È a questo punto che si pone il problema capitale del pensiero di Kautsky e che segna il suo distanziamento da Marx: quali rapporti deve intrattenere il proletariato con la borghesia? Secondo Kautsky, la futura rivoluzione sarà determinata, oltre che dal radicalizzarsi dei conflitti di classe, dall’incapacità di sopravvivere del capitalismo, che col prevalere del capitale finanziario e dei monopoli assume un atteggiamento sempre più aggressivo e autoritario, a tal punto da non poter più nemmeno accettare la conciliazione dei propri interessi col sistema democratico. Secondo Kautsky, dunque, la democrazia è destinata ad essere sempre più intessuta di valori proletari e ad essere sempre più rigettata dal capitalismo: sulla scia di queste riflessioni, il filosofo di Praga può arrivare a teorizzare la via parlamentare al socialismo. Sicché egli sostituisce, all’idea marxiana (espressa nella Critica del programma di Gotha) della dittatura del proletariato (idea recuperata ed enfatizzata dallo stesso Lenin), l’idea della conquista del proletariato, attraverso la competizione elettorale, della maggioranza parlamentare; grazie ad essa, gli operai potranno utilizzare la discussione democratica in direzione di una trasformazione socialista della società. Già nel 1892 Kautsky aveva rifiutato senza mezzi termini la contrapposizione (teorizzata da Marx) tra democrazia diretta e sistema rappresentativo dello stato moderno. Contro la tesi della distruzione dello Stato parlamentare moderno in vista della fondazione di uno Stato interamente nuovo del proletariato, Kautsky sostiene che il sistema rappresentativo parlamentare è l’esito necessario dell’evoluzione istituzionale moderna: a questo suo convincimento, egli rimarrà sempre fedele, facendone uno dei cardini della sua polemica antibolscevica. Civettando con la prefazione engelsiana alle Lotte di classe in Francia di Marx, Kautsky si era convinto che la via alla rivoluzione sarebbe stata pacifica e non violenta, contrassegnata da grandi lotte sociali e politiche di massa, seguite dall’azione parlamentare del partito. L’unica forma di violenza possibile era quella difensiva e dipendeva dalla resistenza opposta dalla classe dominante. L’esplosione, nel 1905, della rivolta in Russia e l’organizzazione di scioperi di massa in diversi Stati dell’Occidente sembrava tuttavia far tornare all’ordine del giorno il ricorso alla violenza, che nella sua prefazione prima citata Engels aveva ritenuto ormai sorpassate ed obsolete: a tal punto che Kautsky modificò la propria concezione, immaginando un possibile scontro armato tra il proletariato e lo Stato capitalistico. Ma si trattava solo di un momento della riflessione kautskyana che sarebbe presto stato abbandonato: Kautsky, infatti, tornò presto a sostenere il carattere non violento del processo rivoluzionario, come è attestato dalla dura polemica che egli condusse contro la Luxemburg. Costei sosteneva la possibilità di una rivoluzione violenta come quella russa del 1905 anche in Germania: essa sarebbe a suo avviso culminata nello sciopero di massa e nel crollo violento del capitalismo. A questa tesi, Kautsky risponde opponendo una paziente “strategia di logoramento” del potere capitalistico: tale strategia deve essere condotta tramite l’azione parlamentare, le rivendicazioni salariali e le pacifiche dimostrazioni per le strade. In quello stesso periodo, Kautsky esamina il fenomeno dell’imperialismo nei suoi rapporti con lo sviluppo monopolistico del capitalismo: se per Lenin l’imperialismo era intrinseco alla natura stessa del capitalismo, Kautsky ritiene invece che esso sia espressione di una sola componente del capitalismo: il grande capitale finanziario. Quest’ultimo, per il suo carattere di violenza e di aggressività, è contrapposto ad una buona parte del capitalismo industriale, che preferirebbe una pacifica convivenza, rapporti internazionali amichevoli, un placido sviluppo dell’economia. Da questa tesi deriva la conseguenza che bisogna assolutamente adoperarsi per una politica di disarmo: è questo il grande compito che deve assumersi la Socialdemocrazia con le sue battaglie pacifiste. L’esplodere della guerra e il fallimento dell’Internazionale socialista avrebbero però smentito le previsioni di Kautsky: per questo motivo, egli ne sarebbe uscito, per iscriversi nel 1917 al Partito socialdemocratico indipendente. Dal dopoguerra fino alla morte (1938), egli non fa altro che polemizzare senza sosta contro la Rivoluzione bolscevica e contro l’opera di Lenin, per il quale aveva in realtà mostrato all’inizio una certa simpatia. Nello scritto su La dittatura del proletariato (1918) e Terrorismo e comunismo (1919), Kautsky conferma ancora una volta la propria idea del nesso inscindibile tra democrazia parlamentare basata sul suffragio universale e socialismo. Nel 1922, Kautsky rientrò nel Partito socialdemocratico tedesco. Egli ravvisa nello scioglimento dell’assemblea costituente imposto dai Bolscevichi all’inizio del 1918 l’avvio della rivoluzione leninista verso esiti autoritari e antidemocratici, che ben presto l’avrebbero capovolta in un regime dispotico basato sull’annientamento terroristico degli avversari e sulla dittatura: una dittatura non del proletariato, ma sul proletariato da parte di una minoranza costituita da una nuova classe di funzionari destinata a creare una nuova forma di cesarismo. A queste tesi, Lenin e Trockij risposero additando Kautsky come un traditore: in realtà, il suo antibolscevismo era motivato dal suo stesso pensiero, per cui la dittatura del proletariato dovrebbe coincidere con la conquista della maggioranza in parlamento e nella società da parte degli operai. Ciò non di meno, negli anni Venti e Trenta Kautsky ha dato una svolta moderata al proprio pensiero, abbandonando l’idea della coincidenza di democrazia e socialismo e preferendole quella di una prima fase di lotta per la repubblica democratica e di una successiva fase di lotta per il socialismo. In questa prima fase, nota Kautsky, è ammissibile una forma di collaborazione con la borghesia e la formazione di un governo di coalizione. Di fronte al trionfo del totalitarismo anche in Germania, sostenne che il ripristino della democrazia (e non l’immediata realizzazione del socialismo) era l’obiettivo della lotta antifascista. Nell’ultimo periodo della sua vita, egli rigetta importanti nuclei teorici di Marx, liquidandoli come meramente utopistici e incompatibili con una prospettiva squisitamente scientifica. Nel secondo volume della sua immensa opera (La concezione materialistica della storia), egli addirittura ripudia l’idea dell’estinzione dello Stato: il superamento della divisione della società in classe non farebbe infatti cadere la divisione del lavoro e la necessità di un’organizzazione amministrativa avente al proprio cuore lo Stato. Rigettata anche la tesi marxista del crollo del capitalismo, Kautsky attribuisce allo Stato democratico moderno, nato con la Rivoluzione Francese, funzioni di intervento anche nell’organizzazione democratica, all’interno della nuova società, della produzione e della distribuzione dei beni. Molto importante fu anche la sua polemica con Bernstein, a cui Kautsky indirizzò uno scritto significativamente intitolato Bernstein e il programma socialdemocratico. Un’autocritica (1899): sostenendo la teoria del socialismo come esito necessario della crisi capitalistica, Kautsky rigetta tutte le proposte di Bernstein, mostrandone l’infondatezza. È vero che il ceto medio e le piccole imprese non sono scomparse, ma – nota Kautsky – è anche vero che su di esse è sempre maggiore il controllo esercitato dal grande capitale, il quale impedisce ai ceti medi un’autonoma espressione politica. La tesi dell’impoverimento assoluto del proletariato è secondo Kautsky un’assurdità inventata da Bernstein e sconosciuta a Marx, il quale s’è limitato a parlare di impoverimento relativo alla crescente ricchezza capitalistica.
DONOSO CORTES

A cura di Maurizio Schoepflin e Diego Fusaro
“Se nell’ordine fissato inizialmente da Dio risiede ogni bellezza, e se la bellezza, la giustizia e la bontà sono una stessa cosa considerata da diversi punti di vista, ne consegue che al di fuori dell’ordine stabilito da Dio non esiste bontà, né bellezza, né giustizia: e poiché queste tre cose costituiscono il bene supremo, l’ordine che tulle le contiene è il bene supremo. Dato che non esiste alcuna specie di bene al di fuori dell’ordine, ciò che esiste al di fuori dell’ordine non può essere che male, né esiste alcuna specie di male che non consista nel porsi al di fuori dell’ordine; per questo motivo, come l’ordine è il bene supremo, così il disordine è il male per eccellenza” (“Saggio sul cattolicesimo, li liberalismo e il socialismo”).
Lo spagnolo Juan Donoso Cortés (1809-1853) fu uno dei più aspri critici della modernità e, in particolare, dei sui riflessi nell’ambito della teoria e della prassi politiche. La sua critica finisce per travolgere la democrazia in quanto tale. In realtà, egli, al tempo degli studi universitari a Salarnanca e a Siviglia, aveva maturato idee di stampo liberale e progressista, leggendo le opere di Locke, Condillac; Rousseau e Voltaire. Tuttavia, in breve tempo, il suo liberalismo si attenuò, finché negli anni 1847-48, in concomitanza con vicende strettamente personali (la coerente testimonianza di un amico cattolico e la morte di un fratello) ed esperienze politiche (le rivoluzioni divampate in tutta Europa, di cui egli poté valutare di persona gli effetti in qualità di ministro plenipotenziario della Spagna a Berlino), si convinse dell’erroneità delle dottrine moderne e dell’unica e piena verità del cattolicesimo. Da quel momento, Cortés dedicò tutte le sue energie a denunciare gli errori del pensiero moderno e ad affermare l’insostituibile ruolo del cattolicesimo al fine di preservare l’Europa dal Caos e dalla tirannide. La testimonianza più completa delle sue concezioni, improntate a un rigido tradizionalismo cattolico, è la Lettera da lui inviata nel 1852 al cardinal Fornari, che gli aveva chiesto un giudizio sui principali errori filosofici e teologici dell’epoca: tale scritto (che verrà significativamente utilizzato da Pio IX al momento della redazione del Sillabo), si presenta come un testo logicamente rigoroso e assai penetrante, con cui l’autore denuncia i gravi limiti dell’ideologia liberale e di quella socialcomunista che si stavano sempre più affermando in Europa. Donoso Cortés fu un uomo di successo, deputato, oratore forbito, consigliere di re e regine, diplomatico, filosofo, le sue opere si diffusero rapidamente e interessarono uomini del calibro di Ranke e Schelling. Tutto ciò non lo distolse dall’impegno di vivere profondamente la fede cristiana, mediante la preghiera, l’ascesi e la carità, finché la morte lo colse appena quarantaquattrenne a Parigi il 3 maggio del 1853. Donoso Cortés appare dominato da un’unica ansia, quella dì rendere testimonianza alla verità senza cedimenti e accomodamenti, e ciò, più volte, lo spinge a sposare posizioni estreme; ma sicuramente non gli mancano le capacità di analisi e di comprensione della realtà, che lo fanno apparire quasi un profeta in grado di prevedere gli sviluppi della storia e della cultura europee incamminate sulla strada dell’ateismo e della secolarizzazione. Seguace di Sant’Agostino, Donoso giudica pessimisticamente la natura umana e critica con durezza l’ottimismo razionalistico che crede nella bontà innata dell’uomo, nella rettitudine degli istinti, nella positiva autosufficienza della ragione, nel progresso illimitato. Scrive il pensatore spagnolo: “Il razionalismo è la contraddizione che riunisce nella sua unità suprema tutte le altre contraddizioni. Infatti, il razionalismo è, al tempo stesso, deismo, panteismo, umanismo, manicheismo, fatalismo, scetticismo, ateismo”. Al centro delle riflessioni donosiane sta il concetto di “ordine divino”, considerato il fondamento sia del creato che della Storia; la natura e l’umanità sono sorrette a un complesso di leggi che le governano e il cui sovvertimento è causa dei mali che affliggono il mondo: secondo Donoso, l’erroneità delle ideologie liberali, socialiste e comuniste deriva proprio dal tatto che esse non riconoscono e non rispettano tale ordine, che invece il cattolicesimo accetta e incrementa, affermandosi così come l’unica dottrina autenticamente valida e apportatrice di salvezza. Donoso sottolinea il grande valore della libertà umana, che raggiunge la pienezza quando si conforma ai comandi divini mentre si perverte nel momento in cui compie il male: il peccato originale, che per primo alterò l’ordine voluto da Dio, continua a condizionare negativamente i singoli uomini e la storia nella sua interezza; coloro che non si rendono conto di tale drammatica evidenza e che negano la terribile forza del peccato non sono in grado di capire né l’uomo né le vicende storiche che, agli occhi del pensatore spagnolo, sono caratterizzate da un titanico scontro tra bene e male. Figlie del peccato sono le rivoluzioni, che infrangono l’ordine politico, come il peccato infrange l’ordine etico; figlio del bene è l’ordine, che dunque deve essere restaurato perché ciò è nei piani stessi di Dio. Scrive il pensatore spagnolo:
“Quest’ordine consiste nella superiorità gerarchica della fede sulla ragione, della grazia sul libero arbitrio, della Provvidenza divina sulla libertà umana, della Chiesa sullo Stato; e, per dirla tutta in una sola volta, nella supremazia di Dio sull’uomo… Solamente nella restaurazione di codesti eterni principi nell’ambito religioso e dell’ordine politico e sociale dipende la salvezza delle società umane… Questi principi non possono essere riattivati se non da chi li conosce, e nessuno li conosce se non la Chiesa cattolica”.
Muovendosi in questo contesto, Donoso difende a spada tratta l’istituto familiare, la struttura gerarchica della società, il potere e l’autorità che lo esercita, e cerca sempre le profonde motivazioni teologiche che sorreggono queste sue certezze politiche, convinto com’è che gli errori dei moderni derivino dal misconoscimento delle basilari verità religiose predicate dal cattolicesimo. Non immune da esagerazioni e viziato da un eccesso di radicalismo, il pensiero reazionario di Donoso Cortés sembra forse trovare qualche giustificazione nella situazione storica in cui si colloca, ovvero quella di un’Europa che si sta scristianizzando e che viene travolta dalle rivoluzioni. Assai importanti sono poi le riflessioni politiche di Cortés, che attacca con incredibile durezza la democrazia: essa è la “clasa discutadora”, ossia la “classe che discute” e che, nel suo discutere, finisce per non decidere mai nulla, restando intrappolata nelle sue stesse infinite discussioni. Simili critiche anticipano quelle che alla democrazia muoverà, nel Novecento, Schmitt, allorché la etichetterà come “discussione che non mette in discussione se stessa”. Tanto Cortés quanto Schmitt, come antidoto alla democrazia e ai mali che da essa germinano, propongono un “decisionismo” in forza del quale sulla discussione prevalgano la decisione e l’agire.
LAMENNAIS

A cura di Alberto Manicone
“Un’immensa libertà è indispensabile per il progresso delle verità che servono per la salvezza del mondo”.
Hugues-Felicitè Robert de Lamennais (1782 1854) fu un importante pensatore cattolico, oltreché leader della restaurazione Francese. Fu il primo sostenitore del cattolicesimo liberale e fautore del cattolicesimo sociale. La sua difesa di una conciliazione tra cattolicesimo e liberalismo lo portò a una rottura con la Chiesa. Lamennais, figlio di un mercante benestante, nacque nel giugno 1782 a Saint malo in Bretagna. Personalità lunatica e solitaria, seguì il fratello nel sacerdozio nel 1816. Lamennais trovò nella religione un rimedio per l’anarchia e la tirannia causata dalla rivoluzione. Credeva che il caos sociale e la religione fossero entrambi radicati nel primato della ragione individuale e che la Chiesa ed il papato potessero riportare unità e ordine sociale. Nei primi anni venti dell’Ottocento, egli spezzò i legami con la monarchia della restaurazione e si dedicò alla promozione dell’indipendenza della Chiesa. Per Lamennais la promozione di valori quali la libertà generale divenne una necessità pratica. Con la libertà di diffusione del suo messaggio, Lamennais credeva che la Chiesa potesse diventare vittoriosa. Dal 1827 la prospettiva di Lamennais in materia di rivoluzione cambiò. Anche se ancora interessato all’anarchia, riesce a vedere positivamente l’intenzione fondamentale della rivoluzione. Iniziò a promuovere una nuova forma di ordine sociale basata sull’alleanza tra Chiesa e rivoluzione. Lamennais entusiasticamente abbracciò la rivoluzione di Luglio in Francia, ma rapidamente sentì la sua inadeguatezza e divenne un convinto repubblicano e democratico. Di conseguenza, appoggiò la rivoluzione in Belgio, dove le sue idee avevano guadagnato popolarità e dove una alleanza tra cattolici e liberali venne realmente effettuata, ed in Polonia. Il 16 ottobre 1830 con Lacordaire, Comte, e Charles de Montalembert ed altri fondò il giornale “L’avenir” per promuovere religione e libertà. Durante i 13 mesi dell’esistenza de “L’avenir”, le teorie di Lamennais si fecero più radicali. Chiese ai cattolici di condurre il movimento in nome della democrazia politica e giustizia economica. La gerarchia francese, il governo francese e l’Austria facevano pressione sul papato affinché condannasse il giornale. Papa Gregorio XVI, sebbene reazionario, avrebbe preferito non farne una questione ufficiale, ma la questione venne forzata dallo stesso Lamennais, che sospese il giornale domandando al papa stesso un verdetto sulla sua ortodossia. Lamennais comunque, non credendo più nella competenza del papa in materia politica, rifiutò di cambiare la sua posizione anche dopo che il papa condannò le idee de “L’avenir” nell’enciclica “Mirari Vos” del 1832. Fu molto difficile per Lamennais rompere formalmente con la Chiesa: alla fine del 1833, ammalato, firmò una sottomissione all’autorità papale ma si pentì velocemente di questa concessione alla tirannia vista come traditrice della sua adorata gente. Anche se scrisse “Paroles d’un Croyant” nel 1833 non le pubblicò sino all’aprile del 1834. Lamennais non difendeva la rivoluzione, ma tuttavia il libro fu una chiamata rivoluzionaria contro la dominazione di uomini contro altri uomini. Lamennais ignorò una esplicita condanna del papa e dal 1836 rinunciò completamente al cattolicesimo. Continuò a scrivere fino alla sua morte, nel 1854, ma dopo la sua rottura con la Chiesa ebbe poco impatto. Promosse una nuova comunità social-democratica, radicata in una cristianità purificata. Nel 1841 venne incarcerato per un anno a causa dei suoi clamorosi attacchi verso le politiche della Monarchia di Luglio in un pamphlet: “Le pays et la gouvernement”. Uscì di prigione non pentito. Similmente rifiutò l’invito di alcuni liberali cattolici di riunirsi alla Chiesa dopo l’elezione dell’apparentemente liberale papa Pio IX. La rivoluzione del 1848 portò a Lamennais il suo ultimo ruolo pubblico. La sua nuova testata, “Le Peuple constituant”, venne pubblicato dal 27 febbraio all’11 luglio. Vinse il trentaquattresimo ed ultimo posto nell’assemblea costituente di Parigi. Nell’assemblea Lamennais scelse di sedere all’estrema sinistra. A causa della sua reputazione, venne scelto per partecipare al comitato per l’elaborazione della nuova costituzione. Lamennais sostenne il suffragio universale, l’educazione libera ed universale, e la tassazione in rapporto all’estrazione sociale. Lottò per la fine del monopolio accademico e della separazione tra Stato e Chiesa. Si oppose fermamente al governo centralizzato e domandò maggiori libertà locali. Rimase deluso dalla rivoluzione. Non fu mai un grande oratore ed ebbe poca influenza sul comitato costituzionale dimettendosi da essa dopo appena due incontri. Anche se non difese mai la violenza, simpatizzò con le condizioni dei poveri e si oppose duramente alla repressione brutale del loro sollevamento di giugno; denunciò la legge sulla stampa di Cavaignac. La sua ultima edizione stampata l’11 luglio portò la denuncia di Lamennais a caratteri cubitali: “Le Peuple, iniziato con la repubblica ora, come essa, arriva al termine”; poi continuava: “È necessario oggi avere molto denaro per godere del diritto di parola […] Silenzio ai poveri”. Un’azione legale venne intrapresa contro Lamennais ed in ottobre il giornale venne condannato e multato. Lamennais si unì alle rappresentazioni della sinistra che supportavano la candidatura presidenziale per Alexandre -Auguste Ledru-Rollin, e scrisse ben 43 articoli per il giornale “La Reforme” nel 1849 prima che il giornale cessasse di essere pubblicato nel gennaio 1850. Lamennais condannò poi il colpo di Luigi Napoleone. Morì a Parigi il 27 febbraio 1854: sul letto di morte rifiutò di vedere qualsiasi prete, ma i suoi resti vennero accompagnati da una folla di poveri quando, come secondo sua richiesta, venne sepolto in una fossa comune. Nel 1817 apparve il primo volume del “Saggio sull’indifferenza in materia di religione”: dall’inizio alla fine, il libro è percorso da un vigoroso attacco all’indifferenza che appare 1) in coloro che vedono la religione come una mera istituzione politica percependola solo come una necessità per le masse; 2)in coloro che ammettono la necessità di una religione per tutti gli uomini ma rifiutano la rivelazione; 3) in coloro che riconoscono la necessità di una religione rivelata ma pensano di poter rifiutare tutte le verità che essa insegna ad eccezione di alcuni punti fondamentali. Pur aperto a delle critiche verso lo sviluppo di questa idea, il “saggio” portò ai cristiani apologetici una nuova forza e allo stesso tempo attirò l’opinione pubblica. Oltre ad un atteggiamento difensivo verso l’incredulità, esso attacca audacemente i nemici con i mezzi della retorica, della dialettica, dell’invettiva, dell’ironia e dell’eloquenza. Dal pulpito di Notre dame a Parigi, Frayssinuous acclamò Lamennais come il più grande pensatore dopo Malebranche. Nel contempo, edizioni del saggio raggiunsero rapidamente la stampa. Quarantamila copie furono vendute in poche settimane e vennero tradotte in molte lingue ed in alcuni posti riuscì persino ad attuare conversioni al cattolicesimo. Lamennais è ora percepito come una delle più illustri personalità tra il clero francese: visitatori si adunavano vederlo, la stampa lo sollecitava per delle collaborazioni. Promise la sua collaborazione a “Le conservateur”, un giornale monarchico del partito dell’estrema destra, per il quale scrivevano Chateaubriandt e de Bonald. Lamennais comunque si interessava meno di politica che di religione e contribuì per “Le conservateur” solo in difesa di interessi cattolici. Per lui non era sufficiente discreditare la filosofia infedele: intendeva mettere qualcos’altro al suo posto. Credeva che il razionalismo cartesiano, il quale aveva recentemente attaccato le fondamenta della fede cristiana, potesse essere combattuto con un sistema che li ristabilisse entrambi. A questo soggetto dedicò il secondo volume del saggio pubblicato nel 1820. Il sistema filosofico presentato in questo volume era basato su una nuova teoria della certezza. A grandi linee, la sua teoria afferma che la certezza non può essere data da una ragione individuale. Appartiene solo alla ragione generale che è per l’universale beneplacito degli uomini il senso comune; esso deriva dalla testimonianza unanime della razza umana. La certezza però non è creata dall’evidenza ma dall’autorità degli uomini. Negli ultimi capitoli del libro, questo sistema filosofico supporta un intero nuovo metodo di apologetica. Esiste, dice Lamennais, una vera religione che è assolutamente necessaria alla salvezza e all’ordine sociale: solo un criterio ci consente di discernere la vera religione dalle false ed è l’autorità della testimonianza. Risultato di una rivelazione primitiva, l’unica vera religione – il cristianesimo – ha perfezionato se stessa nel corso dei secoli senza venir essenzialmente modificata; i cristiani ora credono in tutto ciò che la razza umana ha creduto e la razza umana ha sempre creduto in ciò che i cristiani credevano. L’ultimo volume del saggio (1823) fu dedicato a questa tesi. In questo, Lamennais cerca di provare, con l’aiuto della storia, che i dogmi della cristianità sono stati e sono tuttora, sotto vari aspetti, professati in tutto il mondo. Naturalmente quest’ultimo volume non riuscì ad assicuragli il successo riscosso col primo. Il sistema filosofico di Lamennais, come la sua apologetica, richiamò forti critiche. Era un dato di fatto che questa filosofia favoriva lo scetticismo rifiutando la validità della ragione individuale. Se questa non può fornire certezza, come potersi aspettare qualcosa da quella generale che è una sintesi della ragione individuale? Era anche una confusione dell’ordine del naturale e soprannaturale, di filosofia e teologia, un mettere sullo stesso piano l’autorità della testimonianza della razza umana e la fede religiosa. Queste ed altre critiche irritarono Lamennais senza convincerlo del suo errore: egli sottopose il suo libro a Roma e in risposta alle sue critiche scrisse “La difesa del saggio”, nel 1821. Lamennais stesso visitò presto Leone XII, che lo ricevette molto cortesemente e a un certo punto pensò persino di nominarlo cardinale, malgrado il suo carattere animoso e le sue idee eccessive. Al suo ritorno in Francia, Lamennais dimostrò il perché della grande determinazione nella lotta contro il gallicanesimo e altri liberalismi religiosi. Nell’occasione di un’ordinanza ministeriale che prescriveva l’insegnamento della famosa dichiarazione del 1682, pubblicò “Religione considerata nei rapporti con l’ordine civile e politico” (1825), opera in cui denunciò le tendenze gallicane e liberali come la parte malata della religione ed altrettanto fatale per la società. Irritati da questi attacchi, la maggioranza dei vescovi gallicani, firmarono una protesta contro questi pamphlet che li accusavano di appoggiare lo scisma. Lamennais venne anche citato in giudizio per aver attaccato il governo del re e i quattro articoli del 1682. Difeso da un amico, il grande avvocato Berryer, venne assolto con una multa di 30 franchi. Da questo incidente, manifestò una vivace ostilità verso i Borboni, e fu ancora più invettivo nel mantenere le sue idee contro Frayssinuos ed altri rappresentanti dei principi moderati gallicani. Ma dall’altro lato, fondò una società religiosa i cui doveri distintivi erano di difendere la Chiesa dallo studio della teologia ed altre scienze, dal propagasi di dottrine Romane, dall’insegnamento nei collegi e nei seminari, dall’indirizzare spiritualmente. La rivoluzione del 1830 mise comunque fine a questo progetto. La congregazione al tempo possedeva tre case ma sopravvisse solo per quattro anni. Obbligato a riconoscere il governo di Carlo X, dovette anche accettare la legge contro le congregazioni religiose che si accanì soprattutto contro i gesuiti. Lamennais, pur non nutrendo molta simpatia verso di loro, li difese in un libro pubblicato nel 1829 sotto il titolo “Progresso della rivoluzione e della guerra contro la Chiesa”. Le sue sferzanti invettive non risparmiarono nè il re né i vescovi, a cui rimproverò il loro gallicanesimo e le loro concessioni ai nemici della religione. Qui per la prima volta Lamennais rompe apertamente con la monarchia riponendo le sue più alte speranze nella libertà politica e nell’uguaglianza dei diritti. Scrisse: “un’immensa libertà è indispensabile per il progresso delle verità che servono per la salvezza del mondo”. Questo fu ciò che chiamò “cattolicizzazione del liberalismo”: il progetto riscontrò un enorme successo. I vescovi stessi protestarono quasi unanimemente contro l’azione del governo. Non approvarono comunque il linguaggio violento di Lamennais; e l’arcivescovo di Parigi, in una predica, condannò l’opera e questo portò a due lettere aperte di Lamennais nei confronti dell’arcivescovo di Parigi dove le sue idee venivano criticate senza riserve di sorta.
SOLGER

Karl Karl Wilhelm Ferdinand Solger (1780-1819), figura eminente della filosofia romantica tedesca e professore dal 1811 nell’Università di Berlino, ha consegnato il suo pensiero a un non grande numero di scritti, quasi tutti in forma dialogica (Erwin. Quattro dialoghi sul bello e sull’arte, 1815; Dialoghi filosofici, 1817; Dialoghi filosofici su essere, non essere e conoscere, postumi), ove il tema romantico dell’ironia, da categoria essenzialmente estetica, assurge a chiave di volta di tutta la filosofia e di una visione metafisica, ontologica e religiosa dell’intera realtà. Traduttore dell’intera opera di Sofocle, fu Solger a chiamare Hegel all’università di Berlino. Si tratta di un pensatore difficilmente catalogabile: è un romantico, ma allo stesso tempo va oltre il romanticismo; è un idealista, ma va anche oltre l’idealismo; è un teorico dell’estetica, ma va anche più in là dell’estetica. Con Solger, ci troviamo dinanzi ad un pensatore metafisico e religioso che utilizza l’estetica, facendo della riflessione sul bello uno strumento per afferrare la condizione del finito, del quale il bello sarebbe per l’appunto la manifestazione più pura. Dopo la morte di Solger (1819), in occasione della pubblicazione postuma dei suoi Dialoghi filosofici, Hegel ne fece una grandiosa recensione; in realtà egli s’era già occupato del suo pensiero nelle Lezioni di estetica, collocandolo come un momento dialettico che, nell’economia generale del sistema, doveva portare al pensiero hegeliano stesso. Pur vivendo nel cuore dell’idealismo classico tedesco, Solger non è pienamente ascrivibile a questa corrente di pensiero: la sua dialettica, infatti, si pone come alternativa a quella hegeliana, di cui peraltro (a causa della scomparsa prematura) non potè vedere lo spiegamento completo. In opposizione alla dialettica hegeliana, incentrata sul momento sintetico dell’Aufhebung, quella di Solger è duale, priva di sintesi e di conciliazione: è una dialettica che tenta di scorgere la salvezza del finito non nell’essere conciliato nell’Assoluto, ma nella contraddizione della sua finitezza. Ed è esattamente questo aspetto del pensiero solgeriano che Hegel non può dialettizzare (ancorché ci provi), proprio perché si tratta di un’alternativa al suo pensiero: ed è la mancata dialettizzazione ciò che Hegel più critica di Solger, rinfacciandogli di essersi smarrito nell’infecondità del finito. Un altro punto cardinale della riflessione solgeriana sta nell’aver tentato una comprensione filosofica dell’ironia: aspetto, questo, per cui fu apprezzato tanto da Hegel quanto da Kierkegaard. L’estetica solgeriana si pone come propedeutica alla metafisica, la quale è imperniata sulla nozione di creazione, sull’inconoscibilità dell’Assoluto in se stesso, e sulla salvezza del finito tramite il riconoscimento (e non il superamento hegeliano) della propria nullità. Un pensiero che, a tutta prima, può sembrare, se non affine, sicuramente non così distante da quello di Kierkegaard: eppure il filosofo danese, che pure aveva colto il cuore della riflessione solgeriana, lo rigettò in pieno, scorgendovi troppi aspetti in comune con l’aborrito Hegel. Questi riconosce a Solger il merito di aver colto l’identità tra fede cristiana e filosofia, ma lo accusa di non essere stato in grado di andare oltre: detto altrimenti, agli occhi di Hegel, Solger si è arrestato al momento negativo, senza approdare a quello sintetico. La dialettica duale di Solger poggia sulla “negazione” e sulla “negazione della negazione”, con l’idea che la realtà sia negazione dell’Assoluto (il che non implica tuttavia un tentativo di riconciliazione). Sicché, per Hegel, quella solgeriana è la sua stessa dialettica in forma non risolta: questo tentativo di riassorbimento nel “Sistema” indusse Kierkegaard a sostenere che Solger cadde “vittima” del sistema hegeliano, incapace di dialettizzarne il pensiero. Prova ne è che nelle sue Lezioni sulla storia della filosofia Hegel taccia il nome di Solger, alla luce del fatto che non sa dove e come collocarlo. Il punto di partenza della riflessione di Solger è l’autoimmolarsi dell’Assoluto come Assoluto al fine di far essere gli esseri finiti: il finito è allora soltanto in quanto “apparenza” (Erscheinung), la quale a sua volta è “il nulla di Dio”. E noi siamo appunto questo nulla: siamo apparenze nulle perché Dio prende esistenza in noi (facendoci essere) e si nasconde nel suo essere. Detto altrimenti, l’Assoluto ci fa essere come il suo essere nulla, come non essenti Lui: si tratta di una creazione (e non di un’emanazione in senso neoplatonico), che è insieme Rivelazione, sicché l’essere dell’Assoluto trapassa in finitezza. Si ha dunque una kènosis, uno svuotamento, ovvero un donarsi di Dio al finito negandosi nella propria infinitezza. È dialettica dell’apparire di Dio nella sensibilità, e trova una formulazione compiuta nei Dialoghi filosofici del 1817. La frattura che si apre tra finito e infinito è insanabile, perché senza quella frattura l’esistenza sensibile non sarebbe: si tratta allora di un esistere nella frattura tale per cui una pretesa conoscenza dell’Assoluto in se stesso sarebbe un “non-senso”, giacché “comporterebbe il nostro non esistere”. Infatti, la conoscenza dell’Assoluto implicherebbe, ipso facto, l’annientamento del finito. Quella che si ha tra uomo e Dio è dunque una dialettica della polarità e della scissione, una dialettica in forza della quale dicendo l’uno si nega l’altro. In nessuna pagina di Solger si nega che l’Assoluto sia in sé: semplicemente, si dice che nulla possiamo saperne, giacchè esula dalla dimensione del “per noi” (für uns). La mancata composizione speculativa tra finito e infinito è la chiave di volta dell’intera filosofia e dell’intera esistenza; ciò non condanna l’infinito all’insensatezza, giacché il suo essere nulla è e resta il nulla dell’Assoluto. Proprio in ciò risiede la più alta ironia: donando il proprio essere al finito, l’Assoluto gliene toglie anche la conoscenza. La prima conseguenza è che il finito resta tale, nella sua sproporzione ontologica di fronte ad un Assoluto trascendente che è in lui perché si è fatto lui. La seconda paradossale conseguenza è che il finito accede all’Assoluto proprio quando decide di restare finito: il che segnala la distanza siderale di Solger tanto dal platonismo quanto dall’idealismo hegeliano (tutt’al più Solger guarda con interesse al “secondo Fichte”). Accettando di restare finito, il finito torna all’Assoluto mediante non un superamento della finitezza, ma una sua accettazione, che è necessariamente ironica e che altro non è se non una ripetizione, da parte del finito, del sacrificio di Dio. Proprio perché il supremo bisogno avvertito dal finito è quello di superarsi – che, come s’è visto, è un bisogno che mai può essere soddisfatto –, accettando l’impossibilità di tale superamento il finito compie un sacrificio, un abbandono della violenza del concetto. Dio si cala nell’esistenza e, per l’esistenza, Egli è solamente in questo calarsi negativo: l’essere e il non-essere si incontrano senza mai comporsi e limitandosi a vicenda. Ponendosi come finito, l’Assoluto pone il proprio nulla, lasciando però trasparire la propria infinitezza: è il nulla, sì, ma il nulla dell’Assoluto. Siamo dinanzi a una dialettica ironica anche da parte di Dio: è infatti ironico il continuo porre uno scarto costante tra finito e infinito; ed è altresì ironico il fatto che il darsi di Dio sia al tempo stesso il suo nascondersi. Infine, è anche ironico il fatto che tale sproporzione ontologica tra finito e infinito, lungi dal dover essere colmata o superata, debba essere accettata. Ma si tratta invero di una dialettica che, oltre che ironica, è tragica: infatti, l’esistenza finita è negativa, è gettatezza nella frantumazione, è scandalo e paradosso, scacco e naufragio. E l’ironia riaffiora nella misura in cui la consolazione a tale tragicità dev’essere rinvenuta non al di fuori della tragedia, ma nella tragedia stessa. Se si coglie questo aspetto, si coglie anche come fede e sapere abbiano lo stesso contenuto. Nel mio nulla di essere finito, accetto Dio in me e, per ciò stesso, tramonto; il mio ritornare a Dio è accettazione della mia finitezza, rinuncia al mio essere autonomo. Dio tramonta affinché io sia, e dunque io devo tramontare affinché Egli sia e io sia salvato. È questa la massima ironia e, insieme, la vera mistica.
ADAM HEINRICH MÜLLER

Insieme a Ludwig von Haller, Adam Heinrich Müller (1779-1829) è uno dei principali esponenti del cosiddetto “romanticismo politico”: questa corrente filosofica poggia sulla convinzione (teorizzata da Novalis in Cristianità o Europa) che lo Stato, lungi dall’essere il frutto di un contratto sociale stipulato dagli individui, sia un organismo politico simile agli organismi viventi. In esso, le diverse componenti sono tra loro indisgiungibili e svolgono mansioni specifiche, determinate dalla loro collocazione rispetto alla totalità di cui fanno parte. La nozione di organismo aveva trovato una sua giustificazione filosofica soprattutto nella Critica del Giudizio di Kant, opera in cui il filosofo tedesco metteva in luce come la teoria della causalità su cui si fonda la scienza della natura sia del tutto inefficace a render conto della vita, anche nelle sue forme più basse (un filo d’erba o un verme). Negli esseri viventi, notava Kant, opera una causalità interna in virtù della quale sussiste una circolarità tale per cui ogni parte è funzionale all’insieme, proprio come le foglie di un albero sopravvivono fintantoché fanno parte dell’albero stesso. Ora, andando ben oltre le intenzioni di Kant, Novalis aveva sviluppato questo concetto, in Cristianità o Europa, da un punto di vista politico, notando come in una comunità i cittadini debbano identificarsi con la coppia reale (il re e la regina): e Novalis, nel sostenere ciò, guardava con simpatia al Medioevo, in cui gli individui, fusi sotto il potere imperiale e papale, formavano una totalità. Dal canto suo, Müller, soprattutto in Dottrina dell’opposizione (1804) recupera questa tesi e tende a spiegare la realtà in base ad una proto-dialettica tale per cui ogni realtà presenta un opposto (al soggetto si contrappone l’oggetto, al positivo il negativo, e così via). Così intesa, la realtà viene a configurarsi come una tensione tra opposti, in una polarità che rivela l’influenza della filosofia della natura di Goethe e di Schelling: e tale dialettica diadica esclude necessariamente ogni meccanicismo, nella misura in cui i due opposti sono due aspetti della medesima realtà. Tale realtà polarizzata ha dunque un carattere totalizzante, e la tensione polare non presenta mai un equilibrio, giacché altrimenti non si registrerebbe alcuna tensione. Interagendo con la totalità, le parti sono in perenne movimento e, pertanto, sono vive: sulla base di questo presupposto, Müller sottopone a critica l’idea illuministica di uno Stato concepito come macchina. Il movimento di cui dice Müller dev’essere inteso come un movimento dello Stato, non dei singoli individui che lo compongono: concretamente, se lo Stato ha bisogno della guerra, i sudditi devono andare a combattere, anche se di per sé preferirebbero la pace. Müller attacca anche il “concetto” di cui si serviva l’illuminismo per procedere in filosofia: il concetto come l’hanno inteso gli illuministi è un indebito tentativo di scomporre in parti la realtà, cercando di coglierne alcuni aspetti determinati; ma, così facendo, non si potrà mai cogliere la realtà nella sua totalità viva e in movimento. Per questa ragione, al “concetto” degli illuministi Müller contrappone la “idea”, intesa come coglimento della realtà nella sua viva interezza. Di qui Müller procede a smascherare i grandi errori che l’illuminismo ha generato: in primo luogo, la credenza che l’individuo possa uscire dalla totalità o, magari, distruggerla (come si è cercato di fare con la Rivoluzione francese); si tratta di un errore che, a sua volta, poggia sulla fuorviante credenza che l’individuo possa essere separato dal tutto e godere di vita autonoma. Il secondo errore consiste nel pensare che, all’inizio dei tempi, si fosse fuori dallo Stato o che ci si trovi attualmente alla fine dei tempi e che pertanto si possa giudicare in maniera distaccata ciò che è stato: in opposizione a ciò, Müller nota che l’individuo è nello Stato ed è legato a tutte le generazioni (passate e future). Gli illuministi avevano inteso lo Stato come una macchina che deve occuparsi soltanto delle azioni e, tutt’al più, delle manifestazioni esteriori del pensiero degli individui, senza però arrogarsi il diritto di giudicare le loro personali credenze religiose o politiche. Ma una tale concezione, nota Müller, è inaccettabile poiché finisce per non comprendere la parte spirituale dell’individuo: al contrario, lo Stato può e deve chiedere un’adesione spirituale del cittadino, in una fusione che coinvolge tanto le azioni quanto le intenzioni. Prima che venisse a formarsi lo Stato, secondo Müller non esisteva una condizione senza diritto: quest’ultimo consiste nel fatto che ciascun individuo possa esprimere esigenze personali, le quali possono entrare in conflitto con quelle altrui; il che richiede una mediazione. Ne segue allora che, per Müller, il diritto è una condizione di polarità che implica la contrapposizione di posizioni diverse date dalle diverse esigenze degli individui. Il diritto non deve decidere chi abbia ragione, giacché, a rigore, ciascuna parte in causa è dalla parte della ragione (tutte le esigenze sono legittime). In una simile cornice, il buon giudice è allora quello che media, tentando di trovare una connessione tra le due esigenze considerandole come i due poli della stessa realtà. Così facendo, il diritto si trasforma in legge, e quest’ultima ha un’espressione positiva. Sicché ci troviamo con un diritto naturale (le esigenze sono infatti naturali) e al tempo stesso con un diritto positivo (le esigenze diventano leggi positive). E lo Stato è il momento in cui la comunità (insieme naturale e positiva) assume una conformazione istituzionale precisa. È allora assurdo pensare che lo Stato nasca da un contratto sociale stipulando il quale gli individui si difendono dagli attacchi reciproci: Müller attacca senza tregua le tesi illuminista secondo cui lo Stato sarebbe una macchina artificiale avente per obiettivo la tutela degli interessi degli individui. Ad essa contrappone l’idea dello Stato come organismo totale avente per scopo non la felicità dei singoli, bensì il diritto. Egli attacca anche la teoria della contingenza dello Stato, secondo la quale, qualora venisse meno il motivo per cui lo Stato è sorto, esso dovrebbe essere sciolto; teoria che a sua volta poggiava sull’idea che un giorno gli uomini, educati al bene, non avrebbero più avuto bisogno di essere sottoposti a uno Stato e avrebbero creato spontaneamente una società equa. A questa teoria Müller contrappone quella secondo cui, proprio perché naturale e non artificiale, lo Stato non potrà mai essere sciolto. Le polarità che innervano la realtà vengono da Müller riferite anche allo Stato, soprattutto nel suo testo più matura: Gli elementi dell’arte politica (1809). Le polarità in questione sono giovane/vecchio, uomo/donna, diritto/economia, guerra/pace. Uomo e donna sono due realtà polari (forte il primo, dolce la seconda) che devono essere entrambe presenti, realizzandosi nella forma di ceti diversi: avremo allora un “ceto maschile”, borghese e aggressivo nel suo attivismo; e un “ceto femminile”, nobiliare e legato alla tradizione. Similmente, al “diritto romano” (per cui soggetto è la persona sia fisica sia giuridica) si contrappone il “diritto germanico” (per cui portatori di diritto sono anzitutto le cose). Nella polarità vecchi/giovani, i primi rappresentano lo spirito innovatore e borghese; i secondi quello conservatore e nobiliare. Altra opposizione è quella tra diritto ed economia: il primo, come abbiamo visto, è la mediazione tra esigenze opposte e si realizza nello Stato; la seconda è il luogo dell’interesse, dell’utile e del particolare. All’interno dell’economia, sussiste una polarità tra il bisogno che deve essere soddisfatto e il lavoro che serve a soddisfarlo: da questa polarità scaturisce una terza realtà, il capitale. Intendendo il lavoro come spirituale oltre che materiale, il capitale che ne trae origine può per Müller essere di due tipi: o materiale o spirituale (l’insieme di tutte le conoscenze scientifiche, tecniche, ecc). Con questa struttura polare, Müller può spiegare la vita dell’organismo statale come un incessante movimento in cui la costante tensione tra elementi opposti è il cemento che tiene insieme la totalità.
EMILE DURKHEIM

A cura di Alfio Squillace
“La società non è una semplice somma di individui; al contrario, il sistema formato dalla loro associazione rappresenta una realtà specifica dotata di caratteri propri. Indubbiamente nulla di collettivo può prodursi se non sono date le coscienze particolari: ma questa condizione necessaria non è sufficiente. Occorre pure che queste coscienze siano associate e combinate in una certa maniera; da questa combinazione risulta la vita sociale, e di conseguenza è questa che la spiega. Aggregandosi, penetrandosi, fondendosi, le anime individuali danno vita ad un essere (psichico, se vogliamo) che però costituisce un’individualità psichica di nuovo genere”. (Le regole del metodo sociologico, V, p. 102)
Emile Durkheim nasce a Epinal (Francia) in una famiglia ebrea praticante nel 1858. Rifiutando di diventare rabbino, entra alla Scuola Normale Superiore nel 1879, ove è compagno di studi di Jaurès, Bergson, Janet, Blondel. Legge Herbert Spencer, Renouvier, Auguste Comte e segue i corsi di Fustel de Coulanges sulle istituzioni delle società antiche. Repubblicano, fervente sostenitore di un ideale d’universalismo laico, Durkheim vuole contribuire con l’insegnamento e la ricerca alla ricostruzione sociale e morale della Francia ancora lacerata dalla sconfitta di Sedan del 1870 e dagli eventi drammatici che seguirono (occupazione prussiana, insurrezione della Comune di Parigi e sua repressione). Nel 1882, avvia contemporaneamente alcune ricerche sulla divisione del lavoro sociale (impegno principale) e su Montesquieu (impegno secondario). Viaggia per un anno in Germania, dove studia lo sviluppo delle scienze umane e sociali e constata la loro fioritura, quindi, nel 1887, inaugura a Bordeaux la cattedra di scienza sociale e di pedagogia. Nei suoi corsi tratta della solidarietà sociale, del suicidio, della “fisiologia” del diritto e dei costumi, del fatto morale e religioso, delle strutture educative e delle dottrine pedagogiche. Fin da quest’epoca, raccoglie attorno a sé un gruppo di discepoli e di collaboratori (suo nipote M. Mauss, R. Hertz, F. Simiand, e M.Halbwachs) e fonda l’Année sociologique (1896).
Nel 1902, diventa titolare della cattedra di scienza dell’educazione alla Sorbona, che, nel 1913, prenderà il nome di cattedra di educazione e sociologia. Vicino al partito socialista, dreyfusardo, fermamente convinto dell’evoluzione parallela dei progressi scientifici e tecnici da un lato e dei progressi sociale e morali dall’altro, ma anche dell’armonizzazione razionale e pacifica delle relazioni tra nazioni, cade nella disperazione all’atto della deflagrazione del conflitto mondiale del 1914 che infranse questo suo ottimismo intellettuale e che inghiottì numerosi collaboratori e anche il figlio André, nel 1916. Durkheim sopravvive alla sua morte solo un anno: morirà infatti nel 1917.
Al di là dell’ambito prettamente accademico, le tesi durkheimiane si diffusero in Francia, in ambito storico (scuola delle Annales ), linguistico (Ferdinand de Saussure) ed etnologico grazie a Marcel Mauss. Furono introdotte nei paesi anglosassoni da R. Radcliffe-Brown (scuola di Chicago) e Br. Malinowski (Gran Bretagna), ma sotto una forma mutilata (la teoria funzionalista di Malinowski) o molto semplificata (la concezione del rito di Radcliffe-Brown). Le teorie di Durkheim conoscono un rinato interesse a partire degli anni ’50 del Novecento, soprattutto per via del suo rifiuto dello psicologismo e per i suoi lavori di sociologia della conoscenza.
Della divisione del lavoro sociale (1893)
In Della divisione del lavoro sociale, Durkheim si domanda come mai l’individuo diventa sempre più autonomo e al tempo stesso viene sempre più a dipendere dal resto della società. Infatti, lo sviluppo dell’individuo che caratterizza la modernità non è accompagnato da un indebolimento dei legami sociali, ma piuttosto da un cambiamento di questi ultimi. Le società premoderne (prive della divisione del lavoro) non conoscono spazi per le differenze e per le individualità, le unità sociali stanno insieme perché sono tutte simili e ugualmente sottoposte all’unità di grado superiore di cui fanno parte (l’individuo alla famiglia, la famiglia al clan, il clan alla tribù). È una solidarietà meramente “meccanica”, come quella delle molecole di un corpo inorganico: e che sia una solidarietà meccanica appare evidente non appena si considerino i sistemi giuridici che vigono all’interno delle società premoderne, che sono tutti sistemi che adottano sanzioni repressive contro chi viola le leggi. Al contrario, nelle società moderne, in cui fortissima è la divisione del lavoro, ogni individuo e ogni gruppo svolge funzioni diverse: la solidarietà non si fonda più sull’uguaglianza ma sulla differenza; gli individui e i gruppi stanno infatti insieme perché nessuno è autosufficiente e tutti dipendono da altri. E gli stessi sistemi giuridici mirano non a reprimere, bensì a ristabilire l’equilibrio infranto da chi ha violato le norme (sono cioè sanzioni restitutive). Questo tipo di solidarietà è detta “organica” da Durkheim. Interrogandosi sui fondamenti del consenso sociale che stabilizzano le società, Durkheim intende dimostrare che l’anomia crescente nelle società moderne industriali non è una mera fatalità ma è da mettere in stretta connessione con l’instaurazione, modifica e sviluppo di una morale corrente, di un sistema di valori condiviso e con la loro degenerazione. A tale scopo Durkheim studia i tipi principali di stratificazione sociale in funzione del loro modo di determinare la coesione sociale. Fondamentale è a tal proposito la nozione di solidarietà, ovvero la coscienza sempre più interiorizzata che gli individui hanno di convivere in società e di sposarne i valori fondativi-aggregativi. Secondo Durkheim, con una legge di complessità strutturale crescente, sotto l’influenza del fattore demografico, le società passano dalla prevalenza della solidarietà “meccanica” a quella della solidarietà “organica”. Ma l’aumento in volume e in densità della popolazione ha realmente un effetto soltanto in virtù della densità “morale” o “dinamica” (numero e frequenza degli scambi sociali), la cui crescita causa a sua volta l’evoluzione dei quadri sociali. La solidarietà meccanica è caratterizzata dalla giustapposizione di segmenti sociali equivalenti (ordini, clan), e l’accettazione da parte dei singoli dei presupposti della coesione collettiva tramite funzioni repressive. In questo stadio gli individui vengono colti per somiglianza e la personalità individuale è assorbita in quella collettiva. In quest’ambito prevale un diritto di tipo prescrittivo (o penale). Il vincolo di solidarietà sociale al quale corrisponde il diritto repressivo è quello la cui rottura costituisce il reato; chiamiamo così ogni atto che, in qualche grado, determina contro il suo autore la reazione caratteristica denominata pena. La solidarietà organica si manifesta attraverso la differenziazione di funzioni specializzate (altrimenti detta divisione del lavoro) che implica la cooperazione cosciente e libera degli agenti sociali, quindi lo sviluppo della contrattualizzazione delle relazioni sociali e la nascita dello Stato moderno democratico, centralizzato, gestionale, e la conseguente concezione dell’individuo come persona. In quest’ambito prevale l’adozione di un diritto di tipo restituivo (o privato). Più specificamente per diritto restituivo Durkheim intende un sistema definito che comprende il diritto domestico, il diritto contrattuale, il diritto commerciale, il diritto delle procedure, il diritto amministrativo e costituzionale. Le relazioni regolate da tali diritti sono completamente diverse dalle precedenti: esse esprimono un concorso positivo, una cooperazione che deriva essenzialmente dalla divisione del lavoro. Durkheim riconosce alla divisione del lavoro soprattutto un carattere morale. Infatti in virtù di essa l’individuo ridiventa consapevole del suo stato di dipendenza nei confronti della società e del fatto che da questa provengono le forze che lo trattengono e lo frenano. In una parola, diventando la fonte eminente della solidarietà sociale, la divisione del lavoro diventa anche la base dell’ordine morale.
Le regole del metodo sociologico (1895)
La stesura dello scritto Della divisione del lavoro sociale del 1893 indusse Durkheim a misurarsi con le categorie da lui impiegate in quello scritto: in particolare, a domandarsi quali fossero e come funzionassero, in concreto, le “regole del metodo sociologico”. Non tutto è “sociale” in una società: e il fatto sociale – ossia “l’integrazione degli individui in una comunità morale di significazione” – è poi irriducibile ai fatti psicologici e biologici. Si tratta di un fatto collettivo, obiettivo, non soggettivo né mentale, e rispondente a “leggi sociali” autonome dalla psicologia e dalla biologia.
“Quando adempio ai miei compiti di fratello, di coniuge o di cittadino quando onoro gli impegni che ho contratto, io eseguo dei doveri che sono definiti fuori di me e dei miei atti, nel diritto e nei costumi. Proprio quando sono d’accordo con i miei sentimenti più profondi e ne sento interiormente la realtà, questa non cessa di essere oggettiva; poiché i miei doveri non sono io ad averli fatti, ma li ho ricevuti con l’istruzione […] La caratteristica essenziale dei fatti sociali consiste nel potere che essi hanno di esercitate dall’esterno una pressione sulle coscienze degli individui. […] Un fatto sociale si riconosce dal potere di coercizione esterno che esso esercita o è suscettibile di esercitare sull’individuo”.
È dunque la coercizione o sanzione (contrainte) ai voleri dell’individuo che istituisce il fatto sociale. Posso decidere di portare le scarpe appese al collo, ma la riprovazione collettiva, non il fatto in sé, mi scoraggerà dal farlo.
D’altra parte, una società si manifesta come un “tutto”: in ciò riposa l’olismo durkheimiano. Non è il risultato della somma di individui o di gruppi: è un luogo in cui le norme sono funzione dell’interdipendenza delle sue componenti (olismo). È vero che la società è composta da individui: ma è anche vero che essa è qualcosa di più che la semplice somma di individui, alla luce del fatto che “aggregandosi, penetrandosi, fondendosi, le anime individuali danno vita ad un essere (psichico, se vogliamo) che però costituisce un’individualità psichica di nuovo genere”. Detto altrimenti, nel caso della società, “è la forma del tutto che determina quella delle parti” (in opposizione a Durkheim, Max Weber muoverà dai singoli individui per spiegare la società). Per questo motivo, bisogna guardarsi dallo spiegare i fatti sociali come frutto dei fatti psichici degli individui: piuttosto, nella maggior parte dei casi, i fatti psichici sono il “prolungamento” (così dice Durkheim) di fatti sociali all’interno della coscienza. Ciò appare evidente se, come suggerisce Durkheim, prestiamo attenzione al caso del matrimonio: è l’organizzazione sociale del matrimonio che fa nascere i sentimenti parentali, e non viceversa. Si può così valutare la normalità o il carattere patologico di un fatto sociale soltanto riportandolo al proprio contesto, alla tipicità esibita dalla società osservata in un periodo dato della propria evoluzione strutturale. Di più: ogni società è un insieme di “fatti morali”, una combinazione sui generis di istituzioni. Con istituzione, Durkheim designa ogni forma organizzata – famiglia, istruzione, giustizia – tesa ad un fine sociale, una funzione, che il criterio d’utilità non definisce né spiega: in effetti, “l’organo è indipendente dalla funzione”, poiché “le cause che lo hanno posto in essere sono indipendenti dal fine a cui tende”. L’analisi di Durkheim implica che se l’intersezione dei gruppi, l’interdipendenza costante delle istituzioni determinano il sociale, tutto, in una società, non dipende dalla funzione. Così si trova in anticipo negato ogni valore esplicativo alle teorie funzionaliste del sociale nelle quali ogni item – idea, abitudine, oggetto, ecc. – è ritenuto, in quanto esistente, atto ad adempiere un fine necessario che si raggiungerebbe in un’unità fuori dalla storia: la soddisfazione di bisogni psicobiologici fondamentali. Al contrario, per Durkheim, se l’essere umano ha una capacità indefinita di desiderio, ed è ciò che segnalano i periodi d’anomia, l’espressione dei bisogni è sempre socialmente condizionata. Essi insomma non esistono fuori dalla società e solo in essa si soddisfano.
Durkheim farà delle istituzioni il suo oggetto primario di studio perché sono particolarmente obiettivabili, distinguono le società umane delle società animali e attestano l’unità del tipo umano. La sociologia comprenderà la morfologia sociale, che studia il substrato della vita collettiva (forma e ripartizione del gruppo sul territorio, dell’ habitat, delle comunicazioni), e la fisiologia sociale, che studia la genesi ed il funzionamento delle istituzioni, le “correnti sociali libere”, fonti delle trasformazioni o della creazione delle istituzioni.
Obiettività dei fatti sociali
Proporre “di considerare i fatti sociali come delle cose”, come fa Durkheim, non significa assimilarli a fatti materiali o classificarli in questa o quella categoria del reale, ma invitare a osservarli proprio come delle cose, le quali si oppongono all’idea come ciò che si scorge dall’esterno rispetto a ciò che si coglie dall’interno. Ora la “familiarità” che ciascuno intrattiene con la sua società grazie a formulazioni “spontanee” (è spontaneo portare le scarpe ai piedi), le prenozioni, diffuse in ogni società e più o meno razionalizzate, sono, per Durkheim, “il primo ed il più grande ostacolo” alla comprensione scientifica dei fenomeni sociali, poiché sono essi stessi un fenomeno sociale. Inoltre, rappresentazioni e pratiche collettive soverchiano l’individuo con il loro numero, non sono perché gli preesistono e gli sono trasmessi attraverso l’educazione, ma anche perché esercitano su di lui un ascendente, un’ autorità morale. Poiché l’introspezione conduce a razionalizzare degli “a priori”, occorre abbordare i fenomeni sociali “staccati dai soggetti coscienti che se li rappresentano, “isolarli dalle manifestazioni individuali», cioè «studiare il fatto sociale con il fatto sociale”. Nella Divisione del lavoro sociale, Durkheim individuerà le forme della solidarietà sociale attribuendo loro quelle del diritto, individuabili ed analizzabili per mezzo delle sanzioni prevalenti. La generalità o la frequenza di un ordine di fenomeni, la costrizione/sanzione (contrainte) che esercitano possono fungere da indicatori ma non ne danno né la definizione né la spiegazione. Un fatto è generale e costrittivo soltanto perché sociale, e non l’inverso. Per “costrizione” (contrainte), Durkheim rinvia al carattere “spontaneo” della pressione sociale.
Il suicidio (1897)
Oggettivando le “tendenze collettive” al suicidio, Durkheim costituisce in fatto sociale un fenomeno propriamente individuale: il tasso sociale di suicidio (numero di suicidi rapportato al totale di una popolazione in un periodo dato) ci dice molto di più dello “stato morale” di una società, per la sua costanza e specificità, che il tasso di mortalità generale, a un di presso identico in società di uguale livello di civilizzazione. Inizialmente, Durkheim elimina dall’esame di questo fatto sociale i fattori extrasociali: le psicopatie, la razza, le eredità psicobiologiche, i fattori geografici e climatici, l’imitazione. Successivamente, propone un’analisi a più livelli proponendo di studiare le “variazioni concomitanti” di “serie ordinate” di fenomeni, e mostrare che le cifre del suicidio dipendono dagli ambienti sociali (familiari, confessionali, politici, professionali). Così, per determinare se la crescita del tasso di suicidio derivi o no da quella del grado d’istruzione, egli introduce una variabile intermedia, la religione (non il dogma religioso ma la religione in quanto fatto sociale, orditrice di legami comunitari): l’indebolimento delle comunità confessionali “rafforza ad un tempo il bisogno di sapere e l’inclinazione al suicidio”, poiché l’individuo separato dalla comunità esperisce tutta l’ebbrezza individuale della scoperta del pensiero, ma al contempo, la perdita del quadro di riferimento normativo (anomia) e il conforto della comunità, rende oltremodo rischiosa la sua posizione. Durkheim determina tre tipi principali di suicidio. Due riguardano le società moderne: il suicidio anomico, fortemente connesso alle crisi da esse attraversate, quando si crea cioè disordine (anomia); e a tal proposito Durkheim argomenterà che il numero di suicidi aumenta sia in periodi di recessione economica sia di impetuoso sviluppo; il suicidio egoista, ancora tipico delle società moderne e dovuto all’allentarsi dei legami comunitari. Il suicidio altruistico tipico delle società a solidarietà meccanica, in cui l’individuo si sacrifica per rinsaldare il gruppo di appartenenza (oggi noi potremmo esplicitamente ascrivere in questa categoria il suicidio dei kamikaze).
Le forme elementari della vita religiosa (1912)
Durkheim vede nella religione il fenomeno sociale fondamentale dal quale derivano tutti gli altri. Ne tenta una definizione oggettiva ossia non relativa al contenuto dei dogmi:
“È il sistema condiviso di credenze e di pratiche (riti) relative a cose sacre, ossia separate, interdette”.
La dialettica del sacro e del profano costituisce il centro del fatto sociale (nella religione, è la società che adora se stessa) ed è speculare a quella intercorrente tra individuo e società. Tale dialettica producendo i principi di classificazione dell’universo, le categorie di tempo, di spazio, di forza, ecc., è all’origine dell’esigenza di logica, di razionalità e di universalità della scienza moderna. Durkheim prosegue nelle Forme elementari della vita religiosa il progetto (avanzato ne La divisione del lavoro sociale) di fare la storia delle forme sociali della presa di coscienza del reale, di tentare una teoria generale dell’attività simbolica: l’elaborazione di una sociologia della conoscenza, alla quale partecipò Marcel Mauss. Così, lingua, segni, simboli, per una parte fatti sociali, acquistano significato soltanto in funzione di un contesto sociale e storico dato e della loro posizione in un insieme di relazioni.
J. BURCKHARDT

A cura di Diego Fusaro e Jonathan Fanesi
“Conosceremmo volentieri le onde che ci portano sul mare della vita. Ma queste onde siamo noi stessi”.
Nato a Basilea, in Svizzera, nel 1818, Jacob Burckhardt proveniva da una famiglia di religione evangelica. Egli seguì inizialmente studi teologici, completando la propria formazione nel campo della storia e della storia dell’arte all’università di Berlino dove fu allievo, tra gli altri, di L. von Ranke, J.G. Droysen, A. Boeckh e F. Kluger. Dal 1855 al 1858, Burckhardt ricoprì la cattedra di storia dell’arte al politecnico di Zurigo, quindi quella di storia e di storia dell’arte all’università di Basilea, e dal 1885 in poi insegnò soltanto storia dell’arte, abbinando all’attività didattica frequenti viaggi di studio, soprattutto in Italia. Spirito critico, profondamente pessimista nei confronti della moderna società industriale e in aperto dissenso con le tendenze idealistiche e storicistiche dominanti il mondo accademico dell’epoca, elaborò un autonomo approccio storiografico, noto come Kulturgeschichte (storia della civiltà), inteso a ricomporre le diverse dimensioni del fenomeno storico (politico, spirituale e culturale) entro un quadro unitario. Fu autore di numerose opere, solo in parte pubblicate in vita, tra cui le più importanti furono dedicate ad analizzare periodi di crisi o di trapasso storico. Appartengono a tale filone L’età di Costantino il grande (1852), incentrata sul problema della transizione dalla civiltà ellenistica a quella cristiana e l’ormai classica La civiltà del Rinascimento in Italia. Tra le opere postume (che sono però il prodotto di un lavoro di ricostruzione, e in parte anche di interpolazione, da parte del nipote) si ricorda, oltre alla fondamentale Considerazioni sulla storia universale, l’imponente Storia della civiltà greca (in quattro volumi, 1898-1902), in cui la civiltà greca è vista come il primo esempio storico di sviluppo dell’individualità e spiritualità umane, affrancate dai vincoli naturalistici, ma anche, in polemica con gli storici dell’antichità e le loro visioni edulcorate, come espressione di una società dominata dalla violenza e dalla sete di potere. Storico dell’arte, del Rinascimento italiano e dell’età di Costantino, Burckhardt (1818-1897), proprio nei primi anni del soggiorno di Nietzsche a Basilea, tiene lezioni sulla civiltà greca e sullo studio della storia, lezioni che saranno poi pubblicate postume con i titoli: Storia della civiltà greca e Considerazioni sulla storia mondiale. Morì a Basilea nel 1897. Burckhardt, come Nietzsche, fu assai sensibile all’insegnamento di Arthur Schpenhauer, non condividendo la concezione ottimistica della storia formulata da Hegel nè l’interpretazione del presente come culmine positivo del suo cammino progressivo. Nel mondo moderno, infatti, la libertà dell’individuo é gravemente minacciata dalle tendenze democratiche e socialistiche e dal predominio del mondo degli affari. Questo non vuol dire che la vicenda storica sia caratterizzata da una crescente decadenza; a parere di Burckhardt, si deve piuttosto parlare di ascese e cadute relative. Il passaggio da un’epoca all’altra é segnato da crisi, che portano all’eliminazione di un passato avvertito come oppressivo e all’instaurazione di qualcosa di nuovo; la crisi é dunque segno di vitalità, poichè ogni sviluppo spirituale avviene “a forza di urti e di salti”, sia negli individui sia nelle collettività. Determinanti nell’intervenire o deviare il corso della storia sono i “grandi individui”, unici e insostituibili, ma al tempo stesso portatori di valori universali che vanno oltre gli interessi puramente individuali. Essi non corrispondono, tuttavia, agli individui “storico-universali” di cui aveva detto Hegel: in opposizione al suo “panlogismo”, Burckhardt sostiene che non esiste una “storia universale” e che la filosofia della storia non ha alcun senso. Nella storia il male rimane ineliminabile e la natura umana permane essenzialmente uniforme nonostante l’avanzare della storia. In tutte le epoche storiche operano, infatti, le stesse forze o potenze: la cultura, lo Stato e la religione. Nessuna di esse può essere eliminata, ma tutte si condizionano a vicenda e possono dar luogo a quanto di bello, vero e buono contiene la storia umana. Questo avviene quando esse mantengono un rapporto equilibrato e armonico tra loro e nessuna soffoca la altre; così é stato nel mondo greco e nel Rinascimento, ma ora sussiste il pericolo che la cultura, la quale di per sè é dinamica, libera e spontanea, sia schiacciata dallo Stato e dalla religione, che sono potenze statiche. Burckhardt é avverso allo Stato e alla forza, specialmente ai grandi Stati nazionali che tendono a soffocare le piccole comunità regionali e cittadine, le quali, a suo avviso, offrono maggiori garanzie per lo sviluppo di libere individualità. Nella situazione minacciosa del presente, l’unica consolazione é riposta nella conoscenza storica, che é libera dalle preoccupazioni individuali causate dall’epoca e permette di contemplare in maniera distaccata e senza turbamenti le vicende del passato. L’uomo di cui parla Burckhardt non è quello hegeliano, che compendia lo Spirito: infatti, se nella sua filosofia della storia Hegel muoveva dallo “Spirito del mondo”, Burckhardt parte invece dal patire e dall’agire del singolo individuo, rispetto al quale lo Stato è pura convenzione. Lo stesso individuo, che per Hegel era complice dello Spirito, che lo manovrava come una marionetta attraverso la “astuzia della ragione”, per Burckhardt è libero di fronte al mondo. In particolare, il pensatore svizzero guarda al corso storico con occhi umani, rimuovendo il concetto di felicità e mantenendo esclusivamente quello di infelicità: il male è un fenomeno interno alla storia, che è sempre intessuta di lotte tra uomini che si soverchiano e soffrono sempre nuovi patimenti. Sicché il male è il prezzo della vita storica: un prezzo che si deve scontare e che, con buona pace di Hegel, non può essere giustificato tramite strambi filosofemi. Nella storia, è vero, compaiono anche momenti di felicità; ma essi sono per Burckhardt meri punti nel flusso storico. Anche Kierkegaard porrà al cuore della sua riflessione il singolo individuo, ma prospettando un suo allontanamento dalla storia; al contrario, Burckhardt propone una continuità storica in forza della quale il singolo, pur nella sua individualità, si trova sempre calato in essa. Anche Nietzsche condivide la diagnosi negativa del mondo moderno, formulata da Burckhardt, ma assume un atteggiamento più combattivo e polemico nei confronti di esso. In particolare, Nietzsche vedrà in Burckhardt una sorta di se stesso più anziano, provando nei suoi confronti un’ammirazione sconfinata ma mai corrisposta: per tutto il corso della sua vita, Nietzsche cercherà di entrare nelle grazie del grande studioso svizzero senza raggiungere mai risultati positivi, o addirittura incontrando cocenti delusioni. L’opera nietzscheana in cui si avverte la maggiore presenza di Burckhardt è la seconda considerazione inattuale Sull’ utilità e il danno della storia per la vita. E Giorgio Colli nella prefazione al testo di Burckhardt Sullo studio della Storia ha avanzato la suggestiva ipotesi che non solo Burckhardt abbia influenzato Nietzsche, ma anche il contrario. In particolare, in una conferenza tenuta da Burckhardt, dal titolo A proposito della considerazione storica della poesia, si legge una breve ma intesa parentesi in puro stile nietzscheano:
“Il dramma attico getta squarci di luce su tutta l’ esistenza attica e greca. In primo luogo, la rappresentazione è stata qui una questione sociale di primaria importanza, agonale nel senso più elevato, con i poeti in gara tra loro. Riguardo poi alla maniera e al modo di trattarla: la nascita misteriosa della tragedia ‘dallo spirito della musica’. Il protagonista riecheggia Dioniso e tutto il contenuto è soltanto mito, mentre si evita la storia, che molto spesso incombe da vicino. Ferma volontà di rappresentare l’umano in forme tipiche e non conformi alla realtà; convinzione circa l’inesauribilità dell’epoca arcaica, di quella degli dèi e degli eroi”.
Dalla lettura di questo breve passo, si evince il forte richiamo nietzscheano: il nome di Dioniso riecheggia come fulcro ed origine della tragedia attica, e i personaggi non sono altro che manifestazioni mediante la maschera del Dio–umano greco. Una vera e propria ammirazione per Burckhardt animò anche Karl Löwith, che al pensatore svizzero dedicò un bellissimo libro: Jacob Burkhardt. L’uomo nel mezzo della storia (1936). Per Löwith, Burckhardt rappresenta – in senso radicale – la fine del modo cristiano ed hegeliano di concepire la storia come una linea che avanza verso un obiettivo finale: sicché egli recide il legame tra passato e futuro eliminando il piano finalistico, col che, paradossalmente, Burckhardt è stato – nota Löwith – ben più inattuale di Nietzsche. In The meaning of history (1949), Löwith prenderà in considerazione la continuità storica di cui parla Burckhardt mostrando acutamente come non si tratti più di una connessione forte e teo–teleologica: per “continuità” storica s’intende “l’immagine che ogni epoca storica prende dalle altre epoche per riconoscersi”. Continuità e coscienza storica sono per Löwith i due cardini dell’analisi e del discorso sulla storia di Burckhardt: all’ interno della continuità vi sono – sostiene Burckhardt – tre nodi fondamentali: in primis il processo di ellenizzazione dell’Oriente operato da Alessandro di Macedonia, in secundis la città ed il centro culturale ed economico del mondo antico, e infine il mantenimento del complesso della cultura occidentale mediante l’azione della Chiesa. Burckhardt dà una valutazione positiva del concetto di crisi, di cui la guerra (solo nell’accezione difensiva) è la prima manifestazione che porta alla vivificazione di un popolo. Dopo aver fatto tale analisi generale, Burckhardt sposta la sua attenzione sulla crisi franco–prussiana che nascerebbe dalla Restaurazione e dal principio di legittimità: principio secondo il quale il potere degli stati è tale in quanto é di origine divina e non per consenso popolare. Contro questo principio, si sono mosse i moti rivoluzionari del 1848: Burckhardt non scorge in questi eventi manifestazioni dello spirito di nazionalità, bensì rivoluzioni liberali mediante le quali trionfa la borghesia e il paradigma di “opinione pubblica” espressa mediante la dimensione comunicativa della borghesia. In ogni paese, l’industria aspira al commercio europeo. Si avverte la nostalgia burckhardtiana verso il mondo umanistico–rinascimentale dove si presentava un’aristocrazia dello spirito: il 1848 ha posto in rilievo colui che guadagna, ma la libertà della borghesia è ambigua e rischia di degenerare. Sotto questa prospettiva, la democrazia risulta essere quel governo dello Stato sull’individuo, che tende a superare i confini tra Stato e società, e in ciò Burckhardt prende di mira la prospettiva politico–statale hegeliana. L’avanzamento del capitalismo, grazie alla vittoria della Prussia sulla Francia, porta in auge una rivoluzione di valori e Burckhardt si pone una serie di domande relative a chi si occuperà dell’ arte e della letteratura, a quale fine farà la cultura umanistica. Il grande uomo burckhardtiano è colui che incarna il movimento generale della cultura (artisti e letterati), la sintesi tra particolare ed universale (in maniera simile al processo che si realizza nella facoltà giudicatrice kantiana). La grandezza significa che ciò che noi non abbiamo, e non potremo mai raggiungere definitivamente, una sorta di “Streben” di matrice protoromantica o se si preferisce di fichteana memoria, i “grandi individui” sono definiti tali in virtù del nostro punto di vista particolare, come ogni popolo nel corso della scuola ha celebrato la sua grandezza, senza un grande uomo il mondo risulterebbe ai nostri occhi incompleto. Nell’Ottocento sorge – secondo Burckhardt – il senso storico con la figura di Winckelmann, visto come l’iniziatore del “Neo–umanesimo” tedesco poi conclusosi con Humboldt. La poesia è creazione e potenza e si fonda sul principio della trasfigurazione: essa ha un ruolo superiore al resto delle arti ed alla filosofia, e Burckhardt cita a proposito una lettera di Schiller a Goethe, dove si dice che il filosofo non è altro che la caricatura del poeta. Nel suo celebre scritto La civiltà del Rinascimento in Italia, pubblicato nel 1860, Burckhardt sostiene la tesi, destinata a godere di lunga fortuna, secondo cui il mondo moderno sarebbe sorto nel XV secolo, con una vera e propria frattura rispetto alla buia età medioevale. Nel 1919, lo storico e filosofo olandese Johann Huizinga sottoporrà a critica questa teoria che ha tracciato “con troppa sicurezza” la linea di separazione tra Medioevo e Rinascimento, senza vedere gli aspetti di continuità tra le due epoche: ne L’autunno del Medioevo, Huizinga provava a capovolgere la prospettiva fatta valere da Burckhardt, guardando al Medioevo non come a un’epoca buia rispetto alla quale la modernità sarebbe un ritorno alla luce, ma piuttosto come un’età fondamentale per capire la modernità, che da essa deriva.
JOSEPH-ERNEST RENAN

L’influenza che il “positivismo” di Auguste Comte esercitò nella Francia del XIX secolo fu decisiva e onnipervasiva, arrivando a interessare gli ambiti più disparati: ci fu chi (Emile Littré, 1801-1881) tentò di applicare il positivismo comteano alla linguistica, chi (Hyppolite Taine, 1828-1893) cercò di impiegarlo come chiave di accesso all’estetica, e chi addirittura azzardò ad applicarlo alla storia delle religioni. È questo il caso di Joseph-Ernest Renan, nato il 28 febbraio 1823 a Tréguier da una famiglia cattolica: il padre era un capitano di un battello che, a seguito della sua morte avvenuta in mare, aveva lasciato la famiglia in uno stato di forte miseria. All’età di nove anni, nel settembre 1832, il nostro autore entra alla Scuola ecclesiastica della sua cittadina, dove la sua vivacità d’ingegno si manifesta nei brillanti successi scolastici per i quali ottiene i premi del migliore allievo della classe in tutte le materie. Nel 1838, il quindicenne futuro scrittore riesce ad ottenere, grazie all’interessamento di sua sorella Henriette, una borsa di studio che gli permette di accedere a un seminario minore parigino, quello di Saint-Nicolas-du-Chardonnet, la cui direzione era affidata all’abate Dupanloup, del quale Renan serberà sempre un ricordo non particolarmente piacevole a causa del suo spirito acritico in campo teologico e del suo desiderio di ottenere un certo prestigio mondano. Nonostante che venisse considerato non credente dal suo insegnante di filosofia e mostrasse forti esitazioni a riguardo della sua futura carriera ecclesiastica – siamo ormai agli inizi degli anni ’40, quando il futuro saggista avrà già cambiato una prima volta istituto religioso – , il nostro autore nel 1843 si trasferisce presso il seminario di Saint-Sulpice, dove tuttavia i segni di crisi e, anzi, di decisa insofferenza religiosa tendono ad acuirsi.
Dopo un soggiorno nella sua amata Bretagna, il 9 ottobre 1845, rientrato a Parigi, lascia Saint-Sulpice, rimanendo però in buoni rapporti con i suoi maestri, coi quali anzi avrebbe continuato a instaurare una vivace corrispondenza. Dopo aver ottenuto il premio dell’Institut de France per il suo Essai historique et théorique sur les langues sémitiques (1847) – un riconoscimento che testimonia la sua perizia in siffatto genere di studi – la sua fama ai livelli più alti della cultura francese si era sicuramente rafforzata. Per tale ragione, quattro anni più tardi, Renan potrà iniziare la sua sistematica collaborazione con “La Revue des deux mondes”, pubblicando un articolo sulle origini dell’islamismo e la figura di Maometto. Ma l’evento centrale della sua esistenza è indubbiamente la missione in Fenicia che il governo di Napoleone III gli affida nel maggio 1860: Renan e sua sorella Henriette giungono così a Beirut pochi mesi più tardi, verso la fine di ottobre. Durante questo viaggio scientifico, egli concepisce l’opera che gli avrebbe portato successo e gloria, ma anche un forte coro di condanne e di invettive le quali costituiscono, in verità, un intenso segnale per comprendere come la diffusione del testo in Francia, ma ben presto anche in Italia e in gran parte dell’Europa, non è assolutamente trascurabile.
Nel 1862 Renan è nominato per decreto professore al Collège de France; nondimeno è costretto a sospendere i corsi che stava avviando, a seguito della discutibile prolusione che tenne davanti ai membri dello stesso Collège: infatti il suo discorso, intitolato De la part des peuples sémitiques dans l’histoire de la civilisation, ha sì suscitato il plauso dell’uditorio liberale, che si è anzi dimostrato entusiasta per il modo con cui Renan ha dipinto Gesù, ma le polemiche nondimeno si sono fatte decisamente molto accese: il mondo cattolico non poteva certo apprezzare l’idea di un Gesù “umanizzato”. Per il nostro autore, infatti, il Cristo sarebbe stato un uomo senza dubbio incomparabile, e persino talmente grande che certo non sarebbero per nulla da biasimare quanti lo riconoscono e lo venerano come Dio, nonostante, evidentemente, non sia altro che un uomo eccezionale. L’ordinanza di interruzione delle attività didattiche giunge direttamente dal ministro della Pubblica Istruzione, il quale coglie la pericolosità del discorso. Le dottrine divulgate dal filosofo comteano sono state considerate infatti come nocive e offensive per la fede cristiana, in quanto, oltre a essere totalmente false, sarebbero capaci, almeno virtualmente, di sollevare forti opposizioni popolari, secondo almeno quanto afferma la critica più reazionaria: la gente comune, difatti, potrebbe vedere nelle parole che lo scrittore ha pronunciato, rispecchiate le proprie inclinazioni più nascoste, e soprattutto potrebbe con assoluta facilità passare da una rivendicazione della libertà religiosa – già di per sé temibile – implicita nell’idea di un Gesù umano, a richiedere addirittura l’emancipazione da qualsiasi forma di autoritarismo politico e da qualunque ordine costituito: i ricordi dei moti del 1848, quando lo stesso Renan seguiva con grande attenzione lo svolgersi degli avvenimenti politico-sociali e mostrava tutto il suo entusiasmo per la gioventù liberale, non erano ancora cancellati. Ma il governo, pur mostrandosi preoccupato dagli scritti e dalle parole di Renan, non riesce a condannarlo al silenzio. Renan si spense nel 1892.
L’audace tentativo compiuto da questo filosofo è quello di trovare un campo di applicabilità al positivismo anche in sede di scienze storico-filologiche e, in particolare, in sede di storia delle religioni. Renan fu avviato in gioventù dalla famiglia agli studi seminariali: ma ben presto smarrì la fede in Cristo per trovare quella nella nuova “religione” positivistica fondata da Comte. In particolare, il nostro autore si propone di applicare alle discipline storico-filologiche il principio di Comte secondo cui ogni elemento soprannaturale o metafisico dev’essere rigettato, nel tentativo di ricondurre la spiegazione storica a fenomeni meramente empirici e, dunque, verificabili scientificamente. È sulla base di questi presupposti positivistici che Renan scrive la sua celebre Vita di Gesù, del 1863. In quest’opera, pur difendendo l’esistenza storica del Cristo, Renan ne nega la divinità e riconosce al suo insegnamento un mero valore esemplare. Detto altrimenti, come già aveva sostenuto (seppur in un altro contesto e con diverse prospettive) David Friedrich Strauss nella sua Vita di Gesù (1835), Cristo, lungi dall’essere il figlio di Dio, è inteso come il paradigma dell’uomo eticamente perfetto, un modello da imitare nel tentativo di avvicinarsi asintoteticamente a lui. Quando vide la luce, il libro non potè non suscitare una forte indignazione e un acceso senso di astio, in un’epoca in cui la Chiesa giocava un ruolo ufficiale sia a livello politico (i cardinali infatti erano di diritto senatori), sia nell’ambito della fede. Renan stesso temeva che la sua opera cadesse sotto le maglie di quella giustizia che certo non si era dimostrata tenera nei riguardi del celebre romanzo di Flaubert Madame Bovary e della raccolta baudelairiana Fleurs du Mal. Ma lo straordinario successo dell’opera – nell’arco di appena due mesi erano state vendute ben 25000 copie del testo – avrebbe suscitato forse maggiori rimostranze di protesta qualora essa avesse subito la condanna da parte del potere ecclesiastico per eresia, e fosse stata proscritta così definitivamente ai lettori: perciò i cattolici furono costretti a temporeggiare e ad assumere un atteggiamento di momentanea oscillazione, grazie al quale la Vita di Gesù poteva circolare ancor meglio. Renan aveva già scritto un Essai psychologique sur Jésus-Christ nel maggio 1845, a due anni esatti dal solenne rimprovero che il suo professore di filosofia gli aveva mosso, accusandolo di non essere per nulla un cristiano; successivamente, nel 1857, avrebbe dato alle stampe le sue Études d’histoire religieuse. La Vita di Gesù costituisce il primo dei sette volumi in cui è articolata la Storia delle origini del Cristianesimo (1863-1881). Anche quest’opera fu scritta seguendo i principi positivistici fissati da Comte; e così fu anche per la successiva Storia del popolo d’Israele, in cinque volumi, che Renan compose dal 1887 fino alla sua morte. non si può dubitare che sotto il profumo della leggenda si nasconda uno spessore storico non irrilevante.
LASSALLE

Ferdinand Lassalle (Breslavia 1825 – Ginevra 1864) figlio di un mercante ebreo, studiò a Breslavia e a Berlino, ove divenne un fervente hegeliano. socialista tedesco, prese parte alla rivoluzione del 1848 e fu fondatore dell’Associazione generale dei lavoratori tedeschi nel 1863, primo nucleo del Partito socialdemocratico. Pubblicò il Programma operaio (1862). Lassalle, che fu un hegeliano dell’ala conservatrice, propagandò la cosiddetta “legge ferrea dei salari”, che sanciva l’impossibilità di continui aumenti salariali. Egli era un perfetto idealista; in opposizione al marxismo, Lassalle spiegava che mentre la società borghese “garantiva” l’illimitato sviluppo delle forze produttive, l’idea morale del proletariato è quella di rendere la produzione ed i servizi utili per la comunità. Lassalle credeva che il proletariato rappresentasse la comunità, solidarietà e reciprocità di interessi. Credeva quindi che la causa dei lavoratori è perciò la causa dell’umanità: quando il proletariato guadagna supremazia politica, si crea allora un più alto grado di moralità, di cultura e di scienza, le quali portano ad uno sviluppo della civiltà. Lassalle, come Hegel, credeva nello Stato quale organo di diritto e di giustizia. Credeva quindi che l proletariato potesse vincere solo attraverso lo Stato; in Scienza ed operaio, scrisse:
“Il corso storico è una lotta contro la natura, contro l’ignoranza e l’impotenza, e, quindi, contro la schiavitù e contro ogni genere di sottomissione alla quale siam stati sottomessi dalle leggi stesse di natura sin dall’inizio della storia. Il progressivo superamento di tale impotenza è l’evoluzione della libertà, della quale la storia dà prova. In questa battaglia l’umanità non avrebbe fatto alcun passo avanti se gli uomini avessero deciso di lottare singolarmente, ognuno per se stesso. Lo Stato è la contemplata unità e la cosciente cooperazione degli individui in un organismo morale unico; la sua funzione è quella di portare avanti questa battaglia, attraverso una combinazione che moltiplica di un milione di volte le forze di tutti gli individui in esso concentrati e che accresce di un milione di volte il potere che ogni singolo individuo sarebbe capace di esercitare singolarmente”.
Spiego quindi che “il compito dello Stato è l’educazione e lo sviluppo della libertà del genere umano”. Inutile rimarcare ulteriormente le differenza tra questa visione dello Stato, che, in quanto portatore della causa del proletariato. Rende inutile la necessità di una rivoluzione, e la l’interpretazione materialista, la quale giudica lo Stato come lo strumento dell’oppressione di una classe sulle altre.
In quanto unico leader socialista della sua generazione non costretto all’esilio, riuscì comunque, malgrado i suoi difetti teorici, ad esercitare una forte influenza sul movimento proletario tedesco. I suoi seguaci parteciparono alla fondazione del Partito socialdemocratico tedesco.
Ucciso in duello dal Conte di Racowitza il 31 agosto 1864. In una lettera del 7 agosto 1862 ad Engels, Marx scriveva, a proposito di Lassalle: “politicamente non concordiamo in nulla fuor che in alcuni scopi finali alquanto distanti”. Infatti, in opposizione all’idea dell’autoemancipazione proletaria per via rivoluzionaria, Lassalle propugnava un “socialismo dall’alto”, pilotato dallo Stato, inteso hegelianamente come il vertice, il “Dio in terra”. Inoltre, Lassalle dà molta importanza ai singoli individui: nel suo dramma storico Franz von Sickingen, egli presenta le grandi lotte politico-religiose della Riforma sotto l’angolo visuale dei “Grandi Uomini”. Addirittura, Lassalle conduce trattative segrete con Bismarck, al quale promette il sostegno dell’Associazione in cambio di un intervento sociale dello Stato prussiano. Convinto del proprio ruolo messianico di “Grande Liberatore” degli operai, Lassalle mette in piedi, nell’Associazione, una struttura organizzativa ultracentralizzata, autoritaria, antidemocratica, quasi dittatoriale, nella convinzione della “tendenza istintiva della classe operaia alla dittatura” (come scriverà a Bismarck). Marx attacca impietosamente Lassalle, paragonandolo al personaggio del suo dramma (Sickingen) che vuole costringere Carlo V (fuori dal dramma, Bismarck) a porsi alla testa del movimento operaio. Nella Critica del Programma di Gotha, la critica marxiana si fa più pugnace: “è degno della fantasia di Lassalle che si possa costruire con l’ausilio dello Stato una nuova società, come si costruisce una nuova ferrovia!”. Inoltre, Marx sottopone a critica due aspetti che connotano il pensiero lassalliano: a) il messianesimo (che lo avvicina all’aborrito Proudhon), b) il settarismo. In una lettera a Kugelmann del 23 febbraio 1865, Marx scrive che Lassalle si presentava agli operai come un “redentore così ciarlatanesco che prometteva di portarli con un salto nella Terra promessa”.
HENRY DAVID THOREAU

A cura di Roberta Musolesi
Andai nei boschi perché volevo vivere in profondità e succhiare tutto il midollo della vita… per non scoprire in punto di morte di non aver mai vissuto. ”
Henry David Thoreau nacque a Concord, nel Massachusetts, nel 1817. Si laureò ad Harvard nel 1837 e in seguito ai suoi studi sviluppò un forte interesse nei confronti della poesie greca e romana, della filosofia orientale e della botanica. Nutrì grande interesse ed amore nei confronti della natura e dedicò molte delle sue giornate ad esplorare i boschi e a raccogliere informazioni dettagliate su piante ed animali. Fu seguace di R. W. Emerson e fu una delle figure di spicco del movimento trascendentalista. Henry Thoreau fu sicuramente il primo pensatore a rendere evidente il contrasto tra la piena realizzazione di ogni individuo e una società tecnologicamente organizzata. Precursore di tutti gli americani che prima e dopo l’era hippy hanno fatto ritorno alla natura opponendo un’economia della frugalità al consumismo forsennato, mezzo secolo prima di Jack London egli avvertì il richiamo della foresta e nella primavera del 1845 si recò sulle rive del lago di Walden, a Concord, nel Massachusetts. Usando un’ascia presa a prestito abbatté alcuni pini bianchi per ricavarne legname con cui costruirsi un’austera dimora nella quale avrebbe vissuto per due anni, due mesi e due giorni. Si insediò stabilmente nella nuova casa il 4 luglio e la scelta della data, il giorno della Dichiarazione d’Indipendenza, non fu casuale in quanto, con l’abbandono della civiltà e della vita sociale organizzata, realizzava quella che era effettivamente la sua massima aspirazione: divenire indipendente. L’esperienza del lago Walden ispirò la scrittura di Walden, ovvero La vita nei boschi (1854), un’opera a metà strada tra il saggio filosofico e il diario che oggi viene unanimemente considerata tra i classici della letteratura americana. Malgrado abbia trascorso una buon parte della sua esistenza in solitudine, Thoreau fu un attento osservatore, conoscitore e critico della società americana a lui contemporanea e dedicò numerosi scritti a svariati problemi sociali, primo fra tutti quello della schiavitù. Insieme al Walden, lo scritto più famoso è infatti senza dubbio Disobbedienza civile, un opuscolo pubblicato nel 1849 nel quale viene teorizzata l’idea dell’opposizione non violenta che tanto seguito avrebbe avuto nel secolo successivo. Morì alle nove di mattina del 6 maggio 1862, di tubercolosi, dopo circa un anno di sofferenze fisiche. Sentendosi avvicinare la fine, consolò la madre, la sorella e gli amici con queste parole:
“È meglio che le cose finiscano… Sì, questo è un bel mondo, ma fra poco ne vedrò uno ancor più bello“.
Alla zia, che gli chiedeva se si era messo in pace con Dio, rispose:
“Non mi sembra di averci mai litigato“.
Rifiutò ogni “religiosità” fino alla fine, sentendosi perfettamente in pace con se stesso e con l’infinito e quando, sul letto di morte, qualcuno gli domandò se già poteva vedere “l’altra sponda” rispose: “Un mondo alla volta“. Tra le sue opere postume bisogna ricordare Le escursioni (1863), I boschi del Maine (1864), e Un americano in Canada. Scritti antischiavisti e riformatori (1866).
Gli Stati Uniti d’America tra il 1790 e il 1850: contesto storico e culturale
Tra il 1861 e il 1865, il processo di espansione verso occidente, l’aggravarsi del problema della schiavitù e del differente sviluppo tra regioni del nord e del sud condussero gli stati nordamericani alla guerra civile. Dal punto di vista dell’ indipendenza culturale dall’Inghilterra, non si resero evidenti in questo periodo particolari progressi: la lingua parlata era l’inglese, i libri inglesi, pubblicati dagli editori nordamericani in assenza di leggi protettive, inondavano il mercato e gli scrittori britannici romantici (W. Scott, Coleridge, Wordsworth) esercitavano un fortissimo condizionamento su tutta la letteratura. Nella prima metà del XIX secolo tuttavia, nell’ambito della produzione poetica e narrativa, si giunse alla definizione di elementi caratteristici ed autonomi se non rispetto ai modelli anglosassoni, almeno rispetto ai prodotti specifici. Su questa linea si collocarono Charles B. Brown, Washington Irving , James F. Cooper, e soprattutto Edgar A. Poe. Il primo a tentare la creazione di una nuova letteratura che rispecchiasse gli orizzonti fisici e le atmosfere psicologiche del Nuovo Mondo fu proprio Charles B. Brown che riprese i moduli e i meccanismi narrativi del romanzo nero inglese e diede inizio, in questo senso, ad una tradizione specificamente nordamericana. Nell’ambito della poesia, il maggior esponente, nel periodo a cavallo degli anni della guerra civile, fu Walt Whitman. Tra il 1850 e il 1855 la produzione letteraria negli Stati Uniti raggiunse un ottimo livello. Gli autori, provenienti in gran parte dal New England e dallo stato di New York, esprimevano speranza ed angoscia, desiderio di affermazione del nuovo e dubbi tormentati nei confronti delle origini. I temi affrontati facevano riferimento al rapporto tra gli abitanti nordamericani e la loro terra continentale, ai problemi della natura e della sopravvivenza fisica, dello stato selvaggio e della civilizzazione. A partire dal rigorismo calvinista del Settecento, che vedeva dappertutto segni di Dio, si sviluppò nell’Ottocento l’unitarianismo, un movimento che credeva in un Dio benevolo e favorevole a lasciare l’uomo libero di fare affidamento sulle proprie facoltà interpretative e la cui idea centrale era rappresentata dalla dottrina dell’apertura mentale, in virtù della quale tale movimento perseguì un progressivo, ma radicale affrancamento dall’atteggiamento religioso tradizionale.
Da questo movimento nacque il trascendentalismo, che propugnò l’abolizione della religione puramente formale e riconobbe la possibilità del singolo, lasciato nella solitudine delle proprie percezioni, di raggiungere e conquistare un più alto senso della natura.
Il trascendentalismo
Il movimento trascendentalista era caratterizzato da una sorta di ottimismo metafisico che conduceva a cogliere nella natura solo gli aspetti positivi, posizione questa che, pur non potendo essere condivisa da alcuni autori importanti come Melville ed Emily Dickinson, fu comunque in grado di arricchire l’espressività artistica della corrispondenza simbolica fra visibile ed invisibile, fra materiale e immateriale.
Il trascendentalismo si ispira a Swedenborg, a Goethe, all’idealismo tedesco ed è in polemica con la concezione dell’empirismo di Locke e con le pulsioni utilitariste ed affaristiche della giovane società americana.
Il principale teorico del trascendentalismo fu Ralph Waldo Emerson, a lungo nume tutelare della cultura del New England, di cui egli parlò in termini di “nuova Inghilterra totale”, e personalità in grado di esercitare un’enorme influenza su tutto l’ambiente intellettuale americano della sua epoca. Egli esortò i nordamericani ad operare un distacco dall’Europa per stabilire un rapporto autonomo ed originale con il “nuovo mondo”, per confidare nelle proprie potenzialità artistiche ed estetiche e per scrivere ignorando i modelli; scrisse inoltre poesie e saggi da cui traspare l’immagine quasi mistica di un flusso cosmico che si nasconde ed anima la realtà.
Alla base della visione dell’uomo che Emerson propone c’è una concezione idealistica della conoscenza:
“Ciò che chiamano trascendentalismo non è che l’idealismo: l’idealismo quale appare oggi, nel 1842….E’ ben noto al mio pubblico che l’idealismo odierno ha tratto il nome di «trascendentale» dall’uso del termine fattone da Emanuele Kant di Koenigsberg, il quale replicava alla filosofia scettica di Locke, secondo la quale non c’era nulla nell’intelletto che non fosse prima nell’esperienza dei sensi, dimostrando che c’era una classe assai importante di idee o di forme imperative che non derivano in nessun modo dall’esperienza, ma attraverso le quali l’esperienza veniva acquisita; che queste erano intuizioni dello spirito; ed egli le chiamò forme trascendentali.” ( The Transcendentalist, 1842 )
“La metafisica di Kant, il misticismo di Jacobi, il soggettivismo idealistico di Fichte, il trascendentalismo di Schleiermacher – il nuovo vangelo del rinascente spirito germanico – queste furon le vivide acque della verità per gli assetati intellettuali del New England” (Ibid.)
Proprio perché il trascendentalismo fu essenzialmente una fede, i trascendentalisti si tennero a una certa distanza dalle maglie troppo strette della logica e metafisica, preferendo essere poeti, profeti e mistici. Emerson, a questo proposito, riesce ad essere molto esplicito:
“La mia è una certa fugace esperienza che mi ha sorpreso per strada o al mercato, in qualche posto, in qualche momento – nel corpo o fuori del corpo, lo sa Iddio -, rendendomi conscio di aver per tutto questo tempo fatto la parte di un folle tra i folli, ma che la legge esisteva per me e per tutti; che mi spetta la fiducia, la fiducia e l’obbedienza di un fanciullo, e l’adorazione delle idee, e che non dovrò mai più esser folle” ( ibid.).
Le esperienze e le riflessioni di questo movimento sono quindi piuttosto lontane dall’essere filosofiche in senso stretto e ciò è confermato dal queste affermazioni:
“Se non hai bisogno di udire il mio pensiero, perché sai leggerlo sul mio viso e nel mio comportamento, allora te lo esporrò dall’alba al tramonto. Se non sai indovinarlo, non comprenderesti ciò che dico” (ibid.).
In una società in cui le tradizioni sono scarse e recenti, Emerson esalta il presente e l’autosufficienza di senso della vita immediatamente vissuta: la vita, a suo avviso, è estasi e l’attimo è un miracolo. Queste sue profonde convinzioni lo porteranno ad essere molto vicino alla concezione della vita come “luce interiore” propria dei Quaccheri. Particolare importanza assume nel pensiero di Emerson la poesia, che egli concepisce come manifestazione della purezza cristallina della mente e come mezzo in grado di attingere dall’essenza della realtà:
“…e la fresca bellezza di questa nuova poesia, l’enorme stimolo di quella nuova metafisica, accese in loro il desiderio di cercare ispirazione alla loro fonte e bere dalle loro linfe vitali. Così scopersero la Germania romantica, dove il nuovo idealismo aveva scalzato la filosofia sensista, e dove una grande scuola di pensatori trascendentalisti dominava trionfalmente il campo. Fu una scoperta profondamente stimolante, e ad essa risale la nascita del trascendentalismo del New England” (Ibid., p. 478).
Il poeta, secondo Emerson, è in grado di mutare il mondo in cristallo e ciò cui il vero poeta attinge è la semplicità originaria, entità in grado di suscitare autentica energia creativa. Egli ritiene che il poeta grande non sia quello che si serve di artifici, ma colui che è capace di rapportarsi ed esprimere la semplicità originaria, manifestazione della “verità del mondo”. In virtù proprio della possibilità di attingere a tale semplicità originaria e in virtù di una concezione che, per il fatto di porre un’essenziale correlazione e corrispondenza fra l’uomo come microcosmo con l’universo come macrocosmo, è assimilabile alla visione platonica della realtà, Emerson ama la Natura, in quanto corrispettivo sensibile dello spirito. La civiltà, complicata e tortuosa, è decadenza e il tempo della città è scandito da segnali funesti, mentre in natura lo scorrere delle ore e del tempo è segnato dai ritmi naturali e dalla crescita della gioia che si alimenta di se stessa. Dio pretende, secondo Emerson, che il poeta abbandoni la vita molteplice e confusa e accetti di fondersi totalmente nella natura, che pur avendo perso nel New England, dopo due secoli di colonizzazione, molta della sua originalità, non è stata ancora addomesticata dalla civiltà. Si tratta quindi di una Natura che non è più quella idilliaca dell’Arcadia, ma che mantiene tuttavia la sua solitaria ed incantata imponenza e una misteriosa quanto avvincente estraneità per l’uomo. Le relazioni sociali, con i loro tortuosi artifici, indeboliscono o cancellano la possibilità di comprendere la pienezza perfetta dell’essere che questa Natura offre e si colgono in questo gli echi del pensiero di Rousseau e del Romanticismo europeo; in questo senso si osserva un perfetto accordo fra lo spirito religioso puritano e quello di ispirazione illuminista e preromantica, in quanto entrambi richiamano alla solitudine e al raccoglimento, lontano dal caos effimero della quotidianità, ed invitano a rivolgere lo sguardo alla Natura, in quanto manifestazione più prossima dell’Eterno.
Il pensiero di Thoreau
Thoreau si inserisce a pieno titolo nel ristretto ambito di artisti e scrittori protagonisti del cosiddetto “Rinascimento americano”. Ma, a differenza degli altri esponenti di questa “corrente”, i già citati R.W. Emerson, W. Withman, N. Hawthorne ed H. Melville, Thoreau fece della sua “coerenza” una vera e propria poetica se non una filosofia di vita. Egli rifiutò una accezione della filosofia di carattere puramente intellettualistico, anche se il suo pensiero si andò organizzando intorno ad alcune idee chiave, in particolare:
– scrivere dando voce alla natura e alla storia che in essa si incide
– scrivere come gesto vivo
– scrivere come vigoroso atto d’amore verso la realtà e come espressione di una totale esigenza di realtà
e su questi principi verrà costruita, nei decenni successivi, una parte considerevole della moderna letteratura americana.
Tacciato di un certo egocentrismo venato di aristocratico disprezzo, Thoreau, in realtà, soprattutto in Walden (o Vita nei boschi), cercò di proporre uno stile di vita che presupponeva drastici interventi, in forza dei quali chiunque, al termine della propria esistenza, avrebbe raggiunto la consapevolezza di non aver sprecato la propria vita. La “ricetta” di Thoreau presupponeva la disponibilità del singolo a vivere con saggezza per affrontare solo i fatti essenziali della vita, a vivere felicemente in modo spartano, tanto da distruggere tutto ciò che non fosse vita, e a ridurre la vita stessa ai suoi termini più semplici. Thoreau lanciava questi forti messaggi, che risultavano quindi essere fortemente provocatori, nel bel mezzo dell’ascesa tecnologico-consumistica degli Stati Uniti e dell’emergere del tipico “way of life” americano, di cui egli fu forse uno tra i primi e più decisi critici. L’isolamento in cui condusse la maggior parte della sua esistenza gli consentì di sviluppare un discorso in chiave ampiamente introspettiva e di approfondire idee e concetti che sono divenuti punto di riferimento ideale per generazioni di ecologisti, pacifisti ed anticonformisti che al “credo” del filosofo, alla sua prosa sonora e talvolta enfatica, hanno riconosciuto la dignità di una formale promessa di riscatto. A questa particolare figura di intellettuale impegnato viene pertanto riconosciuta una modernità ed un’attualità che i suoi contemporanei non potevano percepire per obiettivi motivi di prospettiva storica. Quella di Thoreau è una personalità originale ed estrosa, caratteri che si rispecchiano nella sua ampia produzione letteraria, in cui, come filo conduttore comune, Thoreau invita i suoi lettori con i toni profetici a contrapporre alla macchina della civiltà l’ascolto e la cura della propria dimensione interiore e a celebrare un matrimonio con la natura fondato sull’allargamento della visione del mondo e delle prospettive e non sul possesso. Percorse le contee americane tenendo veri e propri sermoni laici che nel loro insieme costituiscono un vero e proprio classico del pensiero americano. Il tipico stile “anti-letterario” dei trascendentalisti americani è mitigato in Thoreau da una leggerezza esuberante ed arguta, da un umorismo tagliente ed una concreta aderenza alle cose, non disgiunta da un profondo lirismo. Nelle sue opere, Thoreau indica nella prassi del vagabondaggio e nell’impulso migratorio il rimedio all’ansia che la modernità e il progresso finiscono per generare. Ciò cui tali concetti sembrano ricollegarsi immediatamente è l’idea totalmente americana della frontiera; lo stesso Thoreau, in molti dei suoi scritti, associa una visione mitica del West alla terra del domani, della nuova vita, luogo di organica unità, di speranza e di progresso, di libertà e di indipendenza. Da tale mito della frontiera Thoreau prese le distanze nel momento in cui andò articolando, in Civil Disobedience, una visione apocalittica del destino delle società americana che, nata ad Est e sviluppatasi verso Ovest, avrebbe trovato il suo declino sulle rive dell’Oceano Pacifico. Nel corso dei suoi viaggi e delle sue peregrinazioni, Thoreau non perse l’occasione di osservare da vicino la natura con lo sguardo tipico dello studioso che cerca di apprendere; il suo approccio di tipo analitico prevedeva un’osservazione ravvicinata, ma il filosofo non disdegnava nelle sue escursioni l’osservazione della natura in modo più ampio e globale per cercare in essa la trama completa dell’intero tessuto naturale. Il suo atteggiamento nei confronti della natura è stato il punto di riferimento ideale della corrente “preservazionista” che ha permesso la nascita di quel forte movimento d’opinione che ha portato alla creazione dei grandi parchi nazionali americani.
Le opere
1- Civil Disobedience
Il saggio più famoso di Henry David Thoreau, comunemente noto come Civil Disobedience, in realtà non venne mai pubblicato dall’autore con questo titolo. Fu dato alle stampe per la prima volta nel 1849 con il nome di Resistance to Civil Government all’interno del libro Aesthetic Papers, curato ed edito da Elizabeth Peabody, ed esso altro non era che la trascrizione di una lezione, dal titolo The Rights and Duties of the Individual in Relation to Government, tenuta da Thoreau nel febbraio del ’48 davanti al Concord Lyceum. Questo testo polemico fu comunque rapidamente dimenticato e lo stesso Thoreau non lo ha mai citato. Fu Tolstoj che riusciì a leggerlo e invitò gli americani, in una lettera pubblicata dalla North American Review all’inizio del XX secolo, a recuperare l’atteggiamento coraggioso ed esemplare di un individuo che ha osato affrontare un governo che sbaglia. Mohandas K. Gandhi, ancora studente presso l’Università di Oxford, venne in possesso dello scritto per intercessione di Henry S. Salt, biografo di Thoreau; Gandhi ne rimase entusiasta e, una volta diventato avvocato, lo pubblicò nella sua rivista Indian Opinion, il 26 ottobre 1907; in seguito, e fino al giorno in cui verrà assassinato, nel 1948, non smetterà mai di raccomandare la disobbedienza civile, che associa alla pratica della non violenza. Soltanto dopo la morte di Thoreau il saggio fu ristampato col titolo di Civil Disobedience, con il quale è diventato poi famoso in tutto il mondo. Convinto antischiavista, Thoreau per tutta la vita scrisse e tenne conferenze contro la schiavitù, specialmente dopo l’approvazione nel 1850 della Fugitive Slave Law che obbligava gli ufficiali del Nord a catturare e restituire gli schiavi fuggiti dal Sud. Egli stesso aiutò alcuni fuggitivi e, in nome del rispetto dei diritti dell’uomo, criticò sempre duramente il fatto che una corte di tribunale potesse decidere in merito alla libertà o meno di un individuo. Thoreau condannò il governo statunitense non solo per l’ammissione dell’istituto della schiavitù, ma anche per l’impegno in una politica imperialistica di espansione, la cui diretta conseguenza fu la guerra col Messico. Per dissociarsi completamente da questi indirizzi politici e per non farsi coinvolgere in una qualsiasi forma di collaborazione con la condotta del governo, Thoreau rifiutò sempre categoricamente di pagare le tasse e per questo fu anche arrestato. Nel luglio 1846, infatti, proprio a Concord dove era nato, Thoreau incontrò Samuel Staples, un vigile comunale incaricato dell’esazione delle tasse, che offrì a Thoreau persino la possibilità di anticipare il denaro necessario per saldare il suo debito. Thoreau, che da quasi due anni viveva in una capanna nel cuore della foresta di Walden e che si trovava in quel momento in città per recuperare le scarpe dal calzolaio, di fronte a questa offerta rispose che, per principio, rifiutava di versare soldi ad uno Stato di cui disapprovava profondamente la politica e che non voleva in alcun modo che il proprio denaro risultasse essere un contributo a favore di un conflitto ingiusto, la guerra contro il Messico. Venne fermato e trascorse la notte in guardina, anche se una donna, probabilmente la zia Maria Thoreau, pagò le tasse in questione. Proprio per spiegare le ragioni del suo arresto e della sua condotta, Thoreau scrisse il saggio Civil Disobedience, che vede come tema centrale la priorità dei diritti di ogni individuo rispetto all’insieme delle leggi: in nome del rispetto della coscienza individuale, egli ammette esplicitamente il principio della disobbedienza, pienamente giustificata, a suo avviso, dal fatto che sono quelle stesse leggi che ammettono la schiavitù a calpestare la dignità dell’uomo. Appare evidente che una simile concezione implica la fiducia pressoché illimitata nelle capacità del singolo individuo di saper scegliere tra giusto e sbagliato e che un tale atteggiamento, che non riconosce valore alle idee espresse dalla maggioranza, ma che difende e tutela invece solo le idee di giustizia e moralità espresse dal singolo, può in effetti compromettere le possibilità di una comune convivenza democratica. Altro aspetto per cui le idee di Thoreau si sono imposte nel corso del ventesimo secolo è quello della condanna della violenza: a leggi o imposizioni ingiuste egli contrappone una sorta di resistenza passiva, il rifiuto cioè di compiere azioni o manifestare comportamenti che non si condividono e di sostenere un governo che vuole imporre, con la minaccia della detenzione, determinate azioni. Nel suo saggio Thoreau non fa mai riferimento a forme di protesta violenta e, soprattutto grazie a figure come Gandhi e Martin Luther King, che fecero della non violenza la linea guida della loro azione, oggi Disobbedienza civile è considerato una sorta di vademecum della protesta sociale pacifica, un saggio molto conosciuto e dibattuto soprattutto nell’epoca attuale, in un momento storico in cui le trasformazioni a livello politico, in Europa ma non solo, rendono di grande attualità il rapporto tra governanti e governati. Thoreau dà inizio alla trattazione con l’affermazione, pienamente condivisa, secondo la quale il governo migliore è quello che governa meno. Tale principio, se attuato, porta a suo avviso ad un’altra importante affermazione, quella secondo cui il miglior governo è quello che non governa affatto; quando gli uomini saranno pronti, sarà proprio questo il tipo di governo che dovranno darsi. Il governo è, secondo Thoreau, unicamente uno strumento, anche se, nella maggior parte dei casi, si tratta di uno strumento inutile. Molto discutibile è inoltre l’esistenza, in ogni stato, di un esercito permanente che, dal punto di vista dell’autore, altro non è che un braccio armato del governo. Quest’ultimo, che è la forma mediante la quale il popolo ha scelto di esercitare la propria volontà, è spesso colpevole di abusi e di deviazioni, di cui è prova lampante la guerra contro il Messico, portata avanti e condotta da un numero relativamente piccolo di individui che si servono del governo come di un proprio strumento per attuare un’impresa alla quale il popolo non avrebbe certamente dato il proprio consenso. Thoreau prosegue quindi con le sue accuse nei confronti del governo americano, colpevole a suo avviso di non possedere alcuna vera e reale vitalità, dal momento che non è mai stato in grado di portare a termine alcuna azione positiva, mentre al contrario ha mostrato grande alacrità e precisione nel venire meno ai propri compiti. Il governo, secondo Thoreau, non garantisce la libertà, non fornisce istruzione e non offre risorse ai cittadini, i quali quindi, senza gli ostacoli interposti dai governanti, potrebbero certamente condurre uno stile di vita migliore. Thoreau, tuttavia, a differenza di coloro che si dichiarano anarchici, non chiede l’abolizione del governo, ma aspira unicamente ad un governo migliore, espressione vera della volontà e delle esigenze dei cittadini. Dal suo punto di vista, il fatto che una maggioranza possa governare per un lungo periodo ininterrottamente non dipende dal fatto che questa operi in modo giusto, nel rispetto delle coscienze, ma dipende unicamente dall’uso della forza, esercitato per mezzo delle leggi. A suo avviso l’unico reale obbligo che può assumersi un individuo è quello di essere uomo, prima ancora di essere cittadino, e di agire pertanto come ritiene giusto. Nessuna legge, secondo Thoreau, ha mai reso gli uomini più giusti, anzi, al contrario, l’obbligo di rispettare le leggi ha reso gli onesti dei veri e propri agenti di ingiustizia; basti pensare che per legge vengono organizzati gli eserciti che portano avanti guerre contrarie al buon senso e ai valori perseguiti dalla maggior parte delle coscienze e ciò è sufficiente a farci comprendere che la massa degli uomini serve lo stato non come popolo dotato di coscienza civile, ma come macchine con i propri corpi. Nella maggior parte dei casi quindi, secondo Thoreau, nella vita di un cittadino non c’è spazio per il libero esercizio della facoltà di giudizio o del senso morale, prova ne è il fatto che sono comunemente ritenuti buoni cittadini coloro che servono lo stato come fantocci nelle mani del governo. Thoreau a questo punto si chiede come debba comportarsi un uomo nei confronti del gruppo di potere che governa lo stato. Sicuramente non deve farsi coinvolgere divenendo complice delle sue azioni; è poi pienamente riconosciuto e perseguibile il diritto all’insubordinazione, cioè al rifiuto dell’obbedienza e alla possibilità quindi di opporre resistenza nei confronti del governo stesso, quando la sua tirannia o la sua inefficienza divengano intollerabili. Tutto ciò, tuttavia, per poter essere attuato richiede che i tempi siano maturi e l’unica posizione sostenibile, a parere di molti, è seguire il criterio della convenienza: finchè l’interesse di una società lo richiede, fin tanto cioè che un governo in carica non può essere combattuto o rovesciato senza danno pubblico, è volere di Dio che a tale governo si presti obbedienza. In effetti però, secondo Thoreau, il principio della convenienza non può essere applicato nel caso in cui sia un intero popolo a dover fare giustizia; per seguire un paragone impiegato dall’autore nel testo, se abbiamo ingiustamente privato di un appiglio un uomo che sta per cadere in un baratro, dobbiamo restituirglielo, anche a costo di precipitare noi nel precipizio. Pertanto, secondo Thoreau, il popolo americano del suo tempo deve cessare di riconoscere la schiavitù e di condurre una guerra ingiusta contro il Messico, anche se ciò potrà costargli la sopravvivenza come popolo. L’opposizione esclusivamente teorica alle grandi ingiustizie sociali senza alcuna azione concreta per porvi fine è del tutto inutile, anzi dannosa e soprattutto di comodo; attendere che altri pongano rimedio al male, così da non doversene più rammaricare, limitandosi a dare il proprio voto a coloro che solo apparentemente promettono giustizia, è dal suo punto di vista inutile e moralmente riprovevole. Secondo Thoreau, quindi, un uomo veramente saggio sa bene che non potrà abolire la schiavitù con il proprio voto e tutti coloro che, pur disapprovando il carattere e i provvedimenti di un governo, continuano ad esprimere, mediante il voto, il proprio favore a politici che in effetti non agiranno in alcun modo, rappresentano i più seri ostacoli ad ogni possibile cambiamento. Thoreau si chiede quindi quale sia il corretto atteggiamento da adottare di fronte ad una legge ingiusta: obbedire in attesa di un cambiamento o trasgredirla per annullarla? Se l’ingiustizia è parte della macchina dello stato e se le leggi realizzano questa ingiustizia anche grazie alla nostra complicità, secondo Thoreau è nostro dovere infrangere le leggi stesse per non operare a favore di quello stesso male che condanniamo. Gli strumenti che lo Stato ha predisposto per porre rimedio al male rappresentano quindi, secondo l’autore, essi stessi il male: la Costituzione è il male, gli avvocati che perseguono il rispetto della legge rappresentano il male e pagare le tasse è male. Dal punto di vista di Thoreau, se mille individui decidessero di non pagare le tasse, ciò non rappresenterebbe una misura molto violenta, mentre veramente violento sarebbe pagarle e permettere allo Stato di commettere violenze e versare sangue innocente. Questo semplice gesto è un piccolo esempio di ciò che Thoreau definisce rivoluzione pacifica; dire di no in modo semplice, ma efficace alle richieste dello stato è l’unico modo per esprimere il nostro dissenso. L’autore analizza quindi la questione della proprietà e dell’accumulo di ricchezze. A suo avviso, coloro che sostengono e perseguono il diritto più puro, e sono conseguentemente i più pericolosi per lo Stato, non hanno dedicato molto tempo ad accumulare beni e proprietà, quindi il governo agisce ben poco a difesa dei loro interessi. L’uomo ricco, invece, divenuto tale anche grazie alla particolare tutela dello Stato, è sempre schiavo dell’istituzione che lo ha arricchito. In generale, più abbondano i soldi, minore è la virtù poiché il denaro si interpone fra l’uomo e gli oggetti; se si decidesse di vivere senza utilizzare denaro, lo Stato mai ne pretenderebbe da noi e mai noi avremmo bisogno della sua protezione. Thoreau prosegue sottolineando come l’unico luogo che il governo americano ha garantito agli spiriti più liberi e giusti sia il carcere, luogo emarginato, ma veramente indipendente dove lo Stato pone tutti coloro che non sono con lui, ma contro di lui, l’unica dimora in cui, in uno stato schiavista, un uomo libero possa abitare con onore. Non potendo agire nei confronti delle proprietà che queste persone non possiedono, lo Stato deve intervenire agendo sui loro “corpi” e limitando la libertà; nessun governo si confronta mai infatti con i sentimenti e i valori di un uomo, ma solo con il suo corpo e con i suoi sensi e non possiede intelligenza ed onestà superiori, ma solo superiore forza fisica. L’autore, inoltre, cerca di argomentare con maggiore precisione in che cosa consista effettivamente il rifiuto di pagare le tasse. Tale rifiuto non si concretizza nel non pagare alcuna tassa; le imposte per il mantenimento delle strade statali devono infatti essere corrisposte e ciò perché essere un buon vicino di casa è importante tanto quanto aspirare ad essere un cattivo cittadino e combattere contro lo stato. Dietro il rifiuto di pagare le tasse si cela, da parte dell’autore, la speranza di poter conoscere effettivamente il percorso del denaro per evitare che con questo sia possibile comperare la libertà di un uomo o acquistare armi con cui uccidere altri uomini. In definitiva, Thoreau dichiara guerra allo Stato in un modo tutto personale, anche se cerca di trarre dallo Stato stesso i vantaggi che gli sono possibili. Se altre persone, afferma, decidono di pagare le tasse al posto suo, per pura solidarietà nei confronti dello Stato stesso o nei confronti della sua persona, non fanno altro che rendersi complici di un’ingiustizia. Thoreau nelle sue accuse non risparmia nemmeno gli statisti e i legislatori, i quali, per il fatto di essere così coinvolti con le istituzioni, effettivamente non le rispettano: la verità degli avvocati e degli statisti non è effettiva verità poiché questa è sempre in armonia con se stessa e non si prefigge mai in nessun modo lo scopo di mostrare come la giustizia può accordarsi con il perseguire il male. L’autorità di governo, conclude Thoreau, anche nel momento in cui si comprende che essa è in grado di operare meglio di quanto noi stessi non siamo in grado di fare, è comunque impura: per essere veramente giusta deve avere il consenso e l’approvazione dei governati e non può avere diritti assoluti sulla nostra persona e sulla nostra proprietà al di là di quelli che noi concediamo. Il passaggio da una monarchia costituzionale ad una democrazia deve essere contrassegnato da un progresso dal punto di vista del rispetto dell’individuo e non vi sarà mai uno stato realmente libero ed illuminato finchè lo Stato non riuscirà a considerare l’individuo come la forma d’autorità più elevata, da cui lo Stato stesso deriva il suo potere. L’idea di Stato a cui pensa Thoreau è quindi uno stato in grado di essere giusto con tutti gli uomini e di trattare l’individuo con il massimo rispetto, uno stato inoltre che non consideri in contrasto con la propria tranquillità il fatto che alcuni vivano in disparte, senza intromettersi nei suoi affari e senza lasciarsi da questi sopraffare. Uno governo in grado di dare questo genere di frutti preparerebbe la strada, secondo Thoreau, ad uno Stato ancor più perfetto e glorioso, che si può immaginare, ma che ancora in nessun luogo è stato possibile realizzare.
2 – Walden, ovvero La vita nei boschi
Walden è il resoconto di due anni di vita solitaria che Henry Thoreau trascorse nella campagna del Massachusetts fra il luglio del 1845 e il settembre del 1847, ma è anche il testo da cui, oltre un secolo dopo, prenderanno le mosse i movimenti ecologisti e ambientalisti di mezzo mondo. Si tratta di un semplice diario che unisce la descrizione della vita quotidiana, fatti di suoni, rumori e odori, all’esperienza interiore, ma è anche, per contrasto, una riflessione sull’economia, sulla politica, sulla democrazia, sugli Stati Uniti, che in quegli anni si vanno affermando come potenza. Tra le pagine di questo libro, in cui viene rappresentata la semplicità della vita fra i boschi, si scopre anche perché Thoreau è l’autore cui si ispireranno Gandhi e le controculture contemporanee, che lo rileggeranno e lo rielaboreranno, criticandolo sì, ma assumendolo come punto di partenza.
L’aggettivo più adatto ad esprimere un giudizio su Walden è pertanto attuale: la ricerca di uno stile di vita sostenibile, il dialogo con le filosofie orientali, il rapporto paritario con la Natura, la critica al lavoro e alla società dell’abbondanza sono temi di cui si dibatte sicuramente più oggi di quanto non avvenisse nel momento storico in cui il libro è stato scritto, ed è per questo che le soluzioni elaborate dall’autore oggi ci fanno sorridere e non appaiono più tanto originali.
L’aspetto sicuramente più interessante, oltre alla fluidità della prosa e ai frequenti mutamenti di registro, è dato dal fatto che Thoreau, in questo scritto, ha delineato un metodo, che integra in modo nuovo ed inedito tre differenti strategie molto distanti fra loro, la spinta verso il compimento di scelte autonome e consapevoli, lo humor e il
contatto con la natura.
Relativamente al primo aspetto ciò che Thoreau propone non è tanto un modello da seguire; egli stesso infatti afferma:
“Io non vorrei che nessuno adottasse il mio modo di vita […]; perché […] desidero che ci sia al mondo il maggior numero possibile di persone diverse; ma renderei ciascuno molto attento a scoprire e perseguire il suo modo.”
Thoreau quindi sembra puntare sulle potenzialità del singolo individuo e ciò fondamentalmente per due motivi: in primo luogo per una questione metodologica, poiché la conquista della consapevolezza, se non vuole ridursi a pura consuetudine, deve necessariamente avvenire attraverso un percorso personale ed individuale di ricerca; secondariamente per una questione di carattere pratico, poiché chi viaggia da solo può partire in qualsiasi momento, mentre chi va con un altro deve aspettare che questo sia pronto. Ciò che però traspare dalla lettura del Walden non è solo che ogni individuo viene esortato ad affermare la propria autonomia e a compiere il proprio cammino, ma anche che la scelta di operare un taglio con la civiltà è frutto di un preciso bisogno. Thoreau, in definitiva, non si rivolge alle persone soddisfatte e contente di lavorare e di vivere in società, ma lancia i suoi appelli unicamente a coloro che sentono il bisogno di una nuova vita e che per questo sono più pronti ad accoglierla. I meglio preparati a “perdere il mondo per ritrovare se stessi” sono infatti coloro che, in quel mondo, hanno ben poco da guadagnare e la loro ricerca, anche se, come già detto, è frutto di un percorso individuale, nasce tanto da pulsioni intime quanto da esigenze concrete condivise.
L’uomo, secondo Thoreau, che non è in grado con i propri mezzi di conciliare spirito e materia, solo nel contatto con la Natura può sperimentare una parvenza di unità ed imparare così a riprodurla e ciò perché nella Natura c’è un elemento che coinvolge spirito e materia allo stesso modo, una sorta di sintesi tra i due opposti. Questa sintesi è rappresentata dal “selvatico”, dal contatto puro con la natura, che serve, secondo Thoreau per essere testimoni della trasgressione dei nostri stessi limiti. Una massiccia esposizione al “selvatico” riesce a rieducare l’individuo e a riportarlo in grado di sentire la vita, che è un continuo fermento e brulichio di cuore e stomaco: se il cuore batte in ciascuno di noi ad un ritmo diverso, lo stomaco è più o meno lo stesso per tutti e rappresenta l’elemento in grado di annullare i rischi dell’individualismo.
Il Walden, che ad un’analisi superficiale appare lontano da noi nel tempo e nello spazio, si rivela invece in grado di parlare perfettamente al nostro presente per mezzo del suo protagonista, lo stesso Thoreau, che, pur essendo voce di una nazione che comincia a lasciare, nel bene e nel male, il suo segno indelebile nella storia, è anche il motivo ispiratore di tutte le istanze più libertarie e democratiche in America e nel mondo.
Alcuni aforismi
§ C’è un solo tipo di successo: quello di fare della propria vita ciò che si desidera.
§ Il massimo che posso fare per un amico è di essere semplicemente suo amico. Non ho ricchezza da donargli. Se lui sa che sono felice nel volergli bene, non vorrà altra ricompensa. Non è divina in ciò l’amicizia?
§ La bontà è l’unico investimento che non fallisce mai.
§ L’opinione pubblica è un tiranno assai debole paragonata alla nostra opinione personale. Ciò che determina il fato di un uomo è l’opinione che egli ha di sé stesso.
§ L’uomo che viaggia solo può partire oggi; ma chi viaggia in compagnia deve aspettare che l’altro sia pronto.
§ Non c’è odore tanto cattivo quanto quello che si leva dalla bontà corrotta.
§ Non esiste rimedio all’amore se non amare di più.
§ Non ho mai trovato il compagno che mi facesse così buona compagnia come la solitudine.
§ Non parlerei così tanto di me stesso se conoscessi qualcun altro così bene.
§ Se uno avanza fiducioso in direzione dei suoi sogni, e si sforza di vivere la propria vita come l’ha immaginata, incontrerà un successo inatteso in situazioni normali.
§ Vai con fiducia nella direzione dei tuoi sogni. Vivi la vita che hai immaginato.
AUGUSTIN THIERRY

A cura di Andrea Edoardo Paron
Vita e opere
Augustin Thierry nasce a Blois nel 1795, in piena età repubblicana, in una famiglia di ferventi cattolici, tanto che il piccolo Augustin viene fatto battezzare clandestinamente. Dopo i primi studi condotti sotto la direzione del padre, uomo di profonda cultura, Thierry entra nel 1804 nel collegio di Blois. Nel 1811 entra all’Ecole Normale di Parigi dove incontra illustri professori del tempo e si mette in luce per una forte propensione verso gli studi umanistici a parte la storia, proprio la disciplina su cui fonderà la sua fortuna di intellettuale. Il vero punto di svolta nella vita di Thierry avviene nel 1814, anno in cui diventa segretario di Saint-Simon, insieme al quale pubblica, già nel ’14, il testo De la réorganisation de la société européenne, a causa del quale viene sospeso dal suo ruolo di insegnante che nel frattempo aveva svolto. La collaborazione con Saint-Simon prosegue con grande intensità e produttività, tanto che escono nel giro di due anni altri testi, come il pamphlet Opinion sur les mésures à prendre contre la coalition del 1815 e il contributo significativo all’Industrie intitolato Des nations et de leurs rapports mutuels; ce qu’il sont aujourd’hui; et quels principes de conduite en derivent. Nel 1817, per motivi mai chiariti, s’interrompe bruscamente la collaborazione con il filosofo francese, forse per la svolta organicista che Saint-Simon stava dando alla sua teoria industrialistica. Thierry inizia allora una importante collaborazione con il Censeur européen, diretto da Charles Comte e Charles Dunoyer. Il contesto del Censeur è calzante per le teorie di Thierry, dato che sviluppa in senso liberista le stesse teorie dell’Industrie sansimoniana. Gli articoli di Thierry riguardano letteratura, filosofia, politica, anche se un articolo in particolare, intitolato Vue des révolutions d’Angleterre, lascia intravedere l’inizio di un nuovo interesse culturale, che marcherà profondamente il pensiero di Thierry, la storia. E difatti l’anno seguente, soppresso il Censeur e iniziata una collaborazione con il Courrier français, Thierry inizia a scrivere esclusivamente di storia, pubblicando in particolare le Lettres sur l’Histoire de France. L’ambiente del Courrier lo mette a stretto contatto l’entourage di La Fayette, con il quale partecipa alle agitazioni politiche del 1821-22. Nello stesso tempo Thierry comincia l’intenso lavoro di ricerca che darà vita all’Histoire de la conquête d’Angleterre. L’intellettuale francese diventa anche punto di riferimento di importanti intellettuali europei: è nella sua casa che infatti s’incontrano Manzoni, Guizot, Cousin, Thiers e molti altri. Nell’aprile del 1825 pubblica l’Histoire de la conquête d’Angleterre che ha un immediato successo di critica e di pubblico. Una malattia agli occhi lo induce ad accettare l’invito di Claude Fauriel per un soggiorno a Montpellier. L’anno successivo ritorna a Parigi, dove, insieme al fratello, concepisce il vasto piano di una “Histoire de France”, in cui ogni secolo sarebbe stato raccontato attraverso i documenti originali. Solo il fratello, però, porterà a compimento la parte di Augustin. In forti difficoltà economiche, completamente cieco e paralizzato agli arti inferiori, nell’ottobre del 1828 lavora alla terza edizione dell’Histoire de la conquête d’Angleterre, che uscirà solo nel ’30. Segue nel frattempo da lontano gli avvenimenti politici ed esulta alla rivoluzione di Luglio, che porta al potere molti suoi amici. Viene eletto all’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. L’anno seguente è a Vesoul, al seguito del fratello nominato prefetto della regione. Qui conosce Julie de Quérengal che sposa nel corso dello stesso anno. A partire dal 1833 pubblica le Lettres sur l’Histoire de France e nel ’35, ristabilitosi a Parigi, gli viene affidata la direzione della sezione incaricata di raccogliere i monumenti inediti della storia del Terzo stato nell’ambito del comitato per la Collection de documents inédits sur l’histoire del France. Nel frattempo è nominato bibliotecario del Duca d’Orléans e, malgrado l’infermità sempre più grave, affronta un periodo di intenso lavoro,con vaste e importanti pubblicazioni. Nel ’44 muore la moglie e si trasferisce nella residenza della principessa Belgioioso di cui era da tempo grande amico. Prosegue nel lavoro di ricerca per i Monuments inédits de l’Histoire du Tiers Etat, che, per varie ragioni, tra le quali una profonda crisi che investe la sua visione politica e storica dovuta alla rivoluzione del 1848, decide di lasciare interrotto al 1715, trasformandolo sostanzialmente nella introduzione al primo volume del Recueil des monuments inédits de l’Histoire du Tiers Etat, che esce nel 1850. Escono ancora il secondo e il terzo volume nel ’53 e nel ’56. Lascia incompleto il quarto e ultimo volume a causa della morte sopraggiunta il 22 maggio del 1856.
Il saggio del 1817 Des nations di Augustin Thierry (Blois 1795-Parigi, 1856), attraverso categorizzazioni concettuali e paragoni storici, tenta di definire le caratteristiche della nazione nella modernità, analizzandone acutamente gli aspetti e abbozzandone gli sviluppi futuri. Il saggio in questione rientra in una serie di scritti che Thierry elabora per Saint-Simon, nel periodo in cui lavorava come suo segretario. Lo scritto infatti fa parte di un’opera più ampia, L’industrie, di Saint-Simon appunto, nella quale il filosofo francese esalta il neonato sistema industriale che sconfigge le tendenze retrograde della politica europea di quegli anni e preannuncia l’ascesa politica delle classi produttrici. Des nations si inserisce pienamente in tale progetto e, utilizzando un punto di vista storico-politico, cerca di dimostrare come tale stravolgimento economico e politico non è un ideale utopistico, bensì un naturale evolversi del progresso dell’umanità. Thierry, in sostanza, analizza il rapporto tra nazione e sistema produttivo, dapprima basato sulle guerre e sul protezionismo, infine, nella modernità, sull’industria e il commercio. Protagonisti di questa evoluzione sono gli uomini che guidano le nazioni con loro princìpi, guerreschi e aristocratici nell’antichità, economico-produttivi e borghesi nella modernità
1. Sul concetto di nazione
Il concetto di nazione, secondo Thierry, è sinonimo a quello di società e corrisponde a «une portion de l’espèce humaine unie pour la poursuite d’un même objet, et par la volonté de le poursuivre»1. La nazione, in sostanza, non è altro che un raggruppamento di individui accomunati dalla volontà di raggiungere lo stesso o gli stessi obiettivi, proprio come nella formazione delle prime società di cacciatori e raccoglitori, dove l’esigenza di unire gli sforzi per sopravvivere costringeva gli uomini a vivere in comunità. Società e nazione sono sinonimi perché hanno le stesse cause nella loro genesi. A tale argomento oggettivo a fondamento della società e della nazione, Thierry aggiunge un aspetto soggettivo, insito nella natura dell’uomo: «il y a des animaux qu’un penchant naturel porte à vivre en troupes; l’homme est de ce nombre»2. Lungi però dall’essere due elementi che all’unisono spingono l’uomo a radunarsi in società, l’istinto naturale a legarsi e l’esigenza di perseguire obiettivi comuni, danno luogo a due atteggiamenti contrari l’uno con l’altro: l’istinto porta l’uomo a essere passivo nei confronti degli altri e a subire ordini e suggestioni; mentre la ricerca di un risultato comune spinge gli individui a essere attivi gli uni con gli altri nel tentativo di migliorare sempre più la propria condizione3. Secondo Thierry, dunque, il nostro istinto ci porta a non rimanere isolati e a rapportarci con gli altri, ma è l’interesse comune il vero motore di crescita e miglioramento della società. L’interesse comune non è altro che un oggetto su cui tutti gli individui operano insieme per ottenere quello che sembra essere un interesse per tutti. Non sempre gli interessi o un unico interesse sono duraturi, anzi, come nel caso delle guerre persiane, in cui i greci furono coalizzati finché il pericolo era presente, spesse volte le nazioni e le coalizioni durano fino a quando l’oggetto persiste, per poi in seguito sparire del tutto4.
La tesi secondo cui una nazione si fonda su un determinato interesse che raggruppa una serie di individui sta a fondamento della visione che un membro di una nazione ha di quegli individui che non ne fanno parte, cioè degli stranieri. Storicamente, osserva Thierry, lo straniero ha via via assunto i caratteri di una preda da mangiare e spogliare, di un uomo che si può maltrattare e uccidere senza scrupoli e, soltanto nell’età moderna, di un individuo che, a determinate condizioni può essere partecipe dei miei stessi interessi e dei miei stessi obiettivi5. L’idea di straniero si è dunque sottoposta a un progressivo processo di sbarbarimento che ha portato l’uomo a considerare colui che è diverso in un’ottica sempre più civile, grazie soprattutto, secondo Thierry, all’intervento dei lumi nel XVIII secolo e dalla forza delle leggi fondate sulla razionalità. Tuttavia, argomenta lo storico francese, si è ancora lontani da una visione universale della figura dello straniero, ed esistono differenze profonde all’interno di una stessa nazione, a seconda della condizione sociale. Gli uomini colti infatti, quelli cioè che partecipano del progresso della ragione, considerano lo straniero come membro della sua stessa società, nel senso che partecipa della libertà e del benessere collettivo. Stessa considerazione anche da parte dell’uomo di mondo, il quale, desiderando ospitare persone di pari grado ed essere ospitato con gli stesi agi di casa propria, considera lo straniero come un individuo che persegue i suoi stessi obiettivi di prosperità e ricchezza. Il popolo invece, proprio per la sua ignoranza e per la sua istintività, non essendo ancora stato illuminato dalla ragione, considera lo straniero come un essere cattivo, come colui che sconfina dal proprio territorio per derubare e impoverire gli altri6.
Traspare da queste argomentazioni l’idea di un progressivo e costante miglioramento degli uomini sia nell’organizzare sé stessi in società libere ed eguali, sia una civilizzazione dei costumi, attraverso il massiccio intervento della razionalità nel regolare gli istinti e le passioni. Si tratta di un’idea di fondo che caratterizza anche il processo di trasformazione dell’idea di nazione così come si è configurata storicamente. Le società antiche infatti nascevano sull’interesse comune di difendersi da un pericolo minaccioso, di procacciarsi determinate derrate alimentari, di conquistare e depredare altri popoli per arricchirsi, in sostanza quello di garantire il bene di ciascuno. Il processo di civilizzazione, che secondo Thierry «simplifie les intérêts sociaux, elle les étend sur un plus grand nombre d’hommes; elle agrandit les sociétés»7, ha fatto sì che il benessere individuale e collettivo non derivasse più da un’azione verso l’esterno della società, ma verso il suo interno, nel favorire cioè la libertà di ciascuno e con ciò il suo benessere. Il ricercare la libertà individuale, osserva Thierry, va oltre l’appartenenza a una comunità e apre una prospettiva universale: «le jour que tout le genre humain sera convaincu que le seul but de l’union sociale, que le seul objet des hommes ressamblés est le plus grand bonheur de chacun en particulier, ce jour là, il n’y aura qu’une nation: cette nation se sera tout le genre humain»8.
Il processo di civilizzazione non vede tutto il genere umano avanzare di pari passo, ma, come nella concezione dello straniero gli uomini colti sono più avanti del popolo, così alcune nazioni sono avanguardia nel riconoscere nella libertà il motore del progresso, mentre altri ancora soccombono all’impulsività e alla passionalità dei sentimenti patriottici. Sono queste nazioni all’avanguardia che devono guidare le altre verso il vero obiettivo comune, la libertà e il benessere, così come devono essere gli uomini colti e illuminati dalla ragione a guidare e a educare il popolo, e non come avviene nella maggior parte dei casi, dove è il popolo a detenere il potere. Emerge qui una visione elitaria della politica, dove solo un gruppo ristretto di persone, proprio perché conosce i veri obiettivi da raggiungere, può detenere il potere, e, allo stesso modo, solo alcune nazioni hanno la facoltà di guidare le altre verso il cammino della libertà e della prosperità. La nazione deve essere guidata da coloro che pensano, giudicano e sentono l’accordo con l’interesse di tutti9.
Il processo di civilizzazione si lega inevitabilmente a quello di progresso dell’uomo che Thierry focalizza essenzialmente in due stadi: 1) lo stadio primitivo, in cui l’uomo «a beaucoup a démêler avec les hommes e peu avec les choses»10, un’età, cioè, dove gli uomini si riuniscono solo per procurarsi il necessario; 2) lo stadio del calcolo e dell’arricchimento, dove «avec une plus grande capacité d’observation et de jugement, l’homme se met plus en relation avec les choses, et, à mesure qu’il fait plus d’attention à elles, il sent moins et calcule davantage»11, dove le relazioni tra gli uomini sono meno brusche e il sentimento di odio e amore nei confronti degli altri è modificato dall’oggetto di interesse. Il passaggio dal primo al secondo stadio, secondo Thierry, si afferma nel XII secolo, quando inizia a prevalere, soprattutto grazie alla nascita dei comuni cittadini in tutta Europa, la volontà di arricchirsi al proprio interno con attività produttive e commerciali, anziché attraverso i bottini di guerra e le conquiste12. Le nazioni antiche erano essenzialmente militari e la guerra era l’industria che produceva ricchezze. Con il XII secolo si apre una nuova fase, in cui l’industria diventa parte attiva all’interno delle nazioni.
L’intervento dei lumi e la nascita della modernità ha segnato per Thierry un ulteriore sviluppo verso l’arricchimento dei popoli e la diminuzione delle guerre. Nel tentativo di esplicitare meglio tale ragionamento, Thierry paragona le nazioni antiche come a un insieme di soldati, quelle successive al XII secolo come a un insieme di mercanti, quelle contemporanee come a un insieme di ricchi negozianti13.
2. Sui rapporti tra nazioni
Dopo aver definito i caratteri della nazione e il suo sviluppo storico, Thierry analizza quali debbano essere i rapporti tra nazioni, a partire da un’analisi storica di eventi antichi e recenti. Thierry riassume l’essenza dei rapporti internazionali secondo questo schema: «détruire pour ne point être détruit, conquérir pour ne point être conquis, voilà les relations des peuples»14. Per lungo tempo, infatti, gli Stati, per garantire la loro sopravvivenza, erano costretti ad aggredire gli altri, generando uno stato di tensione continua. L’esempio più eloquente è la lotta tra Roma e Cartagine, dove, non essendo praticabile la via della cooperazione, perché impensabile per quei tempi, la salvezza e l’affermazione economico-politica doveva passare attraverso la distruzione di uno o dell’altro. Nell’antichità, infatti, il sentimento patriottico era molto forte, perché, osserva Thierry, ai propri confini si vedeva la povertà e la schiavitù e si tendeva a esaltare le virtù della propria patria per scongiurare l’avvento di miseria e cattività15.
In tale contesto la religione assume un ruolo molto importante. Il paganesimo, identificando le divinità come dei della patria, non faceva che esaltare il sentimento di appartenenza a una nazione e la volontà di difenderla ad ogni costo. Il cristianesimo invece, canonizzando l’esistenza di un unico Dio per tutti gli uomini e predicando sentimenti come l’amore per il prossimo, connazionale o straniero, e la fraternità universale, tentava, almeno all’inizio e su basi sentimentali, di superare le divergenze nazionali e unire tutti gli uomini attorno allo stesso interesse, cioè la ricerca del bene e dell’amore. Il cristianesimo però, secondo Thierry, ha fallito lungo questa strada, perché non è riuscito a trasformare il sentimento di fraternità in qualcosa di pratico, in un oggetto cioè che potesse coalizzare tutti gli uomini a lavorare per esso16. La fraternità, in sostanza, era rimasta solo a livello spirituale e teorico, senza tradursi in qualcosa che interessasse realmente gli individui e li spronasse ad agire all’unisono: «c’est par la multiplication des besoins et des travaux divers que la fraternité des hommes peut devenir un objet de pratique. […] L’intérêt d’union, c’est l’ intérêt des jouissances de la vie; le moyen d’union, c’est le travail»17. La vera società cristiana è quella in cui tutti producono per il bene di tutti. Il sentimento di fraternità diventa così il lavoro, mezzo per produrre i beni che mancano e che contribuiscono al benessere della collettività. Per realizzare realmente un sentimento costante di fraternità tra i popoli, cioè una pace duratura, non occorre creare una coalizione di nazioni cristiane, che anzi ha storicamente dimostrato solo la sua crudeltà, ma un’alleanza tra nazioni produttive e industriose, in grado di garantire ricchezza e prosperità per tutti, disinnescando rivalità e atti vendicativi tra nazioni. Thierry, in sostanza, attraverso il riferimento alla religione cristiana vuole sostenere che il tentativo di accomunare i popoli attraverso sentimenti particolari o determinati valori ha sempre fallito, perché hanno prevalso gli interessi particolari, e l’unica strada percorribile è quella di accomunare tutti i paesi nello sviluppo economico e commerciale, i quali, dovendo sussistere in contesti pacifici, permettono di vanificare possibili guerre.
Il tema del rapporto tra nazioni pone il problema di definire quali debbano essere le linee guida di uno Stato, al suo interno e all’esterno. Thierry sostiene che come un individuo deve conformare la propria condotta in base a dei principi, così devono fare anche le nazioni e i principi di una nazione sono stabiliti dalla sua organizzazione sociale e a questo si deve rapportare tutta la sua politica18. Attraverso tale lente è possibile individuare all’interno del continente europeo tre stati, la Francia, l’Inghilterra e l’Olanda, le cui organizzazioni sociali sono similari e perciò anche i loro principi ispiratori. Francia, Inghilterra e Olanda possiedono una strutturazione sociale che ha per oggetto la libertà e l’industria, e sono questi due elementi a determinare la loro condotta. «La liberté comme l’industrie chez les modernes», secondo Thierry, «ne peut donc subsister que par la paix»19, l’industria per prosperare e vivere in un contesto di libero commercio, la libertà per sopravvivere, poiché nei periodi bellici le libertà civili vengono soppresse. Un popolo industrioso, così come un popolo libero, per poter perpetrare il suo status, deve esportare i suoi valori e guidare le altre nazioni ad unirsi per raggiungere gli stessi obiettivi. Nel caso europeo, Francia, Inghilterra e Olanda devono aiutare le altre tre grandi nazioni, l’Italia, la Germania e la Spagna a trovare nell’industria e nella libertà il loro oggetto, principalmente attraverso l’esportazione del pensiero illuminato20. Da questa coalizione potrà nascere, sostiene Thierry, un’unica entità statale europea, prospera e libera.
Non si tratta di una prospettiva politica da auspicare o utopica, ma che emerge da una serie di considerazioni, anche di carattere storico. Alcuni stati europei infatti, se non addirittura l’Europa intera, hanno accantonato da tempo l’isolamento nazionalistico, tendendo sempre più a costituirsi come sistema politico, attraverso rapporti regolati e trattati internazionali. Il primo tentativo è stato fornito proprio dalla religione, in particolare dal cristianesimo, che ha cercato di dare vita a un sistema cattolico, dove la volontà di Roma si potesse diffondere su tutta l’Europa. L’avvento della Riforma e la conseguente scissione del mondo cristiano europeo ha infranto il fragile equilibrio religioso che si era creato intorno al potere papale e a determinati valori sentimentali. Non furono però soltanto motivi dottrinali a infrangere il sistema cattolico, ma anche l’interesse politico, fissato nei risultati della rivoluzione francese, che esalta le libertà civili e l’industria nazionale. Tutte le nazioni guidate dall’interesse politico, cioè dalla volontà di progredire nell’ambito della libertà e della prosperità economica, contribuiranno a creare un sistema politico europeo e a mantenere rapporti reciproci duraturi e pacifici21.
3. Sui valori di una nazione
Tra gli elementi che devono contraddistinguere uno Stato moderno vi è senza dubbio la ricchezza nazionale. Più volte Thierry ha sostenuto come l’affermazione delle libertà civili sia strettamente legata alla prosperità economica e come tali inscindibili valori siano le guide per lo sviluppo e di una nazione o di una coalizione. La ricchezza, secondo lo storico francese, si produce dal capitale e dal lavoro prodotto sul capitale e una società è tanto più ricca in proporzione dei suoi capitali22. Il reddito nazionale è suddiviso tra tutti i cittadini e la parte di ciascuno corrisponde al reddito personale. Il capitale, come si è detto, da solo non basta a produrre ricchezze, occorre che a esso si agganci un grande sistema produttivo, in cui tutti i membri di una società siano parte attiva. Per sistema industriale o industria, Thierry non intende solo la nascente forma di produzione meccanizzata e seriale, ma vi identifica l’attività produttiva in generale, a prescindere da quali siano i metodi di produzione. L’industria è l’insieme di tutti coloro che lavorano, commerciano, producono, comprano e vendono, di tutte quelle attività che permettono un arricchimento personale e, dunque, nazionale.
Riguardo al rapporto tra guida o governo di una nazione e sistema economico, Thierry si presenta come un liberista, affermando non solo che, per esempio, il prezzo delle merci si fissa da solo, ma anche che il commercio è come un corpo naturale che si sviluppa da solo e per una forma interna, e che i monopoli sono dannosi sia per questioni di concorrenza interni, sia per problemi di carattere internazionale.
Il tema della ricchezza nazionale ripone con forza quello della libertà, cui va sempre di pari passo. Secondo Thierry, l’uomo domanda all’uomo semplicemente la libertà di disporre dei suoi beni, delle sue braccia, del suo ingegno, preludendo ad una massima morale che dovrebbe stare a fondamento di tutte le nazioni veramente libere: «fais chacun aussi libre que tu veux l’être; voilà toute la morale»23.
Il valore di una nazione non si dimostra però semplicemente con la sua ricchezza, ma anche con una forza morale che consente a un popolo con pochi mezzi (economici) di conseguire grandi risultati. In passato tale forza morale si dimostrava con i costumi guerrieri e con l’amor patrio, ma oggi, nel progressivo avvicinarsi a uno stato di pace, anche la virtù dell’industria e dell’operosità e della difesa della propria ricchezza sono altrettanto validi. La forza morale infatti non è altro che fiducia nelle proprie forze, sia per l’uomo guerriero, sia per l’uomo produttivo. Tra le due figure, quella del soldato e quella dell’uomo industrioso, esistono però delle forti divergenze. Innanzi tutto l’uomo operoso possiede un sentimento di consapevolezza di essere utile agli altri. In secondo luogo il soldato ha due motivazioni forti per il suo lavoro, il desiderio di conquista e la libertà, mentre l’industrioso ha solo la libertà. «Je suis fort, dit le guerrier; partout les hommes tremblent à mon nom: je suis fort, dit l’industrieux; partout le hommes embrassent mon intérêt»24. Tali distinzioni hanno una valenza certamente politica nell’affermazione o meno di una nazione sulle altre. Secondo Thierry infatti, tra i popoli guerrieri quello industrioso vale di meno, viceversa tra i popoli industriosi quello guerriero non vale nulla. A partire dal Medio Evo e dalla rivoluzione del XII secolo, hanno sempre prevalso le nazioni produttive e ancora oggi, scrive Thierry, il valore di una nazione non si deve più misurare nelle conquiste militari compiute, ma su quelle economiche, tecniche, scientifiche, sociali, civili, liberali. Gli stati dell’antichità infatti vedevano nell’arricchimento il nemico dei costumi guerrieri e il deperimento di un popolo. Oggi, invece, gli Stati tengono molto di più a disfarsi dello spirito guerriero perché foriero di cattività e distruzione, cioè i nemici della prosperità economica.
Sebbene al progressivo arricchimento delle nazioni e dei popoli debba conseguire la cessazione delle ostilità tra gli Stati, a tutt’oggi, in un regime di stati moderni, costituzionali e liberali, di guerre ce ne sono ancora moltissime. Il motivo va ricercato nel fatto che i popoli non sempre si muovono motu proprio, cioè verso un progressivo miglioramento dei rapporti internazionali, ma spesso si trovano a dover eseguire gli ordini di governanti, che, anziché assecondare il naturale progresso della civiltà, soggiacciono agli impeti soggettivi e a interessi particolari25. Il governo ideale è quello ben definito da Millar, il commercial governement, un governo cioè di regime costituzionale, liberale, fondato sull’industria, attento quindi all’economia e al suo sviluppo in senso produttivo. Quei governi che ancora mantengono le proprie truppe all’interno dei loro Stati, non fanno altro che perpetrare, dice Thierry, una forma moderna di schiavitù, quella dei militari, che vivono sotto l’arbitrato di un superiore in una nazione dove tutti sottostanno alla legge26.
Strettamente connesso al valore di una nazione è l’onore cui un popolo tiene. Nell’antichità l’onore corrispondeva con la forza fisica e dunque con la potenza militare. Oggi l’onorabilità coincide con la forza morale, che deve aiutare tutti i membri di una società a perfezionare le capacità produttive, nell’espandere l’applicabilità delle scienze e nel moltiplicare i piaceri. Allo stesso modo, la fortuna di una nazione sta nello sviluppare l’industria, garantendo a tutti i membri di una società l’operosità e l’aumento delle ricchezze.
4. Il progresso e i suoi strumenti: libertà e industria
Il tema della modernità nel saggio di Thierry è legato a un profondo ottimismo nel progresso dell’umanità. La storia dell’uomo dimostra un progressivo passaggio da un’età in cui l’istinto e i sentimenti dominano i comportamenti degli individui a un momento nel quale la ragione prende finalmente il sopravvento. Des nations infatti, per lo meno nelle sue argomentazioni storiche, si basa su una continua contrapposizione tra antichità e modernità, che corrispondono a grandi linee la prima al periodo greco-romano, la seconda al periodo post rivoluzione francese27. Tra le due epoche sembra esserci un arco temporale nel quale si possono intravedere aspetti sia dell’antichità sia della modernità, in un continuo processo di affermazione e negazione, che trova compimento solo nella rivoluzione illuministica del ‘700. Nonostante il periodo burrascoso o poco identificabile tra l’antichità e la modernità, Thierry conserva l’idea di un progresso lineare che ha nell’industria il suo motore interno. Soltanto in apparenza, infatti, lo storico francese sembra porre la libertà e l’industria come due valori equivalenti e reciproci nel progresso dell’umanità. In realtà non è difficile notare la continua preferenza verso la tesi secondo cui soltanto attraverso l’industria, cioè in ultima analisi il lavoro e la produzione di ricchezza, l’uomo può veramente emancipare sé stesso; soltanto attraverso il miglioramento delle condizioni economiche si può parlare di civilizzazione; soltanto attraverso un arricchimento sempre più diffuso si può parlare di progresso dell’umanità.
Se dunque a un livello superficiale Thierry identifica il contrasto tra antichità e modernità attraverso una scala assiologia che vede da una parte l’istinto e dall’altra la ragione, in realtà è la rivoluzione industriale e il massiccio intervento delle scienze e delle tecniche, cioè della razionalità, nella catena produttiva a costituire il vero discrimine tra il mondo antico e il mondo moderno. Il ragionamento sotteso a tale tesi è semplice e logico. Anche se non molto aderente alla realtà: l’applicazione delle scienze nel sistema produttivo ha permesso a molte società di creare maggiori ricchezze e a una sempre più ampia parte di popolazione di accedere a un numero più elevato di beni, facendo sì che il benessere diffuso avesse potenziato il progresso civile. L’uomo arricchito infatti, volendo mantenere la propria condizione è illuminato dalla ragione che gli consiglia di cooperare piuttosto che lottare con gli altri.
L’intervento dei lumi nel regolare i rapporti tra i membri di una società o tra nazioni diverse attraverso leggi e trattati non è sufficiente a garantire il progresso, perché rimarrebbero a livello concreto forti discrepanze tra gruppi di individui più o meno ricchi, determinando rivalità e odi profondi. Il progresso può essere garantito solo con l’intervento dei lumi nel sistema economico, che favorisce il passaggio da una concezione dell’arricchimento frutto di operazioni belliche a quello di uno sviluppo attraverso l’industria e il commercio.
Thierry fa più volte osservare come non è possibile che tutto il genere umano concorra a un tale cambiamento di visione economica, per la quale anzi ci vorrà del tempo, e vede nella crescente borghesia il ceto in grado di recepire il suggerimento dei lumi. La prospettiva dello scrittore francese è infatti quella di favorire non solo la crescita della borghesia dal punto di vista economico, ma soprattutto da quello politico. E’ la nuova borghesia industriale a essere titolata per governare, perché creatrice di ricchezze e quindi di benessere e libertà. Il passaggio alla modernità non si compie solo a livello economico-produttivo ma anche politico, con l’avvento al potere della borghesia industriale che sovverte l’antico sistema aristocratico e feudale fondato sui valori guerreschi, e guida il popolo verso il riscatto e il benessere.
Da tali considerazioni emerge un’immagine della modernità legata fortemente al fenomeno industriale, alla classe borghese, al liberismo economico, al liberalismo politico, antitetica a un’idea di antichità sinonimo di schiavitù, guerra, aristocrazia.
Resta da comprendere perché Thierry assegni all’Europa dei suoi anni (1817, piena restaurazione) l’epoca della modernità, proprio nel momento in cui le monarchie del Vecchio Continente tentano un disperato ripristino degli antichi poteri, scompaginati dalla rivoluzione del 1789 e dalle guerre napoleoniche. Il motivo sta molto probabilmente nel fatto che l’approdo nella modernità è ancora lontano da venire dal punto di vista politico, in virtù anche degli avvenimenti di quegli anni, ma è inarrestabile la trasformazione economica in atto, che porterà prima o poi la borghesia industriale ad affermarsi politicamente. Il traino verso la modernità si risolve sempre nel sistema economico, che precede i cambiamenti politici e li accompagna nelle trasformazioni, secondo un moto inarrestabile perché ingovernabile e troppo allettante per l’appetito umano, intimamente portato a migliorare costantemente la propria condizione economica e, dunque, civile.
1.A. Thierry, Des nations et de leurs rapports mutuels, in H. de Saint-Simon, L’Industrie, t. I, parte seconda, ora in Saint-Simon, Oeuvres, t. I, Paris, Anthropos, 1966, pp.19-127. Qui pp. 21-22.
2. Ivi, p. 19.
3. Cfr. ivi, p. 21.
4. Cfr. ivi p.22.
5. Cfr. ivi, pp. 28-30.
6. Cfr. ivi, pp. 32-33.
7. Ivi, pp. 24-25.
8. Ivi, p. 25.
9. Cfr. ivi, p. 34.
10. Ivi, p. 34.
11. Ivi, p. 35.
12. Cfr. ivi, p. 38.
13. Cfr. ivi, p. 42.
14. Ivi p. 52.
15. Ivi, p. 48.
16. Cfr. ivi, p. 49.
17. Ivi, p. 50.
18. Cfr. ivi, p. 53.
19. Ivi, p. 56.
20. Cfr. ivi, pp. 56-58.
21. Cfr. ivi, pp. 63-68.
22. Cfr. ivi, pp. 68.
23. Ivi, p. 81.
24. Ivi, p. 93.
25. Ivi, p. 107.
26. Cfr. ivi,p. 116.
27. Occorre tenere presente che Thierry è principalmente uno storico e tale è spesso l’approccio con tematiche culturali o filosofiche, come quella della modernità: l’analisi è sempre improntata su una assidua frequentazione di quegli avvenimenti che paiono significativi per la definizione moderna di nazione e società.
CARLO CAFIERO

Carlo Cafiero (Barletta, 1 settembre 1846 – Nocera Inferiore, 17 luglio 1892) è stato il più importante discepolo italiano dell’anarchismo di Bakunin nella seconda metà dell’Ottocento. Fu il primo divulgatore del Capitale di Marx in Italia nel 1879, oltre che amico sincero di Bakunin per alcuni anni. Nacque da una ricca famiglia di borghesia terriera, fu avviato alla carriera diplomatica che però abbandonò presto. Nel 1870 conobbe personalmente, a Londra, Karl Marx e Friedrich Engels; e nel 1871 cooperò alla diffusione della Prima Internazionale in Italia. Successivamente si allontanò dal marximo, di cui comunque non disconobbe mai la grandezza e l’importanza, divenne uno dei maggiori esponenti del comunismo anarchico ispirato da Bakunin (di cui fu in seguito il principale finanziatore), collaborò ai fogli socialisti del tempo (“La Campana” di Napoli, ecc.) e partecipò ai tentativi insurrezionali di Bologna (1874) e del Matese (1877). Arrestato più volte in Italia e in Svizzera per via della sua fervida attività insurrezionale, fu colpito da una grave malattia nervosa che portò al suo internamento in un manicomio (1883). Nel 1879 aveva pubblicato un compendio del primo volume del Capitale di Marx, che ha goduto di larga diffusione: in questo compendio, egli prende in esame i principali snodi dell’opera marxiana, analizzandoli con rigore e – senza per questo rinnegare il suo anarchismo – dimostrandone la veridicità. Va ricordato che, tra il 1871 e il 1872, Engels confidò molto in Cafiero per contrapporre un vero socialista ai seguaci di Bakunin, che stavano spadroneggiando nel napoletano, tanto che, descrivendo la situazione a Napoli, all’inizio del 1872, ad un suo corrispondente, sosteneva – riferendosi a Cafiero – che, “vi erano tutti bakuninisti, e vi è soltanto uno, fra loro, che è per lo meno di buona volontà, ed è con me in corrispondenza”. Cafiero non ha elaborato un pensiero organico e sistematico che, prendendo le mosse da una visione complessiva della realtà, giunga a proporre una riforma della società che sia in grado di porre termine alle ingiustizie e ai soprusi di cui ci dà notizia la storia. Per questo motivo, illustrando a Engels il suo atteggiamento politico-filosofico, non fu in grado di andare al di là di una generica professione di razionalismo:
“per me, non so se vi siate accorto, io non sono che un razionalista materialista; ma il mio materialismo, socialismo, rivoluzionarismo, anarchismo, e tutto ciò che lo sviluppo continuo del pensiero ci potrà dare in avvenire e che sarà da me razionalmente accettato, non possono essere per me che delle modalità eminentemente soggettive allo sviluppo razionale: sono e sarò razionalista, ecco tutto”.
Il suo scritto più originale, Anarchia e comunismo del 1880, muove dalla convinzione che la rivoluzione sia una legge che regola la storia dell’umanità e che rende possibile il progresso dei popoli nel corso del tempo: “la rivoluzione è causa ed effetto di ogni progresso umano, è la condizione di vita, la legge naturale dell’umanità: arrestarla è un crimine; ristabilire il suo corso è un dovere umano”. Non è difficile scorgere in questa affermazione, un’eco marxiana. Cafiero era convinto che la società borghese dell’Ottocento fosse profondamente ammalata e che per essa non vi fosse speranza di guarigione se non attraverso una rivoluzione, della cui necessità il proletariato cominciava a rendersi conto, come gli scioperi, le manifestazioni di protesta e le rivolte sempre più frequenti in tutti gli stati europei dimostravano eloquentemente. La mèta a cui bisogna tendere è la libertà, che non può consistere nel semplice riconoscimento dei diritti borghesi, incapaci di incidere sulle condizioni di vita dei lavoratori e di soddisfare le loro esigenze più importanti; la via a cui ricorrere per liberare l’umanità da ogni catena è la rivoluzione violenta. Fin qui, egli concorda con Marx ed Engels. Per questo motivo, Cafiero è contrario al socialismo ufficiale che persegue il proprio disegno nel rispetto pieno della legalità, attraverso una via evoluzionistica (l’attuazione graduale di una politica di riforme a vantaggio del proletariato), e giudica il passaggio di Andrea Costa nel 1881 dall’anarchismo al socialismo e all’azione parlamentare un vero tradimento della causa del proletariato. Per Cafiero non c’è vera libertà senza l’anarchismo, come non può esserci effettiva uguaglianza tra gli uomini senza il comunismo. Infatti l’anarchia viene concepita come la condizione del libero sviluppo sia dell’individuo che della società e il comunismo viene considerato come riappropriazione, da parte dell’umanità nel suo complesso, di tutte le ricchezze della terra, delle quali era stata espropriata ad opera di una minoranza: anche qui l’influsso marxiano è fin troppo evidente. Il suo pensiero, per il quale accetta le definizioni di collettivismo e di comunismo, che considera sinonimi, ha sulla scia di Bakunin, un orientamento nettamente anti-individualistico:
“non solo si può essere comunisti; bisogna esserlo, a rischio di fallire lo scopo della rivoluzione una volta ci dicevamo “collettivisti” per distinguerci dagli individualisti e dai comunisti autoritari, ma in fondo eravamo semplicemente comunisti antiautoritari, e, dicendoci “collettivisti” pensavamo di esprimere in questo modo la nostra idea che tutto dev’essere messo in comune, senza fare differenze tra gli strumenti e i materiali di lavoro e i prodotti del lavoro collettivo…. Non si può essere anarchici senza essere comunisti. Dobbiamo essere comunisti, perché nel comunismo realizzeremo la vera uguaglianza. Dobbiamo essere comunisti perché il popolo, che non afferra i sofismi collettivisti, capisce perfettamente il comunismo. Dobbiamo essere comunisti, perché siamo anarchici, perché l’anarchia e il comunismo sono i due termini necessari della rivoluzione”.
Scrive ancora Cafiero a proposito dell’anarchia:
“Non solo l’ideale, ma la nostra pratica e la nostra morale rivoluzionaria sono eziandio contenute nell’anarchia; la quale viene così a formare il nostro tutto rivoluzionario. È per ciò che noi l’invochiamo come l’avvenimento completo e definitivo della rivoluzione; la rivoluzione per la rivoluzione”.
Cafiero è ottimista (di un ottimismo che sconfina nell’utopia) nel valutare la società che sorgerà nel futuro, dopo il successo della rivoluzione anarchica: le ricchezze e i beni a disposizione degli uomini per soddisfare i loro bisogni aumenteranno in quantità per noi inimmaginabile, perché saranno il prodotto spontaneo di lavoratori liberi, senza intermediari e privi di interessi egoistici o speculativi. Per questo sarà possibile, secondo la famosa formula usata da Marx nella Critica del programma di Gotha della socialdemocrazia tedesca, dare alla società secondo le proprie forze e ricevere a seconda dei propri bisogni, e non con un criterio meramente.
JOHANN GUSTAV DROYSEN

Johann Gustav Droysen nacque in Pomerania da Johann Christoph Droysen, un cappellano militare che aveva preso parte all’assedio di Kolberg del 1806-1807. Da bambino, Droysen, il cui padre era pastore a Greifenhagen, nei dintorni di Stettino, allora sotto il Primo Impero francese, assisté ad alcune operazioni militari durante la guerra della sesta coalizione. Queste prime esperienze giovanili gli indussero un ardente attaccamento al Regno di Prussia. Fu educato al ginnasio di Stettino e all’Università di Berlino. Nel 1829 divenne insegnante alla scuola francescana Graue Kloster (“Frati grigi”), una delle più antiche di Berlino a cui aggiunse le lezioni gratuite alla Friedrich-Wilhelms-Universität, dal 1833 come Privatdozent e, dal 1835, come professore. Furono anni in cui Droysen si dedicò agli studi classici. Pubblicò una traduzione di Eschilo e una parafrasi di Aristofane. Risale al 1833 la prima edizione berlinese del suo Geschichte Alexanders des Grossen, un testo fondamentale, a lungo il migliore sull’argomento. Il primo testo fu seguito da altri volumi sui successori di Alessandro, pubblicati sotto il titolo Geschichte des Hellenismus (Amburgo, 1836-1843). Una edizione rivisitata dell’intera opera fu pubblicata nel 1885. Droysen deve la sua celebrità universale alle sue rivoluzionarie ricerche sulla storia sociale e politica dell’età di Alessandro Magno e dei suoi successori, che ne fecero, in qualche modo, l’antesignano di un nuovo corso della storiografia tedesca, segnato, sotto l’influenza hegeliana, dall’idealizzazione del potere e del successo. Johann Gustav Droysen fu il primo ad attribuire all’ellenismo, termine peraltro da lui coniato, la funzione storica di mediazione tra il mondo antico e quello occidentale e cristiano. I suoi studi ebbero il merito di sollevare il velo su un’epoca storica e culturale fino ad allora trascurata dalla ricerca e su cui gli studiosi avevano spesso posato il loro occhio attraverso la lente deformante dei pregiudizi di matrice neoclassiciste. Politicamente fu fautore dello stato forte e dell’unificazione della Germania sotto la Prussia. I suoi scritti più importanti sono i seguenti: Geschichte Alexanders des Großen (1833), Geschichte des Hellenismus (2 voll., 1836–1843), Das Leben des Feldmarschalls Grafen Yorck von Wartenburg (3 voll., 1851-1852), Geschichte der preußischen Politik (14 voll., 1855–1886), Grundriß der Historik (1868). Al cuore della riflessione di Droysen sta il problema dell’ermeneutica storica. Allievo di Hegel e di Boeckh, fondò la “scuola prussiana” e contribuì all’unificazione tedesca sotto la Prussia. Ancorché incompiuta, la sua opera principale – Storia della politica prussiana, che giungeva sino al 1756 – offriva una grandissima base culturale – non esente da forzature – alla politica di potenza bismarckiana. Fin dalla giovinezza, come è noto, Droysen coltivò anche la passione per il mondo greco, a cui dedicò studi decisivi: essi trovarono la loro sistematizzazione nella monumentale Storia dell’ellenismo. Quest’opera è di fondamentale importanza non solo perché conia il termine (e il concetto) di “ellenismo”, ma anche perché propone una ricchissima ricostruzione delle vicende comprese tra la morte di Alessandro Magno (323 a. C.) alla battaglia di Azio (31 a. C.). Le idee che Droysen venne maturando in ambito di “ermeneutica storica” furono poi pubblicate sotto il titolo di Istorica. L’introduzione dell’opera si configura come una tematizzazione dell’analisi generale della storia, del metodo e del compito dello storico. La prima parte verte sui problemi di metodo; la seconda invece sviluppa considerazioni teoriche sull’uomo e il suo rapporto con quelle che Droysen chiama “potenze etiche” (successivamente chiamate da Dilthey, nella Introduzione alle scienze dello spirito, “sistemi di cultura”). Nella prima parte ci imbattiamo nella celeberrima distinzione delle quattro forme dell’interpretazione (pragmatica, delle condizioni, psicologica, delle idee) e nella non meno nota distinzione (e contrapposizione) tra le “scienze della natura” e le “scienze dello spirito”. Tale distinzione sarà determinante per il dibattito successivo ed eserciterà un influsso enorme sul dibattito successivo e sugli autori venuti dopo Droysen. Memore della lezione hegeliana, Droysen distingue attentamente tra “ricerca storica” e “speculazione sulla storia”. Tramite questa distinzione egli tematizza il compito proprio dello storico: egli non deve “speculare”; deve piuttosto “comprendere indagando” (forschend zu verstehen). L’attività dello storico deve in altri termini rimanere saldamente ancorata alle esperienze passate e alla loro ricostruzione, senza degenerare in astratte e vuote riflessioni sulla storia. In virtù della distinzione da lui operata tra scienze dello spirito e scienze della natura, Droysen riflette anche sullo statuto specifico delle prime, nel tentativo di adombrarne l’autonomia e di frenare lo sviluppo dilagante delle seconde. Le scienze storiche – spiega Droysen – non possono fare ricorso alla “spiegazione”, giacché essa spiega casualmente le cose riconducendo il successivo all’antecedente (B è stato causato da A). nella storia non ci interessa tanto questo nesso causale quanto piuttosto la possibilità di cogliere il presente nella sua immediatezza, nei suoi caratteri individuali. La storia non deve “spiegare”, bensì “comprendere” (verstehen). Tale distinzione, su cui si riduce in ultima istanza quella tra scienze dello spirito (che comprendono) e scienze della natura (che spiegano) verrà ripresa da Max Weber e godrà di grande fortuna. È in tale contrapposizione che si consuma la frattura tra i due ambiti disciplinari: frattura a rimanere aperta per molto tempo. Abbiamo già detto che Droysen distingue quattro forme di interpretazione. Vediamo in dettaglio quali sono: l’interpretazione pragmatica è quella che ricostruisce il fatto storico nella sua integrità muovendo da indizi, tracce, resti e rammenti. Droysen accosta tale forma di interpretazione al restauro di una statua rinvenuta in frammenti. In questo tipo di interpretazione giocano un ruolo decisivo le ipotesi, che permettono di progettare e controllare il modo in cui bisogna ricomporre i frammenti rinvenuti. La seconda forma di interpretazione – l’interpretazione delle condizioni – aspira a conoscere le condizioni, soprattutto di tempo e di luogo, sotto le quali gli eventi si sono verificati. Essa lavora sul materiale storico già disponibile. La terza – l’interpretazione psicologica – è quella tramite cui lo storico cerca di risalire al volere, alla personalità e al carattere dei personaggi storici indagati. Droysen inserisce qui le sue profonde considerazioni sulle grandi potenze storiche, le “comunità etiche”, che contribuiscono a determinare l’agire umano e il corso degli eventi. L’ultima forma di interpretazione – l’interpretazione delle idee – mira invece a cogliere il contenuto ideale delle opere umane. È la forma più alta di interpretazione. Tali idee, ad avviso di Droysen, sono sempre presenti nei fatti storici e ne garantiscono il significato. È proprio la presenza di tali idee, secondo Droysen, a permetterci di intendere la storia come progresso, dal momento che tramite quelle idee si attua un effettivo sviluppo delle comunità etiche. Anche Droysen resta dunque legato, come la maggior parte dei suoi contemporanei, alle due idee di “progresso” e di “storia in sé”, due idee interconnesse nella formula “progresso della storia”: secondo una nota espressione di Droysen, “al di sopra delle storie, c’è la storia”. E tale storia – il principale “singolare collettivo” (Reinhart Koselleck) del mondo moderno – avanza, per Droysen come per Condorcet, indefinitivamente verso il “meglio”.
JULES MICHELET

Jules Michelet (Parigi 1798 – Hyères 1874) è stato un importante storico francese. Fu direttore della sezione storica degli Archivi nazionali (1831), ebbe la cattedra di storia del Collège de France (1838). Le sue idee liberali gli procurarono l’allontanamento da entrambe le cariche. Per il romanticista Michelet la storia doveva essere «la resurrezione della vita integrale del passato», operata mediante il documento, il simbolo e la poesia, e rivissuta con appassionata e enfatica partecipazione. Scrisse una Storia di Francia (Histoire de France, 1833-1844 e 1855-1867) vista come lunga rivolta contro il dispotismo, e una Storia della rivoluzione (Histoire de la Révolution, 1847-1853). Tra le sue opere descrittive e poetiche sono L’uccello (L’oiseau, 1856), Il mare (La mer, 1861), La donna (La femme, 1860). Importanti le sue traduzioni, tra cui quella della Scienza nuova di Vico (Princì pi della filosofia della storia: così suona il titolo francese). Fu un intellettuale in cui agiva una forte sete di giustizia e princìpi democratici: Il popolo (Le peuple, 1846), e La Bibbia dell’umanità (La Bible de l’humanité, 1864) che è un’opera di largo respiro religioso e morale. Una delle caratteristiche di Michelet scrittore è l’uso di una prosa impetuosa, a tutti gli effetti romanticista. Esponente della scuola liberale, Michelet ebbe della storia una “visione totale”: la storia è politica ma anche religione, scienze, arti, letteratura, diritto, filosofia. Questa visione d’insieme dello svolgersi delle vicende umane permise allo studioso di conferire alla storia quell’ampiezza che non erano state in grado di darle né la storia razionalistica nella sua forma politica, né lo studio della civiltà ristretta all’azione di alcuni uomini, istituzioni o classi dominanti. La storia è storia di popoli, storia di nazioni come del resto venivano dimostrando gli avvenimenti politici contemporanei alla formazione culturale di Michelet, quando in Europa nascevano i movimenti nazionali in cui si dissolvevano l’idea e il progetto di una storia universale così come l’avevano ipotizzata i razionalisti. Michelet studiò Vico, ma anche i grandi eruditi tedeschi, lesse i testi antichi del diritto e ne apprese la storia. Da questa articolata formazione culturale egli trasse l’idea secondo cui l’essenza della storia è quel fluido della società che agisce su di essa mediante l’azione di un genio interiore che non sempre è possibile spiegare. Michelet era attratto dalla tesi del “genio del popolo”, che vedeva manifestarsi in tutta la sua forza nella storia della Francia. La storia universale era fatta dal contributo delle nazionalità e la Francia, grazie alla grande Rivoluzione, era la nazione eletta. Il 1789 offriva alla sua storia, e soltanto a essa, un valore esemplare, trasformando in universale tutto ciò che aveva in sé di particolare; era caratterizzata dal cristianesimo e dalla rivoluzione, al primo si legava la lunga monarchia per diritto divino, alla seconda la rinnovata tensione all’emancipazione e fratellanza tra gli uomini. Concluso nel 1843 il sesto volume della storia di Francia con il racconto del regno di Luigi XI, Michelet aveva appena avviato la parte relativa al regno di Carlo VIII quando, accantonando gli ultimi tre secoli della monarchia, incominciò a scrivere della Rivoluzione (Storia della Rivoluzione 1847-1853). A tale impegno dedicò un decennio scrivendo, in tono narrativo più che critico, degli avvenimenti succedutisi in Francia dalla convocazione degli Stati generali alla caduta di Robespierre, sette volumi apparsi tra il 1847 e il 1852. A questa decisione di scrivere la storia della rivoluzione prima di quella della sua origine contribuì il fatto che quello della rivoluzione era divenuto, negli anni Quaranta dell’Ottocento, un tema di grande attualità. Inizialmente Michelet decise di farne oggetto di studio al corso che teneva al Collège de france. Proprio nel momento in cui E. Quinet aveva scatenato la battaglia contro le pretese della chiesa di sottoporre a controllo l’università, egli dava alle sue lezioni un carattere meno erudito e più politico, entrando appieno nella questione religiosa e sottoponendo a critica e revisione il rapporto tra cristianesimo e democrazia moderna. Rifiutando l’idea di connessioni tra cristianesimo e Rivoluzione francese intervenne vigorosamente nella polemica prima con un saggio contro il clericalismo (Il prete, la donna e la famiglia, 1845, ed. it. 1850) e poi con Il popolo (1856, ed. it. 1989) in cui rielaborava l’idea della fratellanza universale, fondamentale eredità degli avvenimenti del 1789 e minacciata a destra e a sinistra dalla borghesia orleanista e dai socialisti assertori entrambi, sia pur in diversa prospettiva, della lotta di classe. A questi lavori fecero seguito i primi due volumi della storia della rivoluzione, o meglio secondo Michelet della storia della nazionalità francese di cui il 1789 era stato il messaggio. Della Rivoluzione Michelet considerava fondamentali gli esordi, in particolare il periodo che va dagli Stati generali alla Festa della federazione (14 luglio 1790). Ciò che celebrava nel 1789 era l’unità del popolo e della nazione nella riconquista della propria sovranità e nell’affermazione del diritto così come si era venuta esplicitando nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. La Rivoluzione, tuttavia, mantenne meno di quanto promesso. Nella costituzione civile del clero Michelet vedeva i primi segni del cedimento: in quel momento la rivoluzione aveva preteso di riformare il cristianesimo senza credere nel cristianesimo; egli poi detestava la degenerazione della rivoluzione in piccoli gruppi di intolleranti. Non amava la leggerezza dei girondini né il settarismo di Robespierre; condannava il colpo di mano antiparlamentare del 1793, l’assoggettamento del parlamento alla piazza. Nel Terrore vedeva il prodotto del fanatismo giacobino: nel 1793 i giacobini si erano sostituiti al popolo del 1789; dopo tre anni di rivoluzione la nota dominante era divenuta l’indifferenza pubblica, si era perduta l’originale spinta popolare. Michelet cessava di scrivere la sua storia al momento del crescere della reazione del Termidoro. Certamente quello della Rivoluzione è il tema più notevole dell’opera dello storico francese. Vari ne sono i motivi: perché a causa della sua formazione aveva preso contatti direttamente con essa attraverso testimoni oculari; perché era diventata il suo pensiero; perché era in grado di esprimere nella storia della Rivoluzione l’anima del popolo che l’aveva fatta con le sue speranze, le sue illusioni e anche i suoi errori. Nello scrivere Michelet è brillante, pittoresco, concreto (Storia di Francia e La strega); dal punto di vista metodologico la sua opera storiografica non è certo un modello ma, come scrisse G. Lefebvre (La storiografia moderna, 1971, ed. it. 1973) «è impossibile leggerlo senza amare la storia, anzi senza voler fare la storia; non è un maestro, perché le qualità per cui spicca sono qualità personali in modo stretto, in realtà non comunicabili».
BARTHOLD GEORG NIEBUHR

Barthold Georg Niebuhr (Copenaghen, 27 agosto 1776 – Bonn, 2 gennaio 1831) è stato uno storico e politico tedesco. Figlio di Carsten Niebuhr, nacque nella capitale danese Copenaghen. Dalla più giovane età Niebuhr manifestò una precocità straordinaria e dal 1794 al 1796, essendo già uno studioso di studi classici e conoscendo parecchie lingue moderne, studiò all’Università di Kiel. Dopo avere terminato l’università divenne segretario privato del conte Schimmelmann, ministro delle finanze danese. Ma nel 1798 lasciò questo impiego e viaggiò in Gran Bretagna, passò un anno ad Edimburgo a studiare agricoltura e scienza. Nel 1799 tornò in Danimarca entrò al servizio dello stato; nel 1800 si sposò e prese dimora a Copenhaghen. Nel 1804 divenne direttore capo della Banca nazionale, ma nel settembre del 1806 rinunciò per un incarico simile in Prussia. Arrivò in Prussia alla vigilia della catastrofe di Jena. Seguì il governo in fuga a Königsberg, dove rese un servizio considerevole nel commissariato e fu in seguito ancora più utile come commissario del debito pubblico e con la sua opposizione a schemi di tassazione che considerava folli. Fu anche per un breve periodo ministro prussiano nei Paesi Bassi, dove tentò senza successo di contrarre un prestito. L’estrema sensibilità del suo temperamento, tuttavia, lo allontanò dalla politica; era infatti impraticabile nei suoi rapporti con Hardenberg e con gli altri ministri e nel 1810 si ritirò per un certo tempo dalla vita pubblica, accettando l’incarico più congeniale di storiografo reale e professore all’Università Humboldt di Berlino.
Iniziò le sue lezioni con un corso sulla storia di Roma, che formò la base del suo lavoro più grande Römische Geschichte (Storia Romana). I primi due volumi, basati sulle sue lezioni, furono pubblicati nel 1812, ma ricevettero poca attenzione poiché tutti gli interessi erano attratti dagli eventi politici. Nel 1813 anche l’attenzione di Niebuhr fu spostata dalla storia verso la rivolta del popolo tedesco contro Napoleone; Niebuhr entrò nella Landwehr e cercò senza successo di ottenere un’ammissione nell’esercito regolare. Per un po’ di tempo fece l’editore di un giornale patriottico, il Prussian Correspondent, in seguito raggiunse il quartier generale dei sovrani alleati, fu presente alla battaglie di Bautzen ed in seguito fu impiegato in alcuni negoziati minori. Nel 1815 perse sia il padre che la moglie. In seguito (1816) accettò il posto di ambasciatore presso lo Stato Pontificio e nel viaggio verso Roma scoprì, nella biblioteca della cattedrale di Verona, le Istituzioni di Gaio che erano andate perse da molto tempo. Le istituzioni furono poi pubblicate da Savigny, cui aveva comunicato la scoperta nell’impressione di aver trovato dei testi di Ulpiano. Durante la sua residenza a Roma Niebuhr scoprì e pubblicò frammenti di Cicerone e di Livio, aiutò il Cardinale Mai nella sua edizione del De re publica di Cicerone e fu compartecipe nella preparazione del progetto di un grande lavoro, Beschreibung Roms (La descrizione di Roma), basato su una topografia di Roma antica di Christian Charles Josias Bunsen e Ernst Platner (1773-1855), progetto cui contribuì con parecchi capitoli. Durante un viaggio a casa dall’Italia decifrò anche, in un palinsesto conservato all’abbazia di San Gallo, frammenti di Merobaude, un poeta romano del V secolo. Nel 1823 si dimise dall’ambasciata e si stabilì all’università di Bonn, dove passò il resto della sua vita, con l’eccezione di alcune visite a Berlino come consigliere di stato. A Bonn riscrisse e ripubblicò (1827-1828) i primi due volumi della sua Storia romana e compose un terzo volume, portando l’esposizione fino alla conclusione della Prima guerra punica, che, con l’aiuto di un frammento scritto nel 1831, fu pubblicato dopo la sua morte (1832) da Johannes Classen. Inoltre collaborò all’edizione di August Bekker della storia dell’impero bizantino e pubblicò molte dispense sulla storia antica, etnografia, geografia e sulla Rivoluzione francese. Nel febbraio 1830 la sua casa andò distrutta da un incendio, ma la maggioranza dei suoi libri e manoscritti fu salvata. La rivoluzione di luglio dello stesso anno fu un colpo terribile per lui e lo riempì di foschi presagi sul futuro dell’Europa. La Storia romana di Niebuhr è nell’elenco delle storiografie che fanno epoca sia perché segnano un’era nello studio di soggetti speciali ma anche per l’influenza sulla concezione generale di storia. “Il risultato principale” dice Leonhard Schmitz, “raggiunto dalle ricerche di Niebuhr, come le sue opinioni sulla popolazione antica di Roma, l’origine della plebe, i rapporti fra patrizi ed plebei, la natura reale dell’ager publicus e di molti altri punti interessanti, sono stati accettati da tutti i suoi successori.” Altre presunte scoperte, come la costruzione dell’iniziale storia romana sulla base dei primi poemi tradizionali, non sono state ugualmente fortunate; ma anche se ogni conclusione di Niebuhr fosse stata confutata, la sua pretesa di essere considerato il primo ad essersi occupato della storia antica di Roma in uno spirito scientifico rimarrebbe indiscutibile ed i nuovi principi introdotti da lui nella ricerca storica non perderebbero niente della loro importanza. Ha suggerito, sebbene non la elaborasse, la teoria del mito, uno strumento così potente nella moderna critica storica. Introdotto l’inferenza e la deduzione per supplire alle carenze di tradizioni screditate ed ha mostrato la possibilità di scrittura della storia in assenza di fonti originali. Con la sua teoria sulle dispute fra patrizi ed i plebei che originavano da originali differenze etniche ha attirato l’attenzione sull’importanza immensa delle distinzioni etniche ed ha contribuito alla rinascita di queste divergenze come fattori nella storiografia moderna. Più di tutti, forse, poiché la sua concezione della storia romana antica ha reso le leggi ed le norme più comprensibili, ha influenzato involontariamente la storia popolarizzando quelle concezioni che ne sottolineano le istituzioni, le tendenze e le caratteristiche sociali.
THEODOR MOMMSEN

Christian Matthias Theodor Mommsen nacque a Garding [Holstein] nel 1817. Morì a Charlottenburg [Berlin] nel 1903. Fu filologo, storico, linguista, giurista, epigrafista, numismatico. La sua attività fu enorme, non si finirà mai di stupirsi della quantità di interessi che ebbe, e della poderosità della sua produzione di studioso. Mommsen fu docente in varie università, deputato liberale alla Camera prussiana e al Reichstag. Fece in tempo a ricevere persino il premio nobel per la letteratura, nel 1902, per la vivacità della narrazione soprattutto della sua Storia romana. Come studioso rinnovò gli studi storici divenendo ineludibile punto di riferimento, confronto per gli studiosi successivi, soprattutto per quanto riguarda il suo progetto di ricostruzione integrale della civiltà romana. Un migliaio i suoi titoli: Studi oschi (Oskischen Studien, 1845), Dialetti italici del sud (Die unteritalischen Dialekten, 1850), con cui fondò la dialettologia italica antica, Storia romana (Römische Geschichte, 1854-1856), Le province romane da Cesare a Diocleziano (Die Römischen Provinzen von Caesar bis Diokletian, 1884), Disegno di diritto pubblico romano (Römisches Staatsrecht, 1887-1888) che Mommsen considerava la cosa migliore da lui scritta dal punto di vista scientifico, Corpus delle iscrizioni latine (Corpus inscriptionum latinarum) con l’Ephemeris epigraphica. Mommsen curò diverse edizioni filologiche: i Digesta giustinianei, le opere di Solino, di Iordanes ecc. La Storia romana resta però il lavoro più famoso di Mommsen, un classico dei trattati di storia, comparve in tre volumi fra il 1854 e il 1856, esponendo la storia romana dalle origini alla fine della repubblica romana ed al governo di Cesare, che Mommsen ritrasse come uno dei maggiori statisti di tutti i tempi. Le vicende politiche, particolarmente della tarda repubblica, sono attentamente confrontate con gli sviluppi politici del diciannovesimo secolo. Mommsen non scrisse una continuazione della sua storia romana che comprendesse le vicende del periodo imperiale, ma alcune note prese durante le sue lezioni sull’impero romano sono state pubblicate nel 1992. Nel 1885 apparve una descrizione delle province romane nel periodo imperiale come quinto volume della sua Storia romana (Le province dell’impero romano da Cesare a Diocleziano ), sebbene non esistesse un quarto volume. All’inizio della sua carriera scientifica, Mommsen già prevedeva una collezione di tutte le iscrizioni latine antiche conosciute, quando pubblicò le iscrizioni del Reame di Napoli (1852). Egli ricevette ulteriore slancio da Bartolomeo Borghesi di San Marino. Il Corpus Inscriptionum Latinarum completo doveva essere costituito da 16 volumi, di cui 15 comparsi durante la vita di Mommsen, cinque curati da Mommsen stesso. Il principio di base dell’edizione (al contrario delle raccolte precedenti) fu il metodo dell’analisi (che in greco significa letteralmente “vedere per se stesso”), poiché tutte le iscrizioni esistenti furono esaminate e confrontate all’originale.

