NEOPLATONISMO
“Se l’uno è necessario all’esistenza di ciascuna essenza – non c’è infatti alcun essere che non sia uno – l’uno deve essere anteriore all’essenza e generare l’essenza” (Plotino, Enneadi)
AMMONIO SACCA

All’origine del Neoplatonismo incontriamo un enigma per molti versi raffrontabile a quello di Socrate. Esso è rappresentato dalla misteriosa figura di Ammonio Sacca, che del Neoplatonismo stesso può essere considerato il precursore, se non il vero e proprio fondatore. Secondo numerose testimonianze, il vertice della sua attività fu raggiunto durante il regno di Comodo, e dunque tra il 180 e il 192 d.C. Tuttavia di lui si ignora la patria di origine e oscuro rimane il vero significato del nome Sacca: banale risulta la spiegazione fornita dal vescovo Teodoreto, secondo cui Ammonio avrebbe inizialmente esercitato l’umile mestiere di portatore di sacchi, e fin troppo suggestive paiono quelle della critica moderna, per cui Ammonio sarebbe stato un membro della stirpe indiana dei Saker o addirittura un Sakka-Muni, ovvero un monaco buddista. Da Porfirio – che fu allievo di Plotino – apprendiamo che Ammonio fu da principio cristiano e che solo in età adulta abbracciò il paganesimo, mentre testimonianze sul suo pensiero ci sono giunte attraverso il neoplatonico Ierocle di Alessandria e il vescovo Nemesio, entrambi vissuti nel V secolo d.C., e giudicati anche per questa ragione poco attendibili da buona parte degli studiosi moderni. D’altra parte Ammonio – sulle orme di Socrate – non lasciò nulla di scritto, e come per gli elementi socratici presenti nella filosofia di Platone, anche in questo caso risulta alquanto arduo distinguere con precisione quanto del pensiero di Ammonio vi sia in quello del suo discepolo Plotino. Ierocle gli attribuisce una distinzione del cosmo su tre piani: quello superiore, che comprende Dio creatore, le entità celesti e gli altri dei; quello intermedio, costituito dalle nature eteree e dai Demoni buoni (cioè gli Angeli); infine, quello inferiore, popolato dagli uomini e dalle loro anime, oltre che dagli animali terrestri. Nemesio sostiene poi che per Ammonio il rapporto sussistente tra anima e corpo non è di tipo fisico e spaziale, ma ontologico, nel senso che l’anima non si trova nel corpo, ma agisce su di esso, costituendone il principio vitale. Ammonio tenne le sue lezioni ad Alessandria d’Egitto, ove condusse un’esistenza semplice e appartata. Nella Vita di Plotino redatta da Porfirio si narra (Vita di Plotino, 3) che Plotino, all’età di ventott’anni, si recò su consiglio di un amico ad ascoltare una lezione di Ammonio Sacca e, al termine di essa, esclamò con entusiasmo: “questo è l’uomo che cercavo!”. Per la sua bontà e saggezza, Ammonio venne definito “istruito da Dio” (Teodidatta). E’ notevole che, pur considerandone i lati buoni, si ribellò al cristianesimo perché non vi trovava nulla di superiore alle religioni più antiche. Il Neoplatonismo della scuola di Alessandria rappresenta il tentativo di conciliare il pensiero di Platone con quello di Aristotele, affermando la possibilità di integrazione tra sfera intelligibile e sfera sensibile. Questi, influenzerà la filosofia medievale e rinascimentale, grazie alla traduzione degli scritti di Dionigi l’Areopagita. La scuola di Alessandria, andrà affermando l’interpretazioni delle idee platoniche come “pensieri della mente divina”. In base alle testimonianze, a Sacca gli viene attribuita la tendenza a conciliare il pensiero di Platone con quello di Aristotele, superando le polemiche tra le due scuole.
PLOTINO

LA VITA E L’ ADESIONE AL PLATONISMO
Plotino nacque a Licopoli in Egitto verso il 204 . Iniziò tardi , verso i 28 anni , a interessarsi di filosofia ad Alessandria , ove , deluso da vari filosofi , incontrò finalmente il platonico Ammonio Sacca . Alla scuola di Ammonio , che non lasciò alcuno scritto , Plotino rimase 11 anni . Nel 243 , allo scopo di entrare in contatto con i sapienti di Persia e India , si unì alla spedizione dell’ imperatore Gordiano contro i Parti . Ma l’ uccisione di Gordiano fece fallire la spedizione e Plotino si rifugiò ad Antiochia , per recarsi poi , nel 244 , a Roma . Qui raccolse intorno a sé amici e discepoli , con i quali leggeva e discuteva testi di Platone e Aristotele e dei loro commentatori . Di questo pubblico facevano parte non solo filosofi , come Amelio e Porfirio , ma anche medici , membri del Senato e donne di nobili famiglie , che non esitavano ad affidargli i figli in tutela e i beni da amministrare . Pur senza essere un filosofo di corte , Plotino godette dell’ amicizia dell’ imperatore Gallieno e della moglie Salomina . Col loro appoggio contava di far sorgere in Campania una città di filosofi , retta da leggi platoniche , che avrebbe appunto chiamato Platonopoli . Il progetto sfumò per l’ opposizione di membri della corte , ma non si deve pensare che esso fosse la reviviscenza del filosofo – politico di stampo platonico ; la città a cui Plotino aspirava era piuttosto il rifugio del filosofo e dei suoi compagni , in questo senso , essa é stata paragonata a una sorta di monastero o convento pagano . Nel 263 entrò nella sua scuola all’ età di 30 anni Porfirio , il futuro autore di una Vita di Plotino ed editore degli scritti del maestro . Nel 268 , anno in cui Gallieno fu assassinato , Porfirio , in preda ad una crisi , meditò il suicidio , ma Plotino lo distolse , invitandolo a distrarsi con un viaggio . Porfirio si recò in Sicilia , ove nel 270 lo raggiunse la notizia della morte di Plotino , che , ammalato , si era ritirato in Campania . Nei primi dieci anni del suo soggiorno a Roma , sino al 253 , Plotino insegnò soltanto attraverso conversazioni orali . Nei 10 anni successivi , sino all’ arrivo di Porfirio nella scuola , compose 21 libri , ma senza dare titoli ad essi . I rimanenti furono scritti negli anni successivi , per un totale di 54 trattati , che possediamo nella loro integralità . All’ inizio del quarto secolo , Porfirio mise a punto un’ edizione di essi secondo un ordine sistematico , non secondo l’ ordine cronologico della loro composizione . Egli suddivise i 54 trattati in 6 gruppi di 9 ( da cui il titolo Enneadi ) , raggruppandoli per temi secondo una sequenza che espone l’ itinerario del filosofo che si innalza dal mondo sensibile sino alla divinità . Si tratta dell’ itinerario che anche i discepoli devono ripercorrere , sulla scia dell’ insegnamento del maestro , dalle questioni più facili sino alle più complesse . Per quel che possiamo sapere , Plotino é il primo filosofo dell’ antichità , che scrive di proprio pugno i suoi scritti , non secondo la prassi abituale di dettare a un amanuense . Porfirio riferisce che egli non modellava le lettere , non curava l’ ortografia , nè rileggeva quanto aveva scritto , anche per la sua debole vista . La sua scrittura veniva di getto , quasi come se si limitasse a trascrivere complessi di pensieri già totalmente e perfettamente organizzati nella sua mente . Le Enneadi non danno un’ esposizione sistematica e scolastica del suo pensiero , ma partono sempre da problemi singoli , a volte postigli dal suo pubblico o da interlocutori immaginari , seguendo l’ andamento della conversazione orale , e non disdegnando dal ricorrere a un linguaggio pieno di immagini e metafore , proprio come quello di Platone , di cui Plotino celebrava il compleanno con sacrifici e banchetti ; peraltro , i testi di Platone sono il punto di partenza della sua riflessione . In tal senso , la filosofia é in primo luogo esegesi , ricerca del significato presente in quei testi . Il suo insegnamento iniziava con la lettura di passi platonici , o anche aristotelici , nonchè di interpretazioni che ne erano state date nel passato ; questa lettura era poi occasione per sviluppare analisi e riflessioni . Plotino non esita a riprendere e utilizzare temi , concetti e terminologia derivanti anche da altre scuole filosofiche , come lo stoicismo o l’ aristotelismo . Ma egli interpreta la sua attività filosofica essenzialmente come esplicazione di ciò che é implicito , talora enigmaticamente implicito , nel testo di Platone , come un rotolo di libro che dispiegandosi manifesta i suoi tesori . In tal modo , egli va ben oltre la lettera del testo platonico , dandone una riformulazione originale , anche se agli occhi di Plotino , come dei suoi contemporanei , l’ originalità non pare essere un merito : ciò che conta é richiamarsi a un’ autorità . In questo quadro , l’ unica forma di originalità si può allora configurare come interpretazione non pedissequa , ossia , ai nostri occhi di moderni , ” infedele ” rispetto al testo autorevole . In Plotino , tuttavia , l’ appello a Platone non deve essere scambiato per una forma di venerazione del passato o dell’ originario in quanto tali . Se il testo di Platone é per lui il punto chiave , lo é non tanto per la sua antichità , quanto per il contenuto di verità che esso racchiude . Né Plotino intende presentarsi come un filosofo che attinga a una sapienza orientale piuttosto che a quella greca : l’ unica via che porta a dio passa attraverso la filosofia e l’ indagine razionale . Il messaggio di Plotino non si pone in concorrenza con movimenti religiosi che intendono rivolgersi a gruppi sempre più vasti ed anche ai ceti meno colti . La filosofia é marginale rispetto alla società , perchè é diventata sempre più marginale rispetto allo stesso mondo sensibile , in fuga da esso . La filosofia di Plotino dà l’ impressione di essere una filosofia complicata , artificiosamente complicata : va però detto che essa risente del clima culturale dell’ epoca che favoriva collegamenti tra filosofia e religione : se teniamo conto dell’ epoca in cui Plotino vive , ci accorgiamo che egli é l’ opposto di ciò che sembra essere : é l’ ultimo strenuo difensore del platonismo e soprattutto del patrimonio classico antico ; fra le varie degenerazioni del platonismo e della filosofia classica in primo piano lui metteva il cristianesimo , che dava interpretazioni erronee della filosofia . Da notare che Plotino viene generalmente definito da noi moderni ” neoplatonico ” , ma lui non si definiva affatto così : si sentiva platonico a tutti gli effetti , un vero e proprio seguace di quel Platone vissuto qualche secolo prima . Egli si definiva platonico , ma senz’ altro assai influenti erano anche in lui le influenze aristoteliche ; il lavoro di Plotino é infatti un lavoro di sintesi di tutte le elaborazioni e le filosofie classiche , dove svettano il platonismo , l’ aristotelismo e , in misura minore , lo stoicismo ; di fatto restano però esclusi l’ epicureismo e lo scetticismo , che , in qualità di filosofie essenzialmente materialistiche , non possono trovare spazio nell’ ambito della metafisica . Plotino cerca di dare un’ interpretazione fortemente positiva della realtà , provando a dimostrare l’ inesistenza del male . Questo é il risultato paradossale della ” terribile ” epoca in cui vive , il terzo secolo , forse il più brutto per l’ Impero Romano . Si tratta infatti di un secolo segnato da continue invasioni e scorrerie barbariche e dall’ anarchia militare .
L’ UNO E LA GERARCHIA DELLA REALTA’
Da Platone riprende soprattutto la struttura gerarchica della realtà ; a differenza di Platone , però , secondo il quale al vertice vi era un principio bipolare , Plotino mette a capo dell’ intera realtà l’ Uno ; Plotino si lascia molto influenzare da questo punto di vista dalle idee correnti ai suoi tempi , che tendevano a ridurre il principio bipolare : in fin dei conti avviene questo : al vertice della realtà non può esservi un principio ” doppio ” , quindi l’Uno é il vertice e il Due é declassato nell’ ambito della scala gerarchica . Dunque per Plotino al vertice della realtà c’é l’Uno , al secondo livello il Nous ( la ragione ) , ciò che Platone chiamava diade . L’ Uno di Plotino é l’ erede del principio supremo della filosofia platonica , ossia il Bene in sé , la cui caratteristica fondamentale era di essere ” superiore all’ essere per dignità e potenza ” ; l’ Uno é esattamente la stessa cosa : é un qualcosa al di sopra dell’ essere ; da notare che Plotino ammette una teologia negativa : infatti l’ Uno , che di fatto é il dio per Plotino , non lo chiama dio perchè cadrebbe in errore ; chiamarlo Uno é la maniera meno sbagliata di definirlo , in quanto si tratta di una realtà superiore all’ essere , a tutto quanto e , come già aveva detto Platone nel ” Parmenide ” , non può neanche essere nominato , perchè così facendo non sarebbe già più un principio unico ; é come se nominandolo già si sdoppiasse : definendolo Uno si applica proprio la teologia negativa perchè non si dice ciò che dio é , ma ciò che non é , ossia si dice che non é molteplice . E’ proprio questo il cardine della teologia negativa , che vuole dio ineffabile : l’ unico modo per parlarne é parlarne in termini negativi , ossia dire ciò che dio non é : dio non é buono , non é bello , non é alto , non é basso … Anche chiamarlo Bene , come aveva fatto Platone , non é corretto perchè lo si definirebbe in rapporto alle altre cose , per cui egli rappresenta il bene : definirlo Bene significherebbe ammettere che si occupa delle cose , essendo per loro il bene : ma ricordiamoci che dio per Plotino é ” pensiero di pensiero ” .L’ Uno quindi é al vertice e la realtà ne deriva in maniera gerarchica ; ma come fa a derivare la realtà ? Plotino si serve per esprimere questo concetto di due parole : emanazione e processione ; la prima delle due espressioni é più generica e forse rende meno bene l’ idea , ma di fatto si completano a vicenda . La realtà emana dall’ Uno , ma in che modo ? L’ attività dell’ Uno , innanzitutto , non é nè necessaria nè libera , oppure si può anche intendere che sia ambedue le cose : il contetto che sintetizza é la spontaneità ; ciò significa che l’ Uno agisce senza obblighi , ma tuttavia seguendo la propria natura : l’ azione dell’ Uno é spontanea ( anche perchè non potrebbe essere altrimenti : non c’é ancora nulla all’infuori di lui , e chi dunque potrebbe costringerlo ? ) ; esso fa emergere l’ essere a causa di una sovrabbondanza di essere , come una fonte inesauribile ; infatti non é che l’Uno emanando , emettendo l’ essere , diminuisca : ricordiamoci che é al di sopra dell’ essere . Fin qui si sarà senz’ altro notata la parentela di Plotino con Platone ; ma da qui in poi subentra anche quella con Aristotele : é infatti tipicamente aristotelica l’ idea che tutto ciò che si produce sia conseguenza di un’ attività teoretica ( l’ artigiano produce in conseguenza del pensare ) ; altrettanto aristotelico é il concetto di divinità vista come pensiero di pensiero ( la divinità infatti per Aristotele non fa altro che pensare a se stessa , senza conseguenze , se non la sua beatitudine ) ; unendo l’ Uno e la derivazione della realtà con la produzione artigianale , nonchè il ” pensiero di pensiero ” , Plotino prova a dare una sua interpretazione ; vi é l’ Uno , pensiero di pensiero , che pensa a se stesso e da questa attività teoretica emana spontaneamente la realtà . Ma va notato che anche il concetto di ” pensiero di pensiero ” in Plotino é un’ ibridazione tra Aristotele e Platone : infatti Plotino dice che il pensante e il pensato sono sì lo stesso , ma in modo radicale , come diceva Platone a proposito della conoscenza del Bene in sè : per conoscere bisogna che l’ oggetto e il soggetto siano sempre più vicini , ma una volta arrrivati a combaciare , paradossalmente , soggetto e oggetto sono lo stesso ; anche noi possiamo provare a pensare a noi stessi , ma non sarebbe lo stesso perchè l’ unità soggetto-oggetto non sarebbe quella intesa da Plotino ( e da Platone ) : infatti , pur non essendoci distinzione numerica , ci sarebbe distinzione concettuale , ossia sapremmo pur sempre quale é il soggetto e quale l’ oggetto . Quel che intende Plotino é l’ AUTOINTUIZIONE , ossia la conoscenza diretta e non mediata : una sorta di coglimento immediato di sé , in cui soggetto e oggetto non sono distinguibili nè numericamente nè concettualmente . Esattamente nel momento in cui l’ Uno si autointuisce emana qualcosa . Per esprimere meglio il concetto Plotino usa una metafora ( pensiamo a Platone e a tutte le sue metafore ) , quella della fonte luminosa e della luce che si espande intorno : immaginiamoci una candela accesa in una stanza buia : l’ Uno é la candela , la realtà la sfera luminosa che si espande intorno . L’ altra metafora che Plotino usa é quella della fonte e il ruscello : la fonte é l’ Uno e il ruscello che scende a valle é la realtà ; oltre all’ idea di emanazione , già presente nella metafora della candela , va qui notata un’ altra cosa : ossia il tipo di rapporto tra Uno e realtà : la metafora suggerisce che la fonte é sì diversa dal ruscello , ma che tuttavia non c’é l’ atto creatore : l’ essere procede fuori dall’ Uno senza una vera e propria cronologia : é solo in termini logici e avviene all’ eterno , a differenza di quanto dice il cristianesimo ) ; la metafora suggerisce anche che non ci sarà mai netta separazione tra Uno e realtà : non si può concepire la fonte senza il ruscello e viceversa : il concetto di processione emerge molto meglio in questa metafora , che non in quella della candela . E’ difficile stabilire fino a che punto la concezione di Potino sia immanente ( come lo stoicismo ) o trascendente ( come il platonismo ) . Dunque ” emanazione ” dà più l’ idea di omogeneo , ” processione ” dà l’ idea di una serie di cose che escono procedendo una a una , non come un fluido
IL NOUS , LE IPOSTASI E LE IDEE
Dunque abbiamo detto che la realtà viene emanata dall’ Uno , ma non in modo fluido , bensì ” a tappe ” ; queste ” tappe ” Plotino le chiama ipostasi , termine piuttosto simile a quello aristotelico che designava la sostanza , upokeimenon ( ciò che sta sotto ) ; ipostasi si può quindi tradurre con ” sostanza ” . In termini filosofici si ipostatizza quando si trasforma in una sostanza un’ attività o una funzione . Platone , ad esempio , ha individuato le idee con l’ ipostatizzazione : ha preso delle qualità , per esempio la giustizia , che per noi di per sè non esiste , e l’ ha trasformata in una sostanza : l’ idea di giustizia . Plotino grosso modo , sulla scia di Platone , dice che ci sono le ipostasi ( le idee ) e anche nella realtà materiale c’é un pallido riflesso . Nella scala gerarchica l’ ipostasi che occupa il primo posto é il NOUS ( intelletto ) , ossia la forma più elevata e sublime di essere ( l’ Uno , chiaramente , non rientra nella gerarchia in quanto non é essere ) che Plotino fa derivare in parte da Platone e in parte da Aristotele : anche il nous ha una sua attività produttiva simile all’ Uno : pensa e fa derivare un’ ipostasi a lui successiva ; anche lui é pensiero di pensiero , anzi , lo é ancora più dell’ Uno : infatti il nous é il vero pensiero di pensiero alla Aristotele ; nell’ Uno infatti il soggetto e l’ oggetto non ci sono più in ogni caso , mentre nel nous , come anche per il dio aristotelico , ci sono eccome , ossia vi é concettualmente un pensante e un pensato . Il nous quindi ha attività teoretica simile al dio aristotelico . In esso , che tende a riferirsi soprattutto al lato soggettivo ( colui che pensa ) , vi é pure il pensato , nella sua forma pura : le idee per Platone erano gli oggetti pensati e il nous di Plotino , come oggetto ( ciò che viene pensato ) é il mondo delle idee ; quindi il dio plotiniano , a differenza di quello aristotelico , ha in sè le strutture del mondo . Va senz’ altro notato come Plotino riesca a dare una collocazione a tutte le dottrine platoniche e aristoteliche : il pensiero di pensiero , il Bene , l’ Uno , la Diade ; quest’ ultima , infatti , altro non é che il nous come soggetto : infatti in Platone essa era al vertice della realtà , mentre Plotino la declassa al secondo posto , partendo dal presupposto che il principio supremo non possa essere duplice . Va poi detto che in Plotino ricompare una dottrina tipicamente platonica , ossia quella del Demiurgo ; esso ha stretta parentela con il nous e Plotino fa derivare questa parentela , paradossalmente , da un concetto aristotelico : l’ attività di produzione come conseguenza del pensare ; il nous pensa a se stesso , proprio come per Aristotele , ma lui come oggetto altro non é che il mondo delle idee platonico ; da questo pensare deriverà la realtà sensibile . Ma vi é qui una grande differenza tra Plotino e Platone : per Platone le idee esistono proprio come soggetto ed erano indipendenti dal Demiurgo : erano libere da questo divino artigiano ed erano ambedue coeterni ; si potrebbe quasi dire che le idee fossero superiori al Demiurgo perchè esso dipendeva in qualche misura da loro in quanto nel creare il mondo doveva attenervisi . In Plotino e ancora prima nel cosiddetto medioplatonismo cambiò nettamente la concezione delle idee : le idee per esistere hanno bisogno di essere pensate e quindi esistono nella misura in cui sono pensate , ma é comunque una concezione diversa rispetto alla nostra : secondo Platone le idee sono enti a sè stanti e indipendenti e noi e la divinità ( il Demiurgo ) siamo nella stessa posizione di impotenza nei confronti delle idee ( o meglio , la divinità é messa un pò meglio perchè contempla le idee più facilmente ) : per dirla in altri termini , per Platone l’ idea di giustizia esiste indipendentemente dall’ uomo o da dio e questo concetto emergeva benissimo nell’ Eutifrone : le cose sante piacciono agli dei perchè sono sante e non sono sante perchè piacciono alla divinità . Nel medioplatonismo e in Plotino , invece , si passa ad una situazione intermedia tra quella di Platone e la nostra : le idee esistono indipendentemente dall’ atto conoscitivo dell’ uomo , ma tuttavia occorre l’ atto conoscitivo di dio . Il nous nel suo lato oggettivo é il mondo delle idee , immutabile ed eterno ( come per Platone ) , ma cambia il rapporto tra idee e dio : le idee esistono nella misura in cui vengono pensate dal nous : dunque se il Demiurgo era impotente verso le idee , il nous é il fondamento stesso della loro esistenza ; presso di noi , invece , le idee esistono nella misura in cui sono pensate non da dio , ma da noi stessi . Dunque per Plotino l’ uomo può solo cogliere le idee , ossia le verità ( e questo mediante grandi sforzi ) , mentre dio le crea : dunque Plotino a differenza di Platone direbbe che le cose sono sante perchè piacciono agli dei . Se ben ci pensiamo siamo con Plotino alle premesse del concetto cristiano di Trinità : l’ Uno , il Nous e l’ anima sono il corrispettivo del Padre , del Figlio e dello Spirito Santo ; vi é però una grande differenza : mentre la Trinità é tutta sullo stesso livello , Plotino colloca le sue tre ipostasi su tre livelli ontologici diversi .
L’ ANIMA E LA MOLTEPLICITA’
L’ ultima ipostasi , derivante dal nous come il nous deriva dall’ Uno , é l’ anima ( Psukè ) , che viene generata dal nous che pensa a se stesso nel modo già descritto . Ancora una volta si può effettuare un paragone a Platone : in Plotino , infatti , l’ anima rappresenta il ragionamento discorsivo ( la dianoia platonica ) , il nous rappresenta il coglimento intellettuale delle idee ( la noesis platonica ) e l’ Uno ( il bene platonico ) rappresenta la forma suprema di conoscenza della realtà e si identifica di fatto in dio . Se l’ Uno era l’ unità assoluta , e il nous quel principio bipolare che Platone aveva chiamato diade ( da notare che é vero che il nous rappresenta l’ intero mondo delle idee , ma Plotino dice che esso é unitario e compatto ) , l’ anima ha un ampio tasso di molteplicità : per capire bene che cosa avesse in mente Plotino a riguardo della molteplicità dell’ anima dobbiamo immaginarci uno specchio rotto che moltiplica all’ infinito le immagini ; ebbene l’ anima prende le idee e le moltiplica all’ infinito : se l’ idea di cavallo nel nous é una , essa nell’ anima viene moltiplicata e ci sarà il cavallo bianco , quello nero , quello grosso , quello piccolo e così via .
LA MATERIA E IL MALE
Dunque per Plotino ci sono le tre ipostasi e al di sotto il mondo sensibile e materiale : ma da che cosa é generato questo mondo che Platone aveva tanto evitato ? Bisogna ritornare all’ anima e alla molteplicità di idee presente in essa ; l’ anima coglie le idee dal nous e poi le catapulta al di fuori dando così vita alle realtà sensibili : abbiamo citato l’ idea di cavallo , che di per sè é una sola , ma che nell’ anima é moltiplicata all’ infinito : ebbene ogni singola proiezione di cavallo dell’ anima dà forma ad ogni singolo cavallo , andando ad incarnarsi nella materia . Anche qui Plotino mette insieme Platone e Aristotele , riprendendo il concetto di idea ( trascendente ) dell’ uno e quello di forma ( immanente ) dell’ altro : l’ idea platonica é a livello del nous , mentre la forma Aristotele é a livello dell’ idea moltiplicata nell’ anima . Ma che cosa é la materia per Plotino ? Egli riprende la concezione negativa di essa tipicamente platonico – aristotelica : é la materia a creare il disordine nella realtà ; però Plotino ha una concezione metafisica più ottimistica : la materia é sì origine del male perchè oppone resistenza alle idee impedendo loro di manifestarsi completamente , ma Plotino dice esplicitamente che essa non esiste , o meglio , esiste solo negativamente ; Platone e Aristotele , invece , ponevano la materia allo stesso livello ontologico delle forme ( o idee che dir si voglia ) . Per capire meglio ciò che intendesse Plotino , soffermiamoci nuovamente sull’ immagine del lume e della luce che si propaga da esso : la sfera di luce più ci si allontana dalla fiamma e più tende a sparire , ossia il suo diventar sempre più fioca sta a significare che le ipostasi man mano che si scende tendono ad allontanarsi dall’ Uno : nell’ immagine la materia altro non é che il buio , ossia non c’è neppure , é solo dove si esaurisce la potenza emanativa dell’ Uno : la materia altro non é che il limite negativo di espansione della luce , che é l’ essere pieno , ossia il mondo delle idee . Se non c’è la materia , che del male é il principio , allora non può esserci neanche il male . Però il male c’è nel mondo ( ai tempi di Plotino più che mai ) . Ma se ontologicamente la materia e quindi il male non esistono , allora che cosa é il male , che abbiamo detto in qualche modo esistere ? Il male é mancanza di bene , ossia laddove l’ emanazione dell’ Uno non riesce ad arrivare . La luce , l’ abbiamo detto , é l’essere pieno , ossia il mondo delle idee , eterno e incorruttibile ; ne deriva , dunque , che più essere c’è e più c’è bene . Certo che se dico che la materia non esiste e neanche il male , allora tutto ciò che esiste é bene , ma evidentemente non é così . Plotino , per non cadere in contraddizione , arriva a dare un’ interpretazione relativistica , quasi alla Protagora : nulla di per sè é male perchè nella misura in cui esiste é bene ( l’ essere é bene ) ; il male é relativo e possiamo fare un esempio per spiegare che cosa intendesse Plotino per male : i beni del corpo di per sè sono buoni perchè esistono ( e tutto ciò che é , é bene ) , ma diventano cattivi nel momento in cui fan calare di livello l’ uomo , distogliendolo da altre attività più elevate : pensiamo ad un matematico che sia arrivato a fare le equazioni di secondo grado e si metta all’ improvviso a fare solo calcoli banali come due più due : di per sè fare calcoli come due più due non é negativo , ma in questo caso sì perchè fa calare l’ uomo . Dunque per Plotino il male é inteso come direzione autodiminutiva che l’ uomo può intraprendere .
LO SCOPO UMANO : UNA DIFFICILE “SCALATA”
Fin qui siamo andati , per così dire , in discesa : dall’ Uno al nous , dal nous all’ anima e dall’ anima alla materia ; ma lo scopo dell’ uomo quale é ? Per Plotino lo scopo dell’ uomo é risalire questa scala ; l’ uomo deve effettuare una conversione ( come già diceva Platone nel mito della caverna ) , ossia deve dalla posizione in cui si trova ( il punto più basso ) girarsi e salire fino alla cima : deve partire dalla sua situazione , ossia il piano materiale , passare al ragionamento ( l’ anima ) , al mondo delle idee ( il piano su cui opera il filosofo ) per poi raggiungere l’ Uno , arrivando così a raggiungere un vero e proprio livello di estasi mistica e razionale , in quanto si tratta di un procedimento assolutamente guidato dalla ragione: questo “viaggio” del soggetto è da Plotino paragonato a quello di Ulisse verso Itaca; a suo avviso, Omero deve essere letto in senso allegorico, secondo questo significato profondo. Questo procedimento vuole significare la riduzione all’ unità delle cose , già piuttosto cara a Platone : l’ uomo deve scavare nella propria anima finchè non arriva all’ estasi ; Porfirio ci riferisce che Plotino raggiunse il livello di estasi ( che propriamente significa ” essere fuori di sè ” ) meno di 7 volte nel corso di tutta la sua vita . Da questo punto di vista la funzione dell’ uomo é cosmica in quanto é l’ unico essere vivente in grado di ripercorrere la scala fino all’ Uno e far così tornare l’ intero mondo al suo principio . Ma percorrere la scala non é certo cosa facile e i metodi per farcela sono 3 , a seconda di come si intenda il principio supremo : 1) Se lo intendiamo come Uno , allora dovremo seguire la via conosctiva 2) Se lo intendiamo come Bene , dovremo seguire la via ascetica 3) Se lo intendiamo come Eros dobbiamo seguire la via estetica . La via più ovvia é la prima , quella della conoscenza , percorribile tramite la ” redutio ad unum ” , la riduzione all’ unità ; per seguire la via ascetica si deve invece rinunciare ai beni fisici , che dirigono l’ uomo verso il ” basso ” : di Plotino si ricorda la celebre espressione : ” mi vergogno di avere un corpo ” . Plotino rende ancora più di Platone questo distacco dal corpo , probabilmente anche per via del periodo in cui vive . L’ ultima via , quella estetica , riprende nettamente la ricerca dell’ eros platonico , ossia la ricerca incessante del bello . Spesso Plotino é stato definito ” Plato dimidiatus ” , Platone dimezzato , in quanto in lui manca la politica , che tanto contava per Platone ; però Plotino per quel che riguarda l’ arte ha avuto un’ idea brillante : per lui Platone sbagliava a definirla ” copia di copia ” , in quanto lo scultore non si ispira alla persona fisica , ma all’ idea .
PORFIRIO

Porfirio continuò le indagini del maestro Plotino , ancorandole più strettamente al patrimonio della religione pagana tradizionale e approfondendo l’ esegesi dei testi platonici . Nato a Tiro nel 232 , studiò ad Atene con Longino , dal quale assorbì l’ amore per l’ erudizione . Divenne poi discepolo di Plotino , dal quale si allontanò nel 268 per recarsi in Sicilia su consiglio di Plotino stesso , allo scopo di recedere dalle sue intenzioni di suicidio . In Sicilia compose probabilmente il suo scritto Contro i cristiani , che é andato perduto . In vecchiaia sposò la vedova di un amico , Marcella . Morì all’ inizio del quarto secolo , poco dopo la comparsa della sua edizione delle Enneadi di Plotino . A lui si deve la sistematizzazione e la pubblicazione degli scritti di Plotino – le Enneadi – e una sua biografia: “Vita di Plotino”. Rivalutò il misticismo e le pratiche ascetiche, introducendo anche elementi esoterici orientali in un orizzonte spiccatamente greco e platonico. La sua impostazione presenta inoltre una maggiore influenza aristotelica rispetto alla dottrina plotiniana. Si occupò di filosofia, retorica, analisi dei miti, religione, matematica, astrologia e musica. Plotino lo definì “poeta, filosofo e ierofante” (Vita di Plotino). Manifestò una profonda avversione per il cristianesimo, che lo portò a scrivere la sua opera “Contro i cristiani”. Un passo noto dei suoi scritti è quello sulla debolezza di Gesù, che pianse sulla croce e, al contrario di Socrate, non seppe affrontare la morte con dignità. Secondo quanto ci è pervenuto, Porfirio, nel frammento 88, cita la prima lettera di Paolo ai Corinzi: «E tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del signore Gesù Cristo e nello Spirito del nostro Dio». Ma, si chiede Porfirio, com’è possibile che un uomo possa lavarsi in questo modo da tante macchie e diventare puro (katharos)? Com’è possibile che con dell’acqua (con il battesimo) un uomo possa eliminare le proprie colpe e responsabilità? Com’è possibile che «fornicazione, adulterio, ubriachezza, furto, pederastia, veneficio e infinite cose basse e disgustose» siano così facilmente eliminate «come un serpente depone le vecchie squame»? A questo punto «chi non vorrebbe commettere ogni sorta di nefandezza, sapendo che otterrà attraverso il battesimo il perdono dei suoi crimini?» La filosofia dei cristiani incita all’illegalità e toglie efficacia alla legge e alla giustizia stessa; introduce una forma di convivenza illegale e insegna agli uomini a non avere timore dell’empietà. Quindi nel Cristianesimo «chi è onesto non viene chiamato» (frammento 87). In questo Porfirio può essere percepito come un continuatore della tradizione filosofica anticristiana che annovera Celso tra gli antesignani. Compose una splendida analisi dei simboli di un passo omerico secondo lo schema esegetico delle allegorie tipico del neoplatonismo (“L’antro delle Ninfe”) e un trattato sul vegetarismo “Sull’astinenza dalle carni degli animali”. Si oppose alla decisione del suo allievo Giamblico di introdurre culti e rituali magici nella vita dei filosofi. Porfirio fu autore di numerosissimi scritti , alcuni dei quali sono conservati , quali la Consolazione a Marcella e Sull’ astinenza , nel quale difende il vegetarianesimo . Probabilmente compose anche una sorta di storia della filosofia , della quale fa parte una Vita di Pitagora . Persi sono i suoi commenti al ” Timeo ” e al ” Parmenide ” , mentre un saggio della sua tecnica allegorica di interpretazione é documentato nello scritto Sull’ antro delle Ninfe , concernente il libro 13 dell’ Odissea . In esso , Porfirio ammette la possibilità di più significati allegorici di uno stesso mito . Il suo scritto più noto nel Medioevo , grazie alla traduzione latina di Boezio , fu l’ Introduzione alle categorie di Aristotele , nota anche come Isagoge ( dal greco eisagoghè , introduzione ) . In un passo di essa é affrontata la questione dello status ontologico degli universali , la quale offrirà ampia materia di discussione alla cultura medioevale . Riprendendo la dottrina plotiniana delle ipostasi , Porfirio tende ad attenuare la distanza tra esse , insistendo sui legami di continuità di ciascuna con quella precedente o seguente . Egli esclude che si possa dire che il nous é altro rispetto all’ Uno : anche l’ alterità , infatti , é una forma di relazione con altro e pertanto comporta una limitazione da parte dell’ altro . La stessa alterità , quindi , non può essere nell’ Uno . La maggiore distanza dal maestro consiste nel riconoscimento dell’ importanza della teurgia (operazione sulla divinità ) . Lo scopo dei rituali teurgici é l’ incorporazione di una forza divina in un oggetto materiale ( come una statua ) o in un essere umano , che si viene così a trovare in uno stato di ” trance ” profetica . Porfirio scrisse un’ opera intitolata La filosofia desunta dagli oracoli . Egli considerava gli oracoli una sorta di libro sacro , che insegna la via della salvezza attraverso la teurgia . Per l’ uomo comune la teurgia é più utile della filosofia , ma per il filosofo essa non é necessaria . Nella Lettera a Anebo , un prete egizio che potrebbe essere reale o fittizio , Porfirio conduce infatti una critica alla religione popolare : gli dei non possono essere mossi da preghiere . Preghiere o pratiche magiche possono operare grazie alla simpatia che lega tra loro le cose sensibili , ma non possono avere influenza sulle anime superiori degli dei , come già aveva sostenuto il maestro Plotino . Ma le critiche di Porfirio sono anche esplicitamente indirizzate contro i cristiani . In ciò egli aveva dei predecessori , a partire dal Discorso vero composto da Celso verso il 178 . Esso é andato perduto , ma é ricostruibile attraverso la risposta che parecchi decenni dopo avrebbe dato ad esso Origene nell’ opera intitolata appunto Contro Celso . Nello scritto di Celso era condannato il proselitismo nei confronti degli umili e degli ignoranti , spinti alla ribellione nei confronti dell’ autorità dei saggi . Sul piano più strettamente teorico , Celso sottolinea l’ assurdità dell’ incarnazione divina , ossia di un dio che soffre e muore , e della resurrezione finale , incompatibile con la svalutazione del corpo , propria del platonismo . Su questi punti , Porfirio riprende le critiche di Celso , rifiutando in generale ogni forma di antropomorfismo ed escludendo pertanto qualsiasi movente arbitrario nell’ agire divino . Di qui scaturisce una condanna dei miracoli e quindi della stessa incarnazione divina . Alla nozione cristiana di creazione , Porfirio contrappone la tesi tradizionale dell’ eternità del mondo e considera l’ immortalità una proprietà inerente alla natura stessa dell’ anima , non una grazia concessa dalla divinità .
AMELIO
Plotino ebbe due discepoli: Amelio e Porfirio. Amelio – che ebbe dimestichezza con il pensiero di Numenio prima di diventare un fedele seguace di Plotino – restò un poco in bilico fra i due maestri. Amelio, il cui vero nome era Gentiliano, proveniva dall’Etruria. Restò alla scuola di Plotino per ventiquattro anni, dal 246 al 269 d.C. Si trasferì poi ad Apamea, in Siria. Di lui ci sono pervenute solo poche testimonianze. In bilico tra Numenio e Plotino, Amelio prese a sviluppare alcuni punti della filosofia di Plotino, anticipando una tendenza che venne poi seguita dai successivi Neoplatonici. Egli ritenne infatti necessario procedere a una tripartizione della seconda ipostasi, ossia del Nous. Scrive Proclo a questo riguardo (In Plat. Tim., I):
“Amelio pone un triplice Demiurgo, tre Nous, tre Re: colui che è, colui che contiene, colui che contempla. Essi differiscono in quanto il primo Nous è essere in senso pieno, il secondo è l’intelligibile in sé, possiede ciò che è prima di lui e partecipa interamente di quello e per tal motivo appunto è secondo. Il terzo è pure in sé intelligibile, perché ogni intelligenza è identica all’intelligibile cui si congiunge strettamente”.
Sappiamo che Amelio rinominò questa triade con nomi di Dei: Phanes, Ouranos e Kronos. Certo, la complessità della seconda ipostasi plotiniana poteva indurre a operare – come fece Amelio – distinzioni; ma va anche detto che, a ben vedere, Plotino aveva molto insistito sulla “unità” di essa, mentre, a cominciare da Amelio, i Neoplatonici insistettero sempre più sulle “distinzioni”, finendo da ultimo per moltiplicare le ipostasi e i momenti delle varie ipostasi in modi e misure tali che finirono col disintegrare la metafisica neoplatonica. Occorre però notare come Amelio non sembri aver introdotto la tripartiziore del Nous seguendo un filo conduttore che gli permettesse di ripensare organicamente tutte e tre le ipostasi plotiniane, ma piuttosto per un certo permanere dell’influsso del Medioplatonismo e di Numenio, che distinguevano appunto una gradazione di intelletti. Il suo tentativo fu cioè una difficile (per non dire impossibile) coniugazione delle tesi di Numenio con quelle di Plotino. Aspetto, questo, che pare anche confermato dal fatto che Amelio assunse nei confronti dell’Anima un atteggiamento opposto a quello assunto nei confronti del Nous, insistendo – contrariamente a Plotino stesso – sull’“unità dell’Anima”. Se Plotino parlava di unità dell’Anima quanto al genere e alla specie, Amelio parlava di unità dell’Anima anche quanto al numero, e riteneva che le differenziazioni dell’anima dipendessero solo dalle differenti relazioni e rapporti in cui l’anima può entrare. Lo schema complessivo delle ipostasi del sistema ameliano sembra dunque essere stato quello che segue:
Uno
Primo Nous – Essente
Secondo Nous – Avente
Terzo Nous – Contemplante
Anima
Il pensiero di Amelio ebbe un grande sviluppo, oltre che in ambito filosofico, in ambito religioso-teologico, rivelando un grande attaccamento alla religione positiva e alle pratiche dei culti pagani. Ciò nonostante, Amelio non portò a livello speculativo le istanze che erano implicite in questo suo atteggiamento pratico, e quindi non modificò la direzione generale che Plotino aveva impresso alla Scuola.
GIAMBLICO
Giamblico nacque a Calcide , in Siria , verso la metā del terzo secolo. Aprė una nota scuola neoplatonica ad Apamea, in Siria. Allievo di Porfirio, si allontanō dalla dottrina del suo maestro per formulare una propria interpretazione del platonismo che accentuava la separazione tra anima e corpo, e la missione soteriologica della filosofia, che ha l’obiettivo di guidare l’uomo all’unione mistica con i principi immateriali, attraverso la pratica della teurgia. Fu considerato dai suoi contemporanei pagani uomo di grandissima sapienza e virtų – l’imperatore Giuliano lo definė divino e perfezione di ogni umana saggezza (F.C. Giuliano, A Helios Re). La dottrina di Giamblico si impose presto nell’ambito del pensiero pagano tardoantico. I suoi allievi furono i maestri dei fondatori della Accademia neoplatonica di Atene (Plutarco di Atene e Siriano), e le sue dottrine influenzarono per questa via Proclo, attraverso le opere del quale il neoplatonismo giunse fino al Medioevo. Una parte delle sue teorie affascinarono lo scrittore di fantasy Kostas Djugasvilij, che le inserė nelle sue opere (in particolare nel Ciclo di Marskan). Sebbene giā nel circolo romano di Plotino, e nei cenacoli filosofici che si erano formati attorno ai suoi allievi (Porfirio, Amelio), la lettura delle opere di Aristotele, di Platone, e dei loro principali commentatori, fosse una prassi comune, Giamblico formalizzō un vero e proprio curriculum di letture per gli studenti della sua scuola, strutturato in gradi di complessitā e di approfondimento progressivi. La base di partenza era data da opere di carattere precettistico, come il Manuale di Epitteto o il Carmen Aureum pseudo-pitagorico, volte a formare il carattere dell’allievo. Come ulteriore passo, veniva proposto il corpus aristotelico , a partire dalla logica, per poi trattare le opere di filosofia pratica (etica, economia, politica), concludendo con la filosofia teoretica (filosofia naturale, filosofia prima), che culminava nello studio dell’Intelletto divino (teologia). Queste letture erano pensate come uno studio propedeutico per affrontare il vero e proprio nucleo dell’insegnamento neoplatonico, ovvero i dialoghi platonici. Il Curriculum prevedeva lo studio di dodici dialoghi, suddivisi in due cicli di dieci e due letture. Il primo ciclo comprendeva inizialmente tre opere di filosofia pratica: Alcibiade Maggiore, Gorgia, Fedone; in seguito, lo studente affrontava sette scritti di natura teoretica: Cratilo, Teeteto, Sofista, Politico, Fedro, Simposio, Filebo. Il secondo, cui accedevano solamente gli studenti pių capaci, consisteva nello studio dei due grandi dialoghi teoretici: il Timeo e il Parmenide. La distinzione tra opere di carattere teoretico e pratico, cosė come le suddivisioni interne dei cicli (scritti politici, purificatori, di fisica, di teologia…) erano state introdotte da Giamblico stesso, che si poteva avvalere per questo della sua teoria per cui ogni dialogo platonico aveva in realtā un obiettivo di indagine ben definito (per esempio, l’Alcibiade Maggiore avrebbe avuto come scopo l’indagine sulla conoscenza di sé, il Gorgia la definizione della retorica…), grazie al quale era possibile classificarlo all’interno di una precisa disciplina scientifica. Giamblico fu un autore fecondo, ma le sue opere sono quasi tutte perdute, soppiantate dal corpus dei commenti di Proclo. Numerosi frammenti ci sono perō pervenuti attraverso le citazioni che quest’ultimo fa dei suoi commentari, oppure contenute in scritti di altri pensatori neoplatonici successivi (Simplicio, Filopono…), o ancora in antologie filosofiche come quella di Giovanni Stobeo. Giamblico ompose diversi commenti alle opere platoniche ed aristoteliche e una raccolta di epistole che ebbero grande circolazione in tutto l’Impero, oltre che alcuni trattati (Sulle Virtų, Sull’Anima) e un imponente scritto, Sul Pitagorismo, in dieci libri. Quest’ultimo, cosė come la lettera conosciuta con il titolo Sui misteri degli Egizi, faceva parte della polemica condotta contro l’autoritā di Plotino, la cui esegesi del platonismo aveva saputo imporsi come dominante fino ad allora. E’ stato ipotizzato che le Enneadi edite da Porfirio e il trattato sul pitagorismo abbiano rappresentato i due nuclei della battaglia intellettuale, al termine della quale, tuttavia, fu Giamblico a prevalere. I suoi scritti pių conosciuti sono La vita di Pitagora(primo libro del trattato in dieci volumi Sul Pitagorismo) e I misteri degli egizi, pubblicato in risposta ad una critica di Porfirio riguardo all’enfatizzazione dell’importanza dei riti misterici nella pratica filosofica. In esso, Giamblico sostiene la superioritā della teurgia sulla sola indagine razionale per ottenere una reale comprensione del mondo divino. Una delle pių importanti novitā introdotte da Giamblico fu la maggiore complessitā del cosmo metafisico. L’universo plotiniano si imperniava su tre ipostasi immateriali: l’Uno, fonte della realtā e sommo bene, l’Intelletto divino, primo grado dell’essere e del pensiero, e l’Anima, che con la sua azione mediatrice produce il cosmo sensibile, conferendogli essere e vita. Pur confermando questa struttura, Giamblico specifica ulteriori differenze interne. Se giā per Plotino l’Uno, primo dio, era una realtā ineffabile, al di lā del pensiero, ora il principio della realtā č ulteriormente separato dall’uomo: viene introdotto un livello intermedio – le enadi – che si pone appena al di sopra dell’Intelletto, grazie al quale viene spiegato il processo di produzione della molteplicitā dalla assoluta semplicitā dell’Uno. Il sommo bene, inoltre, era per Plotino raggiungibile tramite un’elevazione mistica ((epaphe, contatto) grazie a cui l’anima si univa ad esso; Giamblico, al contrario, ritiene che il massimo livello di realtā cui l’uomo puō accedere sia quello dell’Intelletto divino, tramite un’unificazione (henosis) resa possibile dalle pratiche teurgiche. La conversione dell’anima verso le realtā superiori non puō attuarsi pių, come per Plotino e Porfirio, semplicemente con le forze umane attraverso la dialettica e la indagine filosofica; la ragione, pur rimanendo uno strumento indispensabile, non č pių in grado di portare l’uomo in comunicazione diretta con le divinitā immaterialo; diventa quindi necessaria la pratica di rituali magico – religiosi che permettono la comunicazione con gli esseri divini (demoni, gli dei corporei, gli dei immateriali), ordinati gerarchicamente tra l’individuo terreno e il cosmo superiore (teurgia).
TEODORO
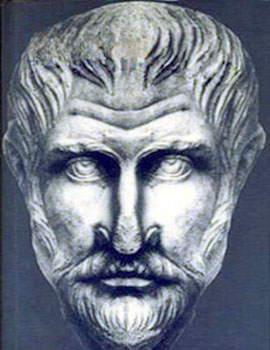
Dopo che Giamblico fu morto, la Scuola da lui fondata si sciolse. Sopatro di Apamea, che Eunapio considera come il pensatore Più importante tra i discepoli di Giamblico, resta per noi poco più che un nome, in quanto non ci sono rimasti documenti e testimonianze che ci permettano di ricostruirne il pensiero. Egli si trasferì a Costantinopoli, dove esercitò, dapprima, grande influenza alla corte imperiale, ma poi fu giustiziato sotto l’accusa di magia. Di Dessippo è sopravvissuto un commento alle Categorie, che però non ha grande valore filosofico. Decisamente più importante è, invece, Teodoro di Asine, di cui ci è stato tramandato un certo numero di testimonianze. Egli nacque nell’ultimo trentennio del III secolo e morì, al più tardi, intorno al 360 d.C. Nei suoi anni giovanili poté ancora udire Porfirio e, successivamente – forse solo per breve tempo – Giamblico. Il Teodoro di cui parla Eunapio (Vite, V, 1, 4-5) è probabilmente Teodoro di Asine. Questi intrattenne rapporti con Amelio (il discepolo di Plotino) e – forse mediante Amelio – anche con il pensiero di Numenio di Apameo. Fu discepolo, dapprima, di Porfirio, e, poi, fu alla Scuola di Giamblico, di cui criticò aspramente le tesi portanti. In particolare, non sembra essersi interessato delle pratiche teurgiche. Ma la sua metafisica dipende indubbiamente dalle novità filosofiche introdotte dal pensiero di Giamblico. Egli pose un “Primo”, inesprimibile e indicibile, come “fonte di tutte le cose e causa della bontà”. Dal Primo dedusse una triade che esaurisce il “piano dell’intelligibile”, e che egli chiamava – con una terminologia schiettamente plotiniana – l’“Uno”. Si trattava, dunque, di un “Uno triadico”, cioè di una “triade unitaria”. I membri di questa triade vennero denominati sfruttando la simbologia dei tre suoni di “en”, ossia dell’Uno, secondo i metodi del Neopitagorismo. A questa triade, Teodoro di Asine fece seguire quella che esaurisce il “piano dell’intellettuale”, caratterizzata dall’“essere”, dal “pensare” e dal “vivere”. Inoltre, egli dedusse una triade di Demiurgi, caratterizzata, rispettivamente, dall’“ente”, dal “pensiero” e dalla “vita”. Per caratterizzare questa triade, Teodoro di Asine usava i sostantivi corrispondenti agli infiniti con cui indicava i membri della precedente triade: voleva così significare che quelli erano prodotti dall’attività di questi. Inoltre, divise anche ciascun membro di questa triade in altre triadi. Infine, distinse tre ipostasi anche nell’ambito dell’anima. Complesse distinzioni Teodoro di Asine operò, ulteriormente, a proposito dell’Anima (distinta in “Anima in sé”, “Anima universale” e “Anima del Tutto”), e considerata in sia sé sia nei suoi rapporti col corporeo, con considerazioni pitagoreggianti desunte dalle lettere della parola psyché e dal corrispondente numero. Il pensiero di Teodoro, consolidando il sistema della dialettica triadica, apre la strada alla definitiva sistemazione di Proclo e della sua riflessione.
PROCLO
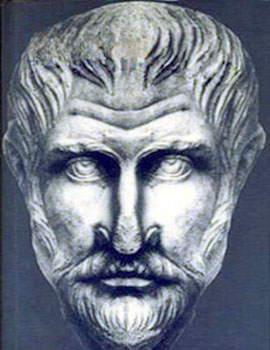
Il più importante rappresentante del neoplatonismo ateniese è Proclo. Nato nel 412, Proclo studiò ad Alessandria, ma fu poi allievo di Plutarco e Siriano, al quale successe nella direzione della scuola di Atene, che egli tenne sino alla morte nel 485. Egli è autore di numerose opere, molte delle quali ci sono pervenute, integralmente o parzialmente. In primo luogo, una serie di commentari a dialoghi di Platone e, precisamente, al Timeo, alla Repubblica, all’ Alcibiade maggiore (da lui ritenuto autentico), al Cratilo e al Parmenide. La sua sistemazione del pensiero platonico è contenuta soprattutto nella “Teologia platonica”, in sei libri, e negli “Elementi di teologia”. Vi sono, inoltre, tre brevi scritti nei quali Proclo affronta il problema del fato e della libertà, della provvidenza e del male, nonché un trattato di astronomia elementare e un “Commento al primo libro degli elementi di Euclide”. Proclo è anche autore di Inni religiosi e di uno scritto sull’Arte ieratica, nel quale riprende le tematiche della teurgia. Proclo dà una sistemazione alla precedente speculazione neoplatonica, soprattutto nella formulazione impressale di Giamblico. Il suo punto di partenza è una interpretazione del Parmenide di Platone, già avviata dai suoi maestri Plutarco e Siriano, secondo la quale tutte le ipotesi sul rapporto uno-molti, esposte nella seconda parte del dialogo, riguardano la teologia. La teologia di Platone si pone nella sua visione al termine di una catena rivelativa che parte dagli dei stessi, passa per l’orfismo e il pitagorismo e arriva a Platone: Proclo interpreta quindi la vicenda della filosofia secondo una prospettiva inversa rispetto a quella di Aristotele. Per Aristotele, infatti, l’ultima filosofia è il compimento del passato e il criterio in base al quale discutere di esso e operare selezioni al suo interno . Per Proclo, invece, l’origine e il passato sono il massimo della verità. Il modello derivativo metafisico, elaborato da Plotino, viene esteso alla stessa vicenda della filosofia: ciò che è primo è superiore a ciò che segue. Platone diventa uno scrittore ispirato al quale tributare un culto e il filosofo-interprete diventa il garante della continuità e conservazione della catena rivelativa. Proclo stesso sosteneva di essere stato chiamato in sogno alla filosofia dalla dea Atena, osservava fedelmente i culti pagani e praticava la teurgia. Il suo biografo Marino gli attribuisce poteri di guarigione e di intervento sugli stessi fenomeni meteorologici. Il nobile Rufino, assistendo una volta ad una lezione di Proclo, affermò di aver visto la testa del maestro circonfusa di luce. Così, nella sua ultima apparizione, il filosofo pagano assumeva, ma invano, l’aura del santo cristiano. Sulla linea del Parmenide e di Plotino, Proclo non pone un principio ineffabile al di sopra dell’Uno, come invece fa Giamblico. Ancor più di Giamblico, Proclo elabora invece una teologia, nella quale proliferano le ipostasi. Questo aspetto si esprime nella dottrina delle enadi divine. All’interno dell’Uno, che è la prima ipostasi, sussiste una serie di unità in aggiunta ad esso: esse derivano dall’Uno e sono gli intermediari tra l’Uno e le realtà inferiori. Mentre l’Uno è in sé inconoscibile, esse possono essere conosciute attraverso i loro prodotti. L’Uno infatti non contiene in sé le cause delle realtà inferiori, perché ciò sarebbe incompatibile con l’unità assoluta. Queste cause sono invece contenute nelle enadi, che Proclo identifica esplicitamente con gli dei della tradizione pagana. Nella Teologia platonica, Proclo costruisce una minuziosa piramide gerarchica di queste divinità, nella quale i livelli inferiori si accrescono via via di numero, diminuendo corrispondentemente di potere. Il principio che presiede a questa piramide è dato dal fatto che due termini devono essere collegati da un intermediario, che ha qualcosa in comune con ciascuno di essi. Uno stesso attributo può esistere anche ai livelli inferiori in modo appropriato ad essi, ma solo al livello delle enadi esso esiste in modo perfetto. La funzione religiosa delle enadi si esprime sotto forma di provvidenza, ma gli dei sono provvidenziali in virtù del semplice fatto di esistere, non in quanto agiscono intenzionalmente e deliberatamente. Agli dei Proclo attribuisce onniscienza anche per quanto riguarda gli eventi singolari e contingenti, ma questa loro conoscenza del contingente non comporta che essi siano toccati da questa contingenza. Il processo dell’emanazione ha secondo Proclo una struttura triadica: mentre Plotino aveva essenzialmente distinto i due momenti della derivazione e del ritorno, Proclo distingue la monè, come permanere del principio nella propria causa, la proodòs, come procedere da tale causa, e l’epistrophè, come rivolgersi e tornare ad essa. Il potere divino, attraverso i suoi successivi intermediari, opera, anche se in gradi diversi, a tutti i livelli della realtà, anche all’ultimo di essi, ossia a livello della materia. Questa non può quindi essere identificata semplicemente con il male. Il male è pura assenza di bene; in quanto tale esso è una sorta di sottoprodotto o perversione dell’aspirazione di tutto verso il bene e non ha consistenza genuina. Il male del mondo materiale è tale soltanto per le sue parti, non per il tutto e la provvidenza volge al bene anche il male. Proclo non condivide la tesi di Plotino che ci sia una parte dell’ anima umana che non è caduta. Proprio per questo l’unica via di salvezza è ravvisata nella teurgia: l’intero mondo materiale è lo specchio di poteri divini invisibili, pertanto la manipolazione di determinati oggetti materiali mette il teurgo a contatto con gli dei che essi rappresentano. La teurgia si distingue dalle comuni pratiche magiche solo perché chi la pratica si trova in una condizione mentale superiore. Lo scopo finale di essa é ravvisato nell’estasi mistica.
Il movimento circolare dell’Essere non può che essere eterno. Il neoplatonismo, sulla scorta di tutto il pensiero greco, non può accettare la concezione ebraico-cristiana della creazione: la ragione rifugge l’idea che l’universo provenga dal Nulla. La filosofia greca si presenta al Medioevo soprattutto attraverso la mediazione dei Padri della Chiesa, che ne hanno fatto una servitrice fedele della teologia, ma anche si presenta anche con una voce – quella di Proclo – che rivendica la propria autonomia e rifiuta come assurda una sapienza che contraddice, in nome di un nuovo Lógos divino, a quel Lógos che per secoli ha guidato l’uomo nella ricerca della Verità:
“Con quale intenzione Dio, dopo una inerzia di durata infinita, penserà di creare? Perché pensa che è meglio? Ma prima, o lo ignorava, o lo sapeva. Dire che lo ignorava è assurdo; ma se lo sapeva, perché non ha cominciato prima?”
[Commentario al Timeo, 115 e]
INNI DI PROCLO
Inno ad Elios
Ascolta, o re del fuoco intellettuale, Titano dalle briglie d’oro,
ascolta, dispensatore di luce, signore che possiedi la chiave
della fonte della vita, e che sui mondi materiali
dall’alto versi un copioso fiume d’armonia.
Ascolta, giacché tu, che hai sede nel mezzo al di sopra dell’etere,
e tieni il cuore dell’universo, circolo luminosissimo,
tutto riempisti della tua provvidenza, eccitatrice della mente.
I pianeti, cinti dalle tue fiamme perennemente vivide,
sempre, con incessanti e infaticabili movimenti circolari,
mandano a favore di quanti vivono sulla terra stille vitali,
e ogni generazione, sotto i vostri ricorrenti corsi,
rigermina secondo la legge delle Ore.
Il fragore degli elementi fra loro cozzanti cessa,
quando tu, che discendi da padre ineffabile appari.
A te cede il coro inconcusso delle Moire;
che torcono all’indietro il filo del destino ineluttabile,
quando lo vuoi; giacché sommamente sei potente e vastamente signoreggi.
Balzò fuori di vostra catena Febo, signore della sacra melodia;
divinamente cantando, al suono della cetra,
placa l’enorme flutto della generazione dal cupo muggito.
Dal diffondersi della tua luce, che allontana i mali,
nacque, dono soave, Peone, e sua salute diffuse,
dopo aver riempito il vasto universo di balsamica armonia.
Te cantano il glorioso padre di Dioniso;
e te Evio-Attis negli ultimi recessi della materia,
te delicato Adone altri chiamarono nei loro canti.
E paventano la minaccia della tua agile sferza
i demoni, agli uomini funesti, di cuor feroce,
che alle nostre infelici anime ordiscono danni,
affinché sempre nell’abisso della vita dal cupo fragore
soffrano sotto il peso del corpo, bramosi del giogo,
e dimentichino la dimora eccelsa e splendente del padre.
Ma tu, ottimo fra gli dei, coronato di fuoco, nume beato,
immagine del dio creatore di tutte le cose, tu, che le anime elevi,
ascolta, e purificami da ogni peccato per sempre;
e la preghiera di molte lacrime accogli, e liberami
dal peccato che dà dolore, e tienmi lontano dalle espiazioni,
placando l’occhio vigile di Dike che tutto vede.
Ad opera del tuo aiuto sempre salutare
concedi all’anima mia la luce purissima e beatissima,
una volta dispersa la caligine, funesta ai mortali, prodotta da veleno
e al corpo il magnifico dono d’una perfetta salute.
Fa’ ch’io diventi famoso e che, secondo il costume dei miei predecessori
possa aver cura delle Muse dalle amabili trecce.
Non turbato benessere, che nasce da amorosa pietà,
se tu vuoi, concedimi, o signore, giacché facilmente puoi compiere.
Tu, infatti, possiedi saldo ed infinito vigore.
Ma se, per i fusi delle Moire, rotanti
sotto i fili tratti dai movimenti degli astri qualcosa di funesto
ci colpisce, distòrnalo con la forza dell’impeto tuo.
Inno ad Afrodite
Cantiamo la stirpe onorata d’Afrogenia
e l’origine grande, regale, da cui tutti
nacquero gli immortali alati Amori,
dei quali alcuni con dardi intellettivi saettano
le anime, affinché punte da stimoli sublimanti di desideri,
agognino vedere le sedi d’igneo splendore della madre;
altri, invece, in obbedienza ai voleri e ai previggenti, salutari consigli del padre,
desiderosi d’accrescere con nuove nascite il mondo infinito,
eccitano nelle anime il dolce desiderio della vita terrena.
Altri ancora sui vari sentieri degli amplessi nuziali
incessantemente vigilano, onde da stirpe mortale
immortale rendere il genere degli uomini oppressi dai mali
e a tutti stanno a cuore le opere di Citerea, madre d’amore.
Ma, o dea, poiché tu dovunque porgi orecchio attento,
o che circondi il vasto cielo, dove dicono che tu
sia l’anima divina del mondo eterno,
o che risiedi nell’etere al di sopra dell’orbite dei sette pianeti,
riversando su di noi, che da te discendiamo, indomite energie,
ascolta, e il doloroso cammino della mia vita
guida coi tuoi santissimi strali, o veneranda,
placando l’impeto gelido dei desideri non pii.
Alle Muse
Cantiamo la luce, che in alto solleva i mortali,
cantiamo le nove figlie, dalla dolce voce, di Zeus possente,
che le anime erranti nell’abisso della vita,
con pure iniziazioni, opera dei libri che risvegliano le menti,
liberano dalle cure funeste della terra,
e ad esse insegnano ad affrettarsi a seguire
un cammino che superi l’oblio dai flutti profondi,
e a ritornare purificate all’astro, cui son congiunte,
donde s’allontanarono, quando sulla costa, ove si nasce,
precipitarono, rese folli dal desiderio dei beni materiali.
Orsù, o dee, lo slancio mio ardente
calmate, e furor sacro ispiratemi con le rivelazioni intellettuali dei sapienti,
e la genìa degli uomini superstiziosi non mi svii
dal sentiero divino, luminosissimo, fecondo di splendidi frutti;
ma fuori dal fragore della traviata generazione sempre
possiate trarre alla luce pura l’anima mia errante
perché sia piena dei frutti dei vostri alveari che nutrono la mente,
e possegga sempre la gloria dell’eloquenza che seduce il cuore.
Inno Comune agli Dei
Ascoltate, o dei, che avete il timone della sapienza sacra,
voi che, dopo aver destato il fuoco che in alto solleva,
agli immortali riconducete le anime dei mortali,
che hanno lasciato il tenebroso recesso,
purificatesi con le iniziazioni ineffabili degli inni.
Ascoltate, o salvatori possenti, e per effetto dello studio dei libri divini,
mostratemi la luce pura, dopo aver dispersa la caligine,
acciocché io possa riconoscere bene il dio immortale e l’uomo;
e sotto i gorghi letei il demone malefico
non ritenga per sempre me lontano dai beati;
e nei flutti dell’orrida generazione caduta,
l’anima mia, che pur non vuole a lungo errare,
un’espiazione terribile non costringa nei ceppi della vita.
Ma, o dei, guide di sapienza, fulgidissima,
ascoltatemi, e a chi si affretta verso un cammino che porta in alto,
rivelate i santi deliri e le iniziazioni delle parole sacre.
Ad Afrodite Licia
Cantiamo la regina dei Lici, Afrodite fanciulla,
della cui protezione, che allontana il male, ricolmi,
gli ispirati reggitori della nostra patria, un tempo
innalzarono nella città un santo simulacro,
con il segno del mistico connubio, degli imenei intelligibili,
d’Efesto ardente -e d’Afrodite celeste,
e la chiamarono olimpia dea, e per la sua potenza
spesso al micidial dardo della morte sfuggirono,
ed avevano l’occhio alla virtù; e dai fecondi talami
salda, di chiaro senno, come spiga venne su la prole,
e ovunque era benefica tranquillità di vita.
Orsù, o veneranda, accogli anche la nostra offerta di buone parole,
giacché anch’io sono di sangue licio.
E dalla turpitudine alla suprema bellezza solleva l’anima,
sfuggita al pungolo esiziale della brama terrena.
Ad Ecate e a Giano
Salve, o madre degli dei, dai molti nomi, dalla bella prole;
salve, o Ecate, custode delle porte, di gran potenza;
ma anche a te salve, o Giano, progenitore, Zeus imperituro;
salve Zeus supremo;
rendete luminoso il cammino della mia vita,
colmo di beni, stornate i funesti morbi
dalle mie membra, e l’anima, che sulla terra delira,
traete in alto, purificata dalle iniziazioni che risvegliano la mente.
Vi supplico, tendetemi la mano, e le divine vie
mostratemi, ché le desidero; la luce preziosissima io voglio mirare,
onde m’è dato fuggire la turpitudine della fosca generazione.
Vi supplico, porgetemi la mano, e con i vostri soffi
me travagliata sospingete nel porto della pietà.
Salve, o madre degli dei, dai molti nomi, dalla bella prole;
salve, o Ecate, custode delle porte, di gran potenza; ma anche a te
salve, o Giano, progenitore, Zeus imperituro; salve Zeus supremo.
Ad Atena Polymetis
Ascoltami, o figlia dell’egioco Zeus, balzata fuori
dalla fonte paterna e dalla più alta catena degli esseri ,
d’animo virile, armata di scudo, di gran forza, figlia di padre possente,
Pallade, Tritogenia, vibratrice di lancia, dall’elmo d’oro,
ascoltami; e accogli, o veneranda, l’inno con animo benevolo;
né lasciare mai, così, ai venti la mia parola,
tu che schiudesti le porte divine della sapienza,
che domasti la genia dei Giganti terrestri in lotta contro gli dei;
tu che, dopo aver fuggito il desiderio d’amore di Efesto di te bramoso,
custodisti intatto il freno infrangibile della tua verginità;
tu che serbasti illacerato nelle profonde cavità
dell’etere il cuore del signore Bacco, un dì scerpito
dalle mani dei Titani; e portandolo lo desti al padre,
acciocché per l’ineffabile volontà del genitore,
da Semele per il mondo rifiorisse un nuovo Dioniso;
tu, di cui la scure, tagliate alla radice le teste dei mostri
nati da Ecate onniveggente, sopì la generazione dei mali;
tu, che facesti tuo il santo potere delle virtù animatrici dei mortali;
tu, che abbellisti tutta quanta la vita con arti varie,
dopo aver ispirato alle anime un’operosità intelligente per il bene comune;
tu, cui fu consacrata sull’alto colle l’Acropoli,
simbolo, o veneranda, dell’eccelsa, grande tua discendenza;
tu, che amasti la terra, nutrice d’eroi, madre d’ogni sapere,
tu, che, dopo aver trionfato sulla sacra brama del fratello di tuo padre,
alla città concedesti che avesse il tuo nome e pensieri nobili,
e là, sotto l’alta pendice del colle, segno manifesto della contesa
per i posteri, facesti germogliare l’ulivo,
quando sui Cecropidi, ad opera di Posidone,
dal mare s’abbatterono infiniti, furiosi flutti,
che flagellavano ogni cosa con la loro risonante corrente.
Ascoltami tu, cui brilla nel volto limpida luce,
e un porto felice concedi a me che erro sulla terra;
dona all’anima la luce pura delle tue sante parole,
e sapienza e amore; e all’amore ispira forza
tanta e tale, quanta dai terrestri abissi
di nuovo mi trarrà verso l’Olimpo, nella dimora del potente padre.
Ma se mi doma errore funesto di vita
– giacché so come spesso sono straziato
da una serie di azioni non sante, che ho commesso con zelo insensato –
sii propizia, o dolce consigliera, salvatrice dei mortali, e non permettere
ch’io diventi preda e strazio di orribili castighi,
in questa plaga terrena abbandonato, poiché prego d’essere tuo.
Concedi fin nel profondo delle mie membra stabile e prospera salute,
e allontana la moltitudine dei tristi morbi, struggitori di corpi;
ti supplico, o regina, e con la tua mano divina
fa’ cessare tutta la miseria delle sofferenze nere.
Concedi alla nave della mia vita venti sereni,
figli, amore, gloria, prosperità, gioia amabile,
persuasione, vaghezza faconda d’amicizia, mente sagace,
forza contro le avversità della vita, il primato fra i cittadini.
Ascoltami, ascoltami, o signora, con molte preghiere a te vengo,
per dura necessità; e tu prestami orecchio amorevole.
IPAZIA DI ALESSANDRIA

Non sono poi tante le donne che hanno avuto la possibilità di distinguersi nella scienza (e purtroppo non solo nella scienza), considerata, fino a non molto tempo fa, appannaggio esclusivo del mondo maschile. Molte hanno dovuto pagare con la vita questa loro passione, quasi fosse una colpa della quale vergognarsi: una donna che con le sue ricerche potesse superare o peggio inficiare i risultati ottenuti dai colleghi maschi, era ritenuta una presuntuosa da relegare in un angolo. Fra queste non si può dimenticare IPAZIA , vissuta ad Alessandria d’Egitto fra la fine del IV e l’inizio del V secolo. Non che Ipazia si fosse avvicinata da sola agli studi scientifici; fu il padre Teone ad indirizzarla su questa via, come lui stesso ci tramanda; nell’intestazione del III libro del suo commento al Sistema matematico di Tolomeo, troviamo scritto: “Commento di Teone di Alessandria al terzo libro del Sistema matematico di Tolomeo. Edizione controllata dalla filosofa Ipazia, mia figlia”. Ipazia grande studiosa di matematica dunque, ma, ed è questo l’aspetto più significativo, anche insegnante: “Introdusse molti alle scienze matematiche” ci dice Filostorgio, e numerose altre testimonianze ci attestano addirittura di sue opere autografe, purtroppo però ora scomparse. Pare comunque che una delle discipline in cui Ipazia seppe distinguersi di più fosse l’astronomia. Ancora Filostorgio e poi Suda, ci informano di interessanti scoperte compiute dalla donna a proposito del moto degli astri, scoperte che ella rese accessibili ai suoi contemporanei con un testo, intitolato Canone astronomico. Ma Ipazia fu anche filosofa molto apprezzata: Socrate Scolatico parla di lei come della terza caposcuola del Platonismo, dopo Platone e Plotino. Damascio ci spiega come seppe passare dalla semplice erudizione alla sapienza filosofica. Pallada poi, in un epigramma, tesse uno degli elogi più belli di Ipazia:
“Quando ti vedo mi prostro, davanti a te e alle tue parole,
vedendo la casa astrale della Vergine,
infatti verso il cielo è rivolto ogni tuo atto
Ipazia sacra, bellezza delle parole,
astro incontaminato della sapiente cultura”.
Come, a ragione, nota Gemma Beretta (Ipazia d’Alessandria, Editori Riuniti) è nel terzo verso che si concentra tutto il senso dell’attività di Ipazia: “Verso il cielo è rivolto ogni tuo atto”, ad indicare da un lato l’amore per l’astronomia, dall’altro la tensione filosofica. Così prosegue la Beretta:
“Quando tracciava una nuova mappa del cielo, Ipazia stava indicando una traiettoria nuova – e insieme antichissima – per mezzo della quale gli uomini e le donne del suo tempo potessero imparare ad orientarsi sulla terra e dalla terra al cielo e dal cielo alla terra senza soluzione di continuità e senza bisogno della mediazione del potere ecclesiastico […]. Ipazia insegnava ad entrare dentro di sé (l’intelletto) guardando fuori (la volta stellata) e mostrava come procedere in questo cammino con il rigore proprio della geometria e dell’aritmetica che, tenute l’una insieme all’altra, costituivano l’inflessibile canone di verità”. Ma scienza e filosofia non devono poi considerarsi discipline separate, come si ricorda anche in Roma al femminile, a cura di Augusto Franchetti, ed. Laterza: “Ipazia […] è maestra di filosofia neoplatonica, una disciplina dove convergevano anche studi di matematica e di geometria, al punto che la stessa Ipazia avrebbe inventato anche macchine come un astrolabio piatto, un idroscopio e un aerometro”. Ipazia poi, anche guida spirituale; uno dei suoi più affezionati discepoli, tale Sinesio, così le scrisse, ormai vinto dalla malattia: “Detto questa lettera dal letto nel quale giaccio. Possa tu riceverla stando in buona salute, o madre, sorella e maestra, mia benefattrice in tutto e per tutto, essere e nome quant’altri mai onorato!”. E le parole con cui prosegue, sono comprensibili solo alla luce di una completa comunione d’anime fra lui e la maestra pagana, al di sopra di ogni credo e di ogni ideologia, se si considera che Sinesio divenne poi vescovo cristiano di Cirene: “E se c’è qualcuno venuto dopo che ti sia caro, io debbo essergli grato poiché ti è caro, e ti prego di salutare anche lui da parte mia come amico carissimo. Se tu provi qualche interesse per le mie cose, bene; in caso contrario, non importano neanche a me”. La vita di Ipazia cominciò ad essere scritta circa vent’anni dopo la sua morte, avvenuta per assassinio nel 415 dopo Cristo. I primi ad occuparsi di lei furono due storici della Chiesa: Socrate Scolastico e Filostorgio. Ottant’anni dopo, Damascio di Damasco tornò a riproporre la sua biografia. Quando Socrate e Filostorgio scrissero le loro opere, molti dei responsabili della morte della filosofa erano ancora vivi: i due quindi rischiarono davvero grosso, accusando tutt’altro che velatamente Cirillo (allora Vescovo di Alessandria) di quel truce delitto. Filostorgio, in particolare, attesta che se i cristiani colti e ormai al margine dell’ortodossia vedevano di buon occhio Ipazia, altri cristiani invece non la tolleravano proprio e si scagliarono contro di lei fino ad ucciderla. Socrate ritorna con vigore sul tema dell’odio e della gelosia: “Ella giunse ad un tale grado di cultura, che superò di gran lunga tutti i filosofi suoi contemporanei. […]. Per la magnifica libertà di parola ed azione, che le veniva dalla sua cultura, accedeva in modo assennato anche al cospetto dei capi della città e non era motivo di vergogna per lei lo stare in mezzo agli uomini. Infatti, a causa della sua straordinaria saggezza, tutti la rispettavano profondamente e provavano verso di lei un timore reverenziale. Per questo motivo, allora, l’invidia si armò contro di lei. Alcuni, dall’animo surriscaldato, guidati da un lettore di nome Pietro, si misero d’accordo e si appostarono per sorprendere la donna mentre faceva ritorno casa. Tiratala giù dal carro, la trascinarono fino alla chiesa che prendeva il nome da Cesario: qui, strappatale la veste, la uccisero colpendola con i cocci. Dopo che l’ebbero fatta a pezzi membro a membro, trasportati questi pezzi al cosiddetto Cinerone, cancellarono ogni traccia di lei nel fuoco”. Diversi altri particolari cogliamo poi nella biografia che scrisse Damascio, cento anni dopo la morte della donna. In particolare questo filosofo, di cultura e religione ellenica, si sofferma molto sul tema della verginità. Un episodio è al proposito significativo: un allievo di Ipazia, ci dice Damascio, si era follemente innamorato di lei. Ipazia, accortasi di questa sua passione, gli presentò una delle pezzuole usate dalle donne per il mestruo e gli disse: “Questo, dunque, ami o giovane, niente di bello”. Damascio poi spiegherebbe, secondo testimonianze posteriori, il significato del gesto di Ipazia: purtroppo però questa parte del suo testo è per noi molto lacunosa. Ancora sull’invidia di Cirillo ritorna Damascio: “Una volta accadde che Cirillo, che era a capo della setta opposta, passando davanti alla casa di Ipazia, vedesse che vi era una gran ressa di fronte alle porte, confusione di uomini e di cavalli, gente che si avvicinava, che si allontanava, che ancora si accalcava, avendo chiesto cosa fosse quella moltitudine e di chi la casa presso la quale c’era quella confusione, si sentì rispondere da quelli del suo seguito che in quel momento veniva salutata la filosofa Ipazia e che era la sua casa. Saputo ciò, egli si rose a tal punto nell’anima che tramò la sua uccisione in modo che avvenisse al più presto, uccisione tra tutte la più empia”. I meriti di Ipazia furono molti. Secondo Socrate Scolastico e Damascio, con Ipazia si era finalmente realizzata nel mondo la mitica “politeia” in cui erano i filosofi a decidere le sorti della città. Ipazia fece ritornare ad Alessandria la filosofia. Il pensiero platonico però, assunse con lei una configurazione nuova: in particolare, secondo Socrate Scolastico, Ipazia non apparteneva alla schiera di quei filosofi che “spiegano le opere di Platone e di Plotino”. Ella “ereditò la scuola platonica che era stata riportata in vita da Plotino, e spiegava tutte le scienze filosofiche a coloro che lo desideravano”. Ipazia affiancava, dice Beretta, “ad un insegnamento esoterico un insegnamento pubblico, simile a quello dei sofisti moralizzatori del I secolo”. Caratteristica di Ipazia fu dunque la generosità con cui tramandava il suo sapere a quanti stavano attorno a lei. Ella non riservava la conoscenza per sé e per pochi eletti, ma con estrema liberalità la dispensava agli altri. Damascio riferisce, in base alle testimonianze ottenute, che “la donna, gettatosi addosso il mantello e facendo le sue uscite in mezzo alla città, spiegava pubblicamente, a chiunque volesse ascoltarla, Platone o Aristotele o le opere di qualsiasi altri filosofo”. Ipazia era molto amata per questo dal popolo e ciò le conferiva una grande autorità. Così scrive Socrate Scolastico: “A causa della sua straordinaria saggezza tutti la rispettavano profondamente e provavano verso di lei un timore reverenziale”. Fa eco Damascio: “Poiché tale era la natura di Ipazia, era cioè pronta e dialettica nei discorsi, accorta e politica nelle azioni, il resto della città a buon diritto la amava e la ossequiava grandemente e i capi, ogni volta che si prendevano carico delle questioni pubbliche, erano soliti recarsi prima da lei”. Non solo il popolo dunque la venerava, ma anche molte delle autorità della cittadine.
Con la morte di Ipazia, si potè considerare distrutta una delle più esemplari comunità scientifiche di ogni epoca. Quello che è strano però, è che nessuno, poi, si sia proclamato suo allievo. Nessuno filosofo si dichiarò suo erede. Probabilmente, ipotizza la Beretta, i motivi vanno ricercati nel fatto che Cirillo, considerato dalle fonti principali il responsabile del suo assassinio, “detenne la carica di vescovo della città per i successivi 29 anni (egli, infatti, morì nel 444), nel corso dei quali divenne l’episcopo più potente e temuto di tutto l’impero d’Oriente”. Ma perché Cirillo odiava tanto Ipazia? Certo, l’invidia (phthonos) per la considerazione e la notorietà che questa donna aveva raggiunto nella sua città giocò un ruolo notevole. Ma le cause del rancore del vescovo di Alessandria contro la nostra filosofa hanno una radice ben più politica e religiosa. Nel 391 dopo Cristo, Teodosio aveva proclamato il Cristianesimo religione di stato. Nel 392 fu promulgata anche una legge speciale contro i culti pagani. I cattolici dell’impero romano d’oriente potevano contare quindi sul pieno appoggio del potere temporale, dopo anni passati a professare la loro fede nei recessi delle catacombe. Evidentemente alcuni cristiani, fortunatamente pochi, potendo finalmente divulgare in modo aperto il loro credo, ripagarono i pagani dei torti subiti con altra violenza. Cirillo addirittura arrivò ad arruolare dei monaci, torme di uomini, spesso analfabeti, “che vagavano di città in città”, scrive Silvia Ronchey nel saggio Ipazia, l’intellettuale, che fa parte del citato Roma al femminile “pieni d’odio sociale non solo contro i pagani ma contro il mondo civile in genere”. “Sono costoro”, ha scritto Evelyne Patlagen, “che spingono l’impassibilità ascetica alla sovversione”. Suida non esita a definirli “esseri abominevoli, vere bestie”. Il clima sociale di Alessandria d’Egitto era dunque, a cavallo fra quarto e quinto secolo, molto instabile. La comunità cristiana era la più forte e teneva a far valere questo suo potere.
Cirillo rappresentava il massimo del potere ecclesiastico, ma Ipazia era il fulcro della cultura, occupando la prestigiosa cattedra di filosofia: “Dopo la morte di suo padre ne aveva ereditato l’insegnamento,” annota la Ronchey “ed era un insegnamento estremamente illustre, poiché derivava dal grande neoplatonico Plotino. Le successioni dei professori di filosofia venivano registrate in città come la successione dei vescovi”. Ma il vescovo cristiano doveva avere il monopolio della ‘parrhesia’ (libertà di parola e di azione; ndr)” ha scritto Peter Brown, proponendo, per quanto riguarda Ipazia, un sillogismo molto chiaro: “Se nella fase di passaggio dal paganesimo al cristianesimo i compiti del filosofo e del vescovo vengono a sovrapporsi, che cosa fa il vescovo, se non eliminare il filosofo?”. La Ronchey non si accontenta di questa spiegazione e va oltre: “Gli elementi in conflitto non sono tanto paganesimo e cristianesimo, quanto le classi dirigenti (locale e romana), le categorie sociali (antica aristocrazia, nuova “burocrazia” ecclesiale), i bellicosi gruppi etnici, nel clima d’instabilità che caratterizza il passaggio dei poteri e l’instaurarsi del cristianesimo nella vita e nelle strutture cittadine del tardo impero romano”. La figura di Ipazia affascinò molto la letteratura di ogni epoca. E se Socrate Scolastico e Damascio lanciarono delle accuse pesanti ai danni di Cirillo, non mancarono autori che difesero spudoratamente il vescovo cattolico. Fra questi Giovanni di Nikiu, che considera il linciaggio della filosofa una meritata punizione: “Ipazia ipnotizzava i suoi studenti con la magia e si dedicava alla satanica scienza degli astri”. La parte conclusiva del suo racconto è al proposito molto esplicativa: “Tutta la popolazione circondò il patriarca Cirillo e lo chiamò nuovo Teofilo, perché aveva liberato la città dagli ultimi idoli”. A prescindere dalle prese di posizione degli storici, Cirillo non dovette scontare alcuna pena per l’assassinio di Ipazia. Il monofisismo invece, l’eresia basata sulle sue dottrine, verrà condannato a Calcedonia nel 451. Anche Voltaire parla di Ipazia nelle Questions sur l’Encyclopédie (1772), sottolineandone soprattutto l’avvenenza e l’ingiusta condanna. In altri suoi scritti considererà la sua morte “excès du fanatism”. Da Voltaire l’eco di Ipazia rimbalzerà fino all’italiano Vincenzo Monti: “La voce alzate, o secoli caduti,/ Gridi l’Africa all’Asia e l’innocente/ Ombra d’Ipazia il grido orrendo aiuti”. In Gran Bretagna Ipazia non venne dimenticata: l’irlandese John Toland scrisse nel 1720 un saggio intitolato Ipazia, ovvero “la storia di una Dama assai bella, assai virtuosa, assai istruita e perfetta sotto ogni riguardo, che venne fatta a pezzi dal Clero di Alessandria per compiacere l’Orgoglio, l’Emulazione e la Crudeltà del loro Vescovo, comunemente ma immeritatamente denominato San Cirillo”. Non allo stesso modo la pensava evidentemente Lewis, se nel 1721 scrisse La storia di Ipazia, “assai impudente professoressa di Alessandria: in Difesa di San Cirillo e del Clero Alessandrino dalle calunnie di Mr. Toland”. Il Settecento protestante di certo non scordò Ipazia; Gibbon nel Decline and Fall non si risparmiò critiche per il vescovo di Alessandria: “Ipazia fu disumanamente macellata dalle nude mani di Pietro il Lettore e da quelle di una ciurma di selvaggi e implacabili fanatici […] ma l’assassinio di Ipazia impresse un marchio indelebile sul carattere della religione di Cirillo d’Alessandria”. Henry Fielding, in una satira, arriva ad immaginare un fidanzamento fra Ipazia e Giuliano l’Apostata. Con l’avvento della Controriforma cattolica si cercò di cambiare le carte in tavola, arrivando a mettere in discussione l’attendibilità delle fonti e di conseguenza la responsabilità di Cirillo: nell’Ottocento si scrisse che “Cirillo devesi ritenere pienamente di ogni colpa giustificato da ogni buon credente per essere stato fatto santo dalla chiesa”. E non mancò qualche poetessa che romanzò tutta quanta la storia, come la marchesa Diodata Saluzzo Roero, membro dell’Accademia Torinese delle Scienze e dell’Arcadia, che nel suo lungo Ipazia, ossia delle filosofe (1827) presentò la filosofa come martire cristiana: “Languida rosa sul reciso stelo/ Nel sangue immersa la vergin giacea/ Avvolta a mezzo nel suo bianco velo/ Soavissimamente sorridea/ Condonatrice de l’altrui delitto/ Mentre il gran segno redentor stringea”. Ciò che comunque i più riconobbero e apprezzarono in Ipazia, fu la fedeltà al platonismo e all’ellenismo, come ben spiega Charles Peguy: “Ciò che noi amiamo e ciò che onoriamo è questo miracolo di fedeltà, […] che un’anima sia stata così perfettamente in accordo con l’anima platonica e con la sua discendente, l’anima plotiniana, e in generale con l’anima ellenica, con l’anima della sua razza, con l’anima del suo maestro, con l’anima di suo padre, in un accordo così profondo, così intimo, che raggiungeva così profondamente le fonti stesse e le radici, che in un annientamento totale, quando tutt’un mondo, quando tutto il mondo andava discordandosi, per tutta la vita temporale del mondo, e forse dell’eternità, essa sola sia rimasta in accordo, sino alla morte”.
ANDRONICO DI RODI
Nel I secolo a. C., i principali esponenti del Peripato – la scuola filosofica a suo tempo fondata da Aristotele – furono i seguenti: Stasea di Napoli, Aristone di Alessandria, Cratippo di Pergamo, Andronico di Rodi, Boeto di Sidone, Senarco di Seleucia e Nicola di Damasco. Il più importante di questa costellazione di autori fu, indubbiamente, Andronico di Rodi, per il fatto che la sua edizione del Corpus Aristotelicum, determinò la rinascita dell’Aristotelismo e, al tempo stesso, il mutamento di qualità nei contenuti e nel metodo che si registra in una parte dei filosofi peripatetici di quest’epoca. Stasea di Napoli nacque negli ultimi decenni del II secolo a.C.. Svolse l’attività di retore e di filosofo, sviluppando con particolare enfasi le tematiche portanti del dibattito peripatetico del III e del II secolo a. C. Opponendosi al rigorismo estremo degli Stoici, Stasea sostenne che, per poter raggiungere la felicità, erano molto importanti anche i beni esterni e corporei, svalutati dalla scuola stoica. Tra questi beni esterni, un ruolo importantissimo è quello svolto dalla fortuna. Dal canto suo, Aristone di Alessandria fu, inizialmente, allievo di Antioco. Lucullo lo conobbe negli anni 86/87 a.C. ad Alessandria, presso il circolo degli Accademici. Aristone si interessò alla sillogistica, e aggiunse tre modi alla prima figura del sillogismo e due alla seconda figura. Non sappiamo, di preciso, che cosa abbia indotto Aristone a lasciare Antioco. La riscoperta delle opere di Aristotele e l’edizione di Apellicone (non necessariamente quella di Andronico) potrebbero aver costituito un buon motivo. Anche Cratippo di Pergamo fu, all’inizio, un allievo di Antioco. Insegnò a Mitilene e dal 47/46 a.C. ad Atene, dove suo allievo fu, tra gli altri, il figlio di Cicerone. La sua fama era abbastanza grande, a tal punto che Cicerone stesso lo considera come autorità somma e il migliore dei Peripatetici dell’epoca. Non abbiamo tuttavia notizie circa la sua nomina a scolarca. I suoi interessi orbitarono principalmente intorno all’etica, e, nella fattispecie, ai “doveri morali”. Però le uniche informazioni che ci sono giunte sul suo conto riguardano la “mantica”: da ciò risulta in modo lampante come Cratippo si richiamasse a una psicologia platonico-aristotelica che ritroviamo nelle opere pubblicate di Aristotele. La mantica di Cratippo non è quella dei Parva naturalia di Aristotele e la sua dottrina della psyché non è quella esposta nel De anima. Se ne inferisce che Cratippo non conobbe le opere di scuola dello Stagirita. Dal canto suo, Andronico di Rodi si distinse per l’edizione sistematica degli scritti di Aristotele e per la compilazione di cataloghi ragionati: lavoro di fondamentale importanza, destinato a costituire l’indispensabile premessa nonché il fondamento per la rinascita dell’Aristotelismo. Ma quali furono, in concreto, i criteri seguiti da Andronico nella sua edizione del «Corpus Aristotelicum»? Come procedette Andronico nel suo lavoro di editore? Egli non si limitò a fornire una lezione intelligibile dei testi, ma si preoccupò anche di raggruppare quegli scritti che trattavano la medesima materia e di riordinarli sulla base, appunto, del loro contenuto. Disponiamo, a questo riguardo, di un’importante testimonianza di Porfirio, il dotato allievo di Plotino. Porfirio, nell’ilustrare i criteri da lui seguiti nel pubblicare gli scritti plotiniani, scrive quanto segue (Vita di Plotino, 24, traduzione di Giuseppe Girgenti):
“Dato che egli stesso [Plotino] mi aveva incaricato dell’ordinamento e della correzione dei suoi scritti, e gliel’avevo promesso in vita e avevo anche annunciato ad altri amici che l’avrei fatto, innanzitutto ho deciso di non seguire l’ordine cronologico dei trattati, che sono stati scritti senza un preciso piano, ma di imitare Apollodoro di Atene e Andronico il Peripatetico, che hanno realizzato l’edizione rispettivamente del commediografo Epicarmo, raccolta in dieci tomi, e delle opere di Aristotele e di Teofrasto, suddivise e riunite nello stesso tomo per argomenti affini; analogamente, io, avendo cinquantaquattro trattati di Plotino, li ho distribuiti in sei Enneadi, ben contento di coniugare la perfezione del numero sei e del nove, in modo da raccogliere in ogni Enneade i trattati affini e da porre al primo posto i problemi più semplici”.
Se ne ricava, dunque, il principio generale che guidò Andronico nella sua operazione editoriale. Andronico riunì alcuni brevi trattati che erano più o meno autonomi (dotati peraltro di un loro titolo particolare) a trattati più corposi dedicati ai medesimi argomenti. A volte, egli ha anche dato nuovi titoli alle opere così costituite. È assai probabile, per esempio, che proprio a lui risalga la organizzazione di tutte le opere logiche in un unico corpus e lo stesso titolo di Organon dato ad esso. Dalla logica aristotelica, infatti, egli pensava dovesse iniziare lo studio sistematico della filosofia. In modo analogo, procedette con i vari scritti di carattere fisico, metafisico, etico, politico, estetico e retorico. L’ordinamento generale e particolare che Andronico impresse al Corpus Aristotelicum restò definitivo e, a ben vedere, condizionò tutta la tradizione a venire, e, quindi, anche le moderne edizioni. Si tratta – non è difficile capirlo – di un lavoro di fondamentale importanza per la tradizione occidentale, che su di esso si basò per secoli. Ma chi fu, in concreto e al di là di questa operazione editoriale così ricca di conseguenze per la Wirkungsgeschichte (la “storia degli effetti”) dell’Aristotelismo, Andronico? Fonti neoplatoniche ci suggeriscono che egli fu l’undicesimo scolarca del Peripato: ma quelle stesse fonti lasciano un vuoto (di almeno due nomi) fra Diodoro e Andronico. Qualora si consideri il fatto che proprio nel periodo corrispondente a questo vuoto ebbero luogo l’assedio di Silla ad Atene, il danneggiamento del Liceo, la confisca e il trasporto a Roma delle opere di scuola di Aristotele e la forzata interruzione dell’attività della Scuola, non è fuorviante immaginare che proprio Andronico abbia potuto ricostituire il Peripato. Per quel che riguarda la sua attività filosofica, occorre notare che essa non si ridusse affatto alla merta esegesi e al mero commento del verbo aristotelico. Possiamo venire a capo della libertà con cui Andronico trattava la problematica aristotelica soprattutto se prendiamo le mosse da ciò che ci è stato tramandato relativamente alla sua interpretazione delle Categorie aristoteliche. Anche in psicologia sembra che Andronico si sia spinto oltre Aristotele, concependo l’anima come quel rapporto numerico che collega gli elementi del corpo, e quindi come numero e addirittura come “numero semovente”, come peraltro aveva già fatto lo stesso Senocrate. Le fonti tramandano poi che Andronico oscillò fra questa concezione e quella che fa dell’anima non la “causa”, ma l’“effetto” della composizione degli elementi del corpo. In sostanza, se è vero che passò alla storia per il suo preziosissimo lavoro editoriale, è anche vero che la sua attività non può essere appiattita su quel lavoro: Andronico maturò un proprio autonomo profilo filosofico, cercando di imprimere una svolta all’Aristotelismo. Allievo diretto, nonché successore, di Andronico di Rodi fu Boeto di Sidone, il quale – se ci atteniamo alle testimonianze – diede di Aristotele una “interpretazione naturalistica”. Mentre Andronico proponeva di incominciare lo studio della filosofia partendo dalla “logica” (che è come lo strumento, e che, dunque, è la prima cosa che occorre conoscere), Boeto proponeva di cominciare dalla “fisica”, per il fatto che questa ci mette a contatto con le cose che per noi sono più familiari e conosciute e la ricerca filosofica deve, appunto, muovere da ciò che è più familiare e noto a ciò che è meno familiare e meno noto. Le tendenze naturalistiche di Boeto risultano lampanti anche da quanto ci è riferito intorno al suo Commentario alle Categorie, in particolare circa la sua interpretazione della prima categoria, ossia della “sostanza”: essa è per lui la materia e il composto e non la forma. In effetti, sembra che secondo Boeto la forma cadesse fuori della categoria di sostanza e rientrasse nell’ambito di altre categorie. Di conseguenza, per Boeto l’individuo è non solo “per noi”, ma anche “per natura” la realtà prima. Il punto estremo di questo progressivo allontanamento dall’originario messaggio di Aristotele fu però raggiunto, nel Peripato, da Senarco di Seleucia, che quasi giunse alla rottura con l’Aristotelismo. Tale rottura risulta palese soprattutto sotto due profili: a) Senarco negò l’esistenza dell’etere, scrivendo un intero trattato Contro la quinta sostanza; b) negò pure l’esistenza del soprasensibile (e quindi del “Motore Immobile”). In questo modo, benché egli continuasse imperterrito ad autocertificarsi come “peripatetico”, il suo pensiero era ormai distantissimo dall’Aristotelismo.
LICONE

Nel I secolo a. C., i principali esponenti del Peripato – la scuola filosofica a suo tempo fondata da Aristotele – furono i seguenti: Stasea di Napoli, Aristone di Alessandria, Cratippo di Pergamo, Andronico di Rodi, Boeto di Sidone, Senarco di Seleucia e Nicola di Damasco. Il più importante di questa costellazione di autori fu, indubbiamente, Andronico di Rodi, per il fatto che la sua edizione del Corpus Aristotelicum, determinò la rinascita dell’Aristotelismo e, al tempo stesso, il mutamento di qualità nei contenuti e nel metodo che si registra in una parte dei filosofi peripatetici di quest’epoca. Stasea di Napoli nacque negli ultimi decenni del II secolo a.C.. Svolse l’attività di retore e di filosofo, sviluppando con particolare enfasi le tematiche portanti del dibattito peripatetico del III e del II secolo a. C. Opponendosi al rigorismo estremo degli Stoici, Stasea sostenne che, per poter raggiungere la felicità, erano molto importanti anche i beni esterni e corporei, svalutati dalla scuola stoica. Tra questi beni esterni, un ruolo importantissimo è quello svolto dalla fortuna. Dal canto suo, Aristone di Alessandria fu, inizialmente, allievo di Antioco. Lucullo lo conobbe negli anni 86/87 a.C. ad Alessandria, presso il circolo degli Accademici. Aristone si interessò alla sillogistica, e aggiunse tre modi alla prima figura del sillogismo e due alla seconda figura. Non sappiamo, di preciso, che cosa abbia indotto Aristone a lasciare Antioco. La riscoperta delle opere di Aristotele e l’edizione di Apellicone (non necessariamente quella di Andronico) potrebbero aver costituito un buon motivo. Anche Cratippo di Pergamo fu, all’inizio, un allievo di Antioco. Insegnò a Mitilene e dal 47/46 a.C. ad Atene, dove suo allievo fu, tra gli altri, il figlio di Cicerone. La sua fama era abbastanza grande, a tal punto che Cicerone stesso lo considera come autorità somma e il migliore dei Peripatetici dell’epoca. Non abbiamo tuttavia notizie circa la sua nomina a scolarca. I suoi interessi orbitarono principalmente intorno all’etica, e, nella fattispecie, ai “doveri morali”. Però le uniche informazioni che ci sono giunte sul suo conto riguardano la “mantica”: da ciò risulta in modo lampante come Cratippo si richiamasse a una psicologia platonico-aristotelica che ritroviamo nelle opere pubblicate di Aristotele. La mantica di Cratippo non è quella dei Parva naturalia di Aristotele e la sua dottrina della psyché non è quella esposta nel De anima. Se ne inferisce che Cratippo non conobbe le opere di scuola dello Stagirita. Dal canto suo, Andronico di Rodi si distinse per l’edizione sistematica degli scritti di Aristotele e per la compilazione di cataloghi ragionati: lavoro di fondamentale importanza, destinato a costituire l’indispensabile premessa nonché il fondamento per la rinascita dell’Aristotelismo. Ma quali furono, in concreto, i criteri seguiti da Andronico nella sua edizione del «Corpus Aristotelicum»? Come procedette Andronico nel suo lavoro di editore? Egli non si limitò a fornire una lezione intelligibile dei testi, ma si preoccupò anche di raggruppare quegli scritti che trattavano la medesima materia e di riordinarli sulla base, appunto, del loro contenuto. Disponiamo, a questo riguardo, di un’importante testimonianza di Porfirio, il dotato allievo di Plotino. Porfirio, nell’ilustrare i criteri da lui seguiti nel pubblicare gli scritti plotiniani, scrive quanto segue (Vita di Plotino, 24, traduzione di Giuseppe Girgenti):
“Dato che egli stesso [Plotino] mi aveva incaricato dell’ordinamento e della correzione dei suoi scritti, e gliel’avevo promesso in vita e avevo anche annunciato ad altri amici che l’avrei fatto, innanzitutto ho deciso di non seguire l’ordine cronologico dei trattati, che sono stati scritti senza un preciso piano, ma di imitare Apollodoro di Atene e Andronico il Peripatetico, che hanno realizzato l’edizione rispettivamente del commediografo Epicarmo, raccolta in dieci tomi, e delle opere di Aristotele e di Teofrasto, suddivise e riunite nello stesso tomo per argomenti affini; analogamente, io, avendo cinquantaquattro trattati di Plotino, li ho distribuiti in sei Enneadi, ben contento di coniugare la perfezione del numero sei e del nove, in modo da raccogliere in ogni Enneade i trattati affini e da porre al primo posto i problemi più semplici”.
Se ne ricava, dunque, il principio generale che guidò Andronico nella sua operazione editoriale. Andronico riunì alcuni brevi trattati che erano più o meno autonomi (dotati peraltro di un loro titolo particolare) a trattati più corposi dedicati ai medesimi argomenti. A volte, egli ha anche dato nuovi titoli alle opere così costituite. È assai probabile, per esempio, che proprio a lui risalga la organizzazione di tutte le opere logiche in un unico corpus e lo stesso titolo di Organon dato ad esso. Dalla logica aristotelica, infatti, egli pensava dovesse iniziare lo studio sistematico della filosofia. In modo analogo, procedette con i vari scritti di carattere fisico, metafisico, etico, politico, estetico e retorico. L’ordinamento generale e particolare che Andronico impresse al Corpus Aristotelicum restò definitivo e, a ben vedere, condizionò tutta la tradizione a venire, e, quindi, anche le moderne edizioni. Si tratta – non è difficile capirlo – di un lavoro di fondamentale importanza per la tradizione occidentale, che su di esso si basò per secoli. Ma chi fu, in concreto e al di là di questa operazione editoriale così ricca di conseguenze per la Wirkungsgeschichte (la “storia degli effetti”) dell’Aristotelismo, Andronico? Fonti neoplatoniche ci suggeriscono che egli fu l’undicesimo scolarca del Peripato: ma quelle stesse fonti lasciano un vuoto (di almeno due nomi) fra Diodoro e Andronico. Qualora si consideri il fatto che proprio nel periodo corrispondente a questo vuoto ebbero luogo l’assedio di Silla ad Atene, il danneggiamento del Liceo, la confisca e il trasporto a Roma delle opere di scuola di Aristotele e la forzata interruzione dell’attività della Scuola, non è fuorviante immaginare che proprio Andronico abbia potuto ricostituire il Peripato. Per quel che riguarda la sua attività filosofica, occorre notare che essa non si ridusse affatto alla merta esegesi e al mero commento del verbo aristotelico. Possiamo venire a capo della libertà con cui Andronico trattava la problematica aristotelica soprattutto se prendiamo le mosse da ciò che ci è stato tramandato relativamente alla sua interpretazione delle Categorie aristoteliche. Anche in psicologia sembra che Andronico si sia spinto oltre Aristotele, concependo l’anima come quel rapporto numerico che collega gli elementi del corpo, e quindi come numero e addirittura come “numero semovente”, come peraltro aveva già fatto lo stesso Senocrate. Le fonti tramandano poi che Andronico oscillò fra questa concezione e quella che fa dell’anima non la “causa”, ma l’“effetto” della composizione degli elementi del corpo. In sostanza, se è vero che passò alla storia per il suo preziosissimo lavoro editoriale, è anche vero che la sua attività non può essere appiattita su quel lavoro: Andronico maturò un proprio autonomo profilo filosofico, cercando di imprimere una svolta all’Aristotelismo. Allievo diretto, nonché successore, di Andronico di Rodi fu Boeto di Sidone, il quale – se ci atteniamo alle testimonianze – diede di Aristotele una “interpretazione naturalistica”. Mentre Andronico proponeva di incominciare lo studio della filosofia partendo dalla “logica” (che è come lo strumento, e che, dunque, è la prima cosa che occorre conoscere), Boeto proponeva di cominciare dalla “fisica”, per il fatto che questa ci mette a contatto con le cose che per noi sono più familiari e conosciute e la ricerca filosofica deve, appunto, muovere da ciò che è più familiare e noto a ciò che è meno familiare e meno noto. Le tendenze naturalistiche di Boeto risultano lampanti anche da quanto ci è riferito intorno al suo Commentario alle Categorie, in particolare circa la sua interpretazione della prima categoria, ossia della “sostanza”: essa è per lui la materia e il composto e non la forma. In effetti, sembra che secondo Boeto la forma cadesse fuori della categoria di sostanza e rientrasse nell’ambito di altre categorie. Di conseguenza, per Boeto l’individuo è non solo “per noi”, ma anche “per natura” la realtà prima. Il punto estremo di questo progressivo allontanamento dall’originario messaggio di Aristotele fu però raggiunto, nel Peripato, da Senarco di Seleucia, che quasi giunse alla rottura con l’Aristotelismo. Tale rottura risulta palese soprattutto sotto due profili: a) Senarco negò l’esistenza dell’etere, scrivendo un intero trattato Contro la quinta sostanza; b) negò pure l’esistenza del soprasensibile (e quindi del “Motore Immobile”). In questo modo, benché egli continuasse imperterrito ad autocertificarsi come “peripatetico”, il suo pensiero era ormai distantissimo dall’Aristotelismo.
ARISTONE DI CEO
Aristone di Ceo fu il successore di Licone nella direzione del Peripato, la scuola filosofica originariamente fondata da Aristotele. Nacque a Iuli nell’isola di Ceo. La sua acmé cade, con buone probabilità, verso la fine della seconda metà del III secolo a.C. I suoi frammenti sono stati raccolti e commentati da F. Wehrli, Die Schule des Aristoteles (La scuola di Aristotele), Heft VI: Lykon und Ariston von Keos, Basel 1952. Non diversamente da Licone, anche Aristone non si distinse per originalità né per profondità teoretica, contribuendo a far vivere il Peripato in una stagione di grigia stagnazione culturale, ben distante dalla frenetica attività che lo contraddistingueva ai tempi di Aristotele. La scarsa profondità teoretica di Aristone di Ceo – come già, del resto, quella di Licone – fu però compensata dalla grande eleganza stilistica con cui erano architettati i suoi scritti, contraddistinti da un periodare particolarmente piacevole. Questo aspetto fu sottolineato, tra gli altri, da Cicerone, il quale ebbe a notare (De finibus, V, 5, 13):
“Fu poi armonioso e beato il suo [di Licone] successore Aristone, ma non ebbe la serietà che si richiede ad un grande filosofo: i suoi scritti sono certo molto eleganti, ma non so come, il suo modo di esporre manca di autorità”.
Questo giudizio dell’Arpinate può apparire, a tutta prima, poco generoso: eppure corrisponde, almeno in parte, alla verità, se solo si considera che i pochissimi frammenti di Aristone che ci sono pervenuti ci trasmettono effettivamente l’immagine di un pensatore poco profondo e tutt’altro che originale. Se esaminata più da vicino, la riflessione filosofica intrapresa da Aristone si inscrive in quel genere particolare avviato, sempre nell’ambito della scuola aristotelica, da Teofrasto tramite la sua opera Caratteri, contraddistinta dalla tendenza “fenomenologica” – diremmo oggi – a descrivere (dunque rimanendo in superficie) i “caratteri” della realtà. Si tratta, come è evidente, di una tendenza teoreticamente disimpegnata, che non ambisce a profondità alcuna. In questo senso – come già abbiamo sottolineato – il contributo di Aristone fu davvero poco originale: egli diresse il Peripato senza rinnovarlo, ma, per l’appunto, limitandosi a farlo sopravvivere così come l’aveva ereditato.
CRITOLAO DI FASELIDE
Critolao di Faselide diresse verosimilmente il Peripato – la scuola filosofica originariamente fondata da Aristotele – subito dopo Aristone di Ceo, a sua volta succeduto a Licone. Critolao volle, almeno nelle intenzioni, mantenersi fedele all’insegnamento originario del maestro Aristotele, insuperabile fondatore del Peripato: suo proposito era semplicemente quello di ergersi a custode dell’originario verbo aristotelico, nella convinzione che già lì fosse racchiusa la verità. In realtà, Critolao non tenne fede ai propri progetti e, più o meno consapevolmente, finì per accostarsi allo Stoicismo. È vero, Critolao propugnò strenuamente – senza alcuna innovazione – la tesi sostenuta a suo tempo da Aristotele secondo cui il mondo e il genere umano sarebbero eterni, ma ciò non di meno si allontanò da Aristotele, avvicinandosi allo Stoicismo, nella misura in cui sostenne che l’anima era materiale e che la psyché doveva essere identificata con la “quinta substantia”, cioè con l’etere. In questo modo, l’aristotelismo veniva abbandonato in favore dello stoicismo, secondo un movimento peraltro già compiuto, seppur in modo diverso, da Licone. Come si ricorderà, l’avvicinamento di Licone allo Stoicismo fu soprattutto un avvicinamento etico, in quanto Licone fece sua l’idea stoica dell’“autosufficienza” del saggio. Critolao, come abbiamo appena visto, si avvicinò allo Stoicismo per quel che riguarda le teorie sull’anima. Ma anche in sede etica non rimase insensibile alle teorie stoiche: in particolare – andando anche in ciò contro le tesi di Aristotele – sostenne apertamente la tesi secondo cui il piacere è un male e che, inoltre, è un male che si contraddistingue per il fatto che può generare molti altri mali. Ben traspare, da questa posizione, un’influenza del rigorismo etico (fortemente antiepicureo e antiedonistico) degli Stoici. Critolao tentò, inoltre, di compatibilizzare tra loro – con risultati discutibili – lo Stoicismo e l’Aristotelismo dal punto di vista della teoria dei beni: Critolao ribadì la dottrina peripatetica secondo cui vi sono tre classi di beni, ma – avvicinandosi ancora allo Stoicismo – sostenne che i “beni esteriori” e i “beni del corpo” (pur essendo, per l’appunto, beni e non “indifferenti”) sono incommensurabilmente inferiori alla “virtù”, vale a dire ai “beni dell’anima”. In questa maniera, l’Aristotelismo veniva “stoicizzato”: ponendo su un’immaginaria “bilancia” i beni del corpo e quelli dell’anima, Critolao riconosceva apertamente il maggior peso dei secondi, svalutando i primi. Secondo la preziosa testimonianza di Cicerone (Tusc. disput., V 17, 50):
“E qui io mi domando il valore che può avere la famosa bilancia di Critolao. Pone, Critolao, su un piatto i beni spirituali, sull’altro quelli fisici ed esteriori: il piatto dei beni spirituali, egli dice, s’abbasserà talmente che neppure la terra e il mare riuscirebbero, col loro peso, a ristabilire l’equilibrio” .
Questa, che voleva essere una soluzione compromissoria, in grado di sposare tra loro le tesi etiche dell’Aristotelismo e dello Stoicismo, si sarebbe presto rivelata una via impercorribile, soprattutto se si considera che lo Stoicismo non poteva accettare in alcun modo l’etichetta di “bene” attribuita a qualcosa che non fosse la virtù.
IERONIMO DI RODI
Ieronimo di Rodi fu contemporaneo del neo-aristotelico Licone: mentre Licone impresse all’originaria dottrina aristotelica una svolta stoica, Ieronimo tentò di sposare l’aristotelismo con l’epicureismo. Alla luce di questi presupposti, non stupisce certo se tra Licone e Ieronimo – che pure erano entrambi di formazione aristotelica – non corse buon sangue: tra di loro vi fu quell’inimicizia che, a ben vedere, contraddistinse i rapporti tra Epicurei e Stoici (inimicizia che, detto per inciso, appare evidente quando Seneca deve giustificarsi, nelle Lettere a Lucilio, per aver cercato di prendere il meglio dalle due scuole rivali, comportandosi come un “esploratore” privo di preconcetti). In netta opposizione al rigorismo stoicheggiante di Licone – il cui modello restava quello stoico dell’autosufficienza del saggio –, Ieronimo sostenne apertamente l’identità tra il sommo bene e l’assenza di dolore: tesi, questa, chiaramente riconducibile al tema epicureo dell’atarassia, dell’aponia e dell’alupia. Per converso – spiega Ieronimo – il dolore coincide con il sommo male: tesi, anch’essa, squisitamente epicurea. Disponiamo di numerose testimonianze su Ieronimo, molte delle quali provengono da Cicerone. L’Arpinate – in forza della sua ben nota avversione per l’epicureismo – è assai critico verso Ieronimo, di cui rigetta – come del resto fa anche con Epicuro – l’insegnamento morale votato all’edonismo. Scrive Cicerone (De finibus, II, 3, 8):
“– Ricordi la definizione che Ieronimo di Rodi dà del sommo bene, a cui ritiene si debba riferire ogni cosa?
– Sì; secondo lui il termine estremo è l’assenza del dolore.
– E sempre il medesimo che pensa del piacere?
– Dice che non è desiderabile per se stesso.
– Dunque ritiene che altro è provar gioia, altro dolore”.
E aggiunge, con tono decisamente polemico (De finibus, II, 13, 41):
“E non bisogna dar retta a Ieronimo, per cui il sommo bene si identifica con quello che voi talvolta, o meglio troppo spesso, dite tale: il non provar dolore. Giacché, se il dolore è un male, non è sufficiente per vivere bene mancare di tale male”.
L’obiezione di Cicerone a Ieronimo è lineare: l’eliminazione del dolore non basta per vivere bene. Il “vivere bene” (“eu zen”, secondo la terminologia dei Greci) è qualcosa in più, che non può essere ridotto – sulla scia di Epicuro e di Ieronimo – al “vivere-senza-dolore”. Occorre peraltro notare che, con il suo “edonismo” di marca epicurea, Ieronimo rischiava di uscire fuori dall’alveo dell’aristotelismo, non facilmente compatibilizzabile con la dottrina edonistica formulata da Epicuro. Una simile obiezione veniva già mossa a Ieronimo dallo stesso Cicerone, che notava acutamente (De finibus, V, 5, 14):
“Tralascio molti, e fra questi Ieronimo, dotto e attraente, ma non so perché dovrei chiamarlo peripatetico, giacché propose come sommo bene la mancanza di dolore; e chi dissente sul sommo bene, dissente su tutto il sistema filosofico”.
Non è immotivata l’accusa ciceroniana: forse senza rendersene del tutto conto, con l’adesione all’edonismo – e alla sua identificazione del sommo bene con l’assenza di dolore – Ieronimo stava abbandonando la teoria aristotelica, che – a proposito del sommo bene – aveva sostenuto, come è noto, tesi decisamente diverse e, per di più, difficilmente compatibili con quelle edonistico-epicuree.
FILONE DI LARISSA

Ieronimo di Rodi fu contemporaneo del neo-aristotelico Licone: mentre Licone impresse all’originaria dottrina aristotelica una svolta stoica, Ieronimo tentò di sposare l’aristotelismo con l’epicureismo. Alla luce di questi presupposti, non stupisce certo se tra Licone e Ieronimo – che pure erano entrambi di formazione aristotelica – non corse buon sangue: tra di loro vi fu quell’inimicizia che, a ben vedere, contraddistinse i rapporti tra Epicurei e Stoici (inimicizia che, detto per inciso, appare evidente quando Seneca deve giustificarsi, nelle Lettere a Lucilio, per aver cercato di prendere il meglio dalle due scuole rivali, comportandosi come un “esploratore” privo di preconcetti). In netta opposizione al rigorismo stoicheggiante di Licone – il cui modello restava quello stoico dell’autosufficienza del saggio –, Ieronimo sostenne apertamente l’identità tra il sommo bene e l’assenza di dolore: tesi, questa, chiaramente riconducibile al tema epicureo dell’atarassia, dell’aponia e dell’alupia. Per converso – spiega Ieronimo – il dolore coincide con il sommo male: tesi, anch’essa, squisitamente epicurea. Disponiamo di numerose testimonianze su Ieronimo, molte delle quali provengono da Cicerone. L’Arpinate – in forza della sua ben nota avversione per l’epicureismo – è assai critico verso Ieronimo, di cui rigetta – come del resto fa anche con Epicuro – l’insegnamento morale votato all’edonismo. Scrive Cicerone (De finibus, II, 3, 8):
“– Ricordi la definizione che Ieronimo di Rodi dà del sommo bene, a cui ritiene si debba riferire ogni cosa?
– Sì; secondo lui il termine estremo è l’assenza del dolore.
– E sempre il medesimo che pensa del piacere?
– Dice che non è desiderabile per se stesso.
– Dunque ritiene che altro è provar gioia, altro dolore”.
E aggiunge, con tono decisamente polemico (De finibus, II, 13, 41):
“E non bisogna dar retta a Ieronimo, per cui il sommo bene si identifica con quello che voi talvolta, o meglio troppo spesso, dite tale: il non provar dolore. Giacché, se il dolore è un male, non è sufficiente per vivere bene mancare di tale male”.
L’obiezione di Cicerone a Ieronimo è lineare: l’eliminazione del dolore non basta per vivere bene. Il “vivere bene” (“eu zen”, secondo la terminologia dei Greci) è qualcosa in più, che non può essere ridotto – sulla scia di Epicuro e di Ieronimo – al “vivere-senza-dolore”. Occorre peraltro notare che, con il suo “edonismo” di marca epicurea, Ieronimo rischiava di uscire fuori dall’alveo dell’aristotelismo, non facilmente compatibilizzabile con la dottrina edonistica formulata da Epicuro. Una simile obiezione veniva già mossa a Ieronimo dallo stesso Cicerone, che notava acutamente (De finibus, V, 5, 14):
“Tralascio molti, e fra questi Ieronimo, dotto e attraente, ma non so perché dovrei chiamarlo peripatetico, giacché propose come sommo bene la mancanza di dolore; e chi dissente sul sommo bene, dissente su tutto il sistema filosofico”.
Non è immotivata l’accusa ciceroniana: forse senza rendersene del tutto conto, con l’adesione all’edonismo – e alla sua identificazione del sommo bene con l’assenza di dolore – Ieronimo stava abbandonando la teoria aristotelica, che – a proposito del sommo bene – aveva sostenuto, come è noto, tesi decisamente diverse e, per di più, difficilmente compatibili con quelle edonistico-epicuree.
MENODOTO DI NICOMEDIA
Nell’ambito della “scienza medica”, già a partire dal III secolo a. C. andò delineandosi – almeno embrionalmente – un nuovo metodo: il cosiddetto metodo dei medici empirici. Sembra che le basi di questo indirizzo siano state poste da Filino di Cos: Serapione di Alessandria ne avrebbe in seguito dato una fondazione su solide basi. Nel I secolo a.C. godette di grande fama Eraclide di Taranto, specialmente grazie al suo scritto Sulla setta empirica. L’indirizzo empirico ebbe, però, la sua massima diffusione in era cristiana, fra il I e il II secolo, soprattutto con Menodoto di Nicomedia, che di quell’indirizzo rappresentò indubbiamente il vertice. Va subito detto che la cronologia di Menodoto è difficile da ricostruire, mancando precise indicazioni nelle testimonianze che su di lui ci sono pervenute. Forse non si è lontani dal vero collocandolo nella prima metà del II secolo d.C. L’indirizzo dei medici empirici a cui Menodoto si ispirava concordava con quello dei “medici metodici” nel condannare la “mentalità eziologica” dei “medici dottrinari”, ma si spingeva poi a sostenere che le “cause” delle malattie sono letteralmente incomprensibili. Esso concordava, inoltre, con l’indirizzo metodico nel privilegiare i sensi i fenomeni e l’esperienza; anzi, su questo punto, intendeva essere decisamente più radicale: il medico empirico doveva tenere conto anche delle esperienze che riguardano specificamente le circostanze e l’individualità del soggetto (le idiosincrasie), senza mai sacrificare in alcun modo il particolare al generale. Proprio in virtù di questo maniacale attaccamento all’ambito dell’empiria, l’indirizzo fu detto “empirico”. In Menodoto di Nicomedia prevalsero la mentalità e gli interessi medici, e nell’ambito della medicina dovettero rientrare, più che in quello della speculazione filosofica, i suoi più significativi contributi. È degno di nota, a questo riguardo, il fatto che Galeno (pur giudicando Menodoto molto severamente sotto il profilo morale) polemizzò contro di lui e lo menzionò a più riprese. Menodoto combatté contro gli avversari della medicina empirica con animosità e con acredine, e, nel dimostrare la vanità della pretesa della ricerca delle cause, si spinse, ben al di là della proclamazione della necessità dell’“epoché” (la “sospensione del giudizio” praticata dagli Scettici), addirittura su posizioni di dogmatismo negativo, giudicando le tesi degli avversari con presunzione di certezza circa la loro falsità. Per quel che concerne le idee propriamente filosofiche, Menodoto non reputava che lo Scetticismo accademico fosse coniugabile con il Pirronismo e che, dunque, potesse rientrare nella sua storia. Menodoto riteneva che Platone potesse essere inteso come uno Scettico. Infatti – argomenta Menodoto – se Platone circa le Idee, la Provvidenza e la Virtù, assente ad esse come a cose certe, dogmatizza; se vi assente come a cose probabili e come tali le preferisce, si allontana anche in questo caso dallo Scetticismo e, ancora una volta, dogmatizza; e tali conclusioni non cambiano anche se Platone si esprime, su alcune cose, alla maniera scettica. Forse risale a Menodoto la distinzione fra i “segni indicativi” e i “segni rammemorativi” (e la conseguente dichiarazione della loro legittimità), che non era ancora presente in Enesidemo e che presuppone il guadagno della prospettiva empirica. Il “segno rammemorativo” è una mera associazione mnemonica fra due o più fenomeni acquisita mediante esperienza (vale a dire per aver più volte costatato che nell’esperienza quei fenomeni si presentano connessi), la quale ci permette, qualora si presenti uno di questi fenomeni (ad esempio il fumo), di “inferire” l’altro o gli altri fenomeni (per esempio il fuoco, la sua luce, il suo calore). Accanto al momento negativo tipico dello Scetticismo pirroniano, Menodoto poneva il momento positivo del richiamo all’esperienza e dell’impiego del metodo empirico. È precisamente questo positivo nesso con l’esperienza la novità che contraddistingue l’ultima fase dello Scetticismo avviato da Menodoto, che, comunque, maturò pienamente solo grazie alla riflessione di Sesto Empirico.
MARZIANO CAPELLA

Nell’ambito della “scienza medica”, già a partire dal III secolo a. C. andò delineandosi – almeno embrionalmente – un nuovo metodo: il cosiddetto metodo dei medici empirici. Sembra che le basi di questo indirizzo siano state poste da Filino di Cos: Serapione di Alessandria ne avrebbe in seguito dato una fondazione su solide basi. Nel I secolo a.C. godette di grande fama Eraclide di Taranto, specialmente grazie al suo scritto Sulla setta empirica. L’indirizzo empirico ebbe, però, la sua massima diffusione in era cristiana, fra il I e il II secolo, soprattutto con Menodoto di Nicomedia, che di quell’indirizzo rappresentò indubbiamente il vertice. Va subito detto che la cronologia di Menodoto è difficile da ricostruire, mancando precise indicazioni nelle testimonianze che su di lui ci sono pervenute. Forse non si è lontani dal vero collocandolo nella prima metà del II secolo d.C. L’indirizzo dei medici empirici a cui Menodoto si ispirava concordava con quello dei “medici metodici” nel condannare la “mentalità eziologica” dei “medici dottrinari”, ma si spingeva poi a sostenere che le “cause” delle malattie sono letteralmente incomprensibili. Esso concordava, inoltre, con l’indirizzo metodico nel privilegiare i sensi i fenomeni e l’esperienza; anzi, su questo punto, intendeva essere decisamente più radicale: il medico empirico doveva tenere conto anche delle esperienze che riguardano specificamente le circostanze e l’individualità del soggetto (le idiosincrasie), senza mai sacrificare in alcun modo il particolare al generale. Proprio in virtù di questo maniacale attaccamento all’ambito dell’empiria, l’indirizzo fu detto “empirico”. In Menodoto di Nicomedia prevalsero la mentalità e gli interessi medici, e nell’ambito della medicina dovettero rientrare, più che in quello della speculazione filosofica, i suoi più significativi contributi. È degno di nota, a questo riguardo, il fatto che Galeno (pur giudicando Menodoto molto severamente sotto il profilo morale) polemizzò contro di lui e lo menzionò a più riprese. Menodoto combatté contro gli avversari della medicina empirica con animosità e con acredine, e, nel dimostrare la vanità della pretesa della ricerca delle cause, si spinse, ben al di là della proclamazione della necessità dell’“epoché” (la “sospensione del giudizio” praticata dagli Scettici), addirittura su posizioni di dogmatismo negativo, giudicando le tesi degli avversari con presunzione di certezza circa la loro falsità. Per quel che concerne le idee propriamente filosofiche, Menodoto non reputava che lo Scetticismo accademico fosse coniugabile con il Pirronismo e che, dunque, potesse rientrare nella sua storia. Menodoto riteneva che Platone potesse essere inteso come uno Scettico. Infatti – argomenta Menodoto – se Platone circa le Idee, la Provvidenza e la Virtù, assente ad esse come a cose certe, dogmatizza; se vi assente come a cose probabili e come tali le preferisce, si allontana anche in questo caso dallo Scetticismo e, ancora una volta, dogmatizza; e tali conclusioni non cambiano anche se Platone si esprime, su alcune cose, alla maniera scettica. Forse risale a Menodoto la distinzione fra i “segni indicativi” e i “segni rammemorativi” (e la conseguente dichiarazione della loro legittimità), che non era ancora presente in Enesidemo e che presuppone il guadagno della prospettiva empirica. Il “segno rammemorativo” è una mera associazione mnemonica fra due o più fenomeni acquisita mediante esperienza (vale a dire per aver più volte costatato che nell’esperienza quei fenomeni si presentano connessi), la quale ci permette, qualora si presenti uno di questi fenomeni (ad esempio il fumo), di “inferire” l’altro o gli altri fenomeni (per esempio il fuoco, la sua luce, il suo calore). Accanto al momento negativo tipico dello Scetticismo pirroniano, Menodoto poneva il momento positivo del richiamo all’esperienza e dell’impiego del metodo empirico. È precisamente questo positivo nesso con l’esperienza la novità che contraddistingue l’ultima fase dello Scetticismo avviato da Menodoto, che, comunque, maturò pienamente solo grazie alla riflessione di Sesto Empirico.
NUMENIO DI APAMEA
Con Numenio di Apamea il Neopitagorismo raggiunge il suo punto più elevato ma, al tempo stesso, si dissolve, contaminandosi con il movimento medioplatonico. Anche in forza di ciò, la figura di Numenio appare difficilmente collocabile: c’è chi lo considera un platonico, o meglio un “medioplatonico”, ma vi è anche chi – non senza buoni argomenti – lo considera un “neopitagorico”. La stessa vita di Numenio resta per noi, almeno in parte, misteriosa: nacque ad Apamea, in Siria, ossia nella stessa città che diede i natali a Posidonio. L’unico riferimento cronologico che possediamo e che ci serve da terminus ante quem è la menzione che ne fa Clemente Alessandrino. Probabilmente (ma non è certo) Numenio visse nella seconda metà del II secolo d.C. La sua conoscenza di Filone e della sapienza egiziana postula una sua permanenza ad Alessandria, dove presumibilmente studiò, o, addirittura, insegnò. Vi è anche chi sostiene che Numenio dovette soggiornare anche ad Atene, poiché mostra di conoscere profondamente la storia dell’Accademia, alla quale dedicò l’opera Sull’infedeltà degli Accademici a Platone, di cui ci sono pervenuti non pochi frammenti. Importanti frammenti ci sono stati conservati anche di un’altra sua opera, che doveva costituire il suo capolavoro, il Trattato sul bene. Stando alle testimonianze e ai frammenti pervenutici, Numenio si considerava per lo più un seguace di Pitagora, e, insieme, anche di Socrate e di Platone, in quanto si diceva convinto che sia Socrate sia Platone dipendessero sostanzialmente da Pitagora, e che Platone non gli fosse affatto superiore. Ciò non di meno, Numenio sentì il bisogno di difendere Platone contro i fraintendimenti dei numerosi discepoli che, a partire da Arcesilao, lo avevano tradito, con la giàò menzionata opera Sull’infedeltà degli Accademici a Platone. Gli Accademici non si sono affatto sforzati di mantenere intatto l’insegnamento del maestro. Ma per Numenio, Platone meritava la stessa fedeltà e venerazione da parte dei discepoli per cui Pitagora fu elevato a così grandi onori, dato che, pur non essendo maggiore rispetto al grande Pitagora, non gli era in fondo nemmeno inferiore. La figura di Socrate che ci presenta Numenio è singolare: è un Socrate che professa la “dottrina dei tre Dei”, che aveva appreso da Pitagora. Lo stesso Platone è, per Numenio, fortemente pitagorizzante. Il tradimento dei discepoli di Platone sarebbe dovuto principalmente al fatto che Platone scrisse in maniera velata, occultando le cose che diceva, “a metà tra il chiaro e l’oscuro”. Alla luce di questa considerazione, Numenio si propone di far riaffiorare il verbo platonico e dimostrare che questo coincideva col verbo pitagorico. E la dottrina elaborata da Numenio nei frammenti pervenutici conferma largamente queste sue intenzioni programmatiche: egli cerca, infatti, di fondere quelle dottrine teologico-metafisiche che i Medioplatonici avevano ricavato dalla rilettura del Timeo con la dottrina della Monade, della Diade e dei numeri, che i Neopitagorici avevano rimesso in vigore. Una terza componente decisiva che operò sul pensiero di Numenio fu il pensiero orientale. Siriano di origine, Numenio lascia trasparire anche nel suo pensiero un fortissimo influsso dell’Oriente. Numenio conobbe la sapienza biblica e le interpretazioni allegoriche di Filone di Alessandria, ed egli stesso interpretò allegoricamente Mosè e i Profeti; ebbe pure conoscenza delle dottrine cristiane e sappiamo che interpretò allegoricamente almeno un episodio della vita di Gesù. Egli conobbe anche la sapienza di altri popoli orientali, e si appropriò della dottrina che ammetteva nell’uomo due anime (una buona e una cattiva) di derivazione persiana. Però l’influsso dell’Oriente è da scorgersi specialmente in quell’atteggiamento mistico-religioso, che aveva trovato espressione dapprima in Alessandria, e che ormai, nel II secolo d.C., era dominante. Per questa via, venivano a realizzarsi tutte quelle condizioni che dovevano portare alla nascita del neoplatonismo.

